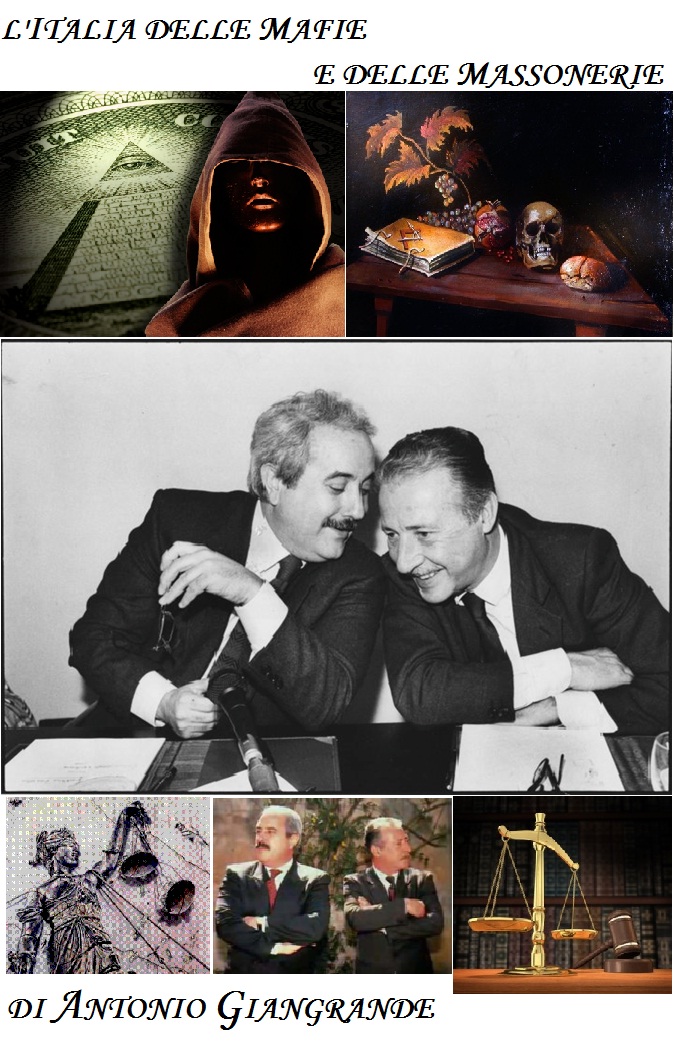Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Gli editori ed i distributori censori si avvalgono dell'accusa di plagio, per
cessare il rapporto. Plagio mai sollevato da alcuno in sede penale o civile, ma
tanto basta per loro per censurarmi.
I miei contenuti non sono propalazioni o convinzioni personali. Mi avvalgo solo
di fonti autorevoli e credibili, le quali sono doverosamente citate.
Io sono un sociologo storico: racconto la contemporaneità ad i posteri, senza
censura od omertà, per uso di critica o di discussione, per ricerca e studio
personale o a scopo culturale o didattico. A norma dell'art. 70, comma 1 della
Legge sul diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di
brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se
effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali
fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica
l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non
commerciali."
L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni
forma e modo (art. 12 comma 2 Legge sul Diritto d’Autore). La legge stessa però
fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze
di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della
cultura e di studio. Si tratta di limitazioni all’esercizio del diritto di
autore, giustificate da un interesse generale che prevale sull’interesse
personale dell’autore.
L'art. 10 della Convenzione di Unione di Berna (resa esecutiva con L. n. 399 del
1978) Atto di Parigi del 1971, ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza
degli ordinamenti internazionali, prevede il diritto di citazione con le
seguenti regole: 1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa
lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali
e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette
citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata
dallo scopo.
Ai sensi dell’art. 101 della legge 633/1941: La riproduzione di informazioni e
notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli
usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro
in quest'ipotesi che oltre alla violazione del diritto d'autore è apprezzabile
un'ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (il cosiddetto
parassitismo giornalistico). Quindi in questo caso non si fa concorrenza
illecita al giornale e al testo ma anzi dà un valore aggiunto al brano originale
inserito in un contesto più ampio di discussione e di critica.
Ed ancora: "La libertà ex art. 70 comma I, legge sul diritto di autore, di
riassumere citare o anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica,
discussione o insegnamento è ammessa e si giustifica se l'opera di critica o
didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell'opera citata e
perciò i frammenti riprodotti non creino neppure una potenziale concorrenza con
i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera
parzialmente riprodotta" (Cassazione Civile 07/03/1997 nr. 2089).
Per questi motivi Dichiaro di essere l’esclusivo autore del libro in oggetto e
di tutti i libri pubblicati sul mio portale e le opere citate ai sensi di legge
contengono l’autore e la fonte. Ai sensi di legge non ho bisogno di
autorizzazione alla pubblicazione essendo opere pubbliche.
Promuovo
in video tutto il territorio nazionale ingiustamente maltrattato e
censurato.
Ascolto e Consiglio le vittime discriminate ed inascoltate. Ogni giorno da
tutto il mondo sui miei siti istituzionali, sui miei blog d'informazione
personali e sui miei canali video sono seguito ed apprezzato da centinaia di
migliaia di navigatori web. Per quello che faccio, per quello che dico e per
quello che scrivo
i media mi censurano e le istituzioni mi perseguitano. Le letture e le
visioni delle mie opere sono gratuite. Anche l'uso è gratuito, basta indicare la
fonte.
Nessuno mi sovvenziona per le spese che sostengo e mi impediscono di lavorare
per potermi mantenere. Non vivo solo di aria:
Sostienimi o mi faranno cessare e vinceranno loro.
Dr Antonio Giangrande
NOTA BENE
NESSUN EDITORE VUOL PUBBLICARE I
MIEI LIBRI, COMPRESO AMAZON, LULU E STREETLIB
SOSTIENI UNA VOCE VERAMENTE LIBERA CHE
DELLA CRONACA, IN CONTRADDITTORIO, FA STORIA
NOTA BENE PER IL DIRITTO D'AUTORE
NOTA LEGALE: USO LEGITTIMO DI MATERIALE ALTRUI PER
IL CONTRADDITTORIO
LA SOMMA, CON CAUSALE SOSTEGNO, VA VERSATA CON:
-
accredito/bonifico al conto BancoPosta intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA IBAN: IT15A0760115800000092096221 (CIN IT15A - ABI 07601
- CAB 15800 - c/c n. 000092096221)
-
versamento in bollettino postale sul
c.c. n. 92096221. intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA
-
SCEGLI IL LIBRO
 PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
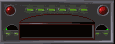
 presidente@controtuttelemafie.it
presidente@controtuttelemafie.it
 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996
 0999708396
0999708396
INCHIESTE VIDEO YOUTUBE:
CONTROTUTTELEMAFIE -
MALAGIUSTIZIA
-
TELEWEBITALIA
 FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
(gruppi)
ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE -
TELE WEB ITALIA -
ABOLIZIONE DEI CONCORSI TRUCCATI E LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI
(pagine)
GIANGRANDE
LIBRI
 WEB TV:
TELE WEB ITALIA
WEB TV:
TELE WEB ITALIA
 NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
MASSONERIOPOLI
DI ANTONIO
GIANGRANDE
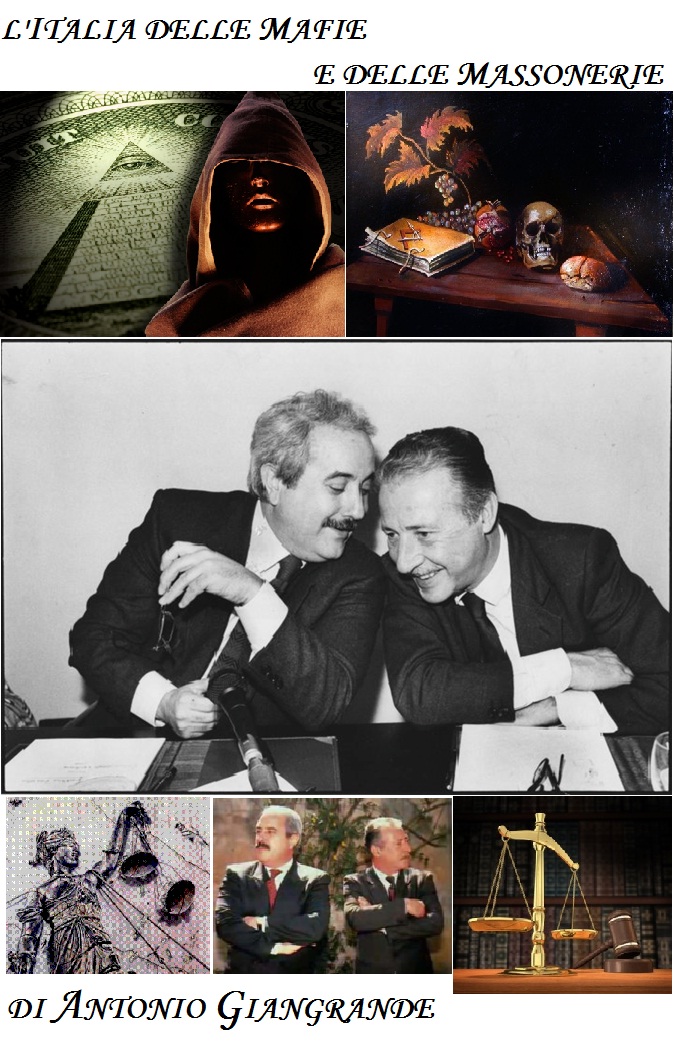
MASSONERIOPOLI
MASSONERIA. QUELLO CHE NON SI OSA DIRE.
MASSONERIA: QUELLO CHE NON TI DICONO.
Difficilmente si
troverà nel mondo editoriale un’opera come questa: senza peli sulla lingua (anzi
sulla tastiera). Nell’affrontare il tema della Massoneria non si può non parlare
dei tarli che divorano il sistema Italia e le commistioni tra le cosche
criminali locali con le lobbies, le caste e le massonerie deviate. Queste
detengono il potere politico, economico ed istituzionale e per gli effetti si
garantiscono impunità ed immunità. Delle Caste e delle Lobbies si parla in
un’inchiesta ed in un libro a parte. Della Mafia, si parla dettagliatamente
anche in altra inchiesta ed in altro libro.
TIRANNIDE indistintamente appellare si
debbe ogni qualunque governo, in cui chi è preposto alla esecuzion delle leggi,
può farle, distruggerle, infrangerle, interpretarle, impedirle, sospenderle; od
anche soltanto deluderle, con sicurezza d'impunità. E quindi, o questo
infrangi-legge sia ereditario, o sia elettivo; usurpatore, o legittimo; buono, o
tristo; uno, o molti; a ogni modo, chiunque ha una forza effettiva, che basti a
ciò fare, è tiranno; ogni società, che lo ammette, è tirannide; ogni popolo, che
lo sopporta, è schiavo. Vittorio Alfieri (1790).
“L'Italia tenuta al
guinzaglio da un sistema di potere composto da caste, lobbies, mafie e
massonerie: un'Italia che deve subire e deve tacere. La “Politica” deve essere
legislazione o amministrazione nell’eterogenea rappresentanza d’interessi,
invece è meretricio o mendicio, mentre le “Istituzioni” devono meritarlo il
rispetto, non pretenderlo. Il rapporto tra cittadini e il rapporto tra cittadini
e Stato è regolato dalla forza della legge. Quando non vi è cogenza di legge,
vige la legge del più forte e il debole soccombe. Allora uno “Stato di Diritto”
degrada in anarchia. In questo caso è palese la responsabilità politica ed
istituzionale per incapacità o per collusione. Così come è palese la
responsabilità dei media per omertà e dei cittadini per codardia o emulazione."
Di Antonio Giangrande
SOMMARIO
INTRODUZIONE
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.
TINA ANSELMI ED AGOSTINO CORDOVA: I PASIONARI
CONTRO LA MASSONERIA DEVIATA.
CHI COMANDA IL MONDO E LE INCHIESTE CHE NON SI
DEVONO FARE.
‘NDRANGHETA, COSA NOSTRA, MASSONERIA DEVIATA E
STATO: TUTTI INSIEME APPASIONATAMENTE…
PARLIAMO DI MASSONERIA E DI CHI COMANDA IL
MONDO.
LA MASSONERIA ED IL NAZI-FASCISMO-COMUNISMO.
GLI ACCORDI SEGRETI DEI GERARCHI.
IN QUESTO MONDO DI LADRI.
CHI FA LE LEGGI?
LA MASSONERIA E PALAZZO GIUSTINIANI.
IL RITO DI INIZIAZIONE.
ERO MASSONE.
"PADRI DELLA PATRIA"
VITTIME E COMPLICI DELLA NOSTRA
ROVINA.
P2 E DINTORNI. CHI ERA
LICIO GELLI?
A SINISTRA SI E’ PIU’ INTELLIGENTI?
L'UGUAGLIANZA E L’INVIDIA SOCIALE.
GLI INTOCCABILI E LA SOCIETA’ DELLE CASTE.
E’ TUTTA QUESTIONE DI COSCIENZA.
SE NASCI IN ITALIA…
AVVOCATI. ABILITATI COL TRUCCO.
I MEDIA ED I LORO PECCATI: DISINFORMAZIONE,
CALUNNIA, DIFFAMAZIONE.
SE IL NEMICO NON LO PUOI BATTERE, FATTELO
AMICO!
PER UNA LETTURA UTILE E
CONSAPEVOLE CONTRO L’ITALIA DEI GATTOPARDI.
POLITICA, GIUSTIZIA ED
INFORMAZIONE. IN TEMPO DI VOTO SI PALESA L’ITALIETTA DELLE VERGINELLE.
LA REPUBBLICA DELLE
MANETTE.
TUTTI DENTRO CAZZO!
LA LEGGE NON E’ UGUALE PER
TUTTI.
ITALIA PAESE DELL’IMMUNITA’
E DELLA CENSURA. PER L’EUROPA INADEMPIENTE SU OGNI NORMA.
STATO DI DIRITTO?
CHI E’ IL POLITICO?
CHI E’ L’AVVOCATO?
DELINQUENTE A CHI? CHI E’
IL MAGISTRATO?
DUE PAROLE SULLA MAFIA.
QUELLO CHE LA STAMPA DI REGIME NON DICE.
CARMINE SCHIAVONE. LA VERA
MAFIA SONO I POLITICI, I MAGISTRATI E LE FORZE DELL’ORDINE.
2 OTTOBRE 2013. LE
GIRAVOLTE DI BERLUSCONI. L’APOTEOSI DELLA VERGOGNA ITALICA.
ITALIA DA VERGOGNA.
ITALIA BARONALE.
CASA ITALIA.
ITALIA. SOLIDARIETA’
TRUCCATA E DI SINISTRA.
LA GUERRA TRA ASSOCIAZIONI
ANTIRACKET.
ITALIA: PAESE ZOPPO.
QUANDO I BUONI TRADISCONO.
DUE COSE SU AMNISTIA,
INDULTO ED IPOCRISIA.
FACILE DIRE EVASORE FISCALE
A TUTTI I TARTASSATI. GIUSTO PER MANTENERE I PARASSITI. LA LOREN E MARADONA.
ANCHE GESU' E' STATO
CARCERATO.
ANCHE GLI STUDENTI SONO UNA
CASTA.
QUANTO SONO ATTENDIBILI LE
COMMISSIONI D’ESAME?
LO STATO CON LICENZA DI TORTURARE ED UCCIDERE.
E LA CHIAMANO GIUSTIZIA. CHE CAZZO DI INDAGINI
SONO?
27 NOVEMBRE 2013. LA DECADENZA DI BERLUSCONI.
FIGLI DI QUALCUNO E FIGLI
DI NESSUNO.
LA TERRA DEI CACHI, DEI
PARLAMENTI ABUSIVI E DELLE LEGGI, PIU’ CHE NULLE: INESISTENTI.
LO SPRECO DI DENARO
PUBBLICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO.
SONO BRAVI I COMUNISTI.
NIENTE DIRITTO DI DIFESA PER I POVERI.
MENTRE PER LE LOBBIES LE
PORTE SONO SEMPRE APERTE.
LA LOBBY DEI DENTISTI E LA
MAFIA ODONTOIATRICA.
UNIONE EUROPEA: ITALIA 60
MILIARDI DI CORRUZIONE. CHI CAZZO HA FATTO I CONTI?
FATTI DI CRONACA, DISFATTI
DI GIUSTIZIA.
LOTTA
ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA. DA QUALE PULPITO ARRIVA LA PREDICA, SE LO
STATO E’ IL PRIMO EVASORE IN ITALIA?
L’ITALIA, IL PAESE DEI NO.
LA SINDROME DI NIMBY.
L’ITALIA DEI COLPI DI
STATO.
PER LA TUTELA DEI DIRITTI
DEGLI INDIGENTI. PRO BONO PUBLICO OBBLIGATORIO.
NON VI REGGO PIU’.
BELLA ITALIA, SI’. MA
ITALIANI DEL CAZZO!!!
FENOMENOLOGIA RANCOROSA
DELL’INGRATITUDINE.
SE NASCI IN ITALIA…
DIRITTO E GIUSTIZIA. I TANTI GRADI DI GIUDIZIO
E L’ISTITUTO DELL’INSABBIAMENTO.
GIUSTIZIA DA MATTI E MOSTRI A PRESCINDERE.
L’ANTIMAFIA DEI RECORD.
LA CHIAMANO
GIUSTIZIA, PARE UNA BARZELLETTA. PROCESSI: POCHE PAGINE DA LEGGERE E POCHI
TESTIMONI.
IL SUD
TARTASSATO.
ITALIANI. LA CASTA
DEI "COGLIONI". FACCIAMO PARLARE CLAUDIO BISIO.
IL NORD EVADE PIU’ DEL SUD.
MASSONERIA: QUELLO CHE NON
SI OSA DIRE.
IL FENOMENO FEMEN.
UN APPROFONDIMENTO, ANCHE LETTERARIO, SULLA
MASSONERIA.
LA MASSONERIA TRA CHIESA E 'NDRANGHETA.
MAGISTRATI MASSONI, GIU' IL
CAPPUCCIO!!!!
LA MASSONERIA DEL
TERZO MILLENNIO. I DELITTI MASSONICI E LE NOTE DI CRONACA. IL MISTERO DELLA
MORTE DI RINO GAETANO, DI MARCO PANTANI E DEGLI ALTRI NOMI NOTI E LO SCANDALO
MOSE.
CHI SONO I MAFIOSI?
GUERRA IN PROCURA A TARANTO. PIETRO ARGENTINO E MATTEO DI GIORGIO. PROCURATORI
DELLA REPUBBLICA ACCOMUNATI DALLO STESSO DESTINO?
GUERRA DI TOGHE.
LE CARICHE PUBBLICHE
E LA MASSONERIA. FATTI AMICO UN MASSONE DI SINISTRA.
SILVIO E GIORGIO: AFFINITA’ E FRATELLANZA.
CHI NON E’ MASSONE DEVIATO, SCAGLI LA PRIMA
PIETRA: MAGISTRATI, POLITICI, MAFIOSI.
LA MASSONERIA ED IL POTERE.
FINANZA E POTERE. IL GRUPPO BILDERBERG E LE
TEORIE COMPLOTTISTICHE.
LA COSTITUZIONE ITALIANA VOLUTA DAI MASSONI.
FRATELLI D’ITALIA? MASSONI ITALIANI.
FRATELLI COLTELLI.
ABOLIAMO LA MASSONERIA?
AFFARI DEI TEMPLARI LEGHISTI.
PARLIAMO DI MASSONERIA, MAFIA, FINANZA E
MAGISTRATURA.
SE TU DENUNCI LE INGIUSTIZIE DIVENTI MITOMANE O
PAZZO. IL SISTEMA E LA MASSOMAFIA TI IMPONE: SUBISCI E TACI. LA STORIA DI
FREDIANO MANZI E PIETRO PALAU GIOVANETTI.
MASSONI. QUEGLI UOMINI IN NERO NASCOSTI TRA
POLITICA, MAGISTRATURA ED AFFARI.
MASSONERIA: GLI
INSOLITI NOTI CHE SONO IN MEZZO A NOI.
MAGISTRATI ED AVVOCATI MASSONI?
PARLIAMO DI
MASSONERIA.
MASSONERIA – I MAGISTRATI DALLA A ALLA
ZETA.
TORINO CAPITALE, COVO DI MASSONI.
PARLIAMO DI MASSONERIA DEVIATA, MAFIA, SERVIZI
SEGRETI E SETTE SATANICHE.
PALERMO: DALLA MASSONERIA ALLA MAFIA.
IL MAGISTRATO PAOLO FERRARO E LE SETTE DI
STATO.
STORIA DELLA MASSONERIA.
POLITICA E MASSONERIA.
IL MISTERO SULLA MASSONERIA.
LOGGIA PROPAGANDA 2.
GLADIO.
P3 E CRICCHE ANNESSE.
LE P....POTERI OCCULTI, MA NON TROPPO.
WALT DISNEY, IL MASSONE?
INTRODUZIONE
Antonio Giangrande,
orgoglioso di essere diverso.
Se si è omologati (uguali)
o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi
nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
In un mondo caposotto
(sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli
ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono
l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I
nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è?
Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.
Dove si sentono alti anche
i nani e dove anche i marescialli si sentono generali, non conta quanti passi
fai e quali scarpe indossi, ma conta quante tracce lasci del tuo percorso.
Il difetto degli
intelligenti è che sono spinti a cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio
degli ignoranti è che non hanno dubbi e qualora li avessero sono convinti di
avere già le risposte.
Un popolo di “coglioni”
sarà sempre governato ed amministrato da “coglioni”.
Un chierico medievale si
imbatté in un groviglio di serpi su cui spiccava un ramarro che già da solo
sarebbe bastato a spaventarlo. Tuttavia, confrontata a quelle serpeggianti
creature, la bestiola gli parve graziosa ed esclamò: «Beati monoculi in terra
caecorum», nella terra dei ciechi anche l’orbo è re.
Noi siamo quello che altri
hanno voluto che diventassimo. Quando esprimiamo giudizi gratuiti, cattivi ed
illogici lo facciamo con la nostra bocca ma inconsapevolmente per volontà di
altri. Lo facciamo in virtù di quanto ricevuto: dall’educazione familiare,
dall’istruzione di regime, dall’indottrinamento politico e religioso,
dall’influenza mediatica. Niente è farina del nostro sacco. Se ci basassimo solo
sulle nostre esperienze staremmo solo zitti, sapendo che nessuno sarebbe capace
e disposto ad ascoltarci.
E’ comodo definirsi scrittori
da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere
“C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di
scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri
scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale.
Da sempre diffido di chi,
vestito da lupo, è pecora genuflessa alla magistratura. I saccenti
giustizialisti dei 5 stelle che provino a proporre la figura del difensore
civico giudiziario con poteri di magistrato, senza essere uno di loro, per poter
metter le mani nelle carte dei fascicoli e poterle sparigliare. Io da anni mi
batto inascoltato per questo. I signori dei 5 stelle non si degnano nemmeno di
rispondere ai messaggi degli esperti: tanto san tutto loro. A sbraitare son
bravi, ma a proporre leggi sensate, mi sa che non son capaci. Parlan solo di
soldi, soldi, soldi ed onestà, certificata dai loro magistrati, e mai parlano di
libertà ed opportunità senza concorsi ed esami pubblici truccati.
Ad ogni azione umana nefasta
si trova sempre una giustificazione...lo si fa per le piante...lo si fa per gli
animali...lo si fa per le persone! Ma, alla fine, rimane solo un'azione nefasta
che fa male al prossimo...e, spesso, il prossimo siamo noi. A parte il partito
preso, noi siamo tutti responsabili delle azioni nefaste di uno, quando gli
permettiamo di farle.
Parlare nei miei libri del
caso singolo del semplice cittadino significa incorrere nell’accusa di
mitomania, pazzia o calunnia, oltre che ne disinteresse. Invece parlo di loro,
delle istituzioni che delinquono impunite. Parlo della vera mafia. Cosa posso
dire di più di quello che ho scritto e che altri non dicono? Credo che quanto
divulgato possa essere di grande soddisfazione per le vittime, non potendo avere
altro che quella in questa Italia con italiani di merda a cui interessa solo di
loro stessi e se ne fottono degli altri.
L'UNITA' IL PECCATO
ORIGINALE.
Scrive "Un Popolo Distrutto" il 30 gennaio 2018. L’intera storia di questo Paese
andrebbe riscritta per smascherare il sistematico ricorso alla coercizione
armata degli apparati dello Stato per perpetuare il potere della “borghesia
compra dora” (una classe media indigena alleata con gli investitori stranieri,
multinazionali, banchieri e gli interessi militari) asservita al grande capitale
cosmopolita e del suo partito: la massoneria. Le origini di molti mali
dell’Italia di oggi risiedono nelle circostanze con cui l’unità nazionale fu
raggiunta, cioè una spietata guerra di conquista e di saccheggio scatenata dal
Piemonte contro i floridi stati preunitari. Gli obbiettivi di Cavour erano
quelli di garantire alla nascente industria del Nord i capitali per il suo
sviluppo e un mercato per i suoi prodotti. Quindi si deve parlare di una vera e
propria guerra coloniale: dove la potenza imperialista interviene direttamente
per garantire la sicurezza degli investimenti e lo sfruttamento del territorio.
Con l'emancipazione nazionale il grande capitale arruola tra gli indigeni il
personale di cui ha bisogno: tecnici, amministratori, forze di polizia. Poi in
modo più sfumato, la potenza imperialista continua a condizionare la colonia
attraverso i programmi di assistenza economica, militare e culturale, ma
ricorrendo anche alla corruzione, all’intimidazione, al colpo di stato e
all’intervento militare diretto. Il tutto nell’interesse del grande capitale,
che nel frattempo è diventato cosmopolita. In Italia il Regno del Piemonte si
sostituì, all’Austria come potenza coloniale e l’unità segnò il punto di
transizione dall’epoca coloniale al neocolonialismo. Di fatto termina una
dominazione straniera e sorge uno Stato unitario e formalmente indipendente sul
piano politico, ma pur sempre aggiogato al carro del grande capitale. Fu la
grande finanza ebraica a spingere i governi europei a intraprendere le
iniziative coloniali dell’Ottocento. Ciò accadde perché il grande capitale non
trovava più sufficientemente remunerativi gli investimenti nelle loro nazioni
d’origine. Il caso italiano non fa eccezione: furono i Rothschild di Parigi e i
loro agenti a Parigi, Londra e Ginevra a finanziare le guerre d’indipendenza, la
costruzione di cantieri navali, ferrovie e fabbriche di armi, l’allestimento di
una moderna flotta. Re Vittorio Emanuele II e Cavour contrassero con la finanza
ebraica debiti di tali proporzioni da rendere necessario il saccheggio
sistematico del resto della Penisola. Questo fu il meccanismo criminale che
portò all’unificazione della Penisola. L’Italia è sempre stata una terra ricca
grazie ai suoi porti, alla sua collocazione geografica, alla fertilità delle
campagne, all’ingegnosità dei suoi abitanti: c’era tanto da predare in Italia.
La resistenza delle strutture tribali alle strutture del capitalismo avanzato
provocano un fenomeno di reazione, che è possibile osservare nella storia di
ogni Paese toccato dal colonialismo. Questa situazione si trova anche nel
Mezzogiorno italiano e prende il nome di brigantaggio. Con l’affermazione di una
classe sociale, detta borghesia compradora, da non confondere con la borghesia
produttiva che fa impresa o la piccola borghesia cittadina dedita al commercio
spiccio, né quella rurale dei piccoli proprietari terrieri. Ma l’agente del
grande capitale nei Paesi in via di sviluppo: è la classe sociale degli
amministratori, degli ufficiali dell’esercito, degli impiegati di banche
straniere e multinazionali, dei liberi professionisti, la cui unica ragione è la
difesa degli investimenti stranieri sul territorio minacciati dalle
rivendicazioni sociali del popolo oppresso. I suoi membri traggono una rendita
di posizione, che si esprime nelle forme del potere personale, del prestigio e
della ricchezza. La borghesia compradora comparve in Italia alla vigilia
dell’unità col preciso compito di saccheggiare il Paese per sé e per i propri
padroni: i potenti banchieri israeliti di Parigi, Londra e Ginevra guidati dai
Rothschild. Furono costoro, che finanziarono le guerre d’indipendenza e il
processo di modernizzazione del Paese. Considerati gli interessi che essi
difendono, non sorprende che governi di diverso colore politico si alternino tra
loro senza che nulla cambi. (“Tutto cambia perché nulla cambi”. Tomasi di
Lampedusa). Il sacco d’Italia iniziò accentrando in un’unica mano la leva della
fiscalità a partire dal 1861 e fu condotto per mezzo di un esercito di
amministratori corrotti e soldati. Così, servendosi della borghesia compradora
selezionata e arruolata dalla massoneria, il grande capitale instaurava le sue
strutture economiche nella Penisola. Il risultato fu un’ondata di miseria quale
non se ne ricordava da secoli: fu a quel punto che milioni di compatrioti
iniziarono a emigrare in America con le famose valige di cartone. (Oggi il
fenomeno si ripete: sono giovani diplomati e laureati che partono in cerca di
opportunità di lavoro che in Italia mancano, piccoli imprenditori che chiudono
le loro fabbrichette in Italia per delocalizzare le produzioni, pensionati che
fuggono in Portogallo, in Romania o in Tunisia per poter vivere dignitosamente
gli ultimi anni della loro vita con quel poco di pensione che si ritrovano).
Tutto questo accade perché esiste una casta che nulla produce, ma depreda,
dilapida e si vende le ricchezze che dovrebbe amministrare in nome del popolo
sovrano. Dal 1861 i vari governi che governavano il Paese imposero al Sud la
pesante tassazione che già gravava sul Nord, aggiunsero nuovi balzelli, come
l’odiosa tassa sul macinato, confiscò i palazzi e le tenute fondiarie della
Chiesa, che i soliti faccendieri si accaparrarono a prezzi stracciati. Tutto ciò
serviva ad alimentare la corruzione, la speculazione e il clientelismo mentre
prestiti sempre crescenti venivano richiesti sui mercati alimentando la spirale
del debito pubblico. Fu così l’Italia si configurò, fin dall’inizio, la
“cleptocrazia” cioè il governo basato sul malaffare.
Ma la vera grande protagonista
dell’unità d’Italia fu la massoneria: il Grande Oriente d’Italia sorse
ufficialmente come estensione della Loggia Ausonia, fondata nel 1859 a Torino
con la benedizione di Cavour. Vi entrarono in massa personaggi che occupavano
posizioni sociali di rilievo ed erano incredibilmente ardenti patrioti. Fu
quindi la massoneria a selezionare la borghesia compradora in Italia, che
sostituì gli amministratori e gli sbirri austriaci e assorbì al proprio interno
quelli borbonici. In una continuità, assicurata dalla massoneria, nella
trasmissione del potere da una generazione all’altra, attraverso i meccanismi
ben noti del nepotismo, della raccomandazione e della corruzione. È l’Ordine che
garantisce l’impunità della casta al potere, controllando contemporaneamente il
potere legislativo, esecutivo e giudiziario, mettendo in relazione il magistrato
col il malavitoso, il politico corrotto col faccendiere corruttore, l’élite
italiane e con quelle straniere. Tutto ciò si palesa chiaramente nella storia di
Adriano Lemmi, il “banchiere del Risorgimento”, Gran Maestro della Massoneria
negli anni tra il 1885 e il 1896. Egli fu il punto di congiunzione tra il mondo
dell’alta finanza e la borghesia compradora italiana. Lemmi fu l’eminenza grigia
dietro il primo ministro Francesco Crispi, un “33” del Rito Scozzese. Fu Lemmi a
creare una Loggia supersegreta, la Loggia di Propaganda, per nascondere
l’affiliazione massonica dei personaggi più autorevoli e influenti del tempo:
banchieri e uomini politici. (Quando il Venerabile Licio Gelli assurse a
eminenza grigia della Prima Repubblica, non fece altro che ricopiare i metodi di
Lemmi creando la Loggia Propaganda 2). Come ogni borghesia compradora, anche
quella italiana è corrotta, inefficiente e arrogante. Il primo scandalo
dell’Italia unita fu quello delle Ferrovie meridionali, nel quale Lemmi figura
come l’organizzatore di un giro di mazzette che coinvolse faccendieri, uomini
politici e avvocati. Nel 1893 il governo Giolitti cadde a causa dello scandalo
della Banca romana, una truffa colossale di cui Lemmi era il regista. Pure negli
odierni scandali bancari si può leggere, dietro alle collusioni tra politica e
finanza, la lunga mano della massoneria. Poco più di un secolo dopo, la storia
si è ripetuta con lo scandalo della metropolitana di Milano, per il quale il
Presidente del Consiglio Bettino Craxi e altri furono condannati per corruzione.
Possiamo aggiungere che Craxi e Martelli, nel 1981, avevano letteralmente
comprato il Partito Socialista con i soldi messi a disposizione dalla P2 secondo
le dichiarazioni dell’on. Cicchitto. La super-loggia di Gelli fu coinvolta anche
nello scandalo del crack del banco Ambrosiano, al quale va collegata l’uccisione
del banchiere massone Roberto Calvi. Questi fenomeni crimininali si ripetono
periodicamente nella storia italiana proprio a causa del peccato originale della
genesi dell’Italia unita: un’operazione colonialista condotta in nome del grande
capitale, nel quale la massoneria ha giocato un ruolo decisivo.
«Noi massoni? Nessuna
segretezza: abbiamo fatto l’unità d’Italia»,
scrive Simona Musco il 18 Febbraio 2018 su "Il Dubbio". Parla Santi Fedele (Gran
Maestro e storico): “I grillini non hanno la cultura politica per capire quale
sia stato il nostro ruolo”. Non si può più parlare di segretezza, né ignorare
che la storia della massoneria «è legata strettamente» all’unità d’Italia. A
dirlo è Santi Fedele, Gran Maestro aggiunto del Grande Oriente d’Italia nonché
professore ordinario di Storia contemporanea nell’Università di Messina, che
interviene sulla caccia al massone avviata dal Movimento 5 stelle. Una caccia «a
ciò che non si comprende», cavalcando le paure di chi non conosce la massoneria
«a fini elettorali», racconta al Dubbio.
Professore, cosa lega la
massoneria all’unità d’Italia?
«Inizialmente
la massoneria viene messa fuorilegge da tutti i governi degli Stati preunitari
ma è presente attraverso la carboneria, nella quale molti massoni continuano a
operare per l’unità. Ma quello che vorrei sottolineare è il contributo dato al
farsi dello Stato italiano. Ricordiamo la celebre frase di D’Azeglio: fatta
l’Italia, bisogna fare gli italiani. Noi la interpretiamo in termini lamentativi
moralistici, invece era un’esortazione: bisognava creare una coscienza nazionale
tra popolazioni prima divise».
Qual è stato il suo
contributo?
«Ad
esempio l’intitolazione delle strade a Roma risorta, a Garibaldi e così via.
Potrà sembrare banale ma è uno strumento formidabile per veicolare, in una
popolazione quasi totalmente analfabeta, un’identità nazionale. E nei 50 anni
dopo l’unità, i massoni ricoprono il ruolo di ministro della Pubblica
istruzione, con l’obiettivo di sviluppare l’istruzione popolare. Coppino, che
istituisce la scuola elementare obbligatoria e gratuita, era massone e questa
legge è finalizzata all’acculturazione ma anche alla conquista dei diritti
civili. La legge elettorale, agli inizi, è infatti censitaria: votano soltanto
coloro che pagano almeno 40 lire di imposte dirette. Successivamente si aggiunge
il criterio della capacità: può votare colui che sa leggere e scrivere. Chi
frequenta le prime due classi elementari, grazie alla legge Coppino, viene
quindi iscritto nelle liste elettorali. Ciò comporta la formazione di una
coscienza civile».
Qual è stato il periodo più
duro?
«Tra
il 1919 e il 1945. Tutti i regimi totalitari in Europa hanno in comune
l’avversione dichiarata nei confronti della massoneria. Il fascismo lo ha fatto
per due motivi: la soppressione della massoneria è il prezzo richiesto a
Mussolini dalla Chiesa – che non ne tollera l’impronta razionalista – affinché
si pervenga ai patti lateranensi, in secondo luogo uno Stato totalitario
esercita un controllo globale e quindi è inconcepibile l’esistenza di una
società che ha un’attitudine alla riservatezza».
Come si spiega l’avversione
da parte del M5s?
«Non
attribuisco al suo gruppo dirigente una cultura politica tale da poter capire
che la storia della massoneria è legata all’avvio del costituzionalismo moderno.
Si pensa di poter avere dei consensi elettorali sfruttando le paure inconsce,
rievocando la P2, che noi abbiamo combattuto dandoci regole rigide. È un dato
inquietante, ma guardiamo avanti. E non si può più parlare di segretezza, ma
solo di riservatezza, riferita al dato meramente rituale. Ma anche quello,
ormai, è cosa nota».
«Sì, la massoneria ha un
valore storico. Ma è un potere che minaccia lo Stato»,
scrive Simona Musco il 18 Febbraio 2018, su "Il Dubbio". Risponde lo storico
Franco Cardini: «La massoneria dice di non essere più segreta, ma mantiene delle
caratteristiche che vanno contro le istituzioni». Franco Cardini, professore
ordinario di Storia medievale presso l’Università di Firenze, non ha dubbi: la
segretezza della massoneria non è mai venuta meno. E sebbene la caccia al
massone sia una fenomeno strumentale, che verrà superato dopo il 4 marzo, il
problema rimane: «il confine stabilito dalla legge non va superato».
Professore, cos’è la
massoneria?
«È
un’associazione di mutuo soccorso che una volta diventata associazione della
classe dirigente è diventata molto più potente. Di per se stessa è segreta: ci
si entra con una serie di atti liturgici. Con la rivoluzione francese si è
avvicinata alla politica, e durante il Risorgimento molti patrioti sono entrati
nella massoneria, perché avversati dalla Chiesa. E lì si è creato uno scontro
rimasto insanato».
Qual è stato il suo
contributo al Risorgimento?
«La
diffusione di una sorta di religione civile, fondata sulla virtù, sulla lealtà
allo Stato, l’onestà dei cittadini. È una religione civile, non ha un fine
trascendente».
Perché la diffidenza nei
suoi confronti è durata a lungo?
«Perché
è una organizzazione di potere: quando i membri della massoneria entrano nei
governi agiscono perché siano i confratelli ad occupare posti di potere. È un
lavoro di coordinamento di un potere occulto, basato su un patto segreto di
aiuto reciproco tra i collegati. Quindi minaccia anche la stabilità dello Stato».
Perché il M5s cavalca
questa paura?
«Il
M5s riprende una vecchia ipotesi comune anche ad altri partiti: la segretezza.
Oggi i massoni fanno anche i convegni, però c’è una tradizione secondo cui
alcune logge si mantengono coperte, cioè hanno membri che sono segreti, con
elenchi non visibili e cerimonie a porte chiuse. Tutto questo può andare contro
le leggi dello Stato, perché alcuni elementi sfuggono al controllo dello Stato.
Il caso più noto fu quello della P2».
Però fu una degenerazione.
«Sì,
ma chiunque viene colto in fallo può dire che è stato un malinteso. È una linea
di difesa che può anche essere presa per buona. Ma è una posizione apologetica
che apre la strada anche a precedenti importanti».
Cosa rinnova la paura nei
confronti delle logge?
«Ogni
tanto viene fuori qualche scandalo legato a questo o quel gruppo massonico e
allora tornano le vecchie questioni, ma è un po’ come le attuali critiche di
ritorno al fascismo. Non bisogna pensare che queste polemiche abbiano un’origine
profonda all’interno dell’opinione pubblica, sono manovrate, sono strategie. È
solo una guerra simbolica tra bande in vista del 4 marzo, dopo il quale saranno
dimenticate».
Ma chiedere l’esclusione di
un massone da un gruppo politico non è antidemocratico?
«Non
sono democratiche organizzazioni che in parte o in tutto sono segrete. Lo scopo
di questa segretezza è favorire personaggi che stanno all’interno del gruppo
stesso. La massoneria ritiene di non essere più un’associazione segreta, ma
conserva quella che chiamano discrezione. C’è una linea sottilissima che la
separa dalla segretezza, che nel nostro codice civile e penale non va
oltrepassata. Ma avviene di fatto, il problema è tutto lì».
Da Garibaldi a John Wayne,
gli iscritti illustri alla massoneria.
Nata per scopi di assistenza, la massoneria nel tempo ha assunto un ruolo
politico e, forte della segretezza, ha avuto anche pagine oscure. Tra i nomi
famosi Garibaldi, Foscolo, Beccaria e Mameli, scrive Cesare Zapperi il 16
febbraio 2018 su "Il Corriere della Sera". Le espulsioni decretate dal Movimento
5 Stelle nei confronti di candidati alle elezioni che si è scoperto essere
iscritti alla massoneria ha portato alla ribalta il tema dell’associazione
segreta che, nata per fini corporativi o mutualistici, è spesso finita al centro
di vicende poco chiare. In Italia viene alla mente subito la loggia P2 di Licio
Gelli e il contorno di scandali e di coinvolgimenti di personaggi illustri dei
mondi della politica, dell’economia e della società. Ma andando indietro nel
tempo, tra gli iscritti alla massoneria (che è un’associazione coperta da
segreto ma non tale da impedire, ex post, di conoscere chi ne ha fatto parte),
ci si imbatte in figure di rilievo, sia in Italia che nel mondo. L’elenco è
lungo: va da Garibaldi a Foscolo, da Cesare Beccaria a John Wayne. Secondo
l’Enciclopedia Treccani, la massoneria «si costituì, a partire dal 17° sec.,
principalmente in Inghilterra e in Scozia, allo scopo di svolgere opera di
assistenza e di beneficenza tra gli associati secondo gli ideali cristiani. Nei
secoli ha subito profonde trasformazioni, assumendo un ruolo culturale e
talvolta politico. Il nome deriva dalle antiche associazioni medievali di
mestiere dei muratori e degli architetti (dal fr. franc-maçon «libero
muratore»), i cui membri si tramandavano segretamente le regole del loro lavoro
perchè nessun altro esterno all’associazione ne venisse a conoscenza». In Italia
«fu sciolta dal regime fascista (1925) perché giudicata un’associazione di
oppositori e i suoi beni furono confiscati. Risorta dopo il 1944, la massoneria
italiana ha vissuto fasi alterne e si è esposta a trame economiche e politiche».
Giuseppe Garibaldi. L’eroe dei
due Mondi è forse il massone più conosciuto della storia. Garibaldi a Montevideo
nel 1844 indossò il primo “grembiulino” ed “ebbe la luce” massonica iniziatica.
Aveva trentasette anni, e la loggia era L’Asil de la Vertud, una loggia
irregolare, emanazione della massoneria brasiliana, non riconosciuta dalle
principali obbedienze massoniche internazionali, quali erano la Gran Loggia
d’Inghilterra e il Grande Oriente di Francia. A Firenze dal 21 al 24 maggio
1864, l’assemblea del Grande Oriente d’Italia elesse gran maestro Giuseppe
Garibaldi; la sua carica durò pochissimo a seguito di disaccordi con gli altri
membri. Diede le dimissioni dalla carica, e rimase gran maestro onorario a vita.
Ugo Foscolo. Anche il poeta
«Dei sepolcri» (1778-1827) è stato associato alla massoneria. Fu iniziato nella
Loggia Reale Amalia Augusta di Brescia e la sua rapida carriera tra le fila
dell’esercito napoleonico si spiega, secondo gli storici, anche con la totale
adesione ai progetti dell’imperatore ed ai suoi ideali profondamente intrisi nel
messaggio massonico. Sulle orme di Foscolo, altri illustri poeti aderirono alla
massoneria. Trai più noti: Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli e Gabriele
D’Annunzio (anche se in questo caso le fonti sono controverse).
Goffredo Mameli. L’autore
dell’inno nazionale (1827-1849), pur giovanissimo, fu protagonista di
innumerevoli iniziative patriottiche (come ad esempio l’esposizione del
tricolore per festeggiare la cacciata da Genova degli Austriaci del 1746) e
venne arruolato nell’esercito di Giuseppe Garibaldi. Fu membro della Gran Loggia
d’Italia.
John Wayne. Anche il celebre
attore americano (1907-1979) si iscrisse all’associazione segreta. La sua scheda
di iscrizione, firmata il 24 giugno 1970 e accettata nella loggia numero 56 di
Phoenix (Arizona) e lo stendardo rosso, su cui è raffigurato un pellerossa a
cavallo, della loggia massonica del Minnesota, una delle prime in America, è
conservata nel Museo italiano di simbologia massonica di Firenze. Ma nel mondo
dello spettacolo massoni furono anche Totò, Stanlio e Ollio, Walt Disney.
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.
Dr. Antonio Giangrande.
Scrittore, sociologo storico, giurista, blogger, youtuber, presidente
dell’Associazione Contro Tutte le Mafie.
"Fatti non foste a viver come
bruti, ma per seguir virtute e canoscenza". Dante, Inferno XXVI
Antonio Giangrande, scrittore, accademico senza
cattedra universitaria di Sociologia Storica, giornalista ed avvocato non
abilitato. "Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere mettiti le mie
scarpe, percorri il cammino che ho percorso io, vivi i miei dolori, i miei
dubbi, le mie risate...vivi gli anni che ho vissuto io e cadi là dove sono
caduto io e rialzati come ho fatto io. Ognuno ha la propria storia. E solo
allora mi potrai giudicare." Luigi Pirandello.
Dapprima ti ignorano. Poi ti
deridono. Poi ti emarginano. Poi ti combattono. Tu sei solo, ma non per sempre.
Loro sono tanti, ma non per sempre. Ed allora sarai vincente, ma solo dopo la
tua morte. I primi a combatterti sono i prossimi parenti ed i compaesani ed
allor "non ragioniam di loro, ma guarda e passa" (Dante Alighieri). “Gesù,
venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva
stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui
il figlio del falegname? E sua madre, non si chiama Maria? E i suoi fratelli,
Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle, non stanno tutte da noi? Da
dove gli vengono allora tutte queste cose?». Ed era per loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in
casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi”. Mt 13,
54-58.
Se si disprezza quello che gli
altri sono e fanno, perché, poi, si è come gli altri e si osteggiano i diversi?
"C’è un’azione
peggiore che quella di togliere il diritto di voto al cittadino e consiste nel
togliergli la voglia di votare.” (R. Sabatier)
«La disperazione più grave che
possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia
inutile» - Corrado Alvaro, Ultimo diario, 1961.
Vivere senza leggere, o senza
sfogliare i libri giusti scritti fuori dal coro o vivere studiando dai saggi
distribuiti dal sistema di potere catto comunista savoiardo nelle scuole e nelle
università, è molto pericoloso. Ciò ti obbliga a credere a quello che dicono gli
altri interessati al Potere e ti conforma alla massa. Allora non vivi da uomo,
ma da marionetta.
Se scrivi e dici la verità con il coraggio che gli
altri non hanno, il risultato non sarà il loro rinsavimento ma l’essere tu
additato come pazzo. Ti scontri sempre con la permalosità di magistrati e
giornalisti e la sornionità degli avvocati avvezzi solo ai loro interessi.
Categorie di saccenti che non ammettono critiche. Se scrivi e sei del
centro-nord Italia, i conterranei diranno: che bel libro, bravo, è uno di noi.
Se scrivi e sei del centro-sud Italia i conterranei diranno: quel libro l’avrei
scritto anch’io, anzi meglio, ma sono solo cazzate. Chi siamo noi? Siamo i
“coglioni” che altri volevano che fossimo o potessimo diventare. Da bambini i
genitori ci educavano secondo i loro canoni, fino a che abbiamo scoperto che era
solo il canone di poveri ignoranti. Da studenti i maestri ci istruivano secondo
il loro pensiero, fino a che abbiamo scoperto che era solo il pensiero di
comunisti arroganti. Prima dell’ABC ci insegnavano “Bella Ciao”. Da credenti i
ministri di culto ci erudivano sulla confessione religiosa secondo il loro
verbo, fino a che abbiamo scoperto che era solo la parola di pedofili o
terroristi. Da lettori e telespettatori l’informazione (la claque del potere) ci
ammaestrava all’odio per il diverso ed a credere di vivere in un paese
democratico, civile ed avanzato, fino a che abbiamo scoperto che si muore di
fame o detenuti in canili umani. Da elettori i legislatori ci imponevano le
leggi secondo il loro diritto, fino a che abbiamo scoperto che erano solo
corrotti, mafiosi e massoni. Ecco, appunto: siamo i “coglioni” che altri
volevano che fossimo o potessimo diventare. E se qualcuno non vuol essere
“coglione” e vuol cambiare le cose, ma non ci riesce, vuol dire che è “coglione”
lui e non lo sa, ovvero è circondato da amici e parenti “coglioni”.
John Keating: Qualunque cosa
si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo. Sono salito sulla
cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da
angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti?
Venite a vedere voi stessi. Coraggio! È proprio quando credete di sapere
qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Carpe diem. Cogliete
l'attimo, ragazzi... Rendete straordinaria la vostra vita!
Gerard Pitts: Cogli la rosa
quando è il momento, che il tempo, lo sai, vola e lo stesso fiore che sboccia
oggi, domani appassirà. John Keating: Non leggiamo e scriviamo poesie perché è
carino: noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana; e
la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono
nobili professioni, necessarie al nostro sostentamento; ma la poesia, la
bellezza, il romanticismo, l'amore, sono queste le cose che ci tengono in vita.
Dal film L'attimo fuggente (Dead Poets Society), film del 1989 diretto da Peter
Weir e con protagonista Robin Williams.
Studiare non significa sapere,
volere non significa potere. Ai problemi non si è capaci di trovare una
soluzione che accontenti tutti, perché una soluzione per tutti non esiste. Alla
fine nessuno è innocente, perché in questa società individualista, violenta e
superficiale tutti sono colpevoli. Io ho preso la mia decisione mentre la
totalità di voi non sa prenderne alcuna (anche nelle cose più semplici). Come
potreste capire cosa è veramente importante nella vita? Non saprete mai se avete
preso la decisione giusta perché non vi siete fidati di voi stessi. Accusate il
sistema, ma il sistema è freddo inesorabile matematico, solo chi è deciso a
raggiungere la riva la raggiungerà. Vi auguro tutto il meglio per la vostra
vita. “Class Enemy”, di Rok Bicek film del 2013.
Dr. Antonio Giangrande. Scrittore, sociologo
storico, giurista, blogger, youtuber, presidente dell’Associazione Contro Tutte
le Mafie, destinatario delle denunce presentate dai magistrati per tacitarlo e
ricevente da tutta Italia di centinaia di migliaia di richieste di aiuto o di
denunce di malefatte delle istituzioni. Ignorato dai media servi del potere.
Come far buon viso a cattivo gioco ed aspettare
che dal fiume appaia il corpo del tuo nemico. "Subisci e taci" ti intima il
Sistema. Non sanno, loro, che la vendetta è un piatto che si gusta freddo. E non
si può perdonare...
Un padre regala al figlio un sacchetto di chiodi.
“Tieni figliolo, ecco un sacchetto di chiodi. Piantane uno nello steccato Ogni
volta che che perdi la pazienza e litighi con qualcuno perchè credi di aver
subito un'ingiustizia” gli dice. Il primo giorno il figlio piantò ben 37 chiodi
ma nelle settimane successive imparò a controllarsi e il numero di chiodi
cominciò piano piano a diminuire. Aveva infatti scoperto che era molto più
facile controllarsi che piantare chiodi e così arrivò un giorno in cui non ne
piantò nemmeno uno. Andò quindi dal padre e gli disse che per quel giorno non
aveva litigato con nessuno, pur essendo stato vittima d'ingiustizie e di
soprusi, e non aveva piantato alcun chiodo. Il padre allora gli disse:
“Benissimo figliolo, ora leva un chiodo dallo steccato per ogni giorno in cui
non hai perso la pazienza e litigato con qualcuno”. Il figlio ascoltò e tornò
dal padre dopo qualche giorno, comunicandogli che aveva tolto tutti i chiodi
dallo steccato e che non aveva mai più perso la pazienza. Il padre lo portò
quindi davanti allo steccato e guardandolo gli disse: “Figliolo, ti sei
comportato davvero bene. Bravo. Ma li vedi tutti quei buchi? Lo steccato non
potrà più tornare come era prima. Quando litighi con qualcuno, o quando questi
ha usato violenza fisica o psicologica nei tuoi confronti, rimane una ferita
come questi buchi nello steccato. Tu puoi piantare un coltello in un uomo e poi
levarlo, e lo stesso può fare questi con te, ma rimarrà sempre una ferita. E non
importa quante volte ti scuserai, o lui lo farà con te, la ferita sarà sempre
lì. Una ferita verbale è come il chiodo nello steccato e fa male quanto una
ferita fisica. Lo steccato non sarà mai più come prima. Quando dici le cose in
preda alla rabbia, o quando altri ti fanno del male, si lasciano delle ferite
come queste: come i buchi nello steccato. Possono essere molto profonde. Alcune
si rimarginano in fretta, altre invece, potrebbero non rimarginare mai, per
quanto si possa esserne dispiaciuti e si abbia chiesto scusa".
Io non reagisco, ma mi si permetta di raccontare
l'accaduto. Voglio far conoscere la verità sui chiodi piantati nelle nostre
carni.
La mia esperienza e la mia competenza mi portano a
pormi delle domande sulle vicende della vita presente e passata e sul perché del
ripetersi di eventi provati essere dannosi all’umanità, ossia i corsi e i
ricorsi storici. Gianbattista Vico, il noto filosofo napoletano vissuto fra il
XVII e XVIII secolo elaborò una teoria, appunto dei corsi e ricorsi storici.
Egli era convinto che la storia fosse caratterizzata dal continuo e incessante
ripetersi di tre cicli distinti: l’età primitiva e divina, l’età poetica ed
eroica, l’età civile e veramente umana. Il continuo ripetersi di
questi cicli non avveniva per caso ma era predeterminato e regolamentato, se
così si può dire, dalla provvidenza. Questa formulazione di pensiero è
comunemente nota come “teoria dei corsi e dei ricorsi storici”. In parole
povere, tanto per non essere troppo criptici, il Vico sosteneva che alcuni
accadimenti si ripetevano con le medesime modalità, anche a distanza di tanto
tempo; e ciò avveniva non per puro caso ma in base ad un preciso disegno stilato
della divina provvidenza.” Io sono convinto, invece, che l’umanità dimentica e
tende a sbagliare indotta dalla stupidità e dall’egoismo di soddisfare in ogni
modo totalmente i propri bisogni in tempi e spazi con risorse limitate. Trovare
il perché delle discrepanze dell’ovvio raccontato. Alle mie domando non mi do io
stesso delle risposte. Le risposte le raccolgo da chi sento essere migliore di
me e comunque tra coloro contrapposti con le loro idee sullo stesso tema da cui
estrapolare il sunto significativo. Tutti coloro che scrivono, raccontano il
fatto secondo il loro modo di vedere e lo ergono a verità. Ergo: stesso fatto,
tanti scrittori, quindi, tanti fatti diversi. La mia unicità e peculiarità, con
la credibilità e l’ostracismo che ne discende, sta nel raccontare quel fatto in
un’unica sede e riportando i vari punti di vista. In questo modo svelo le
mistificazioni e lascio solo al lettore l’arbitrio di trarne la verità da quei
dati.
Voglio conoscere gli effetti, sì, ma anche le
cause degli accadimenti: il post e l’ante. La prospettiva e la retrospettiva con
varie angolazioni. Affrontare le tre dimensioni spaziali e la quarta dimensione
temporale.
Si può competere con l’intelligenza, mai con
l’idiozia. L’intelligenza ascolta, comprende e pur non condividendo rispetta.
L’idiozia si dimena nell’Ego, pretende ragione non ascoltando le ragioni altrui
e non guarda oltre la sua convinzione dettata dall’ignoranza. L’idiozia non
conosce rispetto, se non pretenderlo per se stessa.
Quando fai qualcosa hai tutti contro: quelli che
volevano fare la stessa cosa, senza riuscirci, impediti da viltà, incapacità,
ignavia; quelli che volevano fare il contrario; e quelli, ossia la stragrande
maggioranza, che non volevano fare niente.
Certe persone non sono importanti, siamo noi che,
sbagliando, gli diamo importanza. E poi ci sono quelle persone che non servono
ad un cazzo, non fanno un cazzo e si credono sto cazzo.
Correggi un sapiente ed esso diventerà più colto.
Correggi un ignorante ed esso diventerà un tuo acerrimo nemico.
Molti non ti odiano perché gli hai fatto del male,
ma perché sei migliore di loro.
Più stupido di chi ti giudica senza sapere nulla
di te è colui il quale ti giudica per quello che gli altri dicono di te. Perché
le grandi menti parlano di idee; le menti medie parlano di fatti; le infime
menti parlano solo male delle persone.
E’ importante stare a posto con la propria
coscienza, che è molto più importante della propria reputazione. La tua
coscienza sei tu, la reputazione è ciò che gli altri pensano di te e quello che
gli altri pensano di te è un problema loro.
Le bugie sono create dagli invidiosi, ripetute dai
cretini e credute dagli idioti, perché un grammo di comportamento esemplare,
vale un quintale di parole. Le menti mediocri condannano sempre ciò che non
riescono a capire.
E se la strada è in salita, è solo perché sei
destinato ad attivare in alto.
Ci sono persone per indole nate per lavorare e/o
combattere. Da loro ci si aspetta tanto ed ai risultati non corrispondono elogi.
Ci sono persone nate per oziare. Da loro non ci si aspetta niente. Se fanno poco
sono sommersi di complimenti. Guai ad aspettare le lodi del mondo. Il mondo è un
cattivo pagatore e quando paga lo fa sempre con l’ingratitudine.
Il ciclo vitale biologico della natura afferma che
si nasce, si cresce, ci si riproduce, si invecchia e si muore e l’evoluzione fa
vincere i migliori. Solo a noi umani è dato dare un senso alla propria vita.
Ergo. Ai miei figli ho insegnato:
Le ideologie, le confessioni, le massonerie vi
vogliono ignoranti;
Le mafie, le lobbies e le caste vi vogliono
assoggettati;
Le banche vi vogliono falliti;
La burocrazia vi vuole sottomessi;
La giustizia vi vuole prigionieri;
Siete nati originali…non morite fotocopia.
Siate liberi. Studiare, ma non fermarsi alla
cultura omologata. La conoscenza è l'arma migliore per vincere.
Antonio Giangrande,
orgoglioso di essere diverso.
Se si è omologati (uguali)
o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi
nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
In un mondo caposotto
(sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli
ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono
l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I
nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è?
Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.
Dove si sentono alti anche
i nani e dove anche i marescialli si sentono generali, non conta quanti passi
fai e quali scarpe indossi, ma conta quante tracce lasci del tuo percorso.
Il difetto degli
intelligenti è che sono spinti a cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio
degli ignoranti è che non hanno dubbi e qualora li avessero sono convinti di
avere già le risposte.
Un popolo di “coglioni”
sarà sempre governato ed amministrato da “coglioni”.
Un chierico medievale si
imbatté in un groviglio di serpi su cui spiccava un ramarro che già da solo
sarebbe bastato a spaventarlo. Tuttavia, confrontata a quelle serpeggianti
creature, la bestiola gli parve graziosa ed esclamò: «Beati monoculi in terra
caecorum», nella terra dei ciechi anche l’orbo è re.
Il ciclo vitale, in biologia,
è l'intervallo tra il susseguirsi di generazioni di una specie. L'esistenza di
ogni organismo si svolge secondo una sequenza ciclica di stadi ed eventi
biologici, caratterizzata in base alla specie di appartenenza. Queste sequenze
costituiscono i cosiddetti Cicli Biologici. Ogni essere vivente segue un ciclo
vitale biologico composto dai seguenti stadi: nascita, crescita, riproduzione,
senescenza e morte. Per quanto possa essere breve o corta la vita, nessun essere
vivente preso singolarmente è immortale. Ma la sua specie diventa immortale
attraverso la riproduzione e l'evoluzione. Gli esseri viventi si evolvono nel
corso del tempo per potersi meglio adattare alla natura che li circonda.
Attraverso la riproduzione le generazioni trasmettono i propri geni a quelle
future. Durante questo passaggio le nuove generazioni possono assumere
caratteristiche nuove o perderne alcune. Le differenze si traducono in vantaggi
o in handicap per chi le possiede, agendo direttamente sul processo evolutivo
tramite la selezione naturale degli individui. Le nuove caratteristiche che
agevolano l'adattamento all'ambiente offrono all'individuo maggiori probabilità
di sopravvivenza e, quindi, di riproduzione. E' innaturale non riprodursi. Senza
riproduzione non vi è proseguimento ed evoluzione della specie. Senza
riproduzione il ciclo vitale biologico cessa. Ciò ci rende mortali. Parlare in
termini scientifici dell'eterosessualità e del parto, quindi di stati naturali,
fa di me un omofobo ed un contrabortista, quindi un non-comunista? Cercare di
informare i simili contro la deriva involutiva, fa di me un mitomane o pazzo?
Noi siamo quello che altri
hanno voluto che diventassimo. Quando esprimiamo giudizi gratuiti, cattivi ed
illogici lo facciamo con la nostra bocca ma inconsapevolmente per volontà di
altri. Lo facciamo in virtù di quanto ricevuto: dall’educazione familiare,
dall’istruzione di regime, dall’indottrinamento politico e religioso,
dall’influenza mediatica. Niente è farina del nostro sacco. Se ci basassimo solo
sulle nostre esperienze staremmo solo zitti, sapendo che nessuno sarebbe capace
e disposto ad ascoltarci.
E’ comodo definirsi scrittori
da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere
“C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di
scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri
scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale.
Da sempre diffido di chi,
vestito da lupo, è pecora genuflessa alla magistratura. I saccenti
giustizialisti dei 5 stelle che provino a proporre la figura del difensore
civico giudiziario con poteri di magistrato, senza essere uno di loro, per poter
metter le mani nelle carte dei fascicoli e poterle sparigliare. Io da anni mi
batto inascoltato per questo. I signori dei 5 stelle non si degnano nemmeno di
rispondere ai messaggi degli esperti: tanto san tutto loro. A sbraitare son
bravi, ma a proporre leggi sensate, mi sa che non son capaci. Parlan solo di
soldi, soldi, soldi ed onestà, certificata dai loro magistrati, e mai parlano di
libertà ed opportunità senza concorsi ed esami pubblici truccati.
Ad ogni azione umana nefasta
si trova sempre una giustificazione...lo si fa per le piante...lo si fa per gli
animali...lo si fa per le persone! Ma, alla fine, rimane solo un'azione nefasta
che fa male al prossimo...e, spesso, il prossimo siamo noi. A parte il partito
preso, noi siamo tutti responsabili delle azioni nefaste di uno, quando gli
permettiamo di farle.
Parlare nei miei libri del
caso singolo del semplice cittadino significa incorrere nell’accusa di
mitomania, pazzia o calunnia, oltre che nel disinteresse. Invece parlo di loro,
delle istituzioni che delinquono impunite. Parlo della vera mafia. Cosa posso
dire di più di quello che ho scritto e che altri non dicono? Credo che quanto
divulgato possa essere di grande soddisfazione per le vittime, non potendo avere
altro che quella in questa Italia con italiani di merda a cui interessa solo di
loro stessi e se ne fottono degli altri.
Alle sentenze irrevocabili di
proscioglimento del Tribunale di Taranto a carico del dr Antonio Giangrande, già
di competenza della dr.ssa Rita Romano, giudice di Taranto poi ricusata perché
denunciata, si aggiunge il verbale di udienza dell’11 dicembre 2015 della causa
n. 987/09 (1832/07 RGNR) del Tribunale di Potenza, competente su fatti attinenti
i magistrati di Taranto, con il quale si dispone la perfezione della fattispecie
estintiva del processo per remissione della querela nei confronti del dr Antonio
Giangrande da parte del dr. Alessio Coccioli, già Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Taranto, poi trasferito alla Direzione
Distrettuale Antimafia di Lecce. Remissione della querela volontaria, libera e
non condizionata da alcun atto risarcitorio.
Il Dr Antonio Giangrande era
inputato per il reato previsto e punito dall’art. 595 3° comma c.p.
“perchè inviando una missiva a sua firma alla testata
giornalistica La Gazzetta del Sud Africa e pubblicata sui siti internet
lagazzettadelsudafrica.net, malagiustizia.eu, e
associazionecontrotuttelemafie.org, offendeva l’onore ed il decoro del dr.
Alessio Coccioli, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Taranto, riportando in detto su scritto la seguente frase: “…il PM Alessio
Coccioli, inopportunamente delegando i carabinieri di Manduria, quali PG, ha
reso lecito tale modus operandi (non rilasciare attestato di ricezione da parte
dell’Ufficio Protocollo del Comune di Manduria ndr), motivandolo dal fatto che
non è dannoso per il denunciante. Invece in denuncia si è fatto notare che tale
usanza di recepimento degli atti, prettamente manduriana, può nascondere
alterazioni procedurali in ambito concorsuale e certamente abusi a danno dei
cittadini. Lo stesso PM Alessio Coccioli, inopportunamente delegando i
carabinieri di Manduria, quali PG, per la colleganza con il comandante dei
Vigili Urbani di Manduria, ha ritenuto le propalazioni del Giangrande, circa il
concorso per Comandante dei Vigili Urbani, ritenuto truccato (perché il medesimo
aveva partecipato e vinto in un concorso da egli stesso indetto e regolato in
qualità di comandante pro tempore e dirigente dell’ufficio del personale), sono
frutto di sue convinzioni non supportate da riscontri di natura obbiettiva e
facendo conseguire tali riferimenti, al predetto dr. Coccioli, ad altre
notazioni, contenute nello stesso scritto, nelle quali si denunciavano
insabbiamenti, o poche richieste di archiviazioni strumentali attribuite ai
magistrati della Procura della Repubblica di Taranto”.
Il Processo di Potenza, come i
processi tenuti a Taranto, sono attinenti a reati di opinione. Lo stesso dr.
Alessio Coccioli, una volta trasferito a Lecce, ha ritenuto che le opinioni
espresse dal Dr Antonio Giangrande riguardo la Giustizia a Taranto non potessero
continuare ad essere perseguite.
Ultimo atto. Esame di Avvocato 2015. A Lecce uno
su quattro ce l’ha fatta. Sono partiti in 1.108: la prova scritta è stata
passata da 275 praticanti. Preso atto.....
All'attenzione dell'avv. Francesco De Jaco.
Illustre avv. Francesco De Jaco, in qualità di Presidente della Commissione di
Esame di Avvocato 2014-2015, chi le scrive è il dr Antonio Giangrande. E’ quel
signore, attempato per i suoi 52 anni e ormai fuori luogo in mezzo ai giovani
candidati, che in sede di esame le chiese, inopinatamente ed invano, Tutela.
Tutela, non raccomandazione. Così come nel 2002 fu fatto inutilmente con l’avv.
Luigi Rella, presidente di commissione e degli avvocati di Lecce. Tutela perché
quel signore il suo futuro lo ha sprecato nel suo passato. Ostinatamente nel
voler diventare avvocato ha perso le migliori occasioni che la vita possa dare.
Aspettava come tutti che una abilitazione, alla mediocrità come è l’esame
forense truccato, potesse, prima o poi, premiare anche lui. Pecori e porci sì,
lui no! Quel signore ha aspettato ben 17 anni per, finalmente, dire basta.
Gridare allo scandalo per un esame di Stato irregolare non si può. Gridare al
complotto contro la persona…e chi gli crede. Eppure a Lecce c’è qualcuno che
dice: “quello lì, l’avvocato non lo deve fare”. Qualcuno che da 17 anni,
infastidito dal mio legittimo operato anche contro i magistrati, ha i tentacoli
tanto lunghi da arrivare ovunque per potermi nuocere. Chi afferma ciò è colui il
quale dimostra con i fatti nei suoi libri, ciò che, agli ignoranti o a chi è in
mala fede, pare frutto di mitomania o pazzia. Guardi, la sua presidenza, in sede
di scritto, è stata la migliore tra le 17 da me conosciute. Purtroppo, però, in
quel di Brescia quel che si temeva si è confermato. Brescia, dove, addirittura,
l’ex Ministro Mariastella Gelmini chiese scampo, rifugiandosi a Reggio Calabria
per poter diventare avvocato. Il mio risultato delle prove fa sì che chiuda la
fase della mia vita di aspirazione forense in bruttezza. 18, 18, 20. Mai
risultato fu più nefasto e, credo, immeritato e punitivo. Sicuro, però, che tale
giudizio non è solo farina del sacco della Commissione di esame di Brescia. Lo
zampino di qualche leccese c’è! Avvocato… o magistrato… o entrambi…: chissà? Non
la tedio oltre. Ho tentato di trovare Tutela, non l’ho trovata. Forse chiedevo
troppo. Marcire in carcere da innocente o pagare fio in termini professionali,
credo che convenga la seconda ipotesi. Questo è quel che pago nel mettermi
contro i poteri forti istituzionali, che io chiamo mafiosi. Avvocato, grazie per
il tempo che mi ha dedicato. Le tolgo il disturbo e, nel caso l’importasse, non
si meravigli, se, in occasione di incontri pubblici, se e quando ci saranno, la
priverò del mio saluto. Con ossequi.
Avetrana lì 26 giugno 2015. Dr Antonio Giangrande,
scrittore per necessità.
I mediocri del Politically Correct negano sempre
il merito. Sostituiscono sempre la qualità con la quantità. Ma è la qualità che
muove il mondo, cari miei, non la quantità. Il mondo va avanti grazie ai pochi
che hanno qualità, che valgono, che rendono, non grazie a voi che siete tanti e
scemi. La forza della ragione (Oriana Fallaci)
“L'Italia tenuta al
guinzaglio da un sistema di potere composto da caste, lobbies, mafie e
massonerie: un'Italia che deve subire e deve tacere.
La “Politica” deve
essere legislazione o amministrazione nell’eterogenea rappresentanza
d’interessi, invece è meretricio o mendicio, mentre le “Istituzioni” devono
meritarlo il rispetto, non pretenderlo. Il rapporto tra cittadini e il rapporto
tra cittadini e Stato è regolato dalla forza della legge. Quando non vi è
cogenza di legge, vige la legge del più forte e il debole soccombe. Allora uno
“Stato di Diritto” degrada in anarchia. In questo caso è palese la
responsabilità politica ed istituzionale per incapacità o per collusione. Così
come è palese la responsabilità dei media per omertà e dei cittadini per
codardia o emulazione."
TIRANNIDE indistintamente appellare si
debbe ogni qualunque governo, in cui chi è preposto alla esecuzion delle leggi,
può farle, distruggerle, infrangerle, interpretarle, impedirle, sospenderle; od
anche soltanto deluderle, con sicurezza d'impunità. E quindi, o questo
infrangi-legge sia ereditario, o sia elettivo; usurpatore, o legittimo; buono, o
tristo; uno, o molti; a ogni modo, chiunque ha una forza effettiva, che basti a
ciò fare, è tiranno; ogni società, che lo ammette, è tirannide; ogni popolo, che
lo sopporta, è schiavo. Vittorio Alfieri (1790).
"Quando si cerca di far progredire la
conoscenza e l'intelligenza umana si incontra sempre la resistenza dei
contemporanei, simile a un fardello che bisogna trascinare e che grava
pesantemente al suolo, ribelle ad ogni sforzo. Ci si deve consolare allora con
la certezza che, se i pregiudizi sono contro di noi, abbiamo con noi la Verità,
la quale, dopo essersi unita al suo alleato, il Tempo, è pienamente certa della
sua vittoria, se non proprio oggi, sicuramente domani."(Arthur Schopenhauer)
Il pregio di essere un
autodidatta è quello che nessuno gli inculcherà forzosamente della merda
ideologica nel suo cervello. Il difetto di essere un autodidatta è quello di
smerdarsi da solo.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo con la discultura e la disinformazione. Ci si deve chiedere: perchè
a scuola ci hanno fatto credere con i libri di testo che Garibaldi era un eroe
ed i piemontesi dei salvatori; perché i media coltivano il luogo comune di un
sud Italia cafone ed ignorante; perché la prima cosa che insegnano a scuola è la
canzone “bella ciao”? Per poi scoprire da adulti e solo tramite il web: che il
Sud Italia è stato depredato a causa proprio di Garibaldi a vantaggio dei
Piemontesi; che solo i turisti che scendono a frotte nel meridione d’Italia
scoprono quanto ci sia tanto da conoscere ed apprezzare, oltre che da amare; che
“Bella ciao” è solo l’inno di una parte della politica italiana che in nome di
una ideologia prima tradì l’Italia e poi, con l’aiuto degli americani, vinse la
guerra civile infierendo sui vinti, sottomettendoli, con le sue leggi, ad un
regime illiberale e clericale.
Ad Avetrana, il paese di Sarah Scazzi, non sono
omertosi, sempre che non si tratti di poteri forti. Ma qualcuno certamente
vigliacco e codardo lo è. Sapendo che io ho le palle per denunciare le
illegalità, questi deficienti usano il mio nome ed appongono falsamente la mia
firma in calce a degli esposti che colpiscono i poveri cristi rei di abusi
edilizi o commerciali. I cretini, che poi fanno carriera politica, non sanno che
i destinatari dei miei strali sono magistrati, avvocati, forze dell’ordine, e
comunque pubblici ufficiali o esercenti un pubblico servizio. Che poi queste
denunce finiscono nell’oblio perché “cane non mangia cane” e per farmi passare
per mitomane o pazzo o calunniatore o diffamatore, è un’altra cosa. Però da
parte di questi coglioni prendersela con i poveri cristi per poi far addossare
la colpa a me ed essere oggetto di ritorsioni ingiustificate è da veri
vigliacchi. D'altronde un paese di coglioni sarà sempre governato, amministrato,
giudicato da coglioni.
È molto meglio osare cose straordinarie, vincere
gloriosi trionfi, anche se screziati dall'insuccesso, piuttosto che schierarsi
tra quei poveri di spirito che non provano grandi gioie né grandi dolori, perché
vivono nel grigio e indistinto crepuscolo che non conosce né vittorie né
sconfitte. (...) Non è il critico che conta, né l'individuo che indica come
l'uomo forte inciampi, o come avrebbe potuto compiere meglio un'azione. L'onore
spetta all'uomo che realmente sta nell'arena, il cui viso è segnato dalla
polvere, dal sudore, dal sangue; che lotta con coraggio; che sbaglia
ripetutamente, perchè non c'è tentativo senza errori e manchevolezze; che lotta
effettivamente per raggiungere l'obiettivo; che conosce il grande entusiasmo, la
grande dedizione, che si spende per una giusta causa; che nella migliore delle
ipotesi conosce alla fine il trionfo delle grandi conquiste e che, nella
peggiore delle ipotesi, se fallisce, almeno cade sapendo di aver osato
abbastanza. Dunque il suo posto non sarà mai accanto a quelle anime timide che
non conoscono né la vittoria, né la sconfitta. Franklin Delano Roosevelt
Cari signori, io ho iniziato a destare le
coscienze 20 anni prima di Beppe Grillo e nulla è successo. Io non cercavo gli
onesti, ma le vittime del sistema, per creare una rivoluzione culturale…ma un
popolo di “coglioni” sarà sempre governato ed amministrato da “coglioni”.
"Il popolo cornuto era e cornuto resta: la
differenza è che il fascismo appendeva una bandiera sola alle corna del popolo e
la democrazia lascia che ognuno se l'appenda da sé, del colore che gli piace,
alle proprie corna... Siamo al discorso di prima: non ci sono soltanto certi
uomini a nascere cornuti, ci sono anche popoli interi; cornuti dall'antichità,
una generazione appresso all'altra...- Io non mi sento cornuto - disse il
giovane - e nemmeno io. Ma noi, caro mio, camminiamo sulle corna degli altri:
come se ballassimo..." Leonardo Sciascia dal libro "Il giorno della civetta".
Un chierico medievale si imbatté in un groviglio
di serpi su cui spiccava un ramarro che già da solo sarebbe bastato a
spaventarlo. Tuttavia, confrontata a quelle serpeggianti creature, la bestiola
gli parve graziosa ed esclamò: «Beati monoculi in terra caecorum», nella terra
dei ciechi anche l’orbo è re.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Quando esprimiamo giudizi gratuiti, cattivi ed illogici lo
facciamo con la nostra bocca ma inconsapevolmente per volontà di altri. Lo
facciamo in virtù di quanto ricevuto: dall’educazione familiare, dall’istruzione
di regime, dall’indottrinamento politico e religioso, dall’influenza mediatica.
Niente è farina del nostro sacco. Se ci basassimo solo sulle nostre esperienze
staremmo solo zitti, sapendo che nessuno sarebbe capace e disposto ad
ascoltarci.
In una Italia dove nulla è come sembra, chi
giudica chi è onesto e chi no?
Lo hanno fatto i comunisti, i dipietristi, i
leghisti, i pentastellati. Lor signori si son dimostrati peggio degli altri e
comunque servitori dei magistrati. E se poi son questi magistrati a decidere chi
è onesto e chi no, allora se tutti stanno dalla parte della ragione, io mi metto
dalla parte del torto.
Ognuno di noi, anziché migliorarsi, si giova
delle disgrazie altrui. Non pensando che a cercar l’uomo onesto con il
lanternino si perde la ragione. Ma anche a cercarlo con la lanterna di Diogene
si perde la retta via. Diogene di Sinope (in greco antico Διογένης Dioghénes)
detto il Cinico o il Socrate pazzo (Sinope, 412 a.C. circa – Corinto, 10
giugno 323 a.C.) è stato un filosofo greco antico. Considerato uno dei fondatori
della scuola cinica insieme al suo maestro Antistene, secondo l'antico
storico Diogene Laerzio, perì nel medesimo giorno in cui Alessandro Magno spirò
a Babilonia. «[Alessandro Magno] si fece appresso a Diogene, andandosi a mettere
tra lui e il sole. "Io sono Alessandro, il gran re", disse. E a sua volta
Diogene: "Ed io sono Diogene, il cane". Alessandro rimase stupito e chiese
perché si dicesse cane. Diogene gli rispose: "Faccio le feste a chi mi dà
qualcosa, abbaio contro chi non dà niente e mordo i ribaldi."» (Diogene
Laerzio, Vite dei filosofi, Vita di Diogene il Cinico, VI 60). Diogene aveva
scelto di comportarsi, dunque, come "critico" pubblico: la sua missione era
quella di dimostrare ai Greci che la civiltà è regressiva e di dimostrare con
l'esempio che la saggezza e la felicità appartengono all'uomo che è indipendente
dalla società. Diogene si fece beffe non solo della famiglia e dell'ordine
politico e sociale, ma anche delle idee sulla proprietà e sulla buona
reputazione. Una volta uscì con una lanterna di giorno. Questi non indossava una
tunica. Portava come solo vestito un barile ed aveva in mano una lanterna.
"Diogene! - esclamo Socrate - con quale nonsenso tenterai di ingannarci oggi?
Sei sempre alla ricerca, con questa lanterna, di un uomo onesto? Non hai ancora
notato tutti quei buchi nel tuo barile?". Diogene rispose: "Non esiste una
verità oggettiva sul senso della vita". A chi gli chiedeva il senso della
lanterna lui rispondeva: "cerco l'uomo!". “... (Diogene) voleva significare
appunto questo: cerco l’uomo che vive secondo la sua più autentica natura, cerco
l’uomo che, aldilà di tutte le esteriorità, le convenzioni o le regole imposte
dalla società e aldilà dello stesso capriccio della sorte e della fortuna,
ritrova la sua genuina natura, vive conformemente a essa e così è felice."
TINA ANSELMI ED AGOSTINO CORDOVA: I PASIONARI
CONTRO LA MASSONERIA DEVIATA.
Addio Tina Anselmi, la donna che fece
tremare i piccoli uomini del potere. Persona di
eccezionale coraggio e di straordinaria normalità, si è scontrata contro i
poteri occulti che negli anni Settanta avevano invaso le istituzioni. Per l'ex
partigiana una sfida più rischiosa di quella con il fascismo, scrive Marco
Damilano l'1 novembre 2016 su "L'Espresso". Non l'avevano mai dimenticata. I
vertici del Paese, colpevolmente, sì. Loro, Licio Gelli e i suoi amici, no. Non
la dimenticavano e la odiavano come la loro peggiore nemica. Lo si capì nel 2004
quando il ministero delle Pari Opportunità commissionò a Pialuisa Bianco un
dizionario biografico delle donne italiane. Alla voce Anselmi Tina si leggevano
parole come queste: «Moralismo giacobino, istinto punitivo... I 120 volumi degli
atti della Commissione, che stroncò Licio Gelli e i suoi amici, gli
interminabili fogli dell'Anselmi's list, infatti, cacciavano streghe e
acchiappavano fantasmi». E ancora: «improbabile guerriera. Furbizia contadina».
Così un governo aveva ben pensato di ricordare la prima donna ad aver occupato
l'incarico di ministro in Italia. Ad aver commissionato il testo era stata la
responsabile delle Pari Opportunità Stefania Prestigiacomo. Il presidente del
Consiglio era quel Silvio Berlusconi che faceva parte degli «amici di Gelli»,
tessera numero 1816 della loggia massonica P2, gruppo 17, settore editoria. Non
avevano mai dimenticato lei e i quasi tre anni, dall'ottobre 1981 al maggio
1984, in cui Tina Anselmi aveva presieduto la Commissione parlamentare di
inchiesta sulla P2. Una sfilata ininterrotta di ministri, generali,
ambasciatori, segretari di partito, direttori di giornale, banchieri,
magistrati. Si giustificavano: «Enrico Manca: nel 1980 il 4 aprile entro come
ministro del Commercio estero nel governo Cossiga. A fine aprile conosco Gelli a
un ricevimento all'ambasciata argentina. Visita di Maurizio Costanzo, che disse
di essere massone, e a nome di Gelli mi chiese se ero disponibile a aderire alla
massoneria. Quando mi vidi negli elenchi di Gelli telefonai a Costanzo, ma
questi mi confermò di aver telefonato a Gelli la non disponibilità...».
«Bisignani (Luigi) pagato da Gelli, è ancora in rapporto con Gelli...».
Apparivano untuosi, viscidi come il loro capo, di fronte a quella donna che li
interrogava. Non fu solo la prima donna a diventare ministro, ma soprattutto una
grande artefice del welfare italiano. Cercò di fare luce sula P2 e anche per
questo poi fu emarginata. Aveva tutte le doti per diventare presidente, ma
quando ci fu la possibilità il centrosinistra non ebbe il coraggio di mandarla
al Quirinale e le preferì Napolitano. Una donna contro i poteri occulti che
negli anni Settanta avevano invaso le istituzioni come cellule tumorali che
avvelenano un corpo sano. Di eccezionale coraggio. E di straordinaria normalità.
«Tina, nome di battaglia Gabriella, anni diciassette, giovane, come tante, nella
Resistenza. Non ho mai pensato che noi ragazze e ragazzi che scegliemmo di
batterci contro il nazifascismo fossimo eccezionali, ed è questo che vorrei
raccontare: la nostra normalità....». Comincia così la sua autobiografia,
"Storia di una passione politica" (Sperling & Kupfer), curata da Anna Vinci e
pubblicata dieci anni fa. Una ragazzona del profondo Veneto, campionessa di
giavellotto e pallacanestro a livello regionale, «in un tempo in cui lo sport
era un'attività prevalentemente maschile», a 17 anni era entrata nella
Resistenza dopo un colloquio con un'amica che aveva il fidanzato partigiano,
«una ragazzina passata direttamente dalla vita in famiglia alla lotta armata».
Aveva scelto il nome Gabriella come l'arcangelo Gabriele, il messaggero
dell'annunciazione: staffetta partigiana, cento chilometri al giorno in
bicicletta, la fame e la paura. Non aveva mai dismesso l'abito della resistente.
Neppure quando, dopo la guerra, aveva cominciato a praticare un altro sport
tutto maschile, la politica. Militante dell'Azione cattolica, amica e discepola
di Aldo Moro, l'unica ammessa dalla famiglia in casa durante i 55 giorni del
sequestro del leader dc, eletta deputata nel 1968, prima donna a essere nominata
ministro, nel 1976, a 49 anni, nel terzo governo Andreotti, ministro del Lavoro
e poi ministro della Sanità. Una donna in politica che portava uno spirito
inedito nelle stanze del governo: spiritosa, anti-retorica, il contrario esatto
di certi successivi modelli narcisisti e tutti auto-riferiti, una che di sé
scriveva, con semplicità: «La ventata di leggerezza che nella mia infanzia ha
spazzato tante volte via la malinconia mi accompagnerà fino alla fine, e avrà
sempre per me l'odore del cocomero di nonna Maria e del panetto con l'uva di
nonno Ferruccio». Ingenua, eppure consapevole di tutte le sottigliezze della
politica. Esponente di quella generazione che aveva ricostruito l'Italia e che
alla politica attribuiva primato e nobiltà, non in nome di una parte ma di
tutti. Quando nel 1981 il Parlamento votò l'istituzione di una commissione di
inchiesta sulla loggia di Gelli sembrava destinata a una luminosa seconda parte
della carriera politica nelle istituzioni: presidente della Camera o del Senato.
Invece il suo sì alla richiesta di guidare la commissione, arrivata da Nilde
Iotti presidente della Camera, le cambiò la vita. L'incontro e lo scontro con il
volto oscuro del potere. Quella coltre di mistero, fango, sporcizia, ricatto che
inquinava, e inquina ancora, la vita pubblica italiana. Per l'ex partigiana una
sfida più rischiosa di quella con il fascismo perché più sottile, con le parti
in gioco non dichiarate. La Anselmi ha raccontato giorno per giorno quegli anni
nelle pagine di diario pubblicate da Chiarelettere nel 2011. La pedinarono
(«esco da Palazzo San Macuto e mi accorgo di essere pedinata fino a casa da un
uomo di statura piuttosto bassa, robusta, dell'età di quaranta, quarantacinque
anni», annota all'una e un quarto di notte l'8 febbraio 1983), indagarono su di
lei («Il giorno 7 gennaio 1985 sono venuti da me Lo Presti di Treviso e un suo
collaboratore. Si sono dichiarati di professione agenti investigativi privati.
Mi hanno raccontato di essere stati incaricati di indagare su di me, sui miei
beni, sui miei parenti, per avere elementi contro di me. Hanno rifiutato di
collaborare»), fu lasciata sola dagli uomini del suo partito, la Democrazia
cristiana. «Lei ritiene di non poter fare nulla per impedire che materiale
giudiziario venga sfruttato contro di me. Lei aveva tutti gli strumenti per
bloccare un'operazione infame. Non li vuole usare», le scriveva Flaminio
Piccoli, presidente della Dc. Dai socialisti: «Formica (Psi) mi ha detto ieri
che la commissione P2 va chiusa e basta». E dall'opposizione comunista: «Non mi
pare che il Pci voglia andare fino in fondo. Il gruppo pare abbandonato a se
stesso. La stessa richiesta loro di non approfondire il filone servizi segreti
fa pensare che temano delle verità che emergono dal periodo della solidarietà.
Ipotesi: ruolo di Andreotti che li ha traditi? O coinvolgimento di qualche loro
uomo?». «Nulla si può escludere, neppure che Tina Anselmi sia una
calunniatrice», scrisse infine Gelli al presidente della Repubblica eletto nel
1985, Francesco Cossiga. In tanti pensavano a lei per il Quirinale, in realtà. E
poi nel 1992, quando il suo nome risuonò più volte nell'aula di Montecitorio
durante le votazioni per il presidente della Repubblica e il settimanale di
Michele Serra "Cuore" l'aveva candidata ufficialmente, e non c'era nessun
intento satirico. E invece dopo la commissione la sua carriera politica di fatto
terminò. Come aveva previsto un suo grande amico, partigiano come lei, Sandro
Pertini. «Con Pertini parlano spesso del mio coraggio. Sanno che sono sola in
questo compito», appuntava il 20 settembre 1983. E il 10 maggio 1984, alla
chiusura dei lavori: «Visita a Pertini. Mi ringrazia per quello che ho fatto per
il paese e per l'Italia. Mi conferma la sua stima e la sua amicizia, per il
coraggio che ho. Annota che nel Palazzo non si avrà la volontà di andare a fondo
e di accogliere la mia relazione». «Se la loggia P2 è stata politica sommersa,
essa è contro tutti noi che sediamo in questo emiciclo. Questo è il sistema
democratico che in questi quaranta anni abbiamo voluto e costruito con il nostro
quotidiano impegno: non può esservi posto per nicchie nascoste o burattinai di
sorta», aveva concluso il suo compito il 9 gennaio 1986, presentando nell'aula
della Camera il lavoro della commissione. Sono passati trent'anni, non è andato
via questo odore di stantio che si avverte in molti, troppi passaggi politici e
economici. Ma neppure passerà il ricordo di Tina Anselmi. La ragazza della
Repubblica che non hai smesso di sorridere nei momenti più difficili. La donna
che fece tremare i piccoli uomini del potere. È lei, non i traditori dello Stato
che lo hanno usurpato, a meritare a pieno diritto il titolo di patriota.
«La P2? Presto P3 e P4». La profezia
della Anselmi. I diari segreti: possibile che
Andreotti e Berlinguer non sapessero? I socialisti Tra i primi appunti dell'81
dopo che scoppiò il caso: «I socialisti sono terrorizzati dall'inchiesta» I
comunisti Tra i 773 foglietti: «Strano atteggiamento del Pci... non mi pare che
voglia andare fino in fondo», scrive Marzio Breda il 25 marzo 2011 su "Il
Corriere della Sera". Il 17 marzo 1981 il colonnello Vincenzo Bianchi si
presenta a Villa Wanda, a Castiglion Fibocchi, vicino ad Arezzo, residenza
dell'allora quasi sconosciuto Licio Gelli. Ha in tasca un mandato di
perquisizione dei giudici milanesi Giuliano Turone e Gherardo Colombo, che
indagano sull'assassinio Ambrosoli e sul finto sequestro di Sindona, mandante
del delitto. Dopo qualche ora di lavoro, l'ufficiale riceve una telefonata del
comandante generale della Finanza, Orazio Giannini. Si sente dire: «So che hai
trovato gli elenchi e so che ci sono anch'io. Personalmente non me ne frega
niente, ma fai attenzione perché lì dentro ci sono tutti i massimi vertici».
Poche parole, dalle quali Bianchi è colpito per la doppia intimidazione che
riassumono. Cioè per quel «non me ne frega niente», che esprime un assoluto
senso d'impunità. E per quel «tutti i massimi vertici», che capisce va riferito
ai vertici «dello Stato e non del corpo» di cui lui stesso indossa la divisa. Ed
è proprio vero: c'è una parte importante dell'Italia che conta, in quella lista
di affiliati alla loggia massonica Propaganda Due, che il colonnello sequestra
assieme a molti altri documenti e trasporta sotto scorta armata a Milano. Ci
sono 12 generali dei carabinieri, 5 della guardia di Finanza, 22 dell'Esercito,
4 dell'Areonautica militare, 8 ammiragli, direttori e funzionari dei vari
servizi segreti, 44 parlamentari, 2 ministri in carica, un segretario di
partito, banchieri, imprenditori, manager, faccendieri, giornalisti, magistrati.
Insomma: nella P2 ci sono 962 nomi di persone che formano «il nocciolo del
potere fuori dalla scena del potere, o almeno fuori dalle sue sedi conosciute».
Una sorta di «interpartito» formatosi su quello che appare subito come un oscuro
groviglio d'interessi dietro il quale affiorano business e tangenti, legami con
mafia e stragismo, il golpe Borghese, omicidi eccellenti (Moro, Calvi,
Ambrosoli, Pecorella) e soprattutto un progetto politico anti-sistema. Quando,
dopo due mesi di traccheggiamenti, gli elenchi sono resi pubblici, lo scandalo è
enorme. Il governo ne è travolto e il 9 dicembre 1981, anche per la spinta di
un'opinione pubblica sotto choc e che chiede la verità, s'insedia una
commissione parlamentare d'inchiesta che la presidente della Camera, Nilde
Jotti, affida alla guida di Tina Anselmi. Da allora l'ex partigiana di
Castelfranco Veneto, deputata della Dc e prima donna a ricoprire l'incarico di
ministro, comincia a tenere un memorandum a uso personale oggi raccolto in
volume: «La P2 nei diari segreti di Tina Anselmi», a cura di Anna Vinci
(Chiarelettere, pag. 576, euro 16). Tra i primi appunti, uno è rivelatore del
clima che investe la politica («i socialisti sono terrorizzati dall'inchiesta»)
e l'altro del metodo che la Anselmi intende seguire: «Fare presto, delimitare la
materia, stare nei tempi della legge». Un proposito giusto. Lo sfogo del
colonnello Bianchi le ha fatto percepire l'enormità dell'indagine e i livelli
che è destinata a toccare. Diventa decisivo, per lei, sottrarsi all'accusa di
«dar la caccia ai fantasmi» e di certificare quindi l'attendibilità delle liste
(su questo si gioca la critica principale), come pure evitare che
l'investigazione si chiuda con il giudizio minimalista accreditato da alcuni,
secondo i quali la P2 sarebbe solo un «comitato d'affari». È un'impresa dura e
difficile, per la Anselmi. Carica di inquietudini. Lo dimostrano i 773 foglietti
in cui annota ciò che più la colpisce durante le 147 sedute della commissione.
Riflette, ad esempio, il 14 aprile 1983: «Strano atteggiamento del Pci... non mi
pare che voglia andare a fondo. La stessa richiesta loro di non approfondire il
filone servizi segreti fa pensare che temano delle verità che emergono dal
periodo della solidarietà. Ipotesi: ruolo di Andreotti, che li ha traditi? O
coinvolgimento di qualche loro uomo? Più probabile la prima ipotesi. Mi pare che
Br e P2 si siano mosse in parallelo e abbiano fatto coincidere i loro obiettivi
sul rapimento e sulla morte di Moro». Altro appunto, del 26 gennaio '84, con
l'audizione di Marco Pannella: «Com'è possibile che Piccoli, Berlinguer e
Andreotti non sapessero della P2 prima del 1981?». Ragionando poi sul fatto che
gli elenchi non sono forse completi e che Gelli potrebbe essere solo «un
segretario», si chiede se la pista non vada esplorata fino a Montecarlo, sede di
una evocata super loggia. E ancora, il 16 dicembre '81 mette a verbale che il
parlamentare Giuseppe D'Alema (padre di Massimo) «consiglia di parlare» con un
poco conosciuto giudice di Palermo che cominciava a conquistarsi le prime pagine
sui giornali: Giovanni Falcone. S'incrocia di tutto in quelle carte. La
fantapolitica diventa realtà. Ci sono momenti nei quali la commissione è una
«buca delle lettere»: arrivano messaggi cifrati, notizie pilotate o false,
ricatti. Parecchi riguardano la partita aperta intorno al Corriere della Sera,
che era stato infiltrato (nella proprietà e in parte anche nella redazione) da
uomini del «venerabile» e alla cui direzione c'è ora Alberto Cavallari, indicato
da Pertini per restituire l'onore al giornale. In questo caso sono insieme
all'opera finanzieri e politici, ossessionati dalla smania di controllare via
Solferino. Si agitano anche pezzi del Vaticano, il cardinale Marcinkus, senza
che la cattolica Anselmi se ne turbi e lo dimostra ciò che dice al segretario,
Giovanni Di Ciommo: «Non ho fatto la staffetta partigiana per farmi intimidire
da un monsignore». Ma a intimidirla ci provano comunque. La pedinano per strada.
Qualche collega, passando davanti al suo scranno a Montecitorio, le sibila: «Chi
te lo fa fare? Qua dobbiamo metterci i fiori». Fanno trovare tre chili di
tritolo vicino a casa sua. Lei tira dritto. Quando, il 9 gennaio '86, presenta
alla Camera la monumentale conclusione del suo lavoro, 120 volumi, definisce la
P2 «il più dotato arsenale di pericolosi e validi strumenti di eversione
politica e morale» (il piano di Rinascita Democratica di Gelli). Nel diario
aveva profeticamente scritto: «Le P2 non nascono a caso, ma occupano spazi
lasciati vuoti, per insensibilità, e li occupano per creare la P3, la P4...».
Sono passati trent'anni e la testimonianza di Tina Anselmi, dimenticata e da
tempo malata, è da riprendere. Magari riflettendo su un dato: nella lista
compariva anche il nome di Silvio Berlusconi. All'epoca era soltanto un giovane
imprenditore rampante e i parlamentari non ritennero di sentirlo perché era
parso un «personaggio secondario».
LA P2 E IL DIARIO DI TINA,
scrive il 29/03/2011 Luciano Scalettari su "Famiglia Cristiana". Trent'anni dopo
esce un libro con gli appunti segreti di Tina Anselmi, presidente della
Commissione parlamentare che indagò la loggia occulta di Gelli. Appunti quanto
mai attuali. Oltre 700 foglietti, quasi dei post-it. Brevi, nervosi appunti
presi nel corso delle audizioni o durante la lettura di atti e documenti. Un
materiale enorme, difficile, delicato. «Tina me l’aveva dato da molto tempo, ma
non avevo mai preso il coraggio di affrontare questo lavoro. Sapevo che era
importante pubblicarlo. Ora l’ho fatto». Le parole sono di Anna Vinci, curatrice
del libro La P2 nel diario segreto di Tina Anselmi, in uscita in questi giorni
per Chiarelettere. Anna Vinci, romana, è scrittrice, autrice e conduttrice. Ma
soprattutto è legata da una forte e antica amicizia con l’onorevole Anselmi. «La
prima ragione per cui questo libro andava pubblicato», spiega, «è che volevo
rendere omaggio a una grande donna, che a 17 anni ha voluto diventare staffetta
partigiana (col nome in codice di Gabriella), che è stata il primo ministro
donna della Repubblica, e che, infine, si è trovata a presiedere una delle più
complesse e pericolose commissioni d’inchiesta volute dal Parlamento: quella
sulla Loggia massonica P2 di Licio Gelli». «La seconda ragione», continua, «è
l’estrema attualità di quanto Tina aveva capito e scritto nel corso dei tre anni
di lavoro alla Presidenza della Commissione: la realtà italiana odierna rimanda
sempre più al progetto di Gelli e quei settecento foglietti ci aiutano in modo
sorprendente a svelare le radici dell’attuale situazione del nostro Paese. Del
resto Tina in tutti questi anni ha continuato a ripetermelo: “Attenzione, quello
ritorna”. Non so se si riferiva a Gelli o al suo progetto».
Dottoressa Vinci, perché Tina Anselmi appuntò
furiosamente tante riflessioni, circostanze, fatti nel corso di quei tre anni?
«Aveva a che fare non solo con le audizioni, ma
anche con le carte che venivano dalle Procure. Voleva documentare il suo lavoro
perché temeva – e il timore era fondato – che il lavoro suo e dei commissari non
venisse preso in considerazione. Scriveva per lasciare tutto “a futura memoria”.
Quello che le è passato sotto gli occhi in quei tre anni era colossale. Come lei
stessa l’ha definito, nel suo discorso del 9 gennaio 1986 alla Camera dei
Deputati, la P2 è stata il “tentativo sofisticato e occulto di manipolare la
democrazia”, di svuotarla dal suo interno rendendo l’Italia un Paese solo
apparentemente democratico. Insomma, un vero e proprio piano eversivo».
L’onorevole Anselmi ha dichiarato, proprio al
nostro settimanale in un’intervista del 25 maggio 1984: “Questi tre anni sono
stati per me l’esperienza più sconvolgente della mia vita. Solo frugando nei
segreti della P2 ho scoperto come il potere, quello che ci viene delegato dal
popolo, possa essere ridotto a un’apparenza. La P2 si è impadronita delle
istituzioni, ha fatto un colpo di Stato strisciante. Per più di dieci anni i
servizi segreti sono stati gestiti da un potere occulto”. È per essere andata
fino in fondo che poi ne ha pagato il prezzo politico?
«Sì. Quando le hanno proposto di diventare
Presidente della Commissione, ha accettato perché è una donna coraggiosa. E la
sua conduzione, nei tre anni seguenti, è stata un esempio di dirittura morale e
onestà profonda. Anche se capiva che il “non fare sconti a nessuno” avrebbe
comportato un duro prezzo. E l’ha pagato. Da allora è stata “fatta fuori”
politicamente. È stata emarginata».
Quello che Tina Anselmi ha scoperto non era solo
il tentativo di svuotamento della democrazia…
«No, infatti. C’erano anche le implicazioni con la
strage di Bologna, con l’attentato dell’Italicus, con il caso-Moro, con il
caso-Sindona, le relazioni con la mafia e la banda della Magliana. E con tanti
altri episodi oscuri e inquietanti della storia italiana. Emergeva un cono
d’ombra comune, che aveva la sua matrice nella P2 di Licio Gelli».
Lei, dottoressa, nel ripercorrere quei foglietti e
le vicende ad essi collegati, cosa ne ha tratto?
«Mi ha colpito la mancanza di senso dello Stato,
l’irresponsabilità. “Mi sono iscritto, ma non credevo… non sapevo…” Questo lo
dicevano in tanti. È lo spaccato di un’intera classe dirigente che non si
capisce quanto fosse incompetente o truffaldina. Dal libro emerge non tanto un
giudizio politico ma la pochezza degli uomini. Gelli riceveva all’Excelsior. Non
era lui che andava a trovare i politici. E tanti nomi degli iscritti alla lista
P2 sono ancora in piena attività».
Nel libro si fa riferimento anche al fatto che a
un certo punto fu proposto di sentire in audizione anche Silvio Berlusconi,
anch’egli presente nelle liste…
«Sì, ma come scrive Tina, la Commissione decise di
no, perché in quel momento storico fu considerato un personaggio secondario.
Allora, era soltanto un giovane imprenditore milanese».
È vero che l’Anselmi sottolinea questo senso
d’impunità che manifestavano gli iscritti alla P2?
«C’è spesso questa ostentazione di
“intoccabilità”. Un esempio? Quando viene scoperta la lista a Castiglion
Fibocchi, uno degli investigatori, il colonnello Vincenzo Bianchi della Guardia
di Finanza viene avvertito di chiamare il Comandante generale del Corpo. Il
quale, in sintesi, gli dice: “So che hai trovato gli elenchi. Ci sono anch’io.
Non me frega niente. Ma sappi che là ci sono tutti i massimi vertici”. Messaggio
chiaro, no?».
Ci furono mai contatti fra Licio Gelli e Tina
Anselmi?
«Gelli tentò di avere un’occasione d’incontro,
l’anno scorso, tramite un intermediario. Tina rifiutò».
Tina Anselmi, una donna, si trovò a indagare in
uno dei mondi più esclusivamente maschili, qual è quello della massoneria. È
stato un valore aggiunto o un limite?
«Un valore aggiunto. Non se l’aspettavano la
tenacia e il rigore di Tina. Quel mondo si è trovato spiazzato. Nella vicenda P2
non ci sono donne, in queste pagine non emergono donne. È una vicenda tutta al
maschile. Questo mi porta a dire che, allora come oggi, al nostro Paese manca
l’apporto del talento delle donne».
C’è una figura, fra le tante, che l’ha
particolarmente inquietata?
«Francesco Cossiga. Appena divenne Presidente
della Repubblica scrisse alla Anselmi. Era ossessionato dai vecchi rapporti con
Gelli. Come scrive il magistrato Giovanni Turone, all’epoca titolare
dell’inchiesta (con Gherardo Colombo) che portò alla scoperta della P2, Cossiga
è una delle persone più inquietanti del nostro dopoguerra».
Perché, secondo lei, è importante leggere oggi di
una vicenda di 30 anni fa?
«Tina diceva che una delle tragedie dell’Italia è
che non abbiamo la memoria condivisa. Lei aveva cercato di ricomporre un puzzle
che ci ha lasciato, perché non si dimentichi e perché non si ripeta. Il libro è
in fondo un atto d’accusa della situazione in cui siamo caduti. Il declino
andava fermato allora. Tina aveva compreso una cosa molto importante. Scrisse in
uno dei suoi appunti: “Basta una sola persona che ci governa ricattata o
ricattabile, perché la democrazia sia a rischio"».
Una questione molto attuale. Lei è pessimista?
«No. Vinceremo noi, alla fine, non i piduisti».
Agostino Cordova. Biografia di Agostino Cordova.
Reggio Calabria 1936. Magistrato. «Se qualche
merito ho avuto, me l’hanno trasformato in colpa. Ho fatto sparire da Napoli il
contrabbando dei tabacchi e hanno detto che toglievo il lavoro alla povera
gente».
Cominciò la sua carriera a Reggio Calabria nel
1963, diventando pretore, giudice a latere della sezione penale e poi giudice
istruttore. Nel 1978 firmò 60 rinvii a giudizio contro boss dei clan De Stefano,
Mammoliti e Piromalli: sarebbe stato il primo maxiprocesso contro la ’ndrangheta
calabrese. Nell’87 diventò capo della Procura di Palmi. Condusse inchieste
contro la cosca dei Pesce, contro le Usl di Taurianova e Gioia Tauro, denunciò
la scarsità dei mezzi, fu a sua volta denunciato al Csm per “incompatibilità
ambientale” (caso poi archiviato). Indagò anche su massoneria e P2. Nel luglio
del 1993 diventò procuratore di Napoli. La sua opera di coordinamento fu
contestata da un gruppo di 60 sostituti, il Csm si spaccò, la destra lo
sostenne, le divisioni in Procura diventarono anche politiche.
«Dalla massoneria internazionale al malaffare
delle istituzioni, passando per le corruzioni (solo presunte) di altissimi
funzionari del Viminale. La sua carriera professionale è costellata da battaglie
giudiziarie altisonanti. Chiuse talvolta con sconfitte» (Il Messaggero).
«Furbissimo e scaltro – anche se ama rappresentare
se stesso come un indomito cavaliere che affronta solitario il mondo della
corruzione – preferisce che la politica gli tenga la mano sulla spalla. Ieri, fu
la sinistra (politica e togata) che lo appoggiò contro Giovanni Falcone nella
candidatura alla Procura nazionale antimafia e nel contentino della Procura di
Napoli. Giunto alla falde del corrotto Vesuvio, la mano cambiò. Divenne quella
della destra. Tormentava, senza costrutto (purtroppo per lui), l’amministrazione
di Bassolino “il rosso”, e tanto bastava al centro-destra per non vedere le
sconfitte incassate dal procuratore» (Giuseppe D’Avanzo).
«Ho un brutto carattere e non sono un diplomatico.
Ma la diplomazia è come una bellissima dama che suole avere intimi rapporti con
il compromesso e generare brutti figli che si chiamano
condizionamenti, “apparamenti” (aggiustamenti — ndr) come si dice in dialetto
napoletano, o ricatti».
La moglie Marisa si sfogò nel libro di Giorgio
Bocca Napoli siamo noi (Feltrinelli 2006): «La vera “camorra” forse sono i
colleghi di mio marito, sono i giudici che si fingevano suoi amici quando lui
passava in procura. Lui lavorava senza guardare che cosa poteva essere utile a
questo o a quello».
Gran sigaro, sopracciglioni.
GIORGIO DELL’ARTI, scheda aggiornata al 2 aprile
2014
Clan e massoneria, si (ri)parte
dall’inchiesta Cordova. La proposta dello storico
Ciconte alla Commissione parlamentare antimafia: «Mettiamo le mani su quei
faldoni per ricostruire carriere e fatti che all’epoca ci sono sfuggiti», scrive
Giovedì, 09 Marzo 2017, Pablo Petrasso su "Il Corriere della Calabria". Il nuovo
spunto investigativo per la Commissione parlamentare antimafia arriva
dall’audizione dello storico Enzo Ciconte. Quella dello scorso 1 marzo è più una
lezione che un’audizione. Deputati e senatori sono condotti per mano nella
storia delle mafie, prima dallo studioso Isaia Sales e poi dal docente
calabrese. Che, a proposito della storia recente della ‘ndrangheta, evoca un
nome che è una costante nei contesti in cui si discute dei rapporti tra cosche e
massoneria: quello di Agostino Cordova. Le sue inchieste hanno avuto «pochissima
fortuna sul piano giudiziario» ma il procuratore un merito lo ha avuto: «Ha
raccolto una quantità enorme di carte». Ciconte guida deputati e senatori sul
filo del suo ragionamento: «So che sono almeno 800 faldoni, presidente. Se si
riuscisse a mettere mano su quei faldoni, a leggerli e a mettere in piedi un
gruppo di lavoro che studiasse quelle carte di 25 anni fa, probabilmente
riusciremmo a capire carriere, cointeressenze e fatti che sono accaduti nel
corso degli anni successivi e che probabilmente ci sono sfuggiti, perché non li
abbiamo capiti o non abbiamo attribuito loro una valenza completamente
diversa». Non c’è una via agevole per arrivare al cuore delle sovrapposizioni
tra clan e logge deviate. Non è priva di ostacoli quella seguita finora dalla
Commissione (il prelievo degli elenchi dei massoni di Sicilia e Calabria
eseguito dalla Guardia di finanza). Non lo è neppure quella indicata da Ciconte:
decine di migliaia di pagine, carriere da ricostruire, migliaia di nomi da
incrociare. Eppure è una strada, quest’ultima, che la presidente dell’Antimafia
Rosy Bindi pensa di esplorare: «Valuteremo la proposta del professor Ciconte di
acquisire gli atti dell’inchiesta Cordova e di istituire un gruppo di studio
degli stessi atti, magari chiedendogli di darci una mano». Servirà ben più di
una mano e non soltanto per la vastità dei documenti. Ci sono fili scoperti e
attraversati da altissima tensione. Per Ciconte lo prova, tra le altre, la
storia del notaio Pietro Marrapodi: «Era un 33 (si riferisce al grado raggiunto
nella scala massonica, ndr), quindi di livello elevato. A un certo punto, decide
di collaborare con la giustizia. Marrapodi si mette a parlare dicendo che
c’erano stati rapporti tra la ‘ndrangheta e la massoneria. Era molto amico di
moltissimi magistrati reggini. Si mette a parlare e poi qualcuno gli chiude la
bocca. O se l’è chiusa lui o qualcuno l’ha fatto per lui». Suicida o suicidato,
la morte del notaio è uno dei misteri da illuminare per restituire un’anima alla
città di Reggio Calabria. E si perde in un labirinto che mescola ‘ndrangheta e
massoneria. Entità che, secondo Ciconte, rimangono distinte: «Non c’è un
travaso, c’è semplicemente una cointeressenza – dice lo storico -. Io credo che
funzioni un altro sistema. Lo chiamo “arcipelago” per come nell’arcipelago è
possibile la presenza di più isolotti e isolette che stanno in collegamento tra
di loro». Una lettura diversa da quella sposata dalla stampa e basata
sull’intercettazione cult di uno dei capi del clan Mancuso («la ‘ndrangheta non
esiste più, fa parte della massoneria, diciamo è sotto la massoneria. Ha, però,
le stesse regole»).
Eppure in alcuni contesti i due livelli si fondono
fino a toccarsi. Tra le isole dell’arcipelago si alza una nebbia che tutto
confonde. In questa nebbia si muovono uomini come Paolo Romeo, perno
dell’inchiesta “Gotha” e di tante oscure trame reggine. Alcuni intrecci
conducono a insospettabili, ben felici di intrattenere rapporti con un uomo dal
passato (e dal presente) oscuro: «Che Romeo abbia rapporti con uomini politici
per me è un fatto abbastanza normale, nel senso che è stato deputato, è stato
consigliere comunale e vive a Reggio Calabria. Il problema è perché quelli che
lo conoscono abbiano rapporti con lui. Il problema non è lui. Il problema è chi
con lui ha avuto in questi anni rapporti e, ancora peggio, ha avuto interessi in
comune e ha fatto affari in comune. Un conto è prendersi un gelato in una
gelateria di Reggio Calabria, un conto è fare affari con uno che è
pregiudicato». Sarà dura orientarsi negli arcipelaghi della massomafia. Ma
diradare le nebbie che avvolgono lo Stretto lo sarà ancor di più.
Conoscere i fatti. Nel 2000
l’archiviazione dell’inchiesta sulla Massoneria del procuratore Cordova.
Roma 3 luglio 2000. Porta questa data il decreto di
archiviazione della maxi-inchiesta sulla Massoneria avviata nel 1992 da Agostino
Cordova, all’epoca procuratore della Repubblica di Palmi, indagine che
ultimamente è tornata alla ribalta. Noi non aggiungiamo altro al lancio dell’Agi
che riportò la notizia dell’archiviazione sette mesi dopo e che qui riportiamo.
Quella notizia fu ripresa da alcuni giornali ma non dalle maggiori testate
nazionali. Certo è che, per dovere di cronaca, ci si sarebbe aspettata una
pubblicità maggiore, visto il vastissimo clamore che accompagnò la vicenda sin
dall’inizio e che creò grandissimi pregiudizi e ripercussioni anche in ambito
lavorativo a tanti iscritti del Grande Oriente d’Italia. Ma tant’è, in Italia,
quando si parla di Massoneria. Il lancio dell’Agi sintetizza le ventitré pagine
del documento, firmato da Augusta Iannini, che qui mettiamo a disposizione dei
lettori ricordando anche la testimonianza di un esponente del Grande Oriente
d’Italia che visse quei fatti. Si chiama Mario Valentini e ai
tempi dell’indagine era sindaco di Perugia.
(AGI) – Roma, 24 feb. 2001 – «Non può essere
taciuto che in questo procedimento penale ‘l’indagine conoscitiva ha vissuto
momenti di inusuale ampiezza». Dopo quasi otto anni la maxi inchiesta sulle
logge massoniche in Italia, avviata dall’allora procuratore di Palmi Agostino
Cordova (attuale capo della procura di Napoli), approdata poi a Roma, è stata
archiviata dal gip Augusta Iannini, che ha dichiarato il non «doversi promuovere
l’azione penale» nei confronti dei 64 massoni indagati. Il giudice, in sintonia
con i pm di Roma che hanno ereditato il voluminoso fascicolo, punta, però,
l’indice contro il collega Agostino Cordova che avrebbe avviato una maxi
indagine conoscitiva che, fatta eccezione di uno stralcio relativo alle attività
imprenditoriali su Licio Gelli (rinviato a giudizio anni fa su iniziativa dei pm
della capitale per il crack finanziario del gruppo Di Nepi, il cui processo è
ancora in corso), non avrebbe rilevato alcuna illecita attività compiuta dalla
massoneria. Agostino Cordova ordinando decine e decine di perquisizioni ed anche
alcuni arresti, ipotizzava nella sua indagini lo scambio di voti. Le sedi e gli
uffici della massoneria italiana, su ordine del magistrato, vennero perquisite e
la notizia ebbe particolare risonanza su tutti i quotidiani nazionali. Per il
gip di Roma e su parere conforme dei pm della capitale, invece, non vi sarebbe
stato alcuno scambio di voti. «Da uno sguardo d’insieme del ponderoso materiale
acquisito e raccolto in circa 800 faldoni – scrive Augusta Iannini – e in un
numero imprecisato di scatoloni contenente materiale sequestrato, si può trarre
la certezza che è stata compiuta, in tutto il territorio nazionale, una
massiccia e generalizzata attività di perquisizione e sequestro che le iniziali
dichiarazioni del notaio Pietro Marrapodi (da cui è nata l’indagine, ndr),
certamente non consentivano, quanto meno a livello nazionale». «Da questi
racconti – prosegue il gip di Roma – a contenuto generalissimo, ma conformi
all’immaginario collettivo sul tema ‘gruppi di potere, il pm di Palmi ha tratto
lo spunto per acquisire una massa enorme di dati (prevalentemente elenchi di
massoni) che poi è stata informatizzata e che costituisce una vera e propria
banca dati sulla cui utilizzazione è fondato avanzare dubbi di legittimità,
tanto più che l’indagine si sta concludendo con una generalizzata richiesta di
archiviazione». Per il gip Augusta Iannini «in questo procedimento, infatti,
l’articolo 330 cpp è stato interpretato come potere del pm e della polizia
giudiziaria di acquisire notizie e non, come si dovrebbe, notizie di reato».
Secondo il giudice romano «era infatti chiaro che l’acquisizione di elenchi di
associazioni, anche e non solo massoniche, costituiva una mera notizia e non
certamente una notizia di reato. Lo studio del materiale, una volta messo a
disposizione di questo ufficio, è stato reso particolarmente difficoltoso
dall’assenza di indici ragionati e dalla collocazione del materiale cartaceo,
custodito in uno scantinato dei locali di piazza Adriana, privo di luce, di una
scrivania e di qualsiasi attrezzatura che consentisse una consultazione
dignitosa degli atti». Gli stessi pm di Roma che hanno ereditato l’inchiesta, su
decisione della stessa procura di Palmi che di sua iniziativa aveva ritenuto la
competenza della magistratura della Capitale, nel condurre gli accertamenti
sulla maxi inchiesta avevano rilevato l’elevantissimo «numero di sequestri»
ordinati dai pm calabresi, le «sistematiche richieste di informative indirizzate
a tutti gli uffici di pg d’Italia sulle persone risultate iscritte negli elenchi
massonici acquisiti tramite i sequestri», l’acquisizione di documentazione
bancaria, di elenchi di nominativi di pubblici dipendenti, di attività
d’indagini più mirate, come «sommarie informazioni testimoniali, intercettazioni
telefoniche, ecc.», l’informatizzazione del materiale documentale ed informatico
raccolto per permetterne la consultazione; ed infine la «raccolta di dati
generali ritenuti utili ai fini delle indagini da ministeri e pubbliche
amministrazioni su diversi argomenti». Per il gip Augusta Iannini che ha accolto
la richiesta di archiviazione sollecitata dai pm di Roma Lina Cusano e Nello
Rossi (oggi consigliere del Csm) «all’eccezionale ampiezza del raggio delle
indagini ed alla conseguente accumulazione di un’amplissima documentazione sul
fenomeno massoneria non ha corrisposto un altrettanto ampia localizzazione delle
investigazioni in direzione delle specifiche attività di interferenza in ambiti
istituzionali ricollegabili alle realtà organizzative individuate». «La riprova
più eloquente dello stato delle indagini sin qui descritto – scrive il gip di
Roma – proviene dalla stessa procura di Palmi», che «dopo investigazioni
iniziate il 16 marzo 1993» decide autonomamente di trasferire l’inchiesta alla
procura di Roma che poi, dopo aver inquisito, chiesto ed ottenuto il rinvio a
giudizio di Licio Gelli per il crack del gruppo di Nepi, ha concluso l’indagine
con una richiesta di archiviazione. Gli stessi pm nel sollecitare la chiusura
della vicenda hanno sottolineato come «la trasmissione degli atti del presente
procedimento da Palmi a Roma è avvenuta su esclusiva iniziativa dell’ufficio del
pubblico ministero di Palmi e con i tempi da questo ufficio voluti senza che vi
sia stata alcuna rivendicazione di competenza o richiesta di trasmissione da
parte dell’ufficio del pubblico ministero di Roma». (AGI)
L’ex sindaco di Perugia Mario Valentini,
libero muratore, ricorda la persecuzione inflitta ai massoni venti anni fa.
’Ndrangheta e massoneria, quel teorema di Cordova era perfetto, scrive
l'1/02/2017 “La Gazzetta del Sud. «La prima volta che incontrai il procuratore
di Palmi Agostino Cordova gli chiesi perché volesse tutti gli elenchi dei
massoni del Goi (Grande Oriente d’Italia). Mi rispose: dalle nostre verifiche è
emerso che i massoni della Calabria hanno connessioni con i massoni del Nord
Italia e formulò l’ipotesi che la ’ndrangheta stesse occupando le regioni del
Nord servendosi anche della massoneria. Quella che allora era un’intuizione di
Cordova a distanza di 20 anni è una realtà». Lo ha detto, in audizione davanti
alla Commissione parlamentare Antimafia, Giuliano Di Bernardo già Gran Maestro
del Grande Oriente d’Italia. «Il procuratore Cordova mi ha fornito prove
inconfutabili sul coinvolgimento di alcune persone aderenti al Goi ma anche su
un fenomeno strano: mi mostrò un pacco di fogli che contenevano accuse di
massoni contro altri massoni. Alcuni, insomma, si servivano della magistratura
per fare fuori altri massoni. C’era una guerra fratricida. Quando ho avuto dal
procuratore Cordova queste prove ho convocato la giunta del Grande Oriente
d’Italia e ho presentato la situazione. Al termine di quella riunione ho deciso
di dimettermi dal Goi perchè avevo constatato una realtà che mai avrei
immaginato e che da quel momento mi sarei rifiutato di governare», ha proseguito
Di Bernardo. Nessuno di quella giunta imitò Di Bernardo sulla decisione di
dimettersi. «Dopo – ha raccontato l’ex Gran Maestro all’Antimafia – sono stato
crocifisso, i miei ritratti bruciati nel tempio, ho ricevuto minacce
inimmaginabili. L’allora ministro dell’Interno Mancino ha allertato più volte il
prefetto per farmi proteggere, perché tra le persone da colpire c’ero io. Non ho
potuto fare capire ai miei confratelli le mie ragioni. Ho lasciato al Gran
segretario una lettera che, però, non è stata divulgata. Ancora oggi, dopo 23
anni, sono considerato il traditore, verso di me c’è un odio che non potete
immaginare». Tra i motivi di contrasto, anche il fatto che Di Bernardo è
riuscito a far riconoscere la Gran Loggia regolare d’Italia, che ha costituito
subito dopo le sue dimissioni, dalla massoneria inglese, che, al contempo, ha
tolto il proprio riconoscimento al Grande Oriente d’Italia.
L’INTERVISTA ALL’EX PROCURATORE DI
NAPOLI. Cordova: «A 80 anni mi sento ancora come un
mastino». «A Napoli non ho amici. De Magistris? Non lo giudico, fu uno di quelli
contrari a me», scrivono Roberto Russo e Monica Scozzafava il 26 febbraio 2016
su "Il Corriere del Mezzogiorno". Vent’anni dopo, il procuratore più temuto e
meno amato nella storia giudiziaria di Napoli è seduto su una panchina in pietra
di piazza Bovio. Osserva lo scorrere del traffico con aria pacata, quasi
rassegnata, come se assistesse a un film già visto mille volte. L’immancabile
borsalino di colore blu che appoggia sui capelli radi, grandi occhiali con i
vetri gialli e una sciarpa di colore grigio. Agostino Cordova, 80 anni tra
qualche mese, in città non ha amici. «Nessuno, quei pochi che si dicevano tali
sono spariti…». Così la panchina davanti alla Camera di Commercio è diventata
l’alleato più fedele nei pomeriggi troppo lunghi della terza età, nel suo caso
scandita da acciacchi. «I medici mi hanno proibito il sigaro, mi concedo
raramente una pizzicata di tabacco, ma mia moglie si arrabbia perché si sporcano
i vestiti». Sorride e mostra una scatolina in plastica bianca che contiene
tabacco aromatizzato. «Lo trovo a Palmi, qui non so se si venda…». Abbozza un
altro sorriso stanco e recupera il bastone che nel frattempo è scivolato dalla
panchina. L’età lo rende sicuramente più morbido, nell’approccio e anche nella
comunicazione. Un uomo dall’aspetto sempre burbero, ma che non riesce più a
nascondere le emozioni. Quasi felice di raccontarsi oggi che non ha più cucita
addosso l’etichetta di potente. «Vivo con mia moglie e i miei due figli che non
sono sposati». Abitano sempre nella casa di corso Umberto, nella stessa città
che gli ha riservato più di un’amarezza. Cordova è consapevole di aver subito
tante accuse, a volte ingiuste. Di essere stato un magistrato potente e scomodo,
criticato da destra e da sinistra. Bersagliato anche dai suoi stessi colleghi.
«Mezza procura a Napoli firmò un documento chiedendo il mio trasferimento, gli
altri si astennero». È il passato che torna nella mente di un uomo che oggi
trascorre molti pomeriggi seduto su una panchina di pietra lavica. I pensieri
viaggiano e i racconti dell’ex magistrato sono precisi, così come le sue
riflessioni sulle vicende di stretta attualità.
Presidente Cordova, ci dica la verità. Le manca
ancora la Procura?
«È soltanto una questione di funzioni. Non le
esercito più, certo, ma dentro mi sento l’uomo inflessibile e rigoroso di un
tempo. È una questione di regole che vanno rispettate. So di essere stato
intransigente, ma mai per partito preso».
Eppure appena si insediò a Castelcapuano, nel
luglio ’93, disse: “Napoli è la capitale dell’illegalità”. Scoppiò un putiferio.
Oggi ripeterebbe quella frase?
«Essendo stato dichiarato incompatibile con
Napoli, preferisco non esprimermi al riguardo».
Eppure oggi il sindaco de Magistris dice di aver
ripristinato servizi e arginato il malaffare. È un ex magistrato, peraltro di
sua conoscenza.
«Come sindaco non lo giudico, né mi esprimo sul
suo operato. Se non ricordo male, fu uno di quelli contrari a me».
Meglio il ritorno di Bassolino, allora? Che pure
all’epoca conobbe...
«Guardi, è una vicenda che non m’interessa. Se ha
scelto di ricandidarsi è libero di farlo e avrà i suoi motivi».
Cosa fa, non si esprime? L’età l’ha resa più
diplomatico?
«Io diplomatico? Senza generalizzare, la
diplomazia è talvolta una bellissima dama che suole avere rapporti intimi col
compromesso, generando dei figli che si chiamano ricatti…Macché, mi sento ancora
un mastino, come ero stato soprannominato a Palmi. Non ho più il fisico, né
l’età e soprattutto il ruolo per poter dire o fare determinate cose, ma sono
rimasto quello di sempre. Mi diverto talora, a scrivere qualche articolo».
La massoneria è stata una costante nella sua vita.
«Sì, ma io non sono né sono stato nemico della
massoneria regolare. Mi sono occupato a Palmi delle logge coperte sulla base
delle dichiarazioni di numerosi pentiti circa i legami tra mafia ed alcuni
settori deviati della massoneria. Si trattava, secondo quanto dichiarato, di
organizzazioni segrete aventi complicità ramificate. Quando andai via da Palmi
il procedimento venne trasmesso a Roma, dove fu archiviato. Tranne qualche rara
eccezione in passato, sulla massoneria coperta è caduto il più assoluto e
generale silenzio. Ecco, avendo avuto concrete notizie di reato, io avevo
doverosamente, cioè obbligatoriamente, agito in base ad esse».
Le sue inchieste l’hanno messa spesso nei guai.
«Sì, sono state spesso malviste. Sono andato
numerose volte in giro per i Tribunali a difendermi da accuse offensive contro
cui avevo sporto querela. Su di me hanno detto e scritto tante cose, c’è un sito
in cui mi si accusa addirittura di aver parlato malissimo di Giovanni Falcone,
il che non risponde alla realtà: quando ero a Palmi collaborammo insieme, venne
a trovarmi in Procura e pranzammo al ristorante, altro che avversario».
A ottant’anni la vita ha altre priorità. I ritmi
sono più lenti ma forse anche più piacevoli.
«Mi manca invece l’attività. Trascorro le giornate
a leggere, talvolta lo faccio fino alle tre del mattino. Ho ancora i ritmi di
quando lavoravo in Procura. Navigo anche su Internet, anche se prima ne ero
alieno».
Legge libri o quotidiani?
«Tutti e due. I quotidiani che più mi interessano
sono quelli che non appartengono né alla destra né alla sinistra, che mi aiutano
nella comparazione delle notizie ampiamente propagandate».
Che ne pensa delle unioni civili?
«Non le condivido, in quanto equivalgono ad un
matrimonio civile e sono contro natura in quanto il termine matrimonio deriva
dal latino mater, cioè unione finalizzata alla maternità. Ovviamente non è colpa
degli omosessuali la loro caratteristica, ma è discutibile la loro unione
legale, cioè matrimoniale. A tal punto, beninteso scherzosamente, perché non
legalizzare anche la poligamia, in modo da consentire che il marito abbia più
mogli, e, per la parità dei diritti, la moglie più mariti, riducendo così i casi
di adulterio?».
Lei viene quasi ogni pomeriggio a sedersi in
questa piazza. Non si sente un po’ solo?
«È il mio osservatorio sulla città, mi piace
guardare la vitalità e rilassarmi con i miei ricordi. Uscire di casa, alla mia
età, fa bene».
Non vede qualche amico, magari ex collega?
«No qui a Napoli non ne ho: quasi tutti quelli che
avevo sono spariti. Ho amici a Palmi, a Reggio Calabria, a Roma e in altre
città».
Il sorriso di Agostino Cordova si spegne, il vento
della piazza inizia a diventare sferzante. Un colpo di tosse e lui abbottona il
lungo paltò di colore blu. Napoli è la città che ha segnato, nel bene e nel
male, la sua vita. Una metropoli tentacolare che non lo ha mai veramente
avvinto.
La “cupola” Reggio-Cosenza: le inchieste
di Cordova e i giudici massoni. Da Iacchite del 30
luglio 2017.
RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI.
Da qualche mese ormai stiamo ricostruendo la
genesi dell’asse politico-massonico-mafioso tra Reggio Calabria e Cosenza. Le
inchieste di Federico Cafiero De Raho sono inevitabilmente figlie di quelle
di Agostino Cordova, dello stesso Nicola Gratteri, di Salvatore Boemi e di Luigi
De Magistris. Nessuno di loro, dal 1992 ad oggi, è riuscito a dimostrare
l’esistenza effettiva di questa “cupola” nonostante ci abbiano lavorato con
grande impegno ed ardore. E in mezzo a tanti doppiogiochisti ed esperti in
depistaggi, in una parola sola pezzi deviati dello stato. Siamo partiti dal
bandolo di questa storia, Paolo Romeo, detto dai pentiti il “Salvo Lima
reggino”, che muove le fila della politica a Reggio Calabria, grazie ai contatti
organici con le cosche e la massoneria. Finita la prima guerra di mafia, secondo
le dichiarazioni di diversi pentiti, Giorgio De Stefano, insieme al cugino Paolo
e ad altri appartenenti alla nuova ’ndrangheta, entrò nella loggia massonica
segreta fondata, tra gli altri, da Franco Freda e Paolo Romeo, esponenti della
destra eversiva che il 14 luglio 1970 avevano organizzato la rivolta dei “Boia
chi molla” a Reggio Calabria (per protesta contro l’elezione di Catanzaro a
capoluogo di regione). Il pentito Giacomo Lauro affermerà: “Mi risulta
personalmente che anche alcuni magistrati avevano aderito alla massoneria e, per
garantirli, la loro adesione era all’orecchio e i loro nominativi venivano
tramandati da maestro a maestro”. Un sistema perfetto. Il vero “Modello Reggio”
poi continuato da Scopelliti. Il gancio con Cosenza è Pino Tursi Prato,
socialista prima vicino ai Gentile e poi ribellatosi al loro dominio per sposare
la causa di Paolo Romeo nel PSDI di Antonio Cariglia “niente lascia e tutto
piglia” come scriveva nei telegiornali di Telecosenza Giacomo Mancini, alla cui
corte sarebbe poi approdato. Romeo e Tursi Prato, con l’aiuto di due capibastone
della malavita cosentina come Franco Pino e Pietro Magliari, mettono a segno
un’estorsione ai danni di un imprenditore reggino che aveva vinto un appalto
nell’USL comandata dallo stesso Tursi Prato. E siglano la tregua con Tonino
Gentile in uno studio legale cosentino, garante sempre Franco Pino. Il dado è
tratto. Tursi Prato e Romeo vengono eletti a sorpresa alle Regionali del 1990 ma
bussa alle porte il 1992, l’anno di Tangentopoli e delle grandi inchieste. E se
Tursi Prato ha un rapporto privilegiato con la cosca reggina dei De Stefano,
altri socialisti hanno intessuto trame con la ‘ndrangheta, a Rosarno, il regno
dei Pesce. Ancora una volta la prova di un altro importante asse Reggio-Cosenza.
QUARTA PUNTATA. Alla vigilia delle elezioni
politiche nazionali del 1992 scattò quello passato alle cronache come il “blitz
delle preferenze” ordinato dall’allora procuratore di Palmi, Agostino Cordova, e
dall’allora pm della Procura di Locri, Nicola Gratteri. Durante l’operazione,
gli investigatori trovarono in diverse abitazioni di ‘ndranghetisti della Piana
di Gioia Tauro e delle Locride, numerosi santini elettorali e fac-simili
elettorali di alcuni candidati alla Camera dei deputati ed al Senato, fra i
quali anche quelli di Sandro Principe. All’epoca Principe era appena
quarantenne, alla seconda esperienza da deputato e viveva ancora un po’
nell’ombra del padre Cecchino prima da giovane sindaco di Rende (il loro feudo
indiscusso trasformato in città modello con tanto di università) e poi
da altrettanto giovane deputato investito della carica di sottosegretario al
Lavoro ai tempi delle prime grandi vertenze regionali. Il procuratore Agostino
Cordova chiese due volte alla Camera dei Deputati l’autorizzazione a procedere
contro l’allora onorevole Sandro Principe, autorizzazione però sempre negata.
Nella richiesta del procuratore Cordova era dato leggere di una “campagna
elettorale fatta per Sandro Principe da mafiosi e pregiudicati della Piana di
Gioia Tauro (boss Versace di Polistena, Avignone di Taurianova, Pesce e Pisano
di Rosarno ed altri)”. I carabinieri riuscirono pure a fotografare alcuni
incontri di Sandro Principe con Marcello Pesce, esponente dell’omonimo clan, in
un bar di Rosarno. Agli atti spediti nella richiesta di autorizzazione a
procedere, anche le presunte lettere di “raccomandazione” inviate da Sandro
Principe all’allora sottosegretario alla Difesa socialista al fine di far
ottenere l’esonero dal servizio militare di un pregiudicato di Rosarno
fratellastro di Marcello Pesce. Secondo i magistrati Agostino Cordova e
Francesco Neri, tale ultimo favore sarebbe stato chiesto a Sandro Principe
dall’allora consigliere comunale socialista di Rosarno, La Ruffa, ben noto alle
forze dell’ordine e cognato degli stessi Pesce. Un atto assolutamente
illegittimo, secondo i magistrati inquirenti, visto che il fratellastro di
Marcello Pesce era stato dichiarato idoneo al servizio militare. L’intera
vicenda si concluse per Sandro Principe nel migliore dei modi. Nel 1995 la
Procura di Palmi (Cordova nel frattempo era già divenuto dal 1994 procuratore di
Napoli) chiese ed ottenne dal gip l’archiviazione per le accuse rivolte a Sandro
Principe. Fonte: Zoom24 – Giuseppe Baglivo. Agostino Cordova, figura controversa
e testarda, da procuratore di Palmi firma, nel 1992, la prima grande inchiesta
italiana sulla massoneria deviata. Partendo dagli affari del clan Pesce,
attraverso la scoperta di relazioni pericolose tra mafiosi, politici e
imprenditori calabresi, Cordova finì nelle trame degli affari miliardari di
Licio Gelli e di una miriade di personaggi legati a logge massoniche coperte.
“La massoneria deviata – sosteneva Cordova – è il tessuto connettivo della
gestione del potere […]. È un partito trasversale, in cui si collocano
personaggi appartenenti in varia misura a quasi tutti i partiti…”. Cordova pone
sotto sequestro il computer del Grande Oriente d’Italia, contenente l’archivio
elettronico di tutte le logge massoniche italiane. Fu come aprire un vaso di
Pandora, da cui continuavano a uscire nomi e connessioni.
LA MASSONERIA COSENTINA: ETTORE LOIZZO. Ed ecco
apparire all’orizzonte un altro cosentino dopo Pino Tursi Prato, Antonio
Gentile, Franco Pino, Franz Caruso e Pietro Magliari, che abbiamo incontrato
nelle puntate precedenti. “Ettore Loizzo di Cosenza, mio vice nel Goi, persona
che per me era il più alto rappresentante del Goi, nel corso di una riunione
della Giunta del Grande Oriente d’Italia che io indissi con urgenza nel 1993
dopo l’inizio dell’indagine del dottor Cordova sulla massoneria, a mia precisa
richiesta, disse che poteva affermare con certezza che in Calabria, su 32
logge, 28 erano controllate dalla ‘ndrangheta. Io feci un salto sulla sedia”. A
dirlo è stato l’ex Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia Giuliano Di
Bernardo – in carica nei primi anni ’90 e fondatore poi della Gran Loggia
Regolare d’Italia – sentito il 6 marzo 2014 dal pm della Dda di Reggio Calabria
Giuseppe Lombardo nell’ambito dell’inchiesta Mammasantissima sulla cupola
segreta degli “invisibili” della ‘ndrangheta. Ma chi è Ettore Loizzo di Cosenza?
Prima Gran Maestro Aggiunto e poi reggente del Grande Oriente d’Italia, è il
calabrese col “grembiulino” che ha raggiunto i più alti livelli della Massoneria
di Palazzo Giustiniani, la più importante tra le “obbedienze” riconosciute nel
nostro paese. E’ scomparso nel 2011. Per capire bene chi era bisogna andare
parecchio indietro nel tempo. Ma possiamo partire da un dato: Loizzo è stato per
anni un brillante esponente del Partito Comunista Italiano prima di essere
costretto a lasciarlo proprio perché massone dopo il caso eclatante della loggia
P2 di Licio Gelli degli anni Ottanta e la successiva legge Anselmi che vietava
le società segrete. E quindi consigliava ai partiti di imporre una scelta ai
massoni più o meno esposti.
LE INDAGINI SU ETTORE LOIZZO. Ettore Loizzo
finisce nel calderone. Ecco l’agenzia AGI del 5 novembre 1992. (AGI) Cosenza 5
Nov – Proseguono, anche a Cosenza, le indagini disposte dalla Magistratura di
Palmi alla ricerca delle prove circa l’esistenza di logge massoniche” coperte”.
Sono stati perquisiti lo Studio e l’abitazione dell’esponente massonico
Ettore Loizzo (anche se l’interessato ha negato il fatto) e quella di Mario
Lucchetta, Gran Maestro della Loggia” fratelli Bandiera”. In quest’ ultima
abitazione, secondo indiscrezioni, sarebbero stati sequestrati documenti e
carteggi ritenuti importantissimi. (AGI)
Così scriveva invece La Repubblica. Vengono fuori
molte sorprese. A Cosenza, dove sono stati perquisiti lo studio e l’abitazione
dell’ingegner Ettore Loizzo, uno dei massimi esponenti del Grande Oriente d’
Italia, i carabinieri hanno trovato carte e documenti relativi al processo su
mafia, droga e politica da cui è scaturita questa maxi-inchiesta sulla
massoneria deviata. In che maniera, con quale interesse e per farne quale uso
Loizzo è entrato in possesso di quelle carte? Sono interrogativi che i
magistrati cercheranno di chiarire. Ma nell’ inchiesta sulle cosche di Rosarno è
coinvolto anche Licio Gelli. E in Calabria c’era qualche massone che si era
adoperato per far riammettere l’ex capo della P2 nella massoneria. Una
“trattativa” che si sarebbe conclusa nel 1991 con un accordo mai trovato
dai magistrati di Palmi. Così come non furono mai chiarite le questioni che
ruotavano intorno a Loizzo. Di sicuro, però, Di Bernardo si affretta ad uscire
da questo grandissimo casino e lascia le responsabilità del suo incarico
determinando la scissione. E così il cosentino Ettore Loizzo diventa Gran
Maestro Onorario e reggente, con Eraldo Ghinoi, del Grande Oriente d’Italia nel
1993. Praticamente il nuovo capo della massoneria al posto di Di Bernardo. Già,
Di Bernardo. Oggi che Loizzo non c’è più, è il solo che può riferire di quelle
circostanze e nello specifico, dopo la clamorosa rivelazione del massone
cosentino circa le 28 logge infestate dalla ‘ndrangheta, afferma testualmente.
“Gli dissi: e cosa vuoi fare di fronte a questo disastro. Lui – ha detto Di
Bernardo al pm – mi rispose: nulla. Chiesi perché. Mi rispose che altrimenti lui
e la sua famiglia rischiavano gravi rappresaglie. Fu questo che mi indusse a
prendere contatti con il Duca di Kent, che è al vertice della Massoneria Inglese
che è la vera Massoneria. Mi disse che già sapeva questa situazione tramite
notizie avute dall’Ambasciata in Italia e dai servizi di sicurezza inglesi”. Ma
Ettore Loizzo, già all’epoca, contestava con forza questa interpretazione dei
fatti e definiva pesantemente Di Bernardo. “L’indagine di Cordova? Con questa
rottura diplomatica tra noi e gli inglesi non c’entra – risponde Loizzo – anche
se le menzogne di Di Bernardo hanno fatto da copertura a questo gioco. Non siamo
stati neanche ascoltati dai fratelli inglesi – reclama più diplomatico Ghinoi –
ma un imputato ha diritto ad un processo. Per quanto riguarda Cordova ci ha
ricevuto ed ha specificato di non aver nessuno motivo di contestazione nei
nostri riguardi, ma è interessato alla scoperta di eventuali logge deviate. Dal
canto nostro abbiamo sospeso 75 fratelli sospetti, ma sono un esiguo numero di
fronte agli altri 18mila iscritti oltre alle 1400 domande attualmente in attesa.
Succede solo in in Italia – ha concluso Ghinoi – che l’iscrizione ad alcuni
partiti politici sia vietata a membri della Massoneria. Ma la storia insegna che
quando la Massoneria è attaccata, successivamente dopo viene attaccata la
democrazia”. Il 27 maggio del 1993 Cordova inviò un rapporto al Csm
sull’ingerenza dei massoni nel potere pubblico: consegnò i nomi di 40 giudici e
due liste di parlamentari. Comunicò che almeno 40 degli inquisiti della
tangentopoli milanese erano massoni, così come lo erano 11 dei parlamentari per
i quali è stata richiesta l’autorizzazione a procedere. Provvidenziale arrivò
l’ordine di trasferire per competenza a Roma le indagini. E ancor più salvifico
fu il ruolo del pm che venne delegato. Era Augusta Iannini, moglie di Bruno
Vespa, che sarebbe diventata di lì a poco personalità di spicco a via Arenula
nei governi targati Berlusconi. Quell’inchiesta naufraga nel 2001 in una
colossale archiviazione. «E da allora – raccontò Cordova alla Voce in
un’intervista di qualche anno fa, alla vigilia del suo trasferimento forzato
dalla Procura di Napoli – quei faldoni sono rimasti a marcire dentro i
sotterranei di Piazzale Clodio».
CHI COMANDA IL MONDO E LE INCHIESTE CHE NON SI
DEVONO FARE.
Quelli che decidono tutto: nomi, cognomi,
club, confraternite e…scrive Alberto Di Pisa su
"Sicilia Informazioni" l'8 novembre 2017. Spesso sulla stampa, nei media, nei
talk show, in numerosi libri, si parla di poteri forti. Ma a cosa ci si
riferisce con tale espressione? Tale espressione sta ad indicare un ristretto
numero di persone che, in piena autonomia, gestisce i capitali e la finanza del
mondo. In questi casi il pensiero va alle grandi dinastie dei banchieri come
i Rothschild, J.P. Morgan, i Rockfeller o ancora la famiglia Hahn-Elkann e la
famiglia Worms, la famiglia Thyssen, la famiglia Kahn, la famiglia Goldschmidt,
le famiglie Fitzgerald e Kennedy, le famiglie Agnelli – Caracciolo e molte
altre. Si tratta di poteri per lo più sconosciuti all’uomo comune ma che
agiscono in silenzio ed hanno una notevole influenza sulle decisioni dei governi
ufficiali. Scrive Marco Pizzuti nel suo libro “Rivoluzione non autorizzata” con
riguardo a siffatti poteri: “Il loro braccio esecutivo” clandestino per
eccellenza è la massoneria, un’organizzazione praticamente sconosciuta alla
popolazione, che da secoli occupa tutti i palazzi del potere. Non è quindi una
mera coincidenza se ritroviamo i suoi membri tra i principali leader di ogni
grande capovolgimento storico”. Negli ultimi decenni la massoneria è stata
affiancata da altri organismi, creati dalla èlite finanziaria, tra i quali vanno
menzionati il club Bilderberg, la Commissione Trilaterale, il CFR, la Round
Table e il club di Roma. Scrive ancora Marco Pizzuti nel succitato libro: “Tutti
questi nuovi organismi cooperano con la massoneria, per accelerare il processo
di globalizzazione nel rispettivo campo di competenza e ambito territoriale” Al
fine di realizzare tale obiettivo i suddetti organi invitano nei loro club gli
esponenti di maggiore spicco delle varie categorie sociali: industriali,
banchieri, politici, scrittori, giornalisti, militari. Nel settore bancario
internazionale particolarmente rilevante è, ad esempio, il ruolo svolto in
passato e fino ad oggi dalla famiglia Rothschild, proprietaria di un impero
bancario che, secondo le stime degli esperti controllerebbe più di 350 miliardi
di dollari. Tra i componenti della famiglia, un ruolo primario ricopre Jacob
Rothschild il quale, oltre a gestire i beni di famiglia, gestisce anche i beni
di oltre 10 mila azionisti. Lo stesso ha intrattenuto rapporti con i più
importanti uomini di governo e della politica internazionale quali i presidenti
degli Stati Uniti Ronald Reagan e Bill Clinton e l’ex primo ministro inglese
Margaret Thatcher. Nel 2002 organizzò l’European Economic Round Table al quale
intervennero ospiti di prestigio quali Nicky Oppenheimer, Warren Buffet,
importante imprenditore ed economista statunitense, considerato il più grande
valueinvestor di sempre (nel 2003 definì i derivati come armi finanziarie di
distruzione di massa), Arnold Schwarzenegger, attore, politico, imprenditore e
produttore cinematografico, James Wolfensohn, economista e banchiere australiano
naturalizzato statunitense. Non inferiore a quella degli Rothschild è certamente
la potenza finanziaria della famiglia Rokfeller il cui più prestigioso esponente
è stato David Rockfeller uno dei fondatori del gruppo Bilderberg e della
Commissione Trilaterale. Nel 2012 Rockfeller e Rothschild, due delle più grandi
famiglie di banchieri, si riunirono. La “RIT Capital Partners” di Jacob
Rothschild acquistò una quota del “Financial Services di Rockfeller. Si trattò
di un accordo storico a seguito del quale la RIT Capital Partners divenne socio
del gruppo Rockfellere con il 37% di capitale. Il potere finanziario dei
Rothschild è presente anche in Italia dove il gruppo Rothschild ha condotto
l’acquisizione di Armani Exchange da parte di Armani Group, e ha avuto il ruolo
di advisor per Cassa Depositi e Prestiti e Fintecna sulla privatizzazione di
Fincantieri attraverso un’IPO di 390 milioni, e per l’acquisizione del 40% di
Ansaldo Energia da parte di Shanghai Electric per ben 400 milioni di euro, e
dalla creazione di due joint venture e dalla fusione da 24 miliardi di euro tra
Atlantia e Gemina. Dovendo parlare di poteri forti non si può non parlare del
gruppo Bilderberg del quale, come si è detto, uno dei fondatori fu David
Rockfeller su iniziativa del quale nel maggio del 1954 fu organizzato il primo
incontro. Il gruppo nacque con lo scopo di favorire, in un forum annuale, il
dialogo tra l’Europa e il Nord America. Alle riunioni sono invitati a
partecipare circa 120-150 leader politici, esponenti qualificati dell’industria,
della finanza, del mondo accademico e dei media. L’incontro è un forum di
discussioni informali sui trend e le principali problematiche che affliggono il
mondo. Gli incontri sono caratterizzati da segretezza dato che non possono
essere rivelate all’esterno le informazioni ricevute né l’identità o la
appartenenza di chi ha fornito le informazioni. Non vi è alcun programma
dettagliato, non vengono proposte delle risoluzioni, non viene espresso alcun
voto e non viene esternata alcuna dichiarazione politica. E’ stata proprio la
natura segreta dell’evento e del contenuto delle discussioni svolte all’interno
del forum che intorno al gruppo Bilderberg ha fatto sorgere teorie complottiste,
a mio avviso, non del tutto infondate. Sul presupposto che è impensabile
ritenere che nel contesto di un mondo globalizzato qualsiasi questione, sia in
Europa che nel Nord America possa essere affrontata in modo unilaterale, nel
corso degli anni, gli incontri annuali hanno avuto ad oggetto una vasta gamma di
argomenti spaziando dal commercio, ai posti di lavoro, alla politica monetaria
per gli investimenti alla sicurezza e alle dinamiche politiche internazionali.
Nel club Bilderberg vi sono stati e vi sono anche italiani. Si possono
ricordare Franco Bernabè, banchiere e dirigente pubblico, già amministratore
delegato dell’ENI e successivamente di Telecom Italia, fondatore di FB Group,
holding di partecipazioni e management company di un gruppo attivo nel settore
della consulenza strategica dell’ITC e delle energie rinnovabili e investito di
numerosi altri incarichi di prestigio tra cui quello, dal 2011 al 2013 di
Presidente della GSMA, organizzazione internazionale che riunisce gli operatori
di telefonia mobile eancora membro dell’European Roundtable of industrialist e
dell’International Council di JP Morgan. Si possono poi ricordare come facenti
parte del club Bilderberg gli italiani Claudio Costamagna e John Elkann, il
primo banchiere e dal luglio 2015 presidente della Cassa Depositi e Prestiti
oltre che Presidente di FSI SGR Spa, società costituita dalla riorganizzazione
del Fondo strategico italiano Spa-FSI di cui è statoa sua volta presidente e il
secondo presidente della Fiat Chrysler Automobiles oltre che presidente ed
amministratore delegato della Exor N.V. una società di investimento controllata
dalla famiglia Agnelli. Sembra facciano parte del club anche la nota giornalista
della rete televisiva “La 7” Lilli Gruber nonché Carlo Ratti, architetto ed
ingegnere, docente presso il Massachuttes Institute Technology di Boston. In
passato, ci sono stati anche tanti altri membri italiani nella Bilderberg. Tra i
quali spicca il nome dell’ex premier Mario Monti, un vero e proprio habitué
della Bilderberg. Poi spiccano i nomi di Giovanni Agnelli, Umberto Agnelli,
Renato Ruggiero, Barbara Spinelli, Marco Tronchetti Provera, Mario Draghi,
Alessandro Profumo, Monica Maggioni, presidente della RAI e molti altri ancora.
Per avere un’idea del potere che gestisce il gruppo Bilderberg basta pensare che
tutti coloro che ne fanno parte possiedono più della metà del patrimonio
mondiale, il che induce ad avanzare qualche dubbio sul fatto che la finalità di
questo club e dei relativi incontri sia quella di “aumentare i dialoghi tra
Nord-America ed Europa e che i partecipanti si incontrino per tre giorni
all’anno soltanto per trascorrere un piacevole weekend o per perseguire finalità
benefiche. Così come si è indotti a ritenere che ogni qualvolta questo enorme
potere finanziario e non solo, venga messo in pericolo, il club reagisca con
azioni non sempre ortodosse per usare un eufemismo. E non è un caso se ogni
familiare di David Rockfeller è o direttore della CIA o ambasciatore all’ONU o
segretario di Stato o ricopre incarichi di vertice nel settore della sanità. Lo
stesso David Rockfeller è stato d’altra parte, dal 2000, presidente ed
amministratore delegato di JP Morgan, la banca che certamente costituisce uno
dei poteri forti di cui parliamo. Il gruppo Bilderberg raccoglie i potenti della
terra, leader politici ed economici precursori della globalizzazione, di diversi
paesi come, può constatarsi ad esempio avuto riguardo alla riunione che nel
2002, in un clima di segretezza e tra rigide misure di sicurezza, ebbe luogo a
Chantilly in Virginia. Ebbene, a tali lavori parteciparono, tra gli altri, l’ex
segretario di Stato americano Henry Kissinger, e l’ex direttore generale del
Tesoro, Mario Draghi, oggi presidente della BCE. Più di recente, nel 2012 ha
avuto luogo a Roma, una riunione del gruppo Bilderberg alla quale era presente
Mario Monti, allora Presidente del Consiglio, che illustrò agli intervenuti gli
sforzi dell’Italia per rimettere i conti in ordine. Presenti tra gli altri gli
allora ministri Francesco Profumo, Paola Severino ed Elsa Fornero. Presenti
erano anche importanti esponenti del mondo finanziario quali Ignazio Visco
(Bankitalia), Alberto Nagel (Mediobanca), Rodolfo de Benedetti (CIR), Mauro
Moretti (FS), Enrico Cucchiani (Intesa), Fulvio Conti (Enel), Etienne Davignon
(già commissario europeo per il mercato interno). Presenti anche esponenti del
mondo del giornalismo come Lilli Gruber. A presiedere il gruppo vi era Henry De
Castries, pdg di Axa, società di assicurazioni. Numerose furono le contestazioni
e le critiche allora formulate in occasione del suddetto incontro sia da parte
della sinistra che della destra. In particolare affermò Francesco Storace che
“partecipare al Bilderberg è peggio che essere della P2, è commettere
tradimento”. Per quanto riguarda la partecipazione del Presidente del Consiglio
Mario Monti, Palazzo Chigi fece sapere che Monti aveva accettato l’invito per
poter parlare delle misure adottate dall’Italia per combattere la crisi e che
“le polemiche sono fuor di luogo”. Monti ha ricoperto anche cariche nella
Commissione Trilaterale, nella Università Bocconi, di cui era presidente, e in
Goldman Sachs, incarichi abbandonati all’atto della sua nomina a presidente del
Consiglio. Peraltro è stato sostenuto, non senza fondamento, che il forum del
gruppo Bilderberg altro non è che un consesso dei poteri forti che decide le
sorti del mondo, fuori dai meccanismi democratici. Di Contro Etienne Davignon
nel negare questa caratteristica del gruppo Bilderberg ha affermato: “Se fossimo
la cupola segreta che comanda il mondo dovremmo vergognarci come cani” Certo
Davignon convince meno quando afferma che le 130 personalità che si incontrano
ogni anno sono importanti quanto la cena sociale di un Cral di ferrovieri. Del
club fanno parte e vi vengono invitate soltanto personalità di rilievo del mondo
economico, finanziario, politico, dei media. Significativo è quanto verificatosi
in occasione della riunione tenutasi nel 2011 a Saint Moritz e alla quale erano
presenti tra gli altri Henry Kissinger, David Rockfeller, Paolo Scaroni,
banchieri internazionali, imprenditori greci e spagnoli. In tale occasione,
l’allora eurodeputato della Lega Nord, Mario Borghezio, si presentò al bureau
per chiedere di partecipare ai lavori ma venne malamente allontanato. Dichiarò
allora all’ANSA: “Ci hanno letteralmente preso a spintoni. Mi hanno anche dato
un colpo al naso che ora è sanguinante. Un comportamento che smaschera la reale
natura di questa consorteria: è una società segreta e non un gruppo che si
riunisce in modo riservato”. Sembra che questi incontri, ai quali più volte
Gianni Agnelli aveva partecipato gli piacessero meno di quelli dell’altro grande
circolo di potenti, la Trilaterale fondata nel 1972 dal suo grande amico David
Rockfeller. La natura del gruppo Bilderberg e le sue finalità sono molto
discusse e le critiche nei confronti di tale gruppo provengono sia dalla
sinistra che dalla destra. Comune ad entrambe è la convinzione che ci si trovi
in presenza di una organizzazione globale che vuole dominare il mondo. Per la
sinistra si tratterebbe di un organismo composto da capitalisti e finanzieri che
ordiscono trame politiche ed economiche mentre per la destra si tratterebbe di
una elite che intenderebbe imporre i propri disegni, tipo euro, in un mondo
antidemocratico. Al di là di enfatizzazioni, non vi è dubbio che il Bilderberg è
un gruppo di capitalisti che difendono il capitalismo. Nel corso degli incontri
i partecipanti affrontano non solo temi politici, di economia o di finanza ma
probabilmente discutono di affari e magari ne fanno e talvolta favoriscono
qualche nomina rilevante. Forse non è una coincidenza il fatto che, dopo la
partecipazione di Herman Van Rompuy ad una cena organizzata dal gruppo a
Bruxelles, questi, poco tempo dopo divenne presidente del Consiglio europeo. Van
Rompuy, appena eletto presidente del Consiglio UE, si dimostrò favorevole ad un
prelievo sulle transazioni finanziarie, una specie di Tobintax. Lo stesso, prima
della sua nomina aveva spiegato questo suo orientamento ai potenti politici,
banchieri e uomini d’affari del riservato gruppo Bilderberg in un incontro
avvenuto nel castello di Valduchesse, nelle vicinanze di Bruxelles, in occasione
della cena di cui sopra. Ma negli incontri si parla anche di vicende
internazionali. Così, in occasione della riunione tenutasi a Saint Moritz, si
parlò molto di Grecia, di dollaro, di Libia e del conflitto interno all’Opec tra
sauditi e iraniani sul prezzo del barile di greggio. Se forse è eccessivo
affermare che il gruppo Bilderberg costituisce una organizzazione globale che
vuole dominare il mondo tuttavia tale ipotesi non è del tutto priva di un
qualche fondamento. Ma vi è chi va oltre e ritiene la implicazione del club
Bilderberg anche in vicende tragiche che hanno attraversato il nostro Paese.
Così l’ex magistrato Ferdinando Imposimato, nel suo libro “La Repubblica delle
stragi impunite” e in una intervista rilasciata in occasione della presentazione
del libro sostiene che: “La stagione delle stragi non serviva a destabilizzare
lo Stato, serviva ad impedire la dinamica politica nel senso di portare gli
equilibri politici da destra verso la sinistra.” E continua: “Hanno fatto tutto
questo non per fare un colpo di Stato ma per rafforzare il potere,
destabilizzare l’ordine pubblico per stabilizzare il potere politico”. E
spingendosi oltre afferma, facendo riferimento ad un documento rinvenuto tra gli
atti della indagine condotta dal giudice Alessandrini sulla strage di Bologna e
riportato nel libro, che il gruppo Bilderberg sarebbe responsabile della
strategia della tensione e quindi anche delle stragi. “Il Bilderberg-afferma-
governa il mondo e le democrazie in modo invisibile, in modo da condizionare lo
sviluppo democratico di queste democrazie”. Si è sostenuto poi da Carlo
Freccero, ma anche nei media e in varie pubblicazioni, tra cui Micro Mega, che
Casaleggio & C sarebbero legati al gruppo Bilderberg e con una tesi alquanto
azzardata, ma forse non priva del tutto di fondamento, anche se sfornita di
prove certe, sostiene che i poteri forti “si sarebbero costruiti una gestibile
opposizione interna attraverso Casaleggio, Grillo e quindi il movimento Cinque
Stelle”. Ciò sarebbe avvalorato dal fatto che del gruppo Bilderberg, sempre
secondo Freccero, farebbe parte il giornalista Enrico Sasson, socio di
Casaleggio, manager legato all’Aspen Institute e quindi al gruppo Bilderberg.
L’Aspen Institute , che sorge a Roma in Piazza Navona, è una filiale locale
europea dell’Aspen e una ramificazione italiana dell’internazionale Club
Bildenberg e la cui finalità è l’internazionalizzazione della leadership
imprenditoriale. Enrico Sasson, in una lettera indirizzata al Corriere della
Sera, pur ammettendo di essere socio di minoranza nella Casaleggio associati,
precisava di non rappresentare alcun potere forte, di non conoscere Beppe
Grillo, mai incontrato, di non avere mai partecipato alla gestione del suo blog
in seno alla Casaleggio Associati, di non avere mai avuto niente a che fare con
il movimento Cinque Stelle. Affermava essere calunniose e diffamatorie le teorie
del complotto apparse in blog e in siti di diversa connotazione e che era una
informazione distorta e malata quella che, anche in articoli e servizi
televisivi, sosteneva il teorema dei poteri forti dediti ad infiltrare il
Movimento. Se la tesi di Carlo Freccero fosse fondata, ciò significherebbe che
il potere avrebbe deciso lui stesso di gestire l’opposizione. In altri termini,
se dietro il Bilderberg vi fosse la Casaleggio, ciò significherebbe che il
potere avrebbe deciso di infiltrare l’opposizione. Molto legata al gruppo
Bilderberg è la Commissione Trilaterale all’interno della quale sono presenti
più di 200 personalità eminenti (uomini politici, diplomatici, industriali,
finanzieri, universitari, giornalisti) provenienti da Europa, America, e
Giappone. Anche la Trilaterale fu fondata, qualche anno dopo la Bilderberg, da
David Rockfeller, presidente della Chase Manhattan Bank di New York e altri
dirigenti tra cui Henry Kissinger e pare anche da Gianni Agnelli anche se, per
quanto riguarda quest’ultimo, non vi sono documenti che lo provino. Mario Monti
ne fu presidente dal 2010 al 2011. Nel 2016, dopo oltre 33 anni, la Commissione
Trilaterale si è riunita a Roma; in tale occasione gli Italiani che vi hanno
partecipato sono stati oltre 20 tra cui Mario Monti, John Elkan, Mario
Tronchetti Provera e la presidente della RAI Monica Maggioni. Riunioni della
Commissione sono state tenute a Tokio, Washington, Parigi, Kioto e come si è
detto in Italia. In occasione di una riunione avvenuta a Parigi nel dicembre del
1975 ed avente ad oggetto la gestione delle risorse mondiali, alla domanda su
chi finanziasse l’attività della commissione, il direttore della stessa Zbigniew
Brzezinky rispondeva: “Cittadini privati e qualche governo con contributi di
minore importanza”. In occasione dell’incontro di Parigi si parlò sulla stampa
di “un nuovo ordine mondiale”, affermazione non del tutto campata in aria se si
considera che a tale riunione intervennero e fecero un discorso l’allora primo
ministro Jacques Chirac e l’ex governatore della Banca d’Italia Guido Carli.
Gianni Agnelli, intervenendo, nel 1984 alla riunione della Commissione
Trilaterale a Washington, sottolineò il ruolo dei vertici economici dei “sette
grandi”, cioè i sette paesi più industrializzati.
Chi comanda, come e perché, dalle Logge
all’Opus Dei, finanza e…scrive Alberto Di Pisa su
"Sicilia Informazioni" l'11 novembre 2017. Alla riunione della Trilaterale che
ebbe luogo a Roma nell’aprile del 2016 parteciparono uomini di governo, ministri
imprenditori, i massimi esponenti della classe dirigente mondiale del Nord
America, Europa ed Asia. Tra i partecipanti vi furono l’ex presidente del
Consiglio Enrico Letta, Jean Claude Trichet, ex presidente della BCE, Monica
Maggioni, presidente della RAI. Presenti anche Andrea Guerra, ex AD di
Luxottica, molto amico di Renzi, Maria Elena Boschi, allora ministro delle
riforme che una settimana prima della Trilaterale, in una intervista aveva
dichiarato: “Ci attaccano proprio perché non siamo schiavi dei poteri forti, non
siamo il terminale di niente e di nessuno. Questo non piace a
molti” Affermazione quanto meno strana se si considera che svolse un intervento
in un meeting in cui erano presenti i poteri più forti del pianeta. Per dare una
idea del vero e proprio grumo di potere presente alla riunione della Trilaterale
di Roma basta considerare che tra gli invitati vi erano persone come Michael
Bloomberg, miliardario, ex sindaco di New York, Jurghen Fitchen, della
DeutschBank, Gerald Corrigan, vice presidente della Federal Reserve oggi a
Goldman Sachs, Eric Schmidt, presidente di Google, Marta Dassau Finmeccanica,
Herman Van Rompuy ex presidente del Consiglio europeo, oltre che David
Rockfeller, fondatore della Trilaterale. Gianfelice Rocca, presidente
dell’Assolombarda, intervistato da un giornalista della “Gabbia”, al termine
della riunione dichiarava: “Io credo che questo governo abbia il sostegno di
gran parte dell’establishement”. Secondo indiscrezioni trapelate dalla riunione,
nell’incontro si sarebbe parlato anche del destino affatto roseo dell’Italia: la
Trilaterale non immaginava un bel futuro per il nostro paese. Alla riunione si è
parlato anche di privatizzazioni e di tagli alla spesa, il che significa la
svendita del patrimonio pubblico dell’Italia, cioè la svendita delle aziende
pubbliche. Ma al meeting si è parlato anche di immigrazione e, fatto strano, a
presiedere l’incontro era Peter Satermann, direttore non esecutivo di Goldman
Sachs, rappresentante generale dell’Onu per le migrazioni e componente del
Bilderberg. Come mai e perché uno degli uomini più importanti della finanza
internazionale si occupava di immigrazione? La risposta è semplice: lo scopo
della Trilaterale è quello di favorire l’immigrazione di massa dal sud del mondo
verso l’Europa in maniera da consentire alle multinazionali di avvalersi di una
ingente massa di lavoratori sottopagati. Ciò è avvalorato dal fatto che, sempre
secondo indiscrezioni, tutti i membri della Trilaterale concordarono sul fatto
che i giornali parlassero dei vantaggi dell’immigrazione. Tutto ciò evidenzia la
preminenza del potere economico –finanziario sulla politica che finisce con
l’eseguire il diktat di questa elite di potere e come il fine del Bilderberg,
della Trilaterale e di altri organismi simili, sia quello di togliere sovranità
agli Stati e di creare un nuovo ordine mondiale. Desta impressione oggi leggere
la relazione che, nel 1984, a conclusione della riunione della Trilaterale di
Washington, fu predisposta dall’ex consigliere americano per la sicurezza
Zbgniew Brzezinsky, dal segretario del partito socialdemocratico David Owen e
dall’ex ministro degli esteri giapponese Saburo Okita, per conto della
Commissione Trilaterale, relazione nella quale vengono indicati quelli che
sarebbero stati i quattro pericoli per il mondo. Sembra quasi che i redattori
del rapporto avessero previsto, con estrema precisione, e con 33 anni di
anticipo, quello a cui oggi, nel 2017 assistiamo. Secondo quanto si legge nella
suddetta relazione 4 erano i pericoli che, negli anni successivi avrebbero
minacciato il mondo e l’umanità: Un significativo peggioramento della
collaborazione economica e politica tra gli Stati , una crescente
disoccupazione; un abbassamento del tenore di vita e una minore democrazia. Una
escalation dei conflitti regionali, sempre meno contenibili sul piano
internazionale e latori di rischi crescenti di confronto tra est ed ovest.
Grossi sconvolgimenti sociali in ampie zone d’Africa e forse dell’America
latina; fenomeni di carestie di grandi dimensioni che potrebbero sfociare, in
massicce emigrazioni, in caos e violenza, riducendo in questo modo le
prospettive di democrazia ed offrendo maggiori opportunità agli estremisti di
destra e di sinistra di impadronirsi del potere. L’ultimo dei grossi pericoli
che oggi incombono sull’umanità intera e sul pianeta è costituito dal rischio di
una guerra nucleare. Afferma il rapporto della Trilaterale: “La guerra nucleare,
con le sue capacità di provocare morti e distruzioni illimitate, costituisce una
catastrofe dalla quale il globo potrebbe non essere in grado di riprendersi”. Il
pensiero, leggendo queste parole, non può non andare al conflitto tra il premier
nordcoreano e il presidente Trump che oggi rischia l’esplosione di un conflitto
nucleare. Più che di previsioni viene da pensare ad un programma che nel 1984
qualcuno si proponeva di attuare negli anni successivi. Ma forse si tratta di
una idea eccessiva. Ma come soleva dire Andreotti a pensare male si fa peccato
ma spesso si indovina. Per quanto riguarda le reali finalità del gruppo
Bilderberg, gli studiosi di questa materia scrivono a proposito dei promotori
Bernardo de Lippe, ufficiale olandese, ex ufficiale delle SS e Joseph Retinger,
politico polacco e massone : “La loro ambizione era quella di costruire una
Europa Unita per arrivare ad una profonda alleanza con gli Stati Uniti e quindi
dar vita a un nuovo Ordine Mondiale, dove potenti organizzazioni sopranazionali
avrebbero garantito più stabilità rispetto ai singoli governi nazionali…” Al di
là delle teorie complottiste, non vi è dubbio che costituisce un dato
difficilmente smentibile il fatto che ci si trovi in presenza di un intreccio
tra politica, finanza e in particolare banche in cui un gruppo ristretto di
persone, a partire dal 1954 e una sola volta all’anno, si riunisce per decidere,
nella massima segretezza il futuro politico ed economico dell’umanità. “Le
Monde” intravede nelle biografie di Mario Draghi, Mario Monti e Luca Papademos
la prova dei disegni nascosti maturati “nei piani alti della banca d’affari
Goldman Sachs”. Ed è legittimo nutrire dei sospetti sul conflitto di interessi
di cui hanno dato prova i banchieri che, come Corrado Passera sono diventati
ministri nel governo Monti. E non bisogna dimenticare che la caduta di Silvio
Berlusconi fu determinata e voluta dai poteri forti che teleguidarono lo spread.
L’influenza poi del gruppo Bilderberg sulla politica internazionale, secondo
quanto scrive sulla “Repubblica “Giuliano Balestreri, sarebbe comprovata dalla
lettera che Richard Perle, membro del comitato direttivo del gruppo Bilderberg e
teorico del neoconservatorismo americano, scrisse a Bill Clinton per chiedere la
rimozione di Saddam Hussein. Di tale gruppo direttivo, oltre che Henry Kissinger
e Edmond de Rotschild, hanno fatto parte anche 12 italiani tra cui il presidente
di Telecom Italia, Franco Bernabè. Si è anche sostenuto che le riunioni del
Bilderberg fossero anche finalizzate ad ascoltare quelli che sarebbero stati
futuri presidenti e premier, anche degli USA. Così, sarebbero stati ascoltati,
Tony Blair, Hillary Clinton, e lo stesso Barak Obama. Quest’ultimo si dice fosse
presente con Hillary nel 2008, quando Bilderberg avrebbe negoziato un accordo
per passare la mano attendendo le elezioni del 2016. Al meeting, avrebbero
partecipato un paio di volte Mario Monti (nel 2011 e 2013), Enrico Letta (nel
2012). Non sarebbe estranea a Bilderberg la formazione del governo Monti. Non si
ha notizia di una partecipazione di Renzi. Sembrerebbe quindi che per governare
in Italia e nel mondo bisogna essere graditi ai poteri forti. Non può poi non
suscitare dubbi, sul ruolo del Bilderberg nelle vicende internazionali, quanto
scritto dal giornalista inglese, Tony Gosling, in un giornale di Bristol,
secondo cui nel meeting del Bilderberg, nel 2002, si era parlato di invasione
dell’Irak da parte degli USA, ben prima che ciò accadesse. Per comprendere
l’importanza del Gruppo Bilderberg, della Trilaterale e degli altri organismi
simili e il peso che in ambito internazionale queste elite rivestono, basta
avere riguardo all’oggetto delle discussioni che hanno luogo all’interno di
questi gruppi in occasione delle periodiche riunioni anche se il contenuto delle
relazioni e degli interventi è mantenuto rigorosamente segreto. I temi trattati
infatti, riguardano spesso i rapporti tra Europa e Stati Uniti, l’economia e in
particolare la gestione della crisi economica mondiale, l’euro, l’inflazione, il
protezionismo, la globalizzazione, il petrolio, il mercato delle armi,
l’immigrazione. Essendo però segreto il contenuto delle relazioni, non è dato
conoscere le decisioni adottate dal gruppo riguardo tali problematiche; i
partecipanti agli incontri sarebbero però tenuti a mettere in pratica quanto
deciso. L’interrogativo che spesso si pone è quali siano i rapporti tra la
massoneria e gli altri poteri forti anche se deve riconoscersi che le inchieste
che hanno riguardato la massoneria e il potere politico finanziario nazionale e
internazionale, quasi sempre non hanno portato a nulla. E’ appena il caso di
ricordare come l’inchiesta sulla P2 si concluse, dopo tanto clamore, in un nulla
di fatto. Va tuttavia detto che quando si parla di massoneria bisogna tenere
presente che ci si trova in presenza di due diversi livelli: un livello
ufficiale ispirato a temi quali la libertà, l’eguaglianza la tolleranza
religiosa e un secondo livello segreto caratterizzato dalla presenza di comitati
di affari e di rapporti con la criminalità organizzata, mafia, camorra
‘Ndrangheta, servizi segreti deviati e terrorismo stragista. In altri termini ci
si trova in presenza di due mondi paralleli. Ma, come sostenuto da taluno,
esiste un rapporto tra la massoneria e i poteri forti di cui abbiamo parlato e
se esiste a quale dei due livelli fa riferimento? Una risposta interessante ci
viene da Giuliano De Bernardo, ex Gran Maestro della principale “obbedienza”
italiana, il Grande Oriente d’Italia, dal 1990 al 1993, quindi ai vertici della
massoneria, che abbandonò riferendo quello che pensava realmente. Ha dichiarato
De Bernardo: “Dietro Gelli, (che rappresentava il livello oscuro della
massoneria ndr), c’erano gli ambienti americani. Gelli è un prodotto degli
americani”. De Bernardo parla anche del sequestro di Aldo Moro che aveva perso
la fiducia degli americani che lo consideravano “un cavallo di Troia, “un ponte
che avrebbe consentito ai comunisti di arrivare al potere. Quindi gli americani
si trovarono senza rappresentanti autorevoli e affidabili in un Paese chiave
dello scacchiere internazionale. E in piena guerra fredda”. Ed aggiunge: “Sono
anni convulsi, nei quali il confronto tra il mondo atlantico e il blocco
comunista è durissimo: anni di riarmo nucleare, di servizi segreti attivissimi,
di spie, di omicidi politici. Tutto appare lecito in quel momento. La
prospettiva di un sorpasso elettorale da parte dei comunisti, così come
l’ipotesi di un compromesso storico tra Dc e PCI, terrorizza gli ambienti
atlantici”. Il dipartimento di Stato americano e la CIA si convinsero allora di
avere a che fare con una situazione di emergenza in Italia. Gli americani
ritennero, e qualcuno glielo suggerì che, in Italia, Gelli, l’esponente della
più potente loggia massonica mai esistita, era l’uomo adatto ad arginare il
pericolo comunista. Non vi è dubbio quindi che vi fosse un ben preciso interesse
degli americani ad impedire a Moro di realizzare il suo progetto di un
compromesso storico tra DC e PCI. Continua De Bernardo sostenendo che
allorquando divenne Gran Maestro, Lino Salvini, Sindona, Calvi e Gelli
accrebbero il loro potere “fatto di alta finanza, controllo dei media (come il
gruppo Rizzoli-Corriere della Sera), corruzione politica ed uso dei servizi
segreti” e istaurarono collusioni pericolose. Ma De Bernardo parla anche dei
rapporti con la criminalità organizzata e della mafia infiltrata nella famosa
Loggia Garibaldi in cui confluivano esponenti dell’area grigia tra massoneria e
malavita. Dice De Bernardo; “Ricordo che una volta, quando andai in visita a
quella loggia pensai di avere intorno a me tutti i capi di Cosa Nostra in
America”. La potente massoneria americana d’altra parte era legata fin dai tempi
della Seconda guerra mondiale ai servizi segreti e in rapporti organici con
ambienti siciliani. E’ d’altronde un fatto noto che lo sbarco degli alleati in
Sicilia fu preparato dalla massoneria siciliana insieme a elementi della mafia
americana. Io credo che si può dare per acclarata l’esistenza di rapporti non
sempre leciti tra massoneria e potere politico- finanziario nazionale e
internazionale nonché di una contiguità tra il livello oscuro della massoneria e
le realtà criminali presenti nel nostro Paese. Così, per quanto riguarda La P2,
numerose sentenze hanno accertato come Gelli godesse di un potere enorme ed
avesse creato una rete di potere caratterizzata da favoritismi, finanziamenti
concessi ai privati dalle banche vicine alla P2, da rapporti anche con poteri
criminali, e come avesse un ruolo rilevante nel favorire le nomine anche di
personaggi delle istituzioni; ma se aveva il potere di fare nominare una
determinata persona, aveva anche il potere di asservirla a sé. E’ appena il caso
di ricordare come Gelli raggiunse l’apice del proprio potere con l’appoggio di
banchieri iscritti alla P2 quali Michele Sindona e Roberto Calvi. Va poi
ricordato, a proposito degli intrecci tra massoneria e servizi segreti, come
Gelli dal 1941 al 1945 sembra sia stato al servizio del Counter Intelligence
Corp, cioè il controspionaggio militare americano. E che il potere di Gelli
permanesse immutato anche dopo le indagini aperte sulla P2, a seguito della
scoperta della lista degli iscritti, è testimoniato da una lettera inviata da
Gelli al gran Maestro del Grande Oriente, nella quale lo stesso si dichiara
certo dell’esito favorevole dell’indagine. (Non è un mistero per alcuno-scrive
Gelli- che queste conclusioni saranno interamente assolutorie). E in effetti le
indagini, non concluse dal Procuratore di Palmi Agostino Cordova, vennero
trasferite per competenza alla Procura di Roma dove il procedimento, dopo essere
rimasto fermo per circa sei anni, nel dicembre del 2002 venne archiviato dal
giudice Augusta Iannini. Sempre De Bernardo evidenzia come il trasferimento
della inchiesta Cordova alla Procura di Roma coincise con la pax mafiosa seguita
all’assassinio di Falcone e Borsellino del 1992, anno in cui ebbe inizio
l’inchiesta di Cordova. Analogie inquietanti. Lo stesso Cossiga, in una
intervista, affermò che la P2 era stata una creazione degli americani, una
“operazione “Filoamericana e atlantica…la P2 era perciò un baluardo
anticomunista, un caposaldo di un certo tipo di politica estera e di pensiero”.
Se le sentenze hanno escluso che la P2 cospirasse contro lo Stato, tuttavia “le
ragioni atlantiche” che secondo la P2 dovevano cambiare l’Italia, erano
certamente illegali. Si può parlare di poteri forti o poteri occulti anche a
proposito dell’Opus Dei? Indubbiamente l’Opus Dei e la massoneria presentano una
caratteristica comune che è quella della riservatezza interna. Dichiarò, in
proposito, l’ex Gran Maestro Di Bernardo, in una intervista del 23 marzo 1991:
“Se si parla di potere occulto, volendo fare riferimento alla massoneria,
bisognerebbe considerare anche l’Opus Dei, che svolge una attività
particolarmente occulta”. Ed ancora, in una intervista rilasciata a Giovanni
Bianconi del “Corriere della Sera” Di Bernardo non lesina critiche all’Opus Dei.
Afferma infatti: “Forse che quello non è un potere occulto? La massoneria
(quella ufficiale, n.d.r.) cerca sempre di far conoscere le proprie finalità, si
muove sempre sulla strada della trasparenza. Non mi risulta che l’Opus Dei abbia
fatto qualcosa di simile. Eppure esiste e si muove ai limiti della riservatezza.
Dobbiamo pensare che in Italia esistano due pesi e due misure?” Quanto fin qui
scritto porta a ritenere che un gruppo ristretto di persone detiene ed orienta
la politica finanziaria e internazionale e che con i suoi meccanismi di
globalizzazione impone, in maniera sempre più incisiva, il proprio potere alle
masse. Possiamo dire che una ristretta elite, l’uno per cento dell’umanità
comanda sul restante 99% definendone il destino e in alcuni casi persino la
sopravvivenza. Ma ciò che è più grave è che tale uno per cento detiene il
proprio potere in “regime di democrazia rappresentativa”, favorito dalla
legislazione e addirittura con il consenso popolare! E ciò è stato possibile,
come scrive Rosario Castello nel libro “L’invisibile identità del potere
nascosto”, grazie alla finanza mondiale con l’arma della globalizzazione e della
moneta privata. E’ pertanto fondato ritenere che durante gli incontri che
periodicamente hanno luogo tra i partecipanti del Bilderberg, della Trilaterale
e degli altri organismi simili, vengano prese dalla classe dirigente globale, al
riparo della privacy armata e della segretezza, le decisioni più rilevanti per
il futuro dell’umanità su politica, economia e questioni militari, decisioni che
sono e rimangono top secret.” Noi ci illudiamo di essere liberi ma l’illusione
viene meno nel momento in cui i nostri diritti entrano in conflitto con quelli
che sono gli interessi dei poteri forti e ci rendiamo conto di chi comanda
realmente in questa società. Si assiste oggi ad un appiattimento dei partiti
politici, delle istituzioni e degli organi di informazione che noi crediamo
liberi e indipendenti ma che mai si porranno, salve rare eccezioni, in contrasto
con tali poteri. In realtà sono le elite finanziarie di cui ho parlato che in
ambito politico, finanziario, economico e dell’informazione, stabiliscono al
nostro posto quali sono i limiti di conoscenza e di libertà oltre i quali non è
consentito andare. Woodrow Wilson, nel 1913 eletto Presidente degli Stati Uniti,
dopo la approvazione del “Federal Reserveact (la legge costitutiva della Federal
ReserveBank) e la sua promulgazione da parte dello stesso Wilson, anni dopo
dichiarò: “Sono uno degli uomini più infelici. Io ho inconsapevolmente rovinato
il mio paese, una grande nazione industriale è ora controllata dal suo sistema
creditizio. Non siamo più un governo della libera opinione, non più il governo
degli ideali e del voto della maggioranza, ma il governo dell’opinione e della
coercizione di un piccolo gruppo di personaggi dominanti”. Considerazione che
anche oggi non può non essere condivisa.
Mattei, Kennedy, Moro: quando la mafia
decideva i destini del mondo, scrive Alberto Di Pisa
su "Sicilia Informazioni" il 24 ottobre 2017. Il Presidente degli Stai Uniti
Donald Trump ha annunciato su Twitter la sua intenzione di divulgare i
documenti, a lungo coperti dal segreto di Stato, sull’assassinio di J.F. Kennedy
avvenuto a Dallas, nel Texas, il 22 novembre 1963. Sia la Commissione Warren che
indagò sull’omicidio del Presidente degli Stati Uniti sia la stessa famiglia
Kennedy, avevano optato per l’apposizione del segreto di Stato sui documenti
riguardanti l’assassinio. Si trattò di una scelta infelice dato che tale
decisione non fece altro che rafforzare le tesi degli scettici e dei
complottisti. In realtà, nel corso degli anni, sono stati desecretati più del
90% dei documenti soprattutto a seguito del film JFK di Oliver Stone. I
rimanenti documenti avrebbero dovuto essere desecretati nel 2017, come previsto
nel “President Jhon F. Kennedy Assassination Records Collectio Act, intenzione
che sembra avere, in questi giorni, manifestato il Presidente Trump. Avverso
tale intenzione di Trump è stata tuttavia avanzata, da ambienti della Casa
Bianca e in particolare dalla CIA la preoccupazione che la pubblicazione dei
file più recenti potrebbe mettere in pericolo le operazioni di intelligence. In
una dichiarazione giurata, Jefferson Morley, giornalista del Washington post ed
esperto di servizi segreti, ha dichiarato che la CIA dispone di circa 1100
documenti riguardanti l’assassinio di Kennedy che dovrebbero esser mantenuti
segreti fino al 2017, documenti che non sono mai stati visti dal Congresso degli
Stati Uniti. E’ fondato ritenere che vi siano pressioni da parte delle Agenzie
federali, CIA ed FBI, per convincere il Presidente Trump a mantenere ancora il
segreto sui rimanenti documenti e ciò al fine di evitare di mettere in pericolo
i segreti nazionali, relativi ad inchieste collegate che potrebbero divenire di
pubblico dominio. Se Il Presidente Trump dovesse cedere alle pressioni dei
suddetti organismi, rimarranno negli archivi dei documenti che potrebbero
portare alla luce oscure e dubbie attività della CIA come quelle, ad esempio,
relative ai programmi di assassinio di leader stranieri. Tra i documenti ancora
secretati vi sono ad esempio quelli relativi ad Edward Hunt l’agente della Cia
che partecipò allo sbarco fallito nella Baia dei Porci a Cuba nel 1961 e che
divenne famoso nello scandalo del Watergate che costrinse alle dimissioni il
presidente degli Stati Uniti Richard Nixon nel 1974. Quello di Kennedy non è
stato il primo omicidio di un presidente degli Stati Uniti. Prima di lui vennero
assassinati Abram Lincoln, ucciso il 14 aprile 1865, James Garfield, ucciso il 2
luglio del 1881, William McKinley ucciso il 6 settembre 1901. E ciò senza
contare i numerosi attentati falliti. L’assassinio di Kennedy, avvenuto a Dallas
il 22 novembre del 1963, fu un evento determinante nella storia degli Stati
Uniti per l’impatto che ebbe sulla nazione e sulla politica del Paese. Per
l’omicidio venne arrestato Lee Oswald a sua volta ucciso da Jack Ruby che morì a
sua volta in carcere di cancro. Numerose sono state le ipotesi sull’uccisione di
Kennedy: un complotto di cubani, della mafia, della stessa CIA. La Commissione
parlamentare Warren, istituita per indagare sull’assassinio del presidente degli
Stati Uniti, chiuse frettolosamente l’inchiesta archiviando il caso come
omicidio ad opera di un fanatico e cioè: Lee Oswald. Sulla morte di Kennedy
quindi esiste una verità ufficiale, quella della commissione Warren, istituita
il 29 novembre 1963 dal Presidente Lyndon B. Johnson che concluse che Lee Oswald
fu il solo esecutore materiale dell’omicidio. Le conclusioni della Commissione
furono molto contestate e furono formulate molte ipotesi cospirazioniste.
Soprattutto dei dubbi, peraltro non privi di un certo fondamento, sorsero sul
fatto che soltanto Oswald possa essere stato l’esecutore materiale. Oswald
infatti avrebbe sparato tre o quattro colpi a tempo di record – 6,75 secondi –
un tempo ritenuto da coloro che contestarono le risultanze della commissione
Warren, troppo breve. Un documentario, andato in onda sul canale televisivo CBS,
dimostrò che in realtà si trattava di un tempo più che ragionevole per un
tiratore scelto (qualità che non risulta avesse Lee Oswald) dato che, undici
tiratori, messi alla prova, avevano esploso tre colpi in un tempo medio di 5,6
secondi. Tuttavia, alcuni testimoni affermarono concordemente di avere udito un
quarto colpo che sarebbe stato sparato da una collinetta adiacente e quindi non
soltanto dal deposito di libri da cui avrebbe sparato Oswald. Il che indurrebbe
a ritenere la partecipazione all’assassinio di più persone. Cinque autorevoli
storici americani, docenti universitari, hanno pubblicato dei libri nei quali
hanno ricostruito l’omicidio di Kennedy. Di essi, quattro hanno sostenuto che
Kennedy fu vittima di un complotto e che Oswald non agì da solo e uno ritiene
che l’omicidio potrebbe essere avvenuto con il coinvolgimento di alcuni
ufficiali dell’intelligence americana. David Kaiser, del Naval War College e
Michael kurt, poi, quest’ultimo della Luisiana University, sono concordi nel
ritenere che a tirare i fili di tutta la vicenda sia stata la CIA. Fletcher
Prouty, capo delle operazioni speciali del Pentagono dal 1960 al 1964 ed
ufficiale di collegamento con la CIA, in una intervista rilasciata il 19 marzo
del 1992 all’ “Unità”, sostenne che Kennedy venne ucciso in seguito ad una vera
e propria cospirazione politica affermando che si trattò di un colpo di Stato in
piena regola e che Lee Oswald non era colpevole. L’assassinio, eseguito
militarmente con grande professionalità e coperture da “una anonima assassini”,
sarebbe stato programmato e realizzato per la tutela degli affari e degli
interessi di un strettissima elite di personaggi che da secoli si tramandano il
governo del pianeta, interessi che venivano minacciati da Kennedy divenuto
incontrollabile e pericoloso. Non soltanto l’uccisione di Kennedy ma tanti altri
delitti sarebbero quindi stati eseguiti nell’ottica del dominio del mondo e
delle risorse e a tal proposito Fletcher ricorda la guerra del petrolio e il
cartello del petrolio nel mondo ed aggiunge: “Il Presidente degli Stati Uniti fu
ucciso nello stesso piano strategico in cui fu eliminato. L’anno precedente,
Enrico Mattei. Lei ha presente che cosa rappresenta il potere di controllo sulle
fonti energetiche? Si tratta del governo mondiale: Mattei come Kennedy e poi
come Aldo Moro, sono stati uccisi da mani diverse ma per lo stesso motivo: non
si adattavano a discipline superiori. E tanti altri sono stati uccisi come
loro”. In altri termini una ristretta elite avrebbe il dominio della gran parte
del continente. Ci si troverebbe in presenza di un governo segreto costituito da
pochi gruppi di potere che regolano la fame, l’energia, le guerre e che non
esitano a ricorrere al crimine ogni qualvolta vedono minacciati i loro affari e
i loro interessi. Realizzati i delitti si sono occultate e si continuano a d
occultare le prove. Ciò ad esempio è avvenuto più volte in America (ma anche in
Italia) nel caso Nixon, nel caso dei bombardamenti segreti in Laos e Cambogia,
in Iran, in Nicaragua, con i Contras, con gli ostaggi in Iran e dopo Kennedy con
l’uccisione di Martin Luther King e Bob Kennedy. Ma tra coloro che improntarono
la loro attività a un forte impegno democratico si possono ancora ricordare
Allende, Palme, e Moro. Nell’assassinio di Kennedy non possono trascurarsi
alcune strane coincidenze che sembrerebbero avvalorare, nell’omicidio del
Presidente americano, un connubio tra politica e strutture criminali quali mafia
e massoneria. Ma probabilmente si tratta soltanto di coincidenze che tuttavia
qualche dubbio lo suscitano. Il giorno dell’assassinio infatti a Dallas, sulla
autovettura in cui si trovavano John Kennedy e la First Lady, vi era il
governatore del Texas John Connally, un nome che, curiosamente compare nei
verbali delle varie inchieste italiane sulla Loggia massonica P2. Connally,
fervente anticomunista e in seguito ministro del Tesoro sotto l’amministrazione
Nixon, era infatti amico e sodale del venerabile Licio Gelli come scrive l’ex
giudice Imposimato nel libro “La Repubblica delle stragi impunite”. E non può
non evidenziarsi e lasciare perplessi come negli omicidi di Kennedy e di Aldo
Moro si trovino gli stessi personaggi legati alla mafia e alla massoneria come
appunto il governatore del Texas Jhon Connally e il suo braccio destro Philip
Guarino. E a proposito di quest’ultimo, Luigi Cipriani, nel suo intervento in
aula del 2 agosto 1990, in occasione dell’anniversario della strage di Bologna,
evidenziò come Guarino, che negli Stati Uniti aveva diretto il comitato
elettorale di Regan e di Bush, fosse stato grande amico di Sindona e dirigente
della Franklin Bank che Sindona aveva acquistato negli Stati Uniti. Matteo Lecs
poi, un massone inquisito per la strage di Bologna, ha parlato dei rapporti di
Philip Guarino con Gelli e delle riunioni che venivano tenute a Livorno alle
quali partecipava un ufficiale della base americana di Camp Derby e nel corso
delle quali si discuteva delle operazioni che Gelli e la P2 conducevano in quel
periodo. Il Lecs dichiarò anche che gli elenchi veri della P2 sono depositati in
codice presso il Pentagono. In un messaggio inviato agli americani, John Kennedy
sembra quasi tracciare il profilo di quel coacervo di interessi che poco tempo
dopo decreterà la sua morte. Disse infatti Kennedy in quella occasione: “La
parola segretezza è ripugnante in una società libera e noi abbiamo avuto
storicamente come persone un senso innato di avversione alle società segrete, ai
giuramenti segreti e alle procedure segrete. Per questo si oppone a noi, in
tutto il mondo, una cospirazione monolitica e spietata fondata principalmente
sull’uso di mezzi sotterranei per espandere la propria sfera di influenza.
Sull’infiltrazione anziché l’intrusione. Sulla sovversione anziché sulle
elezioni. Sull’intimidazione anziché sulla libera scelta. E’ un sistema che ha
coscritto vaste risorse umane e materiali per la costruzione di una fitta rete,
una macchina altamente efficiente che combina operazioni militari, diplomatiche,
di intelligence, economiche, scientifiche e politiche. La preparazione di queste
operazioni viene nascosta, non resa pubblica. I loro errori sepolti, non
sottolineati. Gli oppositori sono messi a tacere, non elogiati. Il costo di
queste operazioni non viene messo in discussione; nessun segreto viene rivelato.
E’ per questo che il legislatore ateniese Solone decretò che il rifiuto di una
vertenza, di un dibattito pubblico, costituiva un reato per ogni cittadino. Sto
chiedendo il vostro aiuto nell’arduo compito di informare ed allertare il popolo
americano, fiducioso che con il vostro aiuto l’uomo potrà essere quello per cui
è nato: libero e indipendente”. In fondo lo stesso concetto avevano espresso lo
statista inglese Benjamin Dislaeli e il Presidente Franklin Delano Roosevelt.
Disse infatti il primo: “Il mondo è governato da personaggi molto diversi da
quelli che immaginano coloro che non si trovano dietro le scene”. E in maniera
più incisiva disse il secondo: “La verità su questo tema è che elementi della
finanza sono proprietari del governo nei suoi cardini principali dai giorni di
Andrew Jackson”. Si riuscirà mai a sapere la verità su Dallas? Io credo di no
poiché, per quello che ne sappiamo oggi, non vi sarebbe nulla di scritto e
documentato che proverebbe, nell’assassinio di Kennedy, un complotto di quelli
che oggi si suole definire “poteri forti”. Uno spiraglio tuttavia sembra potersi
aprire se, come annunciato dal presidente Trump, saranno definitivamente e
completamente aperti gli archivi che contengono i documenti sull’assassinio di
Kennedy, fino ad oggi coperti dal segreto di Stato. Soltanto in tal modo, io
credo, si potrà riprendere in mano il controllo della democrazia eliminando la
parola “segretezza” che, come affermò Kennedy, è una parola ripugnante in una
società libera.
Nino Galloni: Come ci hanno
deindustrializzato,
scrive il 29 luglio 2013 "Inchiesta On Line". Per il Dossier L’Europa verso la
catastrofe? pubblichiamo una intervista di Claudio Messora de Il fatto
quotidiano a Nino Galloni, economista, ex direttore del Ministero del Lavoro.
Nino Galloni è figlio di Giovanni Galloni amico e stretto collaboratore di Aldo
Moro.
MESSORA: Nino, buongiorno.
GALLONI: Buongiorno!
MESSORA: Benvenuto
su byoblu.com, a queste interviste volute dalla rete. Io ero rimasto molto
colpito dalla tua affermazione in un convegno che ripresi e misi su Youtube,
intitolando il video “Il funzionario oscuro che fece paura a Kohl”. Nel tuo
racconto del processo con il quale siamo entrati nell’euro, tratteggiavi questa
decisione assunta dalla politica italiana di un vero e proprio progetto di
deindustrializzazione del nostro paese. E mi sono sempre chiesto: ma perché mai,
alla fine, la politica avrebbe dovuto decidere questo strangolamento, questo
inaridimento, la morte del nostro tessuto produttivo? Ho cercato, via via, delle
risposte nel tempo, ma oggi che sei qua forse queste risposte ce le puoi dare
tu. È un processo, quello di deindustrializzazione, che parte da molto lontano.
Riesci a farci una carrellata di eventi e poi arriviamo al focus?
GALLONI: Credo che la data
dalla quale dobbiamo necessariamente partire sia il 1947, quando al Trattato di
Parigi De Gasperi cede una parte della nostra sovranità, ma in cambio ottiene il
riassetto di certi equilibri. La componente socialcomunista esce dal governo, ma
manterrà una grande influenza nel campo creditizio e questo, vedremo, sarà un
fattore decisivo una trentina di anni dopo.
MESSORA: gli Stati Uniti hanno
avuto un bel ruolo in questa decisione.
GALLONI: Gli Stati Uniti hanno
avuto un bel ruolo perché chiaramente gli aiuti del Piano Marshall erano
condizionati all’uscita dei comunisti dal governo. In realtà Togliatti,
giustamente, si lamentava del fatto che ci fosse questo ricatto, ma era
perfettamente consapevole di doverlo fare di uscire dal governo, anche perché
tutto sommato alla Russia stalinista non faceva comodo un Partito Comunista al
governo, come poi trent’anni dopo non farà scomodo il rapimento e l’omicidio di
Aldo Moro, che tutto sommato era stato additato come interessato a fare
avvicinare i comunisti all’area di governo, cosa che poi potrebbe essere
sfatata.
Ma torniamo all’industria.
Quindi nel 1947 la produzione industriale, per non parlare della produzione
agricola italiana, è a livelli del 1938. Il paese è semidistrutto. Tuttavia
inizia una ricostruzione. Ad un certo punto di questa ricostruzione, in cui
hanno un ruolo le industrie energetiche, quindi Mattei, ma si comincia a
sviluppare in modo sorprendente anche il nucleare, ci si trova già negli anni
’60 nel miracolo. Cioè piccole industrie, grandi industrie, industrie a
partecipazione statale, soprattutto, e anche cooperative, trainano l’Italia in
una situazione completamente diversa. Negli anni ’70 scopriamo che abbiamo
superato l’Inghilterra, scopriamo che ci stiamo avvicinando alla Francia,
scopriamo che possiamo, dal punto di vista manifatturiero, andare a dar fastidio
alla Germania. Nel ’71 si sgancia la moneta dall’oro e questo rende teoricamente
tutto più facile: gli aumenti salariali anche in termini reali, la spartizione
dei guadagni di produttività che va in parte ai lavoratori e quindi aumentano i
consumi, aumentano le vendite, aumenta il valore delle imprese. Questo è un
concetto fondamentale che oggi è stato completamente dimenticato. Oggi la
consapevolezza e l’orizzonte delle imprese – e di questo ha grave responsabilità
la Confindustria – è ridotto all’immediato, al profitto annuale. Le imprese
dovrebbero traguardare obiettivi di crescita del valore delle imprese stesse, in
modo di contrattare poi con le banche tassi di interesse buoni e invece manca
completamente questa consapevolezza.
MESSORA: Negli anni ’70
eravamo all’apice.
GALLONI: All’apice. Diciamo
che forse l’anno di maggior crescita è proprio il ’78, che è l’anno, non a caso,
del rapimento di Moro.
MESSORA: Cioè noi stavamo
raggiungendo e superando le altre economie avanzate.
GALLONI: C’erano stati altri
segnali gravissimi di attacco al sistema italiano, come appunto l’omicidio di
Mattei, ordinato perché aveva pestato i piedi alle “Sette Sorelle” in Medio
Oriente, trovando una formula che ci aveva dato una posizione nel Mediterraneo
veramente ragguardevole dal punto di vista della politica estera. E non ci
dimentichiamo che Moro era amico degli arabi moderati, quindi aveva contro
Israele e aveva contro gli arabi estremisti. Poi abbiamo visto che aveva contro
la Russia, che non voleva un avvicinamento del Partito Comunista Italiano al
governo e anzi mal sopportava l’importanza in Europa di questo grande partito, e
gli americani che temevano – questa è la versione non dico ufficiale, ma su cui
concordano molti osservatori, che dobbiamo (va citato in questo caso) alla
ricostruzione di mio padre, che era principale collaboratore di Moro a quei
tempi – che l’avvicinamento del Partito Comunista all’area di governo, secondo
i loro centri studi, i loro servizi, avrebbe potuto vanificare il principale
piano strategico di difesa dell’Occidente nei confronti della Russia sovietica,
che aveva una supremazia evidente di terra. Quindi un’avanzata dei carri armati
sovietici attraverso la Germania orientale, poteva essere fermata prima che i
carri arrivassero nella Germania occidentale solo con degli ordigni atomici
tattici che erano necessariamente e solo piazzabili e piazzati nel Nord-Est
dell’Italia. Quindi se non si poteva fermare con armi atomiche nucleari tattiche
l’avanzata dell’esercito sovietico verso occidente, l’Europa era persa e quindi
gli americani se ne sarebbero dovuti andare dall’Europa, conseguentemente dal
Mediterraneo che – teniamolo sempre presente – è l’ombelico del mondo. Ma questo
è un quadro teorico.
MESSORA: Spieghiamolo bene.
Cosa c’entra Moro in questo quadro? Cosa c’entra Moro con le bombe nucleari?
GALLONI: c’entra! Perché se
Moro faceva riavvicinare i comunisti al governo, si pensava che i comunisti
avrebbero posto un veto all’uso di ordigni nucleari, anche nel caso di
un’avanzata dei carri armati sovietici verso occidente. Ma erano scenari che gli
americani fanno continuamente, non è detto che le politiche si debbano ispirare
a quello. Però c’è un fatto di cui ci sono testimonianze certe, anche della
famiglia di Moro: Kissinger gliel’aveva giurata, aveva minacciato Moro di morte
poco tempo prima, Moro lo aveva riferito alla famiglia e la famiglia aveva detto
“ritirati dalla politica”, cosa che poi lui non aveva fatto, ma non si sa poi
che cosa avesse in mente di fare dopo quel fatidico marzo 1978.
MESSORA: Quindi le Brigate
Rosse in realtà avevano avuto un ruolo…
GALLONI: Dobbiamo distinguere
le prime Brigate Rosse, per capirci quelle di Curcio, che erano un fenomeno
promanante dall’incontro tra l’estremismo, un certo tipo di estremismo
marxista-leninista, che bene o male aveva un legame col Partito Comunista, anche
se lontano, e forze che tutto sommato, partigiani ed ex partigiani che avevano
conservato le armi, anche perché si sapeva che dall’altra parte c’era la
minaccia; tutti gli anni ’70, e forse anche prima, sono stati vissuti con l’idea
che potesse esserci un golpe di destra, quindi partigiani ed ex partigiani
avevano conservato armi, soprattutto nel nord. Quindi una certa continuità col
terrorismo si può anche vedere. Le seconde Brigate Rosse, quelle che – per
capirci – rapirono Moro, eccetera, invece sono fortemente collegate con i
servizi, con deviazioni dei servizi, con i servizi americani, israeliani; ci
sono evidenze ormai incontrovertibili su questa lettura. Torniamo all’industria.
Il problema qual è? Il problema è che in pratica il gioco è: quanto e come ci
avviciniamo all’Europa, quanto e come sviluppiamo l’economia italiana, che già
appunto era arrivata a livelli, come abbiamo detto, di eccellenza. Allora ci
sono due strategie, fondamentalmente. C’è la strategia più moderata che vuole
l’Europa e che faceva capo anche a Moro, ma che faceva capo anche a Paolo Baffi,
governatore della Banca d’Italia, e ad altri personaggi del mondo economico e
finanziario italiano, e poi invece emerge una posizione più estremista, pro
Europa, che praticamente fa propria l’idea che si debba combattere la classe
politica corrotta e clientelare e tutte le sue espressioni facenti capo
fondamentalmente alla Democrazia Cristiana e ai suoi partiti alleati, compreso
il Partito Socialista, e che per questo si debbano anche cedere porzioni di
sovranità, e si comincia con la sovranità monetaria.
MESSORA: Ma chi si faceva
propugnatore di questa tesi?
GALLONI: Intanto era cambiata
la dirigenza della Banca d’Italia ed era passata la linea, diciamo, più
estremista sull’Europa, facente capo a Carlo Azeglio Ciampi. Poi la sinistra
democristiana era divisa tra la sinistra sociale, che faceva capo a
Donat-Cattin, che era su posizioni euromoderate, e la sinistra politica, che
faceva capo a De Mita e soprattutto a Beniamino Andreatta, che invece era su
posizioni euroestremiste e giustificavano questa rinuncia alla sovranità
monetaria, cioè alla possibilità dello Stato di fare investimenti pubblici
produttivi, per impedire alla classe politica stessa, corrotta e clientelare, di
avere potere. Quindi per sottrarre potere alla classe politica, si cominciò a
rinunciare alla sovranità monetaria, quindi agli investimenti pubblici. Quindi
la classe politica poi si trovò ad occuparsi solo di nomine, di poltrone,
eccetera, perché non c’era più da discutere gli investimenti pubblici che ormai
dovevano minimizzarsi. Degli investimenti pubblici la componente più importante
era sicuramente quella riguardante le partecipazioni statali, l’energia, i
trasporti e via dicendo, dove l’Italia stava primeggiando a livello mondiale.
MESSORA: Mario Monti era molto
vicino a De Mita, quindi potremmo dire che già da allora era un euroestremista.
GALLONI: Di Monti mi ricordo
la posizione sulla scala mobile, che era stata considerata interessante da
Donat-Cattin, però poi, per il resto, era sicuramente un rappresentante della
scuola monetarista, non era un keynesiano. I keynesiani si stavano abbandonando.
Anche Andreatta, pur essendo stato un keynesiano, era entrato in quella che noi
chiamiamo “la corrente neo-keynesiana”, li chiamiamo anche “keynesiani
bastardi”, di cui il maggior rappresentante era il premio Nobel Modigliani, i
quali proponevano appunto questo passaggio rispetto alla moneta che impedisse
alla classe politica di decidere investimenti in infrastrutture per lo sviluppo
industriale, per lo sviluppo del paese. Ecco, questo è stato un errore cruciale
che ha determinato poi l’esplosione dei tassi di interesse e quindi del debito
pubblico, ma soprattutto l’accorciamento di orizzonte delle imprese industriali
che assumevano sempre di meno perché dovevano valutare il profitto immediato e
non potevano stare a fare grandi progetti industriali. Quindi quello che accadde
per gli investimenti pubblici, accadde anche per gli investimenti privati, a
causa degli alti tassi di interesse. Io negli anni ’80 feci una ricerca che
dimostrava che i 50 gruppi più importanti pubblici e i 50 gruppi più importanti
privati facevano la stessa politica, cioè investivano la metà dei loro profitti
non in attività produttive ma nell’acquisto di titoli di Stato, per la semplice
ragione che i titoli di Stato italiani rendevano tantissimo e quindi si
guadagnava di più facendo investimenti finanziari invece che facendo
investimenti produttivi. Questo è stato l’inizio della nostra
deindustrializzazione. Il passaggio successivo però è molto più grave e riguarda
appunto il periodo che va dalla fine degli anni ’80 all’inizio delle
privatizzazioni.
MESSORA: Ci arriviamo. Ci
spieghi però, a noi che non siamo economisti, come si lega questa nuova politica
monetarista con l’esplosione dei tassi di interesse? Questo passaggio tecnico ce
lo spieghi un po’?
GALLONI: Fino al 1981 la Banca
d’Italia, se un’emissione di obbligazioni pubbliche che servivano per ottenere
moneta da parte dello Stato non veniva completamente coperta, comprava lei il
restante, quindi era la compratrice di ultima istanza, come diceva il mio
maestro Federico Caffè. Questo faceva sì che se l’emissione avveniva a un tasso
di interesse basso, mettiamo del 3%, e una parte non veniva comprata proprio
perché il rendimento era basso, la Banca d’Italia comprava quello che avanzava e
quindi emetteva moneta. Con il divorzio tra Tesoro e Banca d’Italia, era data
alla Banca d’Italia la facoltà di non essere obbligata… Sembra un po’ un gioco
di parole però, in fondo, lo stesso divorzio tra Tesoro e Banca d’Italia, di cui
stiamo parlando, non è che obbligava la Banca d’Italia a non comprare titoli, le
dava la facoltà di non farlo e la pratica, voluta da Carlo Azeglio Ciampi, fu di
applicare questo divorzio in modo letterale. Per la cronaca, ricordo che
l’Inghilterra aveva le stesse regole, perché noi copiammo quelle, ma non le
praticava. Cioè la Banca d’Inghilterra, quando serviva, stampava sterline a
gogò, mentre la Banca d’Italia si irrigidì su quella facoltà che le era stata
riconosciuta attraverso una semplice lettera del Ministro del Tesoro Beniamino
Andreatta, e quindi la parte di emissione obbligazionaria che non veniva
coperta, causava un aumento del tasso di interesse finché non si piazzava questo
residuo, ma poi questo tasso di interesse andava ad essere applicato su tutta
l’emissione della mattinata. Quindi in questo modo c’è stata una rincorsa dei
tassi di interesse verso l’alto. In effetti io feci un appunto e ci fu una
discussione col Ministro del Tesoro, in cui dimostrai oltre ogni ragionevole
dubbio, applicando semplicissimi tassi di capitalizzazione – come sanno tutti
gli economisti – che il debito pubblico sarebbe raddoppiato e avrebbe superato
il Pil. Addirittura mi dissero che il debito pubblico non poteva superare il
Pil, se no il sistema saltava, al che io gli feci presente che non era così,
perché il debito è uno stock e il Pil è un flusso. Ma avevano deciso una cosa e
non volevano più cambiarla, non accettavano né le critiche di Federico Caffè né
quelle di Paolo Leon, figuriamoci le mie! Per cui poi litigammo e io andai via
da quella amministrazione. E siamo a metà degli anni ’80. Il peggio deve ancora
arrivare.
MESSORA: Lo scopo era soltanto
quello nobile di sottrarre alla politica la gestione dei soldi e quindi andare
verso un’Europa che avrebbe potuto salvarli in qualche maniera, o c’era anche
sotto una strategia che poi avrebbe portato al nostro processo non solo di
deindustrializzazione ma anche di privatizzazione? Qual è stata la road map
successiva?
GALLONI: Nel mio ultimo libro
“Chi ha tradito l’economia italiana”, infatti, affronto questo problema e
identifico due tipi di personaggi, cioè quelli che in buona fede volevano fare i
salvatori della patria, come hai ricordato tu, ma anche quelli che traguardavano
nella possibilità di una svendita delle partecipazioni statali, nelle
privatizzazioni – allora si chiamavano dismissioni – la possibilità di fare
immensi profitti, come fu. Quindi c’è stata anche una parte di questa
componente, diciamo così, anti-statalista, anti-italiana, anti-sviluppista, che
ha fatto affari strepitosi e su cui qualcuno, infatti, ha proposto una
commissione di indagine parlamentare.
MESSORA: arriviamo quindi, con
questo ragionamento, all’inizio degli anni ’90.
GALLONI: Sì. Diciamo che c’è
il passaggio successivo. È prima dell’inizio degli anni ’90, perché all’inizio
degli anni ’90 avviene il crollo del sistema monetario europeo, perché non era
sostenibile per la semplice ragione che produceva tassi di interesse più alti
per i paesi deboli, che quindi si indebolivano di più, e tassi di interesse più
bassi per i paesi forti, che quindi si rafforzavano di più. Ad un certo punto il
sistema è saltato, ma era prevedibile. Ma noi ci dobbiamo rapportare,
raccontando gli eventi, al tempo in cui accadevano, perché col senno del poi
siamo tutti bravi. Nell’89 è emerso, qualcuno aveva detto – lì entra in gioco
l’oscuro funzionario, probabilmente-, l’apice della classe politica italiana,
che tutto sommato faceva capo in quel momento a Giulio Andreotti, capisce che
bisogna trovare una strada un po’ diversa, perché se no si compromettono gli
interessi nazionali. Tra le altre cose, quindi, mi manda un biglietto, mi scrive
Giulio Andreotti e mi dice “caro dottore, vuole collaborare con noi per cambiare
l’economia di questo paese?”. Al che io entusiasticamente aderisco. Per farla
breve io mi trovo al vertice del Ministero del Bilancio, che era il ministero
cruciale, alla fine dell’estate del 1989. Quindi in quel momento Andreotti era
più vicino alle posizioni americane e più lontano dalle posizioni europeistiche
estreme. Passano poche settimane, perché dalla fine di agosto dell’89, quando io
ho ripreso servizio al mio ex ministero, fino a quando praticamente vengo di
nuovo estromesso, che è novembre, passano due mesi praticamente. In questi due
mesi io metto mano, e si sa in giro che io sto mettendo mano, ci fu anche un mio
incontro molto in tensione con Mario Monti alla Bocconi. Io stavo appunto col
mio Ministro e ci fu questo scontro piuttosto forte sul problema della moneta e
del debito pubblico; avevamo posizioni completamente diverse.
MESSORA: La tua qual era?
GALLONI: La mia era che
praticamente si dovesse operare per abbassare i tassi di interesse in qualunque
modo e dimostrai appunto che la Banca d’Inghilterra aveva lo stesso regime
nostro, cioè il divorzio, ma non lo praticava, quindi quando serviva al paese
stampava sterline. Questo era il problema.
MESSORA: E la sua?
GALLONI: La sua, che si
dovesse andare avanti su una politica di forte europeizzazione e quindi si
dovesse continuare con questo forte debito pubblico. Dopo questo incontro alla
Bocconi in effetti si scatena l’inferno, perché arrivano pressioni dalla Banca
d’Italia, dalla Fondazione Agnelli, dalla Confindustria e vengo a sapere che
persino un certo Helmut Kohl aveva telefonato al Ministro del Tesoro Guido Carli
per dire “c’è qualcuno che rema contro il nostro progetto”, adesso le parole le
ho ricostruite in base a delle testimonianze dirette, però vengono fatte
pressioni sul mio Ministro affinché io venga messo da parte, cosa che avviene
nel giro di un pomeriggio, nel senso che io ottengo dal Ministro la verità, mi
rivela la verità, la scriviamo su un pezzo di carta perché lui temeva ci fossero
dei microfoni, gli faccio vedere questo pezzetto di carta, dico “ci sono state
pressioni anche dalla Germania sul Ministro Carli perché io smetta di fare
quello che stiamo facendo?” e lui mi fece di sì con la testa. Per cui ho
mantenuto rispetto per questa persona, però me ne sono andato. Che cosa era
successo? Che fino all’estate del 1989 Andreotti era contrario alla
riunificazione tedesca e questo fatto impediva qualunque progresso, ovviamente,
perché la Germania voleva fare la riunificazione.
MESSORA: e ci fu quella famosa
battuta.
GALLONI: sì, sì. Infatti in
quei tempi ad Andreotti chiesero “ma lei ce l’ha tanto con la Germania?”, dice
“no, io amo la Germania. Anzi, la amo talmente tanto che mi piace che ce ne
siano addirittura due!”. Questa era la frase. Passano appunto pochi mesi e
invece la Germania, pur di ottenere la riunificazione, si mette d’accordo con la
Francia per rinunciare al marco, che era quello che faceva paura alla Francia.
Però perché questo accordo tra Kohl e Mitterand regga, occorre
deindustrializzare l’Italia e indebolire l’Italia. Perché se no che fanno? Si
passa a una moneta unica e l’Italia poi…
MESSORA: che stava fiorendo.
GALLONI: stava già perdendo
colpi l’industria italiana, da vari punti di vista, però era una situazione
ancora di dominio del panorama manifatturiero internazionale. Eravamo la quarta
potenza che esportava. Voglio dire, eravamo qualcosa di grosso dal punto di
vista industriale e manifatturiero. Bastavano alcuni interventi, bisognava
riprendere degli investimenti pubblici e cose del genere. Dopodiché, ovviamente,
si entra nella stagione delle privatizzazioni spinte, negli anni ’90, in cui
praticamente quasi scompare la nostra industria a partecipazione statale.
MESSORA: Quindi decidono la
deindustrializzazione. Dopodiché c’è qualcuno che si attiva.
GALLONI: Sì. La
deindustrializzazione significa che non si fanno più politiche industriali. Non
ci dimentichiamo che poi c’è stato un periodo in cui Bersani era Ministro
dell’Industria, in cui, diciamolo, teorizzò che non servivano le strategie
industriali. Adesso sta dicendo il contrario, ma poteva pensarci pure prima. Per
dirne una. Non si fanno politiche per le infrastrutture. Questo è importante,
perché è un paese che è molto lungo, quindi è costoso trasportare le merci da
sud a nord, mentre il nord è già in Europa dal punto di vista geografico e
infrastrutturale, il centro e il sud sono lontani, quindi potenziare le
infrastrutture sarebbe stato strategico.
Poi, alla fine degli anni ’90,
si introduce la banca universale, quindi la possibilità per la banca di
occuparsi di meno del credito all’economia e di occuparsi di più di andare a
fare attività finanziarie e speculative che poi avrebbero prodotto solo dei
disastri, come sappiamo.
MESSORA: La fine del
Glass-Steagall Act.
GALLONI: Sì, esatto. Poi la
mancanza di strategie efficaci della stessa FIAT, dell’industria privata.
Ripeto, in quegli anni la Confindustria era solo presa dall’idea di introdurre
forme di flessibilizzazione sempre più forti – che poi avrebbero prodotto la
precarizzazione – aumentare i profitti, quindi una visione poco profonda di
quello che è lo sviluppo industriale, quindi perdita di valore delle imprese,
perché le imprese guadagnano di valore se hanno prospettive di profitto che
dipendono dalle prospettive di vendita. Questo è l’ABC. Se invece difendono il
profitto oggi perché devono realizzare e devono portare ai proprietari una certa
redditività ma poi, voglio dire, compromettono il futuro di un’azienda, questa
perde di valore.
MESSORA: Si narra di questo
incontro sul Britannia. Qual è stato il ruolo anche dell’Inghilterra, secondo
te?
GALLONI: L’Inghilterra non è
che avesse un interesse diretto all’indebolimento dell’Italia nel Mediterraneo,
ma ha una strategia complessiva in Africa e in Medio Oriente, che ha sempre teso
ad aumentare i conflitti, il disordine, e c’è la componente che fa capo alla
corona, di cui sono espressione anche alcuni movimenti ambientalisti, che poi si
debba puntare a una riduzione drastica della popolazione del pianeta; quindi è
contraria ad ogni politica che invece favorisca lo sviluppo così come lo
intendiamo comunemente.
MESSORA: Quindi è vero che sul
Britannia si presero delle decisioni?
GALLONI: Qui dobbiamo capirci.
Allora, Bilderberg, Britannia, il Gruppo dei 30, dei 10, gli Illuminati di
Baviera, sono tutte cose vere. Gente che si riunisce, come certi club massonici,
e decidono delle cose. Ma non è che le decidono perché veramente le possono
decidere, è perché non trovano resistenza da parte degli Stati. L’obiettivo è
quello di togliere di mezzo gli Stati nazionali allo scopo di poter aumentare il
potere di tutto ciò che è sovranazionale, multinazionale e internazionale in
questo senso. Dopodiché è ovvio che se gli Stati sono stati indeboliti o
addirittura nei governi ci sono rappresentanti di questi gruppi, che siano il
Britannia, il Bilderberg, gli Illuminati di Baviera, eccetera, negli Stati Uniti
d’America c’era la Confraternita dei Teschi, di cui facevano parte padre e
figlio Bush, che sono diventati presidenti degli Stati Uniti. E’ chiaro che dopo
questa gente risponde a questi gruppi che li hanno, bene o male, agevolati nelle
loro ascese.
MESSORA: Quindi alla fine
decidono.
GALLONI: Ma perché dall’altra
parte è mancata, da parte dei cittadini e degli Stati, una seria resistenza.
Quindi praticamente questi dominano la scena.
MESSORA: Quindi non è colpa di
questi ma è colpa di chi non si oppone abbastanza.
GALLONI: Questi si riuniscono,
decidono delle cose, però rimangono lì. Ci sono sempre stati i circoli dei
notabili che hanno deciso delle cose. Mica è detto che siano riusciti sempre a
farle!
MESSORA: Però in questo caso
ci sono riusciti.
GALLONI: In questo caso ci
sono riusciti perché non hanno trovato resistenza.
MESSORA: Quindi è colpa
nostra.
GALLONI: Beh, sì, un po’ sì,
secondo me.
MESSORA: L’ignavia del
cittadino che non rivendica il potere.
GALLONI: Sì. Ad esempio l’idea
montiana che l’aumento della base monetaria produca inflazione è stato ciò che
ha consentito di attrarre anche i sindacati in un’area di consenso per quelle
riforme sbagliate che si sono fatte a partire dal 1981, quando invece si è
dimostrato, anche in tempi recenti, che l’emissione e l’autorizzazione di mezzi
monetari per migliaia, decine di migliaia di dollari e di euro non ha prodotto
l’iper inflazione. Quindi evidentemente è qualcos’altro che genera l’inflazione,
non è la quantità di moneta. La quantità di moneta può influire sui tassi di
interesse attraverso le tensioni della domanda di essa, ma non è che influiscano
direttamente sull’inflazione. Certo, paradossalmente potrebbe essere il
contrario: se la moneta è poca e i tassi di interesse aumentano, quelli hanno
effetti sui livelli dell’inflazione.
MESSORA: Quindi l’ignoranza
degli attori sociali è stata o anche un certo tornaconto?
GALLONI: Una cosa non esclude
l’altra. Diciamo che quelli che volevano avere un certo tornaconto facevano leva
sull’ignoranza dei fatti monetari, dei partiti, dei sindacati, della classe
dirigente e anche una certa scomparsa della scuola keynesiana dovuta a vari
fattori anche oscuri.
MESSORA: Quindi
privatizzazioni. Anni ’90. Cosa succede poi?
GALLONI: Dopo gli anni ’90 la
situazione praticamente comincia a precipitare quando inizia questa crisi, che è
il 2001. Quando gli operatori di borsa si accorgono che anche i titoli che
avevano tirato fino a quel punto, e-commerce, e-economy, prodotti avanzati,
eccetera, non danno più rendimenti crescenti, allora cominciano a svendere e
comincia la speculazione al ribasso. In quelle condizioni le banche, che avevano
preso grandi impegni coi sottoscrittori dei loro titoli, perché erano diventate,
come ho ricordato prima, universali, per garantire questi rendimenti fanno
operazioni di derivazione. Le operazioni di derivazione sono tipo catene di
Sant’Antonio: tu acquisisci denaro per dare i rendimenti e quindi posticipi la
possibilità di dare i rendimenti agli ultimi che ti hanno affidato delle somme.
Questa cosa, si è fatta nel giro di due o tre mesi, perché dopo c’era la
ripresa, era sempre stata fatta dalle banche, è un’operazione tecnica, diciamo
così. Quindi di tre mesi in tre mesi si diceva che arrivava la ripresa. Centri
studi, economisti, osservatori, studiosi, ricercatori, tutti sui loro libri
paga, prevedevano di lì a tre mesi, di lì a sei mesi, la ripresa. Non si sa
perché. Perché le politiche economiche volute per esempio da Bush, tipo la
riduzione delle tasse, erano chiaramente politiche che non avrebbero risolto il
problema della crescita. Poi tutte queste guerre americane, speculazioni,
vanificavano la potenza di un dollaro che se fosse stato destinato a
investimenti produttivi, alla ricerca, alle infrastrutture, eccetera,
probabilmente avrebbe creato una situazione accettabile. Invece non si faceva
niente di tutto questo, non si avviavano gli investimenti produttivi pubblici,
perché i privati non investono se non c’è prospettiva di profitto; come avviene
in borsa così avviene nell’economia reale. Quindi siamo andati avanti anni e
anni con queste operazioni di derivazione, emissione di altri titoli tossici.
Finché si è scoperto, intorno al 2007, che il sistema bancario era saltato, nel
senso che nessuna banca prestava liquidità all’altra, sapendo che l’altra faceva
le stesse cose che faceva lei stessa, cioè speculazioni in perdita. La massa dei
valori persi dalle banche sui mercati finanziari superava, per la prima volta,
la massa di quello che le famiglie, le imprese e la stessa economia criminale
mettevano dentro il sistema bancario. Di qui la crisi di liquidità che deriva da
questo, cioè che le perdite superavano i depositi e i conti correnti. A questo
punto è intervenuta la FED e ha cominciato a finanziare le banche, anche
europee, nelle loro esigenze di liquidità. La FED ha emesso, dal 2008 al 2011,
17 mila miliardi di dollari, cioè più del Pil americano, più di tutto il debito
pubblico americano, ha autorizzato o immesso mezzi monetari in qualche modo e
poi ha chiesto all’Europa di fare altrettanto. L’Europa alla fine del 2011 ha
offerto qualche resistenza e poi, anche con la gestione di Mario Draghi, ha
fatto il “quantitative easing”, cioè dare moneta illimitatamente per consentire
alle banche di non soffrire di questa crisi di liquidità derivante dalle perdite
che superano nettamente le entrate. Ovviamente l’economia è sempre più in crisi,
quindi i depositi che seguono gli investimenti produttivi sono sempre di meno e
le perdite, invece, sono sempre di più. Allora il problema qual è? Perché
continua questo sistema? Questo sistema continua per due ragioni. La prima è che
chi è ai vertici delle banche, e lo abbiamo visto anche al Monte dei Paschi,
guadagna sulle perdite. Perché non guadagna su quello che sono le performance,
come sarebbe logico, ma guadagna sul numero delle operazioni finanziarie che si
compiono, attraverso algoritmi matematici, sono tantissime nell’unità di tempo.
Quindi questa gente si porta a casa i 50, i 60 milioni di dollari e di euro,
scompare nei paradisi fiscali e poi le banche possono andare a ramengo. Non
vanno a ramengo perché poi le banche centrali, che sono controllate dalle stesse
banche che dovrebbero andare a ramengo, le riforniscono di liquidità.
MESSORA: Non solo le banche
centrali, anche i governi.
GALLONI: Sì, ma sono le banche
centrali che autorizzano i mezzi monetari.
MESSORA: Ma i Monti bond? Chi
ce li ha messi i soldi?
GALLONI: Sì, però i debiti
pubblici sono bruscolini. Nel caso delle perdite delle banche stiamo parlando di
decine di trilioni di dollari e di euro.
MESSORA: Sì, questo non lo
discuto. Però quello che abbiamo dato di Monti bond, alla fine si sarebbe
risparmiata forse l’IMU agli italiani. Per cui sulle singole famiglie questo
discorso ha valore.
GALLONI: sì, sicuramente sulle
singole famiglie. Certo, avremmo potuto risparmiarci l’IMU invece che darli al
Monte dei Paschi. Però è una piccola cosa rispetto ai 3-4 quadrilioni di titoli
tossici che oggi sono in giro per il mondo. Sono tremila, quattromila trilioni.
Un trilione sono mille miliardi. Quindi stiamo parlando di grandezze
stratosferiche. Siccome le perdite si aggirano sul 10%, mediamente, che è quello
che ovviamente questi titoli non rendono, avremmo bisogno a regime non di
qualche decina di trilioni, come hanno dato oggi le banche centrali alle banche,
ma praticamente dai 300 ai 400 trilioni di dollari. Cioè in pratica stiamo
parlando di 6 volte il Pil mondiale. Sono cose spaventose.
MESSORA: Quindi come se ne
esce adesso?
GALLONI: Se ne esce con un
accordo tra gli Stati, Cina, India, Stati Uniti d’America, possibilmente Europa
e qualcun altro, che congelano tutta questa massa, la garantiscono, la
trasformano invece in mezzi monetari che servano per lo sviluppo. Quindi a quel
punto poi il problema diventerebbe la capacità di progettare infrastrutture,
voli su Marte, acchiappare gli asteroidi per farne delle miniere, voglio dire,
se ci vogliamo allargare. Se ci sono queste capacità progettuali, industriali,
produttive, forze disoccupate, eccetera, noi ne usciamo. Diversamente la teoria
ci porta a pensare che potrà esserci una grande botta iperinflattiva che
cancellerà tutti i debiti.
MESSORA: Traduci per i non
capenti.
GALLONI: Allora, dai debiti si
esce in vari modi. Primo, perché si hanno dei redditi che consentono di ripagare
in qualche modo i debiti, e questa è la via maestra, quindi non ci si dovrebbe
mai indebitare per somme che si sa che non si possono ripagare attraverso i
nostri redditi; e questa sarebbe la regola numero uno. Quindi il debito non è un
male, il debito è un bene se tu hai il reddito (nel caso degli Stati il Pil)
sufficiente per poi fronteggiare la situazione. C’è la remissione del debito,
che è una possibilità anche parziale che io ho sollevato in una mia ricerca
sulle banche italiane anni fa, quando ci fu la crisi del 2007-2008, che tutto
sommato agevolerebbe anche le banche e ci metterebbe tutti in condizione di
avere fondamentalmente, per 8 anni, un 5% in più di reddito, riducendo del 40% i
crediti delle banche; questa è un’altra possibilità. E poi c’è l’inflazione che
praticamente, se non ci sono indicizzazioni, si mangia il debito, perché
decresce il valore della moneta e conseguentemente decresce l’importanza del
debito. Queste sono le strade che si possono aprire a livello operativo nei
confronti della gestione del debito.
MESSORA: A livello nazionale?
Per esempio andrebbe bene per l’Italia o parli a livello europeo?
GALLONI: A livello nazionale
c’è appunto chi parla di varie misure riguardanti il debito pubblico. In realtà
la cosa migliore sarebbe riprendere il percorso della crescita e quindi
minimizzare l’importanza del debito rispetto alla ricchezza nazionale. Non ci
dimentichiamo che le ricchezze pubbliche e private in Italia sono 10 volte il
Pil, quindi ovviamente ce n’è, non è che non riusciremmo a ripagare il debito.
Però il debito non è che si deve ripagare, come credono alcuni, il debito sta
lì. L’importante è ridurre i tassi di interesse e che i tassi di interesse siano
più bassi dei tassi di crescita, allora non è un problema. Questo è il modo sano
di affrontare il tema del debito pubblico. Diversamente può succedere, come è
successo in Grecia, che per 300 miseri miliardi di euro poi se ne perdano a
livello europeo 3.000 nelle borse. Allora ci si interroga: ma questa gente si
rende conto che agisce non solo contro la Grecia ma anche contro gli altri
popoli e paesi europei? Ma chi comanda effettivamente in questa Europa si rende
conto? Oppure vogliono obiettivi di questo tipo per poi raggiungere una sorta di
asservimento dei popoli, di perdita ulteriore di sovranità degli Stati per
obiettivi poi fondamentalmente, come è stato in Italia con le privatizzazioni,
di depredazione, di conquista di guadagni senza lavoro?
MESSORA: Adesso c’è un altro
ciclo di privatizzazioni. Sembra che ci stiamo avvicinando a quello.
GALLONI: Il problema delle
privatizzazioni è anche quello dei prezzi di vendita. Perché se ovviamente, come
è successo negli anni ’90, ci si aggirava intorno ai valori di magazzino, voi
capite di che truffa stiamo parlando. È chiaro che se poi i prezzi di vendita
fossero troppo alti, nessuno comprerebbe. Bisogna trovare una via di mezzo. Ma
in realtà bisognerebbe cercare di ragionare sulle capacità strategiche e sul
mantenimento di poli pubblici di eccellenza che servissero per rilanciare la
ricerca, il campo dell’acquisizione delle migliori tecnologie per il trattamento
dei rifiuti, che per esempio in Italia avrebbe delle prospettive enormi. Non ci
dimentichiamo che in Italia siamo depositari di due brevetti fondamentali, uno è
dell’Italgas e l’altro dell’Ansaldo, per produrre degli apparati relativamente
piccoli che consentono al chiuso, quindi senza emissioni, di trasformare i
rifiuti in energia elettrica e in altri sottoprodotti utili per l’agricoltura e
per l’edilizia.
MESSORA: E dove stiamo andando
in Europa, in questo momento?
GALLONI: Io avevo identificato
una spaccatura di impostazione, anche al momento in cui Monti era diventato
Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le posizioni americane e le posizioni
europee. In Europa si diceva “lacrime e sangue. Prima il risanamento dei conti
pubblici e poi lo sviluppo”. Questa strada si sa che è impossibile, perché tu
non puoi fare il pareggio di bilancio o perseguire obiettivi ancora più
ambiziosi se non c’è la ripresa. In condizioni di ripresa è facile ridurre la
spesa pubblica, ma in condizioni recessive ridurre la spesa pubblica significa
far aumentare la recessione con conseguenze sulle entrate e sulle uscite.
MESSORA: ma è possibile,
secondo te, che questi non lo sanno?
GALLONI: Ma bisogna vedere
quali sono i loro obiettivi.
MESSORA: Quali sono?
GALLONI: E che ne so quali
sono i loro obiettivi?
MESSORA: Si possono
immaginare?
GALLONI: Sono obiettivi anche
di asservimento dei popoli, chiaramente. Mentre la posizione americana era una
posizione di sviluppo, cercando di non peggiorare i conti pubblici, che già è
una versione possibilista. Ma non è la concezione né di Monti né della Merkel né
del polo europeo, chiaramente. Quindi al momento le uniche speranze sono quelle
di una politica nuova che reintroduca la Glass-Steagall, che riproponga la
sovranità monetaria a livello europeo o se no si torni alle valute nazionali o
al limite alla doppia circolazione, che sarebbe assolutamente sostenibile.
MESSORA: Valuta nazionale più
euro?
GALLONI: Sì. Terza cosa da
fare è un gestione diversa dei debiti pubblici, tranquillizzante, perché ci sono
tanti altri modi per gestire i debiti pubblici. In parte qualcosa, addirittura,
è stato anticipato da Draghi che è intervenuto sul mercato secondario
raffreddando gli spread. Quindi praticamente forse Draghi ha fatto una
retromarcia rispetto alle decisioni dell’inizio degli anni ’80 dei cosiddetti
divorzi tra governi e banche centrali. Poi in Italia dobbiamo assolutamente
riposizionare la pubblica amministrazione. Oggi è piazzata in modo di creare
un’alleanza tra irregolari e criminali. Questo ci porta a una sconfitta. La
pubblica amministrazione si deve piazzare in un altro modo, si deve piazzare tra
gli irregolari e i criminali. I criminali li deve trattare come meritano, con
gli irregolari, invece, deve avere tutto un altro atteggiamento, cioè deve
essere la stessa pubblica amministrazione che deve realizzare gli adempimenti
previsti dalle normative e quando c’è scontro, perché spesso c’è scontro tra
norma e diritto, tra norma e buonsenso, tra norma ed equità, il funzionario
pubblico deve essere messo in condizioni di scegliere il diritto, l’equità e il
buonsenso e vedere di tutelarsi rispetto alla arida applicazione della norma. Se
non si fa questo non si va da nessuna parte. E poi, quello che è forse più
importante e che riassume un po’ tutto, dobbiamo acquisire quelle strepitose
tecnologie oggi a disposizione dell’umanità, che rimetteranno in gioco tutti gli
equilibri geopolitici a livello internazionale e a livello locale, ma che sono
la nostra più grande speranza per l’ambiente e per lo sviluppo, per esempio
tutte le tecnologie di trasformazione e di trattamento dei rifiuti solidi
urbani. Ci sono, ripeto, delle tecnologie, alcune sono già applicate, ad esempio
a Berlino si stanno applicando. Tu vai a conferire i tuoi rifiuti e ti danno dei
soldi, poi ricevi energia gratis, non inquini, non ci sono i cassonetti per
strada, non ci sono i mezzi comunali o municipali che intralciano il traffico
per trasportare l’immondizia, non ci sono cattivi odori, non ci sono emissioni
nocive. Questo è fondamentale. L’azzeramento delle emissioni genotossiche e la
limitazione di quelle tossiche nell’ambito dei parametri internazionali.
MESSORA: Facciamo un
ragionamento sullo scenario geopolitico globale. Spiegaci come si bilanciano gli
interessi degli Stati Uniti e quelli dell’Europa con quelli della Cina, se
questi Stati Uniti d’Europa convengono oppure no agli Stati Uniti, se c’è una
pressione, secondo te, da parte loro e in che modo la Cina può influire in
questo processo, se è un influsso positivo o negativo. Lanciamoci in queste
speculazioni.
GALLONI: Diciamo che dopo
Kennedy gli Stati Uniti sono sempre più risultati preda dei britannici. È lì che
c’è un nodo fondamentale da sciogliere. Peraltro gli Stati Uniti hanno
drammaticamente cercato, in determinate situazioni regionali, come può essere la
più importante il Mediterraneo, dei partner adeguati. L’Italia questa partita
non se l’è saputa giocare dopo la caduta del muro di Berlino, per le ragioni che
dicevamo all’inizio. La Cina si sta avvicinando agli Stati Uniti d’America sotto
certi profili, ma è ancora lontanissima sotto altri profili. Non dobbiamo
neanche sopravvalutare certi comparti manifatturieri, che se anche fossero
totalmente ceduti alla Cina e all’India – ma c’è anche il Brasile, c’è anche il
Sud Africa, ci sono tante altre realtà emergenti nel pianeta – non sarebbe un
dramma. Il problema è che noi abbiamo un futuro, ad esempio nei nostri rapporti
con la Cina, se capiamo che non dobbiamo andare lì in Cina per fare un business
qualunque, ma se capiamo che cedendo anche parti delle nostre produzioni
industriali e manifatturiere, otteniamo però una maggiore penetrazione rispetto
ai nostri prodotti di qualità, di eccellenza, perché non ci dimentichiamo che
stiamo confrontando un mercato di 60 milioni di persone con un mercato che è 20
volte più grande. Quindi è chiaro che se noi rinunciamo a qualche cosa, ma
riusciamo anche ad esportare un po’, quel po’ moltiplicato per la domanda che in
questo momento sta crescendo, ci dà tutto un altro risultato. Però della Cina
parlerei da un altro punto di vista. All’ultimo congresso del Partito Comunista
Cinese è stato deciso un grande cambiamento di rotta, cioè di puntare di più
sulla crescita della domanda interna e di meno sulle esportazioni. Questo
potrebbe essere l’inizio della fine della cosiddetta globalizzazione. Non ci
dimentichiamo che la globalizzazione è il sistema che premia il produttore
peggiore, quello che paga di meno il lavoro, quello che fa lavorare i bambini,
quello che non rispetta l’ambiente, quello che non rispetta la salute. Questa è
la causa principale delle crisi che stiamo vivendo: che invece di premiare il
produttore migliore, abbiamo premiato il produttore peggiore. Questo ha
danneggiato le industrie europee e soprattutto l’industria italiana,
chiaramente. E non solo l’industria, anche l’agricoltura.
MESSORA: Perché si demanda la
questione della tutela dei diritti oltre il confine, dove non c’è un controllo.
GALLONI: Si deve rimettere in
piedi l’economia, nel senso che deve avere tutta la sua importanza l’economia
reale. L’economia reale deve avere una finanza che la aiuta. Poi se c’è un’altra
finanza che va a fare disastri da qualche altra parte, che non influiscano
sull’economia reale, sulla vita dei cittadini. Questo deve essere il primo punto
che corrisponde alla reintroduzione della legge Glass-Steagall in pratica. Per
questo possono essere utili le doppie e le triple circolazioni monetarie, le
monete complementari e addirittura la reintroduzione di monete nazionali, pure
in presenza di una moneta internazionale.
MESSORA: Ma per scontrarsi o
per far fronte alla Cina è necessario avere gli Stati Uniti d’Europa o basta
anche il piccolo guscio di noce italiano, come alcuni dicono?
GALLONI: Io non penso che ci
si debba scontrare o frenare la Cina. Bisogna avere delle strategie industriali,
e non solo industriali, in grado di difendere i nostri interessi, i nostri
valori, i nostri principi, le nostre vocazioni. Dopodiché ci si confronta con i
cinesi e si vede quali sono le sinergie che possono essere messe in campo. Si
deve fare un discorso di carattere strategico, secondo me.
MESSORA: Ma la politica di
Nino Galloni quale sarebbe? Uscire dall’euro e recuperare sovranità monetaria o
puntare sul “più Europa”?
GALLONI: A me interessa che ci
siano spese in disavanzo, perché se c’è crisi, se c’è disoccupazione è un
crimine puntare al pareggio di bilancio. Ovviamente se gli Stati hanno pareggio
di bilancio, è possibile che l’Europa faccia gli investimenti in disavanzo, e
allora mi sta benissimo l’euro.
MESSORA: Cosa che non c’è.
GALLONI: Cosa che non c’è, ma
è il terzo passaggio che potrebbe essere favorito dalla gestione Draghi. Io non
lo escludo. Perché chi immaginava che avrebbero dato mezzi monetari
illimitatamente alle banche? Chi immaginava che sarebbero intervenuti per
raffreddare gli spread acquistando i titoli pubblici sui mercati? Adesso il
terzo e ultimo passaggio è quello di accettare di autorizzare mezzi monetari per
la ripresa, per lo sviluppo, per gli investimenti produttivi. L’importante però
è che questo non avvenga in una logica di quantitative easing. Cioè la politica
monetaria sbagliata può impedire lo sviluppo, ma la politica monetaria giusta
non produce lo sviluppo. Cioè la moneta è una condizione necessaria, ma non
sufficiente dello sviluppo. Quindi non basta approntare mezzi monetari a gogò e
allora si acchiappa lo sviluppo. Questa è una visione di tipo liberista
riguardante le emissioni monetarie. In realtà bisogna fare dei progetti di
infrastrutture, di ricerca, di ripresa industriale, di salvaguardia della salute
e degli interessi dei cittadini e soprattutto dell’ambiente, e sulla base di
queste grandi strategie approntare i mezzi monetari che certamente non sarebbero
scarsi. Quindi se io dovessi ripetere i miei punti fondamentali, immediati: una
legge che ripristini la netta separazione tra i soggetti che fanno speculazioni
finanziarie sui mercati internazionali dai soggetti che devono fare credito
all’economia. Perché la prima cosa è il credito, la più grande componente della
moneta, il 94% della moneta è credito. Poi il discorso della sovranità
monetaria, come ho detto prima. O gli Stati o l’Unione Europea devono fare spese
in disavanzo per acchiappare la ripresa. Una diversa gestione dei debiti
pubblici, che è possibile, un diverso posizionamento della pubblica
amministrazione, perché il cittadino deve vedere un amico nello Stato, nella
pubblica amministrazione, quindi fermare anche questo progetto di polizia
europea senza controlli che potrebbe compiere qualunque azione senza dover
rispondere a nessuna autorità.
MESSORA: Eurogendorf con base
in Italia a Vicenza.
GALLONI: Quinto: acquisizione
di tutte quelle grandi tecnologie che oggi sono a disposizione dell’umanità per
migliorare veramente le condizioni di vita di tutti.
MESSORA: L’ultima domanda.
Tedeschi cattivi? Amici o buoni?
GALLONI: I tedeschi sono
posizionati nella storia e nella geografia in modo di doversi in qualche modo
espandere. Se devono assumere una posizione di leader, devono anche accettare di
rivedere le proprie politiche estere. Quindi un paese che voglia essere leader,
come sono stati gli Stati Uniti d’America, importano più di quello che
esportano. Se i tedeschi non accettano di importare più di quello che esportano,
non possono neanche pretendere di essere leader.
La mappa dei poteri, ‘ndrangheta,
massoneria e mafia dalla “premonizione” Cordova alla commissione antimafia,
scrive Alberto Di Pisa su "Sicilia Informazioni" il 25 dicembre 2017. Nel
depositare la relazione della Commissione parlamentare antimafia sui rapporti
tra mafia, ‘Ndrangheta, massoneria, la presidente della Commissione ha
dichiarato: “Dentro la massoneria 193 soggetti con procedimenti penali per fatti
di mafia. L’agire massonico si è pericolosamente atteggiato ad ordinamento
separato dello Stato”. E si legge nella relazione: “Cosa Nostra siciliana e la
‘Ndrangheta calabrese da tempo immemorabile e costantemente fino ai nostri
giorni nutrono e coltivano un accentuato interesse nei confronti della
massoneria”. In effetti I rapporti tra ‘ndrangheta, politica e massoneria non
sono un fatto nuovo. Questa triangolazione esistente in Calabria era stata già
accertata da Agostino Cordova, allora Procuratore delle Repubblica di Palmi, che
sulla base di documenti ed intercettazioni telefoniche ed ambientali aveva
tracciato con nomi e dati, la mappa dei tre poteri. Lo stesso, nell’ambito della
indagine sulla massoneria italiana deviata aveva ipotizzato l’esistenza di una
“super loggia segreta” che portava a Licio Gelli e ad una serie di personaggi
legati a logge massoniche coperte. Promosso Cordova a Procuratore di Napoli,
l’inchiesta venne archiviata. Alcuni anni dopo il pool antimafia di Reggio
Calabria accertò le connessioni tra esponenti della famiglia dei “casati” e la
massoneria coperta, connessioni esistenti soprattutto nel reggino. Nel1995 i
magistrati di Reggio scrivevano: “(….) Sulle risultanze probatorie emergenti dal
capitolo dedicato alla cosiddetta “Cosa Nuova”, l’apparato che attualmente è
chiamato a guidare la ‘ndrangheta calabrese, ci si accorge anche che i gruppi
mafiosi rappresentati in tale organismo verticistico possono contare, tra le
loro fila, su esponenti indicati come facenti parte di logge massoniche dai
collaboratori di giustizia”. Della convergenza di interessi tra mafia e
massoneria aveva parlato Giacomo Lauro uno dei primi pentiti di ‘ndrangheta.
Dichiarò in proposito Lauro nell’ambito dell’inchiesta denominata “Saggezza”:
“Sino alla prima guerra di mafia la massoneria e la ’ndrangheta erano vicine, ma
la ‘ndrangheta era subalterna alla massoneria che fungeva da tramite con le
istituzioni… E’ evidente che in questo modo eravamo costretti a delegare la
gestione dei nostri interessi con minori guadagni e con un necessario
affidamento con personaggi molto spesso inaffidabili. A questo punto capimmo
benissimo che se fossimo entrati a far parte della famiglia massonica avremmo
potuto interloquire direttamente ed essere rappresentati nelle istituzioni”. Ed
ancora “Il nostro ingresso nella massoneria deviata cambiò i rapporti di forza e
noi cominciammo a dialogare direttamente con le istituzioni senza più bisogno di
mediatori. Fu così che Paolo De Stefano, Santo Araniti, Antonio, Giuseppe e
Francesco Nirta, Antonio Mammoliti entrarono a far parte della massoneria”. La
‘ndrangheta quindi fa un salto di qualità che le consentirà, di instaurare, per
le sue attività lecite rapporti, su un piano di parità, con esponenti della
classe dirigente della città di Reggio, anche essi aderenti alla logge
massoniche. In forza di questi collegamenti la ‘ndrangheta entrava nei più
importanti circuiti dell’economia locale, dimostrando al tempo stesso una
notevole capacità di adattamento ai processi di modernizzazione. Secondo la DIA,
infatti le ‘ndrine usano molto internet per riciclare i proventi delle loro
lucrose attività. Ed afferma il generale Carlo Alfiero, ex direttore della
Direzione Nazionale Antimafia: “La mafia calabrese ha notevolmente ampliato la
sua presenza nel territorio nazionale, creando una rete operativa estremamente
efficiente per compartimentazione e segretezza, riproducendo in Italia e
all’estero le strutture ordinative presenti da decenni in Calabria”. Questa
espansione e capacità di adeguamento della ‘ndrangheta ha determinato una
maggiore considerazione della stessa da parte delle altre organizzazioni
criminali, ivi compresi i gruppi terroristici che, ritenendola una
organizzazione affidabile, hanno stretto solidi rapporti finalizzati alla
realizzazione di attività illecite anche al di fuori del territorio nazionale.
Un esempio di attività illecite della ‘ndrangheta, nel settore finanziario e
bancario è dato da quanto riferito da Nicola Gratteri (attuale Procuratore della
Repubblica di Catanzaro e da anni impegnato nel contrasto alla ‘ndrangheta) e
Antonio Nicasio nel libro “Fratelli di sangue”. Scrivono infatti gli autori:
“Nel marzo del 2000, una complessa indagine condotta con l’ausilio di satelliti
ed intercettazioni ambientali ha individuato un business di decine di milioni di
euro relativo a falsificazioni di garanzie bancarie, clonazione di titoli e
altre truffe a istituti di credito, tra i quali Deutsche Bank di Milano”. Ed
ancora un esempio di intreccio tra ‘ndrangheta e corruzione politica è dato
dalla vicenda della centrale a carbone di Gioia Tauro. Nel 1967 la zona
destinata alla costruzione della centrale a carbone era stata dichiarata
“territorio di notevole interesse pubblico per la presenza di tradizionali
coltivazioni, di entità tale da creare numerosi quadri naturali di suggestiva
bellezza panoramica”. Malgrado ciò, il CIPE nel dicembre del 1981, individuò
nella piana di Gioia Tauro la zona in cui realizzare una centrale a carbone,
stanziando per la realizzazione dell’opera ben 5625 miliardi. L’Enel peraltro,
pur in mancanza delle prescritte autorizzazioni di legge, iniziò ugualmente i
lavori. Intervenne la Procura di Palmi che avviò una indagine a carico dell’Enel
avendo accertato, attraverso una perizia sismologica, che l’area in cui sarebbe
dovuta sorgere la centrale era ad alto rischio sismico, il che sconsigliava la
realizzazione dell’opera in quel sito. La Procura avviò anche una indagine nella
assegnazione dei subappalti. La questione arrivò in Cassazione che accolse
il ricorso dell’Enel bocciando l’indagine. Con decreto dell’allora Presidente
del Consiglio Giulio Andreotti venne autorizzata la realizzazione della
centrale. Nella richiesta di rinvio a giudizio dei responsabili dell’Enel, i
magistrati della Procura di Palmi così’ avevano scritto: “La presente indagine
ha messo a nudo nuovamente ed emblematicamente il punto di intreccio tra mafia e
corruzione politica e, più specificamente, il sistema di governo che da sempre
ha gestito l’intervento pubblico al sud e il patto di ferro tra Stato e mafia”.
Indagini giudiziarie accertarono che i rapporti tra ‘ndrangheta ed estrema
destra e tra ‘ndrangheta e massoneria deviata, ebbero inizio in occasione dei
moti di Reggio, come risulta dalle dichiarazioni del Lauro che rivelò ai
magistrati di patti stretti tra esponenti di vertice della ‘ndrangheta ed alcuni
settori della politica nonché della infiltrazione dei primi nella massoneria. In
particolare ha riferito di avere ricevuto l’ordine di mettersi a disposizione di
esponenti della eversione nera affermando che l’adesione della ‘ndrangheta
reggina ai moti era determinata soltanto dallo scopo di soddisfare propri
personali e criminali disegni ed interessi economici. Precisò peraltro che
contrario a questa partecipazione della ‘ndrangheta alla rivolta era Domenico
Tripodi, temuto boss di Sanbattello così come contrario era Antonio Macrì per la
considerazione che, avendo la rivolta attirato sulla Calabria l’attenzione di
tutta l’Italia, erano aumentati i controlli di polizia e vi era una minore
disponibilità dei politici. Lauro ha parlato anche della disponibilità della
‘ndrangheta ad intervenire nel colpo di Stato che nel 1970 avrebbe dovuto essere
attuato in Italia. Ha infatti dichiarato, nel corso del processo svoltosi
davanti alla Corte di assise di Palmi: “Si preparava in Italia un colpo di Stato
che nel dicembre di quell’anno (1970 ndr) avrebbe dovuto sovvertire l’ordine
democratico. Il piano prevedeva l’intervento della ‘ndrangheta e mafia
siciliana. I padrini delle consorterie criminali avrebbero dovuto fornire
manovalanza per neutralizzare eventuali sacche di resistenza”. Dichiarazioni
coincidenti, per quanto riguarda la realizzazione del colpo di Stato, con quelle
di Buscetta, di Luciano Leggio e di altri pentiti di mafia. La ‘ndrangheta
quindi ha instaurato collegamenti con gruppi eversivi, con servizi segreti, con
la massoneria e con la politica; il che le ha consentito di gestire impunemente
le proprie attività illecite nel settore economico, finanziario e bancario,
garantendosi in tal modo, come scrive Nicola Gratteri, una copertura “realizzata
in vario modo (depistaggi, vuoti di indagine, attacchi di ogni tipo ai
magistrati non arrendevoli, aggiustamenti dei processi) cui fece seguito una
sostanziale impunità della ‘ndrangheta ma anche una sua capacità di rendersi
invisibile agli occhi delle istituzioni. Persino l’attività del confidente, un
tempo simbolo dell’infamia, venne consentita soprattutto quando serviva a
stabilire relazioni o scambi utili con rappresentanti dello Stato o per
depistare l’attività investigativa verso obiettivi minori”. (Nicola Gratteri, La
Malapianta: la mia lotta contro la ‘ndrangheta). Non vi è dubbio quindi che in
Calabria esiste una forte connessione tra politica, ‘ndrangheta, imprenditoria e
massoneria deviata. Lo stesso ex procuratore della Direzione nazionale
antimafia, Pier Luigi Vigna, in una intervista rilasciata il 16 febbraio 2006 a
“News Settimanale” ebbe a dichiarare: “La ‘ndrangheta ha collegamenti con logge
massoniche coperte che non appartengono alla massoneria ufficiale: centri di
interessi, di incontri, di agevolazioni”.
Massoneria, mafia e ‘ndrangheta così
unite e diverse. L’intuizione del procuratore Cordova,
scrive Alberto Di Pisa su "Sicilia Informazioni" il 26 dicembre 2017. Un
contributo notevole alla conoscenza dell’intreccio tra ‘ndrangheta, massoneria e
poteri dello Stato è venuto dalla collaborazione di due personaggi di rilievo,
il notaio Pietro Marrapodi, democristiano e il sindaco di Reggio Calabria
Agatino Licandro, entrambi massoni. Il Marrapodi, dopo avere nel 1992
abbandonato la massoneria, denunciò ai magistrati della Procura di Reggio
Calabria le attività illecite della ‘ndrangheta in città accusando anche alcuni
magistrati di contiguità con elementi della ‘ndrangheta. Il 28 maggio 1996 venne
trovato impiccato nella sua abitazione. Qualche dubbio fu avanzato se si fosse
trattato di suicidio considerato anche il fatto che a seguito della sua
collaborazione aveva subito minacce tanto che aveva richiesto una scorta. Le
indagini non fornirono però elementi in contrasto con l’ipotesi del suicidio. Il
Marrapodi era considerato dai magistrati della Procura reggina un collaboratore
altamente attendibile tantè che dopo la sua morte, nel dibattimento di primo
grado davanti la Corte di Assise, il Sostituto procuratore, Salvatore Boemi ebbe
a dichiarare: “Pietro Marrapodi e Giacomo Lauro sono due personaggi che con più
chiarezza hanno tracciato la perfida alleanza tra il mondo massonico deviato in
questa città e le organizzazioni mafiose. E’ un livello dove mafia, politica
economia e istituzioni deviate dello Stato si incontrano per stabilire affari,
spartizioni, ridisegnare geografie di potere”. Agatino Licandro venne raggiunto
da una ordinanza di custodia cautelare per abuso di potere con vantaggio
patrimoniale e, successivamente, da altra ordinanza in carcere, per concussione
inseguito alle dichiarazioni di un imprenditore. Condannato per i reati per cui
era stato tratto a giudizio decise di collaborare con la giustizia rivelando il
meccanismo di potere che gestiva la città di Reggio. Parlò di un vero e proprio
comitato di affari di cui facevano parte rappresentanti delle istituzioni,
magistrati della Corte dei Conti, cinque sindaci della città, di cui tre
democristiani e due socialisti. Tutti respinsero le accuse. A seguito delle
propalazioni del Licandro vennero emessi tre mandati di cattura nei confronti di
tre politici di primo piano di Reggio, Franco Quattrone, Pietro Battaglia e
Giovanni Palamara e un quarto mandato di cattura nei confronti di Giuseppe
Nicolò. A tutti venne contestato di avere fatto parte del vertice politico che
aveva deciso l’eliminazione di Ludovico Ligato ex presidente delle Ferrovie.
Insieme a loro vennero accusati per l’omicidio, quali esecutori materiali alcuni
boss della ‘ndrangheta. L’accusa nei confronti dei politici non resse tuttavia
in Cassazione. Va infine osservato come, a differenza di quanto è avvenuto nella
mafia siciliana, in cui dopo Buscetta e fino ad oggi si è assistito ad un vero e
proprio fiorire di collaboratori di giustizia, nella ‘ndrangheta si è avuto un
numero esiguo di pentiti. La ragione del numero ridotto di collaboratori si
spiega con il fatto che mentre Cosa Nostra uccide i parenti dei pentiti e
talvolta gli stessi pentiti, la ‘ndrangheta adotta una strategia più sottile
consistente nel ricontattare i pentiti, uno per uno, cercando di riconquistarli.
Rocco Lombardo, Procuratore della Repubblica di Lodi, infatti, nella relazione
antimafia del2008 ha formulato il convincimento che la ‘ndrangheta dispone di
mezzi economici di gran lunga superiori a quelli dello Stato per pagare i
pentiti e può in questo modo agire per far ritrattare quanto dichiarato o per
impedire le confessioni”. E’ nel contesto sopra delineato che si inserisce la
vicenda giudiziaria di Antonio Caridi al quale viene contestato dalla Direzione
distrettuale antimafia di Reggio Calabria di essere un dirigente ed
organizzatore della componente riservata della ‘ndrangheta, nella cui veste, in
tutte le consultazioni elettorali dal 1997 sino alle elezioni regionali del
2010, avrebbe goduto dell’appoggio elettorale del clan De Stefano e dei clan
Crucitti ed Audino di Reggio Calabria nonché del medico Giuseppe Pansera, genero
del boss Giuseppe Morabito di Africo, uno fra i capi assoluti di tutta la
‘ndrangheta. Nell’ordinanza del GIP Caridi viene poi accusato di avere
interferito sull’esercizio delle funzioni di organi di rango costituzionale di
cui è, oppure è stato, componente e le cui funzioni avrebbe contribuito a
piegare verso interessi di parte in grado di provocare vantaggi ed utilità
personali, professionali e patrimoniali. A tal proposito il Gip fa riferimento
all’assunzione di Savio Leandro Vittorio, dirigente di settore dell’afor –
Forestazione di Reggio Calabria nonché di Giuseppe Richichi, direttore operativo
di Multiservizi Spa ritenuto ” affiliato di rilievo alla cosca Tegano di Archi
di Reggio Calabria”, di Bruno De Caria, direttore operativo di” Leonia spa”,
affiliato di rilievo della cosca Fontana di Archi di Reggio Calabria, di Logotea
Demetrio, presidente del Consiglio di amministrazione della società Fata Morgana
Spa, espressione politica di Giuseppe Scopelliti, di Aiello Salvatore, direttore
operativo di Fata Morgana Spa, poi divenuto collaboratore di giustizia. Tutti i
suddetti personaggi, secondo l’accusa sarebbero stati favoriti dal Caridi nei
periodi in cui aveva ricoperto l’incarico di assessore all’Ambiente del comune
di Reggio Calabria (dal 2002 al 2007 e dal 2007 al 2010). Lungo è l’elenco delle
assunzioni “favorite” da Caridi elencate nell’ordinanza del GIP e tutte
interessanti le società partecipate e soggetti appartenenti alla ‘ndrangheta o a
questa organizzazione criminale vicini. Il Caridi poi, sempre secondo quanto
riportato nell’ordinanza del GIP, avrebbe imposto all’Azienda ospedaliera
Bianchi-Melacrino-Morelli l’assunzione della signora Concetta Santoro, moglie di
Nicolazzo Bruno appartenente alla cosca Tegano. Viene ancora contestato a Caridi
di avere imposto ai dirigenti delle FF.SS, l’aumento del volume di lavoro della
ditta Ferroser per consentire alla cosca Tegano di accrescere l’importo della
somma di denaro imposta mensilmente a titolo di tangente. Nel periodo poi in cui
ricopriva la carica di Assessore regionale alle attività produttive, Caridi
avrebbe canalizzato sul clan Pelle di San Luca i contributi per il settore
agricolo di sua competenza previa, scrive il GIP, “predisposizione di procedure
pilotate e caratterizzate da false attestazioni”. La vicenda giudiziaria del
senatore Caridi costituirebbe una conferma di quanto giudiziariamente accertato
in passato cioè di come oggi la ‘ndrangheta abbia raggiunto un notevole livello
organizzativo con esponenti delle cosche che hanno acquisito la possibilità di
muoversi liberamente tra apparati dello Stato, politica, servizi segreti,
massoneria e gruppi eversivi ed altresì una conferma di come fosse fondata
l’intuizione del Procuratore Cordova che aveva ipotizzato l’esistenza di una
super loggia segreta e ciò ove si consideri che Caridi è accusato di essere
un dirigente e un organizzatore di una componente riservata della ‘ndrangheta.
La verità su Capaci e via D’Amelio,
l’ombra del Gruppo Bilderberg, scrive Alberto Di Pisa
su "Sicilia Informazioni" il 15 ottobre 2017. Sono state depositate dai giudici
della Corte di assise di Caltanissetta le motivazioni della sentenza del
processo Capaci bis a conclusione del quale sono stati condannati all’ergastolo
quattro boss mafiosi e cioè Salvino Madonia, Lorenzo Tinnirello, Giorgio Pizzo e
Cosimo lo Nigro. Nella parte che concerne i moventi che diedero luogo alla
strage, i giudici di Caltanissetta non escludono che ambienti esterni a Cosa
Nostra abbiano potuto condividere il progetto della strage. Scrivono infatti i
magistrati: “In questo processo, è emerso un quadro sia pure non ancora
compiutamente delineato, che conferisce maggiore forza alla tesi secondo cui
ambienti esterni a Cosa nostra si possano essere trovati, in un determinato
periodo storico, in una situazione di convergenza di interessi con
l’organizzazione mafiosa, condividendone i progetti ed incoraggiandone le
azioni, come ha sostenuto la procura». Questa convinzione sembra trarre spunto
dalle propalazioni di due importanti collaboratori di giustizia Antonio Giuffrè
e Gaspare Spatuzza, entrambi ritenuti attendibili da tutte le Corti che si sono
occupate di processi di mafia conclusisi con pesanti condanne di esponenti
mafiosi. Giuffrè ha infatti riferito che prima della realizzazione della strage,
Bernardo Provenzano aveva interpellato ambienti esterni a Cosa Nostra, ambienti
della imprenditoria, della politica e della massoneria. E a proposito
dell’annullamento del progetto di uccidere Falcone a Roma per ucciderlo poi
nell’attentato di Capaci, scrivono ancora i giudici: “Sembra difficile sostenere
– scrivono nella sentenza – che il mutamento di programma rispondesse
semplicemente a ragioni logistiche. Una simile ipotesi si pone in irrimediabile
contrasto con la particolare complessità che contrassegnava l’organizzazione
dell’attentato di Capaci. Appare, invece, molto più plausibile che la decisione
di Salvatore Riina costituisse una coerente attuazione di quella finalità
che Antonino Giuffrè ha sintetizzato con la frase del Capo di Cosa Nostra.
“Facciamo la guerra che poi viene la pace” Una strategia, questa, che fallì per
effetto della forte reazione dello Stato, ma che, con ogni probabilità, fu alla
base della scelta di Salvatore Riina di procedere prima all’eliminazione
dell’onorevole Lima e poi alla realizzazione di un attentato che costituiva un
vero e proprio atto di guerra contro lo Stato, come la strage di Capaci». Se si
vogliono comprendere le ragioni della uccisione di Giovanni Falcone, avvenuta
con la strage di Capaci, occorre partire da un dato di fatto già evidenziato
nella sentenza. Falcone, che al momento della sua uccisione ricopriva l’incarico
di direttore degli Affari penali, presso il Ministero della giustizia, poteva
benissimo e facilmente essere eliminato a Roma dove, tra l’altro, era solito
spesso muoversi senza scorta. Era stato controllato per mesi da un gruppo di
fuoco guidato da Matteo Messina Denaro e quindi costituiva un facile obiettivo.
Ma era improvvisamente pervenuto un ordine che aveva sospeso “la missione”
romana per cui Falcone non doveva più essere ucciso a Roma ma a Palermo e in
modo eclatante. Il pentito Fabio Tranchina infatti, ha riferito che il “gruppo
di fuoco” che doveva eliminare Falcone, era partito dalla Sicilia con un corteo
di auto guidato dal boss Matteo Messina Denaro, allora non ancora latitante. “Ma
all’improvviso, - ha raccontato Tranchina -. Giunse l’ordine di tornare
indietro. Bisognava uccidere Falcone a Palermo in modo eclatante. Questa
decisione non può essere certo stata determinata, come sostenuto, dalla
difficoltà di realizzare l’attentato a Roma dato che la realizzazione
dell’attentato a Capaci si presentava (come d’altra parte sostenuto in sentenza)
molto più difficoltoso e complesso. L’utilizzo dell’esplosivo per realizzare un
attentato di tipo stragistico creando terrore fu dettato non soltanto dalla
finalità di fare maggiore pressione perché andasse in porto la “trattativa” che
secondo quanto ipotizzato dai magistrati di Palermo e Caltanissetta, era già
stata avviata, ma anche dalla finalità di destabilizzare il Paese per
individuare nuovi referenti per l’organizzazione mafiosa dopo che erano venuti
i meno i collegamenti con il mondo politico a seguito della disastrosa
conclusione, per Cosa Nostra, del maxiprocesso. La domanda che bisogna porsi è
tuttavia la seguente: è possibile che Cosa Nostra autonomamente abbia concepito
questi attentati di tipo stragista, soprattutto considerato che gli attentati di
tipo stragista e terroristico non rientrano normalmente negli obiettivi di
questa organizzazione criminale? Io credo che in questo attentato, così come
nell’attentato fallito all’Addaura in cui dovevano essere uccisi Falcone e i due
magistrati svizzeri Carla Del Ponte e Claudio Lehmann, che si erano incontrati
con lui nell’ambito di indagini su un riciclaggio di denaro sporco legato
all’inchiesta “pizza connection” , attentati entrambi realizzati con l’impiego
di esplosivo di tipo militare, certamente non reperibile in commercio, siano da
intravedere quegli elementi che, come sostenuto nella citata sentenza, sembrano
condurre ad elementi esterni a Cosa Nostra in una situazione di convergenza di
interessi con tale organizzazione, di cui avrebbero condiviso i progetti ed
incoraggiato le azioni. Senza volere formulare tesi complottiste o di
fantapolitica, io credo che nelle stragi, sulla base di alcune considerazioni e
di alcuni elementi di fatto, possa intravedersi quello che viene indicato
come governo mondiale invisibile. L’ex magistrato Ferdinando Imposimato (che si
è occupato come giudice istruttore dei più importanti casi di terrorismo tra cui
il rapimento di Aldo Moro) sostiene, nel suo libro “Repubblica. Stragi
impunite”, che nelle stragi vi sarebbero state complicità dello Stato o di
frammenti dello Stato, con la mafia, con la massoneria e con il terrorismo nero,
organizzazioni poi fuse nella organizzazione Gladio, cioè in quella
organizzazione internazionale che era manovrata dalla CIA. Tale organizzazione,
che secondo Imposimato esisterebbe ancora, serviva ad impedire la dinamica
politica nel senso di spostare gli equilibri da destra verso il centro sinistra
per rafforzare il potere, destabilizzare l’ordine pubblico e quindi stabilizzare
il potere politico. Sostiene poi che dietro le stragi vi sarebbe il gruppo
Bilderberg che “comanda il mondo e le democrazie invisibili in modo da
condizionare lo sviluppo democratico dei Paesi. Lo stesso sarebbe “uno dei
responsabili della strategia delle tensione e quindi anche delle stragi” che
“vuole gestire la dinamica democratica dei Paesi occidentali tra cui l’Italia ed
anche la dinamica economica”. Ciò, in effetti risulta da un documento, allegato
alla requisitoria di Emilio Alessandrini, pubblico ministero della strage di
Piazza Fontana, ucciso da prima Linea nel 1979. Si tratta di un documento
riservato, il rapporto RSD/Zeta n.230 del 5 giugno 1967 che descrive l’esistenza
di un governo mondiale invisibile e da cui emergono le connessioni tra
terrorismo e gruppo Bilderberg. In questo documento si dice che i tre pilastri
del governo mondiale sono il gruppo Bilderberg, la CIA e l’ADA (Association for
democraticaction) che all’epoca era diretta da Arthur Schlesinger, braccio
destro e consigliere di John Fitzgerald Kennedy. In particolare, per quanto
riguarda l’Italia, si legge in tale documento, che bisogna influire sulla
dinamica del governo italiano sia intervenendo nella formazione del governo sia
nella scelta dei segretari dei partiti di governo, strategia da attuare anche
mediante atti di terrorismo. Questi documenti, che provengono dal sequestro
disposto dai magistrati che indagavano sulla strage di Piazza Fontana, erano
conservati in una cassetta di sicurezza nella disponibilità di Giovanni Ventura.
Da una indagine condotto dalla Commissione parlamentare risulta che Gladio, uno
dei pilastri del governo mondiale, altri non è che la CIA che esercita il
controllo sui nostri servizi segreti. Pertanto, dice Imposimato nel suo libro e
in alcune interviste che “quando parliamo di servizi segreti presenti nella
strage di via D’Amelio dobbiamo pensare che ci sono i servizi segreti italiani
ma sono a loro volta governati dalla CIA. Ma cosa è il gruppo Bilderberg? Si
tratta di un gruppo ristretto che dal 1954 si riunisce una sola volta all’anno
per decidere in segreto le sorti dell’umanità. Le riunioni, alle quali nessun
giornalista può avere accesso, fino a poco tempo fa avevano luogo presso l’Hotel
Bilderberg, in una piccola cittadina olandese. Dalla privacy armata che la
protegge, la classe dirigente globale detta legge sulla politica, economia e
questioni militari. Questo gruppo afferma che lo scopo di questi incontri è
quello di favorire il confronto libero tra personalità influenti del mondo
occidentale atlantico. La scrittrice e politica statunitense Phillys Stewart
Schlafly, nel suo libro “A Choisenot an Echo”, trattando del gruppo Bidelberg,
sostiene che “dal 1936 fino al 1960, i candidati presidenziali repubblicani sono
stati selezionati da un piccolo gruppo di Kingmaker che sono i più potenti
creatori di opinioni”. La Schlafly, nel suo libro afferma anche, per averlo
appreso da un anonimo osservatore, che nella riunione tenutasi nel 1957 nella
St. Simon’s Island, non erano presenti i capi di Stato ma coloro che “danno
ordini” ai capi di Stato. Un articolo pubblicato sul giornale della JBS
ipotizzava poi un legame tra i Bildberghers e l’assassinio di
Kennedy. L’American opinion inoltre, segnalava la strana coincidenza che pochi
giorni dopo l’incontro avvenuto tra Kruscev e John Mc Cloy, direttore della
Chase Manhattan,” profondamente coinvolto” nel Bilderberg, Lee Harvey Oswald,
sospettato dell’assassinio di Jhon kennedy, abbia contattato l’ambasciata
americana a Mosca per poter tornare negli Stati Uniti. E sempre a proposito del
potere del gruppo Bilderberg, Gary Allen, autore del libro “None dare to call
itconspiracy”, pubblicato nel 1991, dopo avere detto che il Bilderberg è “un
gruppo di sinistra” dal quale nascerebbero importanti scelte di politica estera
per gli Stati Uniti, scrive : “Poco dopo l’incontro ( del Bilderberg), di
Woodstok( aprile 1971) due eventi sinistri e di cambiamento di ruoli sono
avvenuti : Henry Kissinger è andato a Pechino ad accordarsi per l’accettazione
della Cina Rossa come membro della famiglia delle nazioni in commercio tra loro,
e una crisi monetaria internazionale si è sviluppata, dopo la quale il dollaro è
stato svalutato” Non mancano poi coloro che ritengono che il Bilderberg abbia
avuto un ruolo nella creazione dell’euro e che, come risulterebbe da numerose
prove, le riunioni avrebbero avuto come finalità quella di imporre “il
superstato” dell’Unione Europea” ai cittadini europei nonostante la loro
contrarietà. A ulteriore riprova della influenza del gruppo Bilderberg sulla
economia mondiale il giornalista americano Westbrook Pegler parla di una
riunione segreta tenuta a JekillIslands da un gruppo di banchieri statunitensi
dalla quale era nata la proposta di costituzione della Federal Reserve, la banca
centrale americana. Ma chi sono i componenti del gruppo Bilderberg? Si tratta in
molti casi di capi di governo occidentali o banchieri centrali, che prima di
assumere tali incarichi, hanno fatto parte del Comitato direttivo o hanno
partecipato a un incontro del Gruppo Bilderberg o della Commissione trilaterale
(Quest’ultima è un’associazione privata, fondata nel 1973 da un gruppo di
cittadini Nord Americani, Europei e Giapponesi con la finalità di offrire ai
soci un forum permanente di dibattito per approfondire i grandi temi comuni alle
tre aree interessate). Domenico Moro, autore di diversi volumi di carattere
economico, politico e militare, nel suo libro “Il Gruppo Bilderberg : “L’elite
del potere mondiale”, cita tra costoro” Clinton, Blair, Merkel, Cameron, Mario
Monti ed Enrico Letta, ed aggiunge : “Tali strane coincidenze, insieme alla
presenza di personalità del gotha economico-politico come Kissinger e Rockfeller
e alla segretezza con cui il Bilderberg circonda i suoi incontri, hanno offerto
terreno fertile a un’ampia letteratura complottista. (…) Bilderberg e
Trilaterale sono oggi organizzazioni dell’elite transnazionale, che comprende e
riunisce i vertici delle multinazionali, delle grandi banche e del mondo
politico e accademico all’interno dei quali c’è una consistente pattuglia di
italiani. Ed osserva sempre Moro: “E’ evidente che l’esistenza di queste
organizzazioni pone una questione di non poco conto, ovvero il controllo
democratico sui processi decisionali e l’influenza di ristrettissimi gruppi
privati sulle decisioni pubbliche”. Fatte queste premesse ritorniamo al quesito
iniziale: perché Falcone e Borsellino vennero uccisi? Io credo che uno dei
motivi, che non ne esclude altri, quello che può definirsi il motivo scatenante,
va ricercato nelle indagini che Falcone aveva avviato e intendeva portare avanti
su Gladio, come si è visto uno dei tre pilastri del governo mondiale e che altro
non era se non la CIA, indagini che aveva avviato fin dall’agosto del 1990,
allorquando rivestiva le funzioni di Procuratore aggiunto della Repubblica di
Palermo e che venivano osteggiate dall’allora Procuratore capo. Ciò risulta in
maniera evidente dal diario di Falcone, da lui consegnato alla giornalista Liana
Milella e pubblicato sul Sole 24 ore”. Scrive infatti Falcone in proposito:
“Dopo che, ieri pomeriggio, si è deciso di riunire i processi Reina, Mattarella
e La Torre, stamattina gli ho ricordato (al capo della Procura n.d.r.) che vi è
l’istanza della parte civile nel processo La Torre (Pci) di svolgere indagini
sulla Gladio. Ho suggerito, quindi, di richiedere al G.I. di compiere noi le
indagini in questione, incompatibile col vecchio rito, acquisendo copia
dell’istanza in questione. Invece sia egli sia Pignatone insistono per
richiedere al G.I. soltanto la riunione riservandosi di adottare una decisione
soltanto in sede di requisitoria finale. Un modo come un altro per prendere
tempo”. Il giorno dopo, il 19 dicembre: “Non ha più telefonato a Giudiceandrea
(il procuratore capo di Roma ndr) e così viene meno la possibilità di incontrare
i colleghi romani che si occupano della Gladio”. Falcone, che aveva intuito la
possibilità che Gladio fosse coinvolta negli omicidi eccellenti verificatisi a
Palermo, Reina, Mattarella, La Torre, Dalla Chiesa, era consapevole del rischio
che tale indagine comportava tanto da avere detto al pubblico ministero di
Trapani che indagava sull’omicidio di Mauro Rostagno, che entrambi stavano
indagando su fatti che erano pericolosi per la loro vita. Nell’ambito del
processo Rostagno era emerso infatti, che da Trapani, Gladio portava le armi in
Libia. Arconte, un ex agente di Gladio riferì che molte volte era stato a
Trapani e tutte le operazioni in Africa erano coordinate dalla locale sezione
“Skorpio”. L’Arconte testimoniò che arrivava al porto e veniva accompagnato in
una base di appoggio che si trovava in una collinetta. Aveva saputo poi che la
persona che andava a prenderlo e che gestiva la base di Trapani era Vincenzo Li
Muli, un militare italiano, sottufficiale dei servizi segreti italiani, ucciso
in Somalia il 12 novembre 1993 durante la missione Ibis, il giorno prima di
testimoniare davanti ai giudici su Gladio, l’operazione Stay Behind e il
traffico di armi e scorie nucleari in Somalia. L’anno successivo alla morte
emerse che Li Muli sarebbe stato un informatore di Ilaria Alpi, sui traffici di
armi e scorie. Evidenti pertanto erano i rischi che una indagine su Gladio
avrebbe comportato e di ciò era ben consapevole Falcone. Delle indagini su
Gladio Falcone certamente parlò con Paolo Borsellino e questi fece l’imprudenza
di dichiarare pubblicamente il 25 giugno del 1992 che il diario, pubblicato due
giorni prima da Liana Milella sul Sole 24 ore era un diario autentico al cento
per cento così avvalorando e rendendo noto il fatto che Falcone indagava su
Gladio che riteneva implicata negli omicidi di cui si è detto. E’ anche
probabile che Borsellino, nella famosa agenda rossa, misteriosamente scomparsa
dal luogo della strage, avesse annotato quanto appreso da Falcone su Gladio e
sul coinvolgimento di questa organizzazione nei delitti Reina, Mattarella, La
Torre, Dalla Chiesa ed altri delitti eccellenti. Borsellino inoltre aveva
dichiarato pubblicamente che era sua intenzione recarsi dal Procuratore della
Repubblica di Caltanissetta per riferire quanto a sua conoscenza sui moventi
della strage di Capaci. Questa notizia unitamente a quella delle indagini che
Falcone intendeva condurre su Gladio, ben può avere determinato questa
organizzazione alla realizzazione della strage di via D’Amelio. Borsellino non
sarà mai convocato dalla Procura di Caltanissetta. A riprova della delicatezza
delle indagini che Falcone aveva avviato su Gladio non può non ricordarsi che a
tutt’oggi non sono stati identificati coloro che dopo la strage di Capaci
ispezionarono i file del computer di Falcone riguardanti Gladio e i delitti
politico mafiosi e il cui scopo era quello di ricercare documenti scottanti di
cui evidentemente conoscevano l’esistenza. Va detto per completezza che secondo
quanto dichiarato dal figlio di Vito Ciancimino, Massimo, il padre sarebbe stato
un appartenente a Gladio e avrebbe fatto da tramite tra chi dava l’ordine e Totò
Riina. Va tuttavia anche detto che circa l’appartenenza di Vito Ciancimino a
Gladio si dimostrò scettico, pur non escludendo tale possibilità, l’ex
Presidente della Repubblica Francesco Cossiga il quale all’AdnKronos ebbe a
dichiarare: “Mai sentito dire prima e guardi che io, modestamente, la storia di
Gladio un po’ la conosco. Comunque che io non sapessi, non vuol dire nulla. Ne’
mi pare che il suo nome sia negli elenchi pubblici…ma anche questo dice poco.
Nessuno me ne ha mai parlato, neanche in seguito, però era una struttura
altamente compartimentata e quindi è possibile che certi segreti fossero davvero
segreti. Di sicuro il nome di Ciancimino non è citato neanche nei libri che
recentemente hanno raccontato di Gladio. Boh. “Non capisco – aggiunge Cossiga
– che cosa avrebbe dovuto fare un gladiatore in Sicilia. Prima che le armate
sovietiche fossero arrivate fino a Palermo, sarebbero intervenuti americani e
inglesi. Qualcuno dimentica che razza di presidi fossero le loro basi nel
Mediterraneo, un tempo”.
Capaci e Via D’Amelio, la mafia eseguì
ordini esterni. Ecco le prove, scrive Alberto Di Pisa
su "Sicilia Informazioni" il 17 ottobre 2017. Sembrerebbe aprire scenari che per
la strage di Capaci ricondurrebbero non soltanto alla mafia ma anche ad entità
esterne quanto dichiarato da Francesco di Carlo, legato ai Servizi, pentito dal
1996 e che per trent’anni ha fatto da ponte tra Stato e mafia. Questi ha
riferito ai magistrati che mentre si trovava detenuto in Inghilterra erano
venuti a trovarlo più volte, dopo l’attentato all’Addaura, agenti dei servizi
segreti che parlavano in inglese insieme ad altri agenti che parlavano italiano
e tra questi Arnaldo La Barbera già dirigente della Squadra mobile di Palermo,
colui che gestì le indagini per le stragi di Capaci e via D’Amelio e che
convinse a collaborare il falso pentito Vincenzo Scarantino, condannato per la
strage di via D’amelio e le cui dichiarazioni autoaccusatorie sono state
clamorosamente smentite 17 anni dopo dal collaboratore Gaspare Spatuzza, nel
processo Borsellino quater. Ebbene il Di Carlo ha riferito che i suddetti
personaggi lo avevano contattato per avere indicazioni su un esperto in
esplosivi, che lui aveva indicato nella persona di Antonino Gioè (suicidatosi in
carcere) che a sua volta gli aveva indicato Pietro Rampulla. Particolare non
privo di importanza: Pietro Rampulla, condannato per la strage di Capaci nella
quale ebbe il ruolo di artificiere, in passato è stato militante di Ordine
Nuovo, legato alla destra eversiva, e a Rosario Cattafi, l’avvocato di
Barcellona, anche lui esponente in passato di Ordine Nuovo ed oggi testimone nel
processo trattativa Stato- Mafia. Ha in particolare dichiarato Di Carlo: “Quando
ero agli arresti in Inghilterra, prima dell’attentato all’Addaura, in carcere mi
vennero a trovare tre persone. Uno di questi si presentò come Giovanni e mi
disse che mi portava i saluti di Mario (un altro soggetto appartenente ai
servizi segreti). Mi hanno chiesto un contatto con i corleonesi di Totò Riina.
Mi dissero ‘Ci devi fare avere un contatto a Palermo con i corleonesi. A noi ci
interessa il ramo politico di certe situazioni’. Volevano mandare via Falcone da
Palermo perché stava facendo la Dia e la Procura nazionale. Mi raccontavano che
i politici erano preoccupati, che ne dicevano di tutti i colori perché Falcone
voleva indagare su tutto e mettere tutti sotto processo. Loro volevano soltanto
mandarlo fuori e per fare qualcosa in Sicilia volevano avere le spalle
coperte”. Il collaboratore proseguiva dicendo che aveva messo i suoi
interlocutori in contatto con Ignazio Salvo, l’esattore di Salemi condannato per
associazione mafiosa ed ucciso a Palermo nel 1992, ricevendo conferma
dell’avvenuto incontro. In una intervista rilasciata il 2 ottobre 2015 al “Fatto
Quotidiano” parlando di La Babera, Di Carlo afferma: “…Ho accusato Arnaldo la
Barbera che non era il solito agente segreto, ma un superpoliziotto in carriera
messo dal capo della polizia Vincenzo Parisi alla guida del pool che indagava
sulle stragi. Cosa che non ho mai capito. La Barbera stava li per spiarlo, (il
pool, n.d.r.), lo considero il più grande depistatore di tutti i tempi. Era nel
Sisde fino all “88” ma nell’ “89” è venuto a trovarmi in Inghilterra insieme a
Giovannino del Sismi, si era portato a Palermo la squadretta che aveva a
Venezia, ha arrestato Scarantino che non sapeva neppure il proprio nome. Ma a
Caltanissetta dicono: “Si il depistaggio è tutta colpa di La Barbera, lui è
morto chiudiamola qui. Incredibile”. Queste rivelazioni mi inducono a porre i
seguenti interrogativi: Ma per ordine o imput di chi agiva La Barbera? E il
depistaggio quali responsabilità nella strage mirava a coprire?” Alla domanda
poi dell’intervistatore sul perché fossero stati uccisi Falcone e Borsellino
così rispondeva Francesco di Carlo: “La mafia da sola non avrebbe avuto il
coraggio di uccidere Falcone e Borsellino. Ma i due giudici non colpivano
soltanto la mafia. Per scoprire i flussi di denaro sporco hanno introdotto il
segreto bancario perfino in Svizzera: bisognava fermarli e lo hanno fatto. Anche
dentro Cosa Nostra ci sono uomini di potere in grado di dialogare con il mondo
esterno.” Sempre in tale intervista Di Carlo parla di una riunione che molti
anni dopo il 1980 sarebbe avvenuta. in una villa del Circeo e dove erano
presenti mafiosi ed uomini di Stato per decidere i destini d’Italia. Afferma in
proposito: “La riunione si tenne nella villa di Umberto Ortolani a San felice
Circeo, lui era già fuggito in Brasile, la P2 non era stata ancora scoperta, ma
c’era aria di tempesta. Era inverno, febbraio forse: Piersanti Mattarella era
stato ucciso da poco, dio sa se mi sono battuto per salvarlo. Ricordo che
accompagnai da Roma un paio di persone, salimmo lungo un sentiero di montagna,
ma dal promontorio si vedeva il mare”. Alla domanda poi del giornalista che gli
chiedeva se a questa riunione fosse presente Andreotti rispondeva: “Non c’era,
però c’erano Nino Salvo, l’avvocato Vito Guarrasi, il capo del Sismi Giuseppe
Santovito e un politico, forse un ministro, di cui non ricordo il nome. Di
sicuro non si parlò di stragi, semmai di colpo di Stato (parola mai usata però).
C’erano gli scandali giudiziari, la sinistra comandava troppo, bisognava
intervenire e c’era bisogno di Cosa Nostra che stava li a difendere i suoi
interessi. Tutto doveva ancora succedere, la P2 non era stata ancora scoperta e
i generali erano tutti al loro posto”. Da quanto dichiarato da Francesco Di
Carlo, collaboratore ritenuto dai magistrati altamente attendibile, emerge con
tutta evidenza quella convergenza di interessi tra mafia, politica, finanza,
servizi segreti che potrebbe avere determinato le stragi fino a quelle di Capaci
e via D’Amelio, convergenza finalizzata alla realizzazione e al mantenimento
degli interessi propri di ciascuna delle suddette componenti non esitandosi a
ricorrere ad azioni delittuose oggi qualvolta tali interessi venissero posti in
pericolo. Alla luce di quanto fin qui detto può sostenersi che la mafia soltanto
in parte debba ritenersi responsabile delle stragi di Capaci e via D’Amelio,
convinzione che troverebbe riscontro in quanto affermato da Tommaso Buscetta nel
corso di un colloquio casuale intervenuto tra lo stesso e il giudice Ferdinando
Imposimato. Riferisce infatti quest’ultimo in una intervista rilasciata ad una
emittente televisiva: “Io stavo andando nell’America latina per incarico delle
Nazioni Unite per degli addestrarmenti di giudici boliviani colombiani ed
ecuadoregni. Sull’aereo mi sono trovato per caso accanto a Tommaso Buscetta.
Siamo stati 12 ore insieme e Buscetta mi ha fatto una serie di rivelazioni ma
con molta capacità logica. Mi diceva: scusi parliamo dell’omicidio di Dalla
Chiesa, mi ricordo benissimo. Noi mafiosi che interesse avevamo a colpire un
generale che non ci aveva fatto proprio niente? Ma scusi lei che cosa vuole
dire? Che è stata la mafia ma non per volontà della mafia ma per ordini che
venivano dall’esterno? Cioè lui mi ha fatto tutta una serie di casi di delitti
di mafia che la mafia aveva interesse a non eseguire comprese le stragi di
Capaci e via D’Amelio perché avrebbero portato dei danni alla propria esistenza
perché poi da lì è cominciata la fuga da Cosa Nostra. Non c’entra la legge sui
pentiti. Il fenomeno del pentitismo si è verificato prima della legge sui
pentiti. Loro stavano facendo una cosa che non serviva a Cosa nostra ma serviva
ad altre entità.” Anche per ciò che riguarda gli attentati del “93” Buscetta
sosteneva che anche questi erano delitti che Cosa Nostra non voleva commettere.
Cosa Nostra non sapeva nemmeno che esistevano la galleria degli Uffizi e gli
altri monumenti storici. Anche da queste affermazioni di Buscetta, riportate da
Imposimato, si intuisce l’esistenza di entità esterne dalle quali sarebbe
partito l’imput alla realizzazione delle stragi. Falcone aveva capito tutto ciò
come può dedursi dal fatto che dopo il fallito attentato dell’Addaura parlò di
“menti raffinatissime” che non potevano certo essere quelle di esponenti di Cosa
Nostra e che, dopo l’attentato, tentarono di far apparire quello dell’Addaura un
falso attentato organizzato dallo stesso Falcone. D’altra parte, l’allora
vicedirettore della Direzione investigativa antimafia, in un appunto riservato
del 27 luglio 1992, otto giorni dopo l’eccidio di via D’Amelio, scriveva che
dalla strage emergeva “un contesto delinquenziale in cui da un lato trova
conferma l’attualità di una strategia destabilizzante nei confronti delle
istituzioni e, dall’altro, si intravedono elementi tali da far sospettare che il
progetto eversivo non sia di esclusiva gestione dei vertici di Cosa Nostra, ma
che allo stesso possano aver contribuito e partecipato altri esponenti del
potere criminale, sia a livello nazionale che internazionale” Come dire : le
stragi non furono solo un fatto di mafia ma videro coinvolte altre entità a
livello nazionale ed internazionale. E sempre De Gennaro esprimeva tale
convinzione allorquando, parlando dinanzi alla Commissione parlamentare
antimafia dell’omicidio di Paolo Borsellino affermava che tale omicidio
presentava “una chiara anomalia del tradizionale comportamento mafioso, aduso a
calibrare le proprie azioni delittuose si da raggiungere il massimo risultato
con il minimo danno”. Ciò significa, considerati i notevoli danni che derivarono
per Cosa Nostra dalla strage di via D’Amelio (l’immediata applicazione del
decreto legge, emanato dopo la strage di Capaci, che prevedeva il carcere duro
per i mafiosi) che non Cosa Nostra ma altri rimasti nell’ombra, decisero la
realizzazione del nuovo eclatante delitto a così poca distanza di tempo da
Capaci. E d’altra parte le indagini hanno accertato che le stragi non possono
essere addebitate al solo Riina se è vero che, prima della loro attuazione,
questi consultò ed incontrò persone esterne a Cosa Nostra tra cui massoni,
neofascisti, esponenti dei servizi segreti. Bisogna evitare tuttavia un equivoco
che si verifica quando si parla di mandanti esterni a Cosa Nostra. E’noto che
l’organizzazione mafiosa non è adusa a prendere ordini da altri ma agisce quando
si verifica una convergenza di interessi alla realizzazione di un delitto, tra
la stessa organizzazione e entità esterne ad essa quali possono essere soggetti
politici, massoneria, servizi deviati, ambienti imprenditoriali. Questo concetto
è stato affermato anche dal collaboratore Antonino Giuffrè il quale appunto ha
parlato di “interessi convergenti” alla eliminazione di Falcone provenienti dai
suddetti ambienti esterni. Si pensi alla presenza sul luogo delle stragi di
soggetti appartenenti ai Servizi deviati. E che la strategia stragista del
1992-93 sia stata caratterizzata da una convergenza di interessi tra mafia ed
altre forze criminali trova conferma in una informativa del 1993 della Direzione
investigativa antimafia nella quale si legge che dietro le stragi si muoveva
una “«aggregazione di tipo orizzontale, in cui ciascuno dei componenti è
portatore di interessi particolari perseguibili nell’ambito di un progetto più
complesso in cui convergono finalità diverse»; e dietro gli esecutori mafiosi
c’erano menti che avevano «dimestichezza con le dinamiche del terrorismo e con i
meccanismi della comunicazione di massa nonché una capacità di sondare gli
ambienti della politica e di interpretarne i segnali». In termini più semplici
la informativa del 1993 della DIA vuol dire che accanto ai boss di Cosa Nostra,
cioè personaggi come Totò Riina, Messina Denaro, i Graviano che perseguivano gli
interessi propri dell’organizzazione mafiosa, vi erano altri elementi che si
servirono della mafia per destabilizzare, con le stragi di Capaci, via D’amelio
e quelle del “93” l’assetto politico. Alcuni collaboratori di giustizia hanno
parlato di un summit di mafia che verso la fine del 1991 ebbe luogo in un
casolare delle campagne di Enna e al quale parteciparono tutti i capi mafia
della Sicilia convocati da Totò Riina. Nel corso di questa riunione fu fatto
credere agli intervenuti che occorreva effettuare le stragi al fine di
costringere lo Stato a venire a patti per ottenere l’impunità e benefici
penitenziari. Totò Riina disse che bisognava prima fare la guerra per poi fare
la pace. In realtà in quella riunione si celava un progetto politico che stava
dietro alle stragi e che era a conoscenza soltanto di Totò Riina e di alcuni
vertici di Cosa nostra ma che rimase nascosto ad altri capi ed esponenti mafiosi
di minore rilievo; il che è significativo di contatti ed incontri che Riina
aveva intrattenuto con entità esterne a Cosa nostra, interessate alla
realizzazione di quel progetto e che solo lui e pochi altri come i fratelli
Graviano, Santapaola , Madonia ed altri capi detenuti conoscevano. Il capomafia
Giovanni Ilardo, legato ai servizi segreti e alla destra eversiva che aveva
iniziato a collaborare e che era intenzionato a rivelare ai magistrati il
coinvolgimento di apparati deviati dello Stato in stragi ed omicidi eseguiti
dalla mafia, venne assassinato prima che potesse mettere a verbale le sue
propalazioni. E alla presenza di elementi esterni a Cosa nostra riportano le
dichiarazioni del collaboratore Gaspare Spatuzza, che ha confessato la sua
partecipazione alla strage di via D’Amelio, e che ha riferito di un personaggio,
non appartenente a Cosa Nostra, che assistette al collocamento dell’esplosivo
all’interno dell’autovettura utilizzata per la strage di via D’Amelio,
personaggio che non è stato possibile identificare. Come è stato osservato in
proposito dal Procuratore Generale di Palermo “Chi conosce le regole della mafia
sa bene che tenere segreta a uomini d’onore l’identità degli altri compartecipi
alla fase esecutiva di una strage è un’anomalia evidentissima: la prova
dell’esistenza di un livello superiore che deve restare noto solo a pochi capi”.
E la presenza di elementi esterni a Cosa Nostra emerge anche da
una intercettazione telefonica del 14 dicembre 1993 relativa ad una
conversazione intervenuta tra il collaboratore Santino Di Matteo e la moglie
Francesca Castellese, dopo il rapimento del figlio e nella quale quest’ultima
scongiura il marito di non parlare ai magistrati degli “infiltrati” intervenuti
nella strage di Via D’Amelio. Infiltrati che purtroppo non è stato possibile
identificare. Ancora oggi sussistono numerose ombre su quelle che possono essere
state le responsabilità nelle stragi di Capaci e via D’amelio e sul ruolo che
hanno avuto in questi gravi delitti apparati investigativi e organismi nazionali
ed internazionali nonché pezzi dello Stato che potrebbero avere fornito
copertura alla organizzazione mafiosa anche istaurando con questa, in cambio di
una sospensione della strategia stragista, un dialogo; ipotesi questa la cui
fondatezza attualmente è al vaglio dei giudici di Palermo e che costituisce
oggetto del processo noto come trattativa Stato-Mafia. Soltanto un collaboratore
del peso di Totò Riina o un pentito all’interno delle istituzioni potrebbe fare
luce sulle motivazioni reali che determinarono la morte di Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino ma anche sui cosiddetti “omicidi politici” quali quelli
di Michele Reina, Piersanti Mattarella, Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla
Chiesa. Si tratta di omicidi che sono stati commessi non solo per fare fronte ad
interessi di Cosa Nostra ma per attuare una strategia che era perseguita da
altre entità politiche, finanziarie, imprenditoriali non soltanto nazionali ma
anche internazionali. E d’altra parte, come sostenuto da Buscettama anche da
altri pentiti, si tratta di delitti che la mafia era sotto un certo aspetto
restia ad eseguire ma che ha eseguito anche per esigenze estranee a Cosa Nostra,
nell’interesse cioè di entità esterne con le quali i contatti venivano tenuti
soltanto dai vertici di Cosa Nostra e di cui venivano tenuti all’oscuro gli
appartenenti di rango inferiore.
“Falcone seguiva la pista di Gladio”: le
indagini top secret di Borsellino. Le audizioni al Csm
dei magistrati di Palermo all’indomani di Capaci e via D’Amelio: “Allarmi
inascoltati”, scrive Antonella Mascali il 22 maggio 2018 su "Il Fatto
Quotidiano". Ci sono testimonianze inedite dei magistrati di Palermo che hanno
lavorato fianco a fianco con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sulle settimane
precedenti alle stragi di Capaci e via D’Amelio a Palermo, avvenute il 23
maggio e il 19 luglio 1992. Sono racconti drammatici sulla strada sbarrata a
Falcone che voleva la verità sugli omicidi politico-mafiosi e i possibili legami
con Gladio; sulla diffidenza di Borsellino nei confronti di alcuni colleghi, a
cominciare dall’allora procuratore di Palermo Pietro Giammanco. Borsellino stava
conducendo indagini in gran segreto sulla morte di Falcone, ma anche su vicende
indicate dallo stesso magistrato nei suoi diari pubblicati dopo Capaci. Sugli
allarmi ignorati che, forse, avrebbero potuto salvare le vittime delle due
stragi. Alfredo Morvillo, Roberto Scarpinato, Vittorio Teresi, Ignazio De
Francisci, Antonio Ingroia sono alcuni dei pm di allora alla Procura di Palermo
che sono stati ascoltati dal comitato antimafia del Consiglio Superiore della
Magistratura tra il 28 e il 30 luglio 1992, una decina di giorni dopo la strage
di via D’Amelio. Sono i pubblici ministeri che avevano firmato assieme a Teresa
Principato, Antonio Napoli e Giovanni Ilarda (tra i contrari Giuseppe Pignatone,
Guido Lo Forte e Gioacchino Natoli) un documento in cui presentavano
polemicamente le dimissioni per l’assoluta mancanza di sicurezza e per la
gestione della Procura da parte di Giammanco. Il procuratore, com’è noto, su sua
richiesta sarà trasferito nell’agosto successivo, i pm ritireranno le loro
dimissioni e alla guida della Procura arriverà Gian Carlo Caselli. Le
deposizioni dei magistrati non sono mai state rese pubbliche. Stranamente, il
Csm non le ha incluse negli atti desecretati su Falcone e Borsellino in
occasione del venticinquesimo anniversario della strage, l’anno scorso.
Al Fatto risulta che queste testimonianze, di recente, siano state acquisite
dalla Procura di Caltanissetta che è tornata a scandagliare i buchi neri delle
indagini su chi ha voluto la morte di Falcone e Borsellino.
Roberto Scarpinato (Ex pm e ora procuratore
generale di Palermo – audizione del 29 luglio 1992). Dinanzi alla bara di
Giovanni Falcone, Paolo Borsellino disse: ‘Ciascuno di noi deve avere la
consapevolezza che se resta, il suo futuro è quello’ e indicò la bara di
Falcone. Paolo Borsellino sapeva che doveva morire. I carabinieri avevano
segnalato che si stava organizzando un attentato, sapevamo che era arrivato
il tritolo, sapevamo che il prossimo della lista era Paolo Borsellino. Ecco
perché è una strage in diretta. Borsellino è morto per il tritolo e per
l’incapacità di questo Stato di proteggere i servitori dello Stato. Mi è venuto
in mente che era stato abolito il servizio di elicotteri per sorvegliare le
autostrade di Punta Raisi perché ogni volo costava 4 milioni, e che Giovanni era
addolorato di questo fatto. (…). C’è una riunione alla quale partecipa il
Procuratore Giammanco, Falcone dice in tono acceso a Giammanco: ‘Io non
condivido il tuo modo di gestire l’ufficio’ (con riferimento al processo per gli
omicidi politici di Michele Reina, Piersanti Mattarella e Pio La Torre, ndr) . I
problemi con Giammanco si ponevano quando si passava in materia di mafia a
livelli superiori. Per esempio il caso Gladio. Accade in particolare che un
estremista di destra, di Palermo, dichiara alla televisione che lui faceva parte
di un’organizzazione clandestina che era simile a quella di Gladio, che aveva
avuto il compito di seguire alcuni personaggi politici siciliani (tra cui
Mattarella, ndr). ( …) La posizione di Falcone e mia era quella di acquisire
tutti gli atti di Gladio (…). Le resistenze erano talmente avvertite da Falcone
che disse: ‘A questo punto io vi rimetto la delega, occupatevene voi’. Alla fine
si decide che Falcone sarebbe andato nella sede dei servizi segreti a guardare
gli atti e a verificare se per caso c’era qualcosa che ci poteva interessare. Si
decise di affiancarlo con il collega Pignatone (l’attuale procuratore di Roma,
ndr) fatto che lui visse come una specie di mancanza di fiducia e ricordo che io
rimasi insoddisfatto perché dissi: ‘Come si fa nell’arco di pochi giorni a
visionare tutti questi atti, a memorizzarli e a prendere in considerazione tutti
i fatti che ci possono essere utili in questo processo. Può darsi ché un nome
che in quel momento non dice assolutamente niente, tra 15 giorni può essere
rilevante (…). C’è un fatto che mi ha molto inquietato e cioè che Paolo
Borsellino conducesse delle indagini su fatti di grande rilevanza all’insaputa
del Procuratore (Giammanco, ndr). Mi chiedo, ma cosa sta succedendo in questa
Procura? Mi inquieto perché Paolo Borsellino è una persona che gode della mia
assoluta stima e fiducia. Perché se fosse stato qualsiasi altro magistrato avrei
potuto pensare a qualche cosa di deteriore. Paolo Borsellino si comporta così.
Mi vincolò al segreto. E su queste indagini, naturalmente, non posso dir niente
per motivi di ufficio. Diciamo che questa situazione, credo di non sbagliare,
almeno, io l’avevo conosciuta un mese prima (della strage di via D’Amelio, ndr).
Ecco, il fatto che lui l’abbia confidato a me è stato un gesto di grande
fiducia. Però di grande responsabilità (…). Questa circostanza è nota soltanto a
me, al sostituto Ingroia, e forse a uno o due altri sostituti, le persone che
godevano dell’assoluta fiducia di Paolo Borsellino. Paolo riferiva tutto e
sempre (a Giammanco, ndr) ecco perché io vengo colpito (…) proprio perché la
normalità era quella, se così non fosse stato non sarei rimasto colpito. Ma quei
fatti, fatti che non vi posso riferire, ma che sono di grandissima rilevanza e
che riguardano determinati livelli, su quei fatti Paolo Borsellino raccomandò la
segretezza.
Antonio Ingroia (Avvocato. Ex pm di Palermo, ex
coordinatore dell’inchiesta sulla trattativa – audizione del 31 luglio 1992).
Borsellino una volta, eravamo a casa sua a Marsala una sera, quindi prima ancora
che arrivasse a Palermo, lo ricordo con esattezza anche se non mi diede
spiegazioni precise in merito, mi disse testualmente: ‘Giammanco è un uomo
di Lima’ (Salvo Lima, ex ‘proconsole’ di Giulio Andreotti in Sicilia, ndr),
affermazione per la quale io evidentemente rimasi turbato. Dopo la morte di
Giovanni Falcone, oltre a occuparsi delle sue indagini, oltre ad avere interesse
per l’indagine Mutolo (il pentito Gaspare Mutolo, ex pupillo di Riina, ndr)
oltre ad avere interesse per l’indagine Falcone, faceva numerose indagini per
conto suo. Chiamiamole approfondimenti sulle questioni indicate nei diari di
Falcone. Chiese un colloquio con Scarpinato per quanto riguarda la questione
Gladio, la questione del rapporto dei carabinieri sugli appalti. Il discorso è
che non si fidava del dott. Giammanco. (Non approfondii, ndr) Paolo era per me
quasi Vangelo.
Vittorio Teresi (Pm di Palermo, coordinatore
dell’inchiesta sulla trattativa – audizione del 28 luglio 1992). In un’indagine
che conduco io e che conducevo assieme a Paolo Borsellino a un certo punto Paolo
mi comunicò una notizia molto riservata che aveva appreso da un organo di
polizia e riguardava un politico, riguardava un grosso mafioso eccetera, era una
notizia ovviamente tutta da controllare, da verificare ma comunque era una delle
tante ipotesi di lavoro. Paolo disse espressamente di non parlarne in giro
perché temeva che finisse all’orecchio di Giammanco. Qual è l’indagine non lo
posso dire, questa non era affatto notizia confermata, era semplicemente una pur
fondata confidenza di un organismo di polizia, però era molto scottante, era
molto delicata.
Alfredo Morvillo (Ex pm di Palermo, oggi
procuratore di Trapani. Fratello di Francesca Morvillo Falcone – audizione del
28 luglio 1992). Quello che è successo a Borsellino, quello che è successo a
Falcone, credetemi, non è una qualche cosa di imprevedibile e di inevitabile,
perché io vorrei sapere per quale motivo si dica che Falcone era l’uomo più
scortato del mondo, il che non è affatto vero e vi dico perché: a Falcone, negli
ultimi tempi, avevano diminuito le misure di protezione. Lo sapevano tutti a
Palermo che Falcone ormai non aveva più l’auto di staffetta e l’elicottero. Ma
non gliene frega niente a nessuno! I ragazzi della scorta, che sono venuti a
trovarmi, mi hanno detto che avevano chiesto anche la possibilità di avere a
disposizione, a Punta Raisi che è sul mare, di una pilotina per eventualmente
utilizzarla per ritornare via mare, una pilotina, una barca della polizia per
tornare via mare. La verità è questa, che persino nei confronti di Giovanni
Falcone si adopera la mentalità del rilassamento burocratico! Falcone, signori
miei, diciamolo, siamo chiari, in certe situazioni, contava molto poco. Falcone,
al di là delle parole che tutti noi possiamo essere bravissimi a dire (…)
Falcone non coordinava niente! (…). Dopo la strage del 23 maggio arriva un
anonimo con chiare minacce per alcuni colleghi, con le fotografie di Borsellino,
De Francisci, Teresa Principato… nonostante sia successo quello che è successo
il 23 maggio, in questa riunione mi dicono i colleghi (io non c’ero per i noti
fatti) ancora una volta sottovalutazione. Giammanco: “È una stupidaggine, che
fa, la stracciamo?”. La stracciamo? Arriva l’anonimo, dopo quello che è successo
a Palermo, per i colleghi del tuo ufficio che sono come, a volte, lui stesso ha
detto, “tuoi figli” e tu che fai? “Lo stracciamo!”. E allora lo mandiamo, per
competenza, a Caltanissetta. Al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica,
mi dicono i colleghi, che, fra l’altro, non hanno avuto nessuna protezione dopo
questo fatto (fino alla strage di via D’Amelio, ndr).
Ignazio De Francisci (Ex pm di Palermo,
procuratore generale di Bologna – audizione del 29 luglio 1992). Questa lettera
era un collage fotografico: c’era la foto di Paolo, c’era quella mia e quella
della collega Principato. Tra l’altro era una strana fotografia perché io non
ricordavo di averla vista mai, non è che io spunti molto su i giornali, quindi
la cosa mi colpì… Sono andata da Giammanco e io gli ho detto: ‘Senti
Procuratore, io non me la terrei né la cestinerei’. Ricordo che il Procuratore
mi disse: “Mah!”, Cioè era dubbioso sull’opportunità o meno di inviarla (agli
organi preposti, ndr). Dopo ne parlai con Borsellino e ricordo che lui era già
un po’ incupito anche se dal punto di vista personale mi disse una frase del
genere: ‘Noi non ci dobbiamo far spaventare per una lettera’. (…) Ora mi hanno
dato una specie di scorta composta dalla macchina blu con le insegne dei
carabinieri. L’Arma ha fatto levare in volo l’elicottero che ha seguito la mia
autovettura da casa sino all’aeroporto di Punta Raisi. La polizia prima l’aveva
dato a Giovanni Falcone per anni e poi gli era stato tolto. Quando sentivo
questo elicottero non potevo non ricordare l’amarezza di Giovanni Falcone quando
glielo tolsero. Voi lo conoscevate, non è che parlasse molto di queste cose; non
ne parlava in maniera enfatica, però, mi ricordo che una volta che io partii con
lui notai l’assenza dell’elicottero, glielo dissi e lui mi rispose: “Che ci vuoi
fare?”, insomma con una frase un po’ fatalista. (…). Io ho avuto la netta
sensazione che il Procuratore, nella gestione dell’ufficio, avesse una corsia
differenziale sulla quale passavano o potevano passare soltanto alcuni colleghi.
Quello che io sinceramente non ho mai capito è perché lui si fidasse soltanto di
due, tre persone e passasse con loro le grosse decisioni dell’ufficio: Guido Lo
Forte, Giuseppe Pignatone, in prima istanza Giustino Sciacchitano. Ecco, il
fatto che specialmente Lo Forte e Pignatone siano tecnicamente bravissimi e
abbiano una innata dote di prudenza, anche abilità nel gestire tutte le
seccature che un grosso ufficio comporta, questo secondo me, in assoluta
serenità di spirito, non consentiva (a Giammanco, ndr) di accentrare attorno a
queste persone tutte le decisioni, se vogliamo anche strategiche o comunque le
pre-decisioni dell’ufficio, per poi venire alle riunioni con una sensazione che
almeno io avevo di minestra già fatta (…) . L’arrivo di Borsellino aveva ridato
impulso alle indagini (…) Ebbi la sensazione che nei confronti di Paolo si
riproponessero le stesse difficoltà di cui mi aveva parlato Giovanni.
ALTRO CHE STATO-MAFIA. MAFIA-APPALTI.
QUELL'INCHIESTA NON S'HA DA FARE.
Mafia & appalti, una verità scomoda.
Cosa c'è dietro e cosa c'è stato dopo l'inchiesta condotta dai Ros, scrive
Luciano Tirinnanzi il 12 luglio 2013 su "Panorama". Quando, negli anni a venire,
si guarderà con lo sguardo freddo e distante della storia agli eventi che
contraddistinsero i fatti avvenuti tra la seconda metà del 1992 e l’estate del
1993, si accetterà probabilmente la vera ragione per cui sono morti Giovanni
Falcone prima e Paolo Borsellino poi: l’indagine su Mafia e Appalti condotta
dai carabinieri del ROS. Una delle vicende più cupe e al contempo rivelatrici
dell’animus italico - stretto tra segreti di Stato e condizionamenti della
mafia, tra soldi e potere - si fa improvvisamente chiara, quando leggiamo
quell’indagine da cui tutto ha avuto origine e che ha portato i suoi
destinatari, i giudici Falcone e Borsellino, alla morte e i suoi autori, il
colonnello Mario Mori e il capitano Giuseppe De Donno, a un ventennio di
processi a loro carico. In quest’Italia, infatti, spesso si vogliono ammantare
di misteriosi enigmi e ridde di complotti, anche le verità più palesi. Una di
queste verità è scritta nella sentenza della Corte d’Assise di Catania del 22
aprile 2006, dove si afferma, a proposito del movente della strage di via
D’Amelio: “la possibilità che il dottor Borsellino venisse ad assumere la
Direzione Nazionale Antimafia e, soprattutto, la pericolosità delle indagini che
egli avrebbe potuto svolgere in materia di mafia e appalti”. Ma andiamo con
ordine. Ben prima che la Procura di Milano avviasse l’inchiesta che passerà alla
storia come “Mani Pulite” nei primi mesi del 1992, già il 20 febbraio 1991 il
ROS depositò l’informativa Mafia e Appalti, relativa alla prima parte delle
indagini sulle connessioni tra politici, imprenditori e mafiosi, dove si
rivelava l’esistenza di un comitato d’affari illegale e si facevano i nomi di
società e persone coinvolte.
- Falcone e l’importanza di depositare “Mafia e
Appalti”. Il deposito di Mafia e Appalti fu voluto espressamente da Giovanni
Falcone, il quale all’epoca stava passando dalla Procura di Palermo alla
Direzione degli Affari Penali del Dipartimento di Giustizia capitolino: Falcone
si raccomandò con i carabinieri del ROS di depositare subito quelle carte,
poiché ritenute cruciali per spiegare le connessioni tra mafia e politica. Lo
ricordò lo stesso giudice al convegno palermitano del 14 e 15 marzo 1992, a
Castello Utveggio: “la mafia è entrata in borsa” disse due mesi prima di saltare
in aria. Quelle carte “scottavano” al punto che divennero da subito motivo
d’imbarazzo e indecisione da parte della Procura di Palermo. Che inizialmente,
sulla base di Mafia e Appalti emise solo 5 provvedimenti di custodia cautelare
per associazione a delinquere di stampo mafioso (7 luglio 1991), diversamente
dai 44 che suggeriva l’informativa. Giovanni Falcone, nei suoi diari, dirà in
proposito: “Sono scelte riduttive per evitare il coinvolgimento di personaggi
politici”. Non solo. Agli avvocati difensori dei 5 arrestati fu indebitamente e
insolitamente consegnata l’intera informativa del ROS (890 pagine più 67 di
appendice, dunque comprensiva di tutte le 44 persone oggetto d’indagine),
anziché stralci dei soli passaggi relativi alle loro posizioni. Con ciò fu
svelata l’architettura investigativa complessiva, emersero i nomi di tutti i
soggetti nel mirino del ROS e si vanificò sostanzialmente l’intera indagine.
Dopodiché inizia a scorrere il sangue. Il primo a morire fu il deputato
andreottiano Salvo Lima, il 12 marzo 1992, l’uomo “delle cosche” che non poteva
più garantire per esse. Poi, il 4 aprile successivo, toccò al maresciallo
Giuliano Guazzelli, ucciso perché - su esplicita richiesta - rifiutò di
stemperare le accuse contro Angelo Siino, uno dei 5 arrestati di Mafia e Appalti
e ritenuto dal ROS “l’anello di congiunzione tra mafia e imprenditoria”. Quindi,
come noto, il 23 maggio morì lo stesso Falcone e il 19 luglio 1992 la stessa
sorte toccò anche a Paolo Borsellino. - Borsellino e le confidenze a Ingroia.
Borsellino, il 25 giugno del ‘92, volle incontrare segretamente negli uffici del
ROS gli autori dell’informativa, il colonnello Mori e il capitano De Donno,
riferendo loro che l’inchiesta Mafia e Appalti era “il salto di qualità”
investigativo che avrebbe permesso di individuare sia i responsabili della
corruttela siciliana sia gli autori della morte di Falcone. Borsellino indicò
proprio in Mafia e Appalti la causa della morte dell’amico giudice e chiese il
massimo riserbo sull’incontro, in particolare nei confronti dei colleghi della
Procura di Palermo, per timore di fughe di notizie. Il giudice Antonio Ingroia,
intimo di Borsellino, confermò alla Corte d’Assise di Caltanissetta che
Borsellino gli aveva confidato di essere convinto che, attraverso gli appunti di
Falcone relativi all’inchiesta Mafia e Appalti, si sarebbero potuti individuare
i moventi della strage di Capaci. Fatto confermato anche da Giovanni Brusca,
autore materiale della strage, il quale nel 1999 dichiarò alla DDA di Palermo
che i vertici di Cosa Nostra erano “preoccupati delle indagini sugli appalti”.
- L’archiviazione di “Mafia e Appalti”. Il fatto
più inquietante avvenne però il 20 luglio, il giorno dopo la morte di Borsellino
quando, non ancora allestita la camera ardente per le vittime di via d’Amelio,
la Procura di Palermo depositò inspiegabilmente la richiesta di archiviazione
dell’inchiesta Mafia e Appalti, nella parte in cui ci si riferiva a imprenditori
e politici. Il decreto di archiviazione arrivò il 14 agosto. Anche in seguito a
quell’atto, la frattura all’interno della Procura di Palermo e tra questa e il
ROS, sembra non essersi mai più sanata. Così come non si rimarginano le ferite
aperte dalle stragi mafiose del 1992, che hanno originato sospetti e liti di cui
ancor oggi vediamo gli effetti, non solo nelle aule di tribunale.
- Vito Ciancimino e la trattativa. Vale la pena
ricordare anche la cosiddetta “Trattativa Stato-Mafia” che gira intorno alla
persona dell’ex sindaco di Palermo nonché “uomo delle cosche”, Vito Ciancimino.
Tutto ebbe inizio il 5 agosto 1992, dopo le stragi di mafia. Ciancimino fu
avvicinato dal ROS perché collaborasse alle indagini Mafia e Appalti, visto che
rivestiva il ruolo di cerniera tra il mondo politico-imprenditoriale e quello
mafioso. Ed, effettivamente, il sindaco consegnò qualcosa ai militari. Ma non il
famigerato “papello”, bensì il libro “Le Mafie” redatto dallo stesso Vito, dal
quale si evinceva la sostanziale convergenza tra la tesi dell’inchiesta Mafia e
Appalti e la realtà di Palermo. Su sua espressa richiesta, Ciancimino chiese
ripetutamente - ma senza esito - di essere ascoltato dalla Commissione
Parlamentare Antimafia, dove all’epoca sedeva Luciano Violante. Violante fu
informato dei contatti con Ciancimino dal colonnello Mori il 20 ottobre 1992,
nel giorno della sua audizione all’Antimafia. Una settimana dopo, Mori consegnò
al presidente Violante una copia del libro “Le Mafie” che, per la verità, a
detta di entrambi non conteneva fatti poi così rilevanti. Un mese prima, Mori
discusse dell’importanza dell’attività investigativa relativa agli appalti anche
con Piero Grasso, all’epoca consulente della Commissione Parlamentare Antimafia.
E poi con Giancarlo Caselli, poco prima che divenisse Procuratore della
Repubblica, fatto che avvenne il 15 gennaio, stesso giorno in cui fu arrestato
Salvatore Riina, il capo di Cosa Nostra.
- Conclusioni. I passaggi di cui sopra sono tutti
certificati e agli atti dei tribunali. Ma, in ultima istanza, essi saranno
giudicati dal solo tribunale che conta davvero, quello della storia. Detto
questo, è quantomeno bizzarro credere che vi sia stata una “trattativa segreta”
ad opera del ROS finalizzata a favorire la mafia, quando erano stati proprio i
carabinieri a svelare la connessione mafia-politica attraverso l’indagine Mafia
e Appalti e quando di tali circostanze erano a conoscenza quantomeno i più alti
rappresentanti delle istituzioni. Davvero, nel 2013, pensiamo ancora che uomini
dello Stato, carabinieri, abbiano ordito contro il nostro Paese per favorire
Cosa Nostra? E a quale scopo, esattamente? Favorire Salvatore Riina? Ma Riina è
o non è in carcere da vent’anni grazie alle indagini del ROS? E, da ultimo, è o
non è vero che oggi la mafia fa affari miliardari con gli appalti, come
scoprirono proprio i carabinieri e come pensava anche Giovanni Falcone?
La Trattativa secondo Di Pietro. Un
lapsus dell'ex magistrato e il dossier “mafia-appalti” archiviato subito dopo la
morte di Borsellino, scrive Massimo Bordin l'1 Maggio
2018 su “Il Foglio”. Dopo Violante, Antonio Di Pietro dice la sua sul processo
trattativa, con pieno diritto visto che, con i suoi interventi in Commissione
antimafia, a suo tempo ne fu uno degli artefici. Naturalmente Di Pietro proclama
in prima battuta la sua solidale consonanza coi pm palermitani, poi parla di un
suo colloquio con Paolo Borsellino poco prima della strage di via D’Amelio in
cui Borsellino ipotizza un raccordo fra le indagini palermitane e quelle
milanesi. Emerge una verità possibile, diversa dalla tesi accusatoria.
Borsellino, poco prima di essere ucciso, non si occupava della famosa trattativa
ma del più corposo dossier “mafia-appalti” preparato dal Ros di Mori. Singolare
un apparente lapsus di Di Pietro, quando, a proposito delle stragi e di quelle
indagini sugli appalti ha detto: “Hanno fermato le indagini e armato pistole”.
Che c’entrano le pistole con Borsellino? Ben altro fu usato in via D’Amelio, ma
l’ex pm sa bene di che parla. Parla di Raul Gardini, che un anno dopo via
D’Amelio fu ucciso da un colpo di pistola che molti dubitano sia partito dalla
sua mano. Parla dell’indagine mafia-appalti che svelò intrecci fra la Ferruzzi e
la “calcestruzzi Palermo spa”. “Hanno fermato le indagini” dice l’ex pm e
aggiunge che “chi lo ha fatto va individuato”. E’ facile, non ci vuole Sherlock
Holmes. Due giorni dopo la morte di Borsellino, la procura di Palermo chiese di
archiviare l’indagine. Nasce da lì la polemica fra procura e Ros, sfociata nei
processi a Mori e poi in quello sulla trattativa, nel quale la difesa di Mori
aveva chiesto che Di Pietro venisse citato come teste. La corte ha rifiutato di
sentirlo.
La svolta di Gratteri: «Basta giornalisti
innamorati dei pm Abbiamo bisogno di fatti e verità».
Il magistrato calabrese scopre la stampa indipendente, scrive Davide Varì il 3
Maggio 2018 su "Il Dubbio". «I giornalisti non devono fare i piacioni, né
tantomeno innamorarsi dei magistrati: abbiamo bisogno di giornalisti che
raccontino con coraggio la verità, i fatti. In quanto a noi magistrati, vogliamo
essere valutati e giudicati per quel che facciamo». Parole e musica di Nicola
Gratteri. Quel Nicola Gratteri: il magistrato simbolo dell’antimafia; lo stesso
Gratteri che avrebbe dovuto prendere la poltrona di guardasigilli e che, di
fronte al gran rifiuto dell’allora presidente della Repubblica Napolitano, si
scagliò contro i poteri forti del Palazzo, evidentemente impauriti dalla forza
“eversiva” e “antisistema” del magistrato calabrese: «Io sono troppo
indipendente e il potere vero vuole che ci sia sempre qualcuno sopra di te, che
garantisca per te». Lo stesso Gratteri che non disdegna chiacchierate
televisive, un tantino celebrative, con Fabio Fazio e Riccardo Iacona; né premi
in giro per il belpaese. Premi meritatissimi, s’intende. Insomma, quel Gratteri
lì oggi ci fa sapere che il giornalismo che copia e incolla le ordinanze dei
magistrati e cha passa ore nelle di loro sale d’attesa non va (più) bene. E del
resto che i giornalisti dovessero fare da “cane da guardia del potere”, di tutti
i poteri, magistratura inclusa, era un dubbio che in questi anni aveva
attraversato qualche temerario. Ma c’è di più, Il procuratore Gratteri ha
criticato anche un altro cavallo di battaglia dell’antimafia militante: il
sistema dello scioglimento dei comuni. «I Comuni – ha infatti dichiarato
Gratteri – vengono sciolti per mafia nel 99% dei casi quando la procura, a
conclusione delle indagini, invia gli atti alla prefettura e quindi, dopo
l’istruttoria, si procede e viene nominato un ufficiale prefettizio. Il
problema, in alcuni casi, è che il commissario si reca in Comune poche volte a
settimana. Quindi sostanzialmente l’amministrazione viene congelata per due
anni. La popolazione mediamente pensa che era meglio quando c’era il sindaco,
che riuscita almeno a dare risposte» E dunque: «Occorre modificare la norma, il
Commissario prefettizio deve stare al Comune sciolto per mafia sette giorni su
sette», ha aggiunto Gratteri.
Se tutto è mafia, niente è mafia,
scrive Piero Sansonetti il 5 luglio 2017 su "Il Dubbio". L’idea che invece si
possa estendere a macchia d’olio le leggi di emergenza applicandole persino a
banalissimi episodi di corruzione o di truffa trasforma un nobile ideale nello
strumento per un riassetto dei poteri della magistratura. Le leggi d’emergenza
in genere violano lo “stato di diritto” in nome dello “stato d’eccezione”. Ed è
lo stato d’eccezione la fonte della loro legittimità. Quando termina lo stato di
eccezione – che per definizione è temporaneo – in una società democratica, torna
lo Stato di diritto e le leggi d’emergenza si estinguono. La mafia in Italia ha
avuto un potere enorme, e una formidabile potenza di fuoco, dagli anni Quaranta
fino alla fine del secolo. È stata sottovalutata per quasi quarant’anni. I
partiti di governo la ignoravano, e anche i grandi giornali si occupavano assai
raramente di denunciarla, e in molte occasioni ne negavano persino l’esistenza.
Parlavano di malavita, di delitti, non riconoscevano la presenza di una
organizzazione forte, articolata, profondamente collegata con tutti i settori
della società e infiltrata abbondantemente in pezzi potenti dello Stato. È
all’inizio degli anni Ottanta che in Italia matura una nuova coscienza che mette
alle strette prima Cosa Nostra, siciliana, poi le altre organizzazioni mafiose
del Sud. Ci furono due novità importanti: la prima fu un impegno maggiore e
molto professionale della magistratura, che isolò le sue componenti
“collaborazioniste” e mise in campo alcuni personaggi straordinari, come Cesare
Terranova, Gaetano Costa, Rocco Chinnici, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino,
uccisi uno ad uno nell’ordine – tra il ‘ 79 e il ‘ 92. La seconda novità fu
l’emergere di una componente antimafiosa nello schieramento dei partiti di
governo e in particolare nella Dc. Che spinse settori ampi dello schieramento
politico, che negli anni precedenti avevano rappresentato una zona grigiastra
tra Stato e mafia, a scendere in campo contro la criminalità organizzata. Questo
spezzò la linearità che fino a quel momento aveva caratterizzato i rapporti tra
mafia e politica. Fu proprio a quel punto che scattò l’emergenza. Perché i due
contendenti alzarono il tiro. Lo Stato ottenne dei clamorosi successi,
soprattutto grazie all’azione di Giovanni Falcone; la mafia, per reazione,
iniziò a colpire durissimo, con una strategia di guerra, fino alla stagione
delle stragi, nel 1992- 1993. Ma anche nel decennio precedente la sua capacità
militare, non solo in Sicilia, era mostruosa. Negli anni Ottanta a Reggio
Calabria c’erano in media 150 omicidi all’anno (oggi i delitti si contano sulle
dita della mano). Per combattere la mafia, in questa situazione di emergenza,
tra gli anni Ottanta e i Novanta, vengono varate varie misure eccezionali che si
aggiungono a quelle che erano state predisposte per la lotta al terrorismo. Tra
le altre, il famoso articolo 41 bis del regolamento penitenziario (il carcere
duro), che era stato previsto come un provvedimento specialissimo che avrebbe
dovuto durare pochi anni, e invece è ancora in vigore un quarto di secolo dopo.
Oggi la mafia che conosciamo è molto diversa da quella degli anni Ottanta e
Novanta. I suoi grandi capi, tranne Matteo Messina Denaro, sono in prigione, o
morti, da molti anni. Il numero degli omicidi è crollato. Alcuni investigatori
notano che c’è stato un cambio di strategia: la mafia non uccide più ma si
infiltra nel mondo degli affari, dei traffici, della corruzione, della droga. E
questo – dicono – è ancora più grave e pericoloso. Ecco: io non ci credo. Resto
dell’idea che una organizzazione che ruba è meno pericolosa di una
organizzazione che uccide. Il grado di pericolosità della mafia è indubbiamente
diminuito in questi anni, in modo esponenziale, e questa è la ragione per la
quale le leggi speciali non reggono più. Molti se ne rendono conto, anche tra i
magistrati. I quali infatti chiedono che le leggi antimafia siano allargate ad
altri tipi di illegalità. Per esempio alla corruzione politica, che – almeno sul
piano dei mass media, e dunque della formazione dell’opinione pubblica – sta
diventando la forma di criminalità più temuta e più biasimata. Questo mi
preoccupa. Il fatto che, accertata la fine di un’emergenza, non si dichiari la
fine dell’emergenza ma si discuta su come estendere questa emergenza ad altri
settori della vita pubblica. La misura d’emergenza non è vista più come una
misura dolorosa, eccezionale, ma inevitabile dato il punto di rottura al quale è
arrivato un certo fenomeno (mafia, terrorismo, o altro). Ma è vista come un
contenitore necessario e consolidato, voluto dall’opinione pubblica, dentro il
quale, di volta in volta, si decide cosa collocare. La giustizia a due binari
che evidentemente è la negazione sul piano dei principi di ogni forma possibile
di giustizia – cioè quella costruita per combattere l’emergenza mafiosa, diventa
il modello di un nuovo Stato di diritto (in violazione della Costituzione) dove
lo Stato prevale sul diritto e lo soffoca. La specialità della legislazione
antimafia si basava sul principio – scoperto e affermato proprio da quei
magistrati che elencavamo all’inizio – secondo il quale la mafia non è una delle
tante possibili forme di criminalità, né è un metodo, una cultura, una
abitudine, ma è una organizzazione ben precisa – “denominata Cosa Nostra”, amava
dire Falcone riferendosi alla mafia siciliana – con sue regole, suoi obiettivi,
suoi strumenti criminali specialissimi e specifici. E va combattuta e sconfitta
in quanto organizzazione criminale particolare e unica. E dunque con strumenti
particolari e unici. Questa è la motivazione – discutibile finché vi pare, ma è
questa – di una legislazione speciale e di una giustizia con doppio binario.
L’idea che invece si possa estendere a macchia d’olio sia il reato di mafia sia
la legislazione antimafia, applicandola persino a banalissimi episodi di
corruzione o di truffa, cancella quell’idea, persino la offende, e trasforma un
nobile ideale nello strumento per un riassetto dei poteri della magistratura. E
infatti a queste nuove norme antimafia si oppongono anche pezzi molto ampi, e
sani, della magistratura. Forse occorrerebbe un passo di più: avviare un moderno
processo di superamento delle norme antimafia, prendendo atto del fatto che lo
Stato d’eccezione è finito. E riconoscere la fine dello Stato di eccezione non
significa rinunciare alla lotta alla mafia. Mentre invece procrastinare lo stato
d’eccezione – si sa – è l’anticamera di tutte le azione di scassinamento della
democrazia e del diritto.
Qualcuno dovrà rispondere,
scrive Piero Sansonetti il 3 Maggio 2018 su "Il Dubbio". A scartabellare le
carte, e le vecchie sentenze, appare sempre più surreale lo scenario disegnato
dal processo di Palermo. Certo, bisognerà aspettare le motivazioni. Però
qualcosa, intanto, la si può dire. E la prima cosa che si può dire è che
l’ipotesi dell’accusa – e di alcuni giornali – secondo la quale Paolo Borsellino
fu ucciso perché voleva opporsi alla trattativa stato- mafia, appare sempre più
fantasiosa. Mentre, purtroppo, non appare per niente fantasiosa l’ipotesi che
Paolo Borsellino fu ucciso perché voleva portare avanti le indagini avviate dai
Ros di Mori, De Donno e Subranni su mafia e appalti. E se questa ipotesi viene
confermata, cambia tutto nella ricostruzione di quello che successe in quegli
anni e del ruolo avuto dai vari apparati dello Stato. Perché il processo di
Palermo si fonda sull’ipotesi che si fronteggiarono una magistratura “limpida”
ed “efficiente” e pezzi dei carabinieri e forse dei servizi segreti che invece
erano coinvolti in oscure trattative con la mafia. L’ipotesi invece che
emergerebbe dai fatti come li ricostruisce nell’articolo che pubblichiamo in
prima pagina (e a pagina 3) Damiano Aliprandi, è opposta. Dice che i Ros erano
arrivati a un passo dallo sgominare un gigantesco giro di potere che coinvolgeva
mafia, imprenditoria, e politica, e che furono fermati per la negligenza della
magistratura. I Ros, lavorando con Falcone, avevano raccolto indizi e prove
molto pesanti, e se l’inchiesta fosse andata avanti avrebbe fatto saltare un bel
pezzo del sistema di potere mafioso. Paolo Borsellino era ben deciso ad
impegnarsi lui in questa inchiesta e stava solo aspettando la delega che doveva
venirgli dalla Procura. La Procura di Palermo, e in particolare i sostituti Lo
Forte e Scarpinato, invece, sottovalutarono clamorosamente la forza di questa
inchiesta dei Ros, proseguita e sostenuta da Flacone, e la affossarono. Oggi
Roberto Scarpinato è procuratore generale di Palermo. E’ un magistrato colto,
molto preparato, dalle idee forti. Sicuramente è una persona onesta. Ma è giusto
chiedere a lui e al suo collega: perché quella inchiesta fu affossata proprio
pochissimi giorni prima dell’uccisione di Borsellino, visto che, oltretutto, si
sapeva che lo stesso Borsellino era interessato a quella inchiesta e avrebbe
voluto occuparsene personalmente? Naturalmente nessuno sa il perché. Si può solo
supporlo: per scarsa esperienza. (Così come probabilmente per scarsa esperienza
Di Matteo e gli altri Pm che si occuparono dell’inchiesta sull’uccisione di
Borsellino presero per buone le dichiarazioni false del pentito Scarantino, che
mandò su un binario morto tutte le indagini). La Procura di Palermo in quella
tragica estate del ‘ 92 sottovalutò il lavoro dei Ros. E probabilmente,
soprattutto dopo la morte di Borsellino, entrò in conflitto coi Ros, e forse
anche con pezzi dei servizi segreti (penso all’affare- Contrada) proprio per via
del “complesso di colpa”, diciamo così, dovuto all’errore commesso sul dossier
mafia- appalti. Ora però bisogna fare un po’ di luce su tutto questo. Anche
perché al processo di Palermo non si è tenuto conto in nessun modo di questo
scenario. E così il processo ha finito per condannare da una parte proprio i
carabinieri che si erano impegnati di più nella battaglia contro Cosa Nostra,
dall’altro i “berlusconiani” (mi riferisco a Dell’Utri) forse solo perchè, si
sa, se dai addosso ai “berluscones” ti conquisti qualche merito e qualche
popolarità, a prescindere. E trovi l’appoggio della stampa. Le questioni da
affrontare sono tre. La prima è: sono stati condannati, ingiustamente, proprio
quelli che avevano dato di più nella lotta alla mafia? La seconda è: il dossier
mafia appalti è stato la vera ragione dell’uccisione di Borsellino? La terza è:
insabbiando quel dossier si è impedito di dare alla mafia (dopo il maxiprocesso)
il colpo mortale? Sono domande impegnative. Qualcuno dovrebbe rispondere.
Mafia anni 90. I “buoni” erano “cattivi”
e viceversa? Scrive Piero Sansonetti il 5 Maggio 2018
su "Il Dubbio". La ricostruzione fornita dal Dubbio rovescia i teoremi: i Ros
avevano attaccato frontalmente la mafia, la magistratura, persi Falcone e
Borsellino, mollò la presa. Da qualche giorno stiamo pubblicando sul “Dubbio”
una ricostruzione dei fatti tragici che all’inizio degli anni 90 insanguinarono
la Sicilia. Continueremo la settimana prossima. Damiano Aliprandi sta
realizzando questa ricostruzione, lavorando su documenti, sentenze,
requisitorie, testimonianze, carte, atti giudiziari. Senza violare nessun
segreto, senza fidarsi di nessun “uccellino”, senza fonti riservate e coperte,
senza basarsi su supposizioni prive di prove. Generalmente l’informazione
giudiziaria funziona in un altro modo: non perde tempo a seguire i processi e a
verificare le carte, ma “suppone”; e di solito più che supporre prende per buone
le supposizioni delle Procure. Qual è la novità che emerge dalla nostra
ricostruzione? E’ abbastanza sconvolgente. Ci fa capire che probabilmente la
verità è più o meno l’opposto di quello che sin qui si è fatto credere. Vediamo.
Recentemente il processo di Palermo (quello sulla presunta trattativa stato-
mafia) ha stabilito che un gruppo di carabinieri dei Ros tradì lo Stato e
lavorò, insieme alla mafia, per minacciarlo e ricattarlo. Con l’aiuto di
Dell’Utri. Se le cose davvero stessero così, sarebbe una cosa gravissima. Un
vero e proprio tradimento da parte di un settore molto prestigioso dei
carabinieri. Finora, però, non è stata mostrata una sola prova che avvalori
questa ipotesi, tranne la testimonianza di un mafioso pentito (Brusca) che in
cambio della sua testimonianza ha ottenuto le attenuanti, e quindi la
prescrizione, e quindi l’assoluzione. C’è da fidarsi di Brusca, senza un
riscontro, senza una carta, un fatto, un documento? Aspettiamo le motivazioni
della sentenza e vediamo se esce fuori qualcosa. Per ora, zero. La nostra
ricostruzione però giunge a una conclusione del tutto opposta: i carabinieri
“traditori” non erano affatto traditori, ma erano investigatori molto competenti
che avevano scoperchiato (tra la fine degli anni 80 e l’inizio dei 90) un
gigantesco giro di reati, compiuti per assegnare in modo illegittimo a mafiosi e
imprenditori una quantità mostruosa di appalti. La descrizione di questi
delitti, e le prove, erano contenute in un dossier chiamato “mafia appalti”, che
fu consegnato dai Ros alla magistratura. E precisamente al sostituto procuratore
Falcone che iniziò le indagini e giudicò clamorose le scoperte dei carabinieri.
Poi Falcone fu chiamato a Roma e il dossier passò ad altri sostituti
procuratori. Lo stesso Falcone chiese a Borsellino di occuparsi lui
personalmente di quel dossier, perché solo di lui si fidava e perché il dossier
conteneva verità scioccanti. Ma prima che il Procuratore Giammanco si decidesse
a consegnare il dossier a Borsellino, successero tre cose: fu ucciso Falcone, fu
ucciso Borsellino e, nel frattempo, i sostituti procuratori che avevano in mano
il dossier chiesero ( e rapidissimamente ottennero) che fosse archiviato. In una
parola sola: insabbiarono. Questi sostituti procuratori erano Roberto
Scarpinato, attuale Procuratore generale di Palermo e Guido Lo Forte. E visto
che nel frattempo Borsellino e Falcone erano morti, nessuno più mise le mani su
quei documenti (che noi abbiamo potuto leggere) i quali contenevano nomi,
circostanze, collegamenti, con una tale precisione (e di una tale gravità) che
probabilmente avrebbero creato un vero e proprio cataclisma. Sulla mafia, ma
anche sulla politica. Non solo su quella siciliana, perché le imprese coinvolte
operavano su tutto il territorio nazionale e anche gli appalti non erano solo
siciliani ma erano sparsi in ogni regione italiana. Ora le questioni aperte sono
tre.
La prima riguarda l’uccisione di Borsellino. In
questi anni spesso si è detto che la sua morte è avvenuta perché si opponeva
alla trattativa stato mafia. Poi si è detto che stava indagando su Berlusconi.
Ora si capisce con una certa sicurezza che non era così. Borsellino non stava
indagando su nessuna trattativa né su Berlusconi, ma voleva occuparsi di questo
dossier, e negli scandali contenuti in questo dossier non c’era trattativa né
c’era ombra di Berlusconi o di Dell’Utri. Dunque tutta la ricostruzione,
soprattutto giornalistica (ma presente massicciamente anche nelle requisitorie
dei Pm al processo di Palermo) è infondata.
La seconda questione riguarda i Ros. È chiaro che
i Ros del generale Mori non solo non trattarono con la mafia, ma avevano una
strategia del tutto opposta: quella di andare a scontrarsi frontalmente sia con
la mafia sia con quei settori della politica e dell’imprenditoria che con la
mafia facevano affari.
La terza questione è la più inquietante. Cosa
successe in alcuni settori della magistratura di Palermo? Perché insabbiarono
una inchiesta che era una vera bomba atomica e che conteneva i presupposti per
annientare Cosa Nostra? C’è un collegamento tra questa decisione di insabbiare e
di disinnescare quella inchiesta e il clamoroso depistaggio, seguito dalla
magistratura, innescato dal falso pentito Scarantino (primo processo
Borsellino)? E ancora: il processo Stato mafia è in qualche modo figlio di
questi clamorosi abbagli? Come vedete, la terza questione è formata da domande.
Chi può rispondere a queste domande? La magistratura è in grado di fornirci
almeno qualche lume?
Perché Scarpinato affossò l’inchiesta
mafia- appalti? Era clamorosa e forse Borsellino fu
ucciso perché quel fascicolo era finito sulla scrivania, scrive Damiano
Aliprandi il 3 Maggio 2018 su "Il Dubbio". Non esiste nessuna sentenza che
collega la morte dei giudici antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con
la presunta trattativa Stato- mafia, mentre in alcune sentenze emerge un movente
ben chiaro e che fu anche l’inizio della guerra dei cent’anni tra alcuni
magistrati e i carabinieri dei Ros guidata da Mario Mori: l’indagine su mafia
appalti condotta da quest’ultimi. Una di queste verità è scritta nella sentenza
della Corte d’Assise di Catania del 22 aprile 2006, in cui si afferma, a
proposito del movente della strage di via D’Amelio, «la possibilità che il
dottor Borsellino venisse ad assumere la Direzione Nazionale Antimafia e,
soprattutto, la pericolosità delle indagini che egli avrebbe potuto svolgere in
materia di mafia e appalti». A questa si aggiunge un’altra sentenza, quella
della Corte d’Assise di Caltanissetta relativa al processo Borsellino- ter, in
cui viene riportata la testimonianza di Angelo Siino, il cosiddetto “ministro
dei lavori pubblici” di Totò Riina, il quale disse che la mafia era preoccupata
circa l’interesse di Falcone e Borsellino per l’indagine mafia- appalti. Un
particolare non da poco è stato il suo riferimento a Falcone quando disse che la
«mafia era stata quotata in borsa». Sì, perché il magistrato lo disse
all’indomani della quotazione di una delle società appaltatrici che erano sotto
la lente di ingrandimento dei Ros. La sentenza in questione aveva tratto anche
una riflessione. « Appare, pertanto, esatto ritenere che se le indagini condotte
dal Ros in materia di mafia e appalti non avevano ancora avuto all’epoca uno
sviluppo tale da rappresentare un pericolo immediato per gli interessi
strategici di Cosa nostra, tuttavia si legge nel dispositivo della sentenza –
l’interesse mostrato anche pubblicamente da Borsellino per quel settore di
indagini unitamente all’incarico che egli ricopriva nell’Ufficio titolare
dell’inchiesta ed ancor più la prospettiva dell’incarico alla Procura nazionale
per la quale veniva autorevolmente proposta la sua candidatura anche
pubblicamente, costituivano un complesso di circostanze che facevano apparire a
Cosa nostra quanto mai opportuna la realizzazione dell’attentato a quel
magistrato subito dopo quello a Falcone ». Come se non bastasse, si aggiunge la
testimonianza di Antonio Di Pietro, all’epoca dei fatti componente del pool Mani
Pulite. L’ex magistrato ha dichiarato più volte, sia durante il processo
Borsellino- ter e sia recentemente, che Borsellino – lo incontrò poco prima
della strage di via D’Amelio – era interessato a mafia- appalti e che avrebbe
voluto collegare l’indagine palermitana a quella milanese. Il punto è
importante, perché gli elementi di collegamento spuntarono fuori durante
l’inchiesta Mani Pulite. Parliamo di attività imprenditoriali sospette relative
a imprese del nord come la Calcestruzzi di Gardini, impresa capofila del gruppo
Ferruzzi Spa che compariva nell’indagine mafia- appalti dei Ros.
L’inchiesta mafia- appalti, quindi, era potenzialmente una bomba potentissima
visto che scoperchiava legami tra mafia, personalità politiche di rilievo e
società appaltatrici in mano a persone vicine ad alcuni magi- strati. Ma non
solo. Parliamo di una bomba che non sarebbe deflagrata solamente in Sicilia, ma
anche in tutta la penisola (la testimonianza di Di Pietro docet) e le schegge
avrebbero sconfinato oltre le Alpi visto che l’inchiesta avrebbe potuto toccare
il sistema di riciclaggio internazionale. In merito a quest’ultimo punto, in
realtà, Falcone aveva già fiutato qualcosa qualche anno prima che ricevesse il
fascicolo dell’indagine mafia- appalti. Nel giugno 1989, infatti, si era
incontrato con la sua collega svizzera Carla Del Ponte nella villa che aveva
preso in affitto all’Addaura, vicino Palermo, per discutere di riciclaggio del
denaro sporco tramite aziende all’estero e, coincidenza vuole, fu in quel
momento che la mafia collocò una bomba sullo scivolo di accesso al mare della
villa, dentro un borsone da sub. Per fortuna venne notata da uno degli agenti
della scorta di Falcone e disinnescata dagli artificieri. Nel 1991 Falcone prese
in mano l’informativa dei Ros e un anno dopo fu ucciso. Sembra ragionevole
pensare che Falcone e Borsellino siano stati uccisi per il loro interesse
all’inchiesta dei Ros sui grandi appalti pubblici che la Procura di Palermo,
però, archiviò appena qualche giorno dopo la morte di Borsellino. La richiesta
di archiviazione – esattamente il 13, quando Borsellino era ancora in vita e
interessato a prenderla in mano – fu avanzata dagli allora sostituti procuratori
Guido Lo Forte e Roberto Scarpinato, vistata dal procuratore Giammanco tre
giorni dopo l’uccisione di Borsellino e archiviata definitivamente il 14 agosto
dal gip di Palermo Sergio La Commare. Parliamo dell’archiviazione più breve
della storia, avvenuta il giorno prima di ferragosto, quando solitamente gli
uffici dei tribunali sono semideserti. Il gip La Commare è lo stesso che,
qualche mese dopo – esattamente il 23 dicembre, altra data particolare,
antivigilia di Natale – convaliderà l’arresto di Bruno Contrada (ex capo della
Mobile di Palermo, ex vicedirettore del Sisde, ex capo della criminalpol di
Palermo) richiesto sempre da Lo Forte e Scarpinato. Nello stesso anno, gli
stessi magistrati archiviano l’indagine sui mafiosi e arrestano chi per anni è
stato in prima linea contro la mafia. A quel punto, mafia- appalti, che doveva
essere una bomba che avrebbe fatto tremare l’Italia intera, era stata quindi
disinnescata. In realtà, precedentemente, aveva già subito un depotenziamento.
Come? Ricordiamo che l’informativa mafia- appalti dei Ros era di 890 pagine ed
era stata ricostruita la mappa del malaffare siciliano dove erano elencati 44
nomi di imprenditori, uomini politici di quasi tutti i partiti e aziende. Il
dossier passò nelle mani di ben otto sostituti procuratori di Palermo. Furono
indagate soltanto cinque persone. Ma accadde qualcosa di grave. Tutti i
coinvolti nell’informativa dei Ros – gli imprenditori, i politici e i mafiosi -,
ricevettero l’elenco degli appalti e dei nomi citati nel dossier. Da chi? Dalle
risultanze processuali, risulta assolutamente certo che l’informativa del
febbraio del 1991, denominata “mafiaappalti”, fu illecitamente divulgata prima
della emissione dei provvedimenti restrittivi. I Ros accusarono i magistrati
della procura di Palermo e viceversa. Alla fine tutto fu archiviato. Si legge
nell’ordinanza di archiviazione: « Non può affatto escludersi, in via d’ipotesi,
che nella illecita divulgazione delle notizie e dei documenti riservati oggetto
del presente procedimento, possano essere stati coinvolti, o per denaro o in
ragione degli asseriti rapporti di amicizia con svariate personalità politiche,
i magistrati odierni indagati ». Qualunque sia la verità, con ciò fu svelata
l’architettura investigativa complessiva, emersero i nomi di tutti i soggetti
nel mirino dei Ros e si vanificò sostanzialmente l’intera indagine. Dopodiché
inizia a scorrere il sangue. Il primo a morire fu il deputato andreottiano Salvo
Lima, il 12 marzo 1992. Poi, il 4 aprile successivo, toccò al maresciallo
Giuliano Guazzelli, ucciso perché – su esplicita richiesta – rifiutò di
stemperare le accuse contro Angelo Siino, uno dei 5 arrestati di mafia-
appalti e, ricordiamolo nuovamente, ritenuto dai Ros “l’anello di congiunzione
tra mafia e imprenditoria”. Quindi, come noto, il 23 maggio morì lo stesso
Falcone e il 19 luglio morì Paolo Borsellino.
Mafia e Appalti: Falcone lavorò su quel
dossier sparito. Lo aveva ricevuto nel febbraio del
1991 e lo considerava importantissimo, scrive Damiano Aliprandi il 4 Maggio 2018
su "Il Dubbio". Nel corso dei processi per le stragi siciliane del 1992, dalle
persone informate sui fatti (come l’ex generale Mario Mori e il capitano
Giuseppe De Donno dei Ros, e poi pentiti come Angelo Siino e Giovanni Brusca),
era emerso che la gestione illecita del sistema di aggiudicazione degli appalti
in Sicilia era stato il movente principale dell’attacco mafioso. Cioè era la
ragione che aveva indotto “Cosa nostra” a deliberare ed eseguire le terribili
stragi siciliane che portarono all’uccisione di Falcone, Borsellino e molte
altre persone. Emerse, in sostanza, l’interesse che alcuni ambienti politico–
imprenditoriali e mafiosi avevano ad evitare l’approfondimento dell’informativa
dei Ros mafia- appalti, il cui esito positivo avrebbe interrotto l’illecito
“approvvigionamento finanziario”, per l’ammontare di svariati miliardi, di cui
imprenditori, politici e mafiosi beneficiavano mediante l’illecito sistema di
controllo e di aggiudicazione degli appalti pubblici. Le indagini, le quali
avevano aperto già nel 1991 scenari inquietanti, se svolte con completezza e
tempestività fra il 1991 e il 1992, avrebbero avuto un impatto dirompente sul
sistema economico e politico italiano ancor prima, o al più contestualmente,
dell’infuriare nel Paese di “Tangentopoli”. L’interesse della mafia a
neutralizzare le indagini eliminando fisicamente i magistrati ai quali venivano
notoriamente riconosciute la capacità professionale e la volontà per svolgerle,
si era rafforzato quando Paolo Borsellino, dopo la strage di Capaci, si era
fortemente determinato a sviluppare le indagini in questione, riprendendole e
indirizzandole nel solco originariamente tracciato da Giovani Falcone. Tutto ha
avuto inizio la mattina del 20 febbraio del 1991 quando il capitano Giuseppe De
Donno consegnò, all’allora sostituto procuratore Giovanni Falcone, le
conclusioni dell’indagine sulla mafia- appalti sottoscritta dal generale Mori.
De Donno, che Falcone chiamava affettuosamente Peppino e che era uno dei pochi
investigatori che si permetteva di dare al giudice del ‘ tu’, valendosi delle
confidenze di un geometra, Giuseppe Li Pera (nell’indagine dei Ros ci sono le
sue intercettazioni), che lavorava in Sicilia per una grossa azienda del Nord,
aveva ricostruito la mappa del malaffare siciliano, ed aveva elencati 44 nomi di
imprenditori, uomini politici di rilievo e aziende di primaria importanza. In
questo elenco c’erano anche nomi legati a magistrati siciliani. Falcone si
interessò molto dell’indagine dei Ros. Infatti, a distanza di un mese dalla
consegna dell’informativa, in un importante convegno organizzato a marzo del ’
91 dall’Alto Commissario Antimafia, dopo avere riconosciuto che il
condizionamento mafioso esisteva sia al momento della scelta delle imprese, sia
nella fase esecutiva, con caratteristiche ambientali e totalizzanti ( senza
escludere, quindi, le imprese del Nord), e dopo aver fatto cenno ad alcune
intercettazioni telefoniche da cui risultavano varie modalità operative, aveva
testualmente affermato: « Ormai emerge l’imprescindibile necessità di impostare
le indagini in maniera seriamente diversa rispetto a quanto si è fatto finora »,
alludendo non solo a un salto di qualità investigativa, ma all’utilizzazione
nelle indagini su mafia- appalti dell’apparato dell’Alto Commissario e, cioè,
teorizzando la messa a disposizione delle informazioni raccolte nel circuito dei
servizi al pubblico ministero e, comunque, la sinergia tra l’intelligence e le
investigazioni sul territorio. In pratica aveva non solo intuito l’importanza
di mafia- appalti, ma aveva fatto capire la sua intenzione di creare un nuovo ed
efficace metodo di investigazione. Fu un campanello d’allarme per quanti,
mafiosi e contigui, noti e non ancora noti, avrebbero potuto essere attratti nel
cono di luce di questo programma. C’è una testimonianza che conferma il timore
di Cosa nostra. Riportiamo un brano tratto dalla sentenza della Corte di assise
di appello di Caltanissetta del 2000: «A dire del Siino (considerato il ministro
dei lavori pubblici di Cosa nostra, ndr) , le indagini promosse dal giudice
Falcone nel settore della gestione illecita degli appalti, verso cui aveva
mostrato un “crescendo di interessi”, avevano portato alla sua eliminazione.
Difatti, in Cosa nostra, e, in particolare, da parte di Pino Lipari e Antonino
Buscemi, era cresciuta la consapevolezza che il dr. Falcone avesse compreso la
rilevanza strategica del settore appalti e che intendesse approfondirne gli
aspetti: “questo sa tutte cose, questo ci vuole consumare”». A distanza di
qualche mese dal suo intervento, Giovanni Falcone, dopo essere stato isolato dai
suoi colleghi e scansato dal Csm, accetterà dal ministro Martelli la carica di
Direttore Generale degli Affari Penali presso il ministero della Giustizia. Il
dossier dei Ros rimase nelle mani dei sostituti procuratori Guido Lo Forte e
Giuseppe Pignatone, in seguito il Procuratore Giammanco affiancherà altri
sostituti, tra i quali Roberto Scarpinato, cioè l’attuale Procuratore generale
di Palermo. Nonostante ciò, Falcone non recise i suoi collegamenti con le
articolazioni operative delle indagini a Palermo. Si fidava però di uno solo
collega, ovvero Paolo Borsellino. In quel frangente si verificò una circostanza
molto significativa e che turbò molto Falcone. L’intero rapporto mafia
appalti fu consegnato dal procuratore Giammanco al ministro Martelli, che
tuttavia lo restituì alla Procura di Palermo, senza aprire il plico, avendo
riscontrato in Giovanni Falcone una sorta di lamentela sulla condotta del
magistrato, il quale nel consegnare il rapporto aveva inteso delegare alla
politica l’intera questione anziché promuovere le dovute indagini di riscontro.
E addirittura, la lettera di restituzione fu inviata al Csm per conoscenza, per
rimarcare l’anomalo comportamento del procuratore Giammanco. Falcone era
interessato a mafiaappalti collegandolo perfino con le indagini milanesi. Di
questo si trova riscontro nella testimonianza di Antonio Di Pietro nell’ambito
del processo Borsellino ter. Si parla sempre di imprese e casualmente – come
raccontò l’ex giudice di Mani Pulite – cominciavano ad emergere nomi che
rientravano anche nell’informativa dei Ros. Di Pietro durante il processo nominò
ad esempio la Ferruzzi Spa (quella di Gardini) o la De Eccher, tutte imprese del
nord coinvolte in mafia- appalti. Di Pietro disse di averne parlato con Falcone.
«Quella era l’essenza della mia inchiesta – raccontò Di Pietro durante il
processo – cioè la scoperta che le imprese nazionali dovunque andavano si
associavano con imprese locali, si realizzavano questi appalti e producevano
delle dazioni di denaro al sistema dei partiti e ai pubblici ufficiali. Ne
parlai dapprima con Falcone e poi anche con Borsellino. Ma attenzione –
sottolineò Di Pietro-, anche quando Falcone era ancora vivo». Falcone,
ribadiamolo, non perdeva di vista quell’indagine, anche se formalmente non era
di sua competenza. La conosceva così bene che, durante un convegno pubblico,
aveva lanciato un appello esclamando che «la mafia è entrata in borsa», per dire
che società quotate in borsa erano state attratte nell’alveo delle relazioni con
“Cosa nostra”. Il grumo di interessi che riguarda gli appalti, fa maturare la
decisione della mafia di punire i vecchi referenti politici come Salvo Lima,
accusati di non essere più in grado di svolgere utili mediazioni. Mancavano solo
11 giorni all’attentato, il tritolo per Capaci era già partito quando in un
convegno organizzato dall’AdnKronos a Roma, giunse un foglietto anonimo nelle
mani di Falcone, e quel foglietto lo avvertiva che stava arrivando la sua ora.
Quel pizzino di morte fu l’ultimo avvertimento prima di quel boato che il 23
maggio 1992 sventrò l’autostrada uccidendo con Giovanni Falcone anche sua moglie
Francesca Morvillo e i tre agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e
Rocco Dicillo. Solo Paolo Borsellino, dopo la strage di Capaci, voleva risalire
a quella inchiesta e a quel dossier dei Ros per scoprire gli assassini di
Falcone. Alla prossima puntata parleremo di questo.
Mafia- appalti, quel giorno che Paolo
Borsellino fu convocato in Procura…Era la mattina del
19 luglio 1992, il pomeriggio ci fu la strage, scrive Damiano Aliprandi l'8
Maggio 2018 su "Il Dubbio". Esattamente quattro giorni prima che venisse
brutalmente ucciso, Paolo Borsellino era a casa con la moglie, sconvolto e molto
preoccupato. Perché? La spiegazione è in una deposizione della signora Agnese
Borsellino rilasciata il 18 agosto 2009 di fronte ai Procuratori di
Caltanissetta: «Mi riferisco ad una vicenda che ebbe luogo mercoledì 15 luglio
1992; ricordo la data perché, come si evince dalla copia fotostatica dell’agenda
grigia che le SS. LL. mi mostrarono…» «Il giorno 16 luglio 1992 mio marito si
recò a Roma per motivi di lavoro ed ho memoria del fatto che la vicenda in
questione si colloca proprio il giorno prima di tale partenza. Mi trovavo a casa
con mio marito, verso sera, alle ore 19.00, e, conversando con lo stesso nel
balcone della nostra abitazione, notai Paolo sconvolto e, nell’occasione, mi
disse testualmente “ho visto la mafia in diretta, perché mi hanno detto che il
Generale Subranni era “pungiutu” (affiliato a Cosa nostra, ndr) ». L’italiano
non si interpreta, è la nostra lingua madre, eppure i teorici della presunta
Trattativa hanno inteso che Borsellino, dicendo di aver visto la “mafia in
diretta”, si riferisse all’ex generale dei Ros Subranni. Sappiamo che Borsellino
si fidava ciecamente dei carabinieri del Reparto Operativo Speciale e non a
caso, come vedremo in seguito, fece un incontro segreto con loro per discutere
dell’inchiesta mafia- appalti presso la caserma e non negli uffici della
Procura, visto che più di una volta aveva espresso di non fidarsi dei suoi
colleghi. Quindi, ritornando alla testimonianza della moglie Agnese, Borsellino
era rimasto turbato perché qualcuno gli aveva detto che Subranni era un mafioso.
Nella frase “ho visto la mafia in diretta” Borsellino infatti si riferiva al suo
interlocutore, avendo capito la sua intenzione di infangare i Ros. Con chi si
era visto? Non è dato saperlo. Dalla sua agenda personale sappiamo però che
Borsellino, quel giorno, è stato in Procura dalle 17 in poi, dopodiché è
rientrato a casa per l’ora di cena; a seguire avveniva l’angosciosa
chiacchierata con la moglie. Con chi si era visto in Procura? La “mafia in
diretta” era riferito a un suo collega? Non lo sapremo forse mai. Quello che
sappiamo, però, è che Borsellino stava seguendo la pista dell’inchiesta mafia-
appalti anche per risalire agli assassini di Falcone. Diverse sono le
testimonianze di primaria importanza. Una è dei Ros. Paolo Borsellino, subito
dopo l’omicidio di Falcone – secondo la testimonianza del generale Mori –,
chiese un incontro riservato a Mori stesso e De Donno per parlare di mafia-
appalti, dove ribadì la sua convinzione che ci fosse un legame con la strage di
Capaci. «Nel salutarci – racconta sempre Mori – raccomandò la massima
riservatezza sull’incontro, in particolare nei confronti dei colleghi della
Procura di Palermo». L’altra testimonianza è di Antonio Ingroia. Lui stesso,
durante l’udienza del 12 novembre 1997 – parliamo del processo Borsellino bis
della Procura di Caltanissetta -, ha raccontato che Borsellino era convinto che
partendo dagli appunti contenuti nell’agenda elettronica di Falcone su mafia-
appalti si potevano individuare i moventi della strage di Capaci. Probabilmente
Ingroia ha poi rimosso questo ricordo ed ha imbastito l’inchiesta giudiziaria
sulla presunta Trattativa. L’altra testimonianza è quella della dottoressa
Liliana Ferraro resa al Tribunale di Palermo nell’udienza del 28 settembre 2010.
Disse che si incontrò con Borsellino, che le espresse la necessità di fare di
tutto per scoprire gli autori della strage di Capaci. Oltre a riferirle i
difficili rapporti che aveva con la Procura di Palermo, Borsellino le chiese
informazioni su mafia- appalti, visto che lui non aveva nessuna delega dalla
Procura di Palermo. Poi c’è la testimonianza di Antonio Di Pietro. Oltre a
Falcone, l’ex pm di Mani pulite disse che Borsellino voleva approfondire lui
stesso l’inchiesta mafia- appalti e collegarla all’indagine milanese. Di Pietro
racconta che Borsellino lo incontrò al funerale di Falcone e gli disse: «Antonio
facciamo presto perché abbiamo poco tempo». Ma se fin qui parliamo di intenzioni
da parte di Borsellino, c’è un evento che cristallizza i suoi primi passi
concreti su mafia- appalti, nonostante non avesse ancora la delega. Poco prima
della sua uccisione – esattamente il 29 giugno del 1992Borsellino aveva svolto a
casa sua un incontro riservato con il suo collega Fabio Salomone. Non è uno
qualunque: parliamo del fratello di Filippo Salomone, l’imprenditore coinvolto
nell’informativa mafia- appalti dei Ros. Cosa si dissero? Lo riferisce lo stesso
magistrato Salomone in un verbale: «Lo andai a trovare a casa sua. Era un primo
pomeriggio. C’erano altre persone, oltre alla moglie, Agnese. C’era Antonio
Ingroia. Io e Paolo ci siamo chiusi nello studio con una porta a soffietto. Il
colloquio sarà durato un’oretta circa. Ricordo che parlammo ancora una volta del
fatto che Martelli e Scotti, avendolo indicato come probabile Procuratore
Nazionale Antimafia, avevano sovraesposto la sua posizione. Lui si sentiva più
protetto a Palermo. Parlammo ancora della mia situazione, che lui riteneva a
rischio e mi invitò a venire a Palermo. Io obiettai che l’attività
imprenditoriale di mio fratello rendeva inopportuno questo trasferimento, con
Tangentopoli che era scoppiata. Borsellino mi disse che allo stato non gli
risultava nulla a carico di mio fratello ed in ogni caso riteneva sufficiente
che io non mi occupassi delle tematiche, in cui poteva essere coinvolto lo
stesso mio fratello, data la dimensione della Procura di Palermo. Borsellino
comunque insistette perché io andassi via da Agrigento. All’epoca della visita a
Borsellino, io stesso stavo maturando la decisione di allontanarmi da
Agrigento». Il colloquio fin qui riportato dimostra chiaramente che per
Borsellino l’inchiesta mafia- appalti era di primaria importanza. Le ragioni
sono molteplici: perché si svolge qualche settimana prima dell’esecuzione della
strage e dopo soli 4 giorni dall’incontro che Borsellino aveva tenuto con i Ros
alla caserma di Piazza Verdi; perché non vi era stata, in precedenza, un’assidua
consuetudine di frequentazioni fra i due magistrati e, non per ultimo, perché il
fratello del magistrato era tra gli imprenditori implicati nel filone mafia-
appalti. Tutto questo fa pensare che Borsellino, se solo avesse preso in mano la
delega per Palermo avrebbe potuto gestire anche l’inchiesta su mafia- appalti e
sarebbe potuto arrivare fino in fondo. Non doveva far altro che farsi dare la
delega dal procuratore Giammanco. Giungiamo quindi ai suoi ultimi istanti di
vita. Verso le 7 e 30 della mattina di quel maledetto 19 luglio 1992, Borsellino
ricevette una telefonata dal procuratore Giammanco. Lo aveva testimoniato la
moglie Agnese. A quell’ora i tre figli di Borsellino dormivano e il giudice
s’affrettò ad afferrare il telefono al primo squillo. La moglie, turbata dalla
chiamata mattutina, sentì cosa rispondeva, freddo, all’interlocutore: «La
partita è aperta». Il tono allarmò la signora. E fu il marito, rimettendo giù la
cornetta, a spiegarle che era stato Giammanco a chiamarlo per assegnargli la
delega sull’inchiesta palermitana. Borsellino però non poteva sapere che qualche
giorno prima – esattamente il 13 luglio – c’era stata la richiesta di
archiviazione da parte di Lo Forte e Scarpinato. E forse nemmeno Giammanco,
visto che l’avrebbe vistata tre giorni dopo il tragico evento. Il pomeriggio
stesso una Fiat rubata, piena di tritolo, esplose sotto il palazzo dove viveva
la madre di Borsellino, presso la quale il giudice quella domenica si era recato
in visita. Morì lui e i suoi agenti di scorta.
«Tenete quei dossier
lontani da Falcone e Borsellino».
L’informativa “Caronte” dei Ros sulle collusioni Mafia-imprese, scrive Damiano
Aliprandi il 9 Maggio 2018 su "Il Dubbio". Fin qui abbiamo tratteggiato
l’interesse di Falcone e Borsellino per l’informativa dei Ros dedicata a mafia-
appalti. L’interesse era quello di approfondire l’inchiesta, ma sappiamo che non
avevano la delega e così l’inchiesta fu dapprima depotenziata, indagando solo
cinque persone, poi fu diffuso – non si sa da chi – il contenuto del rapporto
che arrivò a tutti i soggetti coinvolti; infine fu tutto archiviato, quando il
corpo senza vita di Borsellino era ancora caldo. La richiesta di archiviazione –
firmata dai sostituti Lo Forte e Scarpinato – fu avanzata pochissimi giorni
prima dell’attentato. In seguito ci sono state diverse inchieste giudiziarie
“spezzettate” ma che non portarono a nulla visto che c’è stata una sorta di
scompenso tra le intuizioni investigative elaborate da Giovanni Falcone (in
qualche modo anticipate al Convegno di Castel Utveggio) puntualmente tracciate
dai Ros e le utilizzazioni processuali conseguenti, da parte della procura di
Palermo dell’epoca. Il che dimostra ulteriormente come gli eccidi di Capaci e di
Via D’Amelio avessero rallentato di molto l’attuazione dell’originario programma
investigativo e che, di conseguenza, Cosa nostra avesse raggiunto i suoi
obiettivi attraverso le stragi del 1992. Ma perché la mafia aveva paura che
quell’indagine venisse approfondita? Perché – secondo la testimonianza di Angelo
Siino, considerato il ministro dei lavori pubblici di Cosa nostra -, la mafia
riferendosi a Falcone avrebbe detto «questo sa tutte cose, questo ci vuole
consumare»? L’indagine dei Ros che dettero vita all’informativa mafia- appalti è
nata sotto la spinta del magistrato Giovanni Falcone, tant’è vero che i Ros lo
informavano delle indagini ben prima che redigessero il dossier. Infatti due
sono le informative dei Ros consegnate a Falcone (e anche a Lo Forte che era
sostituto procuratore a Palermo): una datata il 2 luglio 1990 e l’altra il 5
agosto del 1990. Falcone aveva capito che non bastava arrestare gli esponenti
dei clan, ma bisognava colpire la ricchezza di Cosa Nostra, frutto di vere e
proprie attività imprenditoriali. Del resto già Leonardo Sciascia aveva
tratteggiato la figura dell’imprenditore mafioso, Colasberna, ne Il giorno della
Civetta. Tuttavia, fino al momento in cui i Ros non misero il becco nel
reimpiego dei capitali mafiosi nella gestione degli appalti, la linea
investigativa era concentrata essenzialmente sulle indagini bancarie ai fini
dell’individuazione delle somme di denaro e dei molteplici prestanomi che ne
favorivano l’occultamento. Il meccanismo della gestione degli appalti in mano
alla mafia è ben sintetizzato in un passaggio dell’informativa dei Ros dove si
dice che i mafiosi “disponevano di una capacità operativa sorprendente,
abbinata, tra l’altro, ad una pressoché illimitata forza condizionante la
pubblica amministrazione che permetteva loro di aggirare e superare qualsiasi
vincolo legislativo e non”, e che non aveva solo la capacità di indirizzare la
volontà degli Enti Pubblici, “ma di coartarla in tutti i suoi aspetti, riuscendo
in alcuni casi, a programmare essi stessi l’attività economica d’intervento
pubblico”. Come accade spesso nelle indagini investigative, le collusioni
vengono scoperchiate quasi per caso. Tutto cominciò quando, a settembre del
1989, avvenne l’omicidio di un imprenditore di Baucina, piccolo comune vicino
Palermo. Nel corso delle relative indagini era emerso che l’impresa gestita
dalla vittima legata alla mafia si era associata, in relazione ad un pubblico
appalto di modesta entità, con la società Tor Di Valle Spa, di ben più imponenti
dimensioni ed avente sede in Roma: all’epoca gestiva enormi appalti come la
costruzione della nuova Casa circondariale di Civitavecchia, il prolungamento
della linea ‘ B’ della metropolitana di Roma e altro ancora. È da quel momento
che l’indagine si era concentrata su diverse società importanti della Sicilia
che sarebbero entrate nel circuito mafioso. Sono società di modeste dimensioni
che però erano collegate con le grandi imprese operanti al livello nazionale.
Oltre alla Tor Di Valle, tra le tante, compare anche la società del nord
Calcestruzzi s. p. a. del Gruppo Ferruzzi- Gardini che si era accordata con
l’imprenditore mafioso Buscemi. Sul progressivo cambiamento del ruolo di Cosa
nostra nella gestione degli appalti dopo la metà degli anni 80, è necessario
prendere in considerazione le conclusioni argomentate dai giudici della Corte di
Assise di Appello di Caltanissetta tratte dalla testimonianza di Siino. I
giudici nisseni hanno spiegato che la mafia, da un ruolo prettamente
parassitario incentrato sulle “messe a posto”, sui subappalti, sulle gestioni
dei lavori per conto terzi, era passata a uno imprenditoriale, nel senso che la
mafia aveva cominciato “a gestire direttamente l’aggiudicazione degli appalti ad
imprese a lei vicine”. Cosa nostra, si era inserita “a tappeto nella gestione
dei lavori conto terzi e nei subappalti”, applicando “il pizzo sul pizzo”, cioè
decurtando una parte delle tangenti dirette ai politici. Dall’informativa dei
Ros mafia e appalti, infatti, si evince che l’obiettivo della mafia era quello
di utilizzare il denaro del finanziamento al Mezzogiorno per i lavori da
aggiudicare alle imprese dell’organizzazione. E a gestire i soldi del
Mezzogiorno era la Sirap. Tale ente verrà poi esaminato dai Ros in un momento
successivo tramite l’informativa “Caronte”, solo perché aveva una sua
complessità rispetto alle vicende comprese nella informativa del febbraio del
1991 e perché, anche su sollecitazione dello stesso Falcone, si era preferito
depositare, prima, una informativa di carattere generale. L’informativa
“Caronte” venne tramessa alla Procura di Catania che, al termine delle indagini,
formulò una richiesta di misure cautelari verso numerosi esponenti politici.
L’allora procuratore Gabriele Alicata, non ritendendo competente il suo ufficio,
trasmise le carte alla Procura di Palermo. Tutti gli esponenti politici e
amministrativi per i quali la procura di Catania aveva richiesto misure
cautelare, non vennero in quella sede perseguiti. La Sirap era incaricata dalla
Regione Sicilia – il cui Presidente dell’epoca era l’onorevole Rino Nicolosi –
di gestire finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno e dell’allora Comunità
europea (la ex Cee) per circa mille miliardi, per la realizzazione di venti aree
attrezzate da destinare alle piccole e medie imprese artigianali ed industriali.
Si trattava, quindi, della gestione di venti gare di appalto dell’importo di
circa cinquanta miliardi ciascuna. Erano tanti soldi, miliardi e miliardi delle
vecchie lire, che potevano dare potere alla mafia, quello di condizionare la
politica e l’economia legale. La Procura di Palermo aveva, come già detto, la
delega per le indagini. Ma poteva farlo serenamente? Alcuni magistrati titolari
dell’inchiesta avevano parenti di primo grado e anche padri e fratelli legati a
quelle imprese ed enti sotto la lente d’ingrandimento dei Ros: uno dei sostituti
procuratori aveva il padre presidente dell’Espi, ente economico che aveva il
controllo della Sirap, società coinvolta nelle indagini. Sappiamo che Paolo
Borsellino, ad esempio, aveva già chiesto al magistrato Salomone – fratello di
uno degli imprenditori coinvolti nell’informativa dei Ros – di operare alla
procura di Palermo, ma di non occuparsi di mafia- appalti per questioni di
opportunità. Era solo un’informativa e quindi sono tutti innocenti fino a prova
contraria, ma per questioni di evidenti “conflitti di interesse” forse sarebbe
stato opportuno dare la delega ad altri magistrati, magari proprio a Falcone e
Borsellino. Entrambi – come diverse testimonianze e documento lo certificano –
informalmente seguivano mafia- appalti, ma furono dilaniati dal tritolo. Il
movente che ha concausato la loro morte è stato sepolto con loro, in compenso
sono stati condannati, in primo grado, coloro che dettero vita a quello
scottante dossier.
Borsellino lavorava sul
dossier Mori… Poi fu ammazzato.
La corte smonta il luogo
comune di uno stato inerme e piegato agli interessi di Cosa nostra nel periodo
delle stragi, scrive Damiano Aliprandi il 3 luglio 2018 su "Il Dubbio". Non ci
sono più dubbi. Nelle indagini sugli autori della strage di Via D’Amelio c’è
stato «uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana», con
alcuni funzionari della polizia che convinsero piccoli criminali a trasformarsi
in pentiti di Cosa nostra per costruire una falsa verità sull’attentato al
giudice Paolo Borsellino. Ma non solo. Nelle motivazioni della sentenza della
Corte d’Assise di Caltanissetta, depositata sabato a chiusura del processo
Borsellino quater e rassegnate nelle 1865 pagine, non vengono dimenticate le
responsabilità dei magistrati che fecero le indagini e sostennero le accuse
«senza particolare cautela e rigore». Le considerazioni della Corte d’Assise
presieduta dal giudice Antonio Balsamo, conducono il collegio a disporre nella
sentenza anche la trasmissione dei verbali di udienza dibattimentale alla
Procura di Caltanissetta «impegnata nella difficile ricerca della verità», in
quanto possano «contenere elementi rilevanti». Le dichiarazioni di Vincenzo
Scarantino sono state, quindi, al centro di uno dei più gravi depistaggi della
storia giudiziaria italiana, che ha condotto alla condanna alla pena detentiva
perpetua di Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale,
La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe, per il loro ritenuto
concorso nella strage di Via D’Amelio. Le motivazioni confermano che alcuni
investigatori guidati dall’allora capo della squadra mobile di Palermo Arnaldo
La Barbera dissero a Scarantino cosa confessare, dopo aver ricevuto delle
informazioni su come fu effettivamente organizzata la strage da «ulteriori fonti
rimaste occulte»: furono queste informazioni a rendere credibili le
testimonianze di Scarantino e altri “falsi pentiti”. In particolare su La
Barbera, morto di tumore il 12 dicembre 2002, le motivazioni della sentenza
dicono che ebbe un «ruolo fondamentale nella costruzione delle false
collaborazioni con la giustizia ed è stato altresì intensamente coinvolto nella
sparizione dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, come è evidenziato dalla sua
reazione, connotata da una inaudita aggressività, nei confronti di Lucia
Borsellino, impegnata in una coraggiosa opera di ricerca della verità sulla
morte del padre». E ancora, che ci fu «un proposito criminoso determinato
essenzialmente dall’attività degli investigatori, che esercitarono in modo
distorto i loro poteri».
L’irritualità della vicenda
processuale. Il «più grande depistaggio della storia giudiziaria italiana» è
quello delle «anomalie» e delle «irritualità» che hanno permeato l’intera
vicenda processuale e investigativa della strage di Via D’Amelio. Questa è in
sintesi la conclusione della motivazione. È la vicenda processuale
dell’acquisizione probatoria degli interrogatori di Scarantino, una di quelle
più aspramente contestate dalla Corte. Quelli che vengono citati in sentenza
sono anche stralci delle sentenze dei processi Borsellino bis e ter. È qui che
la Corte non tarda a richiamare l’’ attenzione sull’importanza che avrebbe avuto
la ricerca dei «riscontri individualizzanti, oltre che di rispettare i limiti
della chiamata e il controllo sull’accusa de relato». Proprio in merito al
depistaggio per i giudici della Corte d’Assise era evidente che Scarantino non
fosse mai stato coinvolto nelle attività relative alla strage, e che quindi
fosse logico ritenere che tali circostanze fossero state «a lui suggerite da
altri soggetti, i quali loro volta le avevano apprese da fonti occulte». La
sentenza giudica anche il comportamento degli inquirenti, quando rileva che le
dichiarazioni di Scarantino sono di tutta evidenza «caratterizzate da
incongruenze, oscillazioni e ritrattazioni» e che proprio questi elementi ben
avrebbero dovuto consigliare «un atteggiamento di particolare cautela e rigore
nella valutazione delle dichiarazioni» in capo agli inquirenti. Con queste sue
considerazioni nella sentenza la Corte d’Assise critica aspramente la carenza di
una «minuziosa ricerca di tutti gli elementi di riscontro, positivi e negativi
che fossero». Si parla di irritualità da parte dell’allora procuratore di
Caltanissetta Giovanni Tinebra, come nel caso in cui viene citata la richiesta
di intervento nelle indagini di Contrada, sebbene egli non rivestisse la qualità
di ufficiale di polizia giudiziaria e nonostante «la normativa gli precludesse
rapporti diretti con la magistratura» ; o quando si allude all’assenza di
informazioni assunte da Borsellino nei 57 giorni dopo la strage di Capaci prima
della sua uccisione, «benché lo stesso, avesse manifestato pubblicamente la
propria intenzione di fornire il contributo conoscitivo». In ultimo, ma per
nulla meno importante, balza all’occhio un richiamo, quello alla pervicacia con
cui fu condotta l’attività di determinazione dello Scarantino a rendere
dichiarazioni accusatorie: sono le parti civili che vi alludono ma i giudici
devono averla ritenuta particolarmente interessante, perché ne fanno citazione,
rinviando ad una trama, quella riferita del calunniatore Scarantino, forse un
po’ troppo complessa, perché fu capace di attirare in inganno anche i giudici di
ben due processi sulla strage di Via D’Amelio. È per questo che il Collegio
disporrà la trasmissione degli atti alla Procura di Caltanissetta, per
proseguire nella ricerca della verità: questa volta, con riguardo alle
«anomalie» e «irritualità» di chi si era occupato delle indagini sulla strage di
Via D’Amelio ad ogni livello.
Mafia Appalti, concausa della
strage di via D’Amelio? Nelle motivazioni emerge anche un altro elemento non
trascurabile. Ovvero il fattore scatenante per il quale la mafia avrebbe deciso
di uccidere Paolo Borsellino. Viene citata la testimonianza del pentito Antonino
Giuffrè, tramite la sentenza n. 24/ 2006 della Corte di Assise di Appello di
Catania. La Corte aveva osservato come le ragioni dell’anticipata uccisione del
giudice Borsellino siano state precisate dal collaborante Giuffrè, il quale ha
dichiarato che, dalle notizie apprese dopo la sua uscita dal carcere, ha potuto
comprendere come i timori di Cosa Nostra fossero basati su due motivi: la
possibilità che Borsellino venisse ad assumere la posizione di Capo della
Direzione Nazionale Antimafia, e, soprattutto, la pericolosità delle indagini
che egli avrebbe potuto svolgere in materia di mafia e appalti. «Un motivo è da
ricercarsi – dichiarò Giuffrè -, per quello che io so, sempre nel discorso degli
appalti. Perché il dottore Borsellino, sì sono resi conto che era molto
addentrato in questa branca, cioè in questo discorso mafia politica e appalti. E
forse forse alla pari del dottore Falcone». La motivazione, infatti, preme molto
sulla questione mafia appalti che, ricordiamo, fu un’operazione condotta dai Ros
capitanata dal generale Mario Mori e voluta da Giovanni Falcone. Giuffrè, nel
confermare le precedenti dichiarazioni secondo cui «il Dottor Borsellino forse
stava diventando più pericoloso di quello che addirittura si era pensato, in
particolare (…) per quanto riguarda il discorso degli appalti», ha chiarito che
gli esponenti di ‘ Cosa Nostra’ «avevano avuto notizia di un «rapporto che era
stato presentato alla Procura di Palermo da parte dei Ros all’allora Procuratore
Giammanco». La Corte dà molto credito a Giuffrè, il quale aveva posto in
evidenza altri aspetti di rilievo, come il fatto che, prima di attuare la
strategia stragista, sarebbero stati effettuati “sondaggi” con «persone
importanti» appartenenti al mondo economico e politico. Nelle motivazioni viene
quindi evidenziato come questi “sondaggi” si fondavano sulla “pericolosità” di
determinati soggetti non solo per l’organizzazione mafiosa, ma anche per i suoi
legami esterni con ambienti imprenditoriali e politici interessati a convivere e
a fare affari con essa. Da questo tipo di discorsi iniziava l’isolamento che
portava all’uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i quali «non
interessavano proprio a nessuno» e non erano ben visti neppure all’interno della
magistratura. Nella decisione di eliminare i due Magistrati aveva avuto un peso
proprio il loro isolamento. «L’inquietante scenario descritto dal collaboratore
di giustizia trova – si legge nella motivazione -, in effetti, precisi riscontri
negli elementi di prova emersi nell’ambito del presente procedimento, che
evidenziano l’isolamento creatosi intorno a Paolo Borsellino, e la sua
convinzione che la sua uccisione sarebbe stata resa possibile dal comportamento
della stessa magistratura». Nel verbale di assunzione di informazioni del 18
agosto 2009, davanti al Pubblico Ministero presso questo Tribunale, la signora
Agnese Piraino Borsellino ha dichiarato: «Ricordo perfettamente che il sabato 18
luglio 1992 andai a fare una passeggiata con mio marito sul lungomare di Carini
senza essere seguiti dalla scorta. In tale circostanza, Paolo mi disse che non
sarebbe stata la mafia ad ucciderlo, della quale non aveva paura, ma sarebbero
stati i suoi colleghi ed altri a permettere che ciò potesse accadere. In quel
momento era allo stesso tempo sconfortato, ma certo di quello che mi stava
dicendo». Paolo Borsellino, in tale occasione, non fece nessun nome alla moglie,
la quale però ha soggiunto: «comunque non posso negare che quando Paolo si
riferì ai colleghi non potei fare a meno di pensare ai contrasti che egli aveva
in quel momento con l’allora Procuratore Giammanco». Borsellino non si fidava
dei suoi colleghi e riferendosi alla Procura di Palermo, parlò di «Covo di
vipere». D’altronde, come riportò Il Dubbio, lo stesso Borsellino, dopo la morte
di Falcone, si interessò di mafia appalti e ne parlò con i Ros tramite un
incontro riservato in caserma, non in Procura. Altro aspetto fondamentale è che
la Corte indirettamente sconfessa il teorema giudiziario sulla presunta
trattativa Stato Mafia. «Va, altresì, rilevato – viene evidenziato nelle
motivazioni – che l’attentato contro Paolo Borsellino costituiva un attacco
terroristico diretto a piegare lo Stato. L’obiettivo perseguito con questo e con
analoghi delitti era quello di destabilizzare le Istituzioni e favorire nuovi
equilibri con il potere politico, strumentali alla tutela degli interessi di
Cosa Nostra, ma nulla escludeva che, nella fase successiva, lo Stato avrebbe
potuto reagire, come effettivamente avvenne, mediante misure dirette ad
assicurare una più forte repressione del fenomeno mafioso». Viene confermato che
lo Stato agì duramente per reprimere la mafia. Quindi nessun patto con Cosa
Nostra.
La prima versione sulla
strage. Le indagini sulla strage di via D’Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992,
vennero assegnate al “gruppo Falcone- Borsellino” guidato dal capo della Squadra
Mobile di Palermo Arnaldo La Barbera. Già il 13 agosto il Sisde di Palermo
annunciò di aver individuato l’automobile usata e la carrozzeria dove era stata
preparata; alla fine di settembre venne nominato il “colpevole”, nella persona
di Vincenzo Scarantino, 27 anni: era stato lui a organizzare il furto della Fiat
126. Lo accusavano altri tre delinquenti arrestati un mese prima per violenza
carnale. Il suo arresto era stato annunciato così dal procuratore Tinebra:
«Siamo riusciti con un lavoro meticoloso e di gruppo, con la partecipazione di
magistrati, tecnici e investigatori, che hanno lavorato in sintonia, a
conseguire un risultato importante quale l’arresto di uno degli esecutori della
strage di via D’Amelio». Appena di Scarantino si seppe qualcosa di più, fu però
una vera delusione, tanto apparve fasullo. Era un ragazzo, di bassissimo livello
intellettuale, piccolo spacciatore, non affiliato a Cosa Nostra benché nipote di
un boss della Guadagna, il quartiere meridionale di Palermo dove era conosciuto
come lo scemo della borgata. Però aveva confessato, e nei mesi seguenti questo
personaggio così improbabile, da semplice ladro d’auto che scambiava con qualche
dose di eroina, si trasfigurò in astuto organizzatore, reclutatore di un piccolo
esercito, stratega militare, partecipante di prestigio alle riunioni della
Cupola. Il ragazzo stesso, peraltro, si smentiva, ritrattava, denunciava,
piangeva, ma nessuno gli dava retta malgrado emergessero via via testimonianze
di violenze e pressioni sulla sua famiglia, dei verbali ritoccati e concordati,
degli interrogatori condotti in modi anomali: le sue ritrattazioni erano
«tecniche di Cosa Nostra che conosciamo bene», scrisse l’allora Pm Nino Di
Matteo, che in una requisitoria sostenne che «la ritrattazione dello Scarantino
ha finito per avvalorare ancor di più le sue precedenti dichiarazioni». A questo
si aggiunse la requisitoria della Pm Anna Maria Palma: «dietro questa
ritrattazione c’è la mafia». Il resto della storia, la conosciamo.
Quando il “Corvo” cominciò
a volare su chi combatteva Cosa nostra.
La prima lettera anonima del
“Corvo” contro le istituzioni spuntò nel 1989 e fu ingiustamente accusato il pm
Alberto Di Pisa, scrive Damiano Aliprandi il 16 Maggio 2018 su "Il Dubbio". Fin
qui abbiamo raccontato come l’indagine dei Ros su mafia- appalti è stata seguita
fin dall’inizio da Falcone e poi portata avanti da Borsellino. Per completare il
quadro, però non si può tener conto delle lettere anonime definite
giornalisticamente del “Corvo”. Come un uccello del malaugurio hanno svolazzato
sempre quando ci sono stati gli attentati. La prima lettera arrivò a ridosso
dell’attentato fallito a Falcone, l’altra invece a cavallo tra la strage di
Capaci del 23 maggio 1992 e quella in via D’Amelio del 19 luglio 1992. La prima
missiva anonima spunta in un anno spartiacque: il 1989. Il mondo cambia
letteralmente volto. La caduta del Muro di Berlino, il 9 novembre, produce
conseguenze politiche, economiche e sociali in tutto il pianeta. Mentre le
manifestazioni studentesche in Cina vengono represse nel sangue, in Ungheria si
apre la frontiera con l’Austria, creando il primo varco della Cortina di ferro e
permettendo la fuga dalla Ddr (Repubblica Democratica Tedesca, comunemente
chiamata Germania Est) di molti suoi abitanti. A novembre, una escalation di
pochi giorni, cominciata con la concessione ai rifugiati nelle ambasciate della
Germania Ovest di Praga e Varsavia di trasferirsi nella Repubblica Federale,
porta alla caduta del Muro di Berlino, festeggiata l’anno seguente con un grande
concerto dei Pink Floyd. Il 1989 è un anno rilevante anche nello scacchiere
italiano, sotto il profilo politico, criminale e giudiziario. ll 20 febbraio, a
Catanzaro, si conclude il terzo processo per la strage di Piazza Fontana:
assolti gli imputati ( Stefano Delle Chiaie e Massimiliano Fachini) per non aver
commesso il fatto. La storia si ripete un mese più tardi con l’assoluzione di
tutti gli imputati per un’altra strage, quella di Piazza della Loggia a Brescia
il 28 maggio 1974. I fatti più eclatanti si verificano tra le dimissioni del
governo De Mita (19 maggio) e il giuramento del sesto governo Andreotti (23
luglio), pentapartito composto da Dc, Psi, Psdi, Pri e Pli. Ma l’anno 1989 è
anche quello dove per la prima volta in Parlamento arriva un relazione sulla
sicurezza dove viene denunciato che mafia, camorra e ‘ ndrangheta hanno superato
il terrorismo nella graduatoria delle minacce nella sicurezza nazionale. Il 12
giugno, Angela Casella, madre di Cesare Casella, ragazzo pavese rapito da
diciassette mesi dall’Anonima sequestri calabrese, si incatena nella piazza di
Locri per denunciare l’incapacità dello Stato nel combattere la criminalità
organizzata. La ‘ ndrangheta, infatti, in quel periodo getta le basi della sua
trasformazione e notevole espansione, approfittando soprattutto del cono d’ombra
generato dal maxi processo palermitano contro Cosa nostra. Mentre gli esponenti
di spicco della mafia siciliana sono ad un passo dall’essere condannati
definitivamente dallo Stato italiano, le ‘ndrine calabresi controllano i
territori, gestiscono in modo monopolistico il traffico di cocaina e riciclano
il denaro acquistando beni immobili e attività commerciali, cominciando
progressivamente a scalare le gerarchie criminali nazionali e internazionali. Ma
l’anno 1989 è anche quello del fallito attentato a Giovanni Falcone e l’inizio
di alcune missive inquietanti sempre ai danni del giudice palermitano. Già da un
anno i Ros si stanno interessando di mafia- appalti, in seguito a una “soffiata”
ricevuta dai carabinieri che indagano sull’omicidio di un allevatore in un
comune delle Madonie. Le successive indagini svelano – come già descritto
dettagliatamente nelle puntate precedenti de Il Dubbio ( edizioni del 3, 4, 8 e
9 maggio) – che Cosa nostra non ha più un atteggiamento parassitario (
imposizione del pizzo, di assunzioni, di forniture di materiali) ma, come spiega
Giovanni Falcone, durante un convegno organizzato dall’Alto commissario
antimafia, nella primavera del 1990, «indagini in corso inducono a ritenere
l’esistenza di un’unica centrale mafiosa che condiziona a valle e a monte la
gestione degli appalti pubblici». Ma ritorniamo al 1989. È il 21 giugno quando
cinquantotto candelotti di dinamite vengono rinvenuti sulla scogliera ai piedi
della villa all’Addaura: assieme a Falcone avrebbero potuto eliminare anche
Carla Del Ponte, allora procuratrice a Lugano, e il collega giudice istruttore
Claudio Lehmann, che indagavano sul sistema di riciclaggio internazionale di
Cosa nostra. Poche settimane prima giunsero continue lettere diffamatorie nei
confronti soprattutto di Falcone e inviate a vari rappresentanti delle
istituzioni. Verso la fine di maggio del 1989, Salvatore Contorno, noto
collaboratore di giustizia, trasferitosi da tempo negli Usa dopo la celebrazione
del primo maxiprocesso, veniva arrestato in Sicilia in una operazione
finalizzata alla cattura del latitante Gaetano Grado in una villetta di S.
Nicola l’Arena. Pochi giorni dopo venivano indirizzate a varie autorità una
serie di missive anonime scritte a macchina, note come le lettere del “Corvo”,
che contenevano gravissime accuse nei confronti di vari magistrati e
appartenenti alla polizia, tra cui innanzitutto Falcone e Giovanni De Gennaro,
poi diventato vicedirettore della Dia, accusati di avere ordito un diabolico
piano per contrastare la fazione corleonese di Cosa nostra attraverso il ritorno
in Sicilia di Salvatore Contorno per favorire la cattura o la eliminazione
fisica dei capi corleonesi Salvatore Riina e Bernardo Provenzano e per guidare
la vendetta delle cosche perdenti con una serie di omicidi. Si mette in diretta
correlazione il rientro di Contorno con una serie di omicidi che effettivamente
si erano registrati nel territorio di Bagheria, tra il marzo ed il maggio del
1989, ai danni di persone legate alle cosche mafiose vincenti dei corleonesi. Le
accuse, ovviamente, si sono rivelate assolutamente calunniose anche nel contesto
delle indagini svolte per individuare l’autore delle lettere e che le
dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia successivamente acquisite
hanno concordemente attribuito la responsabilità degli omicidi indicati negli
anonimi al gruppo corleonese escludendo la responsabilità di Salvatore Contorno.
Verrà accusato ingiustamente il magistrato Alberto Di Pisa, all’epoca sostituto
procuratore a Palermo, che ha subito un travagliato processo a seguito delle
indagini avviate dall’Ufficio dell’Alto Commissario che lo avevano indicato come
autore delle lettere e che, comunque, dopo essere stato condannato dal Tribunale
di Caltanissetta, è stato poi definitivamente assolto dalla Corte di Appello di
Caltanissetta. Dalla sentenza però emerge chiaramente come le calunniose accuse
rivolte a Falcone provengano da un ambito istituzionale e come si pongano in
strettissima correlazione logica e cronologica con l’attentato fallito
dell’Addaura. Al riguardo, lo stesso generale Mario Mori ha riferito nel suo
esame dibattimentale ( udienza del 7 febbraio 2000) che aveva concordato con
Falcone nel ritenere che le lettere del “Corvo”, rappresentassero un “atto di
delegittimazione di personaggi delle Istituzioni particolarmente esposti nella
lotta alla criminalità organizzata” e che nella prassi mafiosa le manovre di
isolamento e delegittimazione fossero spesso il primo passo per giungere,
“all’annientamento” di chi si contrapponeva ai programmi della organizzazione
mafiosa. Tutti questi elementi fanno pensare, a detta di chi scrive, che le
lettere del “Corvo” siano state scritte nel consapevole intento di preparare il
terreno per l’imminente tentativo di eliminazione fisica di Falcone. Piano poi
purtroppo riuscito quel maledetto 23 maggio del 1992. Un altro anno particolare,
altro spartiacque della storia del nostro Paese dove spuntò fuori l’ennesima
lettera anonima.
E la lettera del “Corvo 2”
spuntò tra le stragi di Capaci e via D’Amelio.
Una lettera di otto pagine dattiloscritte fu indirizzata a trentanove tra
personalità di livello nazionale, tra cui lo stesso Borsellino, scrive Damiano
Aliprandi il 17 Maggio 2018, su "Il Dubbio". L’anno 1992, come il 1989, è stato
l’ennesimo spartiacque nel mondo intero. Negli Stati Uniti inizia l’era – poi
finita tra pepate polemiche – del democratico Bill Clinton. È uno spartiacque in
Europa, dove entra tragicamente nel vivo il conflitto che dilanierà la Penisola
Balcanica e che si concluderà nel 1995. Perfino il cinema non sarà più lo
stesso. Nel 1992 verrà presentato prima al Sundance poi a Cannes, l’opera
d’esordio di uno stralunato cinefilo di Knoxville – ex impiegato di una
videoteca – chiamato Quentin Tarantino. Reservoir Dogs, nell’ottobre dello
stesso anno, viene rilasciato anche da noi col titolo Cani da rapina: non lo
vedrà praticamente nessuno. Quando poi la distribuzione opta per il titolo che
oggi tutti conosciamo – Le iene – anche il nostro pubblico si desta e comprende
che da lì in poi il cinema non sarà più lo stesso. Ma il 1992 è stato l’annus
horribilis della Repubblica italiana. Un vero e proprio terremoto si abbatte nel
nostro Paese, dove sotto le bombe della mafia esplode Tangentopoli. Crolla
l’impero delle luci e del benessere dalle mille contraddizioni della Prima
Repubblica, si dimette il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga e si
apre la strada per la discesa in campo di un imprenditore milanese, Silvio
Berlusconi, che due anni dopo sarà eletto. Ma è l’anno, appunto, della mafia
corleonese che teme di essere annientata, e cioè teme che sia intaccata la sua
potenza economica, che si fonda non solo sul traffico di droga, ma sulla
gestione degli appalti con la connivenza di alcuni imprenditori e politici anche
di rilievo nazionale. Un mafia che compie le stragi con il tritolo, uccidendo
prima Falcone e dopo Borsellino. Ma ci fu anche l’omicidio di Salvo Lima (capo
degli andreottiani in Sicilia), e non fu un caso isolato: il giorno prima a
Castellammare di Stabia viene ucciso Sebastiano Corrado, un consigliere comunale
del Pds e qualche giorno dopo cinque pallottole calibro 45 uccidono Salvatore
Gaglio, 50 anni, segretario della Federazione del Psi di Bruxelles. La seconda
lettera anonima, giornalisticamente chiamata “Corvo 2” apparve al cavallo tra la
strage di Capaci e via D’Amelio. I Ros, in quel convulso periodo, cercavano chi
gli consentisse di lavorare efficacemente, mentre l’organismo di punta della
magistratura nella lotta contro l’organizzazione mafiosa, la procura della
Repubblica di Palermo, era quasi all’impotenza operativa, preda al suo interno
di forti contrasti: un “covo di vipere” secondo il parere espresso da
Borsellino, nel giugno 1992, ai colleghi Camassa e Russo. Affermazione che non
costituiva solo lo sfogo isolato di una persona delusa, visto che in
quell’estate, tra i magistrati della Procura di Palermo, si manifestarono aspre
polemiche culminate in un documento, reso pubblico e sottoscritto da un numero
significativo di sostituti, che evidenziava una forte contestazione nei
confronti dell’allora procuratore capo Giammanco in relazione alla gestione
dell’Ufficio. Una lettera anonima che spunta in questo periodo particolare,
quando Borsellino riteneva che potesse esserci un legame diretto tra l’attentato
di Capaci e la più recente attività di Falcone; e pensava che la continuazione
dell’indagine mafia- appalti, che i Ros avevano iniziato con Falcone, avrebbe
comunque rappresentato un salto di qualità nel contrasto a Cosa nostra. Parliamo
di una lettera di otto pagine dattiloscritte indirizzata a trentanove tra
personalità di livello nazionale, tra cui lo stesso Borsellino. Otto pagine che
ricostruiscono uno scenario siciliano, che indicano piste investigative, che
invitano a seguire con più attenzione certi indizi, che gettano ombre su alcuni
uomini importanti. Una lettera che fa tremare Palermo e i palazzi romani. Questa
volta si firma con un “noi”. L’hanno messa in circuito fra il 22 e il 23 di
giugno, per una decina di giorni solo sussurri e bisbigli. Poi, improvvisamente,
un giornale, La Sicilia di Catania, decide di pubblicare ampi stralci di
quell’anonimo. Le otto pagine sono diventate un ‘ caso’, tanto da far scaturire
un’interrogazione parlamentare da parte del senatore Lucio Libertini di
Rifondazione Comunista. Gli anonimi del “Corvo 2” riportano il tentativo della
Dc di rinnovare il partito liberandosi di Andreotti. In particolare facevano
riferimento esplicito all’attività degli onorevoli Sergio Mattarella e Calogero
Mannino volta a scalzare il potentato politico detenuto in Sicilia da Giulio
Andreotti, attraverso l’onorevole Salvo Lima, in vista delle elezioni politiche
del 5 e 6 di aprile di quell’anno. Entrando nei particolari l’anonimo
descriveva, tra gli altri, anche di un incontro, facilitato dal professionista
palermitano Pietro Di Miceli, che sarebbe avvenuto in una chiesa di San Giuseppe
Iato, tra Mannino e Salvatore Riina nel corso del quale gli accordi raggiunti
avrebbero anche previsto l’eliminazione fisica dell’onorevole Lima. I
conseguenti sviluppi dell’intesa avrebbero poi determinato, in successione di
tempo, anche l’assassinio di Falcone. Una lettera, insomma, che – come fu per
quella precedente che infangò Falcone e persone dello Stato a lui vicine -, fa
accuse pesantissime, a tratti deliranti. Tanto da sostenere che Totò Riina si
sarebbe messo d’accordo per farsi arrestare in cambio di alcuni punti da
rispettare. Ricorda qualcosa? Sì, sembra il prototipo del teorema giudiziario
sulla presunta trattativa stato- mafia che si basa, appunto, su un papello
(inattendibile quanto la lettera anonima) con diversi punti che lo Stato avrebbe
dovuto rispettare. Ma come accade in tutte quelle lettere dove dietro c’è la
mano di qualcuno che vuole depistare, c’è un mix di qualche notizia vera, di
pubblico dominio, insieme ad altre verosimili e ad altre visibilmente surreali.
Ad esempio – noti- zia vera – viene citato mafia- appalti, comprese alcune
aziende coinvolte, facendo riferimento ai magistrati di Palermo che, di fronte a
un informativa di 900 pagine, si sono limitati ad arrestare persone di basso
profilo. Ma – c’è da dire – questa era roba nota visto che montò una polemica
pubblica su quell’episodio. Chi è stato l’autore della lettera? La serie di
considerazioni e notizie di dettaglio riportate nel testo attribuito al “Corvo
2”, vennero esaminate dagli organismi delegati alle indagini che, in data 2
febbraio 1993, trasmisero, a firma del questore Achille Serra e del generale
Antonio Subranni, l’informativa n. 123G/ 628271/ 100B protocollo del Servizio
centrale operativo e n. 10102/ 14 protocollo Ros. Il documento prendeva in esame
dettagliatamente gli sviluppi della vicenda, nel cui ambito anche il generale
Mario Mori fece una personale attività d’indagine, ricostruendone gli antefatti
e individuando l’estensore dell’anonimo, ma solo come dato probabilistico, in
tale Angelo Sciortino, le cui affermazioni avevano trovato “elementi di notevole
somiglianza” nel contenuto dell’anonimo stesso, con quello riferito da una fonte
informativa del Sisde, denominata “Spada“, e da altre risultanze testimoniali
acquisite. Il Sisde però non comunicò mai il nome della sua fonte. Quello che
sappiamo è che le inchieste delle procure di Caltanissetta e Palermo non
portarono all’accertamento e all’attribuzione di specifiche responsabilità. Le
rivelazioni anonime, però, hanno avuto il potere di distogliere per un po’ di
tempo le energie giudiziarie e di polizia dalla caccia agli autori della strage
di Capaci. Il dato certo, come documentato da questa inchiesta de Il Dubbio, è
che negli ultimi giorni di vita, Borsellino era impegnato con tutte le sue forze
a individuare mandanti ed esecutori della strage di Capaci e la sua attenzione
particolare era rivolta all’inchiesta mafiaappalti, a suo tempo avviata da
Giovanni Falcone, che lui riteneva l’indagine da sviluppare prioritariamente. A
differenza di quanto sostenuto dai titolari dell’inchiesta sulla
trattativa Stato– mafia, l’attività professionale di Borsellino era concentrata
su quello, e nessun cenno, anche indiretto, egli aveva fatto a ipotesi di
trattative o contatti tra istituzioni dello Stato e “Cosa nostra”.
Un pentito accusa la Procura di Palermo:
«Così favorì la mafia». Il pentito Giuseppe Li Pera
racconta perché la procura di Palermo non volle ascoltare la sua versione
sull’inchiesta mafia-appalti, scrive Damiano Aliprandi il 23 Maggio 2018 su "Il
Dubbio". «I magistrati della Procura di Palermo non mi hanno voluto ascoltare
sui fatti». A denunciarlo è Giuseppe Li Pera, allora capo area per la regione
Sicilia della società Rizzani de Eccher, anch’essa coinvolta
nell’inchiesta mafia- appalti, condotta dai Ros capitanati dal generale Mario
Mori e seguita fin dall’inizio dal magistrato Giovanni Falcone, che la coordinò
sino al giorno della sua morte. A distanza di 26 anni, ancora rimane un mistero
la ragione per cui Giovanni Falcone fu ucciso. Così come il mistero rimane per
le sorti di Paolo Borsellino che, prima di essere dilaniato dal tritolo,
attendeva di avere in mano la delega per Palermo: in tale modo avrebbe potuto
gestire anche l’inchiesta mafia- appalti e sarebbe potuto arrivare fino in
fondo. Diverse sono le testimonianze che attestano il suo interessamento, a
partire da quando, nell’incontro riservato con Mori e De Donno per parlare
dell’inchiesta, ribadiva la sua convinzione che ci fosse un legame con la strage
di Capaci. «Nel salutarci – testimoniò Mori – raccomandò la massima riservatezza
sull’incontro, in particolare nei confronti dei colleghi della Procura di
Palermo». Ma ritorniamo a mafia- appalti. L’indagine dei Ros era nata sotto la
spinta del magistrato Giovanni Falcone, tant’è vero che veniva informato delle
indagini ancora prima che fosse redatto il dossier. Esattamente due furono le
informative dei Ros che vennero consegnate a Falcone, ma anche a Lo Forte che
era allora Sostituto Procuratore a Palermo: l’una datata 2 luglio 1990 e l’altra
5 agosto del 1990. Informative, soprattutto quella del 2 luglio, nelle quali
erano contenuti espliciti riferimenti ad asserite cointeressenze, di natura
illecita, di interi gruppi politici oltre che riferimenti a singoli esponenti di
rilievo nazionale. Quindi non solo Falcone, ma anche Borsellino e i successivi
altri suoi colleghi che si sarebbero occupati delle sorti dell’inchiesta mafia-
appalti, erano a conoscenza del contenuto della prima informativa di carattere
generale, che fu depositata proprio dietro volere di Falcone, in attesa di altri
approfondimenti soprattutto in merito alla posizione dell’ente regionale Sirap
che gestiva i soldi per gli appalti. Fu infatti in un momento successivo che i
Ros, solo nell’informativa “Caronte”, approfondirono la posizione della Sirap
nell’ambito dei fatti dell’inchiesta. In seguito alla prima informativa, vennero
emessi solamente cinque mandati di cattura rispetto ai 44 personaggi coinvolti.
Ed è in questo momento che si inserisce il geometra Li Pera, uno dei coinvolti
nei fatti dell’indagine, che decise di collaborare con la giustizia. Ma, a detta
sua, non venne ascoltato dai magistrati di Palermo. In effetti, noi de Il
Dubbio abbiamo potuto verificare la circostanza nel provvedimento di
archiviazione del Gip Gilda Loforti del Tribunale di Caltanissetta, dove viene
confermata la denuncia che Li Pera espose al Sostituto Procuratore Felice Lima.
Tra le denunce, anche il fatto che i magistrati di Palermo avrebbero fatto
pervenire il rapporto dei carabinieri del Ros su mafia- appalti nelle mani degli
avvocati, ancora prima che scattasse il blitz. Accusa che anche lo stesso
carabiniere dei Ros De Donno fece nei confronti dei magistrati. Scaturirono
querele vicendevoli e nell’ordinanza del Gip Loforti, dove entrambe furono
riunite e finirono per essere archiviate, si legge: «Non può affatto escludersi,
in via d’ipotesi, che nella illecita divulgazione delle notizie e dei documenti
riservati oggetto del presente procedimento, possano essere stati coinvolti, o
per denaro o in ragione degli asseriti rapporti di amicizia con svariate
personalità politiche, i magistrati odierni indagati». Un’ordinanza che getta
ombre, addirittura sull’ipotesi che gli inquirenti possano essere stati
coinvolti per denaro o ragioni d’amicizia. Ora Giuseppe Li Pera vuole rinnovare
le sue obiezioni e ha scelto di rispondere alle nostre domande: occorre
rammentare a questo proposito che egli già altre volte, davanti agli inquirenti,
aveva lamentato che la Procura di Palermo avesse usato con lui una mano più
pesante rispetto a quella adottata nei confronti del suo titolare e dei suoi
dirigenti, seppur a fronte del fatto che la maggior parte dell’impianto
accusatorio fosse composto da intercettazioni telefoniche. No, ma solo dopo
alcuni mesi, quando ebbi la certezza che la Procura non voleva sentirmi. Dopo il
mio arresto avevo studiato le carte in mio possesso ed avevo deciso di mettere
alla prova la buona fede dei Pm. Io partivo dall’assunto che era assurdo che i
Pm avessero potuto separare la mia posizione da quello del mio titolare e dei
miei dirigenti, e al primo interrogatorio di garanzia avevo predisposto una
trappola. In quell’interrogatorio avevo citato la parola chiave “PASS”, che è il
meccanismo della illecita spartizione degli appalti, e dissi a me stesso, se mi
chiedono che cosa vuol dire il sistema dei PASS, chi e perché si usa, vuol dire
che non hanno capito di cosa parla il Dossier dei Ros e quindi mi sarei messo a
disposizione per chiarire tutto, se invece non mi chiedono cosa vuol dire PASS,
significa che hanno fatto una scelta politica di proteggere i potenti sia essi
imprenditori che politici e far volare solo gli stracci. Quando poi per due
volte si rifiutarono di sentirmi ebbi la certezza che la loro decisione era
irrevocabile.
Nel 1992 venne sentito dal Pm Felice Lima di
Catania? Perché? Aveva fatto già qualche denuncia in quell’occasione?
«No. Feci
mandare un esposto anonimo. Ricordo che di primo acchito il Pm Lima non era
convinto della bontà delle mie affermazioni, cosicché io gli dissi “dottor Lima
non si preoccupi, se lei non trova le prove di quanto io dico, ed io le dico
quali prove cercare e dove cercarle, amici come prima”. Il dottor. Lima,
ovviamente trovò tutte le prove necessarie, non solo, chiese anche l’arresto di
22/ 23 persone tra cui, se la memoria non mi inganna, anche di due Pm di
Palermo, solo che l’allora Procuratore Capo di Catania gli levò la delega e lo
mandò, da brillante Pm antimafia ad occuparsi di divorzi».
Lei fece una denuncia per corruzione in atti
giudiziari nei confronti di quattro magistrati, uno tra i quali fu il
Procuratore Giammanco. Ne scaturì un’indagine? È a conoscenza di quanto emerse
in seguito?
«Certo, io ho
sempre sostenuto e ne sono sempre più convinto che i Pm di Palermo decisero a
tavolino chi processare e chi salvare. Per me neanche un chirurgo avrebbe potuto
separare la mia posizione da quella del mio titolare e dei miei dirigenti.
Ovviamente quando si ufficializzò la mia collaborazione con la Procura di
Catania, i Pm di Palermo si scatenarono contro. Le potrei fare decine di esempi,
ma gliene cito uno solo. I Pm di Palermo avevano chiesto in dodici diversi
interrogatori a Leonardo Messina, dell’operazione “LEOPARDO”, se mi conosceva, e
lui per ben dodici interrogatori affermò di non avermi mai visto, finchè qualche
giorno dopo l’ufficializzazione della mia collaborazione con il dottor Lima,
improvvisamente il Messina è folgorato sulla via di Damasco e dice testualmente:
“Lo conosco e sono andato con lui a portare una tangente di 100 milioni di lire
al capo mafia di Pietraperzia, ( ovviamente morto), per il lotto dell’autostrada
per Pietraperzia, vinto dalla Rizzani de Eccher”. Va innanzitutto detto che non
esiste un’autostrada per Pietraperzia, ma uno scorrimento veloce Caltanissetta –
Gela ed era previsto uno svincolo per Pietraperzia. Ricordo che all’epoca dei
fatti io ero il capocommessa più anziano in Sicilia della Rizzani de Eccher.
Bene il signor Messina alla domanda del mio legale, il compianto avvocato Pietro
Milio, che gli chiese in che anno avvenne questa dazione di denaro rispose a
dicembre 1991. “Ma a dicembre 1991 il geometra Li Pera era già arrestato”,
ribatté Milio. Rispose che allora è stato nel 1990. Ma quella gara non venne
esperita che a giugno/ luglio 1991, quindi a che titolo si andava a pagare una
tangente per un lavoro non ancora aggiudicato? Ma la cosa più umoristica è che
la Rizzani de Eccher a giugno/ luglio si aggiudicò un lotto della Caltanissetta
– Gela a 60 Km dallo svicolo di Pietraperzia. Chiaro che il tutto era stato
imboccato al Messina con molta superficialità. Per rispondere, infine, alla sua
domanda, sì in effetti ci furono due indagini, la prima fu archiviata e poi fu
riaperta a seguito della denuncia dell’allora Capitano De Donno. La Gip
dottoressa Gilda Loforti archiviò l’indagine dopo alcuni anni, ma la frase più
gentile che usò nei riguardi dei suoi colleghi di Palermo fu “hanno indagato su
se stessi e si sono autoassolti”».
In questi giorni ricorre l’anniversario della
strage di Capaci. Una ventina di anni fa lei fu ascoltato dagli inquirenti e in
un’occasione manifestò delle perplessità sulla dinamica, relativamente alla
preparazione della strage, così come era stata riferita da Giovanni Brusca. A
che titolo venne sentito dagli inquirenti?
«Volevano
sapere se durante il periodo della mia detenzione avevo sentito notizie relative
all’attentato, la mia risposta fu negativa».
Cosa non la convinceva nella dinamica della
strage di Capaci, al punto da manifestare le sue perplessità pur a fronte alle
ricostruzioni di Giovanni Brusca?
«Premetto che
sono un discreto esperto di dinamite, avendo lavorato per tanti anni in Italia
ed all’estero in cantieri in cui si utilizzava la dinamite per lo scavo di
gallerie, di trincee, per l’apertura di cave etc., per cui posso tecnicamente
affermare che quanto dichiarato da Brusca Giovanni, circa la preparazione
dell’attentato, a mio modesto avviso, non è convincente».
Alla luce del suo coinvolgimento nella vicenda
e sulla base delle sue conoscenze dei fatti e dello sviluppo dell’inchiesta
mafia- appalti, conosce un qualche legame tra l’uccisione di Giovanni Falcone e
la circostanza che stesse conducendo l’inchiesta e che volesse portarla in
fondo?
«Io sono
convinto che l’indagine su mafia- appalti non sia il vero motivo della strage
“Falcone”, ci deve essere qualcosa di più grave e di più devastante per la vita
della Repubblica Italiana. Le rivelo un particolare che pochi sanno. Il
compianto avvocato. Pietro Milio stava scrivendo un libro, che purtroppo fu
pubblicato dopo la sua morte con il titolo “Giustizia Assistita”. Bene, io ebbi
l’occasione di visionare le prime bozze ed io collaborai anche alla stesura di
un capitolo, quello relativo alla strage di Capaci, dove contestai pezzo per
pezzo le affermazioni di Giovanni Brusca, grande fu la mia sorpresa nel vedere
che nel libro pubblicato questo capitolo era sparito. Come era sparito il
capitolo dove Milio si chiedeva cosa era venuta a fare l’Fbi, le sue testuali
parole erano “l’Fbi è venuta a cercare le prove o è venuta a cancellarle?”»
Che lei sappia, con riguardo alla strage di
Capaci, qualche potere, politico o giudiziario, poteva sapere o aver agito in
favore della Mafia, anche inconsapevolmente, considerati gli interessi economici
e politici in gioco?
«Io sono sempre
stato convinto, e lo era anche il compianto avvocato Pietro Milio, che il ruolo
della mafia in questa strage sia stata solo quella di esecutore, ma i mandanti
sono altri. Lui parlava spesso di un collegamento tra la strage di Capaci,
l’attentato al giudice Palermo, che trent’anni fa costò la vita ad una mamma ed
ai suoi due gemellini, ed al fallito attentato dell’Addaura».
Scarpinato: «Non ci diranno mai cosa c’è
dietro le stragi». Le parole del procuratore generale
di Palermo, scrive Damiano Aliprandi il 22 Maggio 2018 su "Il Dubbio".
«È inquietante che ci sono tante, troppe cose, e quello che ancora più
inquietante è che ci sono tante persone che sanno e che continuano a tacere.
Perché?», ha detto il Procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato durante
un incontro organizzato in occasione delle commemorazioni per ricordare i
magistrati uccisi dalla mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Poi fa i
nomi. «I Graviano, ad esempio, hanno ancora 50 anni e potrebbero rifarsi una
vita, eppure stanno in silenzio. C’è una storia inquietante anche da questo
punto di vista». Eppure, non è del tutto vero. Anzi, adesso il silenzio è stato
imposto dai pm antimafia. Il caso vuole che lo scorso 12 dicembre, Fiammetta
Borsellino – figlia minore del giudice assassinato nell’eccidio di via D’Amelio,
il 19 luglio ’ 92 – è andata a fare un colloquio con i fratelli Graviano al 41
bis, nei due penitenziari di massima sicurezza. Qualcosa le hanno detto.
Giuseppe Graviano ha fatto un piccolo accenno a Berlusconi è di quando faceva la
bella vita a Milano. «Lo dicono tutti che frequentavo Berlusconi – ha lanciato
lì a sorpresa – più che io era mio cugino che lo frequentava». Ma finisce lì,
nessun riferimento alle stragi come forse altri ben speravano. Infatti la stessa
Fiammetta non era minimamente interessata e ha cambiato discorso, perché quello
che le premeva è la verità sull’omicidio di suo padre. A quel punto – grazie a
un articolo del Corriere della Sera a firma di Giovanni Bianconi – veniamo a
sapere cosa le rispose: «Lei ha fiducia della magistratura attuale? Come mai non
hanno scoperto ancora chi ha ucciso la buonanima di suo papà?». Fino a diventare
quasi aggressivo: «A nessuno interessa far emergere la verità della morte di suo
padre, sono due cose distinte con la morte di Giovanni Falcone… A lei non
interessa sapere chi ha ucciso suo papà… se qualcuno non era amico di suo papà…
meglio morire e non far emergere la verità». Ma non solo, il fratello più
grande, Filippo, dopo averle detto di essere estraneo alle stragi, dopo varie
insistenze a dire la verità, le ha detto: «Io una volta ho detto ai magistrati
“se dovessi dire la verità sulla mia vita passata… voi mi rimandereste in cella
come per dire ci sta facendo perdere tempo”». I Graviano, quindi, hanno
cominciato a parlare, dicendo qualcosa di diverso rispetto alla narrazione
vigente. Cosa è accaduto? Le Procure antimafia di Palermo, Caltanissetta e
Firenze, hanno detto «no» alla possibilità di un nuovo incontro tra Fiammetta
Borsellino e Filippo Graviano, perché potrebbero essere possibili depistaggi.
Ritornando alle affermazioni di Scarpinato, quindi no, i Graviano si stavano
piano piano confidando con la figlia di Borsellino e i magistrati antimafia
stessi hanno deciso che si tratta di depistaggio. Eppure, non si spiega come mai
sono state usate per il processo sulla presunta trattativa Stato- mafia le
intercettazioni ambientali fatte a Graviano, quando sapeva benissimo – anche in
quel caso – di essere ascoltato. Fiammetta Borsellino, che ha appreso in via
ufficiosa del no delle procure antimafia, ha lasciato questa dichiarazione:
«Hanno ignorato la mia richiesta di un altro incontro e questa è la cosa
peggiore che si possa fare». Sempre Scarpinato, durante il suo intervento,
ripercorre anche altre tappe dolorose della storia d’Italia citando la strage di
Portella della Ginestra del 1947 e di quella di Bologna, parlando, appunto, dei
vari depistaggi messi in atto. Da lì, cita dei possibili documenti spariti e
della famosa agenda rossa di Paolo Borsellino e di possibili infiltrati nella
Polizia. Da notare che, questa volta, non cita i Ros che pure li ha inquisiti,
ma soltanto la polizia. Ma non cita nemmeno le preoccupazioni di Borsellino nei
confronti di alcuni suoi colleghi e il suo interessamento su mafia- appalti,
tanto da discuterne riservatamente con i Ros in una caserma, anziché in procura.
Poi Scarpinato parla di Falcone e il fatto che sia stato ostacolato tanto da
andarsene via da Palermo – a causa del suo interessamento dell’omicidio
dell’allora presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella, fratello del
Capo dello Stato, Sergio. Vero, era interessato, anche perché Falcone era
Procuratore aggiunto. Però Scarpinato si è dimenticato di dire che quelli erano
gli stessi anni in cui Falcone seguiva attentamente l’inchiesta dei Ros su
mafia- appalti che avrebbe colpito il cuore di Cosa nostra: ovvero i soldi
derivati dalla gestione degli appalti, anche di rilievo nazionale, con l’ausilio
anche di politici importanti. Inchiesta giudiziaria che come sappiamo fu poi
archiviata definitivamente il 14 agosto del 1992, meno di un mese dalla morte di
Borsellino. Quando quest’ultimo era ancora in vita, a chiederne l’archiviazione
è stato lo stesso Scarpinato assieme al collega Lo Forte.
Lei però dica perché ha archiviato mafia-
appalti (Se non è vero, smentisca). Scarpinato ha
firmato la richiesta? Scrive Piero Sansonetti il 22 Maggio 2018 su "Il Dubbio".
Il Procuratore generale Scarpinato, come sempre, pone dei problemi molto seri,
che sarebbe sbagliato nascondere. Nella storia d’Italia ci sono dei buchi neri
che riguardano le stragi rimaste senza colpevoli, e riguardano anche i rapporti
che organizzazioni criminali come la mafia hanno avuto con l’economia. Sappiamo
poco di questi argomenti. Naturalmente la storia d’Italia non è solo questo.
Come spiega molto bene il dottor Peppino Di Lello nel suo intervento che
raccontiamo ampiamente su questo numero del giornale, la storia d’Italia è fatta
soprattutto di lotte, di movimenti, di conflitti, di battaglie parlamentari, di
impegni dei partiti, dei sindacati, delle organizzazioni popolari. Servono nuove
indagini per capire cosa c’è dentro i buchi neri? Può darsi. Purché si facciano
seriamente e sulla base di fatti reali e accertati, non di fantasie, di ipotesi
letterarie e illogiche. Oppure di tesi politiche confezionate a tavolino per
colpire qualche avversario. Cosa è successo davvero nel ’ 92 e nel ’ 93 quando
furono uccisi Falcone e Borsellino e quando poi la mafia organizzò varie stragi
nella Penisola? E perché furono uccisi Falcone e Borsellino? In questi giorni
noi abbiamo pubblicato una ricostruzione di ciò che successe in quei mesi
insanguinati. E soprattutto ci siamo occupati del dossier “mafia e appalti”,
preparato dal generale Mori, sul quale lavorò Falcone e avrebbe poi voluto
lavorare Borsellino. Che non fece in tempo. Perché fu ucciso. Quel dossier, fu
archiviato pochi giorni dopo la morte di Borsellino. La sua archiviazione era
stata chiesta pochi giorni prima della morte di Borsellino dal dottor Lo Forte e
dal dottor Scarpinato. Perché? Fu un errore molto grave. Archiviando quelle
indagini, alle quali Falcone teneva moltissimo, fu buttato a mare un pezzo molto
importante dell’impegno antimafia dello Stato italiano. Oggi il dottor
Scarpinato può dirci perché chiese quella archiviazione? Può spiegarci se
ricevette pressioni? E perché il dossier non arrivò mai a Borsellino? Nessuno
dubita della buonafede di Scarpinato, neppure lontanamente, ma se lui stesso
sollecita trasparenza sarebbe giusto innanzitutto che fosse lui stesso a offrire
trasparenza, no? Se invece non è stato lui a firmare la richiesta di
archiviazione, allora temo che mi prenderò una querela. Ma a me risulta che fu
lui a firmare.
Il “metodo Falcone”,
scrive il 15 maggio 2018 su "La Repubblica" Attilio Bolzoni. Hanno lavorato con
lui, fianco a fianco fin da quando ha iniziato ad ideare quel capolavoro
d'ingegneria giudiziaria che è stato il maxi processo a Cosa Nostra. Con loro ce
n'erano altri che non ci sono più - come Rocco Chinnici e i poliziotti Beppe
Montana e Ninni Cassarà, o come Antonino Caponnetto e Antonio Manganelli - ma
quelli che ritroverete qui lo possono raccontare ancora oggi. L'hanno incontrato
tutti nel piccolo bunker del Palazzo di Giustizia di Palermo, hanno visto
nascere sulla sua scrivania le prime e più rilevanti indagini antimafia, hanno
accompagnato per almeno un decennio la straordinaria avventura di un magistrato
italiano. Dopo le celebrazioni fastose del venticinquesimo anniversario del 2017
per commemorare le vittime di Capaci e di via D'Amelio, un anno dopo vogliamo
ricordare Giovanni Falcone attraverso voci che portano memoria diretta del
giudice, del suo talento investigativo, della sua passione civile, della forza
delle sue idee e - per riprendere le parole di Giuseppe D'Avanzo -
dell'«eccentricità rivoluzionaria del suo riformismo». In questa pagina
annunciamo il contenuto della serie del blog Mafie che ogni mattina è su
Repubblica.it e che, da oggi e per quasi due settimane, è riservato a quello che
tutti indicano come il "metodo Falcone”. Fuori dalla retorica e fuori da
quell'enfasi che ha snervato e a volte anche sfregiato la figura di quello che è
stato un "italiano fuori posto in Italia" (come lo sono stati Paolo Borsellino,
Pio La Torre, Carlo Alberto dalla Chiesa e tanti altri caduti in Sicilia),
queste sono testimonianze che ci ripropongono il Giovanni Falcone magistrato e
la sua sapienza giuridica. Cosa era quello che poi è stato definito il suo
"metodo”? Cosa ha inventato dalla fine degli anni '70 di tanto fondamentale in
quella piccola stanzetta del tribunale siciliano? Come è cambiata - grazie a lui
- la storia della lotta alla mafia nel nostro Paese nonostante le umiliazioni
che ha dovuto subire da vivo e poi anche da morto? Ce lo spiegano una dozzina di
personaggi, tutti rappresentanti delle istituzioni che nelle fasi più
significative della sua esistenza gli sono stati molto vicini. Giudici,
poliziotti, carabinieri, finanzieri, impiegati civili del ministero della
Giustizia. Alcuni ci hanno offerto un contributo inedito, altri hanno preferito
ripescare nei loro archivi un testo già dedicato al ricordo di Falcone e della
sua attività. Ciascuno di loro ha raccontato un "pezzo” di una vicenda siciliana
iniziata nei primi mesi del 1980 e in parte chiusa con le stragi del '92. Tante
analisi per spiegare la “rivoluzione” avvenuta a Palermo. Nel piccolo bunker
hanno avuto anche origine i reparti speciali investigativi italiani come lo Sco
della Polizia di Gianni De Gennaro e il Gico della Finanza. E anche il Ros dei
carabinieri. Proprio dalla visione ampia degli scenari mafiosi che aveva quel
giudice e dalla necessità di oltrepassare con le indagini i confini provinciali,
Falcone ha avuto l'idea di creare gruppi super-specializzati che potessero
operare con grande libertà di manovra su tutto il territorio nazionale. Suo
interlocutore principale nell'Arma, al tempo era il capitano Mario Parente, che
poi del Raggruppamento operativo speciale ne è diventato il comandante. Una
stanza di Tribunale che è stato un “laboratorio” della lotta alla mafia in
Italia e che ha formato funzionari dello Stato che hanno dato grande prova di sé
nei decenni successivi. Tra gli autori di queste testimonianze i magistrati del
famoso pool (Giuseppe Di Lello, Leonardo Guarnotta, Ignazio De Francisci,
Gioacchino Natoli), l'ex presidente del Senato Pietro Grasso che il maxi
processo l'ha "visto” come giudice a latere della Corte di Assise, Giuseppe
Ayala che ha sostenuto l'accusa. E il capitano della Guardia di Finanza Ignazio
Gibilaro, oggi comandante delle Fiamme Gialle in Sicilia, l'ufficiale dei
carabinieri Angiolo Pellegrini che insieme a Ninni Cassarà e Beppe Montana firmò
il rapporto "Michele Greco+161” che diede origine al maxi processo, il giovane
funzionario della Criminalpol Alessandro Pansa che negli anni a seguire sarà
nominato prefetto e diventerà il capo della polizia italiana. C'è anche la
preziosa testimonianza di Guglielmo Incalza, il dirigente dell'"Investigativa”
della squadra mobile di Palermo, il primo poliziotto che ha collaborato con
Falcone nell'indagine sugli Spatola e gli Inzerillo. Un articolo è firmato da
Vincenzina Massa, giudice palermitana che ha iniziato la sua carriera come
uditore proprio nella stanza di Falcone. Un altro ricordo è di Giovanni
Paparcuri, il fidato collaboratore informatico del giudice che ha voluto un
museo in onore di Falcone e Borsellino nei locali dove i due lavoravano. E'
stato Paparcuri, qualche mese fa, a suggerirci di dedicare una puntata del blog
al "metodo Falcone”. Una buona idea.
Quella “squadra speciale”
nel bunker delle indagini, scrive
il 16 maggio 2018 su "La Repubblica" Ignazio Gibilaro - Generale della Guardia
di Finanza. Nella tarda serata del 9 novembre 1983, il nuovo capo dell’Ufficio
Istruzione di Palermo fece il suo ingresso in quella che sarebbe stata la sua
casa per i successivi quattro anni, la “Caserma Cangialosi” della Guardia di
Finanza. La scelta di alloggiare Antonino Caponnetto in un'austera foresteria
militare era stata imposta dalla terribile eco dell’autobomba che pochi mesi
prima aveva ucciso Rocco Chinnici, suo predecessore al vertice dell’Ufficio
giudiziario palermitano. Ebbene, il destino (o forse la Provvidenza) volle che
proprio tra le sicure mura dell’ex convento accadesse un episodio determinante
per il futuro sviluppo di quello che diverrà “il metodo Falcone”. Infatti, nel
dicembre di quell’anno, passeggiando nel chiostro dell’antico complesso
domenicano, Caponnetto ed il colonnello Gaetano Nanula concordarono di dare
concreta attuazione ad un’idea di Giovanni Falcone: distaccare presso i locali
dell’appena costituito “pool antimafia” un piccolo nucleo di investigatori del
Nucleo Regionale di Polizia Tributaria che fossero in grado di procedere
all’esame dell’enorme quantità di documenti bancari sequestrati nell’ambito di
tutte le principali inchieste su Cosa Nostra. La richiesta di Falcone traeva
origine dall’esperienza che il giudice aveva maturato allorchè, sul finire degli
anni ’70, Rocco Chinnici gli aveva affidato l’istruttoria contro Rosario
Spatola. Lo stesso magistrato ha più volte ricordato che proprio durante tale
inchiesta, mentre ricostruiva il traffico di eroina gestito dalle famiglie
mafiose tra la Sicilia e gli Usa, si era convinto che nelle banche dovevano pur
essere rimaste delle tracce contabili delle ingenti somme scambiate e così, per
“seguire il denaro”, diede inizio alle prime indagini bancarie nei confronti dei
clan. Ma ben presto Falcone giunse all’ulteriore consapevolezza che gli esiti
dell’incrocio dei flussi bancari con le risultanze delle tradizionali indagini
di polizia e con le dichiarazioni dei “pentiti”, dovevano essere ulteriormente
integrati con delle approfondite investigazioni sui reticoli patrimoniali e
societari riconducibili ai criminali ed ai loro insospettabili prestanomi. Da
qui la consapevolezza che, per essere efficaci, le attività di acquisizione,
analisi e rielaborazione di tali enormi masse di dati dovevano essere condotte
in modo sistematico ed organico, avvalendosi di personale altamente qualificato.
Fu proprio in tale prospettiva che, nei primi giorni del gennaio 1984, i
marescialli Angelo Crispino e Paolo Scimemi si insediarono a pochi metri
dall’ufficio di Falcone, nello stanzone in cui era stata accatastata
un’impressionante montagna di documenti contabili, verbali di interrogatori e
rapporti di polizia. Nel giro di poche settimane i due sottufficiali furono
raggiunti da altri finanzieri, finendo con il costituire una vera e propria
“squadra speciale” che, da quel momento in poi, lavorò fianco a fianco dei
giudici istruttori dello storico pool sino al suo definitivo scioglimento.
Questi militari vennero inizialmente selezionati tra gli esperti della “Sezione
Economia e Valuta” del Nucleo di Palermo ed operarono sotto la direzione di un
vero segugio dell’antiriciclaggio, il capitano Carmine Petrosino.
Successivamente la responsabilità della squadra fu attribuita a me, giovane
capitano che avevo già collaborato con diversi autorevoli magistrati di Torino,
Milano e Palermo in una serie di indagini concernenti un imponente traffico di
eroina proveniente dalla Turchia e destinata all’Europa ed agli USA. Ebbene,
proprio in concomitanza del cambio di comandante, la squadra del pool divenne
parte integrante di quella “Sezione Indagini Economico-Fiscali Criminalità
Organizzata” che è stata la prima unità specializzata creata dalla Guardia di
Finanza per il contrasto alla criminalità mafiosa, nonché la storica
progenitrice degli attuali G.I.C.O. e S.C.I.C.O.. In breve tempo il team
investigativo assunse il ruolo di propulsore delle attività di polizia svolte
sul campo dagli altri componenti della Sezione, trasformandosi anche in una
sorta di cinghia di trasmissione tra i giudici istruttori palermitani e tutti i
reparti del Corpo progressivamente lanciati sulle tracce del black money, in
Italia ed all’estero. Fu così realizzato un immane lavoro di ricostruzione della
multiforme ragnatela di rapporti patrimoniali e societari che avviluppava coloro
che venivano progressivamente individuati come “soldati” o “capi militari”
dell’organizzazione mafiosa; i magistrati furono pertanto in grado di
“cementare” con immodificabili prove documentali le ben più volubili
dichiarazioni testimoniali, giungendo anche all’individuazione di nuove filiere
di soggetti (talora del tutto insospettabili) legati agli “uomini d’onore” da
non più negabili interessi affaristici. Un mero dato numerico può forse
esemplificare la straordinaria rilevanza delle indagini economico-finanziarie
svolte: ben 4 dei 40 volumi dell’ordinanza di rinvio a giudizio del “I° Maxi
processo” sono costituiti dagli esiti delle indagini bancarie e 19 degli
ulteriori 22 volumi di allegati sono composti dalla relativa documentazione.
Concludendo questo personale ricordo della “squadra silenziosa” di giovani
Fiamme Gialle che ho avuto il privilegio di comandare, mi permetto di riportare
alcune frasi tratte da una lettera scritta da Giovanni Falcone il 6 novembre
1989: “Nel lasciare il mio incarico di Giudice Istruttore sento di esprimere il
mio più vivo apprezzamento per la preziosa collaborazione svolta in questi anni
dai militari del Nucleo Regionale P.T. di Palermo distaccati presso questo
Ufficio. Senza l’apporto della Guardia di Finanza non sarebbe stato possibile
effettuare complesse e numerose indagini bancarie e patrimoniali che hanno
contribuito a far ottenere notevoli risultati giudiziari. Tali indagini, svolte
nell’ambito di importanti procedimenti contro la criminalità organizzata, hanno
posto in evidenza l’elevata professionalità dei militari operanti e, tenuto
conto della notevole pericolosità sociale dei soggetti nei confronti dei quali
sono state effettuate, il loro alto senso del dovere e spirito di sacrificio”.
Un uomo e un cambiamento
epocale,
scrive il 17 maggio 2018 su "La Repubblica" Alessandro Pansa - Prefetto della
Repubblica. L’arricchimento del mio bagaglio professionale grazie all’esperienza
che mi ha visto collaborare con Giovanni Falcone in molte inchieste di
particolare rilievo, specie sul piano internazionale, è stato enorme.
L’esperienza umana forse lo è stata anche di più, ma questa resta nella sfera
personale che conservo come mio ricordo. Le inchieste del giudice Falcone, pur
avendo come campo di analisi il mondo del crimine, coinvolgevano direttamente
anche quello della criminalità economica. In tale contesto venivano alla luce
costantemente intrecci, sovrapposizioni o identificazioni di interessi occulti,
che facevano capo a centrali d’intermediazione tra realtà politica o economica
con quella criminale. Appariva evidente come la presenza della criminalità
organizzata in settori economici ed in ambienti politico-istituzionali
determinasse, come conseguenza indotta, un inquinamento progressivo non solo del
tessuto economico locale, ma anche del contesto sociale e della vita pubblica.
In quegli scenari tre erano gli attori principali che comparivano: personaggi
della politica locale e non, esponenti del mondo economico e di quello
criminale. Alcune volte i tre insiemi cooperavano tra loro, altre volte solo
alcuni di essi agivano congiuntamente. La storia della criminalità di questo
Paese, in aggiunta a quella di alcune vicende del mondo dell’imprenditoria
nazionale, ha portato alla luce una realtà che consente di individuare il
collegamento tra mondi diversi nella presenza di agenti che facilitano o rendono
possibile l’incontro tra le parti. Come già dalle prime inchieste degli anni '80
sul mercato della droga, che vedeva Palermo al centro del traffico dell’eroina
verso gli Stati Uniti, il ruolo di quegli agenti emergeva nella duplice veste
sia di supplenza alla carenza di quella professionalità di cui Cosa Nostra aveva
bisogno per muoversi nei mercati internazionali, sia di riduzione
dell’asimmetria informativa che grava sulla criminalità organizzata. Complessi e
profondi, e per certi versi sorprendenti, emersero gli intrecci che in quegli
anni il crimine organizzato era riuscito a tessere nell’ambito del sistema
economico e finanziario, rendendo la distinzione tra il legale e l’illegale
sempre più difficile e sfumata. Tutto questo Giovanni Falcone lo aveva prima
intuito, attraverso l’attenta lettura di fascicoli processuali, e poi lo aveva
dedotto dagli eventi ricostruiti nel corso delle indagini. Lo aveva documentato
in diverse occasioni con atti processuali ed alla fine il tutto era stato
cristallizzato in giudicati, a cui si era giunti partendo proprie dalle sue
istruttorie. Oggi si discute con facilità di indagini patrimoniali, del
sequestro dei beni, delle misure antiriciclaggio. Bene: credo che tutto questo
insieme di strumenti, fondamentali nella lotta alla mafia e basilari per gran
parte dei successi più importanti conseguiti sino ad oggi in questo campo, sono
frutto dell’esperienza operativa di Giovanni Falcone e di coloro che hanno da
lui appreso e con lui sperimentato quelle vie dell’investigazione. Seguiva le
piste dell’inchieste passo passo, anche all’estero, studiando prima di partire
gli ordinamenti penali e civili di quei paesi per poter nel modo giusto chiedere
informazioni, dati e documenti utili alle istruttorie italiane. Nel lavoro
d’indagine di Giovanni Falcone, l’esigenza di confrontarsi di continuo con una
realtà multiforme e sommersa, insieme all’esigenza di preservare l’attitudine a
comprendere le dinamiche criminali ed a seguirle, anche per tempi lunghi, nel
loro evolversi, ha portato a sviluppare competenze che sono divenute parte
integrante delle metodologie investigative più moderne. L’insegnamento che è
venuto dal lavoro svolto da Giovanni Falcone e l’esperienza maturata nell’averlo
affiancato in diverse inchieste rappresentano quello che viene definito il
“metodo Falcone”. Seguire le tracce, specie quelle dei soldi, collegarle tra
loro attraverso documenti, testimonianze, accertamenti bancari o altre
acquisizioni probatorie. Ma questo non bastava, bisognava interpretare ognuno
dei passaggi individuati: attraverso le regole comportamentali che
caratterizzavano l’ambiente in cui si collocavano, attraverso la mentalità ed il
codice non scritto dei mafiosi quando essi operavano direttamente oppure
attraverso la prassi che caratterizzava le operazioni e gli operatori che la
mafia utilizzava consapevolmente e non. Anche quando l’accertamento o quanto
accertato diventavano ripetitivi nel tempo non bisognava mai dimenticare che
tutto ciò consentiva di affrontare, per analogia o per esclusione, quegli
scenari criminali che stavano cambiando e che facevano riferimento a regole
comportamentali nuove e mai prima individuate. I confini tradizionali delle
indagini sulla criminalità, in tempi rapidi, si dissolsero, aprendosi ad
orizzonti nuovi in varie parti del mondo ed a livelli impensati. Da un lato, la
criminalità italiana estendeva i propri tradizionali confini di attività
utilizzando strategie eterogenee, stringendo alleanze nuove e cimentandosi in
ambiti operativi di norma non di loro interesse. Dall’altro le organizzazioni
criminali di altri paesi ampliavano il loro raggio d’azione e soprattutto
intrecciavano i loro interessi con quelli delle cosche dell’Italia meridionale.
I fenomeni emergenti potevano spiazzare l’investigatore tradizionale, ma non
Giovanni Falcone e chi seguiva le sue metodologie di lavoro. L’analisi economica
del crimine, sulla scorta dell’esperienza di Giovanni Falcone, produceva,
infatti, una serie di risultati che permetteva di comprendere la natura e la
meccanica delle relazioni pericolose che possono instaurarsi tra crimine
organizzato, da un lato, e dinamiche della produzione e degli scambi, reali e
finanziari, dall’altro lato. Grazie a questo metodo, che non va confuso con la
mera indagine di tipo finanziario, si poteva scoprire che il crimine organizzato
non inquina solo il versante bancario e finanziario, ma anche il versante reale
del sistema economico, e forse con danni ancora più gravi, misurabili non solo
in termini quantitativi ma anche qualitativi: impoverimento e imbarbarimento del
sistema. Con grande agilità e pervasività, i membri delle organizzazioni
criminali si muovevano nell’ambito dell’economica legale, reale e finanziaria,
proponendosi non solo per la loro capacità di violare l’ordine costituito, ma
come fonte autonoma di norme e regole alternative a quelle democratiche. Il
mafioso non si accontentava di infrangere la legge, ma provava sempre a proporsi
come soggetto regolatore, che produce fiducia in alternativa a quella legale che
assicura il sistema attraverso gli strumenti democratici. Forse una riflessione
tardiva, quando ormai non mi occupo più di attività investigativa, mi consente
meglio che in passato di comprendere quando quel periodo di collaborazione sia
stato fecondo. Si è trattato di un periodo di grandi cambiamenti nell’approccio
alle inchieste contro le associazioni mafiose che, a seguito della morte di
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e grazie a loro è divenuto un vero e
proprio cambiamento epocale. Sintesi tratta da Il profumo della libertà Edizione
2011 Ministero della Gioventù
Le geniali intuizioni di un
giudice,
scrive il 18 maggio 2018 su "La Repubblica" Giuseppe Ayala - Magistrato, negli
anni '80 sostituto procuratore della Repubblica di Palermo e pm al maxi processo
a Cosa Nostra. Per comprendere meglio il significato e l’importanza del
cosiddetto “metodo Falcone” è opportuno riflettere brevemente sui significativi
mutamenti intervenuti, a partire della seconda metà degli Anni Settanta,
nell’universo del crimine mafioso. I principali sono tre: l’ingresso massiccio
dell’organizzazione nel traffico, anche internazionale, di stupefacenti;
l’inedito attacco diretto alle Istituzioni, concretizzato dalle uccisioni di
suoi esponenti vittime dell’adempimento del dovere in contrasto con gli
interessi mafiosi e lo scoppio della cosiddetta “guerra di mafia” nel 1981. Cosa
nostra, rompendo una lunga tradizione, usciva dalla clandestinità e accendeva i
riflettori rendendosi drammaticamente visibile. A nessuno era più consentito
riproporre il vecchio interrogativo: “Ma siamo sicuri che la Mafia esiste?”. A
quel tempo, peraltro, neanche nel codice penale italiano era rinvenibile la
parola “mafia” Per trovarla bisognerà attendere il 29 settembre 1982, data
dell’entrata in vigore della legge Rognoni-La Torre con il suo inedito art.
416-bis (associazione di tipo mafioso). Incredibile, ma vero, si dice in questi
casi. Giovanni Falcone prese servizio all’ Ufficio Istruzione di Palermo sul
finire degli Anni Settanta. Nel 1980 il capo di quell’ Ufficio, Rocco Chinnici,
gli affidò un processo che riguardava un traffico di stupefacenti gestito da
esponenti dell’organizzazione mafiosa. Nell’istruirlo Falcone maturò il primo
pezzo della sua visione innovativa. Inutile inseguire la droga che spesso non
lascia tracce. Quello che, invece, le lascia di sicuro è il denaro collegato a
quel traffico. Così nacque il famosissimo “follow the money,” destinato ad
assicurare successi giudiziari sino ad allora impensabili. Ne offro una
testimonianza. Lavorammo assieme alla cosiddetta “Pizza connection”, un enorme
traffico di eroina tra la Sicilia e gli USA che coinvolgeva esponenti mafiosi di
entrambe le sponde dell’Atlantico. Sostenni l’accusa e ottenni pesantissime
condanne senza che nemmeno un grammo di eroina fosse mai stato sequestrato. La
documentazione bancaria certosinamente raccolta da Falcone si risolse in un
impianto probatorio inespugnabile per la difesa. Come ho già accennato,
l’aumento assai significativo dei delitti di matrice mafiosa comportò un pari
incremento dei fascicoli processuali che li riguardavano. La loro “veicolazione”
all’ interno dei vari uffici giudiziari continuava, però, a seguire l’ordinaria
prassi, per cui, per esempio, era del tutto normale che un giudice istruttore
lavorasse ad uno di questi senza sapere nulla di quanto stesse facendo il
collega della porta accanto impegnato nella trattazione di un fascicolo
riguardante un altro delitto di analoga matrice. Falcone si rese conto che, così
stando le cose, non si andava da nessuna parte per la semplice ragione che
ciascuno dei delitti mafiosi altro non rappresentava che la manifestazione
criminale di una logica associativa. C’era, insomma, qualcosa che, pur nella
loro diversità, li accomunava. Una sorta di “fil rouge” che li legava e che, di
conseguenza, li rendeva diversi da tutti gli altri, ma tra loro omogenei.
Ritenne, insomma, necessario compiere un salto di qualità verso quella che
definì la necessità di procedere verso una “visione unitaria del fenomeno
mafioso”. L’unico modo possibile per realizzarla fu quello di procedere alla
riunione di tutti i fascicoli processuali che riguardavano i delitti di mafia.
Un accentramento delle conoscenze orientato verso l’individuazione
dell’immanente “fil rouge.” Col senno di poi può sembrare una svolta ovvia e
scontata. Col senno di prima, però, nessuno ci aveva mai pensato. Fu una vera e
propria rivoluzione destinata ad assicurare successi giudiziari sino ad allora
inimmaginabili. La riunione di tutti i fascicoli processuali concernenti i
delitti mafiosi comportò la nascita di una sorta di enorme monolite giudiziario
che nessun giudice istruttore da solo avrebbe mai potuto portare avanti. Neanche
se possedeva la straordinaria capacità di lavoro di Falcone. Solo una squadra
capace e ben affiatata poteva farcela. Nacque così il mitico “pool antimafia.”
Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Leonardo Guarnotta e Peppino Di Lello, con
la sapiente guida di Antonino Caponnetto, successore di Rocco Chinnici, ne
furono i primi protagonisti. L’ ultimo “tocco” voluto da Falcone, per rendere
ancora più efficace il suo “metodo,” fu quello di coinvolgere, sin dalla fase
istruttoria, almeno un pubblico ministero per metterlo, così, nelle migliori
condizioni di sostenere l’accusa davanti ai Giudici del dibattimento. Il fatto
che la scelta sia caduta sul sottoscritto poco importa. La circolazione
informativa di ogni risultato acquisito divenne la regola. Si scoprì, così, per
esempio, che ciò che appariva non rilevante nell’ambito di un determinato
fascicolo, lo era invece in relazione ad altra e diversa, ma pur sempre
collegata, vicenda processuale. I risultati delle indagini di un’eccellente
polizia giudiziaria e gli ulteriori approfondimenti istruttori possiamo
paragonarli alle tessere di un mosaico. Il problema era che, sino ad allora,
mancando la configurazione dei contorni di ciò che nel loro complesso quelle
tessere avrebbero dovuto rappresentare, non si capiva dove e come collocarle. La
“visione unitaria” voluta da Falcone, e il successivo inedito contributo dei
collaboratori di giustizia, consenti di superare quel limite. Ogni tessera trovò
la sua precisa collocazione. Il “quadro” che ne conseguì risultò, finalmente,
chiaro e completo. Così nacque una grandiosa opera d’arte giudiziaria: il
maxiprocesso. La prima vera vittoria dello Stato e la prima vera sconfitta di
Cosa Nostra. Per quella definitiva restiamo, purtroppo, ancora in attesa.
Le prime indagini sui grandi misteri di
Palermo, scrive il 19 maggio 2018 su "La Repubblica"
Guglielmo Incalza - Dirigente della sezione "Investigativa” della Squadra Mobile
di Palermo nel 1980 e nel 1981. Il 7 gennaio 1980, il giorno successivo al
brutale assassinio del Presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella –
si erano già evidenziati nel corso dell'anno precedente segnali di una forte e
violenta recrudescenza mafiosa con gli omicidi del giornalista Mario Francese,
del segretario provinciale della Democrazia cristiana Michele Reina, del vice
questore di polizia e capo della Squadra Mobile Boris Giuliano, del Consigliere
Istruttore del Tribunale Cesare Terranova e del maresciallo di pubblica
sicurezza. Lenin Mancuso –, sono stato designato a capo della Sezione
Investigativa ed Antimafia della Squadra Mobile palermitana. Ebbi così modo non
solo di conoscere, ma di frequentare con assiduità il compianto Giovanni Falcone
al quale, nel maggio dello stesso anno, era stato assegnato dal Conigliere
Istruttore del Tribunale Rocco Chinnici, il procedimento penale sulla prima
grande inchiesta degli anni '80, più nota come processo su “Mafia e Droga”,
originata dal rapporto di denunzia della Squadra Mobile di Palermo contro
Spatola Rosario + 54, tutti ritenuti essere responsabili di associazione per
delinquere mafiosa e dedita al traffico internazionale di stupefacenti. Su tale
rapporto giudiziario molto è stato già scritto ed è ampiamente noto, in
particolare sulla ferma e decisa determinazione del Procuratore della Repubblica
Gaetano Costa, barbaramente poi ucciso dalla vile mano mafiosa nell'agosto dello
stesso anno 1980, a pochissimi mesi dall'essersi assunto, in perfetta solitudine
ed in evidente e plateale disaccordo dei suoi sostituti, la responsabilità di
firmare “da solo" i relativi provvedimenti di cattura nei confronti di tutti i
denunziati, noti esponenti di una delle più influenti “famiglie “ mafiose
italo-americane, quella dei Gambino, Spatola ed Inzerillo, la maggior parte dei
quali legati tra loro da stretti vincoli di parentela ed implicata, tra le
altre svariate attività delittuose, principalmente in un imponente traffico di
eroina che, partendo dalla Sicilia, aveva gli Stati Uniti d'America come
destinazione finale. All'incirca alla fine del maggio dell'80 dunque, fui
convocato dal questore pro-tempore ed invitato, mi si disse, su specifica
richiesta del dottor Chinnici, a mettermi a disposizione, con tutti i componenti
della mia sezione investigativa, del dottor Falcone, che da poco tempo ricopriva
l'incarico di giudice istruttore della VI Sezione penale e cui intanto era stato
assegnato il fascicolo del processo “Spatola” dopo che la Procura della
Repubblica ne aveva richiesto la formalizzazione. E' opportuno evidenziare che
il rapporto giudiziario all'origine di tale inchiesta, costituiva la risultanza
di due filoni investigativi, quello come sopra detto del traffico di droga,
individuato attraverso alcune mirate intercettazioni telefoniche sui componenti
della consorteria mafiosa dei succitati Spatola/Inzerillo/Gambino con le sue
diramazioni americane (ma anche di appartenenti ad altre “famiglie” palermitane
come ad esempio Vittorio Mangano della “famiglia di Porta Nuova”, più noto poi
come lo “stalliere” di Arcore ) e quello messo in luce dalle indagini svolte dal
Centro Criminalpol di Palermo sul rapimento simulato del finanziere
siculo-americano Michele Sindona, gestito e condotto sin dalla sua prima fase in
territorio americano, fino alla sua permanenza in clandestinità a Palermo e la
sua successiva riapparizione sul suolo americano, ad opera di componenti dello
stesso clan mafioso che contava negli USA sugli strettissimi collegamenti con
una delle più potenti ed agguerrite tra le 5 “famiglie” americane, quella
capeggiata per l'appunto dal Capo dei Capi Charles Gambino. Imponente ed arduo
apparve certamente il compito di portare avanti una istruttoria così vasta e
frammentata tant'è che lo stesso Falcone, successivamente alla emissione della
sua sentenza-ordinanza del 25 gennaio 1982 di rinvio a giudizio di Spatola
Rosario +119 per associazione aggravata di tipo mafioso e per traffico
internazionale di stupefacenti, ebbe a dichiarare ad alcuni giornalisti della
carta stampata: “... La mafia, vista attraverso il processo Spatola, mi apparve
un mondo enorme , smisurato , inesplorato...”. Ed anche per questo, ritengo, che
il Consigliere Chinnici, nell'assegnare a suo tempo a Falcone il relativo
fascicolo processuale, avesse formulato al Questore una cortese ma ferma
richiesta di fornire una collaborazione investigativa più corposa del solito,
per la complessità dell'istruttoria stessa. Quest'ultima, dunque, portata avanti
con la ferma, caparbia ed assai innovativa guida di Giovanni Falcone, non solo
confermò le responsabilità dei soggetti denunziati, ma mise in luce numerose
altre complicità, sia nel traffico della droga, ma anche nella partecipazione e
nella conduzione del finto sequestro di Michele Sindona, oltre che a porre le
basi di successive grandi operazioni di polizia sul territorio nazionale, come
quella nota col nome di “ San Valentino”, condotta a Milano sul riciclaggio dei
narcodollari ad opera di noti imprenditori locali (immobiliaristi, ma anche
finanzieri e liberi professionisti ) e personaggi mafiosi collegati al gruppo
Spatola. La frequentazione di tutti costoro ( tra i quali anche un noto
latitante mafioso palermitano come poi verrà accertato) in un ufficio milanese
di via Larga 13, cui facevano capo numerose società ombra riconducibili ai
predetti personaggi, era stata evidenziata dal traffico telefonico delle
intercettazioni condotte dal mio ufficio ( in specie alcune conversazioni del
Mangano Vittorio con uno tra gli Spatola inquisiti ), e lasciato chiaramente
sottintendere alla consumazione di losche attività. A seguito dell'emissione di
un decreto di perquisizione di Falcone e dell'esito della relativa operazione di
polizia giudiziaria effettuata da personale della mia sezione investigativa,
vennero quindi acquisiti importanti indizi di un imponente riciclaggio dei
proventi criminali del traffico di narcotici che, confermati da una breve ma
intensa rogatoria dello stesso Falcone a Milano, divennero la base per la
prosecuzione delle indagini meneghine poi culminate per l'appunto col blitz di
San Valentino del 14 febbraio 1983. Relativamente al cosiddetto “metodo
Falcone”, cui spesso si fa riferimento, per il modo di condurre le sue
attività istruttorie sulle organizzazioni mafiose, ritengo che quel metodo si
sostanzi semplicisticamente nel suo essere perseverante e dotato di una grande
ed infaticabile capacità lavorativa oltre che di un eccezionale intuito. Tali
sue doti lo portavano a considerare che solo assumendo la effettiva direzione
delle indagini, cosa inconsueta al tempo della vigenza del vecchio codice di
procedura penale, ed a confrontarsi direttamente con i responsabili degli uffici
e comandi operativi delle tre principali forze di polizia (delegando di volta in
volta le attività di indagine in un rapporto di effettiva e costruttiva
sinergia), si potessero raggiungere risultati apprezzabili. Il giudice Falcone
era, ancora, convinto, proprio tenuto conto degli scarsi risultati giudiziari
sin allora raggiunti nell'individuazione degli autori dei singoli delitti di
mafia, soprattutto a causa del senso diffuso di una persistente omertà, che
bisognasse capovolgere il metodo d'indagine sin allora seguito, cercando prima
di mettere in luce e far emergere il vincolo associativo con le sue varie
sinapsi, per poi ricollegarvi i singoli e specifici delitti che sarebbero
altrimenti apparsi scollegati. La percezione, poi, dell'esistenza in Sicilia di
laboratori per la raffinazione della morfina base in eroina (peraltro poi
avvalorata dall'individuazione di uno di essi nell'agosto dello stesso anno in
una villa di Villagrazia di Carini), lo portò ad una grande intuizione e, cioè,
che all'enorme flusso della droga verso gli Stati Uniti dovesse necessariamente
corrispondere un altrettanto enorme flusso di valuta americana a compensazione.
In pratica ...la scoperta dell'uovo di Colombo, solo che nessuno ci aveva
pensato prima. La sua precedente esperienza di giudice fallimentare gli venne
certamente d'aiuto e pertanto dispose una serie di accertamenti bancari mediante
ordinanze di esibizioni di distinte di versamento per cambio di valuta USA,
libretti di risparmio, documentazione di conti correnti e di assegni con la
individuazione del nominativo dei firmatari e beneficiari degli stessi. Alle
iniziali reticenze nella esecuzione dei provvedimenti da parte di alcuni
istituti bancari, come nel caso di una Cassa Rurale ed Artigiana dell'hinterland
palermitano, fu necessario procedere direttamente, facendovi irruzione, Falcone
stesso in testa, allo scopo di costringere alla collaborazione ed alla
esibizione immediata della documentazione richiesta. Come dimenticare la sua
incessante e meticolosa ricostruzione dei collegamenti che riusciva ad
individuare attraverso la visione della gran mole delle distinte di cambio di
dollari e degli assegni che, numerosi, inondavano la sua scrivania? Armato di
santa pazienza, registrava a penna all'epoca i computer erano oggetti pressocchè
sconosciuti) singole schede dei personaggi coinvolti, su cui annotava sia gli
estremi dell'operazione effettuata che il nominativo dei soggetti comunque
implicati nel rapporto bancario, per poter poi procedere alle verbalizzazioni
delle dichiarazioni ed alle contestazioni di quanto riscontrato. Ricordo al
riguardo un episodio altamente significativo della pericolosità di tale
consorteria criminale. Una mattina, regolarmente convocato in Tribunale, si
presentò nell'ufficio di Falcone il noto Michele Greco detto il “Papa” per
rendere conto, me presente, della natura dei suoi rapporti con il capo mafia
Stefano Bontate, il “principe” del quartiere palermitano d Villagrazia, rapporti
rilevati dallo scambio tra di loro di alcuni assegni per rilevanti importi. Alle
domande sempre più incalzanti del giudice, il Greco (indicato poi dal noto
collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta come il capo della “Cupola” mafiosa
siciliana, anche se sottomesso ai diktat del sanguinario boss corleonese Totò
Riina) ebbe improvvisamente ad inalberarsi e, con fare oltremodo stizzito ebbe a
fare un vero e proprio sermone, quasi pontificando con fare ieratico e lanciando
velate minacce. Alla fine dell'interrogatorio, licenziato il teste, con Falcone
ci guardammo sgomenti negli occhi, concordando sul fatto che l'atteggiamento e
le parole del Greco sottintendevano un vero e proprio classico avvertimento
mafioso. Il giudice, tuttavia, alla mia osservazione sul perchè mai non avesse
provveduto a richiedere nell'immediatezza l'intervento del Pubblico Ministero
per la contestazione di reato, mi fece rilevare l'inutilità di tale iniziativa,
giacchè non si sarebbe mai potuto riscontrare in giudizio alcun chiaro elemento
di colpevolezza, essendo state le minacce mai palesemente esplicitate. Gli feci
comunque presente che di quanto accaduto avrei immediatamente riferito al
Questore con relazione scritta per le opportune valutazioni della vicenda e,
provveduto in tal senso, fui incaricato di assicurare temporaneamente la sua
sicurezza, in attesa della costituzione di un ufficio scorte, all'epoca
inesistente, con gli stessi uomini della mia Sezione investigativa, che già si
occupavano a tempo pieno dell'attività di supporto alla indagine istruttoria. E
come non porre in risalto la sua capacità di dialogare con i suoi colleghi di
altre sedi giudiziarie, interessate anch'esse da attività delittuose di tipo
mafioso, nel tentativo di convincerli a riconoscere la unicità di tale fenomeno
criminale e la centralità di Palermo come sede dei vertici mafiosi, al fine di
concentrare nel capoluogo siciliano anche le indagini che avevano riferimento
alle sue propaggini al di fuori della Sicilia? Non sempre fu ascoltato ed anzi,
fu anche da taluni aspramente criticato. Molti di loro, però, credo che nel
tempo si siano ravveduti. La sua passione ed il suo impegno personale, non
disgiunto dalla sua ferrea determinazione a portare avanti la sua attività di
qualificato contrasto al crimine organizzato, lo portò anche a richiedere ( ed
ottenere ) non solo la collaborazione degli organismi centrali operativi delle
tre principale forze di Polizia, ma anche quella preziosissima della Drug
Enforcement Administration e del Federal Bureau of Investigation,
rispettivamente l'agenzia federale antidroga e la polizia federale
investigativa, entrambe americane. L'aver mantenuto con i suoi rappresentanti di
vertice un'attiva e duratura collaborazione in costanza di rapporti di vera
stima e considerazione, gli valsero, post mortem, un tributo di riconoscenza e
di onore al suo valore senza eguali, costituito dal collocamento di una statua
col suo busto nel cortile principale del quartier generale della F.B.I. a
Washington. Concludo questo ricordo di Giovanni Falcone, della sua figura di
grande magistrato e dell'uomo da me conosciuto e frequentato nel corso del mio
affiancamento alla sua attività istruttoria nel primo grande processo contro
Cosa Nostra, affermando di aver tanto imparato da lui e non solo dal punto di
vista professionale. Abbiamo via via, approfondito la nostra conoscenza,
particolarmente in occasione delle poche ore lasciate libere dagli impegni delle
varie rogatorie effettuate insieme, anche al di fuori della Sicilia, quando
talvolta, prima o poco dopo cena, ci si lasciava andare a liberi pensieri ed
egli appariva nello splendore del suo gran sorriso, a volte anche canzonatorio e
di gradevole sarcasmo con le sue battute al fulmicotone. La continua
frequentazione tra di noi, soprattutto in ambito lavorativo, mi valse persino
l'epiteto di “Falconetto” con cui all'epoca mi indicava a mo' di sfottò l'amico
e collega Ninni Cassarà, che era a capo della sezione Omicidi della squadra
mobile e poi succedutomi all'Investigativa a seguito del mio trasferimento da
Palermo. Non potrò mai dimenticare di una sera dell'inverno 1980/81. Insieme ad
un mio collega della Criminalpol e ad alcuni Ufficiali dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza - lo avevamo accompagnato a Milano per procedere ad una
importante rogatoria con l'assunzione a verbale delle dichiarazioni testimoniali
di alcuni noti personaggi, tra i quali il noto banchiere Enrico Cuccia, ognuno
di essi legato per alcuni versi alla vicenda del rapimento simulato del
faccendiere Sindona. A sera, eravamo in un albergo di Milano e, mentre dopo cena
e prima di ritirarci nelle rispettive camere eravamo sprofondati in alcune
poltrone della hall, Falcone, sorseggiando un whisky, a conclusione di alcune
valutazioni sull'andamento della istruttoria del processo, ebbe a dire
chiaramente di essere cosciente del fatto che la mafia lo avrebbe ucciso, ma che
bisognava comunque andare avanti continuando a fare il proprio dovere. Che dire
di più? Dico solo che sento ancora i brividi al ricordo di queste sue parole che
manifestavano chiaramente la sua consapevolezza del grande rischio cui andava
incontro. E' inutile dire che il pomeriggio del 23 maggio 1992 la drammatica
notizia, appresa a Roma telefonicamente, mi provocò una intensa emozione e non
riuscii a frenare le mie lacrime e la mia disperazione.
Io, uditore nella stanza del dottor
Falcone, scrive il 20 maggio 2018 su "La Repubblica"
Vincenzina Massa - Magistrato di Palermo, nel 1980 uditore nell'ufficio del
giudice istruttore Giovanni Falcone. Accompagno mia nipote di dieci anni a
visitare il Museo Falcone e incontro Giovanni Paparcuri (che si occupa con
grande passione della gestione del Museo e di organizzarne le visite guidate),
il quale nel percepire una mia conversazione con la bambina apprende che ero
stata uditore del giudice Giovanni Falcone e mi chiede di entrare in contatto
con Attilio Bolzoni, che cura un blog, nel quale a breve si dibatterà sul
“metodo Falcone”, per offrire un mio contributo conoscitivo. Perplessa, tentenno
non avendo mai dismesso in tanti anni quell’atteggiamento di assoluto e quasi
religioso riserbo col quale ho ritenuto di dover custodire le mie preziose
memorie del periodo nel quale ebbi il privilegio di incontrare il Giudice
Giovanni Falcone, ma alla fine, trovandomi in un momento particolare della mia
vita professionale, sulla soglia del pensionamento anticipato (compirò a breve
63 anni), mi lascio tentare dal bisogno di rivisitarle proprio nel momento
conclusivo della mia carriera. Già prima di giurare (sono stata nominata con
Decreto Ministeriale del 13. 5.1980), ero stata presentata fuori dal Palazzo, e
gli avevo fatto poi una visita deferente in ufficio, al Procuratore capo della
Repubblica di Palermo Gaetano Costa, che nell’agosto di quello stesso anno
sarebbe stato vittima di un vile agguato mafioso. Lo “zio Tano”, com’era
affettuosamente chiamato dai parenti di un mio ex fidanzato dell’epoca, che gli
erano particolarmente vicini e che me lo avevano fatto incontrare, era un
gentiluomo di vecchio stampo, piccoletto, ma dalla personalità forte e dal
ferreo credo nelle istituzioni del quale non aveva mancato di rendermi
partecipe. Il Procuratore, proprio nei giorni a seguire, avrebbe dato prova di
quella fermezza e del suo grande coraggio, così segnando irreparabilmente il
proprio destino, coll’assumersi a titolo quasi esclusivo (perché isolato da
quasi tutti gli altri suoi sostituti dissenzienti, eccettuato il sostituto
procuratore Vincenzo Geraci) la responsabilità di firmare la convalida di oltre
50 ordini di arresto di pericolosissimi mafiosi, fra i quali i noti Rosario
Spatola e Salvatore Inzerillo. Questo il mio primo contatto con la realtà
giudiziaria palermitana. Era la calda estate del 1980 ed a Palermo si erano già
perpetrati numerosi e gravissimi fatti di sangue (il 4 maggio precedente
l’omicidio del Capitano dei carabinieri di Monreale Emanuele Basile) che
preconizzavano quella che sarebbe stata un lunga e sanguinosa vera e propria
guerra di mafia. Nell’allora Ufficio Istruzione di Palermo, diretto dal
Consigliere Istruttore Rocco Chinnici, compagno di scuola del fratello di mia
madre, in ragione del privilegiato familiare rapporto di conoscenza col capo
dell’Ufficio venni accolta personalmente da lui che ci affidò - me e l’altro mio
collega uditore giudiziario – al magistrato affidatario “prescelto”: il Giudice
Giovanni Falcone. Appena entrata in magistratura, avevo ottenuto, infatti, dal
mio magistrato coordinatore del piano di tirocinio, rinunziando appositamente al
godimento delle ferie estive (condicio sine qua non perché non era possibile in
alcun altro periodo - adesso non ricordo per quale ragione), di essere affidata
al collega Dott. Giovanni Falcone, giudice istruttore, per svolgere sotto la sua
direzione il mio periodo di uditorato. Quell’assegnazione (senza precedenti che
io sappia) era stata il frutto di mie vivaci pressioni presso il magistrato
coordinatore, previo un contatto e l’assenso del giudice Falcone, che avevano
vinto ogni resistenza del primo. Già allora, infatti, fra i giovani magistrati
si era diffusa la fama di Giovanni Falcone, come quella di un magistrato non
soltanto competente e tecnicamente ben attrezzato, ma soprattutto era già
ampiamente conosciuta la forte motivazione e una spinta ideale senza precedenti
nella lotta al fenomeno mafioso. Come ho accennato, la mia richiesta di essere
assegnata al dottor Falcone non era stata accolta con grande favore dal
magistrato coordinatore. A quell’epoca non me ne era stato subito evidente il
motivo, ma oggi so bene - ed anche allora mi fu più chiaro in breve torno di
tempo - che fra i magistrati dell’epoca (la maggior parte degli anziani,
comunque) si era già diffuso un grande pregiudizio circa le così decantate
capacità e professionalità di Giovanni Falcone. Tuttavia, alla fine,
l’insistenza della postulante e l’entusiasmo con cui la richiesta era stata
caldeggiata, avevano avuto la meglio su quelle evidenti remore ascrivibili a non
troppo sotterranea malevolente invidia nei confronti di quel collega che, così
giovane, riscuoteva già tanta ammirazione fra i giovanissimi che guardavano a
lui come un faro. Fu, dunque, lo stesso consigliere istruttore Rocco Chinnici
che ci affidò (me e il mio collega Filippo Gullotta) al Giudice Falcone. Io già
avevo avuto il privilegio di farne la conoscenza perché la moglie, Dottoressa
Francesca Morvillo, aveva frequentato in precedenza la casa dei miei genitori,
essendone anche gradita commensale e perché un professore di università comune
amico, molto vicino al vice questore Ninni Cassarà, mi aveva procurato un
informale abboccamento con il Giudice Giovanni Falcone perché potessi chiedergli
la sua generica disponibilità ad accogliere uditori giudiziari. Allora, le cose
si facevano più alla buona rispetto ad oggi, molta meno burocrazia; non
esistevano rigidi criteri per la formazione dei piani di tirocinio e questo
aveva giocato un punto a mio favore, rendendo possibile il soddisfacimento della
mia aspirazione.
E la fortuna volle che quando si concretizzò la
mia assegnazione (insieme al collega Filippo Gullotta) al Dottor Falcone
all’Ufficio Istruzione di Palermo erano appena (all’incirca nel maggio
precedente) transitati dalla procura per essere istruiti, con la formale, i
famosi processi a carico di “Spatola Rosario + 120” e a carico di “Mafara
Francesco ed altri”, che erano stati per l’appunto assegnati entrambi dal
consigliere istruttore Chinnici al Giudice Falcone. Fu proprio istruendo questi
processi che Falcone prese a testare il suo nuovo metodo di indagine, ricusando
il ruolo attendista della vecchia figura di giudice istruttore disegnata
dall’allora vigente codice di rito (che in sostanza aspettava il rapporto
redatto dalla Polizia giudiziaria per esaminarlo) ed assumendo in prima persona
il controllo e la direzione delle investigazioni, compiendo anche personalmente
alcuni atti, o delegandone singoli altri, ma non mai più genericamente, come per
il passato, tutta l’attività di investigazione. Quelle indagini vennero portate
avanti con criteri del tutto innovativi. Giovanni Falcone, infatti, facendo
tesoro delle sue competenze nel ramo civile e del diritto bancario, essendo
stato giudice fallimentare, aveva sviluppato una tecnica di investigazione che
partiva dal presupposto che per colpire la mafia ed i suoi affari illeciti,
occorreva seguire i flussi di denaro, nella consapevolezza che in qualunque
attività lucrosa sul territorio controllato l’organizzazione criminale si
insinuava con sapienza, con i suoi metodi, ora violenti, ora sotterranei, a
seconda della bisogna. Fu così che noi uditori trovammo la scrivania del Giudice
Falcone (che allora naturalmente chiamavo, come si fa fra colleghi,
familiarmente, Giovanni, dandogli del tu, ed oggi mi guardo bene, come ritengo
doveroso, dal continuare a chiamare così) diuturnamente “affollata” - quel che
colpiva particolarmente - da numerosissimi assegni, vere e proprie mazzette di
assegni, lì pronti per essere meticolosamente passati al setaccio ed esaminati
nelle loro girate per individuare i destinatari finali dei crediti portati da
quei titoli. E fu quindi proprio in quei giorni per l’innalzarsi della soglia di
rischio dei magistrati in dipendenza della qualità degli imputati, e, quindi,
dei processi da istruire che venivano fatti i sopralluoghi tecnici per il
montaggio dei vetri blindati nell’Ufficio d’Istruzione e Processi Penali (così
si chiamava). Fino ad allora, nessuna sofisticata misura di protezione era stata
ancora adottata a tutela di quelli che sarebbero diventati i paladini della
lotta a Cosa Nostra (e recentissimi erano l’uso da parte del Giudice Falcone e
dei suoi colleghi di auto blindate e l’assegnazione di scorte). Ricorderò solo
per inciso che quei vetri ben presto si sarebbero rivelati non sufficienti a
fermare le armi letali di Cosa Nostra, che aveva utilizzato, con soddisfacenti
risultati, proprio i vetri blindati della gioielleria Contino di via Libertà per
provare i suoi kalashnikov poi serviti nell’agguato in cui trovò la morte nel
maggio 1981 Salvatore Inzerillo. Tornando agli assegni, il giudice Falcone ci
mise al corrente della necessità di una verifica capillare dei diversi passaggi
di mano dei titoli di credito e ci insegnò a porre attenzione alla lettura delle
“girate”. Al di là di quelle indicazioni di metodo del tutto anodine (nessun
riferimento all’identità dei primi prenditori e dei giratari e all’eventuale
loro inserimento nell’organizzazione mafiosa) necessarie ad illustrarci nelle
linee generali la sua nuova metodologia di indagine, però, con mia grande
incosciente delusione, Falcone ci tenne sempre ben lontani dalle notizie e dai
fatti potenzialmente pericolosi, quelli cioè emergenti dalle indagini su Cosa
Nostra, spiegandoci con grande delicatezza che non era certo per mancanza di
fiducia sulla nostra serietà e riservatezza, ma che si trattava di tutelare la
nostra sicurezza. A noi venne affidata, quindi, la stesura di ordinanze o di
ordinanze-sentenze riguardanti i fascicoli “ordinari”. Ma Giovanni Falcone,
nonostante oberato da una mole di lavoro veramente spaventosa (la quantità di
fascicoli che affollavano la sua stanza e i diversi armadi la diceva lunga al
riguardo) che lo costringeva ad orari veramente stressanti, trovava, comunque,
il tempo di indirizzarci nella lettura delle carte processuali e nella redazione
dei provvedimenti a noi assegnati; le minute che gli sottoponevamo venivano da
lui attentamente corrette e le correzioni antecedentemente discusse e concordate
con noi. Anche nello svolgere il compito di “magistrato affidatario”, quindi, il
giudice Falcone non mancava di essere, come sempre nello svolgimento della sua
attività professionale, attento, infaticabile, preciso, puntuale; ma il suo
essere in tutto eccellente non gli faceva perdere di vista l’indulgenza. Potrei
dire, con quasi assoluta certezza (anche se, estremamente riservato
nell’esternazione dei suoi sentimenti, nulla avrebbe mai verbalizzato al
riguardo) che dietro alcuni dei suoi indimenticabili sorrisi sornioni, che non
ci faceva mancare mai, si nascondesse anche una tenera benevolenza e
comprensione per i nostri primi incerti passi. Sono ancora in possesso - e le
custodisco gelosamente - di quelle bozze di provvedimenti che recano le
correzioni vergate a mano da Giovanni Falcone. Una di queste mi è
particolarmente cara, perché rammento ancora l’interesse e l’impegno che prodigò
per aiutarmi ad addivenire alla decisione più giusta di quella vicenda
giudiziaria così delicata, riguardante un caso umano veramente pietoso. Si
trattava di un processo penale per tentato omicidio plurimo e pluriaggravato a
carico di tale C. F., della quale non ho mai potuto dimenticare il nome. Il 29
novembre 1979, a Palermo, la donna, madre di due figli adolescenti (di 17 e 14
anni), entrambi portatori di handicap, perchè gravemente cerebrospatici, dopo
aver messo a letto i ragazzi nel letto matrimoniale della propria stanza nella
quale aveva collocato una bombola di gas liquido da 15 Kg, aprendone la valvola,
si era distesa, a sua volta su un lettino vicino. L’odore di gas proveniente
dalla casa aveva allarmato una vicina che aveva chiamato il 113 e provocato
l’intervento di un altro vicino che entrato nella casa aveva tratto in salvo i
ragazzi e la mamma ancora vivi e coscienti, apprestando loro i primi soccorsi in
attesa dell’intervento dell’autoambulanza. Si era, dunque, proceduto con la
formale istruzione, nel corso della quale era stata disposta perizia tecnica
“per accertare la possibilità di esito letale dell’avvelenamento da gas” (sic la
correzione del dottor Falcone riportata nella mia minuta, come sempre
rigorosamente con la sua inseparabile stilografica). Il PM aveva concluso
chiedendo il proscioglimento dell’imputata con la formula perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato. Ho molto apprezzato il fatto che il Giudice
Falcone mi avesse assegnato proprio quel processo così delicato e spinoso, per
lo studio degli atti e la stesura del provvedimento conclusivo, perché avevo
avuto modo di comprendere come Egli avesse preso molto a cuore quel caso umano
veramente straziante; infatti, dimentico delle migliaia di carte sul suo tavolo
(assegni e quant’altro) in attesa di essere studiate meticolosamente, posponendo
anche i mille abboccamenti quotidiani con la PG (i cui dirigenti – alcuni dei
quali oggi tristemente noti, vuoi perché caduti per mano mafiosa, vuoi perché
condannati per collusioni con Cosa Nostra - quotidianamente facevano la fila nel
corridoio antistante la sua stanza per relazionargli gli ultimi esiti delle
attività di indagine), si era messo a spiegarmi qual’era la via migliore per
giungere alla “giusta” conclusione della vicenda processuale, facendo ricorso
all’istituto, ben poco usato, del reato impossibile. Ricordo bene che
infervorandosi, a dispetto dell’ostentata sempiterna imperturbabilità, si era
raccomandato di redigere una motivazione molto accurata perché la sentenza di
proscioglimento non fosse passibile di impugnazione. Quella sfortunata donna
andava prosciolta e messa al riparo da conseguenze giudiziarie negative del suo
gesto disperato. Il mio "Affidatario", noncurante e dimentico degli altri
impegni, si era prodigato, quindi, in ogni possibile chiarimento soffermandosi a
rammentarmi quali fossero i criteri per ritenere applicabile l’istituto,
sostanzialmente facendomi una dotta disquisizione sul reato impossibile,
argomento che mostrava di avere “fresco” nella memoria come lo avesse studiato
il giorno prima. Questi era il giudice istruttore Falcone, una persona profonda
con doti umane non comuni e grande sensibilità come deve essere un Giudice,
prima ancora che un raffinatissimo giurista, un eccellente investigatore ed un
tecnico espertissimo dotato di una memoria degna di Pico della Mirandola. Da
quest’uomo di dirittura morale inimitabile, di mentalità moderna, dallo
straordinario coraggio e dalla prorompente personalità, dalle doti umane
superiori, dall’intelligenza poliedrica (o piuttosto genio) ed eclettica,
all’humor pungente e salace, che faceva capolino in battutine buttate lì a fare
da contrappunto ed alleggerire le non dissimulate, né dissimulabili atmosfere
pesanti e spesso grevi di quell’Ufficio, e dalla volontà ferrea nel perseguire
la sua missione, con energia inconsumabile, ho appreso il fortissimo senso delle
istituzioni e del dovere ed è questo “metodo Falcone” (l’unico che ho potuto
apprendere) che ha guidato ogni passo della mia carriera, nella quale con i miei
limiti e nel mio piccolo, ho cercato di non dimenticare mai gli insegnamenti
ricevuti, con l’opera, ed in ogni gesto quotidiano, da un uomo dalla statura
morale superiore quale era il giudice istruttore dottor Giovanni Falcone.
Uno “scienziato” dell'investigazione,
scrive il 21 maggio 2018 su "La Repubblica" Angiolo Pellegrini - Generale
dell'Arma in pensione, nei primi anni '80 capitano della “sezione Anticrimine”
dei carabinieri di Palermo. Il 23 maggio 1992 si verificava l’attentato più
grave nella storia della giovane Repubblica italiana: l’esplosione di 500
chilogrammi di tritolo, posti all’altezza di Capaci e, di conseguenza, la morte
del magistrato Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e dei tre agenti di
scorta. Perdeva la vita quel “giudice” che mi piace definire ”lo scienziato
dell’attività istruttoria ed investigativa” mente e coordinatore del pool
antimafia che, in soli 4 anni (1980 – 1984), era riuscito a dimostrare che la
mafia esisteva come organizzazione unitaria e gerarchicamente strutturata, e,
nello spazio di poco più di dieci anni, al termine del più grande processo mai
celebrato al mondo, ad ottenere la condanna per i capi a 19 ergastoli e per gli
appartenenti all’organizzazione a 2665 anni di reclusione. La mafia, nata come
associazione segreta, radicata in una subcultura ben definita era riuscita per
lungo tempo a far pesare sulla società la sua forza intimidatrice e, nel
contempo, a fare sorgere nei suoi confronti il consenso, adattandosi
apparentemente ai canoni di giustizia propri della società delle aree
meridionali. Ma, come si sarebbe potuto e dovuto prevedere, i settori
d’intervento della mafia all’inizio degli anni 70 non erano più limitati a
quelli tradizionali della Sicilia agricola: in pochi anni si sarebbe assistito a
sempre più stretti collegamenti delle organizzazioni mafiose siciliane con
quelle della Calabria e della Campania, prima nel settore del contrabbando dei
T.L.E. e, poi, nel traffico degli stupefacenti, gradualmente esteso in tutto il
mondo. La mafia, con l’aumento vorticoso del consumo delle droghe, ha sentito la
necessità di disporre di grossi capitali con conseguenti enormi utili che
attrassero nel “gioco” anche coloro che potremo definire di “terzo livello”.
Quando la mafia – divenuta ricchissima - tanto da ritenersi più forte dello
“Stato legale” – esce allo scoperto, la lotta si radicalizza ed, in conseguenza,
della più decisa azione di contrasto degli organi investigativi dello Stato, si
assiste ad una reazione quanto mai violenta, sfociata negli omicidi del T.C.
Russo, dei Capitani Basile D’Aleo, del Maresciallo Ievolella, del V. Questore
Boris Giuliano, dell’agente Zucchetto, dei Magistrati Terranova, Costa, Chinnici
e del Prefetto dalla Chiesa. Ma, nello stesso tempo si verificano alcuni fatti
importanti: la perdita progressiva del consenso da parte della popolazione,
l’affermarsi di nuovi metodi d’indagine, la convergenza degli sforzi della
magistratura e delle forze di Polizia, l’approvazione della c. d. “legge
Antimafia”. E’ vero che il traffico internazionale di stupefacenti coinvolge una
vera e propria multinazionale del crimine: i produttori di oppio del Medio
Oriente, i contrabbandieri italiani, francesi e greci, addetti al trasporto
della morfina, i gestori dei laboratori di produzione dell’eroina in Sicilia, i
corrieri siciliani e italo – americani per la distribuzione degli stupefacenti
in USA ed in Canada e per il ritorno in Sicilia di ingentissime quantità di
dollari e le collusioni politiche per il riciclaggio del denaro. Ma, se è vero
che la complessità degli accertamenti comporta grandi difficoltà per gli
investigatori e per i magistrati, sono proprio tali difficoltà ad introdurre
metodi d’indagine nuovi: in particolare si prende coscienza che il punto debole
del fronte della mafia è costituito dalle tracce che lasciano i grandi movimenti
di denaro. Falcone, proseguendo su questa strada, riesce a dimostrare dopo ben
18 secoli la mancata attualità dell’assunto, tramandatoci dallo storico latino
Svetonio, “Pecunia non olet”. E’ nato quello che sarebbe divenuto il famoso
“metodo Falcone”. Falcone, infatti, capovolse il metodo d’indagine: il Giudice
Istruttore anziché lavorare, come era stato sempre fatto, su quanto riferito
dalle forze di Polizia, assunse in prima persona lo svolgimento delle indagini,
compiendo direttamente atti istruttori e delegando una serie impressionante di
accertamenti, approfondimenti, indagini, riuscendo così a pervenire ad una
visione unitaria del fenomeno mafioso. Riunì vari processi, pur se sembravano
non riconducibili a gruppi criminali tra loro collegati (Spatola più 119,
Gerlando Alberti, Mafara Francesco, sequestro Sindona, arresto del belga Gillet
e poi Greco Michele più 161, Riccobono Rosario più 39, Provenzano Bernardo più
29 ), evidenziando che avevano tutti numerosi dati in comune e, soprattutto, il
coinvolgimento nel traffico di stupefacenti e nel riciclaggio del denaro. In
sostanza, la capacità di sintesi, la memoria eccezionale, la visione strategica
del problema consentì a Falcone di realizzare una sorta di enorme mosaico, sul
quale riuscì a porre, ciascuno al posto giusto, migliaia di tessere, fornendo
così una rappresentazione attuale ed aggiornata di “Cosa Nostra”,
un’organizzazione unitaria, verticistica, con i propri organi di comando a
livello provinciale e regionale, con collegamenti in tutta Italia e nel mondo
intero. Lo stesso Falcone in un suo intervento alla tavola rotonda, organizzata
a Palermo nel 1984 da Unicost, ha affermato: “Negli ultimi anni, uno sparuto
drappello di magistrati e di appartenenti alle FF.PP. ha cominciato in più parti
d’Italia ad impostare le indagini in modo finalmente adeguato alla complessità
del fenomeno ed i risultati non si sono fatti attendere. E’ cominciata ad
emergere una realtà di enormi dimensioni ed inquietante, solo intuita nel
passato”……… “Non ci si è lasciati scoraggiare dalle difficoltà e, fra
l’indifferenza e lo scetticismo generale, si è proseguita la via intrapresa
cominciandosi ad ottenere i primi risultati: la positiva verifica dibattimentale
di istruttorie particolarmente complesse riguardanti organizzazioni mafiosi ed
efferati delitti di stampo mafioso”……. “Dall’iniziale separatezza fra i diversi
organismi preposti alla repressione del fenomeno mafioso, si è passati in
pochissimi anni, superando ostacoli ed incomprensioni di ogni genere, ad un
clima di collaborazione di reciproca fiducia, impensabile fino a poco tempo
addietro”.
La mossa vincente di seguire il denaro,
scrive il 22 maggio 2018 su "La Repubblica" Leonardo Guarnotta - Già Presidente
del Tribunale di Palermo, nei primi anni '80 componente del pool antimafia
dell'ufficio istruzione. La lotta dello Stato alla mafia ha origini che
risalgono, quanto meno, agli ultimi anni dell'800 e, verosimilmente, al 1°
febbraio 1893, giorno in cui venne assassinato per mano mafiosa il marchese
Emanuele Notarbartolo, persona incline all'etica e al rispetto della legge, già
sindaco di Palermo per alcuni anni e direttore del Banco di Sicilia, storico
istituto di credito dell'isola. E' stato considerato il primo eccellente delitto
di mafia che, all'epoca, accese un importante dibattito sulla situazione della
mafia in Sicilia e, soprattutto, sulla collusione tra mafia e politica, anche se
inizialmente nessuno osò fare nomi. Da allora e, per moltissimi anni, la lotta
alla mafia è stata quasi sempre emergenziale consistendo in provvedimenti
susseguenti a singoli fatti delittuosi, come la commissione antimafia del 1963
dopo la strage di Ciaculli, una borgata di Palermo, regno di Michele Greco il
“Papa”, in cui perirono sette carabinieri e due civili, dilaniati da una carica
di tritolo nascosta nel portabagagli di una Alfa Romeo “Giulietta”. Poi gli anni
settanta con la Palermo dei delitti eccellenti ad opera dei corleonesi Salvatore
Riina e Bernardo Provenzano quando, in proditori agguati mafiosi, vennero
uccisi, tra gli altri, il Procuratore Pietro Scaglione, il colonnello dei
carabinieri Giuseppe Russo, il vice questore Boris Giuliano, il giornalista di
inchiesta Mario Francese, il dottore Paolo Giaccone, il consigliere istruttore
Cesare Terranova, il Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella, il
Procuratore Gaetano Costa, Pio La Torre e il generale Carlo Alberto dalla
Chiesa. Era questo il fosco, nebuloso contesto temporale in cui approdarono
all'Ufficio di Istruzione del Tribunale di Palermo, alla fine degli Anni
Settanta, Rocco Chinnici, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello
e, dopo l'uccisione di Rocco Chinnici per mano mafiosa, il dottor Antonino
Caponnetto che gli subentrò nelle funzioni di consigliere istruttore. Con il
loro avvento e con la creazione del pool antimafia, nel quale era stato nel
frattempo cooptato il giudice Leonardo Guarnotta - io - i rapporti di forza tra
Stato e mafia cambiarono e venne sferrato un attacco senza precedenti a “cosa
nostra” grazie all'impegno quotidiano profuso da quei magistrati, alla
inaspettata collaborazione di Tommaso Buscetta il cui “esempio” venne seguito da
Salvatore Contorno, Giuseppe Calderone e Marino Mannoia, passati dalla parte
dello Stato, le cui propalazioni, accuratamente riscontrate, hanno consentito di
infrangere il muro dell' omertà che, da sempre, è stato uno dei pilastri sui si
basa la stessa esistenza di Cosa nostra, ma grazie anche e soprattutto alla
professionalità, alla competenza, alla preparazione ed all'intuito investigativo
di Giovanni Falcone. In una stagione giudiziaria in cui le conoscenze
dell'apparato strutturale e funzionale di Cosa Nostra erano frammentarie e
parziali e, correlativamente, episodica e discontinua era stata l'azione
repressiva e punitiva dello Stato, diretta prevalentemente a colpire, con
risultati ovviamente deludenti, le singole manifestazioni criminose (si pensi
alle numerosissime assoluzioni per insufficienza di prove con le quali, negli
anni '60 e '70 si erano chiusi i processi di Catanzaro e Palermo a carico di
centinaia di mafiosi), Giovanni Falcone seppe cogliere la struttura unitaria,
verticistica, piramidale di Cosa Nostra, intuì che il fenomeno mafioso andava
affrontato con una strategia diversa da quella posta in essere sino ad allora (e
che si era dimostrata inefficace) ed elaborò un metodo investigativo del tutto
innovativo e straordinariamente incisivo che, a ragione, è stato definito
“rivoluzionario”. Nei primissimi mesi del 1980, il consigliere Rocco Chinnici
aveva incaricato Giovanni Falcone di istruire il procedimento penale a carico di
Rosario Spatola, un costruttore e faccendiere siciliano su cui gravava l'accusa
di gestire un grosso traffico di sostanze stupefacenti tra Palermo e New York,
dove coesistevano ben cinque “famiglie” mafiose dedite al commercio di armi e
allo spaccio della droga. Quel processo, in cui erano coinvolti importanti
soggetti legati a cosa nostra, consentì a Falcone di comprendere che la potenza
economica della mafia aveva superato i confini della Sicilia, che era riduttivo
e fuorviante indagare solo a Palermo e che, soprattutto, era necessario
penetrare nei “santuari” degli istituti di credito nei quali affluivano e
venivano “puliti” gli ingentissimi capitali accumulati con i traffici
internazionali di armi e droga. Perchè, argomentava Falcone, se la droga non
lascia quasi tracce (se non nella salute di colore i quali l'assumono, viene da
osservare), il denaro ricavato dal suo commercio non può non lasciare dietro di
sé tracce, segni, orme del suo percorso, del suo passaggio da chi fornisce la
droga a chi l'acquista.
Ed allora era necessario fare un passo in avanti,
dare una svolta definitiva alla strategia di attacco alla mafia economica e
finanziaria operante anche all'estero, in particolare negli Stati Uniti ed in
Canada, intensificando la collaborazione con gli organi investigativi e
giudiziari di quelle nazioni. Vedeva così la luce il “metodo Falcone”,
mediaticamente inteso “follow the money”, inseguire il denaro. Venivano svolte
accurate e mirate indagini bancarie, patrimoniali e societarie, in Italia ed ora
anche all'estero, nei confronti di centinaia di soggetti al fine di rintracciare
e portare alla luce, infrangendo il segreto bancario, sino ad allora considerato
alla stregua di un totem inviolabile, rapporti di affari, contatti,
trasferimenti di somme di denaro da un soggetto all'altro, venivano passate al
setaccio migliaia di assegni bancari e numerosissima altra documentazione
bancaria (il tutto compendiato in ben sei dei quaranta volumi della
ordinanza-sentenza depositata l'8 novembre 1985) al fine di acquisire la prova
inconfutabile, sino ad allora quasi mai raggiunta, di rapporti di conoscenza e
di affari illeciti tra mafiosi, trafficanti di denaro sporco e colletti bianchi,
ostinatamente negati dagli interessati. Ma il successo della vincente strategia
attuata con il “metodo Falcone” è stato dovuto anche allo straordinario lavoro
di squadra posto in essere dal pool antimafia, fortemente voluto e mirabilmente
guidato dal consigliere Antonino Caponnetto, un organo giudiziario non previsto
dall'allora vigente codice di procedura penale, ai cui componenti, in attuazione
di un disegno non del tutto innovativo ( era stato sperimentato, alcuni anni
prima, nella azione di contrasto al terrorismo), vennero affidate le indagini
sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso in modo che,
lavorando in stretto collegamento fra di loro, fosse possibile uno scambio di
notizie ed informazioni sui risultati delle indagini espletate da ciascuno di
essi ed il patrimonio di notizie così acquisite da ognuno degli inquirenti non
fosse disperso ma fosse portato a conoscenza degli altri colleghi. Ma alla
strategia vincente del pool antimafia ha contribuito anche la fattiva
collaborazione di appartenenti ai reparti investigativi della polizia, dell'arma
dei carabinieri e della guardia di finanza, dotati di una elevata
professionalità e di un non comune spirito di servizio, divenuti anche essi
protagonisti di quel perfetto “gioco di squadra” che ha reso possibile esperire
la prima, efficace e vincente azione di contrasto a “cosa nostra”, quella
“pericolosissima associazione criminosa che, con la intimidazione e la violenza,
ha seminato e semina morte e terrore”, come venne definita nell'incipit
dell'ordinanza-sentenza depositata l'8 novembre 1985. Oggi, a distanza di circa
trentacinque anni, il “metodo Falcone” è comunemente utilizzato, con risultati
mai raggiunti prima, in Italia ed all'estero, avendo segnato una svolta epocale,
fissato un punto di non ritorno, delineato uno spartiacque definitivo con i
precedenti sistemi di indagine utilizzati nella lotta di contrasto a qualsiasi
forma di criminalità organizzata.
Il “metodo Falcone” era lui stesso, uomo
e giudice, scrive il 23 maggio 2018 su "La Repubblica"
Pietro Grasso - Giudice a latere della Corte di Assise del maxi processo,
Procuratore nazionale antimafia, ex Presidente del Senato della Repubblica. Le
mie conoscenze ed esperienze personali, professionali ed istituzionali mi
inducono ad affermare che l’espressione “metodo Falcone” è una approssimazione
generica e superficiale, usata spesso per riferirsi ad ambiti diversi e che
riesce a dare l’immagine, di volta in volta parziale, solo di talune peculiarità
dell'azione di Falcone, senza riuscire a coglierne per intero la complessità e
l’importanza. Ricordo che lui stesso non amava quell'espressione, ritenendola
quasi alla stregua di quell’altra dispregiativa qualificazione dei risultati
delle sue indagini come “teorema Falcone”. In realtà il “metodo Falcone” era
Falcone medesimo, la sua stessa personalità, il suo modo di essere e di
concepire in maniera rivoluzionaria la funzione del giudice istruttore del
vecchio codice di procedura penale. Anziché, come in passato, limitarsi a
verificare gli elementi raccolti dalla polizia giudiziaria nei rapporti
presentati, Falcone iniziò a dirigere direttamente le indagini, compiendo
personalmente tanti atti, come interrogatori di imputati e assunzioni di
testimoni, o delegandone altri specificatamente volti a trovare riscontri
obiettivi. Io stesso potei rendermi conto personalmente di questa sua nuova
concezione del ruolo di giudice istruttore.
ERA DIVERSO, ERA UN FUORICLASSE. Giovanni Falcone
aveva iniziato la sua carriera in magistratura dapprima come Pretore a Lentini,
poi come giudice a Trapani, finché nell’estate del 1978 chiese e ottenne il
trasferimento presso il Tribunale di Palermo. Dopo una prima esperienza alla
sezione fallimentare, nell’autunno del 1979 e dopo l’omicidio del giudice
Terranova e la nomina a capo dell’ufficio istruzione di Rocco Chimici, venne
accolta la sua domanda di essere assegnato a quest’ultimo ufficio. Io in quel
periodo, giovane sostituto procuratore presso la Procura di Palermo, mi trovai a
seguire da P.M. il caso di rinvenimento di una carcassa di un ciclomotore
rubato, con numero di matricola abraso. Un fatto assolutamente insignificante
destinato a concludersi, come tanti altri, con una richiesta di archiviazione
contro gli ignoti autori del furto. Grande fu la mia sorpresa quando mi resi
conto che Falcone, nel restituirmi il fascicolo per le mie ulteriori richieste,
trattò questa istruttoria con lo steso scrupolo con cui si indaga su un
omicidio. Affidò una perizia al medico legale Paolo Giaccone (ucciso da Cosa
Nostra l’11 agosto 1982), che aveva frattanto sperimentato un sistema per
ricostruire il numero di matricola; attraverso questo risalì al derubato, cui
restituì il motorino; trovò dei testimoni e fece arrestare i ladri,
individuandoli in ragazzi del quartiere. Scoprii così che Falcone era un
magistrato che non trascurava nulla, neanche le cose minime, che prendeva a cura
i diritti delle vittime, che manifestava una tenacia investigativa ed un impegno
eccezionali. Mi resi subito conto che era diverso da tutti noi: era un
fuoriclasse. Anche Rocco Chimici intuì subito le sue qualità e gli affidò sin
dal maggio 1980 alcuni rilevanti indagini sulla mafia e sul fiorente traffico di
stupefacenti fra Italia e USA, come quelle contro Spatola Rosario + 120 imputati
e contro Mafara Francesco ed altri. Il primo processo riguardava i rapporti tra
la mafia siciliana e quella statunitense nel traffico di eroina fra i due
continenti, l’affare Sindona e il reinvestimento dei profitti; il secondo aveva
avuto origine con l’arresto all’aeroporto di Roma Fiumicino di un belga con 8 kg
di eroina destinata ad una famiglia mafiosa palermitana. Frattanto al quadro
generale investigativo Falcone collegò altri fatti: il sequestro da parte del
Capo della Squadra mobile di Palermo Boris Giuliano (ucciso il 19 luglio 1979)
di 4 kg di eroina nel covo di via Pecori Giraldi, frequentato da Leoluca
Bagarella; il sequestro di una valigia all’aeroporto di Palermo contenente
500.000 dollari e magliette di pizzerie di New York (da qui nasce il nome
dell’indagine “Pizza Connection”), cui seguì dopo pochi giorni il sequestro a
New York di valigie piene di eroina purissima. Infine la scoperta presso una
villetta di Trabia (nei pressi di Palermo) di un laboratorio per la produzione
di eroina gestito da Gerlando Alberti, a cui si arrivò seguendo tre chimici
francesi inviati a Palermo dal “clan dei marsigliesi” per far apprendere ai
mafiosi il procedimento di raffinazione e trasformazione della morfina base in
eroina purissima.
LA SCOPERTA DELLE RAFFINERIE DI EROINA. Nel
prosieguo dell’indagine sul sequestro all’aeroporto di Roma di 8kg di eroina,
Falcone ottenne dal belga arrestato (Gillet) e da altri due corrieri (un altro
belga, Barbé, e uno svizzero, Charlier) delle sensazionali dichiarazioni che
aprirono degli scenari assolutamente inaspettati. Rivelarono infatti di essere
stati, tra l’altro, incaricati di reperire in Medio Oriente, ed in particolare
in Turchia e in Libano, morfina base da portare a Palermo, che, una volta
trasformata in eroina con alto grado di purezza, provvedevano essi stessi a
consegnare in Usa da dove, di ritorno, portavano a Palermo e in Svizzera ingenti
quantità di dollari, provento della droga. Si ebbe così l’importante riscontro
che la mafia non importava più l’eroina, ma la produceva direttamente. E
sull’onda di tale svolta investigativa si accertò che per il traffico di
stupefacenti si era riproposta una struttura analoga a quella del contrabbando
di tabacchi, con partecipazione per quote e con utilizzazione, da parte dei
mafiosi Nunzio La Mattina, Tommaso Spadaro e Giuseppe Savona, dei canali del
“Triangolo d’oro” del sud est asiatico (Thailandia, Laos, Birmania), per
l’approvvigionamento della morfina. Falcone si trovava proprio a Bangkok a
seguire le tracce di tali traffici in collaborazione con la polizia thailandese
il 29 luglio 1983, giorno della strage del suo capo, Rocco Chinnici. Aveva
compreso che la mafia siciliana operava non solo in Sicilia, ma anche in altre
zone d’Italia e all’estero, per cui attraverso la cooperazione internazionale,
basata soprattutto sui rapporti personali, bisognava viaggiare e cercare
contatti e prove al di fuori degli uffici. I primi contatti furono stabiliti con
i magistrati di Milano nell’ambito del processo Spatola, perché in quella città
era stato sequestrato il più grosso quantitativo di eroina (40kg), che,
provenendo da Palermo, avrebbe dovuto raggiungere gli U.S.A., eludendo i
pervasivi controlli agli aeroporti di Palermo e di Roma. Falcone convinse il
collega milanese a trasmettere per competenza l’indagine a Palermo, istaurando
un clima di fiducia e di collaborazione, che si rivelò particolarmente
fruttuoso, anche coi magistrati della Procura milanese Colombo e Turone nel
corso delle indagini sul caso Sindona, riuscendo a ricostruire tutti i suoi
movimenti ed il ferimento compiacente da parte del medico Miceli Crimi.
I SUOI RAPPORTI CON L'FBI E CON RUDOLPH GIULIANI.
Identica e feconda attività di cooperazione internazionale venne svolta da
Falcone con l’ufficio del Procuratore distrettuale di New York, Rudolph Giuliani
e coi suoi collaboratori Louis Free e Richard Martin. Al di là dei trattati
internazionali e di precedenti significativi, gli strettissimi e amichevoli
rapporti personali instaurati gli consentirono di muoversi con concretezza e
speditezza, al di fuori delle formalità delle rogatorie internazionali, nello
scambio di informazioni sui rapporti tra le famiglie mafiose siciliane ed i
componenti di cosa nostra americana. Falcone fece tesoro anche degli strumenti
investigativi usati in maniera pragmatica dai colleghi statunitensi, come i
collaboratori di giustizia e gli infiltrati, figure che sarebbero state dopo
molti anni (1991), introdotte anche nel nostro ordinamento. Si gettarono anche
le basi per un accordo Italia-Usa su collaborazione giudiziaria ed estradizioni
che venne sottoscritto nel 1984. Poiché molti indagati nelle intercettazioni
telefoniche disposte sia dalla DEA e poi dall’FBI parlavano in dialetto
siciliano stretto, per accorciare i tempi delle trascrizioni in inglese e in
italiano, di comune accordo, squadre della polizia italiana si trasferirono da
Palermo in Usa, per procedere direttamente all’ascolto delle conversazioni.
L’idea di squadre investigative comuni era per quei tempi assolutamente
innovativa, realizzabile soltanto per la fiducia e il rispetto dei ruoli e delle
regole che Falcone aveva il pregio di saper infondere. Frattanto erano stati
scoperti, a Palermo, altri laboratori per la raffinazione dell’eroina. Un’altra
importante indagine, che poi confluì formalmente nella “pizza connection” e nel
Maxiprocesso, venne generata dall’attività di un infiltrato dagli agenti
americani, tale Amendolito, reclutato dalla mafia siculo-americana per
trasferire valigie piene di dollari in piccolo taglio dapprima a Nassau, nelle
Bahamas, e poi in Svizzera in banche di Lugano e Zurigo. Parte di quei soldi
venivano reinvestiti nel traffico, una parte tornava a Palermo e veniva
depositata in banche con false attestazioni di vendita di prodotti
agroalimentari e parte ancora finiva nell’impresa edile di Rosario Spatola.
Falcone, per ricostruire i flussi di denaro, spulciava ogni singolo assegno,
chiedendone la causale ad ogni emittente o giratario con una tenacia ed uno
scrupolo quasi maniacale, che però gli consentì di entrare nelle banche allora a
completo ed omertoso servizio dei mafiosi, ricostruendo legami, rapporti e
relazioni, che avrebbero in seguito fornito adeguati riscontri alla
ricostruzione delle famiglie mafiose e della struttura piramidale di Cosa
Nostra, rivelata dalle dichiarazioni dai più importanti collaboratori di
giustizia. Falcone non si consentiva nessuna distrazione o superficialità e si
dedicava con la massima attenzione ai penetranti controlli bancari, alla
certosina ricostruzione di società (vere e proprie scatole cinesi), affari,
rapporti di “comparatico” (compare di battesimo, di cresima o d’anello) e
relazioni parentali frutto di matrimoni reciprocamente intrecciati tra rampolli
di famiglie mafiose, per cementare coi rapporti di sangue i legami associativi.
Falcone non tralasciava nulla e si precipitava ovunque in Italia e all’estero
avesse notizia dell’arresto di un trafficante di droga, di esperti in materie
specialistiche, avulse dalla diretta competenza dell’organizzazione, come
chimici, riciclatori, professionisti o imprenditori, per cercare connessioni con
cosa nostra. Manteneva contatti con giudici, investigatori e polizie di mezzo
mondo, per mettere insieme tutte le informazioni possibili a disegnare un quadro
probatorio complesso. Inoltre, aveva inaugurato la prassi di essere presente con
attenti sopralluoghi dove erano stati commessi omicidi o stragi. Tutti questi
comportamenti innovativi per il ruolo del giudice istruttore gli avevano fatto
affibbiare la denigrante nomea di “giudice sceriffo” e “giudice planetario”. A
tutti i soggetti con cui veniva in contatto, Falcone garantiva rispetto delle
loro funzioni, reciprocità nello scambio delle informazioni, rigorosa difesa del
segreto istruttorio: ciò gli conferiva un patrimonio di credibilità, di
imparzialità e di fiducia che convincerà anche tanti mafiosi a collaborare, e
solo con lui. Tutto ciò faceva parte del suo “metodo “? Certamente sì, ma non si
può liquidare solo con questo. Falcone credeva anche nell’importanza del lavoro
di gruppo, del coordinamento delle indagini, e nella necessità di non
disperdere, attraverso nuove tecnologie, la memoria dei singoli fatti
d’indagine.
UNA NUOVA STRADA FINO AL MAXI PROCESSO. Ad aprire
questa strada giuridico-organizzativa fu Chinnici. Quando, dopo l’omicidio del
collega Cesare Terranova divenne capo dell’ufficio Istruzione del Tribunale di
Palermo, del quale già faceva parte come giudice anziano, diede nuovo impulso
all’ufficio, dirigendo personalmente tutte le indagini più importanti come
quelle sui cosiddetti omicidi eccellenti (Mattarella, La Torre, Dalla Chiesa) e
affidando a magistrati di indubbio valore, come Falcone, Borsellino, Di Lello e
Guarnotta, le altre inchieste più rilevanti come quelle sul costruttore Rosario
Spatola, sull’omicidio del Capitano dei carabinieri Emanuele Basile, e su
Michele Greco + 161, così creando i presupposti per quel pool antimafia, che
avrebbe sviluppato al massimo la sua potenzialità con il successore, Antonino
Caponnetto. Questi, infatti, col pieno accordo dei citati magistrati,
validissimi sotto il profilo delle tecniche investigative e dotati di
ineguagliabile tensione morale, formò attraverso la co-assegnazione di tutte le
istruttorie pendenti, un gruppo coeso, capace di una particolare efficienza e
laboriosità, l’unico idoneo a indagare sui mille rivoli dell’attività della
mafia. Superando i problemi procedurali e sostanziali del vecchio codice, che
prevedeva la monocraticità del giudice istruttore, e adottando soluzioni già
sperimentate, anche per la condivisione dei rischi, dai giudici di altri uffici
del nord nel contrasto al terrorismo, fu possibile coordinare e ricondurre ad
un’unica centrale investigativa, diretta nel quotidiano da Giovanni Falcone, una
massa innumerevole di episodi delittuosi, di documenti e di pregresse indagini.
Così inaugurando un nuovo metodo di indagine, che collegava i tanti filoni
legati unicamente, più che da connessioni soggettive o oggettive, dalla
riferibilità dei reati all’organizzazione mafiosa cosa nostra, di cui era
intuita quella struttura unitaria, verticistica, che sarà svelata
successivamente da Buscetta e avallata da altri collaboratori di giustizia. Per
la prima volta, attraverso le risultanze degli ultimi dieci anni di indagine, si
potè tracciare un’immagine più aderente alla realtà criminale di Cosa Nostra,
già tracciata, in passato, ed in ultimo col rapporto Michele Greco +161, dalla
polizia giudiziaria attraverso fonti confidenziali, che, in mancanza di
riscontri documentali e testimoniali, avevano portato sempre all’assoluzione dei
mafiosi. Fu un lavoro di gruppo, ma che si fondava sulla capacità strategica di
Giovanni Falcone, sulla capacità di trovare rimedi e soluzioni a problemi che
apparivano insuperabili, che andavano dall’ottenere dal Ministero risorse
materiali e addirittura di costruire un’aula bunker ad hoc per il Maxiprocesso
sino all’interpretazione inedita di una norma. L’enorme quantità di lavoro, la
sua singolare abilità nel prevedere gli sviluppi delle indagini e
nell’organizzare il lavoro degli altri componenti del pool, il necessario
coordinamento di tutto il materiale raccolto, anche tramite precise e puntuali
deleghe alla polizia giudiziaria, trovarono poi, il prezioso, determinante e
valido contributo di Buscetta che, a partire dal luglio del 1984, svelò regole,
strutture e storie delle famiglie di cosa nostra, avallate da una miriade
impressionante di riscontri. A questo apporto, seguì quello di numerosi altri
collaboratori, che mostrarono anche il volto violento della mafia, descrivendo
nei minimi dettagli decine e decine di omicidi, strangolamenti, cadaveri sciolti
nell’acido. E si deve allo scrupolo investigativo di Giovanni Falcone, se,
seppur, dopo tanti anni dai fatti, a seguito di ispezioni, sequestri, rilievi e
perizie anche su una vecchia corda, rinvenuta nella cosiddetta “camera della
morte”, vennero trovate tracce di sangue e di cellule umane, inequivocabile
riscontri che resero credibili i racconti dei pentiti e rafforzarono l’impianto
probatorio del maxiprocesso. Così come fatti apparentemente non conducenti, come
le minacce epistolari ad una famiglia non gradita sul territorio per
costringerla a sloggiare, furono utilizzati per dimostrare in maniera
inequivocabile la condizione di assoggettamento, intimidazione e di omertà in
cui vivevano i cittadini, a riprova dell’elemento costitutivo dell’associazione
di tipo mafioso. L’arresto poi di Ciancimino e dei cugini Nino e Ignazio Salvo,
potenti esattori siciliani, il rinvio a giudizio di questi ultimi tra gli
imputati del maxiprocesso (fu processato solo il secondo, essendo Nino deceduto
in Svizzera prima della fase processuale), furono utilizzati da Falcone per
dimostrare che cosa nostra, come dichiarato da Buscetta, non era una comune
organizzazione criminale, da contrastare soltanto con operazioni di polizia, ma
un potere con ramificazioni nascoste nell’imprenditoria, nella pubblica
amministrazione, nella politica, tra i professionisti e nella società, dato che
i cugini Salvo, appartenenti a cosa nostra ed in particolare alla famiglia di
Salemi (Trapani), erano stati per anni il fulcro tra affari, mafia e politica
regionale e nazionale. Infine, a maggiori riprova dei rapporti di cosa nostra
con entità eversive esterne, di notevole interesse si rivelò il coinvolgimento,
riferito da Buscetta in istruttoria e confermato in aula dallo stesso Luciano
Liggio, dell’organizzazione, attraverso i suoi vertici del tempo, nella fase
preparatoria del Golpe Borghese del 1970. Liggio voleva delegittimare il
pentito, attribuendogli delle interessate omissioni e si ritrovò in aula come un
boomerang le puntuali dichiarazioni di Buscetta nei verbali precedentemente rese
a Falcone, trattenute per approfondimenti istruttori. Anche in questo consisteva
il “metodo Falcone”: saper prevedere e disinnescare preventivamente le trappole.
Sapeva perfettamente che un processo poteva essere distrutto da un solo errore,
bastava un nonnulla per poter incrinare irrimediabilmente la credibilità di un
pentito o di un perfetto impianto accusatorio. Per questo era maniacale nella
revisione e nel controllo di ogni singola carta, di ogni atto, di ogni
riscontro. Cercava di evitare al massimo gli incidenti di percorso provocati da
leggerezza, superficialità e sciatteria.
LA "GESTIONE” DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA. Con
questo metodo, con queste qualità, potè impostare una istruttoria, prima ed un
processo, poi, come il maxiprocesso di Palermo, con 475 imputati, 438 capi di
imputazione che comprendevano non solo l'associazione per delinquere di tipo
mafioso, ma anche tutti i reati contestati a componenti o a criminali collegati
a cosa nostra, come estorsioni, rapine, traffico di stupefacenti e 120 omicidi,
che comprovassero le attività anche a livello internazionale
dell'organizzazione. E questa fu una ben precisa scelta di Giovanni Falcone,
dato che qualcuno aveva prospettato la possibilità di portare a giudizio solo
gli imputati detenuti, proprio per accelerare i tempi ed evitarne la
scarcerazione, ma Falcone giustamente ritenne che solo una visione complessiva
di tutti i fatti ed i soggetti collegati a cosa nostra potesse fornire ai
giudici di una corte di assise, composta anche da cittadini non togati,
l'inequivocabile contesto probatorio sull'esistenza dell’organizzazione, fino ad
allora sempre negata. Sarebbero, peraltro, rimasti fuori dal processo tanti capi
allora latitanti, come Riina e Provenzano e difficile da comprendere il loro
contributo alla commissione provinciale di Palermo, organo propulsivo
dell'associazione che ne testimoniava la struttura unitaria e verticistica. Il
metodo Falcone, avuto riguardo al maxiprocesso, fu quindi quello di ripercorrere
i fatti e i delitti di mafia a partire dalla prima fase successiva alla strage
Ciaculli e di viale Lazio, cui partecipò anche Provenzano, sino alla cosiddetta
seconda guerra di mafia, caratterizzata dalla supremazia delle famiglie
appartenenti alla fazione dei “corleonesi”, che si impadronirono di tutti
traffici, anche quello lucroso degli stupefacenti, mettendo insieme tutte le
pregresse indagini bancarie, cementate dalle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia, primo fra tutti Tommaso Buscetta, nonchè le relazioni esterne di cosa
nostra con le realtà imprenditoriali e politiche, rappresentate dei cugini Salvo
e da Ciancimino. Cioè con quell'area che riusciva a far realizzare investimenti
produttivi e grandi profitti, a persone che allora non avevano la competenza e
la professionalità per farlo. Il “metodo” comprendeva anche magistrati e
strutture di polizia giudiziaria specializzate, centralizzate e coordinate, che
mettessero insieme tutti quegli indizi provenienti dalla captazione delle
intercettazioni telefoniche e soprattutto ambientali, da eventuali infiltrati e
soprattutto dai collaboratori di giustizia. La gestione di questo piccolo
esercito di coloro che via via uscivano dall'organizzazione fu estremamente
difficile per il pool antimafia, per l'assenza di norme che ne regolassero i
rapporti con i requirenti e con gli addetti alla loro tutela. Per tanti anni la
loro protezione fu affidata al volontarismo, all'improvvisazione e alla
genialità dei singoli uffici investigativi. Falcone per Buscetta, prima, e per
Contorno e Marino Mannoia, in un secondo momento, si dovette “inventare” un
accordo con le autorità statunitensi, che prevedesse “il prestito” temporaneo
dei pentiti per farli testimoniare nel processo americano della “Pizza
connection”, in cambio di un'adeguata protezione. Si dovettero attendere ben
sette lunghi anni dalle prime dichiarazioni di Buscetta (luglio 1984) per
ottenere nel 1991 la prima legge che stabilisse i requisiti della
collaborazione, i diritti e i doveri dello status di collaboratore, oltre che
misure di protezione e di copertura dell'identità, compatibili con il nuovo
processo penale, anche sotto il profilo dei benefici. A Falcone non mancò mai la
piena consapevolezza (tant'è che ne incriminò qualcuno per calunnia come il
catanese Pellegriti) delle insidie che, in una procedura assolutamente
garantista dei diritti della difesa, comportasse l'uso di tale strumento di
indagine. Il suo metodo, che era solito suggerire ai giovani magistrati, era
quello che, in senso figurato, si doveva sempre mettere un tavolo tra
l'inquirente e il pentito, senza confidenziali incontri al caminetto, per
rendere manifestamente visibile all'interlocutore che davanti aveva un
rappresentante di quello Stato, che fino a poco prima aveva considerato un
nemico da battere, e a cui doveva dare contezza della sua assoluta credibilità.
Il metodo Falcone applicato ai pentiti suggeriva di acquisire il maggior numero
possibile di dettagli, particolari, circostanze, anche apparentemente
insignificanti, circa i fatti caduti sotto la loro diretta percezione, per
potere trovare più agevolmente i relativi riscontri. Per dare il giusto rilievo
alle motivazioni che avevano portato alla determinazione di rompere il vincolo
di sangue acquisito col giuramento di appartenenza a cosa nostra, bisognava
approfondire ed esemplificare con fatti concreti quelle espressioni gergali
spesso usate dai dichiaranti, come, ad esempio, “Tizio è nelle mani di…”, “Caio
è un uomo di…”, “Sempronio è collegato con..., Mevio è coinvolto in…”, così come
valutazioni e opinioni assertive e spesso immotivate. Naturalmente, in
applicazione del rigore metodologico di Falcone, bisognava evitare di mostrare
particolare interesse per un argomento o per taluno degli indagati; accertare se
il pentito avesse eventuali ragioni personali di vendetta o di ritorsioni nei
confronti degli accusati; impedire qualsiasi possibilità di incontro dei
collaboratori, in modo da poterli utilizzare, senza sospetti di preventivi
accordi, come riscontri reciproci; ed, infine, mantenere un atteggiamento
critico, non supinamente acquiescente, attento ad approfondire ogni elemento
utile per un giudizio di piena attendibilità, come, ad esempio, la spontanea
ammissione di responsabilità per reati non contestati. Il rigore metodologico di
Falcone era un giusto equilibrio tra l'estrema cautela nel raccogliere
dichiarazioni da soggetti che si erano macchiati di gravissimi delitti e l’ovvia
considerazione che in una organizzazione criminale, che aveva fatto del segreto
e dell'omertà uno dei suoi fattori di sopravvivenza, solo dalla viva voce dei
protagonisti era possibile trarre elementi di conoscenza, altrimenti non
acquisibili, di gravissimi episodi delittuosi.
SEMPRE ALLA RICERCA DI VERITA'. Sono queste le
ragioni per cui il maxiprocesso di Palermo riuscì a resistere a 1000 eccezioni
di nullità, impugnazioni, critiche anche da parte della politica,
dell'informazione e soprattutto di una folta schiera di grandi avvocati di tutta
Italia. Fu così che il 30 gennaio del 1992 la corte di Cassazione presieduta da
Arnaldo Valente (cui aveva ceduto il posto il collega Carnevale per ragioni di
opportunità, stante l'infuriare di aspre polemiche per la mancata rotazione
nelle cariche) pronunciò la sentenza definitiva che sanciva l'esistenza di cosa
nostra e della sua struttura unitaria e verticistica, accogliendo in pieno
l'impianto accusatorio della sentenza di primo grado. Un colpo durissimo per
un’organizzazione che per la prima volta, dalla sua ultracentenaria esistenza,
vide i suoi vertici condannati all'ergastolo, col vantaggio, per gli altri
giudici che si sarebbero occupati di cosa nostra, di potersi limitare a provarne
l'appartenenza. Si infranse così il mito dell'invincibilità e dell'impunità
della mafia e si realizzò la concreta azione di uno Stato che in tutte le sue
componenti, magistratura, forze di polizia, governo e Parlamento, si mostrò
finalmente deciso a interrompere il rapporto di connivenza, di sudditanza e di
indifferenza di cittadini e istituzioni. Del “metodo Falcone” non bisognerebbe
trascurare un particolare e cioè che Falcone, nonostante tutte le accuse
rivoltegli in vita: di essere dapprima comunista, poi andreottiano, infine
socialista (quando fu chiamato al ministero della giustizia da Martelli), non si
fece mai influenzare da idee o motivazioni che non rientrassero nella sua
strategia di politica giudiziaria. Seguendo la sua visione della lotta alla
mafia, cercava di volta in volta di ottenere l'aiuto e la collaborazione di chi
poteva dargli l'opportunità di realizzare il suo obiettivo: l’ostinata ricerca
di verità e di giustizia nel solo interesse di liberare i cittadini e le
istituzioni dalla pesante oppressione della mafia.
IL "METODO FALCONE” COME MATERIA DI STUDIO. In
conclusione, tutti i successi ed i risultati ottenuti sino ad oggi nel contrasto
a cosa nostra e alle altre organizzazioni di tipo mafioso, non ho remore ad
affermarlo con convinzione, costituiscono il frutto diretto del “metodo”, se
vogliamo chiamarlo così, o meglio della estrema capacità personale e
professionale di Giovanni Falcone. Infatti, le fondamenta della legislazione
antimafia furono edificate proprio da lui, quando, dopo gli ostacoli che lo
avevano convinto a lasciare la procura di Palermo, si trasferì, come direttore
generale degli affari penali presso il ministero della giustizia. In quell’anno
(era il 1991), oltre la già citata legge sui pentiti e sui sequestri di persona,
videro la luce norme per obbligare le banche e gli istituti finanziari a
segnalare le operazioni sospette ai fini di riciclaggio di proventi illeciti;
furono istituiti i servizi centrali (ROS, SCO, GICO) e interprovinciali di
polizia giudiziaria, costituiti rispettivamente da carabinieri, polizia di stato
e guardia di finanza, per assicurare il collegamento investigativo. Fu creata,
per accentrare tutte le indagini sulla mafia, la direzione investigativa
antimafia, organo interforze accostato dei giornali ad una sorta di FBI
italiana, la procura nazionale antimafia (DNA) e le direzioni distrettuali
antimafia DDA), strutture indispensabili per coordinare tutte le indagini svolte
dalle procure distrettuali sulla criminalità organizzata nazionale e
transnazionale e sui traffici collegati. Questo modello, questo metodo di lavoro
condiviso era, per Giovanni Falcone, null’altro che la trasposizione sul piano
nazionale dell'esperienza del pool antimafia maturata negli anni del suo
eccezionale impegno a Palermo. È difficile oggi spiegare, soprattutto a chi non
ha vissuto quegli anni eroici, quali forze, quale coraggio, quale capacità di
resistenza siano state necessarie per superare migliaia di ostacoli personali,
materiali e giuridici. È difficile oggi raccontare come Falcone portasse avanti
il suo lavoro nonostante le invidie, le calunnie, i veleni e gli schizzi di
fango lanciati contro di lui. Così come far comprendere con quale spirito di
servizio e rispetto dei ruoli istituzionali, dopo il trasferimento di Caponnetto
e la nomina di Antonino Meli come nuovo capo dell'ufficio istruzione, pur
preferito dal consiglio superiore della magistratura a lui, che più di tutti la
meritava, collaborò, suo malgrado, a smantellare e a smembrare tutte le
indagini, trasferendole ad altri uffici giudiziari, dal suo capo ritenuti, con
ottuso formalismo, competenti per territorio, secondo una logica e una strategia
giudiziaria completamente opposta rispetto a quella da lui precedentemente
seguita. Ritengo che oggi sia giusto che tutti gli operatori di giustizia e
tutti i cittadini sappiano quanto dobbiamo a Falcone e a quello che,
genericamente, è stato più volte definito come il “metodo Falcone”. Se proprio
vogliamo accettare questa definizione con tutto quello però che la
contraddistingue, ritengo che il miglior riconoscimento a tutta la sua vita
fatta di dedizione, di sacrifici e di professionalità sia quello di istituire
presso la Scuola Superiore della Magistratura, per meglio formare i giovani
magistrati, che si apprestano a svolgere funzioni così importanti per i
cittadini e per la società, una nuova materia: il “metodo Falcone”.
Quello che ha rappresentato per lo Stato,
scrive il 24 maggio 2018 su "La Repubblica" Ignazio De Francisci - Giudice del
pool antimafia dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo nei primi anni
'80, oggi è procuratore generale della Repubblica di Bologna. Dopo ventisei anni
dall’assassinio di Giovanni Falcone mi viene chiesto di raccontare cosa fosse il
“metodo Falcone”. Ho esitato a lungo prima di accogliere la richiesta di Attilio
Bolzoni perché mi sembrava di dire sempre le stesse cose e quindi essere poco
utile o, peggio, inutilmente ripetitivo. Poi ci ho ripensato, e ciò sia per la
cortese insistenza di Bolzoni sia perché sempre più spesso, incontrando giovani
colleghi o studenti, specie qui in Emilia Romagna, mi rendo conto quanto la
figura e le opere di Giovanni Falcone siano poco conosciute e quindi non siano
diventate memoria collettiva. Troppo poco si sa di lui e quindi torno a parlare
di lui, di quello che ha rappresentato per l'azione dello Stato italiano contro
la mafia. Troppe volte, quando dico che il 23 maggio devo essere a Palermo, mi
si chiede il perché; questa data non è entrata nella comune memoria e invece
dovrebbe essere scolpita nella coscienza di ogni italiano. Il segreto del metodo
Falcone non aveva nulla di segreto; era tutto nella persona di Falcone, nelle
sue qualità umane prima ancora che professionali. La sua assoluta serietà nel
lavoro, impegno totalizzante di tutta la sua vita. Lavorare con lui, che per me
fu un grande privilegio, significava adottare i suoi ritmi di lavoro o almeno
cercare di avvicinarsi a quelli. Falcone non aveva hobby, passatempi, non
giocava a calcetto, non scalava montagne, lui stava in ufficio. Le trasferte di
lavoro, anche all'estero, con Falcone sono state per me una scuola di elevato
livello, con esami continui, con lui sempre in prima fila e tu dietro a seguire,
a imparare, a stare zitto, a fare domande dopo, nelle pause. Si imparava a
interrogare i detenuti, con calma, a volte col sorriso, sempre con serenità e
rispetto. Mi tornano in mente mille episodi, alcuni anche divertenti, che per me
hanno significato apprendimento di tecniche, di stile, di vita professionale. La
prima trasferta a Milano con lui, interrogatori nella sede della Criminalpol.
Gli chiedo il permesso, a fine pomeriggio, di andare in piazza Duomo, non ci
andavo dagli anni dell'infanzia. Gli chiedo di andare insieme, mi risponde di
no: vai tu, io devo finire di leggere qualche carta. Lui non mollava mai. E poi
ancora a Marsiglia, seconda metà degli Anni Ottanta, indagine per un traffico di
stupefacenti tra Italia, Francia e Stati Uniti. La polizia francese ci invita a
pranzo prima degli interrogatori fissati nel pomeriggio; era una splendida
giornata di sole, ristorante sul mare, mi ricordo ancora quasi tutto il menu.
Lui mangia come tutti, ma finito il pranzo è pronto per iniziare a lavorare, io
molto meno, cerco di stare al passo, ma con esiti molto modesti. Quel giorno ho
imparato che quando si lavora, meno si mangia e meglio è. Lui capì la mia
difficoltà, non mi disse nulla, ma io sapevo che aveva capito e, almeno quella
volta, perdonato. E poi la sua lealtà nei confronti di tutti i colleghi, specie
quelli giovani, che trattava con rispetto e con grande umanità. Mi correggeva
qualche mio scritto sempre in punta di piedi, senza commenti sgradevoli, con
brevi tratti di penna stilografica. Non sopportava i superficiali, gli
spregiudicati, gli arruffoni. Era coraggioso come sanno esserlo le persone serie
che hanno consapevolezza dei rischi che corrono, ma credono di avere gli
strumenti per superarli. Ricordo perfettamente, durante un interrogatorio di
alcuni mafiosi americani negli Stati Uniti, le minacce che uno di questi gli
rivolse; in tono untuoso e con la faccia che dice più delle parole, in perfetto
stile mafioso. Io percepii la serietà della situazione, ma non lo vidi
particolarmente preoccupato, ma conscio che quella inchiesta aveva smosso acque
stagnanti. Aveva una fiducia illimitata nel rapporto con gli organi
investigativi degli Stati Uniti, preparava con precisione ogni viaggio oltre
Atlantico tutte le carte, le domande pronte, l’elenco degli atti da chiedere ai
colleghi americani. Si entusiasmava financo del caffè americano che ci veniva
offerto ovunque con generosità. Apprezzava quel sistema giudiziario, ma senza le
approssimazioni utilizzate da chi vuole importarlo da noi solo nei limiti della
convenienza del momento. Sognava un pubblico ministero nuovo, non poliziotto ma
che guidava la polizia giudiziaria, che partecipava attivamente alle indagini,
delegando solo l’indispensabile, interrogando imputati e testi, e soprattutto
conoscendo ogni carta del processo. Sono passati 26 anni. Che ne è
dell'insegnamento di Falcone? Quanto è stato realizzato della sua visione del
mondo giudiziario? Non sono il più indicato per rispondere a queste domande.
Certamente il Ministero della Giustizia (dove egli dette il meglio di sé), negli
anni, ha portato avanti molte delle sue idee e i metodi di indagine da lui
inventati e sperimentati sono stati diffusi in tutte le Direzioni Distrettuali
Antimafia, organismo che lui ideò e che ha consentito di accentrare in sede
distrettuale le indagini di mafia, obiettivo che oggi sembra facile aver
raggiunto, ma che, allora, fu una rivoluzione e che ha impiegato anni per
funzionare a regime. La Direzione Nazionale Antimafia, altro frutto delle sue
idee, anche se diversa da quella da lui pensata, si muove comunque nel solco del
metodo Falcone e del suo esempio. E non è poco.
Mafia: Fico, meglio mano in tasca che su
cuore di traditori Stato, scrive Adnkronos riportato
il 23 Maggio 2018 da "Il Dubbio". “Il rispetto per il Paese - scrive Fico -
passa da qui, da quello che noi facciamo ogni giorno, dalla dignità che con le
nostre azioni diamo alle istituzioni. Ma capisco che faccia più notizia una mano
tenuta in tasca per sei secondi mentre ero assorto da tutta quella energia e da
quelle […] “Il rispetto per il Paese -scrive Fico- passa da qui, da quello che
noi facciamo ogni giorno, dalla dignità che con le nostre azioni diamo alle
istituzioni. Ma capisco che faccia più notizia una mano tenuta in tasca per sei
secondi mentre ero assorto da tutta quella energia e da quelle emozioni,
piuttosto che tutto quanto detto e fatto in questa meravigliosa giornata.
Preferisco una mano in tasca per qualche secondo alla mano sul cuore di chi poi
tradisce lo Stato”. Poi il presidente della Camera prosegue sulla strage di
Capaci: “Ciò che avvenne quel 23 maggio del 1992 ha smosso l’anima del nostro
Paese, come ha smosso la mia. Ricordo perfettamente quel pomeriggio, quando si
diffuse la notizia della strage di Capaci e della morte di Giovanni Falcone,
della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta”. “Il percorso che
ho intrapreso in questi anni deriva anche da quella giornata, da quella
sensazione e da quella presa di coscienza che non avrei più dimenticato: bisogna
decidere da che parte stare, ogni giorno. Perché ogni giorno possiamo lottare
contro la mafia attraverso il nostro lavoro e le nostre azioni”.
Memoria d'accusa: quando Giovanni Falcone
denunciava il caso Palermo. Ecco l'intervento del
giudice ucciso che L'Espresso ha pubblicato in esclusiva il 18 settembre 1988.
«C'è un senso di scoraggiamento. Ci hanno messo nella condizione di non
muoverci», scrive Pietro Calderoni il 23 maggio 2018 su "L'Espresso". Ecco
l'atto d'accusa che il giudice palermitano Giovanni Falcone ha fatto domenica 31
luglio (1988 ndr) davanti al Comitato antimafia del Consiglio superiore della
magistratura. È una testimonianza eccezionale (l'audizione era segreta) e
sconvolgente con la quale il magistrato più esposto nella guerra contro “Cosa
nostra”, per la prima volta, ha parlato esplicitamente degli intralci nel suo
lavoro, dei contrasti insanabili col suo capo, il consigliere istruttore
Antonino Meli, del tentativo di smembrare e di fatto disinnescare il “pool”
antimafia, dell'impossibilità - visto il clima che tira nell'Ufficio istruzione
di Palermo - di continuare a istruire i processi. Insomma, dice Falcone,
qualcosa si è inceppato nella lotta alla mafia. E spiega il perché. Falcone
denuncia che, al Palazzo di giustizia di Palermo, è in corso uno scontro,
decisivo, tra due modi d'intendere la lotta alla mafia. Da una parte, il
consigliere Meli, reo di voler gestire il delicatissimo momento giudiziario in
forma esclusivamente burocratica, rallentando l'iter dei processi più importanti
e svilendo il lavoro del pool; dall'altra parte, appunto, i giudici del pool
antimafia, con Falcone in testa, preoccupati per questo calo di tensione negli
uffici giudiziari palermitani. È una polemica che nasce, in realtà, il 20 luglio
dopo una intervista, a “Repubblica”, del giudice Paolo Borsellino, fino a
qualche tempo prima nel gruppo dei giudici antimafia di Palermo e poi passato a
dirigere la procura della Repubblica di Marsala. Borsellino fa pesanti accuse:
«Stiamo tornando indietro come vent'anni fa», dice. E aggiunge: «Le indagini si
disperdono in mille canali e intanto Cosa Nostra si è riorganizzata come prima,
più di prima». Non solo: Borsellino sostiene che Meli ha cominciato a
smantellare, con i pretesti più diversi, il pool anti mafia. Meli replica
stizzito che non è vero. Le gravi parole del giudice Borsellino, però, non
cadono nel vuoto. Nemmeno 24 ore dopo l'intervista, infatti, è addirittura il
presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, a intervenire chiedendo che sia
fatta piena luce su quello che sta accadendo all'interno del Palazzo di
giustizia di Palermo. Lo scontro fra Meli e Falcone, fino a quel momento covato
sotto la brace, emerge in tutta la sua crudezza. Uno scontro che, il 19 di
gennaio (1988 ndr), aveva avuto il suo prologo, quando il Consiglio superiore,
premiando l'anzianità rispetto alla professionalità e alla competenza specifica,
aveva deciso di nominare, a strettissima maggioranza, dopo lunghe discussioni e
spaccature, consigliere istruttore di Palermo proprio Meli invece di Falcone.
Alla fine di luglio, dunque, in una Roma oppressa da un caldo africano, le porte
del palazzo dei Marescialli, dove ha sede il Csm, si aprono per ascoltare le
ragioni dei protagonisti. È un'indagine il cui epilogo è destinato a emergere
dalla riunione del Consiglio fissata a partire da martedì 13 settembre. A
luglio, il giudice Borsellino conferma le sue parole. Subito dopo, davanti agli
11 membri del Comitato antimafia del Csm, si siede Giovanni Falcone. Ha appena
consegnato una lettera in cui chiede di essere trasferito in un altro ufficio;
lui, l'uomo che ha istruito il maxiprocesso, che per primo ha raccolto le
confessioni di Tommaso Buscetta, che ha incriminato il sindaco democristiano
Vito Ciancimino, che ha indagato per scoprire gli assassini dei grandi delitti
eccellenti, da quello di Piersanti Mattarella a quello di Pio La Torre, dice che
così non ha più senso andare avanti. E ricorda, accusa, elenca, davanti agli
altri giudici del Consiglio superiore della magistratura, portando esempi,
rievocando fatti, rivelando episodi rimasti fino a quel momento segreti. Il
lungo intervento di Falcone è introdotto dal consigliere Carlo Smuraglia:
«Falcone, la ringraziamo per essere qui. Lei conosce le ragioni... la preghiamo
di parlare». E il giudice parla.
Parole di Falcone. «Si è verificata purtroppo una
situazione di stallo che ci sta portando verso quella gestione burocratica dei
processi di mafia che è stata la causa non secondaria dei fallimenti degli anni,
dei decenni trascorsi. Cosi vengono a confronto due filosofie del fare il
giudice: quella che prevede una gestione burocratica-amministrativa-verticistica
dell'Ufficio e quella che tende ad ottenere i risultati dell'istruttoria. Il
consigliere Meli spesso, molto spesso, mi sollecita a chiudere le istruttorie,
ma certi processi hanno bisogno del loro sfogo, certi processi politici, come
l'omicidio Mattarella [era il presidente democristiano della Regione, dc, ndr.],
quello La Torre [era il segretario regionale del Pci siciliano, ndr.] o quello
Parisi [Roberto Parisi, presidente del Palermo calcio, ndr.] non si possono
chiudere, a meno che non si voglia fare il solito fonogramma al Commissariato
chiedendo l'esito di ulteriori indagini e, alla risposta che l'esito è negativo,
chiudere la solita bellissima sentenza contro ignoti. «Il problema è cominciato
a diventare più pressante con l'insediamento del consigliere Meli. Ci saremmo
aspettati quanto meno di essere convocati per uno scambio di idee, per discutere
dei problemi enormi, materiali e di gestione di tutti questi processi, ma nulla
di tutto questo è avvenuto... Se c'è una filosofia del pool, del lavorare
insieme in materie così intimamente connesse come quelle che riguardano le
attività mafìose, era proprio quella di cercare di seguire sempre l'evolversi
delle varie indagini per vedere attraverso un esame globale del fenomeno di
poter incidere in maniera più efficace; senonché ci siamo accorti che mano mano
le cose cambiavano. I processi venivano assegnati con un criterio da noi non
conoscibile e in contrasto coi criteri predisposti e approvati dal Consiglio
superiore della magistratura, criteri che prevedevano che a quel gruppo di
sezioni dovessero essere affidati tutti i processi di mafia... Tutto questo
invece non veniva osservato: non soltanto non veniva osservato, ma noi non ne
conoscevamo il perché».
IL SEQUESTRO MISTERIOSO. «Faccio un esempio, il
processo per l'omicidio di Tommaso Marsala [industriale, ucciso nel 1987,
titolare dell'appartamento-base dei killer del vicequestore Ninni Cassarà,
ndr.]: Marsala era imputato dell'omicidio Cassarà, era stato scarcerato per
mancanza d'indizi ma permanevano sul suo conto pesanti sospetti. A un certo
punto Marsala viene ammazzato: dopo l'inchiesta sommaria il processo contro
ignoti viene formalizzato e assegnato al giudice Lacommare. Egli prospetta dci
motivi di opportunità [poiché evidentemente non fa parte del pool antimafia,
ndr.], ma gli viene risposto che un po' tutti si devono occupare d'indagini di
mafia. «Lo stesso avviene col processo per il sequestro di Claudio Fiorentino
[il maggior gioielliere palermitano, rapito il 10 ottobre 1985, ndr.], che è uno
dei fatti più gravi e più significativi su cui occorre, a mio avviso,
approfondire le indagini. I Fiorentino erano già venuti fuori nel 1980, ai tempi
del processo Spatola [il clan mafioso in contatto anche con Michele Sindona,
ndr.] per una sorta di attività di riciclaggio di denaro, dollari statunitensi
di provenienza illecita, Il sequestro appariva abbastanza anomalo e soprattutto
in contrasto con un divieto di compiere sequestri di persona stabilito da Cosa
Nostra in Sicilia. Quindi delle due l'una: o il sequestro era finto o erano
cambiate le regole di Cosa Nostra; fra l'altro il sequestro era avvenuto in
territorio Partanna-Mandello, cioè in una zona molto vicina ai Corleonesi e
quindi si trattava di cercare di fare luce sull'episodio. Bene, questo processo
il Consigliere istruttore se lo assegna a se stesso senza dare nessuna
spiegazione in merito. A questo punto prendiamo atto di questa realtà e gli
chiediamo copia degli atti, una richiesta che ci consentiva di vedere se e quali
agganci potessero esserci con altri processi in corso. Tra l'altro segnaliamo al
Consigliere, nella nostra richiesta, l'esigenza indifferibile del potenziamento
del pool; gli abbiamo detto, nei modi più garbati, che in questa maniera si
smembra tutto, gli abbiamo spiegato i motivi per cui noi ritenevamo che quei
processi avessero attinenza al gruppo antimafia; infine gli abbiamo ricordato
che all'Ufficio istruzione esiste uno strumento informatico molto importante,
creato da noi giorno dopo giorno, per cui la conoscenza di quel processo ci
serviva anche per inserire gli atti nell'elaboratore elettronico...«Succede che,
di fronte a queste nostre richieste, il consigliere avoca la titolarità del
processo contro Cosa Nostra... E poi si rifiuta di trasmetterei copia degli atti
richiesti affermando che dovevamo chiedere atti determinati e non tutti gli
atti. Io mi chiedo com'é che potevamo chiedere atti determinati se non li
conoscevamo! «Poi sono cominciati ulteriori problemi, da ultimo questo processo
per l'omicidio di Antonio Casella (grosso imputato, chi si occupa di queste
indagini sa bene che significa questo nome: Edilferro eccetera), fatto di
gravità inaudita, perché significa una spaccatura all'interno della maggioranza
egemone [di Cosa Nostra, ndr.]. Naturalmente chiedo ai colleghi della Procura:
"Quando lo formalizzate, me lo fate sapere". Il processo viene assegnato al
collega Grillo, il quale, appena lo legge, va da Meli e gli dice: "Ma guardi,
cosa c'entro io?". Risponde Meli: "Ah, non me ne ero accorto''. Allora io dico,
come si fa a non accorgersi di un fatto del genere, significa non aver letto
nemmeno il rapporto, cioè fare l'assegnazione solo sulla copertina. Allora, per
rimediare, è un po' maligna la cosa, il Consigliere Meli assegna il processo per
l'istruttoria di questo omicidio a otto persone! Ora io chiedo, come si fa a
istruire così, un processo del genere? La risposta la lascio alla vostra
intelligenza. «E poi in queste assegnazioni, stranamente, alcuni colleghi del
gruppo antimafia non vengono presi in considerazione, nel senso che non vengono
loro assegnati questi processi, ma processi ordinari, processi per rapine...
Tutta una serie di processi del carico ordinario li abbiamo istruiti sempre; ma,
se si aumenta indiscriminatamente il carico ordinario, ci fermiamo tutti e
difatti quando io parlo di situazione di stalla, intendo dire che adesso le
indagini, gli interrogatori, gli esami testimoniali, li posso fare soltanto io
perché gli altri sono occupati a gestirsi l'ordinario. E a questo punto ci
blocchiamo tutti. «Ecco io non lamento altro; però una cosa è molto seria,
questa mancanza di comprensione dei problemi. Il Consigliere non ha letto ancora
una pagina del processo di cui è formalmente assegnatario, ma ha determinato
tutta questa serie di reazioni a catena per cui ci siamo inevitabilmente fermati
tutti. E io personalmente non intendo avallare una gestione di processi di
questa gravità in una visione burocratico amministrativa».
IL BLOCCO TOTALE. «Io non intendo assolutamente
sovraccaricare nulla e ho sempre ispirato la mia condotta alla volontà di
sdrammatizzare tutti i problemi, ma le condizioni obiettive sono queste: noi ci
troviamo bloccati da fatti che, presi uno per uno, sembrano delle miserie, ma
presi globalmente bloccano tutto. Tutta questa situazione all'interno
dell'Ufficio in realtà ha prodotto il blocco totale. Ci trastulliamo con vicende
che non meriterebbero nessuna attenzione, mentre sui nostri problemi non
riusciamo a concentrarci».
Domanda il consigliere Guido Ziccone, del
Sindacato magistrati: «Da come lei ha riferito i fatti, mi sembra di aver capito
che c'è una serie di difficoltà che mano a mano sono emerse, evidenziate dal
modo in cui questo pool ha ragionato e operato. È un modo che il Consigliere
istruttore avrebbe voluto o vorrebbe modificare?»
Falcone: «Io non so nemmeno se vuole che ci sia un
pool, e con quali persone, perché non ce ne ha informato ancora!».
Ziccone: «La cosa che mi colpisce, che colpisce
tutto il Paese... è come si arrivi a questa diagnosi d'impossibilità di andare
avanti... ».
Falcone: «C'è un senso di scoraggiamento da parte
dei colleghi... Le faccio un altro esempio (ma ne potrei fare centinaia di
questo esempi): processo per truffa di miliardi alla Sicilsud Leasing, processo
molto importante sorto fra l'altro da indagini che avevamo fatto noi (io in
particolare) e che poi sono state sviluppate dalla Procura della Repubblica e
dalla Guardia di finanza; processo in cui ancora una volta viene a trovarsi
coinvolto, come perno, Tommaso Marsala.
IL PROCESSO NEGATO. «Essendo un processo molto
importante, aspettiamo che arrivi all'ufficio istruzione; finalmente un giorno
telefono alla cancelleria c mi dicono che è arrivato da una decina di giorni;
chiedo a chi è assegnato c mi rispondono che è assegnato anche a me. Pensando di
dover lavorare anch'io, chiamo il collega assegnatario e gli chiedo quando ci
riuniamo per parlarne. Risponde di no, che è inutile riunirsi, che io posso
richiedere la sola copia degli atti. Pensando che ci fosse l'assegnazione
congiunta, vado a vedere e l'assegnazione è in questi termini: il processo è
assegnato al giudice istruttore Barrile e, limitatamente agli atti che
potrebbero essere importanti nelle indagini su Marsala, anche ai giudici Falcone
e Lacommare; s'inserisce una terza persona ed ecco che siamo in quattro. Ora io
vi chiedo: sulla base di questa delega, come ci possiamo muovere noi?... Cosi mi
si mette in condizioni di non muovermi, non posso fare nulla. Giorno dopo giorno
c'è un problema, poi quando cerchiamo di far capire queste cose, ti spunta sul
“Giornale di Sicilia” un comunicato: basta coi miti, queste beghe fra
magistrati, queste sono beghe fra cordate di magistrati, tutti sono in grado di
fare tutto. Voglio dire che è tutta una serie di colpi di spillo che ti mette in
condizione di non muoverti. Certo, se scomponiamo e rianalizziamo queste
vicende, sono tutte risolvibili, però, poi, in concreto ti accerchiano c non ti
muovi. Tutto questo ti delegittima, tutto questo t'impedisce di andare avanti;
diceva Dalla Chiesa che Palermo era una città dove il “prestigio” conta...».
Domanda il consigliere Smuraglia: «Rispetto a
quando è venuto a Palermo il Comitato antimafia del Consiglio, cioè a fine
gennaio, la situazione complessiva è migliorata, è rimasta uguale o è
peggiorata?».
Falcone: «io direi che al peggio non c'è mai fine,
ma certo migliorata non è... Recentemente mi è capilato di dover rivivere quegli
stessi errori che abbiamo censurato per il passato. Agli inizi degli anni '60
certe frasi come “rappresentante”, “famiglia mafiosa”, “reggente” (tutto un
insieme di notizie che poi ci sarebbero state dette anche da Tommaso Buscctta)
c'erano già scritte nei rapporti. Poi, dagli anni '70 in poi, tutto questo
sparisce, perché? Per la mancanza di memoria storica, per la mancanza di
professionalità specifiche per questi problemi. Cosi noi ci troviamo adesso in
una situazione identica a quella di prima che iniziassimo le indagini
istruttorie... Adesso constatiamo scarsezza di collaborazione e di entusiasmo,
io non vedo funzionari di Polizia nel mio ufficio da mesi, mesi e mesi...».
L'AUTISTA AL COMPUTER. Smuraglia: «Il Procuratore
Borsellino ci ha detto che adesso dei computer, dell'impiego degli elaboratori
elettronici si occupa il collega De Francisci».
Falcone: «Se ne occupava! Perché Dc Francisci,
occupato anche lui nell'ordinario, è costretto a diradare il suo impegno
nell'informatica ed il laboratorio viene gestito da un commesso, l'ex autista di
Chinnici...»
Smuraglia: «Non è arrivato un tecnico?»
Falcone: «No, no, no. Queste elaborazioni vengono
affidate a questa persona dotata di sensibilità, che però può omettere dei dati
che per noi sono significativi e per lui non lo sono».
Domanda il consigliere Pietro Calogero: «Il
ricorso al carteggio che si è dispiegato in questi mesi fra i componenti del
pool e il consigliere Meli a cosa è dovuto? Qual è la ragione del ricorso allo
scritto tra componenti dello stesso ufficio?».
Falcone: «Noi abbiamo fatto ricorso allo scritto
solo dopo che ci siamo resi conto che non c'era alcun dialogo. Io stesso più
d'una volta l'ho detto al Consigliere: incontrati con noi, non vogliamo altro
che lavorare in piena armonia. Non è stato possibile».
Calogero: «Quindi anche la richiesta di copia
degli atti in ordine al sequestro Fiorentino, era stata preceduta da richieste
verbali di conoscere gli atti del processo?».
Falcone: «Erano andati a parlare con Meli sia
Natoli che Trizzino... Insomma nel concreto: ci siamo resi conto che se l'è
assegnato lui, ritenendo che fosse un qualcosa di ordinario e credo che forse
tuttora non sia convinto che sia importante questo processo, ma in realtà è
molto importante».
Calogero: «In relazione ai processi che si è
autoassegnato, processi di mafia s'intende, risulta che Meli abbia svolto atti
istruttori?».
Falcone: «No...».
Il consigliere Massimo Brutti: «Vorrei che Falcone
ci desse tutte le indicazioni possibili sulla base della buona volontà per
uscire dall'impasse, perché si possa risolvere tutto questo problema nella
chiarezza».
Falcone: «La buona volontà da parte nostra c'è
tutta. Io penso che il punto focale è che il Consigliere Meli dovrebbe
comprendere che non c'è nessun complotto di nessun genere. Meli, a mio avviso, è
stato male informato. Io credo che non abbia compreso un fatto fondamentale: che
noi non abbiamo altri interessi che non siano quelli istituzionali. Ma,
vivaddio, tutte le responsabilità, tutte le colpe saranno perseguite, a
qualsiasi partito appartengano coloro che abbiano commesso determinati reati.
Solo a queste condizioni io sono disponibile per continuare. Ripeto, purché
tutti quanti ci si renda conto che bisogna lavorare serenamente, in buona fede e
senza fini di altro genere».
"Ho tollerato le accuse in silenzio".
Le parole di Giovanni Falcone, tratte da lettere e libri del giudice ucciso,
scrive il 23 maggio 2012 "L'Espresso".
Lettera di Giovanni Falcone al CSM, Palermo, 30
luglio 1988, ora in G. Monti, Falcone e Borsellino. La calunnia, il tradimento,
la tragedia, Editori Riuniti/L’Unità, Roma, 2007, pp. 88-90. Ho tollerato in
silenzio in questi ultimi anni in cui mi sono occupato di istruttorie sulla
criminalità mafiosa le inevitabili accuse di protagonismo o di scorrettezze nel
mio lavoro. Ritenendo di compiere un servizio utile alla società, ero pago del
dovere compiuto e consapevole che si trattava di uno dei tanti inconvenienti
connessi alle funzioni affidatemi. Ero inoltre sicuro che la pubblicità dei
relativi dibattimenti avrebbe dimostrato, come in effetti è avvenuto, che le
istruttorie cui io ho collaborato erano state condotte nel più assoluto rispetto
della legalità. Quando poi si è prospettato il problema della sostituzione del
consigliere istruttore di Palermo, dottor Caponnetto, ho avanzato la mia
candidatura, ritenendo che questa fosse l’unica maniera per evitare la
dispersione di un patrimonio prezioso di conoscenze e di professionalità che
l’ufficio a cui appartengo aveva globalmente acquisito. Forse peccavo di
presunzione e forse altri potevano assolvere egregiamente all’esigenza di
assicurare la continuità dell’ufficio. È certo però che esulava completamente
dalla mia mente l’idea di chiedere premi o riconoscimenti di alcun genere per lo
svolgimento della mia attività. Il ben noto esito di questa vicenda non mi
riguarda sotto l’aspetto personale e non ha per nulla influito, come i fatti
hanno dimostrato, sul mio impegno professionale. Anche in quella occasione però
ho dovuto registrare infami calunnie e una campagna denigratoria di inaudita
bassezza cui non ho reagito solo perché ritenevo, forse a torto, che il mio
ruolo mi imponesse il silenzio. Ma adesso la situazione è profondamente cambiata
e il mio riserbo non ha più ragione di essere. Quello che paventavo è purtroppo
avvenuto: le istruttorie nei processi di mafia si sono inceppate e quel
delicatissimo congegno che è costituito dal gruppo cosiddetto antimafia
dell’ufficio istruzione di Palermo, per cause che in questa sede non intendo
analizzare, è ormai in stato di stallo. Paolo Borsellino, della cui amicizia mi
onoro, ha dimostrato ancora una volta il suo senso dello Stato e il suo coraggio
denunciando pubblicamente omissioni e inerzie nella repressione del fenomeno
mafioso che sono sotto gli occhi di tutti. Come risposta è stata innescata
un’indegna manovra per tentare di stravolgere il profondo valore morale del suo
gesto, riducendo tutto a una bega tra «cordate» di magistrati, a una «reazione»,
cioè, tra magistrati «protagonisti», «oscurati» da altri magistrati che, con
diversa serietà professionale e con maggiore incisività, condurrebbero le
indagini in tema di mafia. […] Mi auguro che queste mie istanze, profondamente
sentite, non vengano interpretate come gesto di iattanza, ma per quello che
riflettono: il profondo disagio di chi è costretto a svolgere un lavoro delicato
in condizioni tanto sfavorevoli e l’esigenza di poter esprimere compiutamente il
proprio pensiero senza condizionamenti di sorta.
Da "Cose di Cosa nostra", in collaborazione con
Marcelle Padovani, 1991, edizione del maggio 2004, p.8'2-83 e p.170-171. Gli
uomini d’onore non sono né diabolici né schizofrenici. […] Sono uomini come noi.
La tendenza del mondo occidentale, europeo in particolare, è quella di
esorcizzare il male proiettandolo su etnie e su comportamenti che ci appaiono
diversi dai nostri. Ma se vogliamo combattere efficacemente la mafia, non
dobbiamo trasformarla in un mostro né pensare che sia una piovra o un cancro.
Dobbiamo riconoscere che ci rassomiglia […] Parlando di mafia con uomini
politici siciliani, mi sono più volte meravigliato della loro ignoranza in
materia. Alcuni forse erano in malafede, ma in ogni caso nessuno aveva ben
chiaro che certe dichiarazioni apparentemente innocue, certi comportamenti, che
nel resto d’Italia fanno parte del gioco politico normale, in Sicilia acquistano
una valenza specifica. Niente è ritenuto innocente in Sicilia, né far visita al
direttore di una banca per chiedere un prestito perfettamente legittimo, né un
alterco tra deputati né un contrasto ideologico all’interno di un partito […] Il
condizionamento dell’ambiente siciliano, l’atmosfera globale hanno grande
rilevanza nei delitti politici: certe dichiarazioni, certi comportamenti valgono
a individuare la futura vittima senza che la stessa se ne renda nemmeno conto.
Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo
grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché
si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che
lo Stato non è riuscito a proteggere.
Da "Interventi e proposte" (1982-1992), Sansoni
editore, pp.304-305. Se non si comprenderà che, per quanto riguarda Cosa nostra
e altre organizzazioni similari, è assolutamente improprio parlare di
"emergenza", in quanto si tratta di fenomeni endemici e saldamente radicati nel
tessuto sociale, e se si continuerà a procedere in modo schizofrenico,
alternando periodi intensificata repressione con altri di attenuato impegno
investigativo, si consentirà alle organizzazioni criminali di proseguire
indisturbate nelle loro attività e, in definitiva, sarà stato vano il sacrificio
di tanti fedeli servitori dello Stato. E’ necessario, dunque, prescindere da
fattori emozionali e procedere ad una analisi razionale della situazione
attuale; analisi che, è bene ribadirlo, è non solo legittima, ma doverosa anche
in sede giudiziaria, senza perciò ledere prerogative istituzionali di altri
organismi statuali […].
Dopo le inchieste della magistratura, ora
la politica ritrovi le responsabilità di quegli anni.
La nuova Commissione antimafia deve continuare il lavoro interrotto. E svolgere
nuovi approfondimenti per fare luce sui lati oscuri di quel periodo, scrive
Lirio Abbate il 22 maggio 2018 su "L'Espresso". Le indagini su gravi episodi di
omissione e depistaggio hanno portato negli ultimi anni a nuovi processi per le
stragi del 1992, aperti a Caltanissetta. Processi rifatti e nuovi imputati alla
sbarra. E nuove sentenze di condanna sono arrivate. Per l'attentato di Capaci si
sta ancora processando il latitante Matteo Messina Denaro, considerato uno dei
mandanti. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, alla partenza della nave della
Legalità che porta gli studenti di tutta Italia a Palermo ha detto: «Il 23
maggio è una data che non si può dimenticare, viene ricordata ogni anno la data
del vile attentato di Capaci. Da allora si è sviluppato un movimento di reazione
civile prezioso e importante, contro la mafia che ha ottenuto risultati
importanti ma che richiede ulteriori impegni». Del periodo stragista di ventisei
anni fa e si è occupata la Commissione parlamentare antimafia, presieduta da
Rosy Bindi che ha affrontato il carattere politico-mafioso di quelle stragi.
Sono stati sentiti i magistrati di Palermo e Caltanissetta, i componenti della
famiglia Borsellino, dalla sorella Rita, al fratello Salvatore, alle figlie
Fiammetta e Lucia. È stato audito anche il magistrato Gianfranco Donadio, per il
suo ruolo di procuratore aggiunto della direzione nazionale antimafia, e per i
peculiari compiti che gli erano stati affidati, per il quale è stato un
protagonista delle indagini sulle stragi «con un inevitabile strascico di
polemiche e di ulteriori vicende anche giudiziarie». I commissari hanno svolto
un grande lavoro che però non si è potuto allargare, per mancanza di tempo, e di
fine legislatura. È adesso compito della prossima Commissione antimafia a
svolgere ulteriori approfondimenti, tentando – sempre che ci sarà la volontà
politica - di far luce su alcuni aspetti di queste oscure vicende. Le inchieste
giudiziarie faranno il loro corso, ma è opportuno dare maggiore spazio
all’inchiesta politica e all’analisi storica sulle responsabilità – politiche? -
di quegli anni.
Perché Giovanni Falcone vive ancora oggi.
Dal giorno dell'attentato il giudice ha cominciato a rinascere, a diventare
immortale per i giovani, per gli onesti, per le persone perbene. Sino a essere,
con Paolo Borsellino, punto di riferimento di chi crede in una giustizia capace
di schiacciare la sopraffazione e la mentalità mafiosa. Per questo occorre
ricordarlo. Facendo memoria di tutto quello che ha fatto e subìto, scrive Lirio
Abbate il 23 maggio 2016. Giovanni Falcone ha iniziato a rinascere proprio su
quel cratere dell'autostrada squarciata 24 anni fa da cinquecento chili di
tritolo fatti esplodere dai mafiosi. C'è voluta questa strage, con il pesante
sacrificio umano che si è trascinata, per scuotere le coscienze. E far cambiare
idea non tanto ai mafiosi ma a quella pletora di nemici, pubblici e privati, che
il dottor Falcone ha avuto durante la sua carriera. E a quei siciliani che
continuavano a ripetere fino a quel momento: tanto si uccidono fra di loro i
mafiosi. Magistrati e professionisti, politici e borghesi, che hanno attaccato
il dottor Falcone in vita, dopo la sua morte come per un incantesimo hanno
iniziato a dire che erano tutti amici di "Giovanni", che stimavano "Giovanni" e
che gran magistrato era "Giovanni". Dopo la sua uccisione il dottor Falcone
sembrava di colpo aver conquistato più amici. Anche e soprattutto fra i nemici.
Che strana è la vita di questo uomo-magistrato che durante la sua carriera si è
dovuto confrontare prima contro i mafiosi, che hanno cercato in più occasioni di
ucciderlo, poi contro una maggioranza di suoi colleghi che proprio perché erano
maggioranza lo mettevano in minoranza quando Falcone chiedeva di poter andare a
ricoprire altri incarichi dove avrebbe potuto mettere a frutto l'esperienza
nella lotta alla criminalità organizzata. Poi contro i politici che difendevano
gli interessi dei mafiosi. E poi contro i veleni di "palazzo". Non si è fatto
mancare nulla. La gente, che però non era una maggioranza, lo sosteneva. Ma i
corvi avevano sempre la meglio. Ma una giustizia arriva sempre. Per tutti. Sono
però tutte storie dimenticate. La strage ha fatto dimenticare - non a tutti -
queste cose. Ma il dottor Falcone proprio da quell'attentato di Capaci ha
iniziato a rinascere. A diventare immortale per i giovani, per gli onesti, per
le persone perbene. Oggi Giovanni Falcone è il punto di riferimento, come lo è
anche Paolo Borsellino, di chi crede in una giustizia che può schiacciare la
sopraffazione mafiosa con i loro clan e i loro affiliati. Ma anche la mentalità.
Per questo Giovanni Falcone ancora oggi vive. E per questo occorre ricordarlo.
Facendo memoria di tutto quello che ha fatto e subìto. I magistrati di
Caltanissetta dopo aver istruito diversi processi ai mandanti ed esecutori della
strage, ancora oggi si trovano a puntare il dito su altri responsabili che fino
adesso erano rimasti fuori dalle indagini e grazie alle dichiarazioni di nuovi
collaboratori di giustizia è stato possibile individuare. Come pure il latitante
Matteo Messina Denaro che per 24 anni è rimasto lontano dalle indagini e adesso
i pm nisseni hanno provato il suo coinvolgimento, insieme a Totò Riina, come
mandante dell'attentato. Il lavoro di Falcone dava fastidio a Cosa nostra, e per
questo è stato ucciso. I pm di Caltanissetta escludono l'intervento di soggetti
esterni alla mafia nell'esecuzione della strage di Capaci. Lo ha voluto ribadire
poche settimane fa il pm Stefano Luciani durante la requisitoria del nuovo
processo per la strage. "Abbiamo diverse dichiarazioni generiche sull'intervento
di soggetti esterni, in particolare componenti dei servizi. Dichiarazioni che
arrivano da persone estranee a Cosa nostra o da chi era ai piani bassi
dell'organizzazione, ma nessuno di coloro che stava ai piani alti della mafia e
che poi ha deciso di collaborare con la giustizia, come ad esempio Giovanni
Brusca, ha mai parlato dell'intervento di esterni nell'esecuzione della strage.
E allora cosa dovremmo fare? Teorizzare un enorme complotto che mirava a tappare
la bocca a questi collaboratori?", ha detto il magistrato Luciani. "Ci stiamo
occupando di un fatto che ha segnato profondamente la storia del nostro Paese, a
livello di ipotesi si può dire tutto, ma quando dobbiamo andare sul concreto
dobbiamo agire sulla base degli elementi raccolti. Sono stufo di sentire dire
che questo ufficio tiene la polvere nascosta sotto il tappeto. Si è parlato
anche del coinvolgimento di Giovanni Aiello (ex agente di polizia reclutato dai
Servizi indicato come "faccia di mostro" ndr). Abbiamo sentito molti testi, ma
riscontri sicuri non ne sono arrivati. I suoi familiari hanno detto di non
sapere che collaborasse con i servizi e quando ad alcuni testi è stato chiesto
di descriverlo sono stati commessi errori". La Procura di Caltanissetta, che dal
2008, dopo il pentimento di Gaspare Spatuzza, sta cercando di riscrivere la
verità sui due attentati di Capaci e di via D'Amelio, ha messo insieme gli
elementi raccolti individuando mandanti ed esecutori materiali rimasti per lungo
tempo impuniti. Falcone intanto risorge.
Strage di Capaci, il racconto dei
sopravvissuti: "Quel giorno ho visto l'asfalto salire in cielo".
Il racconto dell'attentato costato la vita al giudice Giovanni
Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e a tre agenti della scorta nelle parole
degli agenti sopravvissuti al tritolo, scrive Lirio Abbate il 23 maggio 2017 su
"L'Espresso". Una delle tappe della strategia attuata dai mafiosi di Cosa nostra
nel 1992 - attaccare frontalmente lo Stato - è l’attentato di Capaci al
magistrato Giovanni Falcone. È una strategia funzionale alla ricerca di nuovi
referenti politici. E anche per questo l’attentato viene eseguito in fretta.
Totò Riina aveva premura di portare a termine il progetto di uccidere il
magistrato che era il principale nemico di Cosa nostra. Perché aveva premura?
Perché aveva perso il potere, non era più credibile agli occhi di alcuni boss e
quindi doveva essere un attentato eclatante. Riina si era impegnato con i suoi
picciotti affinché la sentenza della Cassazione ribaltasse le condanne
all’ergastolo per gli imputati del maxi processo a Cosa nostra. Ma questo non
era successo. Accanto all’azione dei mafiosi gli inquirenti oggi cercano di
capire se possono esserci delle mani esterne ad aver agito insieme a Cosa
nostra. Ciò che è avvenuto il 23 maggio 1992 lo spiegano i sismografi siciliani
che registrano una fortissima esplosione alle ore 17 e 56 minuti e 32 secondi.
Un’esplosione che è come una scossa di terremoto. Una carica di 572 chili di
esplosivo viene fatta saltare sotto un condotto dell’autostrada in direzione di
Palermo, vicino allo svincolo di Capaci. L’esplosione prende in pieno la prima
delle tre auto blindate che formano il corteo su cui viaggiano Giovanni Falcone
e la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato. Nella prima auto ci sono i
poliziotti Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani mentre in quella
che segue ci sono i coniugi Falcone e Morvillo con l’autista giudiziario
Giuseppe Costanza che siede nel sedile posteriore. Il magistrato aveva preferito
mettersi alla guida con accanto la moglie. La deflagrazione provoca un
gigantesco cratere sul bordo del quale si ferma l’auto del magistrato. Appena
dietro c’è la terza blindata del corteo, con gli agenti Angelo Corbo, Paolo
Capuzza e Gaspare Cervello, che sono scioccati e feriti, ma sopravvivono. I tre
poliziotti scendono dall’auto e cercano di dare aiuto al giudice, alla moglie e
all’autista. Nonostante le lesioni riportate e con il contributo di alcuni
soccorritori, i feriti vengono estratti dall’auto, ad eccezione di Falcone, che
resta incastrato fra le lamiere. Per lui è necessario aspettare i Vigili del
Fuoco. Come raccontano agli inquirenti Corbo, Capuzza e Cervello, il giudice
Falcone, sua moglie Francesca e l’autista Costanza dopo l’esplosione sono ancora
vivi. La donna respira ma è priva di conoscenza, mentre Falcone mostra con gli
occhi di recepire le sollecitazioni dei soccorritori. La corsa in ospedale in
ambulanza e gli sforzi dei medici non riescono però a salvarli. Entrambi muoiono
in serata per le emorragie. Lesioni interne provocate dall’onda d’urto
dell’esplosione. L’autista Costanza invece, ricoverato in prognosi riservata, ce
la farà. Della prima auto blindata, quella che apre il corteo, nell’immediatezza
dell’arrivo dei soccorsi non c’è traccia. Le prime persone arrivate sul posto
pensano in un primo momento che sia riuscita a sfuggire alla deflagrazione. Solo
dopo alcune ore la Fiat Croma verrà ritrovata accartocciata in un appezzamento
di terreno a un centinaio di metri di distanza, con i corpi dei tre poliziotti
dentro. I momenti immediatamente successivi e quelli precedenti l’attentato
vengono ricostruiti dai tre agenti sopravvissuti alla strage. E sono loro che
offrono agli inquirenti le “immagini” dell’attentato attraverso la loro
descrizione di ciò che hanno visto.
Macerie dappertutto. «C’è stato un grosso botto,
uno spostamento d’aria, una deflagrazione. Mi sono sentito catapultare in
avanti», racconta Angelo Corbo. «Dopo l’esplosione con grossa difficoltà si è
cercato di uscire dall’auto, perché purtroppo eravamo anche pieni di detriti, di
massi. Uscendo si è capito della gravità della situazione, la voragine purtroppo
era ben visibile. Ci siamo avvicinati alla macchina del dottor Falcone
mettendoci intorno per non fare avvicinare nessuno. L’auto era praticamente in
bilico su quel cratere con la parte anteriore che sembrava mancante. Non
riuscivamo a estrarre né Falcone né la dottoressa Morvillo, altre persone sono
venute in aiuto. Ricordo che non riuscivamo ad aprire gli sportelli,
specialmente quello del dottor Falcone che era bloccato. Dalla parte della
dottoressa Morvillo invece c’era il vetro sradicato, e con l’aiuto di volontari
l’abbiamo tirata fuori dall’abitacolo. Intanto l’auto di Falcone stava prendendo
fuoco, allora ci siamo attivati per spegnere questo principio d’incendio. Il
dottor Falcone era in vita, non so dire se era cosciente, perché purtroppo con
il vetro blindato non si sentiva nulla, comunque era vivo. Si era pure rivolto
verso di noi guardandoci. L’autista Costanza era sul sedile posteriore ed era
sdraiato su un fianco».
Uno sguardo ormai chiuso. «Nei pressi dello
svincolo autostradale di Capaci, ho sentito una grande deflagrazione,
un’esplosione. Non ho visto più niente e non so che cosa ha fatto in quel
momento l’auto», racconta Gaspare Cervello. «Non so il tempo che ho trascorso
svenuto dopo quella deflagrazione. Ho ripreso i sensi dentro l’auto, lo
sportello era bloccato e solo con forza riesco ad aprirlo. Non ho fatto caso ai
colleghi, se stavano bene, cioè se erano vivi; l’unica cosa che mi ha dettato
l’istinto è stata di uscire dall’auto e andare direttamente verso quella del
giudice Falcone. Mentre mi avvicinavo alla blindata ho visto una scena
straziante. L’auto era coperta da terriccio e asfalto, e c’era ancora il vetro,
ma non riuscivamo a dare aiuto. Nulla. L’unica cosa che ho fatto è stata quella
di chiamare il giudice Falcone: “Giovanni, Giovanni...”, e lui si è voltato,
però era uno sguardo ormai chiuso, abbandonato, perché aveva tutto il blocco
della macchina davanti che lo schiacciava. Aveva soltanto la testa libera di
muoversi. Ha mosso la testa solo per quegli attimi in cui l’ho chiamato. La
dottoressa Morvillo era chinata in avanti come l’autista Giuseppe Costanza, e la
prima sensazione è stata: “Ormai tutti e tre non ce l’hanno fatta”. Mentre la
macchina degli altri colleghi che stava davanti, non l’ho vista... Ho pensato
che ce l’avevano fatta, che fossero andati via per chiamare i soccorsi, perché
noi via radio non potevamo fare più niente perché la nostra auto era distrutta».
L’ultima parola: “Scusi”. «L’ultima cosa che
ricordo del dottor Falcone è quando gli ho chiesto quando dovevo riprenderlo. Mi
ha detto: “Lunedì mattina”. Io gli ho risposto: “Allora, arrivato a casa
cortesemente mi dia le chiavi dell’auto in modo che io lunedì mattina posso
prendere la macchina», racconta Giuseppe Costanza. «Probabilmente era
sovrappensiero perché lui allora sfilò le chiavi che erano inserite al quadro
dandomele dietro e io a quel punto lo richiamai dicendo: “Cosa fa? Così ci
andiamo ad ammazzare”. E lui allora mi disse: “Scusi, scusi”. Ecco, queste sono
le ultime parole che io ricordo perché poi non c’è più nulla. Potevamo andare a
una media di 120-130, non più di tanto. Nel momento in cui sfilò le chiavi ci fu
una diminuzione di velocità».
Le mani che tremavano. «Guardavo a destra
dell’auto e ho sentito un’esplosione, seguita subito da un’ondata di caldo. Mi
sono girato verso la parte anteriore dell’autovettura, per guardare cosa
accadeva», ricorda Paolo Capuzza. «Ho visto l’asfalto che si alzava nel cielo.
Poi mi sembra che l’autista abbia sterzato e siamo andati a finire sul guardrail
destro per evitare di andare addosso all’auto del dottor Falcone. Sul tettuccio
sentivamo ricadere tutti i massi e una nube nera. Non vedevamo niente, polvere e
nube nera. Poi siamo usciti dall’auto con le armi in pugno, ho cercato di
prendere l’M12 in dotazione, oltre che le pistole che avevo addosso, ma non sono
riuscito a prendere il mitra, perché la mano non riusciva a tenerlo, non
riuscivo a stringerlo. Ho preso la mia pistola e siamo usciti dalla blindata e
ci guardavamo intorno, perché ci aspettavamo che arrivasse il colpo di grazia.
Poi abbiamo visto la voragine che c’era davanti all’auto del dottor Falcone,
alla quale mancava il vano motore. C’era un principio di incendio ed abbiamo
preso l’estintore che era sulla nostra auto, abbiamo spento le fiamme.
L’incendio era proprio davanti l’autovettura del dottor Falcone, che era sul
limite del precipizio, dove si era creata la voragine. Ci siamo guardati intorno
per proteggere ancora il magistrato mentre il collega Gaspare Cervello chiamava
per nome il dottor Falcone, che non ha risposto. Però si è girato con la
testa... Abbiamo aspettato i soccorsi e non abbiamo fatto avvicinare nessuno».
Era il 23 maggio 1992, 25 anni fa.
Strage di Capaci, il racconto dei
sopravvissuti. La drammatica testimonianza di Angelo
Corbo, Paolo Capuzza e Gaspare Cervello, i tre agenti che si trovavano sulla
terza auto blindata che seguiva quella del giudice Falcone e della scorta,
scrive Lirio Abbate il 20 maggio 2016 su "L'Espresso". Il 23 maggio 1992 i
sismografi siciliani dell’Osservatorio geofisico di Monte Cammarata (Agrigento)
registrano una fortissima esplosione alle ore 17 e 56 minuti e 32 secondi. Una
carica di 572 chili di esplosivo viene fatta saltare sotto un condotto
dell'autostrada in direzione di Palermo, nei pressi dello svincolo di Capaci.
L’esplosione impatta sulla prima delle tre auto blindate che formano il corteo
su cui viaggia il magistrato Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo.
Nella prima auto ci sono gli agenti della Polizia di Stato Antonio Montinaro,
Rocco Di Cillo, Vito Schifani mentre in quella che segue immediatamente dopo ci
sono i coniugi Falcone e Morvillo con l’autista giudiziario Giuseppe Costanza
che siede però nel sedile posteriore. Falcone aveva preferito mettersi lui alal
guida con accanto la moglie. La potente deflagrazione provoca un gigantesco
cratere sul bordo del quale si ferma l'auto del magistrato. Appena dietro c'è la
terza blindata del corteo in cui c'erano i poliziotti Angelo Corbo, Paolo
Capuzza e Gaspare Cervello, che sono scioccati e feriti, ma sopravvivono
all'attentato. I tre poliziotti dopo l'esplosione scendono dall'auto e cercano
di dare aiuto al magistrato, alla moglie e all'autista. Nonostante le ferite
riportate e con il contributo di alcuni soccorritori, i feriti vengono estratti
dall’auto, ad eccezione di Falcone, che resta incastrato fra le lamiere e per
questo è necessario attendere l’intervento dei Vigili del Fuoco. Come
racconteranno Corbo, Capuzza e Cervello, Falcone, Morvillo e Costanza erano
vivi. La giudice Morvillo respirava, ma priva di conoscenza, mentre il dottor
Falcone mostra di recepire con gli occhi le sollecitazioni che gli chiedono i
soccorritori. Dal luogo dell'attentato dunque, Giovanni Falcone e la moglie
escono vivi. La corsa in ospedale in ambulanza e poi gli sforzi dei medici non
riescono a salvarli. Entrambi muoiono in serata per le emorragie. Lesioni
interne provocate dall’onda d’urto dell’esplosione, mentre Costanza ricoverato
con la prognosi riservata, ce la farà. Della prima auto blindata, quella che
apriva il corteo, nell’immediatezza dell'esplosione non c'era nessuna traccia
sull'autostrada, tanto che i primi soccorritori pensano in un primo momento che
fosse riuscita a sfuggire alla deflagrazione e che sarebbe corsa avanti a
chiedere soccorsi. Solo dopo alcune ore la Fiat Croma viene ritrovata in un
appezzamento di terreno a un centinaio di metri completamente distrutta. È in un
terreno adiacente il tratto autostradale, con i corpi dei tre poliziotti morti.
I momenti immediatamente successivi e quelli precedenti l'attentato vengono così
ricostruiti dai tre poliziotti che sono sopravvissuti alla strage di Capaci.
Sono queste le prime “immagini” della strage descritte grazie al racconto dei
sopravvissuti.
Angelo Corbo: «Ho sentito solamente un grosso
botto, uno spostamento d'aria, una deflagrazione e mi sono sentito solamente
catapultare in avanti. Dopo l'esplosione con grossa difficoltà si è cercato di
uscire dalla macchina, perché purtroppo eravamo anche pieni di detriti, di
massi. Quindi con difficoltà ho cercato di uscire dalla macchina. Niente, già
uscendo si era capito della gravità della situazione perché la voragine
purtroppo era ben visibile. Ci siamo avvicinati e mi sono avvicinato con gli
altri alla macchina del dottor Falcone mettendoci intorno per non fare
avvicinare o per controllare la situazione, e anche per non far si' che c'era
magari qualche altra persona che si stava avvicinando all'autovettura sulla
quale viaggiava il dott. Falcone, che era praticamente in bilico a quel cratere
con la parte anteriore che sembrava mancante o potrebbe essere stata coperta da
detriti. Dopodiché visto che non che non riuscivano ad uscire la persona del
dottor Falcone e della dottoressa Morvillo, abbiamo cercato insieme a delle
persone che poi sono sopraggiunte di estrarre, appunto, il dottor Falcone e la
dottoressa Morvillo. Mi ricordo che non si riusciva ad aprire gli sportelli,
specialmente quello del dottor Falcone che era bloccato. Dalla parte della
dottoressa Morvillo invece c'era questo vetro che si era riuscito a sradicare,
infatti insieme ad altre persone si era proprio presa la dottoressa Morvillo e
uscita dall'abitacolo della macchina. Invece il dottor Falcone purtroppo non si
riusciva ad aprire questo sportello. Fra l'altro poi la macchina stava anche
prendendo fuoco, quindi c'era stato anche un cercare di spegnere questo
principio d'incendio. Il dottor Falcone era in vita, ecco non so dire se era
cosciente, chiaramente, perché purtroppo con il vetro blindato non si sentiva
neanche un gemito, un qualche cosa, comunque era in vita. Addirittura si era
pure rivolto verso di noi guardandoci, però, ecco, purtroppo noi eravamo
impossibilitati ad un immediato soccorso. L'autista Costanza era messo nel
sedile posteriore, se mi ricordo bene era coricato di lato nell'abitacolo della
macchina».
Gaspare Cervello: «Dopo il rettilineo, diciamo,
all'inserimento del bivio di Capaci, ho visto dopo una deflagrazione proprio
gigantesca, un'esplosione che neanche il tempo di finire un'espressione tipica
che non ho visto più niente, non so che fine ha fatto la macchina, cosa ha fatto
in quel momento la macchina; non so il tempo che ho trascorso svenuto dopo
quella deflagrazione. Dopo che ho ripreso i sensi dentro la macchina stesso,
vedevo che non potevo aprire lo sportello; con forza riesco ad aprirlo. Non
faccio caso neanche ai colleghi se stavano bene, cioé se erano vivi; l'unica
cosa del mio istinto era quello di uscire dalla macchina e recarmi direttamente
nella macchina del giudice Falcone. Mentre mi avvicinavo alla macchina ho visto
quella scena proprio straziante, di cui mi avvicino un poco sopra, perché poi
c'era il terriccio dell'asfalto che proprio copriva la macchina; c'era soltanto
il vetro, quindi anche se volevamo dare aiuto non potevamo. Niente, l'unica cosa
che ho fatto è di chiamare il giudice Falcone: "Giovanni, Giovanni", però lui si
è voltato, però era uno sguardo ormai chiuso, abbandonato, perché aveva tutto il
blocco della macchina davanti, aveva soltanto la testa diciamo libera; no
libera, che muoveva, diciamo, per quegli attimi che io l'ho chiamato. La
dottoressa era chinata verso avanti come l'autista Giuseppe Costanza, di cui la
prima sensazione, quella mia: "Ormai tutti e tre non ce l'hanno fatta", mentre
la macchina davanti, non l'ho vista... Ho pensato che ce l'avevano fatta, ce
l'avevano fatta, che erano andati via... ho pensato sono andati via per chiamare
i soccorsi, perché noi via radio non potevamo dare più niente perché la macchina
nostra era anche distruttissima».
Giuseppe Costanza: «Io l'ultima cosa che ricordo
del dottor Falcone è, appunto, nel chiedergli quando dovevo venire a
riprenderlo; mi ha detto: "Lunedì mattina", io gli dissi: "Allora, arrivato a
casa cortesemente mi dà le mie chiavi in modo che io lunedì mattina posso
prendere la macchina, ma probabilmente era soprappensiero perché una cosa del
genere non riesco a giustificarla soprattutto da lui. Sfilò le chiavi che erano
inserite al quadro dandomele dietro e io a quel punto lo richiamai dicendoci:
"Cosa fa? Così ci andiamo a ammazzare". Questo è l'ultimo ricordo che lui
girandosi verso la moglie e incrociandosi lo sguardo e girandosi ancora verso di
me fa: "Scusi, scusi". Ecco, queste sono le ultime parole che io ricordo perché
poi non c'è più nulla. Potevamo andare a una media di 120, 120-130, non più di
tanto. Nel momento in cui sfilò le chiavi ci fu una diminuzione di velocità
perché la marcia era rimasta inserita era la quarta».
Paolo Capuzza: «Io ero rivolto, diciamo, un po'
nella sedia della parte destra e guardavo un po' sulla destra ed il davanti, ed
ho sentito un'esplosione ed un'ondata di caldo è arrivata, ed in quell'attimo mi
sono girato nella parte anteriore dell'autovettura, per guardare cosa accadeva,
ed ho visto l'asfalto che si alzava nel cielo. Poi mi sembra che l'autista abbia
sterzato l'autovettura sul guardrail destro per evitare di andare addosso
all'autovettura del dottor Falcone; poi, quando siamo scesi ci siamo accorti che
ci siamo ritrovati dietro proprio l'autovettura del magistrato. Mentre eravamo
all'interno dell'autovettura, si sentivano ricadere sull’auto tutti i massi ed
una nube nera, cioé non si vedeva niente, polvere e nube nera che non riuscivamo
a vedere niente. Dopodiché siamo usciti dall'autovettura con le armi in pugno,
io ho cercato di prendere l'M12 in dotazione, oltre che le pistole che avevo
addosso, ma non sono riuscito a prenderlo, perché appunto la mano non riusciva a
tenerlo in mano, non lo riuscivo a prendere, insomma; e, quindi, ho preso la mia
pistola di ordinanza. Siamo usciti dall'autovettura e per guardarci intorno,
perché ci aspettavamo, come si dice, qualche colpo di grazia. Poi abbiamo visto
la voragine che c'era davanti all'autovettura del dottor Falcone, alla quale
mancava il vano motore completamente; poi c'erano delle fiamme ed abbiamo preso
l'estintore che era sulla nostra autovettura e le abbiamo spente. Le fiamme
erano proprio davanti l'autovettura del dottor Falcone, che era proprio sul
limite del precipizio, diciamo, dove si era creata la voragine, perché non c'era
più il vano motore e... ci siamo guardati intorno per proteggere, appunto,
ancora la personalità, perché mi sembra che il Cervello Gaspare, sì Cervello,
abbia chiamato per nome il dottor Falcone, il quale non ha risposto però si è
girato con la testa come... poi abbiamo aspettato i soccorsi e non abbiamo fatto
avvicinare nessuno».
Queste dunque le prime immagini della strage
tratte dal racconto dei sopravvissuti.
‘NDRANGHETA, COSA NOSTRA, MASSONERIA DEVIATA E
STATO: TUTTI INSIEME APPASIONATAMENTE…
Ci sono più pentiti che boss: la vera
follia dell’antimafia. Costano 100 milioni l’anno ma
non fanno nomi nuovi. Che dirà Salvini nella relazione? Scrive Errico Novi il 10
Agosto 2018 su "Il Dubbio". Sarà interessante sentire Matteo Salvini alla sua
prima relazione sui pentiti. Tecnicamente, la “Relazione al Parlamento sulle
speciali misure di protezione”. L’ultima l’ha presentata Marco Minniti. Il nuovo
ministro dell’Interno non ha ancora esordito su tale terreno. Sappiamo solo che
vuole «togliere anche le mutande, ai bastardi mafiosi». Ma come? Attraverso le
confessioni dei collaboratori di giustizia? Non che tocchi a lui, certo, la
prima linea della lotta alla mafia, presidiata da magistrati e forze di polizia.
Eppure spetta al Capo del Viminale riflettere sulle decisioni della Commissione
centrale, che decide se e a chi applicare i programmi di protezione. È al
ministro dell’Interno che è giusto chiedere conto dell’efficacia del sistema. Ed
eventualmente, di predisporre modifiche alle norme. A oggi le collaborazioni
sono regolate dalla legge 82 del 91 così come modificata dalla legge Amato, la
45 del 2001. Naturalmente sono decisive le azioni e le valutazioni dei
magistrati, compresi quelli della Direzione nazionale Antimafia, che presentano
relazioni e pareri su ciascun aspirante pentito. Ma sarà Salvini a dover
riflettere su due dati: il numero totale dei collaboratori di giustizia, che
secondo l’ultima statistica disponibile, quella presentata appunto dal
predecessore Minniti nel giugno 2017, è di 1.277 unità; l’altro dato è il numero
dei boss in carcere, che si può desumere semplicemente dai detenuti in regime di
41 bis: in tutto, 730 persone. I secondi, cioè i capimafia, sono poco più della
metà di chi è “beneficiato” e protetto affinché aiuti a scovare nuovi boss. Ha
senso tutto questo?
Il regime speciale di detenzione resta uno dei
vulnus giuridici più gravi, in Italia, ed è stato scientificamente liquidato
come incostituzionale dall’ultima commissione Diritti umani del Senato. Ma qui
interessa ragionare sul meccanismo che consente di decapitare le cosche. E
chiedersi se i collaboratori di giustizia siano davvero ancora utili allo scopo.
La domanda, peraltro, viene suggerita da una fonte riservata dello stesso
ministero dell’Interno: «I programmi di protezione sono costosi. Sono anche una
scelta giudiziaria. Negli ultimi anni l’impegno complessivo dello Stato su
questo fronte non è mai sceso al di sotto degli 80 milioni di euro. E se si
considera il costo degli immobili messi a disposizione dei pentiti, si arriva
sicuramente ai 100 milioni annui. Adesso», continua la fonte, «i collaboratori
di giustizia propriamente detti dovrebbero aver superato quota 1.300. Ma se un
magistrato riconosce il valore delle dichiarazioni di un mafioso, o di un
camorrista, e se riferisce alla Commissione centrale che quel soggetto va
ammesso al programma, ritiene che l’aspirante pentito possa servire ad accertare
la verità. Ecco, per esempio, dovrebbe consentire di portare al 41 bis almeno un
paio di soggetti di spessore. Non può limitarsi ad additare qualche gregario, né
ad attribuire il novantesimo omicidio a Riina, cioè a chi tanto è già al 41 bis
o è morto». È chiaro che se al 41 bis c’è un numero di criminali pari a poco più
della metà di chi si pente, i conti non tornano. «E forse le direzioni
distrettuali antimafia su questo dovrebbero riflettere», chiosa l’interlocutore
del Viminale. Da una delle Dda più impegnate quanto a collaboratori di
giustizia, quella di Napoli, viene poi fatto notare l’altro aspetto del
problema: «Molti di coloro che sono ammessi al programma di protezione sono
ormai figure di bassissimo spessore. Piccoli criminali che non hanno capacità di
direzione strategica. Vanno protetti, ma non sono in grado di dare informazioni
di peso. Ciononostante portano dietro costi enormi». Quello di Napoli è il
distretto di Corte d’appello che produce più pentiti. Sui 1.277 totali, quasi
800 vengono da lì. I “collaboratori” dell’area che fa capo al capoluogo campano
hanno famiglie numerosissime. Da proteggere a loro volta. Non solo mogli (le
donne pentite restano pochissime, 63 in tutta Italia conto 1.214 uomini). Spesso
si aggiungono le nuove compagne, magari con rispettivi figli nati da precedenti
relazioni. Delle comunità complesse, diciamo così, che fanno lievitare in modo
impressionante l’altro dato significativo dell’affare “collaboratori”: i
congiunti a cui si estende il programma. A livello nazionale sfiorano
l’astronomica cifra delle 5.000 unità: sono, precisamente, 4.915. C’è solo
un’annata, nella cronologia del pentitismo, in cui si è andati oltre: il 1996.
L’apice di una fase del tutto particolare, descritta dal libro di Paolo Cirino
Pomicino, "La Repubblica delle giovani marmotte" di cui diamo ampia “rilettura”
in queste pagine. Ventidue anni fa si registrò il picco delle persone protette:
se nell’ultimo score disponibile se ne contano 6.525, nel ’ 96 si arrivò a 7.020
persone. Grazie soprattutto al record dei familiari dei pentiti, 5.747, mentre i
collaboratori veri e propri restarono comunque di poco al di sotto del primato
recente: se ne contarono 1.214 (alla somma vanno aggiunti i testimoni di
giustizia, poche decine). Ma si era nel pieno della rivincita da parte dello
Stato nei confronti della criminalità organizzata, in particolare siciliana.
Parliamo degli anni in cui furono acquisite collaborazioni come quella di
Giovanni Brusca. Oggi non si riesce a individuare più pentiti di quel “calibro”.
Ed ecco perché nella lotta alla mafia, il governo, prima di ogni altra
ambizione, dovrebbe coltivare quella di riconsiderare il sistema della
protezione.
Pentiti di mafia, logge deviate e pezzi
di Stato. Quegli strani intrecci dietro l'omicidio
Scopelliti. Il ritrovamento dell'arma del delitto apre scenari inediti. C'è
qualcuno che parla con i magistrati? Analisi di un assassinio che coinvolge ben
più delle strutture militari del crimine, scrive Consolato Minniti, giovedì 9
agosto 2018, su lacnews24.it. Ha scelto una giornata simbolica il procuratore
capo di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri. Aveva la notizia già da un po',
ma ha preferito attendere perché il giorno del ricordo non fosse solo tale, ma
diventasse anche quello della speranza. Così come avvenne qualche anno fa, per i
carabinieri Fava e Garofalo, i cui congiunti ascoltarono dalla viva voce
dell'allora capo della Procura, Federico Cafiero de Raho, una frase sibillina:
«Presto arriveremo alla verità». Fu una promessa, mantenuta solo pochi mesi
dopo, quando il gip di Reggio Calabria emise un'ordinanza di custodia cautelare
in carcere per i presunti mandanti di quel duplice omicidio. Una verità ancora
da scrivere con una sentenza, certo, ma che dimostrò il grande lavoro svolto dal
procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo.
La novità investigativa. Oggi Bombardieri fa di
più e annuncia il ritrovamento di un fucile calibro 12, ritenuta l'arma
utilizzata per uccidere il giudice Antonino Scopelliti. Non è un'ipotesi campata
in aria. Prima di pronunciarsi, il procuratore ha atteso i primi accertamenti
della Squadra mobile di Reggio Calabria, ossia un gruppo di investigatori di
primissimo livello che raramente sbagliano un colpo. E gli esiti dicono che ci
sono altissime probabilità che quel fucile sia quello da cui partirono i colpi
all'indirizzo del magistrato Antonino Scopelliti. Non staremo certo qui a
ricordare chi fosse il giudice “solo”: dalle inchieste sul terrorismo e mafia,
passando per quelle riguardanti l'omicidio di Aldo moro, Scopelliti rappresentò
un punto fermo per la Corte di Cassazione della quale era sostituto procuratore
generale.
Il maxi processo e l'omicidio. La sua vita cambiò
decisamente nel momento in cui sulla sua scrivania arrivò un fascicolo con su
scritto “Maxi processo a Cosa nostra”. Quello istruito dai giudici Falcone e
Borsellino. Alla sbarra c'erano tutti i più grandi boss che rischiavano di
essere sommersi da centinaia di ergastoli. Scopelliti non fece una piega. Per
lui quelle carte erano lavoro. Come sempre, come ogni processo. Così, con la
meticolosità che gli era propria, se le portò persino in vacanza, nella sua
amata Campo Calabro. Era solito girare sempre senza scorta, accadde anche il
pomeriggio del 9 agosto del 1991. Pochi chilometri più a sud, sulle strade di
Reggio Calabria i cadaveri si contavano a centinaia. Circa 700 morti ammazzati
con la seconda guerra di mafia. Il clima era rovente fra i due casati più
importanti. Scopelliti, però, aveva in testa solo i boss siciliani. Ignorava che
nel tragitto che l'avrebbe ricondotto a casa, lo stavano attendendo due sicari.
L'auto finì in un dirupo. Si pensò ad un incidente. Poco dopo la scoperta: il
giudice era stato ucciso con più colpi di fucile. Ma da chi e perché?
Il processo a Reggio. Iniziò a circolare con
sempre maggiore insistenza la voce che a volerlo morto sarebbe stata Cosa nostra
con la complicità della 'ndrangheta. Una voce che divenne presto ipotesi
processuale che vide alla sbarra i maggiori boss siciliani ed anche un presunto
killer. Era Gino Molinetti “la belva”. Lui, che in diverse indagini emerse come
sicario senza scrupoli, finì sotto processo per poi essere definitivamente
assolto così come tutti i grandi nomi della mafia siciliana. Non si riuscì a
provare la loro colpevolezza e l'omicidio del giudice rimase di fatto senza
responsabili. Quale mandante del delitto, fu condannato in primo grado Pietro
Aglieri, boss palermitano implicato anche nell'omicidio di Salvo Lima. Poi,
però, pure per lui giunse l'assoluzione. Ma è un particolare che oggi torna di
particolare attualità.
Le parole dei pentiti. La ragione? Va ricercata
nelle dichiarazioni vecchie e nuove dei collaboratori di giustizia. Sono stati
tanti, tantissimi quelli che hanno parlato di un continuo scambio di favori fra
'ndrangheta e cosa nostra. Scambio di killer, di omicidi, di affari. Ed il
delitto Scopelliti rientrerebbe proprio in questa logica: la 'ndrangheta – hanno
riferito numerosi collaboratori di giustizia – uccide il giudice su mandato dei
siciliani, in cambio questi ultimi intervengono per far cessare le ostilità a
Reggio, dove il business è fortemente in crisi a causa di quella guerra iniziata
nel 1985. Sta di fatto che, proprio l'omicidio del magistrato segna la fine
delle ostilità. Di recente, nel processo “'Ndrangheta stragista”, che sta
facendo luce sui presunti mandanti dell'omicidio Fava-Garofalo e sugli attacchi
ai carabinieri, ha deposto il pentito Francesco Onorato, killer siciliano ed
esecutore materiale dell'omicidio di Salvo Lima. Stesso delitto per il quale fu
chiamato a rispondere Aglieri. E cosa ha raccontato Orlando al pm Lombardo?
Che l'omicidio Scopelliti fu un favore fatto dalla 'ndrangheta a Cosa nostra e
nello specifico una questione di cui si fecero carico i Piromalli ed i Mancuso.
Parole che sembrano segnare qualcosa più di una mera novità. Perché se è vero
che da sempre sono stati ritenuti gli arcoti coloro che hanno organizzato
l'esecuzione del delitto, è altrettanto vero che una decisione del genere non
poteva essere presa – in costanza di conflitto interno di tale portata – senza
l'avallo delle famiglie più rappresentative della 'ndrangheta. Ed allora ecco
che le parole di Onorato acquistano ancor più vigore. La ragione risiede in una
indissolubilità delle inchieste. Non si può pensare di comprendere la genesi
dell'omicidio Scopelliti se non si analizza bene il contenuto dell'inchiesta
“'Ndrangheta stragista” che ne rappresenta una naturale evoluzione con i suoi
fitti legami fra Sicilia e Calabria.
Mafia, 'ndrine e massoneria. Ecco allora che se
ciò è vero, non può sfuggire come il contesto nel quale maturò l'omicidio del
giudice “solo” è qualcosa più di un humus meramente mafioso. Chiama in causa
anche quei grumi di potere, al cui interno vi sono pezzi deviati dello Stato,
senza i quali le mafie oggi non sarebbero quelle potenti organizzazioni che
abbiamo imparato a conoscere. Sono processi come “Gotha” a rivelare l'esistenza
di una componente riservata della 'ndrangheta, quella in grado di dettare le
linee guida della strategia criminale, poi messa in atto dalla componente
militare. Risulta evidente come un simile delitto non possa essere stato deciso
solo da coloro che avevano il potere di sparare. Del resto, la storia dei legami
fra Sicilia e Calabria è ben più risalente nel tempo. Non si dimentichi quanto
hanno riferito gli storici pentiti calabresi Giacomo Ubaldo Lauro e Filippo
Barreca in ordine ad una super loggia segreta costituita a Reggio Calabria dal
terrorista nero Franco Freda, nel periodo in cui la città dello Stretto divenne
il laboratorio prediletto dell'eversione. Un capitolo che il giudice Scopelliti
conobbe anche piuttosto bene. E cosa dissero i pentiti? Che una loggia gemella
fu costituita anche a Catania. Sì, nella stessa città dove oggi il Procuratore
Bombardieri ritiene di aver individuato l'arma che sparò a Scopelliti. Una pura
coincidenza? Può darsi. O forse no. Forse, invece, quei legami inconfessabili
fra lo Stretto e la città dell'Etna sono qualcosa di più profondo. Forse quegli
scambi, continui e costanti, nascondevano una compenetrazione criminali ben più
strutturata. Sta di fatto che aver individuato oggi un'arma, sotterrata e
rimasta segreta per ben 27 anni fornisce un preciso messaggio.
Cosa c'è dietro il ritrovamento? Che ci sia
qualcuno che finalmente abbia iniziato una collaborazione seria sulla morte del
giudice Scopelliti? Non siamo in grado di dirlo, ma, se così fosse, l'arma
potrebbe rappresentare un formidabile riscontro. Del resto, si dice sempre che
un pentito, per essere credibile, debba dimostrare ciò che dice. E chi poteva
sapere dove era tenuta l'arma del delitto? Solo chi ne ha avuto piena
conoscenza. Ecco allora che questa notizia è molto più che un fatto tecnico. Il
riserbo del procuratore potrebbe celare qualcosa di simile. La capacità tecnica
degli operatori di polizia, peraltro, è nota: da una mera arma potrebbero
risalire a molto di più. Per esempio capire se la stessa fu utilizzata per altri
delitti eccellenti, magari con imputati condannati in via definitiva. Bisognerà
attendere e non sarà certo questione di poco tempo. Ma la sensazione è che,
anche in questo caso, non bisogna certo andare troppo lontano per cercare la
verità. Chissà che, una volta per tutte, non si riesca a scrivere una parola di
verità su uno fra i delitti più indecifrabili della storia recente. La Procura
di Reggio Calabria ci ha già dimostrato di essere perfettamente in grado di
farlo.
Chi infanga la massoneria, scrive Vittorio Sgarbi,
Venerdì 10/08/2018, su "Il Giornale". Non avendo problemi, in Sicilia, se li
creano. Non bastassero la mafia e l'antimafia, la disoccupazione e lo
sconvolgimento del paesaggio, gli sfaccendati parlamentari dell'Assemblea
regionale si trastullano con disegni di legge come quello che impone l'obbligo
di dichiarare l'affiliazione dei deputati e degli assessori regionali a logge
massoniche e similari. Il proponente è Claudio Fava, che si compiace di
sovrapporre associazione a delinquere con le libertà di associazione religiosa,
culturale, politica previste dall'articolo 18 della Carta Costituzionale. Un
simile arbitrio era stato tentato nelle Marche e prontamente dichiarato
illegittimo dal Consiglio di Stato. Infatti la norma discrimina l'appartenenza
alla Massoneria da ogni altra per cui non è richiesta alcuna declaratoria. Le
leggi speciali odorano di stato di polizia e di dittatura. E umiliano
un'appartenenza come se essa stessa fosse un crimine. Il crimine presuppone una
responsabilità individuale. La massoneria ha una storia gloriosa che non può
essere infangata dai disturbi persecutori di un Fava, seguito da parlamentari
distratti e opportunisti, privi di rispetto per la storia e per la libertà di
idee, senza nulla fare di penalmente rilevante. Essere massoni non significa
essere criminali. Gli iscritti al Grande Oriente d'Italia, anche per statuto
interno, devono avere i medesimi obblighi di rispetto delle leggi dello Stato,
con la «dovuta obbedienza e la scrupolosa osservanza alla Costituzione dello
Stato democratico e alle Leggi che ad essa s'ispirino». La vera colpa è
ignorarlo.
Il pentito della super loggia massonica
segreta: "C'erano anche capi di Stato ed esponenti di governo",
scrive Ignazio Dessì il 26 settembre 2017 su "Tiscali". Che rapporto esiste tra
le mafie e la Massoneria? Ha tentato di chiarirlo la Commissione Parlamentare
Antimafia presieduta dall'onorevole Rosy Bindi che, dopo aver impattato contro
il diniego delle organizzazioni massoniche italiane a consegnarli, ha deliberato
il sequestro degli elenchi degli iscritti. Così a inizio marzo scorso gli uomini
dello S.C.I.C.O., il Servizio centrale di investigazione sulla criminalità
organizzata, hanno sequestrato le liste degli affiliati alle quattro principali
associazioni massoniche italiane: il Grande Oriente d’Italia, la Gran Loggia
Regolare d’Italia, la Serenissima Gran Loggia d’Italia e la Gran Loggia d’Italia
degli Antichi Liberi Accettati Muratori. La reazione delle obbedienze massoniche
non si è fatta attendere. Il Gran Maestro del Goi, Stefano Bisi, ha dichiarato:
“Noi cerchiamo di utilizzare tutti gli strumenti che la legge consente per
respingere l’atto (secondo noi illegale) che la commissione parlamentare
antimafia ha fatto. La nostra non è lotta contro lo Stato”. Ma Rosy Bindi ha
risposto spiegando che “la mancanza di collaborazione con le Istituzioni
parlamentari, arrivata al diniego di consegnare i nominativi alla Commissione,
ha portato al sequestro perché è stata lanciata una sorta di sfida. Ha fatto
nascere alcuni dubbi sull’organizzazione massonica, assolutamente legittima
nella sua esistenza, che non può tuttavia presentarsi come un ordinamento
separato rispetto allo Stato rifiutando la collaborazione per proteggere i
propri iscritti e il buon nome dell’organizzazione. Eppure non stiamo facendo
una inchiesta sulla Massoneria, stiamo facendo una inchiesta sui mafiosi
massoni”.
Il Gran Maestro del Goi Stefano Bisi e Rosy Bindi.
Si tratta insomma di gettare un fascio di luce sulla nuova organizzazione delle
mafie. Per la commissione presieduta dalla Bindi la questione è fondamentale. E’
importante cercare di far chiarezza su una realtà che vede “insieme pezzi delle
mafie con pezzi delle massonerie, dello Stato e delle classi dirigenti del
nostro Paese”, precisa la presidente della commissione.
"Indizi concreti". La esigenza di chiarezza del
resto non è ingiustificata, si basa su indizi concreti. “Le conclusioni cui
siamo giunti non sono definitive – spiega la Bindi nella puntata
di PreasaDiretta intitolata I Mammasantissima mandata in onda lunedì su Rai3 -
ma i primi risultati del nostro lavoro dimostrano che fra i nominativi degli
iscritti di alcune logge della Calabria e della Sicilia vi sono alcuni
condannati in via definitiva per 416 bis, quindi per associazione mafiosa, e un
numero considerevole di situazioni giudiziarie in itinere di imputati rinviati a
giudizio sia per reati di mafia, sia per quelli che comunemente chiamiamo reati
spia, ovvero comportamenti mafiosi o comunque di collusione con la mafia”. Sono
stati scoperti effettivamente dei mafiosi all’interno di logge regolari? Alla
domanda della giornalista di PresaDiretta la presidente dell’Antimafia risponde
di sì. Ma i Gran Maestri hanno detto seccamente no alla consegna degli elenchi.
Anche se la Bindi precisa che “nessun nome è circolato e circolerà proprio
perché non vogliamo rivelare un dato riservato che è quello dell’iscrizione alla
massoneria”. La situazione sembra ormai a tinte fosche. “I dati quantitativi che
stanno emergendo – afferma la Bindi - sono obbiettivamente ed effettivamente
preoccupanti, si dimostra che alcune teorie sulle nuove organizzazioni della
mafia, per cui questa starebbe assumendo nuove connotazioni che passano anche
attraverso le organizzazioni massoniche sono in qualche modo convalidate”.
"Quali i nuovi varchi delle mafie". E' allora
fondamentale comprendere bene e fino in fondo “quali sono i nuovi varchi delle
mafie oggi”, quelle che “sparano meno ma corrompono di più, condizionano
l’economia legale, la politica, la Pubblica Amministrazione e riescono a piegare
ai loro voleri e interessi le classi dirigenti del Paese”. Per l’onorevole Bindi
è indubitabile, “dopo i primi risultati, poter dire che anche le associazioni
massoniche rischiano di essere un varco o addirittura una nuova forma di
organizzazione attraverso cui le mafie creano relazioni con il potere”.
L'aderente alla massoneria pentito e la super
loggia segreta. Particolarmente istruttiva l’intervista fatta da Raffaella
Pusceddu di PresaDiretta ad un aderente pentito della massoneria, Cosimo
Virgilio, imprenditore calabrese legato alla ‘ndrangheta e massone d’alto
livello. Virgilio inizia col ricordare il suo ingresso in Massoneria, nel Goi
(Grande Oriente d’Italia), negli anni ’90, a Messina. Poi il trampolino di
lancio per arrivare a Roma: “L’ordine dei Templari, dove si ambiva ad essere
riconosciuti dalla Santa Sede, dal Vaticano”, racconta. La loggia dove approdò
dopo però non era una loggia delle obbedienze ufficiali. “Era una massoneria
diversa”. In sostanza, sintetizza Virgilio, si trattava “dell’accorpamento del
vero potere. C’erano Capi di Stato, esponenti del governo, alcuni dei quali
ancora in carica”. Descrive anche il suo rito di iniziazione alla loggia
segreta. “Un rito molto crudo – afferma – teso a significare la morte della vita
terrena, in cui si doveva stare per ore a fianco di quella che rappresentava la
morte del profano, ovvero lo scheletro”. Una Super Loggia in definitiva, “al di
sopra di leggi e governi che decideva le sorti del Paese e non solo”. Il fine
ultimo era sempre il solito: “Il denaro e il potere”. Per questo si arrivava
alla “costituzione di banche per raccattare i capitali”. E altro. “Per fare un
esempio, all’epoca era in ballo la fornitura in Turchia di elicotteri Agusta, mi
sembra, e si andava a decidere lì” il da farsi.
"Anche esponenti della criminalità organizzata". E
nella Super Loggia segreta c’erano “anche – a detta del massone e imprenditore –
esponenti della criminalità organizzata. Ad esempio, per la ‘ndrangheta si
gestivano proventi illeciti, si faceva riciclaggio insomma. Una nostra missione
era inoltre quella di accorpare sempre più avvocati, perché gli avvocati avevano
i rapporti con i magistrati, e se un ‘ndranghetista ha bisogno di aggiustare un
processo non può andare a parlare direttamente con un magistrato”. Ma si tratta
di una “’Ndrangheta al servizio della massoneria o di una massoneria al servizio
della ‘ndrangheta? “Io lo definisco un sistema di mutuo scambio”, risponde
Virgilio nell’intervista. Il punto di vista di uno che sa quello di cui parla.
Virgilio infatti, oltre a far parte della loggia massonica segreta faceva parte
anche di una loggia ufficiale. Era maestro venerabile della Loggia dei
garibaldini, spiega il servizio. E a questo proposito la domanda
dell’intervistatrice è puntuale: si trattava di una copertura o esiste un
rapporto tra le logge segrete e quelle ufficiali? La risposta dell’imprenditore
calabrese fa davvero riflettere: “C’è un riconoscimento universale, ogni massone
non può rifiutare il riconoscimento di un altro massone. E’ inutile distinguere
tra massoneria riconosciuta e non, con questa super loggia i maestri venerabili
avevano grossi interscambi culturali. Diciamo così, culturali”. La giornalista
di LineaDiretta a questo punto approfondisce non senza un moto di sorpresa:
“Quindi lei mi dice – incalza - che esistevano rapporti tra obbedienze della
massoneria ufficiale e quella dove c’era la ‘ndrangheta?”. La risposta: “Si,
siamo fratelli comunque”.
I lavori della Commissione. Diventa allora ancor
più comprensibile lo sforzo portato avanti dalla Commissione Antimafia per
acclarare quali siano i rapporti reali tra mafie e massoneria. Davanti alla
presidente Rosy Bindi hanno sfilato i nomi più importanti delle obbedienze
italiane. Si sono domandati chiarimenti tesi a verificare possibili rapporti con
ndrangheta e mafia. Si è chiesto se i Gran Maestri fossero a conoscenza di
talune inchieste e rapporti. Si sono infine richiesti i nomi degli iscritti. Ma
tutti i responsabili si sono barricati dietro il diritto alla privacy. Il 17
gennaio il Gran Maestro del Goi, Stefano Bisi, ha chiarito che “la consegna
degli elenchi dei circa 23mila fratelli non può avvenire, perché si compirebbe
noi stessi un reato”. La Bindi gli ha detto a quel punto: “Vi siete chiesti
perché in Sicilia e Calabria vi è una sproporzionalità tra abitanti di quelle
regioni e iscritti alla massoneria rispetto alle altre regioni italiane?”. E
Bisi ha risposto: “Sì, conosco i fratelli di quei territori e non sono peggiori
di altri, sono come altri. Noi finché non c’è un documento penale non possiamo
agire come organi di polizia giudiziaria”.
Trasparenza e rifiuto degli elenchi. Inevitabile
per la giornalista autrice del servizio porre una domanda al Gran Maestro del
Goi intercettato durante una riunione della sua organizzazione. “Come si
concilia con la sua annunciata politica della trasparenza il fatto di non voler
fornire i nomi dei vostri elenchi alla commissione parlamentare?”. E’ semplice,
ad avviso del Gran Maestro: “Nessun’altra organizzazione umana di persone
fornisce l’elenco dei propri iscritti, nessuna”. In soldoni, tutte le grandi
obbedienze rifiutano di consegnare l’elenco degli iscritti. E la difesa si è
fatta strenua. Schiere di avvocati sono state mobilitate perché – ha detto Bisi
ai suoi – “Non si può continuare con le pesche a strascico. Ci opporremo con
tutte le forze a chi sta trasformando in una caccia alle streghe una caccia
all’uomo”. Inevitabile per la Commissione Antimafia e per Rosy Bindi deliberare
per il sequestro degli elenchi attraverso la Guardia di Finanza.
Calabria: Platì è mafiosa? Già, ma ha
eletto Rosy Bindi, scrive Ilario Ammendolia su Il
Dubbio, il 7 giugno 2016. In questi giorni di vigilia elettorale, Platì, paese
di tremila abitanti della Locride, in Calabria, è andato sulla prima pagina di
tutti i più importanti quotidiani nazionali. Domenica s'è votato ed i candidati
a sindaco sono due normalissime persone del luogo: Ilaria Mittica, funzionaria
regionale e Rosario Sergi assicuratore. Elezioni normali come in tutti i paesi
d'Italia ed, a tratti, quasi noiose. Ma per gli inviati speciali che per tutta
la giornata si sono aggirati ai seggi con penna e taccuino, quella di ieri non è
stata una normale manifestazione di libertà e di democrazia. A Platì, dietro
ogni cosa, c'è sempre la ndrangheta anche se non è spuntata la lupara né il
coltello. Anche se uomini e donne sono andati gioiosamente ai seggi e senza
pistola alla tempia. Inutile. Qui si è colpevoli a prescindere. L'inviato di un
importante quotidiano nazionale dinanzi alla gente che va al voto scrive che a
"Platì siamo al Medioevo. Questa è una terra che è Italia solo sulla carta
geografica". (La Repubblica)
Ed è vero. Questa è una Terra che non è Italia gli
ospedali somigliano tremendamente ai lazzeretti. Non è Italia perché ha il tasso
di disoccupazione più alto di Europa. Perché la garanzie costituzionali sono
state sospese da tempo. Perché uno Stato intriso di mentalità mafiosa si arroga
di sciogliere i consigli comunali democraticamente eletti. Non è Italia perché
le classi dirigenti hanno seminato per decenni la malapianta della ndrangheta
trasformando un popolo di lavoratori in popolo di emarginati. Non è Italia
perché i parlamentari e la classi dirigenti regionali ha scambiato per mezzo
secolo i voti della ndrangheta con favori accordati ai mafiosi. Infatti, la
ndrangheta per decenni è stata uno di strumento di governo cresciuta persino (o
soprattutto) nelle caserme e nei tribunali. Non è Italia perché le
disuguaglianze sono più evidente che altrove. Non è Italia perché qui è stata
eletta Rosy Bindi che, chiusa in una caserma di Locri, e debitamente a distanza
dai "lebbrosi" che l'hanno eletta, pontifica come una vestale del tempio sulla
mafiosità dei calabresi. Non è Italia perché il presidente del consiglio dei
ministri indica il candidato a sindaco di Platì dal palco della Leopolda. Perché
l'on. Fava si è permesso di affermare che i candidati di Platì pur essendo in
regola con i criteri dell'antimafia sono comunque sospetti, ci mancherebbe
altro! Non è Italia perché l'indegno spettacolo che in occasione del 2 giugno
del 2015 il PD ha messo in scena a Platì, ha dimostrato la consistenza e la
serietà dei partiti calabresi. Sostanzialmente uguali! Non è Italia perché il
procuratore della Repubblica di Reggio, ha dichiarato che sarebbe utile
affiancare al nuovo sindaco di Platì un funzionario per controllare ogni atto
della futura amministrazione. Un super controllo a Platì mentre le classi
dirigenti fanno sparire nel nulla i miliardi che sarebbero destinati alla sanità
o all'ambiente. Si vuole una Calabria ridotta tout-court alla sola dimensione
criminale (che esiste) perché ciò fa molto comodo alla "catena di comando". I
mafiosi ci sono e vanno fieri dell'attenzione che ricevono dai giornali, dai
"partiti", dalle istituzioni. In questa nottata in cui tutti i gatti sono neri,
loro ci sguazzano come pesci nel mare. In tutta la Calabria il voto è stato
espressione di un disagio estremo. Ovunque si notano segnali di una rivolta
strisciante contro lo Stato e che solo Dio sa come potrebbe andare a finire. A
Cosenza più che per il "buongoverno" del sindaco uscente si è votato contro gli
oligarchi del potere. A Napoli De Magistris, che in Calabria, si è mosso come
rigoroso custode dell'ordine costituito, è diventato il Masaniello che agita il
"Sud ribelle" contro il Gran Ducato di Toscana. Napoli e Platì sono distanti
solo in apparenza. Per usare il linguaggio di Sciascia è la linea della Palma
che avanza. Chi vuole ridurre la questione meridionale che oggi si allarga sino
a diventare una "questione Mediterranea" a mera questione criminale o di ordine
pubblico si assume sulle spalle e per intero le responsabilità storiche di
quanto potrebbe accadere. Nel Mezzogiorno, probabilmente la rabbia, lungamente
repressa, non troverà sbocco nel movimento "5 Stelle" ma potrebbe sbucare come
un fiume carsico nei luoghi più impensati con conseguenze che nessuno in questo
momento è in grado di prevedere.
Bindi a capo dell'Antimafia: sfruttò i
sindaci anti boss per farsi eleggere alla Camera. Il
Pd la candidò in Calabria: ma una volta presi i voti, non s'è più fatta vedere,
scrive Felice Manti, Giovedì 24/10/2013, su "Il Giornale". A Siderno la stanno
ancora aspettando. Eppure a Rosy Bindi la Locride dovrebbe esserle cara, visto
che quei voti raccolti alle primarie Pd in Calabria sono stati decisivi per la
sua elezione come capolista. Da febbraio invece l'ex presidente Pd i calabresi
la vedono solo in tv. D'altronde la Bindi non ha fatto un solo incontro sulla
'ndrangheta durante la campagna elettorale, ammettendo «di non sapere niente di
mafia». «Doveva venire anche il 2 agosto, ero lì ad attenderla», dice al
Giornale Maria Carmela Lanzetta, ex sindaco antimafia di Monasterace. Per la
cronaca, allora Rosy preferì un talk show su La7. La Lanzetta è amareggiata, ma
non lo ammette per orgoglio. Aveva resistito alla tentazione di dimettersi dal
Comune stritolato dalla mafia, quando i boss le hanno bruciato persino la
farmacia di famiglia. Poi era arrivato Pier Luigi Bersani, l'aveva eletta icona
della sua campagna elettorale, e tutto lo stato maggiore del Pd in Calabria si
era convinto che alla fine sarebbe stata lei la capolista del Pd nel feudo
bersaniano. E invece il commissario bersaniano Alfredo D'Attorre - ça va sans
dire - anziché rilanciare il partito si è fatto eleggere e ha dato l'ok al
paracadute pure per Rosy, tra lo sconcerto dei sindaci antimafia: «Avevamo
scritto a Bersani - dice ancora la Lanzetta - per chiedere una candidatura
simbolica, del territorio, per un segnale di cambiamento». Poteva essere la
Lanzetta oppure Elisabetta Tripodi, sindaco di Isola Capo Rizzuto (feudo degli
Arena, quelli che elessero l'ex senatore Pdl Nicola Di Girolamo in Germania) o
Carolina Girasole (bersaniana poi arruolata con Monti). Alla fine la Lanzetta ha
perso tutto: niente scranno e niente fascia tricolore. Si è dimessa dopo il «no»
del suo votatissimo assessore democrat alla richiesta del Comune di costituirsi
parte civile in un processo nato da un'inchiesta antimafia che coinvolgeva due
funzionari. Clelia Raspa, medico alla Asl di Locri dove lavorava il
vicepresidente Pd del Consiglio regionale Franco Fortugno, ucciso in un seggio
delle primarie nell'ottobre del 2005, forse non voleva mettersi contro il
capoclan della cittadina della Locride, Benito Vincenzo Antonio Ruga. «Ma alla
fine ce l'ho fatta a costituire il Comune parte civile per difendere l'integrità
dell'istituzione», sorride amara la Lanzetta. In fondo il povero Bersani non
aveva scampo. La Bindi era a un passo dalla rottamazione, travolta dal ciclone
Matteo Renzi. Solo delle primarie «blindate» avrebbero potuto salvarla, come
successo con Anna Finocchiaro, siciliana ma eletta a Taranto. Esclusa la
«renziana» Toscana, quale posto migliore della Calabria? Anche nel 2008 il Pd di
Walter Veltroni aveva piazzato Daniela Mazzucconi dalla Brianza, guarda caso
protegée della stessa Bindi. A stenderle il velo rosso al debutto di Rosy c'era
tutto lo stato maggiore del Pd. Il cronista di Report Antonino Monteleone venne
cacciato in malo modo da un congresso al quale partecipavano tutti i colonnelli
locali, come la vedova di Fortugno, Maria Grazia Laganà o il potentissimo
signore delle tessere Gigi Meduri, sponsor dell'ex consigliere regionale Mimmo
Crea, beffato da Fortugno che gli scippò il seggio e beneficiario «politico»
della sua morte. Che c'entra Crea, oggi travolto da pesantissime accuse, con la
Bindi? Quando entrò nella Margherita, come scrive Enrico Fierro nel suo
Ammazzati l'onorevole, Crea «fu festeggiato a Torino in una cena. Meduri,
intercettato al telefono, si lasciò scappare: «Sedici erano a tavola, sedici
deputati. C'era Franceschini, la Bindi. Quando è arrivato il conto ho detto a
D'Antoni provvedi a nome del compare Crea. Una scena che mi si mori... (una
scena che a momenti morivo dalle risate, ndr)». Sai che risate con la Bindi
all'Antimafia.
“La quaestio massoneria ha assunto i
crismi di una vera e propria crociata”, scrive il 30
dicembre 2017 "Il Corriere del Giorno". La lettera del Gran Maestro del GOI
Stefano Bisi inviata ai direttori dei giornali, che contesta l’operato della
Commissione Antimafia presieduta da Rosy Bindi: “Noi per primi abbiamo sempre
condannato e condanniamo la Mafia e le criminalità che inquinano la Società e
oscurano la Legalità”. "Gentile Direttore, Le scrivo questa lettera all’indomani
della relazione della Commissione Antimafia sulle infiltrazioni mafiose nelle
Logge delle diverse Obbedienze italiane per sottoporre ai lettori del suo
autorevole quotidiano e all’opinione pubblica alcune necessarie e opportune
riflessioni sul ruolo etico della Massoneria nella Società e sulla enorme
gravità, a mio avviso, di alcune idee ispiratrici di proposte di legge che la
stessa Commissione ha avanzato per porre una esorbitante ed allarmante Quaestio
Massoneria che ha assunto di fatto piuttosto i crismi di una vera e propria
crociata nei confronti dei liberi muratori alla luce degli intendimenti della
presidente Rosy Bindi e delle possibili determinazioni legislative future che
sono state proposte dai commissari. In base ai numeri resi noti dopo il
sequestro degli elenchi di Sicilia e Calabria al Grande Oriente d’Italia e ad
altre tre Obbedienze sarebbero stati nell’arco temporale di 26 anni, 193 i
soggetti indagati per fatti di mafia, in circa 350 procedimenti penali, e sei le
persone che sono state condannate in via definitiva, mentre per altri 25 i
procedimenti risulterebbero ancora in corso. Per quanto riguarda poi il Grande
Oriente d’Italia, la Comunione di cui sono il Gran Maestro dal 2014, queste
figure risulterebbero due (un pensionato e un commercialista, di cui la
Commissione non ha fornito i nomi opponendo motivi di privacy). Questi i numeri
che, pur non sottovalutando affatto la questione e auspicando la via della
Giustizia e della Verità, nella realtà credo si commentino subito da soli. Ma,
lascio a Lei e ai lettori, ampia valutazione di giudizio e di visione del
problema. Secondo la Presidente Bindi e i membri dell’Antimafia, comunque questi
numeri su un totale di 17.000 nomi passati al setaccio, basterebbero e/o
sarebbero sufficienti per fare emergere un quadro a tinte fosche e preoccupante,
per suffragare così l’equazione mafia-Massoneria e bollare a priori in modo
infamante tanti onesti liberi muratori italiani. Siamo nel Paese dei teoremi e
dei sospetti, si sa, e basta poco per scatenare una inopportuna e pericolosa
caccia al massone. Lo stesso Giovanni Falcone non a caso diceva che il sospetto
è l’anticamera della calunnia. Noi ci siamo sempre opposti e ci opporremo da
fedeli cittadini osservanti della Costituzione ai tentativi di creare una
situazione di estremo disagio e di vera e propria ghettizzazione nei confronti
di uomini di tutte le estrazioni sociali che hanno liberamente intrapreso la via
iniziatica di Libertà, Uguaglianza e Fratellanza per l’elevazione personale e il
miglioramento dell’Umanità. Non certo per essere tacciati di collusioni con
organizzazioni che sono lontane dal nostro Dna e dai nostri sani valori. Noi per
primi abbiamo sempre condannato e condanniamo la Mafia e le criminalità che
inquinano la Società e oscurano la Legalità. Lo facciamo quotidianamente con le
nostre azioni trasparenti dentro e fuori i Templi. Lo facciamo con la nostra
solidarietà che ha portato la luce dell’impianto di illuminazione al campo di
calcio di Norcia donato dall’Ordine ai ragazzi di questa area terremotata, e con
le borse di studio ai maturandi delle scuole delle zone interessate dal Sisma
che hanno studiato con coraggio, impegno e merito. Ma, alla luce degli ultimi
eventi, tornando nel merito della vicenda, la nostra trasparenza e le nostre
note finalità, per certi politici sono lontani dalle loro idee e dal modo di
vedere la Libera Muratoria qual essa veramente è. La Massoneria e i suoi membri
restano per questi filosofi del pregiudizio, entità sospette e segrete, dedite a
chissà quali trame occulte e con l’aggravante – non provata – della presunta
infiltrazione mafiosa. Al di là di quelle che possono essere le convinzioni
altrui, entrare in Massoneria non è affatto facile e scontato, i controlli sono
estremamente rigorosi e non legati solo all’ingresso nell’Istituzione. La nostra
riservatezza eguale a quella di tutte le associazioni, non può essere fatta
sconfinare in modo arbitrario e falso nell’accusa di segretezza. Ora
l’onorevole Bindi e i membri dell’Antimafia propongono l’assoluta necessità di
un intervento legislativo che vieti esplicitamente la segretezza delle
associazioni. Ma lo fanno con toni, modi e soprattutto analogie di leggi
fasciste che non esito a definire aberranti e inquietanti per chi ha a cuore la
Storia, il sangue versato per la Libertà e la Democrazia. Questo è scritto nella
relazione: “Non si vuole di certo auspicare il ripristino delle disposizioni
fasciste sopra riportate, seppure, non va dimenticato che, accanto a coloro che
perseguivano evidenti volontà illiberali, insigni giuristi apprezzavano tali
normative che, per l’eterogenesi dei fini tipica delle leggi, garantivano
comunque un sistema di conoscenza e di trasparenza”. Ebbene queste norme
fasciste andrebbero tristemente rispolverate e fatte proprie oggi per mettere in
riga la Massoneria, quella stessa Massoneria che il Fascismo colpi duramente
sopprimendola. Il solo Gramsci con un discorso celebre si alzò in difesa del
libero pensiero e della Libertà. Tutti quanti sappiamo cosa è accaduto dopo e
quanto è costato il ritorno alla Democrazia. Gli odierni sostenitori di questo
grave e allarmante richiamo al passato vogliono riutilizzare questa legge
per “trasparenza e conoscenza”. Ma, in realtà, dietro la loro reclamata e
declamata azione c’è il fine di mettere i massoni in un recinto. Dovranno
esibire il loro status per legge e essere messi costantemente all’angolo. Chissà
se in seguito potranno insegnare nelle scuole e nelle università o concorrere
per posti pubblici? Quando si inizia con questi fini si può arrivare ovunque.
Ecco perché, caro Direttore, mi sono permesso di sottoporle questa lettera che è
anche un campanello d’allarme. Perché la Democrazia e il libero pensiero sono un
bene di tutti e non di parti o visioni politiche. E dopo i liberi muratori
potrebbe toccare ad altri soggetti essere destinatari di quella pregiudizievole
attenzione che se non equilibrata può portare allo spegnimento della luce della
ragione e al triste passato. Cordiali Saluti. Stefano Bisi, Gran Maestro del
Grande Oriente d’Italia".
Bindi vuole il diritto di sputtanare i
massoni, scrive Simona Musco il 23 Dicembre 2017 su
"Il Dubbio". La presidente dell’Antimafia vuole vietare il diritto alla
segretezza degli iscritti alle associazioni. Bisi: “Vogliono reintrodurre le
leggi fasciste”. In 26 anni sono state 193 le persone indagate per fatti di
mafia, in circa 350 procedimenti penali, tra gli iscritti alle logge massoniche
di Calabria e Sicilia. Ma tra questi, solo sei sono quelli condannati in via
definitiva, mentre per altri 25 i procedimenti penali sono ancora in corso. Sono
questi i numeri emersi dalla relazione conclusiva su “Mafia e massoneria”,
illustrata ieri a palazzo San Macuto dalla commissione parlamentare antimafia.
Numeri che, stando alle conclusioni del presidente Rosy Bindi, destano allarme e
necessitano un intervento legislativo che vieti categoricamente la segretezza
delle associazioni, elemento comune alle due associazioni e dunque terreno
fertile per l’infiltrazione. L’analisi si è limitata a Calabria e Sicilia e ha
interessato quattro fratellanze, per un totale di poco superiore ai 17mila
iscritti. Su sei persone condannate, solo due (un pensionato e un
commercialista) sarebbero tuttora iscritti e attivi. «Non è un’inchiesta sulla
massoneria – ha precisato Bindi – ma sulla presenza della mafia nella
massoneria». Un’inchiesta che parte dalle recenti indagini antimafia nelle due
regioni e caratterizzata da «una mancanza di collaborazione dei gran maestri
ostentata fin dall’inizio», denuncia la presidente. «Gli elenchi ufficiali – ha
spiegato – presentano una certa opacità e impossibilità piena di individuare gli
iscritti», circostanza che il gran maestro del Goi, Stefano Bisi, ha smentito al
termine della conferenza stampa. La mafia sarebbe interessata alla massoneria,
si legge, «perché consente di incontrare la classe dirigente del paese», utile
alla mafia per riciclare denaro sporco in attività legali. Di fronte a questa
volontà, le logge si sarebbero dimostrate «arrendevoli» e avrebbero dimostrato
«mancanza di volontà a dotarsi di strumenti» in grado di chiudere le porte alle
mafie, «tollerando» la doppia militanza a mafia e massoneria, «spesso nota ad
entrambe le organizzazioni» e «quasi ricercata». Le indagini giudiziarie,
ammette però la relazione, non sono «mai giunte» ad un giudicato definitivo
«circa una relazione stabile e continuativa» tra le due parti, ma il quadro
complessivo rivelerebbe, in ogni caso, «una pericolosa e preoccupante
contiguità», iniziata in Sicilia alla fine degli anni ‘70 e grazie alla quale
sarebbe stato possibile «interferire in qualche modo sulle indagini
giudiziarie». Più complessi, invece, i rapporti con la ‘ndrangheta, che ha dato
vita ad una carica di livello superiore – la “Santa” – in grado «di creare un
collegamento stabile tra l’associazione mafiosa e i vari centri di poteri
presenti nella massoneria». Dura la replica di Bisi, che si è detto
«preoccupato» dalla possibilità di reintrodurre «leggi fasciste», che in un
passaggio della relazione vengono definite, al di là delle «volontà illiberali»,
come garanzia «di conoscenza e di trasparenza». Leggi che, ricorda Bisi, «hanno
prodotto un regime repressivo violando ogni libertà».
Quei massoni mafiosi che sussurrano ai
potenti. Sacerdoti, politici, magistrati,
professionisti, imprenditori. E padrini delle cosche. La commissione
parlamentare antimafia ha presentato la relazione sulle infiltrazioni dei clan
nella massoneria. Tra Sicilia e Calabria 17 mila iscritti alle 4 obbedienze
ufficiali distribuiti in 389 logge. 193 "fratelli" sono collegati a cosa nostra
e 'ndrangheta, uno ogni due templi. I nomi restano top secret, scrivono Federico
Marconi e Giovanni Tizian il 22 dicembre 2017 su "L'Espresso". Sacerdoti,
magistrati, consiglieri comunali e regionali, assessori, sindaci, imprenditori,
studenti, professionisti. E mafiosi, calabresi e siciliani. Al gran ballo della
massoneria ci sono tutti, non manca proprio nessuno. Alle danze tra Sicilia e
Calabria partecipano in 17 mila. In fondo, una loggia non si nega a nessuno.
Insomma, tutti pazzi per il grembiule. Il dato inquietante è però un altro: in
queste due regioni del Sud c'è un mafioso o un suo complice ogni due logge
massoniche. Sono 193, infatti, i “fratelli” collegati ai clan. C'è chi è stato
condannato, chi è stato prosciolto, chi ha festeggiato l'assoluzione e chi si
sta ancora difendendo nelle aule dei tribunali. Gli iscritti totali alle quattro
obbedienze, solo in Sicilia e Calabria, sono oltre 17mila. Una popolazione in
grembiule numerosa come quella dell'isola di Capri. La commissione antimafia
presieduta da Rosy Bindi ha terminato l'indagine sull'intreccio tra massoneria e
mafie. La relazione, approvata il 22 dicembre, è un viaggio nel lato oscuro
della massoneria italiana. Un mondo di mezzo nel quale boss e insospettabili
professionisti, padrini e rispettabili imprenditori, criminali e politici, si
scambiano favori e appoggi. Dei 193 nomi sporchi la commissione precisa che
«nove risultano condannati in via definitiva per reati vari, quali il traffico
di stupefacenti, ricettazione, falso, bancarotta fraudolenta, o destinatari, in
via definitiva, di misure di prevenzione personali, come tali indicative di
pericolosità sociale». Poi per altri quattro è in corso il processo di appello
con l'accusa di associazione mafiosa o di reati aggravati dal metodo mafioso.
Uno di questi in primo grado ha subito già una condanna a 12 anni. L'obbedienza
con la maggiore presenza di iscritti dal profilo equivoco è il Goi, il Grande
Oriente d'Italia. Il Gran Maestro è Stefano Bisi, il massone che più degli altri
si è opposto al lavoro della commissione antimafia bollandolo come un atto
fascista. Ora che l'indagine si è conclusa e la riservatezza è stata rispettata-
nel documento non è presente alcun nome- si scopre che più di qualche boss ha
frequentato i templi. Nella Gran Loggia regolare d'Italia i sospetti sono 58,
nella Gran loggia d'Italia sono 9 e nella Serenissima solo 4. «Le risultanze
illustrate nella relazione hanno fornito conferme in ordine alla rilevanza del
fenomeno, a fronte di una sua negazione da parte dei gran maestri, indice o di
un’inconsapevolezza o di una sua sottovalutazione, se non di un rifiuto ad
ammettere la possibile permeabilità rispetto a infiltrazioni criminali», osserva
l'Antimafia. La commissione, tuttavia, precisa che gli investigatori che hanno
collaborato ai risconti sugli elenchi sequestrati nelle sede delle obbedienze
hanno indicato solo «i soggetti iscritti per reati di mafia in senso stretto,
restando pertanto non segnalati tutti i casi in cui il nominativo risulta essere
stato, invece, indagato o condannato per altri reati, taluni certamente di non
minore gravità». Come a dire: attenzione, i 193, che possono sembrare poca cosa,
potrebbero aumentare sensibilmente se si sommassero a questi i massoni con
precedenti per corruzione, abuso d'ufficio, reati economici e tributari. Tutti
reati spia di una criminalità mafiosa che si insinua nei centri di potere
locali: municipi, assessorati, aziende sanitarie, assemblee regionali e
provinciali. «A tal proposito, si segnala che il 17,5 per cento degli iscritti
presenti negli elenchi acquisiti dalla Commissione non sono identificabili o
compiutamente identificabili». Questo significa che molti nella lista sono
indicati con le iniziali, oppure con dati anagrafici errati. Il che ha reso
impossibile risalire alla loro identità. «Nell’ambito dei 193 soggetti segnalati
vi sono, come risulta dall’anagrafe tributaria, numerosi dipendenti pubblici. Le
categorie professionali prevalenti sono quelle dei professionisti, come
avvocati, commercialisti, medici e ingegneri. Presenti pure in numero rilevanti
i soggetti impiegati nel settore bancario, farmaceutico e sanitario, nonché
imprenditori nei più diversi settori, in primis quello edile. Così pure, non
mancano coloro i quali hanno rivestito cariche pubbliche». Sono ben 9 gli
amministratori, tra sindaci, assessori o consiglieri comunali. «Uno spaccato
professionale denotante soggetti di un livello di istruzione medio-alto e, di
tutta evidenza, in grado di stringere relazioni anche nel mondo della
criminalità e in quello della società civile», si legge nella relazione.
Logge e politica. Un focus la commissione lo ha
dedicato alla presenza della massomafia all'interno degli enti locali sciolti
per mafia. Caso emblematico l'Asl di Locri, commissariata undici anni fa. «Fra i
soggetti a vario titolo menzionati nella relazione della commissione di accesso
e nell’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Reggio Calabria,
figurano 306 nominativi. Di questi, 17 risultano censiti in logge massoniche.
Tra essi, 12 soggetti figurano negli elenchi sequestrati dalla Commissione il 1°
marzo 2017; 4 figurano solo negli elenchi (della massoneria ndr) sequestrati
dalla Procura della Repubblica di Palmi nel 1993-94 (uno nel frattempo è
deceduto); mentre un altro è presente in entrambi gli elenchi. Appare
significativo che i 4 soggetti presenti negli elenchi del 1993-94 ma non in
quelli del 2017, risultano essere stati raggiunti da provvedimenti cautelari
personali o a carattere detentivo, uno dei quali per il reato di cui all’art
416-bis c.p». Ma chi sono questi mafiosi armati di compasso? «Uno è il figlio di
un noto capo mafia; un altro, il nipote di un controverso personaggio ritenuto
molto influente nell’ambiente mafioso; un altro ancora, figlio di un condannato
in primo grado per mafia ma assolto in appello e, comunque, indicato come
referente di una nota cosca calabrese, nonché in stretti rapporti con un capo
indiscusso di una cosca del mandamento ionico della provincia reggina». Detto
dei criminali o presunti tali, nella relazione si evidenzia un altro aspetto:
«Deve ritenersi non occasionale, la significativa presenza di massoni in posti
apicali dell’azienda sanitaria, nelle società presso la medesima accreditate e
nelle pubbliche amministrazioni interessate dall’indagine penale. Di rilievo è
il fatto che tali personaggi, di cui si è accertata l’appartenenza a logge
massoniche regolari, hanno interagito con altri “fratelli” della stessa loggia o
di altre per affari riconducibili a persone indagate e, in taluni casi,
condannate per associazione mafiosa». Insomma, non è tanto la quantità di
mafiosi presenti nelle logge, ne basta uno per usufruire dei vantaggi che il
circolo di amicizie può garantire. Anche la Azienda sanitaria provincia di
Cosenza è stata sciolta. Incrociando i risultati emersi nella relazione
prefettizia con gli elenchi sequestrati, la commissione ha concluso che «su 220
nominativi individuati, presenti a vario titolo nella relazione conclusiva, 23
persone risulterebbero iscritte a logge massoniche».
A casa del padrino. Nel paese di Matteo Messina
Denaro pullulano compassi e grembiuli. Undici logge di varie obbedienze per 31
mila abitanti. Una vera città della massoneria, Castelvetrano. Tanto da essere
rappresentata degnamente in consiglio comunale, sempre e comunque. Nell'ultima
consiliatura, 2007-2012, «8 consiglieri su 30 appartenevano, o avevano chiesto
di entrare in logge massoniche. Tra i componenti del consiglio comunale eletto
nel 2012, vi sono 11 iscritti ad associazioni massoniche (anche diverse da
quelle in esame), uno dei quali è stato anche assessore e componente della
giunta comunale, quest’ultima poi revocata il 28.01.2015. Nella nuova giunta
nominata l’11.02.2015, il numero di assessori massoni aumenta considerevolmente,
diventando cinque su dodici membri complessivi della giunta, cioè poco meno
della maggioranza. In sintesi, considerando le ultime due consiliature del
comune di Castelvetrano hanno assunto cariche elettive o sono stati membri di
giunta almeno 17 iscritti alle quattro obbedienze. A questi potrebbero
aggiungersene verosimilmente altri 4 - per un totale, dunque, di 21
amministratori pubblici. Negli elenchi massonici di una obbedienza (GLRI), vi
sono infatti omonimi di altri quattro consiglieri comunali di Castelvetrano tra
i soggetti che risultano privi del luogo e della data di nascita in quanto
depennati. Il tutto distribuito in 11 logge quasi tutte presenti nella città di
Castelvetrano e dintorni».
Capi e massoni. Il collaboratore di giustizia
Leonardo Messina: “Molti uomini d’onore quelli che riescono a diventare capi,
appartengono alla massoneria (..) perché è nella massoneria che si possono avere
i contatti totali con gli imprenditori, con le istituzioni, con gli uomini che
amministrano il potere diverso da quello punitivo che ha Cosa nostra.” Lo stesso
concetto è stato ribadito alla Commissione, con riferimento ai primi anni del
2000, da un altro collaboratore di giustizia, Francesco Campanella. Anche lui
politico, massone e mafioso. Scrive la commissione: «Nelle più recenti indagini
giudiziarie, calabresi e siciliane, ricorre la medesima affermazione che appare
ancor più vera alla luce del mutamento delle mafie, ormai propense, come è noto,
al metodo collusivo/corruttivo seppur collegato alla propria capacità di
intimidazione...Anzi, proprio in questo peculiare momento in cui la mafia tende
più ad “accordarsi che a sparare”, deve altresì considerarsi il dato oggettivo
del continuo aumento del numero degli iscritti alla massoneria». Del resto le
inchiesta recenti dell'antimafia di Reggio Calabria puntano a svelare proprio
quel sistema criminale fatto di padrini e insospettabili uomini di potere, che
spesso si ritrovano in circoli massonici, non per forza ufficiali.
Un favore al “fratello” boss. Nella loggia “Rocco
Verduci” di Gerace, a Locri, si sono verificati fatti inquietanti. «Un
magistrato onorario, appartenente alla predetta loggia, aveva chiaramente
denunciato, ma soltanto in ambito massonico, una prima vicenda, risalente al
dicembre 2010, riguardante le pressioni da egli subite ad opera di due suoi
confratelli affinché si adoperasse per intervenire sul giudice monocratico del
Tribunale di Locri al fine di ottenere, in favore dei figli di uno dei due,
sottoposti a un procedimento penale per ricettazione, la derubricazione del
reato. Vale la pena aggiungere che il massone che sollecitava l’intervento del
magistrato onorario in favore dei propri figli indagati, era un medico della ASL
di Locri, poi sciolta per mafia, nonché figlio di un noto boss ‘ndranghetista,
mentre il massone che lo accompagnava, per sostenerne la richiesta, era un
soggetto che, all’epoca di fatti, svolgeva un ruolo direttivo nell’ambito della
“Rocco Verduci”». Allo stesso magistrato onorario viene chiesto successivamente
un secondo favore: «Intorno al mese di aprile 2012, fu ulteriormente
sollecitato, da un altro dei suoi fratelli di loggia, affinché intervenisse
ancora, riservatamente, presso i magistrati della Procura distrettuale antimafia
di Reggio Calabria al fine di perorare la causa di un terzo massone, già
consigliere della Regione Calabria, avendo questi saputo che, in quel momento,
nell’ambito di una indagine antimafia, naturalmente coperta dal più rigoroso
segreto, si stava vagliando la sua posizione». In questo caso la vicenda assume
contorni molto più oscuri. Sia perché è evidente la fuga di notizie che giungono
all'orecchio di massoni borderline, sia perché si trattava di indagine in corso.
«Vale la pena aggiungere, anche in questo caso, che il massone che si stava
prodigando, presso il magistrato onorario, in favore del politico, già si era
prestato, nei confronti di quest’ultimo per far ammettere nella loggia un nuovo
bussante, figlio incensurato di un soggetto tratto in arresto per associazione
mafiosa nell’ambito dell’operazione “Saggezza” dell'antimafia di Reggio
Calabria».
Tonaca e grembiule. Nello sterminato elenco di
personalità, non potevano mancare i sacerdoti delle logge. La chiesa lo
vieterebbe, ma questo non ha evidentemente fermato le aspirazioni dei religiosi.
«Non è questa la sede per affrontare la questione plurisecolare del rapporto tra
Chiesa cattolica e massoneria, tuttavia appare utile ricordare che, in base alla
Declaratio de associationibus massonicis emanata dalla Congregazione vaticana
per la Dottrina della Fede il 26 novembre 1983 - presieduta dal Prefetto
cardinale Joseph Ratzinger, poi papa Benedetto XVI - vi è inconciliabilità tra
l’adesione alla Chiesa cattolica e alla massoneria», scrive la Commissione. Di
recente, tra l'altro, papa Francesco ha respinto le credenziali di un
ambasciatore straniero presso la Santa Sede perché iscritto alla massoneria.
Logge segrete e sconosciute. L'indagine della
Commissione è stata effettuata sulle obbedienze conosciute, quelle più note e
ufficiali. Tuttavia nel variegato mondo massonico esistono numerosi gruppuscoli
più o meno noti, più o meno legali. Il tempo per analizzare anche quel mondo non
sarebbe stato sufficiente. Per questo la commissione invita i prossimi membri
della futura legislatura a proseguire nell'opera di inchiesta: «È stato
evidenziato dallo stesso mondo massonico come in Italia, e in particolar modo
nelle regioni del centro-sud, sia presente un florilegio di numerose piccole
obbedienze, con dichiarate finalità lecite, considerate alla stregua di
massonerie irregolari o di logge spurie. Così come è stato segnalato che
esistono canali di dialogo tra queste entità associative e la massoneria
regolare». E quindi: «L’insieme di queste dichiarazioni, dunque, proprio perché
provenienti dall’interno del circuito massonico, e peraltro da chi lo
rappresenta, acquistano particolare valenza in quanto pongono le premesse,
unitamente ad altri elementi raccolti da questa Commissione, sulla necessità che
il lavoro d’inchiesta avviato in questa Legislatura debba proseguire. Non potrà,
infatti, essere trascurato l’approfondimento del mondo magmatico delle
massonerie irregolari, del loro potenziale relazionale, dell’atteggiarsi delle
mafie nei loro confronti». Interessante a questo proposito i particolari forniti
dal gran maestro della Gran Loggia Regolare d’Italia: «Una cosa che accade
spesso è che gli iscritti alla massoneria, alla libera muratoria, sono
contemporaneamente iscritti anche ad altre forme associative. Parlo del Rotary,
dei Lions, dei Kiwanis. In queste associazioni i massoni di varie obbedienze –
ed è l'unico posto dove avviene – si incontrano. Quindi, sarebbe ancora più
interessante, secondo me, analizzare queste realtà, perché sono le uniche realtà
all'interno delle quali la massoneria irregolare e regolare va a incontrarsi.
Spesso, quindi, i presentatori incontrano i presentati all'interno del Rotary o
del Kiwanis. Molti iscritti alla massoneria ne sono presidenti».
Gli elenchi? No, grazie. La Commissione pensava di
trovare una sponda nei vertici delle obbedienze massoniche. Così non è stato.
Nelle audizioni dei vertici delle organizzazioni negavano la presenza di
infiltrazioni mafiose e sottolineavano l’esistenza di regole e prassi massoniche
– come la richiesta dei carichi pendenti e del certificato antimafia ai nuovi
membri – in grado di fronteggiare il possibile ingresso di “personalità
problematiche”. Si aggiunge poi il rifiuto, in nome della segretezza, di fornire
alla Commissione gli elenchi degli appartenenti alle logge, che una volta
consegnati sono risultati parziali e incompleti. Le obbedienze hanno
sottovalutato, minimizzato e a volte persino negato la presenza di massoni
“problematici” all’interno delle logge. Basti pensare che l’infiltrazione
mafiosa non è mai esplicitata nei documenti formali con cui ne viene decretata
la chiusura delle logge infiltrate. Piuttosto vengono utilizzati l’espediente
della “morosità degli iscritti” o questioni di mero rito massonico.
Massoneria, la Commissione antimafia:
"Rilevate infiltrazioni delle cosche nelle logge". La
relazione dopo le audizioni e i contestati sequestri delle liste di affiliati:
quasi 200 'fratelli' sono stati coinvolti in inchieste sulla criminalità
organizzata. E non tutti i condannati sono stati espulsi, scrive Alessia Candito
il 22 dicembre 2017 su "La Repubblica". Quasi 200 "fratelli" toccati o lambiti
da indagini di mafia. Sei condannati per associazione mafiosa, di cui due ancora
attivi. Più di 130 logge calabresi e siciliane abbattute dal 1990 dalle quattro
principali obbedienze massoniche in Italia, il Goi, la Gran Loggia degli Alam,
la Gran Loggia regolare d'Italia, la Serenissima Gran Loggia d'Italia-Ordine
generale degli Alam. Sebbene l'analisi del fenomeno sia stata solo parziale e
nessun nome venga esplicitamente fatto, è un quadro inquietante quello
ricomposto dalla Commissione parlamentare antimafia nella relazione appena
approvata su "Mafia e massoneria". "L'esistenza di forme di infiltrazione delle
organizzazioni criminali mafiose nelle associazioni a carattere massonico - si
legge - è suggerita da una pluralità di risultanze dell'attività istruttoria
della Commissione, derivante dalle audizioni svolte, dalle missioni effettuate e
dalle acquisizioni documentali". I rapporti fra mafie e massonerie ci sono. E la
Commissione ne ha la prova concreta. Dalle audizioni dei magistrati calabresi e
siciliani sono emersi dati allarmanti. Gli inquirenti trapanesi e palermitani
hanno infatti evidenziato "un filo conduttore che ipotizza come le logge coperte
si annidino ancora all'ombra delle logge ufficiali; come gli uomini, pur
risultati iscritti alle logge coperte, abbiano continuato a far carriera sia nel
mondo politico, sia nel mondo degli affari, non essendoci mai stata un'efficace
reazione delle Istituzioni per isolarli anche dopo che i loro nomi e la loro
appartenenza fosse divenuta palese; come vi sia riscontro che già appartenenti a
logge segrete e irregolari siano poi trasmigrati in altre logge; di come sia
possibile passare da una loggia regolare a una coperta e viceversa". Una
situazione delicata soprattutto nel trapanese, "regno" di Matteo Messina Denaro.
Nell'area, in cui si concentra un numero di iscritti, soprattutto provenienti
dalla borghesia cittadina, assolutamente sproporzionato rispetto ad altre zone
d'Italia - hanno riferito in commissione i magistrati - c'è il rischio che le
logge si trasformino in comitati d'affari. Ancor più compromessa, se possibile,
sembra la situazione in Calabria, dove - hanno riferito i magistrati - la
massoneria, tramite la Santa (la direzione strategica dell'organizzazione, ndc)
"si è piegata alle esigenze della 'ndrangheta, così creando all'interno di quel
mondo in cui convivevano mafiosi e società borghese professionale, all'ombra
delle logge, un ulteriore livello ancor più riservato formato da quei soggetti
che restano occulti alla stessa massoneria. Si tratta di coloro che, dovendo
schermare l'organizzazione ed essendo noti soltanto a determinati appartenenti
ai vertici più elevati, non si possono esporre a nessuna forma evidente, quali
possono essere le organizzazioni massoniche". Indicazioni importanti, sebbene
necessariamente generiche a causa di indagini e accertamenti in corso. Ma la
commissione non si è fermata qui. Il lavoro principale è stato fatto sugli
elenchi sequestrati alle quattro obbedienze con decreto firmato dalla presidente
della commissione Rosy Bindi e affidati allo Scico per i controlli sulla fedina
penale degli iscritti. Un'indagine che dimostra come i Gran Maestri, che si sono
avvicendati in Commissione per giurare di non avere condannati o indagati per
mafia tra i propri ranghi, abbiano mentito. Sono 193 - è emerso dal lavoro dei
parlamentari - gli affiliati alle logge massoniche di Sicilia e Calabria
coinvolti o lambiti da inchieste di mafia. In molti casi, si tratta di
procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, proscioglimento o sentenza
di proscioglimento per morte del reo, ma si tratta - si sottolinea nella
relazione - di "un consistente numero di iscritti che è stato coinvolto in
procedimenti per gravi delitti". Non per tutti però le inchieste si sono
concluse con un nulla di fatto. In 6 sono stati condannati per associazione
mafiosa piena, mentre altri 8 sono stati puniti per traffici di stupefacenti,
ricettazione, falso, bancarotta fraudolenta o sono stati destinatari in via
definitiva di misure di prevenzione personali e dunque indicative della
pericolosità sociale (semplice o qualificata). E non tutti sono stati espulsi
dalle logge a cui appartenevano. Tanto meno sono stati tutti allontanati gli
ulteriori 25 massoni che risultano condannati per altri reati gravi o sono
tuttora sotto processo per associazione mafiosa o per intestazione fittizia di
beni. Al contrario, 12 sarebbero ancora iscritti e attivi, di cui "10 presso
logge del Grande oriente d'Italia, uno con una domanda di regolarizzazione
presentata presso una loggia calabrese del Goi e membro del consiglio regionale
della Calabria dal 2005 al 2010, il che fa desumere che fosse a quei tempi
quantomeno pienamente iscritto ad altra obbedienza; uno, imprenditore agricolo,
presso una loggia calabrese della Glri". E fra i fratelli che frequentano
regolarmente le logge ci sarebbero anche i due, un commercialista e un
pensionato, condannati definitivamente per mafia. "Tale dato - si legge nella
relazione - che si riferisce ai soli nominativi compiutamente identificati
assume significativi profili di inquietudine considerato che 193 soggetti, così
come segnalati dalla Direzione nazionale antimafia, hanno avuto modo di operare
nelle obbedienze massoniche e così segnalando una mancata o quanto meno parziale
efficacia delle procedure predisposte dalle varie associazioni per la selezione
preventiva dei propri membri". Ma per i parlamentari c'è un altro dato
preoccupante. "Al di là delle condanne o dei procedimenti in corso per gravi
reati e al di là dell'appartenenza alle singole obbedienze - si legge nella
relazione non può sottacersi che nell'ambito dei 193 soggetti segnalati, molti
dei quali incensurati, a fronte di 35 pensionati e otto disoccupati, vi sono
numerosi dipendenti pubblici. Le categorie professionali prevalenti sono
avvocati, commercialisti, medici e ingegneri. Presenti in numero rilevante anche
soggetti impiegati nel settore bancario, farmaceutico e sanitario, nonché
imprenditori dei più diversi settori, in primis quello edile".
Massoneria: Antimafia, mafia interferisce
su giustizia, scrive il 22 dicembre 2017 "Il
Giornalelavoce.it". “Con il sequestro non è stato possibile venire in possesso
degli elenchi effettivi degli iscritti perché presso le sedi ufficiali forse
neanche ci sono” e comunque “non consentono di conoscere un’alta percentuale di
iscritti, occulti grazie a generalità incomplete, inconsistenti o generiche. Il
vincolo di solidarietà tra fratelli consente il dialogo tra esponenti mafiosi e
chi amministra la giustizia, legittima richieste di intervento per mutare il
corso dei processi e impone il silenzio” come emerge “in un caso di estrema
gravità”. Lo scrive l’Antimafia. In particolare nella relazione presentata oggi
dalla presidente dell’Antimafia Rosy Bindi si evidenzia il caso di un magistrato
onorario che nel 2010 aveva denunciato, solo in ambito massonico, di aver subito
pressioni ad opera di due confratelli perchè si adoperasse per intervenire sul
giudice monocratico del tribunale di Locri per ottenere, in favore dei figli di
uno dei due, sottoposti a procedimento penale per ricettazione, la
derubricazione del reato. Nel 2012 il magistrato fu ulteriormente sollecitato da
un altro dei suoi fratelli di loggia, perchè intervenisse presso i magistrati
della procura distrettuale di Reggio Calabria per perorare la causa di un terzo
massone, già consigliere della Regione Calabria, avendo questi saputo che,
nell’ambito di una indagine antimafia coperta da segreto, si stava vagliando la
sua posizione. L’ex consigliere regionale è stato poi arrestato insieme ad altre
13 persone e condannato a 12 anni di reclusione. L’antimafia critica il fatto
che non siano state avvertite le autorità civili “degli evidenti indizi di
violazione delle norme penali. Nemmeno dal magistrato onorario risulta alcuna
denuncia. L’agire massonico si è pericolosamente atteggiato ad ordinamento
separato dallo Stato. Probabilmente un atteggiamento diverso gioverebbe alla
massoneria: si abbatterebbe il pregiudizio nei suoi confronti e si ridurrebbe il
rischio di pericolose zone grigie”, conclude la relazione Bindi.
Antimafia, legge Anselmi va modernizzata. E’
opportuno “modernizzare la legge Spadolini-Anselmi” ed necessaria una previsione
di legge che chiarisca che le associazioni segrete, “anche quando perseguono
fini leciti, sono vietate in quanto tali perché pericolose per la realizzazione
dei principi di democrazia”. E’ quanto scrive la Commissione antimafia nella
relazione sulla massoneria. “Una norma del genere attuerebbe, finalmente, la
volontà dei costituenti finora rimasta ignorata anche dalla legge Spadolini
Anselmi”. Una norma che vieti la segretezza di tutte le formazioni sociali,
massoniche e non, che celino la loro essenza – ragiona la presidente Bindi nella
relazione sulla massoneria, presentata oggi alla stampa – non potrebbe ritenersi
discriminatoria e nemmeno persecutoria nei confronti della massoneria, come più
volte paventato dalla stessa”. L’Antimafia suggerisce di estendere ad alcune
categorie – magistrati, militari di carriera in servizio attivo, funzionari ed
agenti di polizia, rappresentanti consolari all’estero – oltre all’iscrizione ai
partiti politici, già previsto, anche “il divieto ad aderire ad associazioni che
richiedano, per l’adesione, la prestazione di un giuramento che contrasti con i
doveri d’ufficio o impongano vincoli di subordinazione”, cosa che si oppone alla
fedeltà assoluta alle istituzioni repubblicane. Infine la Relazione
dell’Antimafia evidenzia come la legge Spadolini-Anselmi “non ha offerto uno
strumento adeguato” nemmeno per perseguire quanto prevede all’articolo 2, dove
si dice che “Chiunque promuove o dirige un’associazione segreta o svolge
attività di proselitismo a favore della stessa è punito con la reclusione da uno
a cinque anni. La condanna importa la interdizione dai pubblici uffici per
cinque anni. Chiunque partecipa ad un’associazione segreta è punito con la
reclusione fino a due anni. La condanna importa l’interdizione per un anno dai
pubblici uffici”.
Massoneria: Antimafia, per alcuni tutt’uno con
mafia. C’è un persistente “interesse delle associazioni mafiose verso la
massoneria fino a lasciare ritenere a taluno che le due entità siano divenute
una cosa sola”. Lo scrive l’Antimafia. “Ciò non significa criminalizzare le
obbedienze”; l’Antimafia si chiede se si siano “dotate di anticorpi”. Dei circa
17 mila iscritti alle quattro obbedienze la gran parte di loro appartiene al
mondo delle professioni (medici, avvocati, ingegneri, commercialisti). C’è una
certa presenza delle forze dell’ordine e, fino a diversi anni addietro, di
magistrati e politici. La presidente Bindi evidenzia tuttavia come in diversi
casi non venga coltivato dalle obbedienze “il primario interesse alla
impermeabilità dalle mafie” e come spesso il preteso rispetto delle leggi da
parte della massoneria “si è rivelato più apparente che reale”. In particolare
la relazione della Commissione parlamentare antimafia bacchetta “la segretezza,
che permea il mondo massonico (e quello mafioso) il segreto costituisce il perno
di alcune obbedienze”. Il documento parla di “un senso di riservatezza a dir
poco esasperato”. L’insieme di queste regole viene “suggellata da una sorta di
supremazia riconosciuta alle leggi massoniche rispetto a quelle dello Stato”.
“Peculiare appare il giuramento del Goi, il Grande oriente d’Italia, in cui
l’affiliato è tenuto a osservare la Costituzione “quasi si riservi un giudizio
di legittimità costituzionale massonico sulle leggi che dunque non sono da
rispettare sic et simpliciter ma solo se da essi ritenute conformi al dettato
costituzionale”. Sul fronte dei numeri emerge che degli oltre 17 mila iscritti
nelle obbedienze esaminate nelle regioni Sicilia e Calabria, la gran parte,
oltre 9 mila, insiste nelle logge calabresi; in Sicilia gli iscritti sono 7.819.
Per uno su sei nominativi presenti negli elenchi (quasi 3 mila nomi) non è stato
possibile procedere alla completa identificazione poichè mancavano dati
anagrafici essenziali. Oltre mille di questi 3 mila soggetti sono risultati
anagraficamente inesistenti, altri 1800 privi di generalità complete, altri 80
indicati con le sole iniziali del nome o del cognome.
Bindi, pentito racconta importanza adesione
a mafia e massoneria. “C’erano persone importanti che determinavano gestione di
potere come pubblici funzionari, avvocati, notai, magistrati (..) la massoneria
aveva (..) importanza nella città di Palermo in termini di potere economico,
politico, decisionale, quindi aveva senso che io stessi anche all’interno di
questa organizzazione”. E’ quanto dichiara il collaboratore di giustizia,
Francesco Campanella, originario di Villabate, in provincia di Palermo, e
riportato nella relazione conclusiva su “mafia e massoneria” presentata oggi a
Roma dalla presidente della commissione Antimafia, Rosy Bindi. Campanella “sin
da giovane si era dedicato alla politica, alla massoneria – si legge nella
relazione -, aderendo alla loggia palermitana del GOI “Triquetra”, ma anche alla
mafia, ponendosi al servizio del noto capomafia Nicola Mandala il quale, per un
certo periodo, curò la latitanza di Bernardo Provenzano. La contemporanea
adesione, quasi contestuale temporalmente (fine anni ’90), alle due diverse
associazioni, non era osteggiata nè dall’una nè dell’altra parte. Mandala,
infatti – si legge nella relazione dell’Antimafia -, aveva ritenuto che potesse
essere “una cosa interessante e che … sarebbe potuta tornare utile in qualche
maniera”. Utilità, in effetti, giunte all’occorrenza. Attraverso i fratelli a
lui più vicini, infatti, aveva acquisto informazioni utili dai Monopoli di Stato
per la gestione delle sale Bingo (facente capo all’associazione mafiosa) nel
momento più delicato in cui era intervenuto l’arresto di Mandala, e si temeva
che tali esercizi potessero essere sequestrati”. Le sue dichiarazioni confermano
– conclude l’Antimafia -, innanzitutto che l’appartenenza alla massoneria crea
un vincolo esclusivo e permanente, che, come avviene in Cosa nostra, si dissolve
solo con la morte”.
Massoneria: Bindi, pentito dice Provenzano aveva
info da loro. “Esisteva un terzo livello di soggetti in relazione direttamente
con Bernardo Provenzano, all’epoca, che consentiva alla mafia di avere benefici
a livello di informazione da forze dell’ordine, magistrati, servizi segreti,
ecc. (..) Informazioni di prim’ordine. (..) a un terzo livello dove c’era di
mezzo la massoneria”. E’ quanto dichiara il collaboratore di Giustizia,
Francesco Campanella, originario di Villabate, in provincia di Palermo, e
riportato nella relazione conclusiva su “mafia e massoneria” presentata oggi a
Roma dalla presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi. Francesco
Campanella, pur dichiarando che non ebbe “il tempo di capire come funzionavano,
per dirla con tutta franchezza”, ha riferito di uno specifico episodio di “fughe
di notizie” che potette constatare personalmente: “in quel momento specifico in
cui Mandala era nelle grazie di Provenzano e gestiva la latitanza, (..)
Provenzano comunica a Mandala, esattamente la settimana prima che sarà
arrestato, che si deve fare arrestare, che cambierà covo, quindi di non parlare,
di mettere tutto a posto. Mandala lo comunica a me: “mi arresteranno, fai
riferimento a mio padre Tutta questa serie di informazioni arrivavano”. Un gioco
a fare il massone (così Campanella ha definito la sua partecipazione alla
“Triquetra”) ma che, tuttavia, corrispondeva all’interesse dello stesso
collaboratore di giustizia, della sua famiglia mafiosa e della massoneria. Va
ricordato che è stato sentito dalla Commissione Antimafia anche Cosimo
Virgiglio, collaboratore calabrese, già più volte ascoltato dai magistrati di
Reggio Calabria ai quali aveva reso un ampio resoconto sui meccanismi
propriamente massonici.
“Davanti alla Commissione ha sostanzialmente
confermato le sue ampie dichiarazioni, peraltro riportate in diversi
giudiziarie. Tra queste si ricorda, come nota di colore, che dopo il suo
arresto, l’obbedienza lo fece raggiungere in carcere da un avvocato incaricato
di dirgli di tacere il nome dei fratelli. Un segreto dunque ancor più valido
anche per chi sta dietro le sbarre di un carcere. Anche lui confermava, come
Campanella, che il vincolo massonico e perpetuo: si estingue solo con la morte”,
si legge nella relazione.
Gli interessi di ‘ndrangheta e mafia per
la massoneria: la relazione dell’Antimafia, scrive il
22 dicembre 2017 "Qui Cosenza". Sono 193 i soggetti indicati dalla Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo come iscritti in procedimenti penali ed è
consistente il numero di soggetti che, pur non indagati, imputati o condannati
per delitti di natura mafiosa, hanno collegamenti diretti con esponenti della
mafia e possono costituire un anello di collegamento tra mafia e massoneria. La
presidente della commissione antimafia, Rosy Bindi, ha presentato oggi la
relazione finale sulla massoneria dalla quale emerge come “Cosa Nostra siciliana
e la ‘ndrangheta calabrese da tempo immemorabile e costantemente fino ai nostri
giorni nutrono e coltivano un accentuato interesse nei confronti della
massoneria”. “Da parte delle associazioni massoniche si è registrata una sorta
di arrendevolezza nei confronti della mafia. Sono i casi, certamente i più
ricorrenti, in cui si riscontra una forma di mera tolleranza che si rivelano i
più preoccupanti”. Un persistente “interesse delle associazioni mafiose verso la
massoneria lasciano ritenere che le due entità siano divenute una cosa sola. Ciò
non significa criminalizzare le obbedienze”; l’Antimafia si chiede se si siano
“dotate di anticorpi”. Dei circa 17 mila iscritti alle quattro obbedienze la
gran parte di loro appartiene al mondo delle professioni (medici, avvocati,
ingegneri, commercialisti). C’è una certa presenza delle forze dell’ordine e,
fino a diversi anni addietro, di magistrati e politici. Dunque “il tema del
rapporto tra mafia e massoneria “affiora in modo ricorrente nelle inchieste
giudiziarie degli ultimi decenni, con una intensificazione nei tempi più recenti
in connessione sia con vicende criminali tipicamente mafiose, soprattutto in
Sicilia e in Calabria, sia con vicende legate a fenomeni di condizionamento
dell’azione dei pubblici poteri a sfondo di corruzione”.
Un “rapporto” emerso dopo la missione effettuata a
Palermo e a Trapani. “In quell’occasione è stato ripetutamente affrontato il
tema del rapporto tra Cosa nostra e la massoneria in Sicilia anche in relazione
alla vicenda dell’appartenenza a logge massoniche di alcuni assessori del comune
di Castelvetrano (Tp) luogo di origine del noto latitante Matteo Messina
Denaro”. Nel documento si ricorda che attualmente nel trapanese sono presenti
200 “fine pena” già detenuti per reati di mafia e di traffico di stupefacenti
che, scontata la pena, ora sono in stato di libertà. Nel comune di Castelvetrano
insistono 6 logge massoniche su 19 che operano nell’intera provincia di Trapani
e nell’amministrazione comunale della cittadina, nel 2016, 4 su 5 assessori
erano iscritti alla massoneria e 7 su 30 tra i consiglieri. Nella relazione si
evidenzia anche che i fatti di Castelvetrano fanno il paio con le indagini delle
autorità siciliana e calabrese, queste ultime sfociate nei procedimenti “morgana
mammasantissima e Saggezza. In tutti i casi si evidenziano recenti episodi di
infiltrazione mafiosa nella massoneria e si attualizzano gravi fatti del passato
“che lasciavano supporre l’esistenza delle infiltrazioni di Cosa nostra e della
‘ndrangheta nella massoneria”. “Con il sequestro non è stato possibile venire in
possesso degli elenchi effettivi degli iscritti perché presso le sedi ufficiali
forse neanche ci sono” e comunque “non consentono di conoscere un’alta
percentuale di iscritti, occulti grazie a generalità incomplete, inconsistenti o
generiche. Il vincolo di solidarietà tra fratelli consente il dialogo tra
esponenti mafiosi e chi amministra la giustizia, legittima richieste di
intervento per mutare il corso dei processi e impone il silenzio” come emerge
“in un caso di estrema gravità”.
Servizi segreti, massoni e politici: ecco
tutti i legami della 'ndrangheta in Emilia Romagna.
Nuovi pentiti svelano i contatti delle cosche padane. Tra cene elettorali, 007
"amici di Bisignani" e "grembiuli" bolognesi. A parlare sono soprattutto i boss,
che fanno tremare un sistema di potere. E così gli 'ndranghetisti riprendono a
uccidere, in una guerra di mafia che non sconvolge la Calabria. Ma la pianura
emiliana, scrive Giovanni Tizian il 07 dicembre 2017 su "La Repubblica". Il lato
oscuro della 'ndrangheta emiliana. Popolato da 007, forze dell’ordine, politici
e massoni. L’intreccio tra potere e clan nella narrazione di quattro nuovi
pentiti rivela scenari inediti in una terra che rifiuta l’etichetta di preda
delle cosche. Sospetti per ora, che affiorano però negli interrogatori di alcune
gole profonde. Un intrigo padano, dai contorni nebulosi, reso ancor più
inquietante da un omicidio. La settimana scorsa in provincia di Reggio Emilia è
stato ucciso un giovane di 31 anni, originario della Calabria. Persona perbene,
lo descrivono tutti. Due figli piccoli e nessun precedente. Nella stessa via
erano state bruciate due auto in quindici giorni. Oltre alla procura ordinaria
si è attivata anche l’Antimafia. Si scava nel privato, senza tralasciare piccoli
dettagli che portano all’attività del padre della vittima, un edile con una
partecipazione in un consorzio dove sono presenti personaggi vicini ai clan. Il
delitto è «come sale su una ferita aperta», ha detto il questore nei giorni in
cui anche a Ostia le pistole sono tornate a far paura. Il timore che avessero
ragione i pentiti però è forte. Alcuni di loro hanno avvertito i magistrati di
Bologna di una possibile lotta interna alla ’ndrangheta. Non in Calabria, ma
nella pianura emiliana. E come in tutti i conflitti la possibilità che muoiano
anche gli innocenti è concreta. Sintomi di questa fibrillazione sono comparsi
fin dentro i penitenziari, dove si sono verificati duelli tra ’ndranghetisti di
opposta fazione. A nove mesi dell’inizio del più grande maxi processo alle
’ndrine del Nord, c’è chi teme un ritorno agli anni Novanta, quando a Reggio le
cosche non esitavano a usare le bombe e le lupare. Sembrava la Corleone di
Salvatore Riina, eppure era ed è la provincia di Reggio Emilia. Lungo la via
Emilia si sta abbattendo un ciclone giudiziario, alimentato dalle dichiarazioni
dei collaboratori di giustizia che stanno rivoltando il passato di complicità
che molti davano per sepolto. C’è chi prega in segreto per salvarsi, chi
riflette come prevenire il colpo e chi, invece, contrattacca nelle aule di
tribunale dove lo Stato sta fronteggiando la cosca Grande Aracri - originaria di
Cutro, nel Crotonese - ma trapiantata dagli anni Ottanta al di là della Linea
Gotica. Una cosa è certa: calato il sipario su questo processo dimenticato dalla
stampa nazionale, nulla sarà più come prima in questa pianura trasformata in Far
West. Tanto che il gruppo di ’ndranghetisti finiti in carcere ha trasformato le
celle in hotel a 5 stelle. Tablet, cellulari, droga, caffè in cella preso con i
poliziotti penitenziari, in stile don Raffaè. Pestaggi e accordi con la camorra.
Tutto questo nella sezione alta sicurezza, da dove partivano persino pen drive
con gli audio che servivano a istruire i testimoni del maxi processo. Episodi
emersi grazie ai collaboratori. Il contagio più temuto dalla ’ndrangheta si è
ormai diffuso: in meno di un anno cinque nuove richieste di collaborare con la
giustizia. Quattro super pentiti affidabili e un altro che la procura antimafia
di Bologna non ha ritenuto credibile, nonostante sia il braccio destro del capo
dei capi Nicolino Grande Aracri, detto “Manuzza”, e reggente del clan a Reggio
Emilia. Gli altri che hanno ottenuto la patente di collaboratori credibili non
sono, però, da meno. Nell’ordine: Nicola Femia, “Rocco” per gli amici, col grado
di boss dell’omonimo gruppo mafioso; Pino Giglio, imprenditore e cassaforte
della cosca Grande Aracri; Antonio Valerio, affiliato del cerchio magico del
padrino “Manuzza”; Salvatore Muto, uomo d’affari del gruppo criminale cutrese.
Insomma, per l’impenetrabile mafia calabrese è un colpo durissimo. Una tragedia
epocale per l’organizzazione che vanta il minor numero di pentiti rispetto alle
mafie tradizionali. Il primo ad alzare bandiera bianca, sotto i colpi della
procura antimafia di Bologna è stato Nicola Femia. A febbraio scorso “Rocco” ha
chiesto di incontrare i magistrati. Dieci giorni dopo i giudici bolognesi lo
condanneranno in primo grado a 26 anni per mafia. Nell’ambiente del gioco
d’azzardo legale è conosciuto come il signore delle slot. Uno dei primi a
investire nel settore allo scoccare del nuovo millennio. Affondano qui le radici
del suo impero economico e criminale. Stringe alleanze commerciali con imprese
note del gaming, diventa partner di affermati imprenditori del Nord Italia e
sfrutta la complicità di ingegneri informatici. Regista di joint venture tra
mafie con fatturati a sei zeri. Oggi è un super pentito, che ha già riempito
migliaia di pagine di verbali di interrogatorio. Carte scottanti, per gli
argomenti che svela e per i nomi citati. Dichiarazioni che hanno permesso di
aprire fascicoli in diverse procure antimafia e di rafforzare inchieste che sono
in corso. Di certo, Femia, non ha mostrato alcuna remora di fronte ai pm: già al
primo confronto ha ammesso di aver ucciso una persona quando aveva 15 anni. Fu
assolto. L’omicidio era stato ordinato dal vecchio patriarca della mafia
calabrese Vincenzo Mazzaferro. Quello fu l’inizio della sua carriera. In segno
di riconoscenza il padrino lo battezzò «riservato» dell’organizzazione. In
pratica Nicola Femia non aveva dovuto affiliarsi formalmente: «Sapeva (il boss
ndr) che poteva contare su di me per qualsiasi cosa, non aveva interesse a
rendere ufficiale una mia affiliazione». Da allora Femia inizierà la sua ascesa.
Era uomo dei Mazzaferro, e questo bastava a spianargli la strada verso il
successo. In Calabria come in Emilia. Nipote, peraltro, di un pezzo da novanta
della cosca processato assieme a Michele Sindona, il banchiere della mafia pre
Riina. Femia, insomma, qualche segreto lo custodisce. Anche perché da quando ha
lasciato la carriera di narcos per diventare re delle slot ha conosciuto figure
di un certo peso. Come quel tale, descritto nei verbali come uomo dei servizi
segreti, che si vantava di essere amico di Luigi Bisignani, «quello della P4,
P5...», ha spiegato con una battuta. Non è l’unico 007 da lui frequentato. Le
indagini hanno documentato diversi incontri con un agente segreto. Chiamato dai
pm non ha voluto fornire spiegazioni. Il collaboratore Femia sta illuminando con
le sue dichiarazioni zone buie di questo territorio che sono collegate anche
alla politica. Svela ai magistrati le richieste ricevute dai clan della
Lombardia per organizzare cene elettorali in Emilia in favore di alcuni politici
i cui nomi sono ancora coperti dal segreto. Riferisce anche di un ex deputato,
sempre emiliano, che gli aveva fatto chiedere voti tramite il suo faccendiere.
Rivela, poi, i rapporti con professionisti iscritti alla massoneria bolognese,
delle mazzette per comprarsi le sentenze e il rapporto con un avvocato già
parlamentare. Le storie trapelano dall’ambiente giudiziario dove però vige un
grande riserbo. Tutto quello che emerge dagli interrogatori fa vedere come in
questo territorio si riesce con facilità a mettere in contatto un ex narcos
diventato re dell’azzardo legale con pezzi delle istituzioni locali e
nazionali. Basta pensare che nell’arco di sei mesi Femia con una sola società di
gaming online è stato in grado di incassare fino a 40 milioni. Don “Rocco” non è
tra gli imputati del maxi processo Aemilia contro la cosca Grande Aracri, ma in
quell’aula è andato a testimoniare, perché con alcuni emissari di quella ’ndrina
aveva stretto una partnership.
UNA QUESTIONE POLITICA. Il “pentito” Salvatore
Muto ripercorre adesso l’intreccio politico mafioso in Emilia, partendo dal 1994
quando sostiene che venne impartito l’ordine dai clan di far votare Forza
Italia. «Quelli che si diedero da fare erano tutte persone appartenenti alla
’ndrangheta o in qualche modo legate... mi occupavo del volantinaggio, appendevo
i manifesti». Secondo Salvatore Muto a distanza di ventitrè anni la passione per
il partito di Berlusconi non si è affievolita. Il primo politico condannato in
Emilia per complicità con i clan si chiama Giuseppe Pagliani, consigliere
comunale e provinciale di Forza Italia. Condannato in appello a 4 anni, assolto
in primo grado, nel filone politico del maxi processo. In un altro stralcio
della medesima inchiesta è tuttora indagato per rivelazione di segreto il
senatore Carlo Giovanardi, in passato nel Pdl. Muto dopo la campagna elettorale
per Berlusconi racconta di essere partito per Reggio Emilia. Accolto nella corte
del padrino Nicolino Grande Aracri. Fu proprio don Nicolino a confidargli la
formula del successo criminale: «Le guerre le ho fatte al Nord e le ho vinte
io». Il collaboratore di giustizia custodisce segreti anche sull’attività
politica attuale. Questioni di voti e potere. Ricorda quando il suo capo gli
raccontò di aver ricevuto da un affiliato la richiesta di raccogliere voti per
il candidato a sindaco del Pd di Reggio Emilia. Si tratta dell’attuale primo
cittadino Luca Vecchi, successore dell’attuale ministro Graziano Delrio. Un
sostegno interessato, che però non è stato ricambiato: «Il sindaco non era a
favore nostro, si è messo contro di noi», precisa Muto nel verbale del 17
novembre scorso. La moglie di Vecchi, Maria Sergio, è stata per anni dirigente
dell’ufficio urbanistica del Comune guidato da Delrio. La coppia Vecchi-Sergio è
stata presa di mira dal boss Pasquale Brescia, volto imprenditoriale
dell’organizzazione e vicino a diversi poliziotti. In una missiva inviata alle
redazioni di giornali dal carcere ha lanciato accuse pesantissime sia al sindaco
che a sua moglie. Lettera dai toni minacciosi, che ha portato la procura
antimafia di Bologna a indagare Brescia e l’avvocato che lo difendeva. Il
pentito Muto sta svelando ulteriori particolari di quella vicenda: sostiene che
l’autore della lettera si vantava di sapere molte cose del sindaco Vecchi ma che
non poteva parlarne. La lettera, dice un altro pentito che si chiama Antonio
Valerio, «fu scritta per far muovere il sindaco Vecchi a prendere le parti dei
cutresi... visto che anche sua moglie Maria Sergio è cutrese e aveva un parente
capo di Cutro negli anni ’60-’70... sapendo questo si cercava a livello
psicologico di assoggettarlo». In questo modo la 'ndrangheta emiliana messa alla
sbarra ricatta. Per difendere ciò che ha costruito in trent’anni di
colonizzazione.
CATASTO È POTERE. I carabinieri hanno acquisito
documenti e sentito alcuni funzionari in Prefettura a Modena. È l'ultimo
clamoroso sviluppo dell'indagine sui clan emiliani. Tutto questo mentre il maxi
processo contro gli oltre 200 imputati è in corso. E al ministero dell'Interno
giace una richiesta di scioglimento per il Comune di Finale. Potito Scalzulli è
un ex dirigente del demanio di Reggio Emilia. Oggi fa politica in Romagna,
lontano dalla città in cui tutto è cominciato. La prima denuncia porta la data
del 23 novembre 2010, in tempi non sospetti, dunque. Quando, cioè, il bubbone
'ndrangheta emiliana non era esploso pubblicamente. Scalzulli nei suoi esposti
non ha mai usato mezzi termini: all’interno dell’ufficio che dirigeva si era
incancrenito un sistema, «il sistema catasto», lo definisce. Sette anni di
esposti che non hanno smosso alcunché. Per questo, adesso, con il maxi processo
in corso ha deciso di inviare il malloppo di documenti e denunce raccolte negli
anni alla Commissione antimafia presieduta da Rosy Bindi. «Prove documentali che
certificano la collusione e la connivenza con il gruppo organizzato di pubblici
dipendenti fautori del malaffare, il cosiddetto sistema catasto», si legge
nell’incipit del documento inviato alla Commissione. Alla spartizione avrebbero
partecipato, secondo l’ex dirigente, funzionari di vertice dell’Agenzia,
politici interessati alla tenuta del “Sistema” per garantirsi la continuità del
consenso «determinante per fare la differenza sugli equilibri politici
elettorali». Al centro delle denunce di Scalzulli anche un politico locale del
Pd nonché dipendente dell’Agenzia del territorio, Salvatore Scarpino.
Consigliere comunale di riferimento della numerosa comunità calabrese a Reggio
Emilia e in ottimi rapporti con l’attuale ministro Delrio. Su Scarpino oltre
alle denunce di Scalzulli pesano le dichiarazioni in aula di un testimone
durante il processo alla ’ndrangheta emiliana. Renato Maletta, in passato
candidato a sostegno di Delrio sindaco e sottoposto di Scarpino all’Agenzia, ha
raccontato di aver fatto campagna elettorale per il consigliere Pd.
Sorprendenti, tuttavia, le frequentazioni di Maletta: invitato al matrimonio, in
Germania, del figlio di un boss e proprietario di un cavallo nel ranch reggiano
di un imputato per ’ndrangheta. Non il massimo per chi aspira a ruoli politici.
D’altronde, però, l’Emilia non è neanche più la roccaforte etica di un tempo.
Cateno De Luca, le accuse ai magistrati in
diretta su La7, scrive il 27 novembre 2017 "Lettera Emme". "A Messina, nel
momento in cui emergi, o ti affili o ti fanno fuori". Show del deputato
regionale a "Non è l'Arena" di Massimo Giletti: dito puntato e fatti
circostanziati, dai quali il conduttore ha tentato in tutti i modi di
dissociarsi. Un imbarazzatissimo Massimo Giletti, conduttore su La 7 della
trasmissione “Non è l’arena”, mentre tenta invano di domare un Cateno De
Luca senza freni: L’essenza dell’intervista al deputato regionale di Sicilia
Vera di ieri sera è questa. Come da qualche settimana a questa parte, De Luca
non esita ad attaccare sempre più duramente la magistratura messinese, ogni
volta aggiungendo un tassello in più. Stavolta, è toccato ad un non precisato
alto magistrato, il cui figlio, secondo De Luca, sarebbe stato assunto in un
ente di formazione: le sue indagini da parlamentare e lo “smascheramento” di una
manovra che avrebbe portato il rampollo al Ciapi, un ente regionale, sarebbe
alla base della sua persecuzione giudiziaria. Così ha gridato a tutta Italia un
De Luca rosso in faccia ed in iperventilazione, mentre Giletti tentava di
riportarlo a più miti consigli e, fallito il tentativo, ha scaricato su De Luca
la responsabilità delle sue parole. “Si assume la responsabilità di quello che
sta dicendo”, ha messo le mani avanti il conduttore, tentando di sovrastare le
urla di De Luca, il quale ha prontamente risposto. “Ho già denunciato tutto due
volte, sto procedendo con la terza, certo che me le assumo”, ha continuato l’ex
sindaco di Fiumedinisi, senza mollare di un millimetro, e anzi rincarando la
dose e parlando anche dell’arresto di Francantonio Genovese. “Abbassiamo i
microfoni”, ha concluso ad un certo punto Giletti, che non riusciva ad avere la
meglio su De Luca.
“A Messina, nel momento in cui
emergi, o ti affili o ti fanno fuori”, aveva spiegato qualche minuto prima del
siparietto Cateno De Luca. Secondo il parlamentare nel Palazzo di Giustizia
messinese ci sarebbe una mano nera. Accusa appoggiata anche dal suo
legale, Carlo Taormina, il quale ha riferito di altri esposti depositati per
fare luce sulla vicenda, scrive “News Sicilia”. Ad alzare ulteriormente i toni
l’accusa lapidaria lanciata dal neo deputato che ha parlato di “mafia della
magistratura”, provocando la presa di distanza di Giletti e dell’ex magistrato
di Mani Pulite, Antonio Di Pietro, in collegamento da Milano. In collegamento,
durante la trasmissione, anche Antonio Di Pietro, ex ministro ma soprattutto ex
magistrato. Che ovviamente si è dissociato dall’attacco di De Luca contro quello
che per decenni è stato il suo mondo.
La rete massonica ha
condizionato (anche) la magistratura,
scrive Paolo Pollichieni, lunedì 27 Novembre 2017, direttore de "Il Corriere
della Calabria". La Commissione parlamentare antimafia intende consegnare alla
magistratura, e segnatamente alle Procure distrettuali di Reggio Calabria,
Catanzaro, Palermo e Catania, copia dei fascicoli contenenti tutto il materiale
raccolto nell'ambito del filone sui rapporti tra massoneria e criminalità
mafiosa e circa l'esistenza di logge occulte o coperte. La decisione dovrebbe
essere formalizzata a breve, in una apposita seduta della Commissione. In questa
direzione spinge, in particolare, il vicepresidente della Commissione, Claudio
Fava il quale nel merito degli elenchi ha già avuto modo di puntualizzare alcune
osservazioni: «Da una prima lettura degli elenchi degli aderenti alle logge
massoniche in Calabria e in Sicilia, non sembra che emergano nomi di
straordinaria notorietà ma c’é una dimensione di adesione alla massoneria che
sfugge a ogni controllo, per esempio con le logge coperte o con “i fratelli
all'orecchio”. La sensazione che ci siano propaggini che si spingono nel
Parlamento è più che una sensazione; non mi stupirei se anche in Commissione
Antimafia ve ne fosse qualcuno». Una «sensazione», quella di cui parla Fava, che
il rapporto della Guardia di Finanza successivo alla comparazione degli elenchi
con i tabulati degli archivi delle forze di polizia, avrebbe ulteriormente
irrobustito. Sullo sfondo viene richiamata non solo la sentenza del Consiglio di
Stato che “invita” quanti ricoprono incarichi di vertice nella pubblica
amministrazione a segnalare la propria appartenenza alla massoneria, ma anche
uno scontro che in precedenza aveva visto tre magistrati del Consiglio di Stato
(Roberto Giovagnoli, Claudio Contessa e Raffaele Greco) presentare un esposto
disciplinare nei confronti di un loro collega che aveva redatto un articolo
scientifico sulla degenerazione dei concorso pubblici, non mancando di citare i
condizionamenti da parte della massoneria e dell’Opus Dei. I tre magistrati
ritenevano che in alcune parti quello scritto fosse offensivo nei confronti
della giustizia amministrativa. Il successivo arresto dell’ex consigliere di
Stato Carlo Malinconico per fatti corruttivi, nonché altri accertamenti
giudiziari a carico di un ex presidente dell’associazione dei consiglieri di
Stato e di altri magistrati in servizio nel Consiglio di Stato, si incaricò di
far decadere l’esposto e riproporre la questione su quanti sono i massoni che
indossano grembiulino e toga da consigliere di Stato. Non di meno resta aperta
anche la questione dell'eventuale ricattabilità di tali soggetti, posto
l'espresso divieto per i magistrati amministrativi di appartenere a logge
massoniche. In merito va anche osservato che molti magistrati del Consiglio di
stato (Luca Cestaro, Umberto Maiello, Antonio Plaisant, Roberto Pupilella, ecc.)
hanno riproposto la questione chiedendo che venga imposto a tutti di fare
chiarezza sulla propria eventuale militanza massonica. Il rischio, che dal
lavoro della Commissione antimafia ormai viene fuori con chiarezza, è che il
potere sia transitato dalle mani della politica a quello di ambienti non solo
sottratti al controllo democratico ma addirittura in grado di condizionarne le
scelte e l'operato. Non esiste solo la democrazia o la dittatura, esiste anche
la cosiddetta oligarchia ed è a questa forma di gestione della cosa pubblica che
sembra abbia puntato la massoneria. Una oligarchia che si svincola dalla diretta
protezione politica, si autonomizza e tende a costruire un potere personale
grazie al quale ottiene prima di tutto la sua sostanziale inamovibilità.
Scorrendo gli elenchi, assicurano, si rileva come sempre gli stessi nomi passano
vorticosamente da un posto all'altro, da un grembiulino a un ente, da un
incarico extragiudiziale a quello successivo, costruendo così reti di relazioni
che diventano autentiche reti di complicità, sommando spessissimo incarichi che
incarnano casi clamorosi di conflitto di interessi.
Insomma, se i politici sono la
casta, l'oligarchia burocratico-funzionale è molto spesso la super casta. Nella
stessa loggia, poi, ecco convivere il grande burocrate con il boss di primo
livello e tutti e due sottobraccio con mondo imprenditoriale e bancario. Anche
la peculiarità territoriale di alcune logge ha attirato l'attenzione degli
inquirenti. Ad esempio in Calabria quanti hanno a che fare con la sanità
finiscono col ritrovarsi nella stessa loggia che pure è distante dai luoghi dove
gli adepti vivono o esercitano la propria professione. In questo contesto oltre
che di logge coperte si torna a parlare di massoni “all'orecchio”, vale a dire i
cui nomi non compaiono in alcun elenco ufficiale ma sono noti solo al gran
maestro. In molti casi si tratta addirittura di magistrati che operano in
Procure della Repubblica e presso Tribunali importanti. Qualcuno di questi è
rimasto impigliato in rapporti della polizia giudiziaria. In particolare è
capitato a Potenza, Crotone e Vibo Valentia; le relative indagini, tuttavia,
avrebbero segnato il passo una volta finite in mano, tutte, a un unico pubblico
ministero in servizio presso la Procura ordinaria di Catanzaro e il cui nome
comparirebbe, oggi, in uno degli elenchi sequestrati dalla Guardia di finanza.
Insomma, attraverso il
controllo di alcuni importanti snodi della magistratura ordinaria e di quella
amministrativa, il potere oligarchico avrebbe garantito una rete di protezione
non solo a boss mafiosi ma anche a imprenditori disinvolti e a burocrati in
carriera. Non sarebbe un caso il fatto che in un Paese dove la corruzione,
secondo i parametri di rilevamento internazionali, si attesta su posizioni di
preoccupante rilievo (al punto da far creare un apposita autority, l'Anac,
affidata alla presidenza del magistrato Raffaele Cantone) si registra poi un
bassissimo numero di indagini, processi e condanne per corruzione. E se si
scende ad analizzare tali indagini si scopre che in massima parte sono
riconducibili all'azione di uffici giudiziari del Centro-nord, con in testa
Milano, Torino e Venezia, mentre si contano sulle dita di una mano i processi
per corruzione nei distretti giudiziari di Catanzaro, Reggio Calabria,
Caltanissetta e Cagliari. E sempre spulciando tra gli archivi di una loggia
massonica calabrese, gli investigatori si sono imbattuti in una “Petizione al
Capo dello Stato, On. Giorgio Napolitano, nella sua veste di Presidente del
Consiglio Superiore della Magistratura” a mezzo della quale si chiedeva di
invitare i magistrati a dichiarare sotto giuramento la loro eventuale
partecipazione o iscrizione alla massoneria. Vale la pena di riportare alcuni
passi di quella petizione, della quale non si ha notizia circa l'esito e neppure
circa la sua effettiva consegna al presidente Napolitano.
Vi si legge: «La domanda circa
l'appartenenza alla Massoneria non può mai ottenere risposta affermativa. Il
perché è ben spiegato dalle parole stesse del giuramento che gli aspiranti
Massoni pronunciano durante il rito d'iniziazione: “prometto e giuro di non
palesare giammai i segreti della Massoneria, di non far conoscere ad alcuno ciò
che mi verrà svelato, sotto pena di aver tagliata la gola, strappato il cuore e
la lingua, le viscere lacere, fatto il mio corpo cadavere e in pezzi, indi
bruciato e ridotto in polvere, questa sparsa al vento per esecrata memoria di
infamia eterna. Prometto e giuro di prestare aiuto e assistenza a tutti i
fratelli liberi muratori su tutta la superficie della terra”». Muovendo da tale
premessa si chiedeva: «Il Consiglio Superiore della Magistratura, ha il dovere
di garantire la intangibilità della fiducia dei cittadini nell'istituzione
giudiziaria e quindi di rendere disponibile un'informazione pubblica sui
magistrati appartenenti alla Massoneria poiché lo stringente giuramento innanzi
riportato comporta la promessa "di prestare aiuto e assistenza a tutti i
fratelli liberi muratori su tutta la superficie della terra" potrebbe far
dubitare dell'imparzialità del magistrato massone qualora, in un procedimento
giudiziario, fra tutti i liberi muratori della terra, ve ne fosse uno coinvolto
direttamente o indirettamente nei fatti soggetti al suo giudizio”. Infine la
richiesta di notificare ad ogni singolo magistrato un formale atto d'interpello:
«Lei ha aderito alla Massoneria? Se risponde affermativamente, può indicare lo
stato attuale della sua appartenenza e la documentazione che lo
comprova? Per completezza si allega un estratto di sentenza del Consiglio di
Stato che esclude l'esimente della riservatezza in tema di appartenenza alla
Massoneria del Pubblico Ufficiale o Pubblico Incaricato: Consiglio di Stato,
sez. IV, sentenza 06.10.2003 n° 5881. Il Consiglio di Stato ha stabilito che è
legittima una legge regionale che impone ad un soggetto l'obbligo di comunicare
l'appartenenza ad una loggia massonica ai fini del conferimento di un incarico
pubblico. Con la sentenza n. 5881 del 6 ottobre 2003 i giudici di Palazzo Spada
affermano che tale obbligo non viola il diritto di riservatezza in quanto è
correlato alla particolare posizione funzionale rivestita dal soggetto designato
o nominato ad una pubblica funzione ed è giustificato da preminenti interessi
pubblici e generali direttamente assistiti da garanzia costituzionale. Nella
motivazione della sentenza il giudice amministrativo precisa inoltre che il
diritto alla riservatezza, pur integrando un aspetto di non secondaria rilevanza
della proiezione della persona, non è un valore assoluto che trova diretta
tutela nella Carta costituzionale vigente come bene primario ed inviolabile ed è
destinato perciò a soccombere di fronte al principio di buon andamento
dell'amministrazione, postulato a livello costituzionale dell'art. 97».
Adesso a riproporre il tema è
l'indagine conoscitiva della Commissione parlamentare antimafia, una indagine
però che arriva alla sua parte più delicata proprio mentre la legislatura sta
per chiudersi, il che, come capitato altre volte, lascerà incompiuto il
tentativo di fare luce su ambiti che pure condizionano pesantemente il sistema
democratico del nostro Paese.
Scocca l’ora dei magistrati
massoni: ecco come bloccano la Giustizia in Italia,
scrive Iacchite il 2 marzo 2017. Sembra che (finalmente!) ci siamo. L’annuncio
della Commissione Antimafia di voler procedere al sequestro degli elenchi della
massoneria ci dovrebbe dare (al di là delle proteste dei “fratelli”) l’esatta
misura dell’inquinamento delle istituzioni da parte dei “deviati”. I massoni
onesti, dunque, non dovrebbero contestare questa procedura perché è l’occasione
giusta per cacciare a calci nel sedere chi approfitta dell’Istituzione.
Soprattutto i magistrati. Può un magistrato venir meno al vincolo di fedeltà
giurato, pena la morte, per entrare in massoneria? E quali prove possono addurre
quei giudici o PM che affermano di esserne usciti? Molti sono ancora in
servizio. E rivestono ruoli apicali. Gli italiani lo hanno capito da tempo, a
reggere davvero le sorti del Paese non sono né le banche né le istituzioni
democratiche e nemmeno la magistratura: sono i massoni – regolari o, quasi
sempre, appartenenti a logge coperte – che proprio in quei tre ambiti sono
capillarmente infiltrati. Sono sempre loro, i confratelli, a detenere saldamente
le leve del potere. E tutto attraverso quel vincolo di segretezza che, dopo
l’iniziazione, si può cancellare solo con la morte. Lo dicono, chiaro e tondo,
le parole stesse del giuramento. «Prometto e giuro di non palesare giammai i
segreti della Massoneria, di non far conoscere ad alcuno ciò che mi verrà
svelato, sotto pena di aver tagliata la gola, strappato il cuore e la lingua, le
viscere lacere, fatto il mio corpo cadavere e in pezzi, indi bruciato e ridotto
in polvere, questa sparsa al vento per esecrata memoria di infamia eterna.
Prometto e giuro di prestare aiuto e assistenza a tutti i fratelli liberi
muratori su tutta la superficie della terra». Chiaro, no? Come la mettiamo,
allora, con quei confratelli che rivestono ruoli apicali in settori nei quali è
richiesta la loro facoltà decisionale? Basta insomma, per fare un esempio, che
qualche magistrato se la cavi dicendo frasi del tipo «La massoneria? Io l’ho
lasciata da tempo…», senza poterlo in alcun modo provare? E come si comporterà
se l’imputato – o, più spesso, l’avvocato di quest’ultimo – è un grembiulino
come lui? Cominciamo dal primo quesito. Giuseppe De Lutiis, uno fra i più
autorevoli studiosi di eversione e di poteri occulti, consulente di numerose
Procure della Repubblica, non ha dubbi: «dalla Massoneria si esce solo nel caso
in cui si venga espulsi. Altrimenti si rimane “in sonno”, una condizione
comunque revocabile in qualsiasi momento». Aggiunge un altro consulente, più
volte fin dagli anni ‘80 al fianco dei PM in indagini sulle Logge segrete:
«accade con una certa frequenza che un massone in sonno decida di rientrare tra
i confratelli attivi, anche perché spesso la scelta dell’“assonnamento” è dovuta
all’assunzione di cariche pubbliche. Il suo ritorno viene vissuto come una
festa: non solo non occorre rifare tutti i complessi rituali dell’iniziazione,
ma spesso riceve in dono il passaggio ad un grado superiore rispetto a quello
che aveva lasciato. Questo indica che dalla massoneria non ci si può
“dimettere”: loro lo vivono come un battesimo, che non prevede alcuna
possibilità di “sbattezzarsi”». Tutto ciò riguarda le Logge regolari, con tanto
di elenchi depositati, mentre sulle eventuali “norme” vigenti fra i massoni
coperti non è possibile azzardare ipotesi. Di sicuro, il giuramento non viene
meno né potrà essere mai svelata l’identità dei confratelli. Quali siano le
“punizioni” per chi trasgredisce, si può a questo punto solo immaginarlo. È
sulla base di questa premessa che siamo andati a cercare chi sono, dove sono ora
e cosa fanno alcuni magistrati sulla cui originaria affiliazione massonica non
ci sono dubbi. L’inchiesta sulla massoneria, condotta da Agostino CORDOVA con
l’ausilio della Guardia Municipale di Vibo Valentia, signor VILLONE, ha
consentito di scoprire parecchi altarini. Magistrati inseriti nella lista della
P2 e DF all’orecchio GOI assonnati dell’epoca, e non, negli elenchi attuali dei
massoni: BARBARO Guido, in servizio. BUONO Antonio, in pensione. CASSATA
Salvatore, in pensione. LIBERATORE Vittorio, in pensione. MARSILI Mario, in
servizio. PALAIA Giovanni, in servizio. RANDON Giacomo, in servizio. RASPINI
Domenico, in pensione. SIGGIA Elio, in pensione. STANZIONE Antonio, in servizio.
ZUCCHINI Paolo, in servizio.
FONDO SEGRETO P2: DI BLASI
Salvatore, D’ONOFRIO Mario, PALERMO Domenico, PINELLO Francesco, RINAUDO
Antonio, SPINA Antonio, VELLA Angelo.
ELENCO MAGISTRATI MASSONI
ESTRATTI DA ARCHIVI GOI-CSI- GL I: ALIBRANDI Tommaso Cds, in pensione. ARITI
Alfredo, ARMANI Giuseppe, CASOLI Giorgio, D’AMICO Antonio, in pensione, DE
PANFILIS Lorenzo, in pensione, DI PRIMA Lillo, in pensione, MONTI Davide.
SCHEDA MAGISTRATI MASSONI GOI
(non risultanti negli archivi come Magistrati):
D’AGOSTINO Luciano (sì, negli
archivi, non come magistrato, dati anagrafici rispondenti). D’AGOSTINO Luciano.
La sua affiliazione esplode come una bomba nel ‘92, quando il napoletano
D’Agostino, classe 1955, è PM a Locri. «Sono sconcertato – dichiara ai giornali
– queste fughe di notizie sono inammissibili». Il vero problema era che il suo
nome compariva negli elenchi di una Loggia coperta, la Luigi Ferrer del
capoluogo partenopeo. Anche nel caso di D’Agostino assistiamo alle affermazioni
– peraltro senza prove – su una presunta uscita dalla massoneria, proprio come
si fa per dimettersi da un Cral: «prima di prendere servizio a Lamezia Terme
avevo scritto alla loggia Luigi Ferrer di Napoli, regolare del Grande Oriente
d’Italia, per segnalare che ritenevo l’esercizio di funzioni giurisdizionali non
compatibile con l’appartenenza alla massoneria. Da allora non ho avuto alcun
rapporto con i massoni». Basta la parola. Sapeva che era una Loggia coperta?,
gli chiede il cronista del Corriere della Sera. E lui: «Un grande oratore del
GOI ha detto che è una loggia coperta. Nel breve periodo in cui ne ho fatto
parte, non lo era». Non riesce a convincere il CSM, che nel ‘95 gli infligge una
sanzione disciplinare, dichiarando che l’appartenenza alla massoneria è lesiva
dell’imparzialità dell’ordine giudiziario. Fino a inizio anni 2000 D’Agostino è
sostituto procuratore a Catanzaro (dove si occupa, fra l’altro, della delicata
questione del testimone di giustizia Pino Masciari), nel 2002 passa alle sezioni
giudicanti dello stesso Tribunale. Dal 2007 è tornato a Locri, dove è stato
giudice per l’udienza preliminare. Nel frattempo era stato alle prese come
imputato in un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Salerno. L’accusa
(condanna in primo grado per peculato e assoluzione in appello) riguardava
l’affidamento ad una ditta dell’incarico di eseguire intercettazioni
telefoniche, quando D’Agostino era in servizio alla DDA di Catanzaro.
ABBADESSA Lorenzo – Classe
1939, nato a Napoli (dove gli Abbadessa sono conosciuti come influente famiglia
di medici), dal 2006 si è iscritto all’albo degli avvocati e risulta avere lo
studio a Soverato, perla costiera della provincia di Catanzaro. Con la qualifica
di “Magistrato” lo si ritrova invece negli elenchi dei massoni aggiornati a
tutto dicembre 2007 e pubblicati dalla Voce nel 2008. Lorenzo Abbadessa è
attualmente responsabile, proprio a Catanzaro, della Procura Generale della
Repubblica presso la Corte d’Appello, in via Falcone e Borsellino.
DI BLASI Salvatore – Per molto
tempo giudice al Tribunale civile di Milano, Di Blasi era fra le toghe iscritte
alla massoneria dell’elenco Cordova. Nel 2001 aveva assunto anche il delicato
incarico di presidente di sezione in seno alla Commissione Tributaria della
Lombardia. Fino a pochi anni fa il giudice Di Blasi si è occupato invece della
vicenda INNSE, la fabbrica milanese del legno a rischio chiusura.
FRANCIOSI Niccolò (sì, negli
archivi, non come magistrato, dati anagrafici rispondenti). FRANCIOSI Niccolò.
Anche lui presente negli elenchi Cordova del lontano ‘92, oggi il giudice
Franciosi, napoletano, classe 1942, è consigliere della Corte d’Appello a
Milano. Nel 2003 fa parte della terna giudicante che respinge la richiesta
avanzata dai legali di Cesare Previti di ricusazione dei giudici nel processo
IMI-SIR. Turbolente le vicissitudini del giudice Franciosi dinanzi al CSM per
quell’antica affiliazione: dopo la sanzione disciplinare fa ricorso alla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo. Strasburgo condanna al risarcimento in favore di
Franciosi non il CSM ma lo Stato italiano, reo di scarsa chiarezza sulle norme
che regolano l’appartenenza alla massoneria nel caso di un magistrato. Il
Consiglio Superiore, però, nel 2002 respinge la richiesta avanzata da Franciosi
di revisione della sentenza di sanzione e, due anni dopo, dice no anche
all’inserimento della sentenza europea nel suo fascicolo personale.
MARTINO Salvatore (scheda
numerata e con timbro, non negli archivi, sì, tra i magistrati, dati anagrafici
corrispondenti).
PERRONE Pio, in pensione
(scheda numerata e con timbro, non negli archivi).
RINAUDO Antonio (scheda con
timbro, non negli archivi, sì, tra i magistrati). RINAUDO Antonio. Anche la
iscrizione di Rinaudo alla massoneria viene a galla con gli elenchi del ‘92.
Attualmente in servizio a Torino (la città in cui è nato nel 1948) come pubblico
ministero, si è recentemente occupato dell’ex giocatore della Juve Michele
Padovano, sotto accusa per un presunto traffico di droga col Marocco. Nel 2006
le intercettazioni a carico di Luciano Moggi disposte dalla Procura partenopea
portano alla luce la frequentazione assidua fra l’ex plenipotenziario del calcio
italiano ed il PM Rinaudo, fra cene con signore e scambi di regali natalizi. Ai
magistrati napoletani che lo interrogano sulla sua possibile affiliazione alle
Logge, Moggi risponderà: «Massone io? Mai»…
ROMAGNOLI Riccardo (scheda
numerata e con timbro, sì, negli archivi, non come magistrato e senza dati
anagrafici). ROMAGNOLI Riccardo. È in servizio al Tribunale civile di Roma il
dottor Romagnoli, che a gennaio dello scorso anno ha pronunciato una storica
sentenza riguardante Poste Italiane. Nel 1996, a seguito del ritrovamento del
suo nome negli elenchi massonici del ‘92, a Riccardo Romagnoli il CSM inflisse
la perdita di due anni d’anzianità. Il che scatenò la vibrata protesta del
Grande Oriente d’Italia.
SALEMI Guido, in pensione
(scheda numerata e con timbro, sì, negli archivi, ma non come magistrato).
SCARAFONI Stefano (sì negli
archivi, non come magistrato, dati anagrafici corrispondenti).
SERIANNI Vincenzo, assonnato
(scheda con timbro, non negli archivi, dati anagrafici corrispondenti).
SPINA Antonio (scheda con
timbro, non negli archivi, risulta tra i magistrati).
VELLA Angelo, in pensione
(scheda numerata e con timbro, sì, negli archivi, ma senza dati). VELLA Angelo.
Ha fatto epoca, nel 1990, la decisione di Palazzo dei Marescialli, che aveva
bloccato la promozione di Vella a presidente di sezione del Tribunale felsineo
per la sua dichiarata appartenenza alla massoneria. Un parere che scatenò le ire
di Francesco Cossiga. Nel 1974 il giudice Vella si era occupato della strage
dell’Italicus. In anni più recenti, almeno fino al 2001, è stato membro della
Corte di Cassazione.
VITALE Francesco, in pensione
(scheda numerata e con timbro, sì, negli archivi, non come magistrato).
VITALI Massimo (scheda con
timbro, sì, negli archivi, ma non come magistrato, dati corrispondenti). VITALI
Massimo. Era sostituto procuratore a Brescia ai tempi della strage di Piazza
della Loggia e proprio a lui, insieme ad altri due colleghi, furono affidate le
indagini su una tragica vicenda della quale ancor oggi si cerca una verità. La
affiliazione di Vitali alla Massoneria verrà alla luce solo con gli elenchi del
‘92. Cosa fa ora? Classe 1946, originario di Grosseto, Vitali è in servizio.
Sempre a Brescia. Come consigliere di Corte d’Appello.
E per il momento ci fermiamo
qui.
Unical, il trionfo della
massoneria sotto gli occhi di Minniti, Bindi e gattopardo,
scrive Iacchite il 28 novembre 2017. Sulla stampa (anche di regime) delle
settimane sorse sono state pubblicate le vicende dei sette professori di diritto
tributario di Firenze messi agli arresti domiciliari da lunedì 25 settembre con
l’accusa di corruzione per aver truccato le procedure per l’abilitazione
universitaria. Altri 22 docenti sono stati sospesi dall’insegnamento per dodici
mesi, mentre il numero totale degli indagati dalla procura di Firenze in quella
stessa inchiesta è 59. Le accuse vanno dalla corruzione all’induzione indebita e
alla turbativa del procedimento amministrativo. Molti degli indagati, in quanto
membri delle commissioni nazionali nominate dal ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per rilasciare le abilitazioni all’insegnamento,
sono pubblici ufficiali. Nonostante questa triste pagina di storia per
l’Università Italiana, l’Università della Calabria, comandata dal massonissimo
Babbo Natale (che di Santa Claus ha solo la fisionomia e la stazza, visto il suo
menefreghismo e ci dicono anche la sua puerile cattiveria), rimane fuori dalle
inchieste della Procura di Cosenza per grazia ricevuta. Molti si chiedono il
perché. Ma trovare una risposta non è poi tanto difficile. Lo scriviamo da mesi
ormai: il procuratore-gattopardo Mario Spagnuolo ha fatto affari e soldi con
l’informatica grazie all’ineffabile professore Guarasci (quello che trucca i
concorsi con Crisci) e il suo sostituto anziano Bruno Antonio Tridico è stato
premiato con l’assunzione della compagna dopo aver fatto ridere tutta Italia con
la sua inchiesta sui falsi esami all’Unical che ha assolto tutti i “pezzi
grossi”. E così succede che Crisci sta allo stesso tavolo con Minniti, la Bindi
e Spagnuolo e si prende addirittura la libertà di dare la mano al ministro
dell’Interno con le modalità massoniche (il dito indice della mano destra
staccato dal resto delle dita) sotto gli occhi di quell’incapace di Rosy Bindi,
che fa guerra alla massoneria soltanto a chiacchiere. La situazione
dell’Università della Calabria pertanto può degenerare senza problemi, tanto
nessuno toccherà nessuno. L’8 novembre scorso si è verificato quello che abbiamo
anticipato un anno fa: la vittoria del concorso dirigenziale predestinato e
costruito ad hoc del dottore Roberto Elmo. Successivamente anche Repubblica è
stata costretta a scrivere che non solo nel Dipartimento di Guarasci si truccano
i concorsi e il Tar li annulla ma si ripresenta lo stesso candidato che ha
barato tanto l’impunità regna sovrana. Prossimamente ci sarà anche un aumento di
mansioni e di soldini per la bionda dissennata del primo piano, che dopo le
battute veritiere di donna Rosa, fa finta di niente, ma continua a scegliere
ditte e a fare le scarpe al suo capo Fabbricatore seminando odio con Babbo
Natale. L’ex capo dell’ufficio stampa, Ciccio Kostner, dopo mille tentativi di
ripresa e di ricorsi, pare si sia rassegnato alla volontà del supremo rettore,
che con il placet del Dimeg e del suo vero direttore Saccà continua, nell’ombra,
a governare l’ateneo. Raffaele Perrelli, solo intellettuale in questa bolgia di
peccatori, sembra ormai sempre più un pesce fuor d’acqua. Il buon Franco Rubino,
sperando in una sua condivisa candidatura a rettore, tesse rapporti con stato e
antistato, regalando incarichi, dottorati di ricerca e tante altre cose ancora.
Ma Gino Crisci, mentre ostenta la chiusura del Diatic, comincia ad alimentare
(chiediamoci come) altri studenti (rappresentanti) per barcamenare nel
tormentoso oceano dell’università. Il prorettore Luigino Filice (che si vuole
candidare a Rettore a tutti i costi) invece fa finta di non sapere e non vedere
che nelle residenze universitarie molti dipendenti e molti studenti sono
abusivi. Ma Filice non può parlare altrimenti gli tolgono i suoi scheletri
fuori. Altro schifo sono i fondi destinati alle associazioni studentesche. Le
uniche a percepire di più sono quelle gestite dal dottore di ricerca (promosso e
sostenuto da Rubino a discapito di gente meritevole e preparata) Diego
Mazzitelli, consigliere di amministrazione in quota studenti, col voto
telecomandato dal rettore. Che continua ad esaltare la “sua” massoneria, tanto
anche Minniti e la Bindi ridono quando gli dà la mano come un “fratello”.
Ovviamente deviato…
Omicidio Dalla Chiesa,
l’intervista a Sciascia: «La mafia è cambiata e nessuno lo ha ancora capito».
Nell’anniversario dell’omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
ripubblichiamo l’intervista a Leonardo Sciascia apparsa sul «Corriere della
sera» del 5 settembre 1982. «Carlo Alberto Dalla Chiesa lo abbiamo ucciso tutti
quanti noi indicandolo come l’unico che poteva combattere il terrorismo, come
l’unico che poteva combattere la mafia. Ne abbiamo fatto un bersaglio cui
qualcuno poi ha sparato». Comincia così il nostro colloquio con lo scrittore
Leonardo Sciascia venti ore dopo l’assassinio del generale dei carabinieri.
Sciascia non aveva stabili frequentazioni con il militare, ma ne era rimasto
affascinato tanto da trasformarlo nel capitano Bellodi, protagonista de «Il
giorno della civetta». L’incontro avviene nella casa di campagna dello scrittore
a Racalmuto, poche migliaia di anime al centro del triangolo della miseria in
Sicilia. Sciascia vi trascorre le vacanze in compagnia della moglie, n resto del
mondo appare lontano. La notizia dell’assassinio del prefetto di Palermo
Sciascia l’ha appresa solo ieri mattina, dodici ore dopo l’agguato. «Questo
assassinio — dice — ha un solo significato ed è l’eliminazione di una singola
persona che era diventata un simbolo. Le istituzioni sono tarlate, non
funzionano più, si reggono solo sulla abnegazione di pochi uomini coraggiosi. A
partire dall’assassinio del vice questore Boris Giuliano, la mafia ha deciso di
eliminare questi uomini simbolo. Arrivati a Dalla Chiesa, però, mi domando, se
non ci sia della follia in chi ordina questi delitti: che cosa vogliono? Qual è
il loro obiettivo? Pretendono forse il governo dello Stato? In verità non riesco
a capire. Vogliono forse Imporre un ordine mafioso che si sovrapponga a quello
dello Stato? Ma questo è impossibile perché livello dei delitti è talmente alto
da suscitare una fortissima reazione». «Io credo - continua Sciascia — che
nessuna organizzazione eversiva possa gareggiare con lo Stato in fatto di
violenza, anche quando lo Stato appare inefficiente. Anzi, la sua inefficienza,
è direttamente proporzionale alla mancanza di funzionalità. In queste condizioni
sfidarlo mi sembra un atto di napoleonismo folle. Ma tutto ciò mi preoccupa
perché uno Stato inesistente è sempre capace di approvare una legge sui pentiti
e di scatenare una furibonda repressione poliziesca». «Secondo me la mafia si
combatte utilizzando onestà, coraggio e intelligenza e le indagini fiscali
illustrate due giorni fa dal ministro Formica mi sembrano un buon inizio. Con
questi strumenti la mafia si può debellare. «Per capire tale affermazione
bisogna rifarsi alla tesi classica che voleva la mafia inserita nel vuoto dello
Stato, mentre in realtà essa vive nel pieno dello Stato. Credo che
dall’istituzione della commissione antimafia in poi, l’organizzazione abbia
cominciato a sentirsi esclusa dal pieno dello Stato e ora ha assunto questa
forma che potremmo definire eversiva. Ma in effetti appare come un animale
ferito che dà colpi di coda». «Dalla Chiesa, forse — aggiunge lo scrittore —,
non aveva intuito tale trasformazione e i pericoli che ne derivavano. Anch’io,
peraltro, non credevo che si arrivasse a colpire tanto in alto. Ma in effetti
noi tutti conosciamo bene solamente la vecchia mafia terriera. Per il resto
tiriamo ad indovinare. Possiamo dire in ogni caso che la mafia è una forma di
terrorismo perché vuole terrorizzare la gente. Ma i fini sono sostanzialmente
diversi. Di comune c’è una sola cosa e cioè l’attentato alle nostre libertà».
«Ma forse Dalla Chiesa — conclude Sciascia — non aveva piena coscienza di questo
fenomeno. Mi meraviglio infatti della maniera con cui è stato ucciso. Quando un
uomo arriva alle sue posizioni ha il dovere di farsi proteggere e di farsi
scortare bene. Le manifestazioni di coraggio personale possono diventare forme
di imprudenza pericolosa. Ciò nonostante mi sgomenta la incapacità della nostra
polizia di prevenire. Infatti un attentato ad un uomo come Dalla Chiesa non si
improvvisa in quattro e quattr’otto, ma nessuno ne aveva avuto sentore».
I nemici del generale dalla
Chiesa. Non soltanto terroristi e mafiosi.
«Dalla Chiesa» (prefazione di
Aldo Cazzullo, Mondadori, pagine 324, euro 20). La biografia di Andrea Galli
(pubblicata da Mondadori) ripercorre le vicende che portarono all’omicidio del
1982. C’è un vuoto di verità che va colmato, scrive Giovanni Bianconi il 28
agosto 2017 su "Il Corriere della Sera”. Il generale dei carabinieri Carlo
Alberto dalla Chiesa (1920-1982), assassinato a Palermo da Cosa nostra. Si
respira un’atmosfera da Giorno della civetta, quando un giovane capitano dei
carabinieri sbarcato a Corleone il 3 settembre 1949 fa emergere a fatica i
contorni di un misterioso delitto, nonostante latitanze e assoluzioni a
protezione dei colpevoli. E non si fa scrupolo di denunciare le interferenze dei
politici che «cercano di sopraffarsi affinché l’uno tragga vantaggi a scopi
elettorali a danno dell’altro». Quel capitano — non il Bellodi creato da
Leonardo Sciascia, ma l’ufficiale dell’Arma in carne e ossa Carlo Alberto dalla
Chiesa — ha toccato con mano la mafia e gli intrecci che la proteggono, e
sembrano inseguirlo fino a Milano, dove nella prima metà degli anni Sessanta si
trova a indagare sulle propaggini lombarde della guerra fra cosche che ha rotto
gli equilibri tra gli «uomini d’onore», con tanto di omicidi in trasferta. Poi
dalla Chiesa, divenuto colonnello, torna sull’isola per comandare la Legione
della Sicilia occidentale, ed eccolo alle prese con inchieste sui funzionari
regionali legati a Cosa nostra, anticamera dei rapporti tra mafia e pubblica
amministrazione; e con le calunnie di un Corvo ante litteram, impegnato a
spargere veleni contro il comandante che con la sua fissazione per il rispetto
delle regole rischia di mettere in pericolo il quieto vivere sul quale i boss
hanno costruito il loro potere. Se ne andrà ma tornerà ancora, il carabiniere
promosso generale e infine prefetto di Palermo, incaricato di guidare una
battaglia che non farà in tempo neppure a cominciare: la mafia chiude i conti
ammazzandolo a colpi di kalashnikov, insieme alla giovane moglie e all’inerme
guardia del corpo. Era il 3 settembre 1982, trentatré anni dopo il primo
incarico a Corleone. E stavolta non c’è lo sfondo arido e assolato da Giorno
della civetta, bensì la determinazione cupa e sanguinaria de Il padrino. Tutto
questo e molto altro, insieme alla sintesi di un lungo tratto di storia
criminale e politica d’Italia, affiora dalle pagine in cui Andrea Galli ha
ricostruito la vicenda del «generale dei carabinieri che sconfisse il terrorismo
e morì a Palermo ucciso dalla mafia» (Dalla Chiesa, Mondadori, con prefazione di
Aldo Cazzullo). Una parabola che comincia e finisce in Sicilia, ma in mezzo
attraversa la lunga e drammatica parentesi della lotta armata, contro la quale
lo Stato schierò dalla Chiesa due volte: prima agli albori delle Brigate rosse e
poi, dopo l’inspiegabile scioglimento del suo Nucleo speciale, all’indomani del
sequestro Moro. Il racconto di Galli, ricco di dettagli, suggestioni e episodi
inediti o poco conosciuti, aiuta a ricordare che il capitolo più tragico del
terrorismo rosso si apre e si chiude con le indagini di dalla Chiesa e dei suoi
carabinieri, che tra il 1974 e il 1975 quasi arrivano a smantellare le Brigate
rosse e in seguito, fra il 1978 e il 1981, avviano il percorso investigativo che
porterà alla loro definitiva sconfitta. Un metodo innovativo più che una
struttura organizzata, grazie al quale gli uomini del generale (un manipolo di
fedelissimi selezionati e votati alla causa) riescono a infiltrare le bande
armate e gli ambienti nei quali reclutano militanti, studiandone abitudini e
obiettivi per anticiparne le mosse e riuscire a neutralizzarle. Fino al decisivo
aiuto fornito dai terroristi «pentiti», primo fra tutti quel Patrizio Peci che
proprio con dalla Chiesa decide di saltare la barricata e passare dall’altra
parte. I successi del generale e del suo modo di lavorare — accompagnati dalle
perplessità mai nascoste nei confronti di uno Stato che non sembra reagire
compatto alla sfida del terrorismo rosso, e soprattutto non usa la stessa
determinazione contro l’eversione di marca neofascista — lo trasformano in un
obiettivo per i suoi avversari sul «campo di battaglia», ma determinano
inquietanti preoccupazioni anche all’interno delle istituzioni, nonché gelosie e
attenzioni poco benevole dentro l’Arma. Un quadro poco limpido, nel quale
s’inserisce il ritrovamento del suo nome nell’elenco degli iscritti alla Loggia
P2 di Licio Gelli, che accompagna la nomina di dalla Chiesa a vice-comandante
dell’Arma e poco dopo, nella primavera del 1982, a prefetto di Palermo, chiamato
a contrastare l’emergenza della mafia che ha sferrato un attacco senza
precedenti alle istituzioni, con una raffica di «omicidi eccellenti». Lui
accetta anche per provare a sfuggire all’isolamento nel quale si sente confinato
con il precedente incarico «privo di contenuti», come scrive lui stesso. Pur
nella consapevolezza di essere strumentalizzato: «Mi sono trovato al centro di
uno Stato che usa il mio nome per tacitare l’irritazione dei partiti e non ha
nessuna volontà di debellare la mafia», pronto a «buttarmi al vento non appena
determinati interessi saranno o dovranno essere toccati e compressi», annota nel
diario. Al generale promosso prefetto non viene concesso il tempo di verificare
la sua amara profezia. I killer mafiosi entrano in azione su ordine di Totò
Riina e della Cupola prima ancora che dalla Chiesa possa cominciare a incidere
su quegli interessi. Un particolare che ha pesato e continua a pesare sul reale
movente del delitto, come avevano già sentenziato Giovanni Falcone, Paolo
Borsellino e gli altri giudici istruttori del maxi-processo a Cosa nostra:
«Persistono zone d’ombra sia nelle modalità con le quali il generale è stato
mandato in Sicilia (praticamente da solo e senza mezzi) a fronteggiare il
fenomeno mafioso, sia nella consistenza di specifici interessi, anche
all’interno delle istituzioni, volti all’eliminazione del pericolo costituito
dalla determinazione e dalla capacità del generale». A trentacinque anni di
distanza dall’omicidio, il libro di Andrea Galli aiuta a riempire, almeno
parzialmente, quel vuoto di verità.
“Dalla Chiesa, il mandante
fu il deputato Cosentino”.
Palermo 1982 - Il procuratore generale Roberto Scarpinato
racconta all’Antimafia le accuse al piduista andreottiano per l’omicidio del
prefetto, scrivono Gianni Barbacetto e Stefania Limiti il 4 aprile 2017 su "Il
Fatto Quotidiano". Parla lentamente, il procuratore generale di Palermo, Roberto
Scarpinato, davanti ai parlamentari della Commissione antimafia. È stato
chiamato in audizione, come altri “esperti”, per raccontare i rapporti tra mafia
e massoneria. Una storia lunga e complessa di due poteri che si sono, di volta
in volta, fronteggiati, confrontati, alleati. E intrecciati con il potere
politico. A un certo punto della sua audizione, parlando dell’omicidio del
prefetto di Palermo Carlo Alberto dalla Chiesa, il procuratore generale
scandisce le parole: “L’ordine di eliminare Dalla Chiesa arrivò a Palermo da
Roma. Dal deputato Francesco Cosentino”. Democristiano, andreottiano, massone,
Cosentino era un potente parlamentare della Dc, segretario generale della
Camera, fedelissimo di Giulio Andreotti e personaggio di rilievo della loggia
massonica P2 di Licio Gelli. È l’8 marzo 2017 quando Scarpinato fa risuonare di
nuovo il suo nome davanti ai parlamentari della commissione. L’audizione era
iniziata in seduta pubblica: “Sono stato informato”, aveva detto Scarpinato, “di
progetti di attentati, nel tempo, nei confronti di magistrati di Palermo orditi
da Matteo Messina Denaro per interessi che, da vari elementi, sembrano non
essere circoscritti alla mafia, ma riconducibili a entità di carattere
superiore”. Dopo le prime battute, l’audizione era stata secretata. A porte
chiuse, il magistrato siciliano, secondo quanto risulta al Fatto Quotidiano, ha
fatto una lunga ricostruzione storica dei rapporti tra mafia e massoneria,
ricordando che già Stefano Bontate – capo di Cosa Nostra prima di Totò Riina,
che lo fece ammazzare nel 1981 – era affiliato a una loggia segreta “che era
un’articolazione in Sicilia della P2 di Licio Gelli”. Il 3 settembre 1982 viene
ucciso Dalla Chiesa: un omicidio politico, non solo mafioso. E qui Scarpinato ha
rivelato ai commissari dell’antimafia che Gioacchino Pennino, medico, uomo di
Cosa nostra e massone, diventato collaboratore di giustizia ha raccontato di
aver saputo da altri massoni che “l’ordine di eliminare Carlo Alberto dalla
Chiesa arrivò a Palermo da Roma, dal deputato Francesco Cosentino”. Nessuno dei
commissari lo ha interrotto, nessuno ha chiesto spiegazioni. Scarpinato ha
proseguito il suo racconto, mettendo a fuoco i complessi rapporti con la
massoneria dei corleonesi di Totò Riina e Bernardo Provenzano, dopo
l’eliminazione di Bontate. Riferisce che un fedelissimo di Riina, Giuseppe
Graviano – che è uno degli strateghi dell’uccisione di Giovanni Falcone e delle
stragi del ’93 – partecipa a riunioni massoniche. Le relazioni continuano fino a
oggi, tanto che alcune fonti indicano come massone anche il superlatitante
Matteo Messina Denaro: il boss che ha progettato attentati nei confronti di
magistrati di Palermo “per interessi che sembrano non essere circoscritti alla
mafia, ma riconducibili a entità di carattere superiore”. Per l’omicidio di
Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente di scorta
Domenico Russo, sono stati condannati all’ergastolo, come mandanti, i vertici di
Cosa nostra dell’epoca: i boss Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco,
Pippo Calò, Bernardo Brusca e Nenè Geraci. Nel 2002 è arrivata la condanna anche
per gli esecutori: Vincenzo Galatolo, Antonino Madonia, Francesco Paolo Anzelmo
e Calogero Ganci. Nella sentenza si legge: “Si può senz’altro convenire con chi
sostiene che persistano ampie zone d’ombra, concernenti sia le modalità con le
quali il generale è stato mandato in Sicilia a fronteggiare il fenomeno mafioso,
sia la coesistenza di specifici interessi, all’interno delle stesse istituzioni,
all’eliminazione del pericolo costituito dalla determinazione e dalla capacità
del generale”. Ora abbiamo qualche indicazione in più sugli “specifici
interessi, all’interno delle stesse istituzioni”, che hanno portato
all’uccisione del generale, in “coesistenza” con quelli di Cosa Nostra. Sul
ruolo di Cosentino, Scarpinato in Commissione antimafia non ha fornito altri
dettagli. Morto nel 1985, è “figlio d’arte”: suo padre Ubaldo, anch’egli
massone, fu segretario generale della Camera dei deputati dal 1944 fino alla sua
morte, nel 1951. Il figlio Francesco ebbe la stessa carica dal 1962 al 1976,
quando fu coinvolto nello scandalo Lockheed. Fu poi per breve tempo parlamentare
europeo. Nel 1981 il suo nome fu ritrovato negli elenchi della P2, scoperti dai
magistrati milanesi Gherardo Colombo e Giuliano Turone negli uffici di Gelli a
Castiglion Fibocchi. Una ventina dei 962 nomi dell’elenco trovato in cassaforte
erano segnati con un evidenziatore giallo: tra questi, quello di Francesco
Cosentino, come quello di Licio Gelli, di Michele Sindona, di Roberto Calvi, di
Silvio Berlusconi… Il nome Cosentino compare più volte anche sulle agende di un
altro noto fratello della P2, il direttore di Op Mino Pecorelli, che segnava
meticolosamente i suoi appuntamenti: “Costa-Berlusconi-Licio-Gregori-Cosentino”
(5 settembre 1977): “Berlusconi-Cosentino” (16 ottobre 1977);
“Cosentino-Berlusconi Montedison” (27 ottobre 1977). Nel 1979, il Maestro
Venerabile della P2 Licio Gelli apre una trattativa con il petroliere Attilio
Monti per comprare i suoi giornali, Il Resto del Carlino di Bologna e La Nazione
di Firenze. A Monti dice che sta lavorando per Cosentino, che è lui il possibile
acquirente. La trattativa non andrà in porto. Ma anni più tardi, il ruolo
preminente di Cosentino nella P2 fu messo in rilievo dalla moglie del banchiere
Roberto Calvi, Clara Canetti, che alla commissione P2 di Tina Anselmi il 6
dicembre 1982 dichiarò: “Gelli era solo il quarto… Il primo era Andreotti, il
secondo era Francesco Cosentino, il terzo era Umberto Ortolani, il quarto era
Gelli”. Lo ripeterà il 2 febbraio 1989 a Michele Santoro nella trasmissione tv
Samarcanda: “Mio marito mi aveva detto che sopra Gelli e Ortolani c’erano
Andreotti e Cosentino”. Il secondo era tutt’uno con il primo. Nel suo diario
personale, Dalla Chiesa racconta che il 5 aprile 1982, poco prima di andare a
Palermo, ebbe un colloquio con Andreotti al quale disse che non avrebbe avuto
riguardi per “la famiglia politica più inquinata del luogo”. Era quella
andreottiana. Ora Scarpinato rivela: “L’ordine arrivò da Roma”.
Dall’andreottiano Francesco Cosentino.
"ECCO CHI E' IL MANDANTE
DELL' OMICIDIO DALLA CHIESA",
scrive il 4 ottobre 1989 "La Repubblica”. L' ultima verità sull' uccisione di
Carlo Alberto Dalla Chiesa i giudici della Corte d' Assise di Palermo sono
andati ieri a cercarla nel carcere di Alessandria. Gliel' ha offerta il pentito
Giuseppe Pellegriti, già boss emergente di un paese dell'Etna, arrestato nel
febbraio del 1986. Ma le confessioni del pentito sono andate oltre l'omicidio
del prefetto: Pellegriti infatti ha sostenuto di aver saputo dai Santapaola, al
cui clan era collegato, che il mandante degli omicidi Mattarella, La Torre e
Dalla Chiesa. Era uno solo: un politico democristiano di Palermo. Pallegriti ha
fatto il nome e quel nome scottante adesso è nel verbale che la Corte ha
riportato con sè a Palermo. Ci saranno controlli e verranno fatti accertamenti
sui molti punti toccati da Pellegriti, il quale più d' una volta ha detto cose
inesatte. Alla Corte che si era trasferita ad Alessandria, Pellegriti non è
sembrato molto ansioso di indicare quel nome del mandante politico. IN
PRECEDENZA, ad altri giudici che lo avevano sentito, parlando dell'ambiente nel
quale era maturato il delitto Dalla Chiesa, aveva detto: Il mandante è un
personaggio molto in alto di Palermo o di Roma. Ma non saprei aggiungere altro.
Ieri le cose sono andate diversamente. Il presidente della Corte lo ha
incalzato: Lei è in una Corte d' Assise. Questa Corte si occupa dell'omicidio
Dalla Chiesa, se ha qualcosa da dire la dica adesso. Interessi palermitani e
catanesi E Pellegriti ha risposto, facendo quel nome. E ha spiegato che per
Dalla Chiesa si erano saldati alcuni interessi palermitani ad interessi
catanesi. Gli esecutori furono scelti dai Santapaola. Pellegriti avrebbe avuto
le prime notizie sulla vicenda nel corso di una riunione a Belpasso, vicino a
Catania. Poi, fra l'86 e l'87 almeno altri due mafiosi incontrati in carcere gli
confermarono tutto. Anche qui Pellegriti ha fatto i nomi: Salvatore Tuccio detto
Turi di l'ova e Carletto Campanella. Entrambi del clan Santapaola. I giudici gli
hanno chiesto se avesse riferito questo fatto ad altri inquirenti. Pellegriti ha
riferito di esser stato sentito ai primi di agosto dal giudice bolognese Libero
Mancuso, il quale passò i verbali a Falcone che lo interrogò il 17 agosto. Anche
Domenico Sica si era fatto avanti. Ad uno dei tre, Pellegriti ricordava di aver
fatto il nome del politico siciliano, ma non era più sicuro di quale fosse. E
come mai soltanto adesso, l'improvviso pentimento? Qui Pellegriti ha dato una
strana versione: ha detto di aver provato rimorsi nel momento in cui ha
abbracciato la fede cristiana evangelica pentacostale. In realtà la Corte sembra
più propensa a credere che la svolta sia avvenuta dopo che nell' ottobre ' 87
gli fu ucciso il padre Filippo. Una volta il presidente lo ha colto in fallo: è
stato quando Pellegriti ha indicato in Carletto Campanella uno degli esecutori
dell'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ebbene: Campanella in quei giorni
era in carcere. Nel raccontare le meccaniche dei tre omicidi, Pellegriti avrebbe
anche spiegato che mentre il delitto dalla Chiesa aveva anche un obiettivo per
così dire funzionale, nel senso che gli si voleva impedire di fare indagini
giudicate pericolose, gli altri due delitti, quello Mattarella e quello La Torre
furono essenzialmente delitti politici. Ma dietro a tutti e tre c'era la mano
dell'esponente politico dc. Nel carcere i due avvocati della famiglia Dalla
Chiesa, il difensore di Pippo Calò, il presidente della Corte, insieme a uno dei
giudici a latere e a un rappresentante della procura generale, hanno vissuto ore
di tensione. La decisione di ascoltare il pentito era stata presa il 29
settembre scorso. Pellegriti avrebbe avuto un ruolo in almeno 12 dei 50 omicidi
compiuti ad Adriano e a Biancavilla tra il 1985 e il 1987, e si è accusato
dell'assassinio di Giuseppe Fava, il giornalista ucciso a Catania nel gennaio
del 1985. Disse di aver organizzato l'agguato per fare un favore a Santapaola. A
sparare sarebbe stato Antonino Cortese, arrestato nel marzo scorso a Padova.
Riscontri non univoci Pellegriti ha parlato a lungo anche del delitto
Mattarella. Le sue rivelazioni sono arrivate quando ormai l'inchiesta del
giudice Giovanni Falcone volgeva al termine. Falcone ha fatto numerosi controlli
sulle rivelazioni del pentito e ieri ha detto che esse sono risultate solo in
parte coincidenti con riscontri obiettivi o con quanto era già stato acquisito
dall' indagine.
LA MASSONERIA NEL VANGELO
SECONDO I PENTITI. SCARPINATO: IL P.G. UN PO’ DISTRATTO,
scrive il 5 aprile 2017 Mauro Mellini su "La Valle dei Templi". “Parla
lentamente il Procuratore Generale di Palermo, Roberto Scarpinato, davanti alla
Commissione Antimafia. E’ chiamato in audizione come altri “esperti”…per
raccontare i rapporti tra mafia e Massoneria”. Ad un certo punto il P.G.
“scandisce le parole “l’ordine di eliminare Dalla Chiesa arrivò a Palermo da
Roma. Dal deputato Francesco Cosentino, democristiano, andreottiano, massone”.
Immagino la scena: Scarpinato che parla dopo aver convenientemente agitato la
criniera leonina, con Rosy Bindi, il volto illuminato da un mezzo sorriso di
compiaciuta, soddisfatta, estatica ammirazione. A Scarpinato piace fare scena.
Tentò di farla, figuratevi, anche con me, teste a Palermo al processo Andreotti,
agitando un giornale e contestandomi: “Lei ha parlato in un’intervista di “golpe
dei giudici”. Come se potesse ritenere di avermi preso in castagna per una frase
imprudentemente lasciatami sfuggire. Ed io a rimbeccarlo “Non è esatto!”
Facendolo ricorrere subito a minacce di incriminarmi. Finché, superando i suoi
rimbrotti ed i preoccupati interventi del Presidente, riuscii a dirgli “Ho
parlato? Guardi che ho scritto un libro dal titolo “Il golpe dei giudici”. Certo
è che del mio libro avrò anche “parlato”…Questo perché la precisione,
l’esattezza non pare che sia la caratteristica degli exploit del Procuratore
Generale. Leggendo i titoli di giornali ed agenzie “Dalla Chiesa, il mandante fu
il deputato Cosentino”, sono andato subito a vedere a chi si riferisse, dove
quel deputato fosse stato eletto etc.. Ma non c’era nessun deputato Francesco
Cosentino. No so se perché anche le ulteriori qualifiche sono state dallo stesso
Procuratore attribuite a Francesco Cosentino, o perché i giornalisti vi hanno
messo del loro, ma di seguito si legge… “democristiano, andreottiano,
massone…era un potente parlamentare della D.C. SEGRETARIO GENERALE DELLA
CAMERA…”. Ma, in verità non so se Scarpinato oppure i giornalisti, mostrano di
essere ignorantelli. Il Segretario Generale della Camera non è un deputato, ma
un funzionario, che, in genere, se ha una propensione politica se la tiene per
sé. Di Francesco Cosentino si diceva fosse “di area repubblicana” qualcuno si
diceva informato del fatto che fosse Massone. Risultò, poi, nelle “liste” di
Gelli. Espertissimo di diritto parlamentare, uomo autorevole e “potente” è
probabile che si occupasse di cose siciliane e, in genere, di cose e di persone
lontane da Montecitorio come è probabile che io mi occupi di commercio con la
Cina. Scarpinato, così perentorio e, a dire dei giornali, solenne,
nell’affermare che “l’ordine di ammazzare Dalla Chiesa venne da Cosentino”
(glielo aveva detto tale Gioacchino Pennino, coinvolto in vicende mafiose e,
pare, massone pentito, che lo aveva saputo da altri. Per i magistrati gli
ambienti mafiosi sono molto pettegoli, specie per le questioni più rigorosamente
segrete). Così disinvolto ad appioppare a Francesco Cosentino la qualifica di
deputato, di democristiano e di “andreottiano”, Scarpinato ha dimenticato di
riferire alla Commissione Antimafia che il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa,
che affermò essere stato ucciso per mandato della Loggia P2 di Licio Gelli (e
quindi, del “vero” capo di esso, il noto massone Giulio Andreotti, il quale era
l’ultimo in Italia ad aver bisogno di qualcosa come la P2!!!) era egli stesso
appartenente a tale singolare organizzazione massonica. “De mortuis nisi bonum,
ma cancellare anche i fatti documentati (e farlo addirittura prima della morte)
è un po’ troppo. Che Carlo Alberto Dalla Chiesa avesse fatto regolare domanda di
iscrizione alla Loggia di Licio Gelli è indiscutibilmente provato e da lui
stesso fu ammesso. E’ anche noto che Dalla Chiesa sostenne di avere chiesto
quella iscrizione per “infiltrarsi” e conoscere che cosa si andava approntando
là dentro. Ma la tesi del Generale dei Carabinieri (mica un sottoufficiale!)
“infiltrato” è in sé assai poco plausibile. A renderla addirittura ridicola ci
pensò lui stesso: “Chiesi…l’iscrizione, ben deciso, però, essendo cattolico
praticante, a non giungere mai all’iniziazione”. Uno strano modo di
“infiltrarsi” e di andare a conoscere le segrete cose di quella Loggia un po’
strana, rimanendo, però, sempre in anticamera. Addirittura tale da ben figurare
in una pièce umoristica è, poi, l’affermazione che, essendo stato invitato da
Gelli ad un colloquio, “io aderii a condizione, però, che fosse presente un
sacerdote di mia fiducia, che indicai in Monsignor Pisoni…il giorno
dell’appuntamento, però Monsignore ebbe altro da fare, così ci andai da solo”.
Come dire: mostrai a Gelli di considerarlo un demonio, ma mi premurai di
avvertirlo che mi portavo dietro l’esorcista, di cui fece, poi, a meno. Questo
dichiarò il Generale al P.M. Turone di Milano. Il quale nulla eccepì né gli
contestò al riguardo. “Piduista” il dott. Cosentino, ma “piduista”, anche il
Gen. Dalla Chiesa. Perché, dunque la P2 (capeggiata in realtà dal noto massone
Andreotti) avrebbe dovuto far uccidere il Generale se “era della partita?”. Di
questi particolari, di queste quisquiglie Scarpinato non se ne è curato né ha
cercato di darne spiegazione agli on. Parlamentari della Commissione. Rosy
Bindi, figuriamoci. Anche se non dovrebbe essere digiuna di un po’ di storia
parlamentare, credo si sia deliziata di tanta abbondanza di accuse di non poco
conto alla sua ex casa politica, la D.C. Così si fanno le Commissioni
Parlamentari di inchiesta nel nostro Paese. E si fa la storia. Non c’è da
meravigliarsi che poi, la gente, ne faccia delle storielle e, magari, ci si
diverta. Che, invece, c’è assai poco da divertirsi. Mauro Mellini.
Dalla Chiesa e la P2. Un
fatto che “Il Fatto Quotidiano” nasconde,
scrive giovedì 6 Settembre 2012 Giuliano Guzzo. Premessa: consideriamo – al pari
di chiunque lo abbia conosciuto o ne abbia sentito parlare – il generale Carlo
Albero Dalla Chiesa (1920-1982) un eroe. Di più: un eroe che si dovrebbe
ricordare più spesso di quanto non si faccia, come in questi giorni, solo
allorquando ricorre la commemorazione del suo vile assassinio. Parimenti, anche
se non lo reputiamo titolo meritorio, ci rifiutiamo di considerare una vergogna
inenarrabile l’essere appartenuti alla Loggia P2. Un punto di vista, questo, ben
distante da quello della redazione de Il Fatto Quotidiano, in particolare del
suo direttore, Antonio Padellaro, e del suo vice, Marco Travaglio: il primo
quando lavorava per il Corriere ebbe il merito – come lo stesso Travaglio
riporta in Inciucio (Bur, 2005) – di «portare in redazione gli elenchi della
loggia di Gelli, appena scoperti dai giudici milanesi», il secondo non perde
occasione di ricordare – vedi il libro Le mille balle blu (Bur, Milano 2006) –
che Licio Gelli risulta «condannato per i depistaggi nelle stragi, e per la
bancarotta del Banco Ambrosiano, ed è indagato per l’omicidio di Roberto Calvi».
Insomma, Padellaro e Travaglio non stravedono affatto per la P2 e per coloro che
ne fecero parte, tutt’altro. E poi si battono per far emergere il più possibile
i “fatti” senza censure o bavagli. Sono giornalisti seri, insomma. E allora ci
devono spiegare come mai hanno consentito che ieri il loro giornale pubblicasse
un articolo di Gian Carlo Caselli dove si celebra – giustamente – il generale
Dalla Chiesa spiegando che la sua eredità è di «importanza fondamentale», che
rappresenta un «simbolo della lotta (vincente) al terrorismo brigatista» e che
è al suo sacrificio che dobbiamo «i due pilastri su cui ancora oggi si regge
l’azione antimafia (reato associativo e misure contro l’illecita accumulazione
di ricchezze)», ma dove ci si dimentica di dire che Dalla Chiesa chiese di
entrare nella P2 e che pare non la considerasse affatto – lui, uomo delle
istituzioni e del dovere – quel club di mezzi criminali e sovversivi che molti
lettori del Il Fatto Quotidiano pensano. Come mai questa censura? Non eravate
voi, cari giornalisti liberi e indipendenti, quelli contro il bavaglio? E allora
perché lasciare i vostri lettori nell’ignoranza? E dire che la volontà di Dalla
Chiesa di far parte della Loggia di Gelli è storia. Infatti, quando il 17 marzo
1981 la Guardia di Finanzia scovò gli archivi della P2 contenuti nella
cassaforte di Licio Gelli – oltre al nome degli affiliati – scoprì parecchie
«domande di iscrizione con firme illustri», tra cui quella del generale (Cfr. De
Luca M. – Buongiorno P. Storia di un burattinaio in AA.VV. L’Italia della P2,
Mondadori, Milano 1981, p. 60). Da quanto sappiamo Dalla Chiesa inoltrò questa
richiesta tramite il generale Raffaele Giudice e il deputato Francesco Cosentino
grazie ai quali «fu “presentato” (avevano sottoscritto il modulo di
presentazione per l’inserimento nella loggia») a Gelli» (Pennino G. Il vescovo
di Cosa nostra, Sovera, Roma 2006, p. 121). E’ meno chiara la ragione per cui
Dalla Chiesa presentò quella domanda. Secondo alcune fonti lo fece quasi
involontariamente – «anch’io, come altri, sono stato costretto a iscrivermi alla
Loggia», avrebbe detto (cit. in Di Giovacchino R. “Il libro nero della Prima
Repubblica”, Fazi, Roma 2005, p. 91) -; per altre avrebbe inoltrato la domanda
ritenendo la cosa come non grave, anzi: «Io ho fatto la domanda […] per quanto
ne sapevo, per le persone che conoscevo, si tratta di uomini per bene, servitori
dello Stato...» (cit. in Carpi A.P. “Il Venerabile”, Gribaudo & Zarotti, Torino,
1993, p. 443). Dinnanzi ad una così vasta pluralità di fonti, una cosa appare
comunque certa: Dalla Chiesa fece regolare domanda per affiliarsi alla Loggia
P2, quella guidata da tale Licio Gelli, «condannato per i depistaggi nelle
stragi, e per la bancarotta del Banco Ambrosiano, ed indagato per l’omicidio di
Roberto Calvi». Cosa che per noi – lo ribadiamo – rappresenta un aspetto della
minima rilevanza e che non scalfisce minimamente la statura morale, umana ed
istituzionale di questo compianto ed eroico servitore dello Stato. Per altri,
per i quali la P2 rappresenta il Male Assoluto, dovrebbe invece costituire un
fatto quanto meno problematico. A meno che i “fatti”, come in questo caso, non
vengano fatti sparire. Giuliano Guzzo
Indagini, veleni e guai:
ecco cosa sta scuotendo l'Arma dei Carabinieri.
Vertici sotto inchiesta. Litigi tra ufficiali. E rapporti opachi con la
politica. La Benemerita vive il suo momento peggiore. Ecco cosa sta succedendo e
chi potrebbe essere il prossimo comandante generale, scrive Emiliano Fittipaldi
il 22 agosto 2017 su "L'Espresso". Chiunque arriverà, «dovrà rimboccarsi le
maniche. Perché troverà macerie: erano decenni che l’Arma dei Carabinieri non
soffriva di una crisi così grave». Il militare che lavora al Comando Generale di
Roma forse esagera, ma non è l’unico a pensare che la Benemerita stia vivendo
uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Una crisi latente da
tempo, esplosa con l’indagine Consip. Uno scandalo che ha tramortito, in un
domino di cui ancora non si vede la fine, tutti. Dal comandante generale Tullio
Del Sette (indagato per favoreggiamento) ai capi di stato maggiore, ascoltati
come testimoni; passando ai comandanti di reparti specializzati, accusati di
depistaggio; e ai carabinieri iscritti nel registro per falso ideologico e
materiale; per finire con la caduta di eroi simbolo dell’Arma come il colonnello
Sergio De Caprio, meglio conosciuto come “Capitano Ultimo” per aver arrestato
Totò Riina, allontanato su due piedi lo scorso mese da una delle nostre agenzie
di intelligence perché considerato improvvisamente «non più affidabile».
Leggendo le carte e le accuse dei magistrati - tutte ancora da provare - sembra
che sul caso Consip l’Arma si sia spaccata a metà. Con il vertice della piramide
impegnato a rovinare attraverso fughe di notizie insistite un’indagine
giudiziaria che rischiava di compromettere l’immagine del Giglio magico di
Matteo Renzi, e la base - rappresentata dagli investigatori del Noe -
concentrata al contrario a costruire prove false pur di inchiodare Tiziano
Renzi, il padre del segretario del Pd. Un cortocircuito mai visto nel Corpo, un
disastro giudiziario e mediatico che ha indebolito ancor di più la posizione del
numero uno Tullio De Sette, indagato dallo scorso dicembre a Roma per
favoreggiamento e divulgazione di segreto istruttorio, con l’accusa di aver
fatto trapelare a soggetti terzi (come l’ex presidente della Consip Luigi
Ferrara) l’indagine sulla stazione appaltante dello Stato su cui stavano
lavorando i pm di Napoli. Per lo stesso reato sono iscritti anche il ministro
Luca Lotti e il generale Emanuele Saltalamacchia: il comandante della Legione
Toscana, è stato accusato di aver spifferato informazioni segrete sia da Luigi
Marroni (l’ex ad di Consip ha detto che era stato anche Saltalamacchia, suo
amico, a dirgli «che il mio cellulare era sotto controllo») sia dall’ex sindaco
Pd di Rignano sull’Arno Daniele Lorenzini. «Durante una cena a casa di Tiziano»,
ha specificato in una deposizione, «sentii Saltalamacchia» suggerire al papà
dell’ex premier «di non frequentare un soggetto, di cui tuttavia non ho sentito
il nome, perché era oggetto di indagine». Se gli ultimi mesi sono stati
difficilissimi, va evidenziato che Del Sette, nato 66 anni fa in Umbria, a
Bevagna, era inviso a pezzi dell’Arma anche prima dell’iscrizione nei registri
della procura, e che fonti del Comando generale non negano come molti generali,
davanti ai guai giudiziari del loro capo, non si siano certo stracciati le
vesti.
Già: il comandante generale,
arrivato al posto di Leonardo Gallitelli all’inizio del 2015, è infatti stato
giudicato fin da subito “troppo” vicino alla politica: anche se la lunga
carriera dell’Arma ne faceva un candidato autorevole, in molti non gli
perdonavano (e non gli perdonano) i sette anni in cui è stato capo ufficio
legislativo del ministero della Difesa, sotto governi sia di destra sia di
sinistra; né la scelta, nel 2014, di accettare la chiamata del ministro Roberta
Pinotti, per diventarne capo di gabinetto. Non era mai accaduto prima che un
carabiniere assumesse quell’incarico fiduciario. A Del Sette viene poi
contestato un carattere non facile. Se Gallitelli, mente fredda e raffinata, ha
puntato su una guida inclusiva e meritocratica, seppur giudicata da alcuni
troppo “curiale”, Del Sette ha preferito un comando verticistico, che per i
critici ha finito con l’essere divisivo. «Del Sette è persona di grande valore,
molto leale con le istituzioni. Ha lavorato bene con i ministri di ogni partito,
come Martino, Parisi, anche con Ignazio La Russa. Molte delle leggi vigenti
portano la sua “firma”, compreso l’accorpamento del Corpo forestale ai
carabinieri», spiega chi lo stima e ha lavorato con lui al dicastero della
Difesa. «Cosa lo ha penalizzato negli ultimi tempi? Su Consip credo si sia
trattato di un’ingenuità, e la sua posizione sarà archiviata. Al comando
generale invece, non l’ha mai aiutato il suo carattere fumantino. È un uomo
capace, che però si arrabbia facilmente. Soprattutto quando si convince che il
suo interlocutore non rispetta le gerarchie e i ruoli che lui ha definito». Del
Sette viene definito sia dai suoi estimatori (che sono molti) sia dai suoi
nemici (che sono ancor di più) un uomo schivo, persino timido, ma poco propenso
alla mediazione. Appena nominato dai renziani a numero uno dei carabinieri, ha
deciso in effetti di spazzare via la vecchia nomenclatura costruita in sei anni
dal suo predecessore, scegliendo di andare allo scontro frontale con alcuni
generali fedelissimi di Gallitelli. Molto stimati, però, dalla base dell’Arma.
Così, se il Capo di Stato
maggiore Ilio Ciceri è stato sostituto da Vincenzo Maruccia (anche lui sentito
come testimone dai pm di Roma per la vicenda Consip), e il generale Marco
Minicucci è stato sottoutilizzato, un altro pezzo da novanta come Alberto Mosca
ha dovuto cedere la poltrona di comandante della Legione Toscana a uno dei
pupilli di Del Sette, proprio Saltalamacchia, dovendosi accontentare del comando
della Legione Allievi Carabinieri. Clamorosa poi la scelta del colonnello
Roberto Massi: l’ex comandante dei Ros considerato uno degli ufficiali più
brillanti dell’Arma, e promosso da Gallitelli capo dell’ufficio legislativo nel
2014, dopo una breve convivenza con Del Sette ha preferito fare armi e bagagli e
trasferirsi all’Anas nel 2016. All’ente nazionale per le strade Massi ricopre
l’incarico di “responsabile della tutela aziendale”. L’unico gallitelliano che è
riuscito a stringere un patto di ferro con il comandante umbro è stato Claudio
Domizi, ancora influente capo del personale del primo reparto. «Le tensioni
interne sono iniziate fin dal suo arrivo, ma sono peggiorate nel tempo. La crisi
Consip le ha fatte solo esplodere», ragiona preoccupato un militare con le
stellette, che considera i colleghi gallitelliani veri responsabili della
spaccatura, perché nostalgici e incapaci di accettare il nuovo corso. Tutti,
però, mettono sul banco degli imputati anche il sistema della rotazione
obbligatoria degli ufficiali (che costringe pure i carabinieri più esperti e
capaci a cambiare reparto dopo due anni) e l’assenza di una vera meritocrazia
interna. «Qualche tempo fa a Reggio Calabria durante un giuramento a passare in
rassegna i reparti, oltre agli ufficiali, è stato anche un appuntato del Cocer,
il sindacato interno dei carabinieri a cui Del Sette si è molto appoggiato
dall’inizio del suo mandato», racconta uno degli scontenti «Forse a voi civili
sembra una sciocchezza, ma nell’Arma è una cosa inverosimile, che ha fatto
accapponare moltissime divise». Ottimi rapporti con Maria Elena Boschi e lo
stesso Lotti, qualche incontro con l’imprenditore renziano Marco Carrai (tra cui
una cena a casa del compagno di Mara Carfagna, Alessandro Ruben, che ama
invitare mimetiche e stellette nel suo salotto), Del Sette ha dovuto gestire
anche la patata bollente del colonnello Sergio De Caprio, “Ultimo”. L’attivismo
“anarchico” dell’ex vice comandante del Noe (che ha collaborato con il pm John
Woodcock a quasi tutte le inchieste più delicate degli ultimi anni su politica e
potere, da quelle sulle tangenti di Finmeccanica alla P4 di Luigi Bisignani,
passando dalle tangenti della Lega Nord a quelle sulla Cpl Concordia) non è mai
stato amato dai piani alti della Benemerita.
Ma la goccia che ha fatto
traboccare il vaso è caduta proprio nel luglio del 2015, quando una delle
intercettazioni del fascicolo sulla Cpl (una telefonata privata tra il generale
della Finanza Michele Adinolfi e Matteo Renzi in cui il segretario del Pd
definiva il suo predecessore Enrico Letta «un incapace») è finita in prima
pagina sul “Fatto Quotidiano”. Del Sette, dopo un mese di buriane politiche e
polemiche infuocate, deciderà di firmare una circolare che toglie ai
vicecomandanti dei reparti le funzioni di polizia giudiziaria. Una norma
considerata da molti “contra personam”. «Continuerete la lotta contro quella
stessa criminalità, le lobby e i poteri forti che le sostengono e contro quei
servi sciocchi che, abusando delle attribuzioni che gli sono state conferite,
prevaricano e calpestano le persone che avrebbero il dovere di aiutare e
sostenere», polemizzò senza mezzi termini “Ultimo” in una lettera di saluto ai
suoi uomini. Poi grazie alla mediazione dell’allora sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio Marco Minniti e del capo dell’Aise Alberto Manenti, De
Caprio a fine 2016 viene distaccato ai servizi segreti. Per la precisione
all’ufficio Affari interni, quello che controlla gli 007 italiani che righino
dritto. Se malumori e dissapori sono una costante di ogni struttura
gerarchica, la crisi dell’Arma supera i livelli di guardia a inizio del 2017.
Alle indagini sulla fuga di notizie si aggiungono prima quelle sul capitano
Gianpaolo Scafarto del Noe, accusato dai pm di Roma di aver falsificato le prove
nell’informativa. Poi quelle al suo capo Alessandro Sessa, numero due del
reparto, incolpato nientemeno per “depistaggio” per non aver detto la verità
(questa l’ipotesi della procura) durante un’audizione con i magistrati. Infine
il tentativo di ritrattazione dello scorso giugno di Luigi Ferrara, il manager
Consip che aveva tirato in ballo Del Sette come colui che lo aveva messo
sull’avviso in merito a un’indagine giudiziaria sull’imprenditore Alfredo Romeo
e la stessa Consip: dopo un confuso interrogatorio, in cui probabilmente il
manager ha cercato di proteggere proprio Del Sette, i pm hanno iscritto anche
Ferrara nel registro degli indagati. Per falsa testimonianza.
La crisi strutturale del corpo
“Nei Secoli Fedele” ha toccato nuove vette qualche giorno fa, quando i pm romani
hanno scoperto che Scafarto mandava documenti riservati sull’inchiesta Consip a
ufficiali ex Noe traslocati con “Ultimo” ai servizi segreti. L’ipotesi
investigativa è che questi stessero ancora collaborando alle indagini su Consip
portate avanti dagli ex colleghi. “Ultimo” e tutti i suoi uomini (De Caprio
aveva portato con se due dozzine di fedelissimi, di cui la gran parte
provenienti dal Noe) sono stati così allontanati dal nuovo incarico, e sono
rientrati nell’Arma. Un allontanamento avvenuto senza accuse formali da parte
della magistratura, e senza una richiesta esplicita di Manenti. È stato Marco
Mancini, un alto funzionario del Dis (il dipartimento che coordina le agenzie
d’intelligence) coinvolto in passato nel sequestro dell’imam Abu Omar a
chiederne la testa. Dopo aver scoperto che Scafarto e gli investigatori del Noe,
sempre nell’ambito dell’inchiesta Consip, lo avevano seguito e fotografato,
mandando ai collaboratori di “Ultimo” all’Aise le risultanze dei loro
appostamenti. L’incarico di Del Sette terminerà il prossimo gennaio. Ed è
probabile che il suo successore verrà nominato non dal governo Gentiloni, ma da
quello che entrerà in carica dopo le elezioni politiche, previste per la
prossima primavera. In pole position ci sono il numero uno del comando
interregionale Ogaden Giovanni Nistri (romano, tre lauree, giornalista
pubblicista, ex comandante del comando per la Tutela del patrimonio e direttore
del Grande Progetto Pompei, che ha ottimi rapporti con il Pd) e il generale
Riccardo Amato, numero uno della divisione Pastrengo ed esperto di antimafia,
che gode dell’appoggio del Quirinale. Subito dietro c’è Vincenzo Coppola
(chiamato “il paracadutista”, una vita in prima linea nelle missioni di
peacekeeping e da marzo promosso numero due dell’Arma), mentre il generale Ilio
Ciceri e Riccardo Galletta, capo della Legione Sicilia, sembrano avere tutti i
titoli necessari, ma meno chance. Il primo, considerato il miglior uomo macchina
possibile, sconta il peccato di essere considerato un gallitelliano, mentre il
secondo - all’inverso - un uomo di Del Sette. A chiunque toccherà, risollevare
l’Arma non sarà impresa facile.
Il caso Saguto non finisce
più. In
ballo un'altra toga antimafia, scrive Riccardo Lo Verso il 20 febbraio 2017 su
“Live Sicilia”. Il caso Saguto non è chiuso. Ci sono due informative che tirano
in ballo un altro giudice che lavora a Caltanissetta. Con tutta probabilità il
nuovo filone investigativo dovrebbe essere già approdato, per competenza, a
Catania. Nelle intercettazioni dei finanzieri del Nucleo di polizia tributaria
di Palermo sono finiti i dialoghi fra Giovanbattista Tona, Silvana Saguto e
Carmelo Provenzano. Tona oggi è consigliere della Corte d'appello nissena, in
passato da gip si è occupato anche delle stragi del '92, ed è uno dei magistrati
più impegnati sul fronte antimafia. Saguto è l'ex presidente della sezione
Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo travolta dall'inchiesta nissena,
il perno di un sistema che, secondo l'accusa, aveva trasformato la gestione dei
beni confiscati alla mafia in un affare di famiglia. Provenzano è uno degli
amministratori giudiziari che di quel sistema avrebbe fatto parte. Secondo i pm
di Caltanissetta, Provenzano era stato scelto da Saguto per prendere il posto di
Gaetano Cappellano Seminara, quando quest'ultimo iniziò ad essere troppo
chiacchierato. Passaggi delicati di cui Tona sarebbe stato a conoscenza.
L'ingresso di Provenzano nel sistema sarebbe coinciso con l'incarico nella
gestione degli impianti di calcestruzzo degli imprenditori Virga di Marineo. Una
procedura inizialmente assegnata a Giuseppe Rizzo che, secondo i pm, poteva
contare su un big sponsor, il colonnello della Dia Rosolino Nasca. Saguto
considerava Rizzo "un ragazzetto che non so come farà, adesso io devo nominare
un coadiutore giusto perché sennò". E gli venne affiancato Provenzano perché "è
un docente e non può dire niente nessuno". Professore alla Kore di Enna,
Provenzano è finito sotto inchiesta assieme alla Saguto. Si sarebbe speso, tra
le altre cose, per agevolare la carriera universitaria, laurea inclusa, del
figlio del giudice. Ad un certo punto, però, la coabitazione Rizzo-Provenzano
divenne impossibile. Provenzano aveva un piano per sbarazzarsi del concorrente e
ne parlò con Tona. L'esautorazione di Rizzo, per essere indolore, doveva
apparire come la conseguenza della sua inefficienza. Dovevano “trovare un modo
per dire che lui, la minchiata l'aveva fatta così grossa che lui scatti in
piedi”. Bisognava fare emergere “tutto quello che ha fatto male. Il problema non
è prendere incarichi, ma uscire con onore dagli incarichi”. Lo stesso Rizzo,
sentito dal pm Cristina Lucchini, ha dichiarato di avere capito che tra Saguto e
Provenzano c'era un rapporto confidenziale. Era Provenzano ad avere influenza
sul giudice e non viceversa, tanto che Rizzo fu costretto a mandare a casa tutti
i collaboratori che aveva scelto per fare spazio a quelli del professore. Ed è
nel contesto di questo rapporto di forza sbilanciato a favore di Provenzano che
si inserisce la figura di Tona e le due informative consegnate dai finanzieri ai
pm di Caltanissetta alla fine del settembre sorso. Vi sono annotate le
registrazioni dei dialoghi fra Provenzano e Tona di cui si fa cenno nell'avviso
di conclusione delle indagini notificato nei giorni scorsi a Saguto e agli altri
indagati. È ipotizzabile che sia avvenuta la trasmissione di questa parte
dell'inchiesta a Catania, competente quando in ballo ci sono magistrati i
servizio a Caltanissetta. Tona e Provenzano erano “amici”. Sarebbe stato il
giudice a indicare al professore la strategia per scalzare la concorrenza di
Rizzo. E il professore lo aggiornava passo dopo passo. Dalle conversazioni
trasmesse a Catania sembrerebbe emergere che il magistrato nisseno era bene
informato del modus operandi dei colleghi palermitani e anche dell'operato di
Cappellano Seminara.
PER IL CULO SI PRENDONO LE SUPPOSTE, NON LE
PERSONE.
La massoneria torna a fare paura: sono
tremila gli affiliati non identificabili. Dopo il caso
P2, le obbedienze avevano promesso trasparenza. Invece regna l’opacità assoluta
come dimostrano gli elenchi visionati dalla Commissione parlamentare sulle logge
calabresi e siciliane, scrive Gianfranco Turano l'8 febbraio 2018 su
"L'Espresso". Secondo Agatha Christie, un indizio è un indizio. Due indizi sono
una coincidenza. Tre indizi sono una prova. Nell’inchiesta della Commissione
parlamentare antimafia sui rapporti fra massoneria e crimine organizzato gli
indizi sono 2.993. Tanti sono gli affiliati alle logge calabresi e siciliane che
non è stato possibile identificare. Per un caso da manuale di eterogenesi dei
fini, il lavoro della Commissione ha trovato il suo risultato più clamoroso in
un contesto giuridico diverso da quello di partenza che era la caccia ai mafiosi
fra le colonne mistiche di Jachin e Boaz. I pregiudicati per 416 bis sono sei su
17.067 nominativi, una percentuale da beatificazione degli ordini massonici
rispetto a qualunque categoria professionale calabro-sicula. E le cose non
cambiano di molto se si considerano i 193 soggetti «aventi evidenze giudiziarie
per fatti di mafia... concluse in grande parte con decreti di archiviazione» o
le «25 posizioni per cui vi sono ancora processi pendenti». A tornare in ballo
nella relazione finale della Commissione è lo spettro della legge Anselmi sulle
associazioni segrete nata all’indomani dello scandalo P2, la loggia coperta
guidata dal Venerabile Licio Gelli con 962 affiliati, un terzo degli ignoti
trovati nelle liste sequestrate per ordine di Rosy Bindi, presidente
dell’Antimafia, il primo marzo del 2017. Per trentasei anni i dirigenti delle
varie obbedienze hanno giurato di avere stroncato il fenomeno delle affiliazioni
cosiddette all’orecchio o sulla spada cioè la pratica di occultare agli stessi
fratelli, con l’eccezione del gran maestro, l’identità di iscritti che dovevano
rimanere sotto il cappuccio. Lo hanno ribadito anche durante le audizioni
davanti alla Commissione e Stefano Bisi, gran maestro del Grande Oriente
d’Italia (Goi) lo ha anche detto sotto la forma dell’interrogatorio (18 gennaio
2017) ossia in una delle fasi in cui l’Antimafia è investita dei suoi poteri
giudiziari in base all’articolo della legge che la istituisce. Gli scontri
polemici di Bisi con la presidente Bindi, senese come il gran maestro del Goi,
sono stati i più accesi di tutte le audizioni. Esiste anche la possibilità che
il suo caso venga segnalato alla procura e che Bisi (appena assolto a Siena nel
processo Timeout, legato a Montepaschi) sia l’unico leader massonico a finire
indagato per falsa testimonianza in relazione alla segretezza degli iscritti e
alle vicende della loggia Rocco Verduci nella Locride, sospesa nel 2013 dopo
l’inchiesta “Saggezza” per disposizione del predecessore di Bisi, Gustavo Raffi,
e poi cancellata. Quel che si può dire fin da adesso è che nelle due regioni a
maggior rischio di infiltrazione della criminalità organizzata la trasparenza è
un sogno. I consulenti della Commissione, lo Scico della Guardia di finanza e i
magistrati Marzia Sabella e Kate Tassone, hanno suggerito che non si può
«escludere in maniera aprioristica fenomeni di mera superficialità nella tenuta
degli elenchi». Ma la trascuratezza qui è sistema. Ottanta nomi sono inseriti
con semplici iniziali, in parte riferibili a soggetti cancellati. Altri 1.883
presentano generalità incomplete e 1.030 sono «anagraficamente inesistenti»
perché non possono essere associati a un codice fiscale che riveli la certezza
dell’identità.
“Irriconoscibili” ovunque. In grandissima parte,
quindi, si tratta di fratelli attivi che, presumibilmente, partecipano alle
attività sociali e che pagano la quota annuale e i contributi in mancanza dei
quali si è passibili di sospensione e poi di espulsione. Esoterica quanto si
vuole, con i soldi la massoneria non scherza e intere logge sono state abbattute
perché non versavano il dovuto. Eppure proprio la più mistica delle obbedienze,
la Gran loggia regolare d’Italia (Glri) del gran maestro Fabio Venzi, successore
di Giuliano Di Bernardo, presenta il numero più alto di iscritti non
identificabili. Sono 1.515 nelle 25 logge calabresi e nelle 44 logge siciliane
su un totale di 1959 affiliati. La proporzione di fratelli non riconoscibili è
del 77,3 per cento.
La più grande obbedienza italiana, il Grande
Oriente d’Italia (Goi) ha 1185 nomi non identificabili, la Gran loggia degli
Alam ne ha 258 e 35 la piccola Serenissima guidata da Massimo Criscuoli Tortora
(appena 197 affiliati in tutta Italia di cui 60 nella sola Calabria). Il
confronto con la precedente inchiesta sulla massoneria italiana, di stampo
giudiziario perché condotta dalla Procura della Repubblica di Palmi e dal suo
capo di allora Agostino Cordova nel 1993-1994, lascia scarso spazio
all’ottimismo sulla voglia di trasparenza delle logge. Sui 5.743 nominativi di
massoni calabresi e siciliani analizzati da Cordova un quarto non era
identificabile. Oggi è il 17,5 per cento. Oltre vent’anni dopo il miglioramento
è trascurabile. Non solo, ma l’Antimafia segnala un passaggio inquietante.
«Premesso che gli elenchi agli atti della Procura di Palmi nel 1993-1994
riguardavano un novero di obbedienze in parte diverso e più ampio rispetto a
quelli oggetto di esame da parte di questa Commissione, va rilevato che vi è una
parziale discordanza tra di essi nella misura in cui non sono stati rinvenuti
negli elenchi acquisiti nel 2017, come noto riferiti a un arco di tempo che va
dal 1990 a oggi, taluni nominativi di soggetti all’epoca censiti e poi coinvolti
in fatti di mafia». È il caso dell’Asl di Locri commissariata per infiltrazioni
della “masso-’ndrangheta” e già al centro dell’omicidio mafioso di Francesco
Fortugno, vicepresidente del consiglio regionale, nell’ottobre del 2005. «Alcune
delle modalità di tenuta dei registri sequestrati alle quattro obbedienza
massoniche», dice il membro dell’antimafia Davide Mattiello (Pd), «fanno pensare
a pratiche di segretezza che nulla hanno a che fare con la riservatezza. Una
sostanziale pratica di segretezza e di irriducibilità all’ordinamento
repubblicano delle obbedienza massoniche desumibile anche da altre
caratteristiche raccontate dai gran maestri auditi in Commissione. Non poter
parlare di quel che si fa, non poter conoscere quel che si farà nei livelli
successivi del percorso iniziatico, né chi ci sia, non poter denunciare alla
giustizia profana un fratello colpevole, riservarsi un autonomo giudizio
massonico non riconoscendo validità alle sentenze della giustizia profana».
Tra esoterismo e fascismo. Fatte le
proporzioni, il dato più clamoroso riguarda l’obbedienza di Venzi (Glri) che
raccoglie il 63 per cento dei suoi 2400 affiliati nelle due regioni a massimo
rischio. Non è soltanto una questione numerica. La Glri è l’unica loggia
italiana a potersi fregiare del riconoscimento internazionale più ambito, quello
della Gran Loggia Unita d’Inghilterra (Ugle), vera casa madre della libera
muratoria per filiazione diretta dalle Costituzioni di Anderson del 1717. A
cavallo dello scandalo P2, che lo storico della massoneria Aldo Alessandro Mola
ha definito una loggia “speciale” del Goi, era proprio il Grande Oriente
d’Italia a godere del riconoscimento. Con l’uscita polemica e la scissione
dell’ex gran maestro Di Bernardo nel 1993, in piena tempesta Cordova, la Ugle ha
concesso il riconoscimento alla Regolare di Di Bernardo. Il suo erede Venzi,
sociologo esperto di esoterismo, di Julius Evola e di rapporti tra massoneria e
regime fascista che regna incontrastato sull’obbedienza dal 2001. Romano di
origini calabresi, Venzi è il più restio ai rapporti con la stampa. In audizione
ha messo in evidenza una volontà di massima di consegnare gli elenchi sua sponte
senza poi metterla in pratica, in modo simile ad Antonio Binni, gran maestro
degli Alam, e a differenza di Bisi che si è opposto fin dall’inizio. Per
rafforzare la sua posizione di trasparenza, Venzi ha dichiarato di presentare
due volte all’anno gli elenchi al ministero dell’Interno e in particolare alla
Digos per controlli. A prendere per vere queste parole, si dovrebbe concludere
che i controlli sono stati negligenti: oltre tre quarti degli iscritti alla
Regolare non sono identificabili. Venzi in audizione ha spostato il problema
sulle associazioni paramassoniche. «Bisogna verificare», ha detto il gran
maestro, «gli ambienti di Rotary, Lions e Kiwanis, dove massoni regolari e
irregolari si incontrano. La ’ndrangheta sceglie le obbedienze spurie piuttosto
che sopportare le nostre riunioni a carattere filosofico-culturale».
In nome di San Giovanni. La tempesta che investe
la massoneria sta portando alla luce un fenomeno che l’Antimafia non ha avuto il
tempo e la possibilità di verificare. La disgregazione di alcune obbedienze come
la Gran Loggia degli Alam, che avrebbe perso tremila affiliati sugli oltre
ottomila che Binni aveva dichiarato solo un anno fa alla presidente Bindi, sta
facendo proliferare nuove obbedienze e le cosiddette “logge di San Giovanni”.
Due fuoriusciti dagli Alam, l’ex gran maestro Luigi Pruneti e il numero tre
dell’obbedienza Sergio Ciannella, si sono messi in proprio ognuno con una loro
organizzazione all’inizio e alla fine del 2017. «Noi aspettiamo che si risolva
il contenzioso legale con Binni», dice Ciannella. «Se vinceremo ci riprenderemo
palazzo Vitelleschi, se no, resteremo dove siamo e cercheremo di lanciare un
discorso giuridico sull’articolo 18 della costituzione per stabilire i requisiti
fondamentali su che cosa è la libera muratoria in collaborazione con la
Serenissima, il Sovrano ordine massonico italiano e la Federazione del Diritto
Umano. Oggi chiunque può dirsi massoneria e certamente esiste una proliferazione
incontrollata di logge di San Giovanni. In parte, si spiega con la tendenza a
sfuggire alla tirannia del gran maestro, che è un dato tipicamente italiano,
mentre la massoneria nasce come loggia, non come obbedienza. In Svizzera il gran
maestro è un semplice coordinatore, non un monarca. In parte, però, c’è la
tendenza a coprire certe deviazioni malavitose che vogliamo e dobbiamo
combattere insieme a quelle che un tempo si chiamavano logge coperte». Bastano
sette fratelli, magari espulsi da un’altra obbedienza, a organizzare un nuovo
tempio. È a questo fenomeno che ha fatto riferimento il numero uno degli Alam
Binni quando in Commissione ha dichiarato che soltanto ad Arezzo esistevano 92
raggruppamenti massonici autonomi.
Obiettivo lobby. In Italia il fenomeno delle logge
di San Giovanni è così diffuso che è nata anche una federazione di queste monadi
massoniche, con tanto di sito web e pagina Facebook. Da anni il procuratore
aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, sta affrontando il fenomeno. Una
delle sue fonti principali è il collaboratore di giustizia Cosimo “Mino”
Virgiglio che si è dilungato sull’attività della sua Loggia dei garibaldini, fra
comitati d’affari, riti iniziatici da reality-show e ’ndrine di Gioia Tauro.
«Noi non riconosciamo», si difende Stefano Bisi, «associazioni come quella dei
garibaldini ed è motivo di provvedimento disciplinare frequentarsi in riti
misti, anche se fra obbedienze regolari. La massoneria irregolare noi l’abbiamo
sempre combattuta». Ma il fenomeno non è mai stato debellato. Come ha dichiarato
Virgiglio, l’obbligo di assistenza fra massoni va oltre l’appartenenza alle
obbedienze e, secondo quanto racconta all’Espresso un fratello di provenienza
Alam, sta tornando di attualità una riedizione perversa delle vecchie camere
tecnico-professionali della massoneria pre-gelliana, quando i fratelli si
riunivano per categorie di appartenenza (medici, giornalisti, avvocati) allo
scopo di presentare proposte agli iniziati che sedevano in parlamento.
Questo lobbying discreto in Calabria e in Sicilia ha visto partecipare migliaia
di iscritti dei quali non si conosce l’identità. Se si pensa che mafia e
’ndrangheta hanno da tempo esteso la loro attività imprenditoriale ben più a
nord del Pollino e che la Commissione non ha potuto approfondire le sue ricerche
nelle altre diciotto regioni, c’è da sperare che la prossima legislatura
continui il lavoro iniziato, anche se Bindi non si ricandiderà.
Mafia e ’ndrangheta unite dalle stragi:
«Così lo Stato scenderà a patti». L’uccisione nel ‘94
di due carabinieri collegata agli attentati decisi da Cosa nostra. La procura di
Reggio Calabria: «Gli attentati del 1993-1994 non vanno letti in maniera
isolata», scrivono Giovanni Bianconi e Carlo Macrì il 27 luglio 2017 su "Il
Corriere della Sera". A Gaspare Spatuzza, soldato fedele che aveva già
partecipato alla strage di Firenze del 1993 e si preparava a far saltare in aria
un camion di carabinieri allo stadio Olimpico di Roma (progetto poi fallito), il
capomafia Giuseppe Graviano l’aveva detto chiaro: «In Calabria si sono già
mossi». A colpi di mitraglietta: la stessa M12 che aveva ucciso due militari
dell’Arma - Antonino Fava e Giuseppe Garofalo - e ferito altri quattro in tre
diversi agguati fra il 18 gennaio e il 1° febbraio 1994. A sparare andarono due
giovani ‘ndranghetisti, uno all’epoca minorenne, che subito dopo l’arresto
dissero che trasportavano armi e non volevano essere fermati e controllati; un
depistaggio per coprire il disegno che la Procura di Reggio Calabria, nove anni
dopo la traccia delle prime dichiarazioni del pentito Spatuzza, ritiene di avere
svelato: un patto segreto tra Cosa nostra e ‘ndrangheta, con l’avallo di
massoneria e spezzoni di servizi segreti deviati, per aggredire le istituzioni e
costringere lo Stato a norme meno severe contro il crimine organizzato.
La presunta trattativa con le istituzioni,
insomma, si estende anche alle cosche calabresi, e ieri è arrivato un nuovo
ordine d’arresto per il boss stragista Giuseppe Graviano e per il capo
’ndrangheta Rocco Filippone, oggi settantasettenne, che secondo l’accusa
all’epoca dei fatti fece da tramite tra i capi dei clan e delle ‘ndrine nelle
riunioni riservate in cui si decise il ricatto allo Stato. Un’indagine avviata
su impulso della Procura nazionale antimafia al tempo della gestione di Pietro
Grasso, basata sulle dichiarazioni di decine di pentiti delle due organizzazioni
e sulle indagini della polizia, Servizio centrale operativo e Servizio centrale
antiterrorismo; ai mandanti degli omicidi e dei ferimenti dei carabinieri viene
contestata anche «la finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico».
Il disegno stragista che doveva condurre alla
trattativa fu infatti figlio — secondo questa ricostruzione — dei mutamenti
politici che caratterizzarono il biennio 1992-1994, ma in un certo senso cercò
anche di orientarli. Perché dopo la fine dei partiti tradizionali, sia la mafia
che la ‘ndrangheta si misero alla ricerca di nuovi referenti, e i boss
dell’isola avevano in testa la creazione di un gruppo chiamato Sicilia Libera. I
pm calabresi (il procuratore Federico Cafiero De Raho, l’aggiunto Giuseppe
Lombardo e il sostituto Di Bernardo) hanno acquisito e aggiornato l’inchiesta
sui cosiddetti «Sistemi criminali» archiviata dai colleghi palermitani, che
avevano scritto: «I vertici di Cosa nostra cambiarono cavallo abbandonando il
progetto autonomista di Sicilia Libera, poiché ritennero di avere avuto
sufficienti garanzie da un nuovo soggetto politico (che in effetti poi avrebbe
vinto le elezioni) sicché a questo nuovo movimento, Forza Italia, andò il loro
appoggio». All’esito della nuova indagine il pm Lombardo precisa che la
strategia stragista «si arresta o si depotenzia non appena i corleonesi, la
`ndrangheta e altre organizzazioni criminali trovano nel nuovo partito di Forza
Italia la struttura più conveniente con cui relazionarsi».
A confermare questa impostazione sono arrivate le
ultime registrazioni dei colloqui in carcere di Giuseppe Graviano, in cui il
boss si lascia andare (consapevole o meno di essere intercettato) a espressioni
di risentimento nei confronti di Silvio Berlusconi, «al quale rimprovera di non
aver rispettato sostanzialmente i patti», sottolinea il giudice nel
provvedimento di arresto. Che si sofferma anche sulla «straordinaria anomalia,
davvero macroscopica» sull’allentamento del «carcere duro» introdotto dopo le
stragi palermitane del 1992 con l’articolo 41 bis dell’ordinamento
penitenziario. Se nel ‘92 ci fu una sola revoca e una sola mancata proroga, che
nel ‘95 diventarono 2 e 2, nel 1993 si ebbero 122 revoche e 358 mancate
proroghe, mentre nei primi mesi del ‘94 ci furono 9 mancate proroghe. Numeri che
per il giudice segnano una coincidenza «non casuale» tra le stragi del ‘93 e gli
omicidi dei carabinieri di inizio ‘94 con quei provvedimenti, «sintomatici del
fatto che lo Stato aveva recepito le rimostranze degli stragisti, che avevano
così perseguito con successo il loro obiettivo».
Essenziale, perché il messaggio lanciato da mafia
e ‘ndrangheta alle istituzioni andasse a buon fine, era che la vera matrice
delle bombe e delle sparatorie restasse coperta. Ecco allora le firme della
fantomatica sigla Falange armata, utilizzata anche da appartenenti al servizio
segreto militare rimasto spiazzato dallo svelamento della struttura clandestina
di Gladio, che pure erano alla ricerca di nuovi referenti politici. Le indagini
dell’Antiterrorismo hanno portato alla luce tre rivendicazioni calabresi per gli
attacchi all’Arma, mentre il pentito Tullio Cannella ha ricordato che dopo le
bombe del luglio ’93 a Roma e Milano il boss corleonese Leoluca Bagarella «era
proprio vicino a me ad ascoltare il tg, e disse con soddisfazione e ironia:
“Vedi che ora queste cose le appioppano alla Falange armata”, poi disse ancora
con tono compiaciuto: “Vedi ora come gli brucia il culo a questi politici!».
Mafie, massoneria e servizi segreti
deviati: la congiura per rovesciare lo Stato. Le
stragi calabresi e siciliane con il marchio della Falange Armata. Dal 1990
nacque la "Cosa sola". 'Ndrangheta, Cosa nostra e le altre mafie decidono di
fare la guerra allo Stato, scrive Guido Ruotolo il 26 luglio 2017 su "Tiscali
Notizie". Quando il maresciallo della stazione dei carabinieri di Polistena aprì
la busta, quella fredda mattina del 4 febbraio del 1994, rimase di stucco.
Imprecò ma non capì. Lesse anche la firma «Falange Armata» e rimase
disorientato. «Quanto ci siamo divertiti per la morte dei due carabinieri
bastardi - era scritto con il normografo, con un carattere tremante su quel
foglio di carta stropicciato - uccisi sull'autostrada. È un inizio di una lunga
serie e mi auguro che a Polistena facciate tutti la stessa fine…cornuti e
bastardi e figli di puttana». Non capirono i carabinieri, e neppure gli
inquirenti quella rivendicazione. E neppure quelle tre telefonate tutte dello
stesso tenore: «Questo non è che l'inizio di una strategia del terrore».
Era il 18 gennaio del 1994 quando sull'autostrada
Salerno-Reggio Calabria, all'altezza di Scilla, furono uccisi i carabinieri
Antonino Fava e Giuseppe Garofalo. E prima, nella notte tra l'1 e il 2 dicembre
del 1993, e dopo, il 1 febbraio del 1994, altri quattro carabinieri rimasero
feriti. Tutti colpiti da una stessa mitraglietta M12. Uno dei due esecutori
materiali degli attacchi ai carabinieri spiegò che quegli omicidi o tentati
omicidi furono fatti per impedire che quelle pattuglie intercettassero tre
distinti carichi di armi. Anche per la mancata strage di via Fauro a Roma,
l'autobomba che doveva uccidere il giornalista Maurizio Costanzo, il 14 maggio
del 1993, e poi per le stragi di Firenze, Roma e Milano, arrivarono
rivendicazioni telefoniche della Falange Armata. Mai la Ndrangheta e Cosa nostra
avevano rivendicato un omicidio, una strage. E ora, leggendo le 976 pagine
dell'ordinanza di custodia cautelare del gip di Reggio Calabria, contro il boss
di Brancaccio, Palermo, Giuseppe Graviano, della cupola di Cosa nostra, e Rocco
Santo Filippone, esponente di spicco della Ndrangheta dei Piromalli, quali
mandanti dei tre attentati contro i carabinieri, si scopre che furono proprio
Cosa nostra e la Ndrangheta a rivendicare le stragi e gli attentati firmandosi
Falange Armata.
L'ipotesi (che sarà approfondita da nuove
indagini) della Procura reggina, del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo che
ha coordinato le indagini della squadra mobile e dell'Antiterrorismo, è che
furono uomini dell'ex Sismi, in particolare esponenti «del VII Reparto
cosiddetto “OSSI” che, fino a pochi mesi dopo la caduta del Muro di Berlino
(1989) si occupava di Stay Behind, (Gladio, l'organizzazione paramilitare che
doveva fronteggiare una eventuale invasione comunista, ndr) che, evidentemente,
volevano destabilizzare il Paese creando un nuovo allarme terroristico. Costoro,
che per anni avevano operato agli ordini di Licio Gelli, suggerirono alla
criminalità mafiosa e segnatamente, per primi, agli uomini della ndrangheta, di
rivendicare un omicidio di un funzionario dello Stato con la sigla “Falange
Armata”. Pochi mesi dopo, l'idea di usare questa rivendicazione, venne fatta
propria anche da Cosa nostra, nel corso della riunione di Enna (1991)».
Le indagini reggine aprono squarci e scenari mai
coltivati prima, né a Reggio Calabria né a Palermo, Firenze e Caltanissetta,
dove le procure hanno indagato sulle stragi di Palermo e del Continente e sulla
trattativa Stato-Mafia. E questi scenari in sostanza ipotizzano che le varie
mafie, anche la camorra e la Sacra corona unita, oltre che la Ndrangheta e Cosa
nostra abbiano deliberato una strategia comune di attacco eversivo e
terroristico contro lo Stato.
Per non essere equivocati, il gip ricorda che «la
matrice stragista (il riferimento è ai tre attacchi alle tre pattuglie di
carabinieri, ndr) frutto di un accordo tra Cosa nostra e la Ndrangheta, ha
l'obiettivo di rompere con la vecchia classe politica e colpire le istituzioni e
la società civile, nell'ottica di ottenere benefici a proprio favore in specie
in relazione all'applicazione del 41 bis». Forse è giunto il momento di mettere
in archivio vecchie «certezze». Intanto, dobbiamo retrodatare, e di molto,
all'agosto del 1990, la riunione in cui la Ndrangheta che parla con Cosa nostra
(un summit tra Ndrangheta e Cosa nostra si era già svolto a Milano) comunica al
suo “popolo” che la strategia comune in via di definizione prevede una offensiva
mia vista prima contro lo Stato.
Antonino Fiume, l'autista del boss (“capo
crimine”) reggino, Giuseppe De Stefano, mette a verbale che nell'estate del 1990
al Villaggio Blu Paradise, in provincia di Vibo Valentia, già si parlava di
adesione alla strategia stragista di Cosa nostra. E una conferma l'abbiamo con
la decisione di rivendicare gli attentati con la firma di Falange Armata. «Sul
finire del 1990 la Ndrangheta utilizza la rivendicazione falangista in relazione
all'omicidio dell'educatore carcerario Umberto Mormile (Lodi, 11 aprile 1990),
compiuto dal gruppo di fuoco lombardo dei Papalia perché l'educatore aveva
scoperto i rapporti che lo stesso Papalia aveva intessuto con gli apparati di
sicurezza». In conferenza stampa, il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo ha
ricordato che i pentiti attribuiscono a Antonio Papalia la decisione di
rivendicare l'omicidio Mormile con la sigla Falange Armata: «L'indicazione di
utilizzare la sigla in questione - sostiene il gip - veniva dai servizi di
sicurezza, Il Papalia, infatti, era persona scarsamente scolarizzata e del tutto
priva di strumenti culturali, pensare che potesse avere concepito una simile
rivendicazione equivale a formulare un periodo ipotetico del terzo tipo».
Quella presentata ieri in conferenza stampa dal
procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, dal procuratore di Reggio
Federico Cafiero De Raho e dagli investigatori della questura di Reggio guidata
da Raffaele Grassi, è solo un frammento di una inchiesta che deve ancora
esplorare nuovi territori. A partire dall'omicidio del sostituto procuratore
generale presso la Cassazione, Antonino Scopelliti, che doveva sostenere
l'accusa contro i capi mafia condannati all'ergastolo nel maxi processo a Cosa
nostra. Le carte reggine lasciano intravedere anche scenari politici che
maturano alla fine delle stragi del 93, cioè dell'inizio del '94 con il fallito
attentato e contro i carabinieri. Ci sono pentiti che raccontano che ben prima
della stagione delle leghe meridionali di Cosa nostra (Sicilia libera che si
presentano alle elezioni provinciali di Palermo e Catania nell'autunno del
1993), c'era stata quella della Ndrangheta con Calabria libera. E i magistrati
reggini vogliono capire perché la famosa riunione tra i movimenti
indipendentisti e leghista meridionali a cui aderiscono Livio Gelli e lo stesso
Vito Ciancimino si svolge a Lamezia Terme. E perché Totò Rina sceglie l'aula del
Tribunale di Reggio Calabria per pronunciare il proclama contro i
«tragediatori», i Lentini, Caselli, Violante. Insomma, l'inchiesta di Reggio
sembra un trattore diesel. Cammina piano ma vuole arrivare molto lontano.
Reggio Calabria, arresti e perquisizioni:
"Strategia comune di 'ndrangheta e Cosa nostra per le stragi mafiose".
Blitz condotto dalla Direzione distrettuale antimafia. In manette due elementi
di vertice: sono tra i mandanti degli attacchi contro i carabinieri tra il 1993
e il 1994. Le tre riunioni "preparatorie" e il racconto di Spatuzza su un
fallito attentato a Roma, scrivono Fabio Tonacci ed Alessia Candita il 26 luglio
2017 su "La Repubblica". Se la procura di Reggio Calabria ha visto giusto, un
pezzo di storia d'Italia va riscritto. Un pezzo delicatissimo e cruciale, a
cavallo tra il 1993 e il 1994, quando l'assetto dei partiti fu rivoluzionato
dalla discesa in campo di Forza Italia e nacque la Seconda Repubblica. Secondo i
magistrati, infatti, non furono solo i Corleonesi a compiere le "stragi
continentali", con le bombe in via dei Georgofili a Firenze, via Palestro a
Milano e San Giorgio al Velabro a Roma: alla strategia terroristica di
destabilizzazione dello Stato partecipò, su richiesta di Cosa Nostra, anche la
'ndrangheta, con tre attentati in Calabria che lasciarono a terra i due
carabinieri Antonino Fava e Giuseppe Garofalo (18 gennaio 1994) e ne ferirono
gravemente altri due. L'inchiesta si chiama, non a caso, "'ndrangheta
stragista". E' il frutto di un lavoro durato più di quattro anni, a cui si sono
dedicati principalmente il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, il sostituto
procuratore della Dna Francesco Curcio, e i poliziotti della Squadra Mobile
della Questura di Reggio Calabria. Sono stati riascoltati decine di pentiti e
collaboratori di giustizia, tra cui Antonino Lo Giudice e Giovanni Brusca.
Decisive per rileggere i fatti di quel biennio sono state le dichiarazioni rese
in altri processi da Gaspare Spatuzza, protagonista degli anni di sangue. Questa
mattina è stato arrestato nella sua casa di Melicucco Rocco Santo Filippone, 77
anni, a capo del mandamento tirrenico della 'ndrangheta ai tempi delle stragi e
tuttora "vertice della cosca Filippone, collegata alla più potente famiglia dei
Piromalli di Gioia Tauro, al quale è demandato il compito di curare le relazioni
con gli altri capi clan". Sono in corso una ventina di perquisizioni in tutta la
regione. Un mandato di arresto è stato notificato in carcere anche a Giuseppe
Graviano, il capo del mandamento palermitano di Brancaccio detenuto a Terni e
"coordinatore" delle stragi continentali. L'alleanza 'ndrangheta-Cosa Nostra per
mettere in ginocchio lo Stato e sostituire la vecchia classe politica "divenuta
inaffidabile" si consolidò attraverso loro due.
Fu il boss dei boss Totò Riina, secondo gli
inquirenti, a decidere di chiedere alla 'ndrangheta di cooperare alla strategia
del terrore. Dopo il suo arresto nel gennaio 1993, seguito alle stragi di Capaci
e Via D'Amelio, si tennero nell'autunno di quell'anno almeno tre importanti
riunioni in Calabria tra mafiosi e 'ndranghetisti: una in un villaggio turistico
in provincia di Vibo Valentia, cui parteciparono tutti i capi delle cosche; una
a Melicucco (alla presenza forse dello stesso Giuseppe Graviano); l'ultima a
Oppido Mamertina. Territorio dei clan Mancuso, dei Pesce, dei Mammoliti ma
soprattutto dei Piromalli, quelli che più avevano stretto i rapporti con i
Corleonesi. I calabresi decisero di aderire al piano dei siciliani. E per questo
organizzarono tre attentati contro i carabinieri, cioè contro quell'istituzione
dello Stato che aveva materialmente arrestato Totò Riina. Il primo, nella notte
tra il 1 e il 2 dicembre 1993, quando il commando composto da Giuseppe Calabrò,
Consolato Villani (entrambi già condannati) e Mimmo Lo Giudice (deceduto),
tentarono di uccidere due carabinieri a Saracinello con un mitra M12, senza
riuscirsi e senza neanche ferirli; il secondo, il 18 gennaio 1994, quando con la
stessa arma furono ammazzati sulla Salerno-Reggio Calabria, all'altezza di
Scilla, gli appuntati Fava e Garofalo; il terzo, l'agguato ai due carabinieri
Bartolomeo Musicò e Salvatore Serra, che non morirono ma rimasero gravemente
feriti.
E' in questo contesto che si inseriscono le
dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, affiliato della famiglia di Brancaccio dei
fratelli Graviano. Ai magistrati ha raccontato di un suo incontro con Giuseppe
Graviano al cafè Doney di via Veneto, a Roma, durante il quale il boss gli fece
capire che dovevano riprendere l'iniziativa, con qualcosa di sconvolgente.
"Abbiamo il Paese in mano, si deve fare per dare il colpo di grazia", mette a
verbale Spatuzza. "Graviano mi dice che dovevamo fare la nostra parte perché i
calabresi si sono mossi uccidendo due carabinieri e anche noi dovevamo dare il
nostro contributo. Il nostro compito era abbattere i carabinieri e quello era il
luogo dove potevano essercene molti, almeno 100-150". Quel luogo era lo Stadio
Olimpico di Roma. Il giorno fissato, secondo Spatuzza, era "il 22 gennaio 1994".
Un sabato. La macchina, una Lancia Thema riempita con 120 kg di tritolo, 30 kg
in più rispetto a quello usato in via D'Amelio. Ma il telecomando non funzionò.
Nonostante lo stesso Spatuzza premette più volte il pulsante, l'auto (che era
posizionata in viale dei Gladiatori, vicino alle camionette dei carabinieri) non
esplose.
Nell'indagine "ndrangheta stragista", cui hanno
partecipato anche il procuratore capo Federico Cafiero de Raho, il pm Antonio De
Bernardo, i poliziotti del Servizio centrale operativo, dell'Antiterrorismo
della polizia di Prevenzione, sono diversi "i fili" che vengono tirati dagli
inquirenti. Nelle mille pagine dell'ordinanza cautelare, infatti, si
ricostruisce l'intera strategia di destabilizzazione dello Stato, a cui erano
interessati in quei primi anni Novanta non solo 'ndrangheta e Cosa nostra:
vengono approfonditi i legami delle cosche con la massoneria, gli apparati
deviati dei servizi segreti (possibili ispiratori della strategia stragista) e
l'appoggio che le mafie offrirono alle leghe meridionali. Emergono anche gli
interessi della galassia dell'eversione nera e l'influenza che tutto ciò ebbe
sul nascente assetto politico dei partiti. "Sullo sfondo delle stragi - scrivono
i magistrati - appare chiara la presenza di suggeritori occulti da individuarsi
in schegge di istituzioni deviate, a loro volta collegate a settori della P2
ancora in cerca di rivincite".
Reggio Calabria, arresti e perquisizioni
contro la guida comune di 'ndrangheta e mafia.
L'inchiesta di Dda, Ros e Sco, anticipata dall'Espresso in gennaio, colpisce la
direzione strategica integrata fra Cosa Nostra e 'ndrangheta, unite nel decidere
l'attacco ai carabinieri fra la fine del 1993 e l'inizio del 1994. Tra gli
arrestati Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, scrive Gianfrancesco Turano
il 26 luglio 2017 su "L'Espresso". L'inchiesta anticipata dall'Espresso in
gennaio, colpisce la direzione strategica integrata fra Cosa Nostra e
'ndrangheta, unite nel decidere l'attacco all'Arma a cavallo fra la fine del
1993 e l'inizio del 1994, in una fase delicatissima della storia della
Repubblica italiana: il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica. In
territorio reggino le aggressioni ai carabinieri furono tre, dal dicembre 1993
al febbraio del 1994, con un bilancio di due morti (Fava e Garofalo) e due
feriti gravi (Musicò e Serra). Il passaggio successivo avrebbe dovuto essere
ancora più devastante con la strage dello stadio Olimpico a Roma, fallita per un
malfunzionamento del telecomando. Fra le tre richieste di arresto il nome più
famoso è quello di Giuseppe Graviano, palermitano di 53 anni. Il mafioso di
Brancaccio, insieme al fratello maggiore Filippo e all'affiliato Gaspare
Spatuzza, sono da anni al centro delle inchieste che cercano di fare luce sulla
stagione delle stragi. Della sua statura criminale non è lecito dubitare. Gli
indagati calabresi (Rocco Santo Filippone e il figlio Antonio), invece, sono
meno conosciuti, nonostante la lunga anzianità di servizio. Rocco Santo
Filippone, 77 anni, è nato ad Anoia, un paesino di 2 mila persone
nell'entroterra di Rosarno confinante con Melicucco dove Filippone è stato
arrestato. È la culla della 'ndrangheta, la piana di Gioia Tauro, dove le
affinità strutturali fra crimine calabrese e mafia siciliana dei feudi sono
assolute. Il volto contadino di questa 'ndrangheta non deve ingannare. I clan
della Piana sono in prima linea quando si tratta di rapporti con la politica e
di esportazione dell'impresa mafiosa verso il nord. Negli anni Settanta, il
trentenne Filippone si fa strada nelle gerarchie partendo dalla guardiania di un
terreno del Bosco in contrada Acquabianca. Il Bosco è la grande zona verde di
ulivi e agrumeti fra Rosarno e Gioia Tauro dove il governo Colombo, a seguito
dei Moti di Reggio del 1970-1971, ha deciso di impiantare il quinto centro
siderurgico. Filippone si trova coinvolto come mediatore nella principale saga
criminale di quel periodo. È la faida di Cittanova fra il clan Facchineri, già
sbarcato nella capitale dove ha stretto rapporti con il cassiere della Banda
della Magliana Enrico Nicoletti, e il gruppo rivale Gullace-Raso-Albanese. La
furia dello scontro è però inarrestabile. Ci saranno oltre 30 morti. Nel
frattempo, le vicende politiche si evolvono. Il centro siderurgico viene
abbandonato per la crisi dell'acciaio e sostituito con il progetto del porto di
Gioia Tauro sul quale presiedono gli uomini della famiglia Piromalli, la cosca
più potente della zona, se non la più potente in assoluto. Con il beneplacito
dei re della Piana Filippone organizza il suo gruppo che controlla l'area di
Cinquefrondi con i Bianchino e i Petullà e si federa con i Bellocco di Rosarno.
È una cosca satellite, non di primo piano, una delle tante che reggono quel
territorio con una dittatura feroce e che, come dimostrano gli arresti di un
mese fa ordinati dalla Procura di Roma, sbarca il lunario con il traffico di
droga. Il dinamismo di Filippone si esercita anche attraverso i nipoti, figli
della sorella che vivono a Reggio. Sono Giuseppe e Francesco Calabrò. Il primo
diventa un pistolero: è lui che aprirà il fuoco sui carabinieri Fava e Garofalo.
Il secondo si dà all'edilizia insieme al primo cugino, Giovanni detto il
marchese, e finirà sepolto con la sua macchina in fondo al porto di Reggio. Di
Filippone non si avranno tracce fino al 2011 quando l'operazione Artù della Dda
di Reggio, guidata al tempo da Giuseppe Pignatone, manda in carcere un gruppo di
'ndranghetisti che avevano tentato di cambiare un certificato di deposito falso
da 870 milioni di dollari al Credito Svizzero. Filippone viene arrestato e poi
rilasciato. Il processo è trasferito a Bologna per competenza territoriale,
visto che il consorzio finanziario-criminale aveva centro in Emilia. Alla fine
del 2016 ci sono stati i rinvii a giudizio, con Filippone a piede libero. Nella
riunione plenaria delle 'ndrine all'hotel Sayonara, quando i mafiosi calabresi
decisero di ritirarsi dalla strategia stragista, Filippone avrebbe svolto un
ruolo di tipo logistico ricevendo i siciliani sbarcati in Calabria per discutere
con i colleghi della 'ndrangheta l'attacco allo Stato. La parte qualificante
dell'inchiesta sta però nei contatti con il mondo dell'eversione unificata fra
massoneria segreta (loggia P2), servizi di informazione e quell'eversione
nera che, dagli ordinovisti fino alla Falange Armata, prese la laurea proprio
con i Moti di Reggio del 1970 e divenne, a braccetto con la 'ndrangheta, un
interlocutore di spessore per chi desiderava pregiudicare il processo
democratico nella fase della strategia della tensione. È questa la
cosiddetta componente riservata della 'ndrangheta dove i confini fra criminali e
uomini dello Stato sono troppo spesso spariti. L'operazione della Dda di Reggio,
da questo punto di vista, è ancora incompleta, come gli stessi magistrati
lasciano trapelare. Per mettere le mani sui traditori, gli uomini
dell'intelligence che hanno aiutato i criminali a insanguinare l'Italia, si
rimanda a una fase successiva dell'indagine.
Strategia comune 'ndrangheta e mafia,
l'atto di accusa dei giudici. Dopo il blitz
dell'Antimafia che ha portato agli arresti degli organizzatori degli omicidi dei
carabinieri del '94, ecco la ricostruzione degli investigatori, scrive
Gianfrancesco Turano il 26 luglio 2017 su "L'Espresso". L'ordinanza di custodia
cautelare che accusa Giuseppe Graviano, Rocco Santo Filippone e il
figlio Antonio, di 45 anni, inizia la sua ricostruzione dalla pagina oscura dei
tre assalti ai carabinieri nella zona di Reggio fra dicembre 1993 e febbraio
1994. Questa vicenda è stata riportata al centro delle investigazioni da un atto
di impulso della procura nazionale firmato dall'allora aggiunto Gianfranco
Donadio. Le dichiarazioni del killer dei carabinieri, Giuseppe Calabrò,
incaricato dallo zio Rocco Filippone, rappresentano una sostituzione del movente
tipica dei depistaggi. Calabrò disse che Fava e Garofalo erano stati uccisi
perché seguivano l'automobile carica di armi di Calabrò, guidata da Consolato
Villani, imparentato con la famiglia Lo Giudice, al tempo minorenne e oggi
pentito. In realtà, le tre aggressioni condotte in quaranta giorni segnalano il
coinvolgimento della 'ndrangheta nella strategia stragista di Cosa Nostra che
aveva colpito a Roma (via Fauro, San Giovanni in Laterano e Velabro), di Firenze
(via dei Georgofili) e di Milano (via Palestro).
I Graviano di Brancaccio erano già legati per
affari di droga alle 'ndrine della Tirrenica e chiesero ai calabresi di
partecipare alle stragi volute da Totò Riina in modo da “garantire e realizzare
i desiderata di Cosa Nostra” nel contesto del passaggio dalla Prima alla Seconda
Repubblica con le elezioni fissate il 28 marzo 1994 e la discesa in campo di
Silvio Berlusconi che in Calabria farà eleggere Amedeo Matacena junior, primula
rossa della latitanza a Dubai dopo la condanna definitiva per concorso esterno
in associazione mafiosa. Bisognava sostituire, dicono i magistrati: “una vecchia
ed ormai inaffidabile classe politica con una nuova, diretta emanazione delle
mafie”. E aggiungono: “i tre delitti, nella la loro apparente incomprensibilità,
come si vedrà, avevano dei tratti e delle tracce comuni, presentavano delle
simmetrie tali, da indurre a ritenere, ragionevolmente, che i loro autori non
agissero a caso o per sanguinaria imperizia, ma, piuttosto, seguissero un
copione ben studiato, un preciso cliché, che, per la verità, avrebbe potuto
consentire, già all'epoca dei fatti, a chi indagava su quelle vicende, di
poterle ricondurre ad un medesimo disegno criminale di stampo mafioso/
terroristico”. E più oltre: “Sia l'opinione pubblica, sia la classe dirigente
del paese, sia gli appartenenti all'Arma, dovevano intendere che il solo fatto
di indossare una divisa rappresentava un rischio che trasformava il militare in
un bersaglio. Ed è qui, proprio qui, attraversando questa linea di confine, che
si passa dalla logica criminale a quella terroristica. E venendo ad un episodio
più risalente nel tempo, in questa logica terroristica, come sarà poi
analizzato, a dimostrazione dell'ampiezza del disegno criminale di cui ci si
occupa, si poneva, anche, l'omicidio dell'Ispettore di PS Giovanni Lizzio in
servizio presso la Questura di Catania. Tale delitto avvenne il 27.7.1992 a
Catania per mano di sicari della famiglia Santapaola che così, all'epoca,
intesero aderire alla richiesta dei Corleonesi di attacco frontale allo Stato”.
“L'elaborazione di tale disegno eversivo (servente
rispetto a quello "politico") manifestò i suoi primi segnali di esistenza ben
prima dell'inizio della cd stagione stragista in un periodo che può essere
ricompreso fra due eventi determinanti nella presente ricostruzione, e cioè fra
la prima rivendicazione ( avvenuta nell'autunno del 90) a nome delle sedicente
organizzazione eversiva "Falange Armata", avvenuta in relazione all'omicidio
dell'educatore carcerario Umberto Mormile, delitto consumato vicino Milano,
nell'Aprile del 1990, per mano di sicari della potentissima cosca
calabro-lombarda dei Papalia che su richiesta di non identificati esponenti dei
servizi di sicurezza utilizzò quella sigla per rivendicare il delitto, e le
riunioni di Enna, dell'estate-autunno 1991, in cui i vertici di Cosa Nostra
iniziarono a elaborare la strategia stragista programmando che le rivendicazioni
dei futuri attacchi allo Stato sarebbero, pure, state eseguite con la ancora
sostanzialmente sconosciuta sigla "Falange Armata". Giova, ribadire nuovamente,
e sottolineare che, anche in relazione agli episodi oggetto della presente
trattazione risulta la rivendicazione "Falange Armata"... la stessa sigla
Falange Armata — poi utilizzata per rivendicare gli attentati materialmente
eseguiti dalle mafie - è stata ideata ed utilizzata da appartenenti infedeli ai
Servizi di Sicurezza, sia per regolare conti interni ai servizi stessi, sia per
essere messa a disposizione, inizialmente in funzione di depistaggio, delle
azioni criminali eseguite delle organizzazioni mafiose... il fatto che lo stesso
Paolo Fulci, già direttore del Cesis (proveniente però da una carriere diversa,
quella diplomatica) in quegli anni fu vittima (precisamente in un periodo
immediatamente successivo al disvelamento della struttura Gladio, ma precedente
alla stagione stragista) di gravissime minacce da parte di soggetti
riconducibili ai servizi di sicurezza (e, in particolare, come vedremo,
riconducibili alla cd VII Divisione del Sismi — struttura che istituzionalmente
si era occupata di organizzare e sovraintendere a stay behind e, quindi alla
struttura Gladio)”.
“Per il numero e lo spessore dei soggetti
intervenuti quella di Nicotera Marina fu sicuramente la più importante e
tuttavia, altri incontri (che per comodità possiamo definire "satellite") su
questo tema messo sul tavolo dai corleonesi, si svolsero in Calabria come
risulta da numerose dichiarazioni acquisite sul punto. Ed è importante dire che
in nessuna delle riunioni in questioni la `Ndrangheta prese, ufficialmente, una
posizione netta. Risulta che non vi fu mai, all'interno della `Ndrangheta
unitaria, una unanimità di vedute e che almeno all'epoca ed ufficialmente
(parliamo di un periodo che va dal 1990, passando per il 1991- in coincidenza,
sostanzialmente, con la riunione di Enna di cui si è detto, fino all'estate del
1992, cioè subito dopo la strage di Via D'Amelio, epoca in cui si svolse
l'incontro plenario di Nicotera Marina) venne in sostanza presa - salve alcune
eccezioni che poi vedremo - una posizione attendista. Insomma la `Ndrangheta nel
suo complesso, intesa come forza unitaria, cioè, per motivi tattici, sia esterni
(non si poteva opporre un rifiuto agli amici siciliani) che interni (si è detto
che non vi era unanimità di vedute) fece intendere ai siciliani di essere pronta
a collaborare se specificamente richiesta e se necessario, senza, però,
attivarsi motu proprio. La partita, in realtà, come vedremo, si giocava
sottobanco. Infatti, nel complessivo attendismo (quando non scetticismo) della
`Ndrangheta, dove molte famiglie e molte cosche, abituate ad una pacifica e
fruttuosa convivenza con lo Stato, erano restie ad azioni eclatanti, le famiglie
più potenti, invece, quelle che ruotavano intorno ai Piromalli/Molè ed ai De
Stefano-Tegano-Libri - che, non a caso, avevano, ad un tempo, i più profondi
legami con Cosa Nostra e con la massoneria deviata ( che in Italia aveva un nome
e cognome, certificato da sentenze e da atti di di Commissioni Parlamentari
d'Inchiesta : Licio Gelli ) —si muovevano nell'ombra, all'insaputa del resto
della consorteria. Davano rassicurazioni agli amici siciliani fino a organizzare
la riunione conclusiva di Melicucco a ridosso degli agguati ai Carabinieri, in
cui si dava il via operativo agli attacchi armati per cui è richiesta
cautelare”.
Madre contro figlio. Il ruolo di Filippone Maria
in relazione alla ritrattazione di Calabrò Giuseppe. La correttezza dell'assunto
appena riportato trova conferma nel contenuto della nota informativa della
locale Squadra Mobile, del 15 maggio 2015 (successivamente integrate con
ulteriori note informative di completamento e rettifica parziale, che si
allegano alla presente) che, ad evasione di specifica delega verbale di questa
Direzione Distrettuale Antimafia, ha collazionato e documentato alcuni specifici
passaggi dichiarativi, registrati in sede di intercettazione telefonica e
ambientale audio-video in carcere, riferibili a CALABRO' Giuseppe54 (operazioni
autorizzate nell'ambito del presente procedimento penale, giusta R.I.T. 262/14
D.D.A., in data 10.02.2014). Giova precisare, peraltro, che nel corso della
disposta attività di intercettazione, gli operatori di Polizia Giudiziaria hanno
avuto modo di appurare fattivamente tutta una serie di criptici rimandi
lessicali caratterizzati spesso da toni allusivi che, interfacciati con le
risultanze probatorie già evidenziate nel corpo degli ulteriori atti di
indagine, hanno consentito di mettere in evidenza le evidenti pressioni
esercitate dai familiari del CALABRO', ed in particolare dalla di lui madre
FILIPPONE Maria Concetta, al fine di costringere lo stesso a ritrattare le
dichiarazioni accusatorie rese in merito ai fatti per cui si procede,
interamente ricavabili dal verbale di trascrizione dell'interrogatorio dal
predetto reso in data 07 maggio 2014 presso la Casa Circondariale di Tempio
Pausania (Olbia), in qualità di testimone. Tale programma delittuoso non risulta
in alcun modo privo di rilevanza per il sol fatto che la prima missiva di timida
ritrattazione sia stata inviata a questo Ufficio in data 10 maggio 2014 e,
quindi, in data antecedente alle conversazioni di seguito riportate. Tale primo
accenno del CALABRO' alla sua intenzione di ritrattare le dichiarazioni
accusatorie rese in data 7 maggio 2014 va letto, invero, alla luce della
precedente missiva dell'8 maggio 2014 in cui il CALABRO' aveva comunicato a
questo Ufficio di voler confermare e rafforzare il suo contributo narrativo a
favore della condivisa strategia stragista di `Ndrangheta e Cosa Nostra. La
ritrattazione del 10 maggio 2014 è, quindi, il frutto della fortissima tensione
emotiva che vive il CALABRO' nel periodo immediatamente successivo alle
dichiarazioni gravemente accusatorie rese a questo Ufficio. Appare fisiologico,
invero, che il predetto dichiarante oscilli tra i propositi collaborativi e il
timore di coinvolgere i propri prossimi congiunti in vicende di elevatissima
rilevanza penale: tale assunto trova conferma letterale nelle parole che il
CALABRO' pronuncia in data 8 maggio 2014: "Sono cosciente che, al termine delle
mie affermazioni, molti miei congiunti saranno a rischio e, qualora ciò non
dovesse avvenire, comunque tutti si allontaneranno da me rinnegando il ‘grado di
parentela'. Appare evidente che il dichiarante senta un peso enorme sulle
proprie spalle, che si traduce in un proposito collaborativo ancor più forte il
giorno successivo alle dirompenti dichiarazioni del 7 maggio 2014 per poi
trasformarsi dopo qualche giorno in un ritorno al desiderio di non provocare
ricadute pesantissime sui soggetti chiamati in correità. Solo quando si registra
l'intervento minaccioso e deciso della madre, FILIPPONE Maria Concetta, il
detenuto, come di seguito documentato, abbandona definitivamente i suoi
propositi collaborativi a favore dell'Autorità Giudiziaria — destinati a fornire
ulteriori elementi di prova utili nell'ambito della presente indagine — per
adottare nuovamente la scelta di scontare il lungo periodo di detenzione ancora
residuo nel più assoluto silenzio. La palese condotta intimidatoria consumata da
FILIPPONE Maria Concetta è da ricondurre in primo luogo alla voluta e
programmata delegittimazione processuale del CALABRO', in grado di pregiudicare
il corretto inquadramento delle complesse dinamiche criminali sottostanti alle
azioni delittuose consumate in provincia di Reggio Calabria ai danni di
appartenenti all'Arma dei Carabinieri e, quindi, di individuare nella figura del
fratello FILIPPONE Rocco Santo e nel nipote FILIPPONE Antonino le ulteriori
figure a cui riconoscere un ruolo di assoluto rilievo causale nella consumazione
dei gravissimi delitti oggetto di contestazione in questa sede... Sin dal suo
esordio "tutto dietro…di ritornare tutto indietro.." la donna condiziona le
decisioni operative del figlio, esortandolo a tenere fede — nell'interesse
comune, quale elegante accezione della comune appartenenza alla organizzazione
di tipo mafioso — "fede... fedeltà...fedeltà", a comportarsi stoicamente in un
certo modo: "bocca chiusa... e non sbagli mai".
Stragi di mafia, l'altra verità sui veri
piani della 'ndrangheta. La malavita organizzata
calabrese insieme a Cosa Nostra siciliana nell'attacco allo Stato. Ma solo per
pochi mesi: poi gli interessi e le strategie sono cambiate. Ecco cosa svela
un'inchiesta che riscrive il passaggio alla Seconda Repubblica, scrive
Gianfrancesco Turano il 26 gennaio 2017 su "L'Espresso". Aggiornamento del 26
luglio 2017. La strategia stragista della ’ndrangheta dura appena due mesi:
dicembre 1993, gennaio 1994. Il 2 febbraio è tutto finito». Parla Federico
Cafiero de Raho, procuratore capo di Reggio Calabria. Non c’è altro che il
magistrato possa dire riguardo all’inchiesta di importanza colossale sui tre
attentati contro i carabinieri risalenti a 23 anni fa che, secondo quanto
risulta all’Espresso, sta per giungere alla conclusione. Partita come una sorta
di “cold case” dalle intuizioni di investigatori etichettati come visionari ed
emarginati per la loro determinazione ad andare in fondo, questa indagine è
diventata la chiave d’accesso ai misteri d’Italia nei sessanta giorni che
portano alla Seconda Repubblica. È una rilettura che investirà posizioni di
potere e personaggi rimasti attivi per decenni e, fino a oggi, nella zona
d’ombra dove i confini fra crimine organizzato e istituzioni non esistono più
per una tragica tradizione del potere in Italia iniziata ai tempi della
strategia della tensione, quasi mezzo secolo fa. Il lavoro che ha preso forma a
Reggio è frutto di un impegno collettivo durato anni fra Calabria e Sicilia
perché alla fine si è capito che la distinzione fra ’ndrangheta e Cosa nostra ha
senso solo a livello territoriale o mandamentale e non nella componente
riservata, quella legata con filo diretto alla politica in una fase di passaggio
delicatissima quale è stata la lunga e cruenta transizione dalla Prima
Repubblica, fra discese in campo e spinte autonomistiche estese dal
Lombardo-Veneto alle due regioni più a sud d’Italia. Sui nomi interessati
dall’inchiesta il riserbo è ovviamente assoluto. Ma il quadro può essere
delineato ricostruendo le attività di magistrati come Vincenzo Macrì e
Gianfranco Donadio, ex aggiunti della Dna, o come Francesco Curcio, attuale
sostituto alla direzione nazionale antimafia, e Giuseppe Lombardo, pm reggino
titolare dei fascicoli più delicati del rapporto ’ndrangheta-politica confluiti
da poco nel maxiprocesso battezzato Gotha. Tassello dopo tassello le parole dei
pentiti, fra i quali Gaspare Spatuzza, Consolato Villani e suo cugino Antonino
“il Nano” lo Giudice, potrebbero comporre lo scenario chiaro e definitivo nel
quale la cosiddetta ’ndrangheta ha agito come tecnostruttura terroristica, per
citare un’espressione di Donadio, in compartecipazione con gli apparati dello
Stato.
Il primo attentato avviene il 2 dicembre 1993. Dal
punto di vista criminale, è un fallimento. Il commando apre il fuoco contro una
pattuglia di carabinieri in servizio nei quartieri della periferia sud di Reggio
Calabria ma non centra il bersaglio. Il fatto rimane nelle cronache locali.
Il secondo episodio è un salto di qualità
terrificante sotto il profilo militare. Il 18 gennaio 1994, poco dopo le feste
natalizie, gli appuntati scelti Vincenzo Garofalo, 33 anni di Scicli, sposato
con due figli, e Antonino Fava, 36 anni di Taurianova, capoequipaggio, anch’egli
sposato con due figli, scortano fino al tribunale di Palmi un magistrato in
arrivo dalla Sicilia. Attendono di riaccompagnarlo ma l’incontro negli uffici
giudiziari si prolunga e la centrale operativa manda l’Alfa 75 dell’Arma in
pattugliamento sull’autostrada. Una decina di chilometri a sud di Palmi, in un
tratto in discesa e con varie gallerie fra gli svincoli di Bagnara e Scilla, i
carabinieri notano un’auto sospetta. Prima che possano intervenire, vengono
affiancati da un’altra macchina e investiti lateralmente da decine di colpi di
Beretta M12, un’arma automatica. L’Alfa 75 finisce contro il guard rail. Gli
assassini scendono e sparano ancora, stavolta frontalmente, dal parabrezza.
Infieriscono con una valanga di piombo a compensazione del fallimento del 2
dicembre. Una telefonata rivendica l’azione. Si saprà dopo che a chiamare è
Villani, autista del commando. Pentito del clan De Stefano, Villani ha
dichiarato al processo Meta otto mesi fa: «Dovevamo fare come la Uno bianca». Il
riferimento è alla catena di delitti commessi dai fratelli Savi, poliziotti, a
Bologna e dintorni. Il massacro dell’A3 provoca un effetto enorme. A Reggio
arriva il comandante dell’Arma Luigi Federici e annuncia la mobilitazione
generale. Il cronista di Repubblica scrive senza mezzi termini che il massacro
dell’autostrada è «il tassello di un disegno criminale terroristico-mafioso». Ci
vorranno anni perché la definizione trovi riscontro giudiziario. E lo trova in
Sicilia nell’autunno 2009, grazie alle dichiarazioni rese dal pentito Gaspare
Spatuzza a Caltanissetta.
«Spatuzza aveva notizie frammentarie sulle
operazioni contro i carabinieri desunte da colloqui con il suo boss Graviano»,
dice Antonio Ingroia che da pubblico ministero ha raccolto le parole del pentito
insieme al collega Nino Di Matteo e che oggi da avvocato è difensore di parte
civile delle vedove di Fava e Garofalo. «Sa però che il duplice omicidio
dell’autostrada fa parte di una reazione concertata contro l’Arma». Dopo il
massacro di Scilla Graviano dice a Spatuzza che i calabresi si erano mossi e che
adesso toccava a loro. Inizia così la preparazione della strage dell’Olimpico,
dove un’autobomba deve esplodere in una domenica di calcio vicino a un pullman
dei carabinieri. Una prima versione, definita dal procuratore antimafia Piero
Luigi Vigna, fissa l’attentato al 31 ottobre 1993 durante Lazio-Udinese, dunque
prima delle operazioni in Calabria. Successive indagini spostano la data al 9
gennaio 1994 (Roma-Genoa) e infine al 23 gennaio (Roma-Udinese). L’attentato non
va a segno per un malfunzionamento del telecomando dell’autobomba. L’operazione
non sarà ripetuta perché i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano vengono
arrestati il 27 gennaio 1994, quattro giorni dopo la partita di Roma e circa un
anno dopo Totò Riina. Il 26 gennaio 1994, mercoledì, Silvio Berlusconi annuncia
in televisione la sua discesa in campo con Forza Italia, il partito-azienda
organizzato in pochi mesi da Marcello Dell’Utri.
Ma in Calabria non è ancora finita. Alle 20.35 del
primo di febbraio 1994 una pattuglia in servizio sulla tangenziale di Reggio,
nei pressi dello svincolo di Arangea, nota una macchina ferma. È l’ora di punta
e il veicolo in sosta è un rischio per la circolazione. I militari, Bartolomeo
Musicò e Salvatore Serra, scendono per un controllo e vengono accolti da una
tempesta di proiettili: fucile a canne mozze e machine pistol Beretta M12, la
stessa dei delitti precedenti. Feriti in modo grave, i carabinieri si salvano
soltanto perché i killer, a differenza di quanto accaduto a gennaio
sull’autostrada semideserta, non possono fermarsi per il colpo di grazia.
Rischiano di finire incastrati nel traffico. I due soldati si salveranno. L’Arma
non tarda a reagire. Il 5 maggio 1994 vengono arrestati per gli assalti ai
carabinieri Giuseppe Calabrò, Consolato Villani, ancora minorenne, e i presunti
armieri. Calabrò e Villani incominciano a collaborare. In sostanza, confessano.
Hanno sparato loro ed erano solo loro due quella notte d’inverno
sull’autostrada: Villani guidava, Calabrò sparava. Ma operano una sostituzione
del movente che condizionerà l’esito del processo: l’assassinio di Fava e
Garofalo sarebbe stata la reazione d’impulso per evitare un controllo a un’altra
auto di mafiosi che trasportava un carico di armi da guerra prelevate a Gioia
Tauro. Gli investigatori seguono la pista del M12. Si scoprirà che la
mitraglietta è un’arma prodotta per esigenze sceniche del cinema o della tv,
senza marchio né matricola. Esce dalla catena di montaggio devitalizzata e viene
rimessa in condizioni di normale funzionamento senza troppo sforzo dagli armieri
delle ’ndrine. Pochi mesi dopo il massacro, gli uomini della Dia di Milano
trovano anche il deposito dal quale provengono le armi sceniche. È in un
capannone in Val Trompia nel bresciano, nel distretto produttivo della Beretta.
Poi la traccia viene abbandonata. Le acque si calmano, salvo gli ultimi fuochi
della banda della Uno bianca che arriva al capolinea con gli arresti di Roberto
e Fabio Savi nel mese di novembre. Il 7 dicembre 1994 viene inaugurata a Reggio
la scuola allievi carabinieri, intitolata a Fava e Garofalo. Le due vedove
ritirano la medaglia d’oro al valor militare. Oltre quindici anni dopo sarà
Donadio a riprendere la pista delle armi sceniche con l’aiuto di Francesco
Piantoni e Roberto De Martino, i colleghi della procura di Brescia che si sono
occupati della strage di piazza della Loggia.
Villani ha 17 anni. È un debuttante del crimine ma
la sua famiglia ha solide tradizioni di ’ndrangheta ed è imparentata con i Lo
Giudice, un clan di Reggio nord schierato con i Condello-Imerti-Serraino e
contro i De Stefano-Tegano-Libri nella guerra da 700 morti finita nell’estate
1991, a ridosso dell’omicidio del giudice Antonino Scopelliti. Calabrò, che al
tempo ha 22 anni, ha invece già una storia di sangue alle spalle. Si propone
come uomo d’armi alla cosca di Reggio sud Ficara-Latella, schierata con il clan
De Stefano-Tegano-Libri nella guerra. Viene accettato con riluttanza perché ha
un profilo poco ortodosso. Gli piace esibire la sua mafiosità. Ama
’ndranghetiare, come si dice in Calabria. In compenso ha il grilletto facile
tanto che viene soprannominato “Scacciapensieri” per la leggerezza d’animo con
la quale esegue gli incarichi dei capi. Senza troppe domande ha sparato quindici
colpi in pieno giorno e in centro per ammazzare un vigile urbano, Giuseppe
Marino. Qualche giorno prima Marino aveva osato multare l’auto di un boss per
divieto d’accesso alla zona pedonale del corso Garibaldi. La cosca tiene Calabrò
a distanza di sicurezza perché lo considera instabile, come il fratello
Francesco, coinvolto anch’egli nell’assalto ai carabinieri, pentito e subito
bollato come psicopatico da una perizia ad hoc. Quando il processo inizia,
Giuseppe Calabrò collabora. Il tribunale decide che è credibile quando si accusa
ma non è credibile quando accusa gli altri. Il verdetto (febbraio 1997) condanna
all’ergastolo il killer mentre Villani viene affidato al giudice del tribunale
dei minori Domenico Santoro, poi gip nel processo Mammasantissima. Nel 1998
Calabrò viene spedito agli arresti domiciliari a Bologna. Lì evade e in mezzo
alla folla del Natale ammazza due bangladeshi che, secondo lui, avevano stuprato
la sua ragazza due anni prima. Il processo chiarirà che nel 1996 le vittime non
erano neppure in Italia. Condannato all’ergastolo, stavolta in via definitiva,
nel 2011 Calabrò pubblica il libro-memoriale “Una scia di sangue” con la
prefazione di uno dei giudici più potenti del tribunale di Reggio, Giuseppe
Tuccio, allora garante dei diritti dei detenuti su nomina del governatore
regionale Giuseppe Scopelliti. Quando esce il libro di Calabrò, il fratello
Francesco, che nel frattempo è diventato imprenditore, è già scomparso da cinque
anni (2006). I suoi resti saranno trovati ad aprile del 2013, dentro una Smart
gialla affondata nel porto di Reggio. Anche il primo cugino di Giuseppe Calabrò,
Giovanni detto “il marchese”, diventerà un imprenditore, ma di notorietà
internazionale con appoggi in Russia, Kazakhistan e un rapporto diretto con il
presidente turco Tayyip Erdogan. Amico del governatore della Liguria Giovanni
Toti e debitore del Comune di Roma per 36 milioni di euro, Calabrò ha fatto
parlare di sé l’anno scorso grazie al tentato acquisto del Genoa calcio da
Enrico Preziosi, prima di essere condannato in secondo grado a sei anni per la
bancarotta dell’Algol dal tribunale di Busto Arsizio nell’aprile del 2016.
A cavallo fra il 1993 e il 1994 matura un
mutamento politico di grande importanza a livello nazionale. È in arrivo Forza
Italia, che troverà in Calabria il suo coordinatore in Amedeo Matacena junior,
oggi latitante a Dubai per sfuggire a una condanna definitiva per concorso
esterno in associazione mafiosa e per le sue frequentazioni con il clan De
Stefano, ribadite di recente in aula dal pentito Nino Fiume. Di qua e di là
dello Stretto, stanno crescendo le proposte autonomistico-secessioniste con le
Leghe del Sud. L’ipotesi investigativa è che l’attacco all’Arma sia inquadrato
in un’ipotesi di autonomismo eversivo. A decidere la strategia è una commissione
ristretta dove i siciliani, autori delle stragi del 1992 (Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino) e del 1993 (Roma, Firenze, Milano) concordano la linea con i
rappresentanti dei due principali clan calabresi: i De Stefano di Reggio e i
Piromalli di Gioia Tauro. Dopo gli assalti ai carabinieri, però, le famiglie
della ’ndrangheta chiedono una riunione plenaria di tutta la provincia nel luogo
dove per tradizione si svolge questo tipo di summit: il santuario della Madonna
della Montagna a Polsi, in Aspromonte. Il dissenso delle altre famiglie verso la
strategia stragista è netto ed esplicito. La ’ndrangheta ha interesse a crescere
e a prosperare economicamente, non a guerreggiare con la Repubblica italiana.
Bisogna smetterla subito di attaccare l’Arma per rientrare nei ranghi e
amministrare il nuovo potere all’orizzonte dall’interno, come la vera mafia ha
sempre fatto, individuando referenti politici nell’ordine emerso dalle elezioni
politiche del 28 marzo 1994 dove, fra gli altri, è eletto anche Matacena. La
mozione di maggioranza è accolta, e forse con sollievo, anche da parte di chi
aveva iniziato a seguire i siciliani sulla via dello scontro totale.
I Piromalli e i De Stefano non sono gente nuova al
protagonismo politico. Già nel 1970, con i Moti per Reggio capoluogo, hanno
strumentalizzato la rivolta popolare in parallelo con l’estrema destra del
golpista Junio Valerio Borghese (Fronte nazionale) e del fondatore di
Avanguardia nazionale Stefano Delle Chiaie. Ma anche lì hanno saputo tirarsi
indietro quando i finanziamenti statali sono piovuti su Reggio città e su Gioia
Tauro per il centro siderurgico, poi diventato il porto. Dal febbraio 1994, il
crimine calabrese tornerà sott’acqua per diventare in pochi anni
l’organizzazione più ricca e potente del mondo. Che poi sia davvero ’ndrangheta
è una questione nominalistica. Il boss Pasquale Condello “il Supremo”, al
momento del suo arresto nel 2008 ha dichiarato: «Chiamatela come volete:
’ndrangheta, se siamo in Calabria. Ma se eravamo in Svezia si chiamava in un
altro modo». E Giuseppe De Stefano, erede al 41 bis del clan reggino
protagonista dei Moti e di due guerre da mille morti, ha affermato in udienza al
processo Meta: «Noi non siamo ’ndrangheta». E non voleva dire: siamo pacifici
cittadini. Intendeva: siamo ben altro, siamo molto di più.
Il caso dei carabinieri rimane chiuso dalla
sentenza del 1998 fino al 2011, quando in Dna lavora come aggiunto Macrì, poi
sostituito dall’altro reggino Alberto Cisterna. Macrì è il primo e forse il più
acuto analista dei legami fra la ’ndrangheta e lo Stato. È lui a inquadrare la
figura di Calabrò nel contesto dei legami fra la cosiddetta ’ndrangheta e gli
apparati dello Stato. In questo ambito sta già prendendo forma l’intuizione
investigativa di Donadio, anch’egli alla Dna, su “Faccia da mostro”, il
poliziotto coinvolto nell’omicidio del collega Antonino Agostino. Prima delle
ferie estive del 2012, l’aggiunto di Reggio Michele Prestipino manda in Dna
un’informativa con una lettera anonima che inquadra gli assalti ai carabinieri
del 1993-1994 in una riedizione dell’eterna strategia della tensione italiana.
Il 18 settembre 2012 un ex compagno di cella di Calabrò dice che la lettera è
del killer. L’11 ottobre Donadio interroga in carcere Villani che, alla fine di
un colloquio senza sostanza, mentre il magistrato sta uscendo dalla stanza, lo
ferma: «Dottore, non ve ne andate». E racconta i fatti allineandosi ai contenuti
della lettera. Calabrò viene interrogato a Bollate il 27 novembre 2012.
Esordisce dicendo a Donadio: «So perché mi avete contattato». Conferma il
contenuto della lettera, ammette che è sua ma si blocca quando sente parlare dei
De Stefano.
Un terzo collaboratore entra in scena. È Nino Lo
Giudice. Le sue prime dichiarazioni (14 dicembre 2012) sono fondamentali per
identificare Faccia di mostro ossia il poliziotto Giovanni Aiello, che si gode
la pensione dello Stato a Montauro Lido, poco a nord di Soverato. Il Nano dice
fra l’altro di essere in contatto con il capocentro del Sismi (i servizi
militari) Massimo Stellato e che Aiello gli è stato presentato dal capitano dei
carabinieri Saverio Spadaro Tracuzzi, uomo della Dia arrestato a dicembre del
2010 per concorso esterno in associazione mafiosa e condannato in secondo grado
a 10 anni nel maggio del 2016 insieme a Luciano Lo Giudice, fratello di Nino il
Nano. Consapevole del rischio che corre, Lo Giudice si dà malato al colloquio
successivo, fissato prima di Natale, poi scrive alcuni memoriali dove calunnia
Donadio, Cisterna, Prestipino, lo stesso procuratore capo del tempo Giuseppe
Pignatone, e a giugno 2013 scompare dalla località delle Marche in cui vive
sotto il programma di protezione. Il caos organizzato di Lo Giudice ottiene
risultati notevoli. Il 6 settembre 2013, il nuovo procuratore capo della Dna,
Francesco Roberti, entrato in carica da un mese, ritira le deleghe a Donadio
che, sotto procedimento disciplinare, si trasferisce alla Commissione Moro. Ma
l’indagine procede a Reggio con Cafiero e Lombardo che lavorano su un arco
temporale molto ampio. I primi risultati si vedono nel 2016, quando gli avvocati
Giorgio De Stefano e Paolo Romeo, già condannati come Matacena per concorso
esterno, tornano in carcere con nuove accuse che non configurano un ne bis in
idem. Lo stesso accade con il fascicolo sulle stragi dei carabinieri. Condannati
gli esecutori materiali, l’inchiesta riparte dai mandanti e dai moventi reali,
molto diversi dalle follie individuali di un pistolero. «Siamo stati
manipolati», conclude il pentito Villani. Stavolta sono i traditori dentro lo
Stato a tremare.
La 'ndrangheta stragista che voleva
attaccare lo Stato. In carcere i boss Filippone e
Graviano, mandanti dell'omicidio dei brigadieri Fava e Garofalo. Quei delitti,
svela la Dda, erano parte di una strategia mirata a destabilizzare l'Italia. Gli
incontri con gli emissari di Riina e il sì dei clan al progetto di aggressione
alla democrazia. Le rivelazioni "calabresi" di Spatuzza, scrive Mercoledì, 26
Luglio 2017, Alessia Candito su "Il Corriere della Calabria". Negli anni Novanta
c’era un piano per destabilizzare l’Italia ma a portarlo avanti non è stata solo
Cosa Nostra. Anche la ‘ndrangheta ha fatto la sua parte. Per questo motivo,
questa mattina la Squadra Mobile di Reggio Calabria ha stretto le manette ai
polsi di due elementi di spicco dei clan calabresi e siciliani. In carcere
è finito Rocco Santo Filippone, elemento organico al potentissimo clan Piromalli
di Gioia Tauro, ed è stata notificata una nuova ordinanza di custodia cautelare
in carcere a Giuseppe Graviano, capomafia del mandamento di Brancaccio,
Palermo. Per il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo della Dda di Reggio
Calabria, sono loro i mandanti dell’omicidio dei carabinieri Antonio Fava e
Giuseppe Garofalo, trucidati nei pressi dello svincolo di Scilla il 18 gennaio
1994, e dei due agguati che nei giorni successivi sono quasi costati la vita ad
altri quattro loro colleghi, Bartolomeo Musicò e Salvatore Serra, feriti alla
periferia sud di Reggio Calabria il 1 febbraio, e Vincenzo Pasqua e Salvo
Ricciardo, rimasti miracolosamente illesi dopo l’attentato subito il 1 dicembre
del ’93. Tutti delitti – ha svelato l’indagine coordinata dal procuratore
Lombardo insieme al sostituto della Dna, Francesco Curcio – che si inscrivono in
una strategia di attacco allo Stato, che dopo i brutali attentati costati la
vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ha continuato a mietere
vittime anche fuori dalla Sicilia. E non solo a Firenze, Roma e Milano. C’è
stata una tappa calabrese nella strategia degli “attentati continentali”,
concordata dai vertici delle mafie tutte. Un piano funzionale alla costruzione
dello Stato dei clan. Sono in corso di esecuzione anche numerose perquisizioni
in diverse regioni d’Italia. Alle operazioni eseguite dalla Squadra Mobile di
Reggio Calabria, dal Servizio Centrale Antiterrorismo e dal Servizio Centrale
Operativo della Polizia di Stato, partecipano anche i Carabinieri del Comando
Provinciale di Reggio Calabria. I particolari dell’operazione saranno resi noti
nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 nella sala convegni
della Questura di Reggio Calabria, alla presenza del Procuratore Nazionale
Antimafia e Antiterrorismo Franco Roberti dei magistrati inquirenti e degli
investigatori. A oltre vent’anni di distanza dal brutale omicidio dei
carabinieri Fava e Garofalo e dal ferimento rimasto senza perché dei loro
quattro colleghi, si ricompone in un quadro inquietante quello che all’epoca fu
considerato un delitto da balordi. Per arrivarci, i magistrati hanno ascoltato
centinaia di boss, pentiti e non, hanno fatto sopralluoghi, cercato riscontri,
incrociato informative. Perché fra le pieghe di indagini del passato, più di
un’indicazione era già affiorata. Oggi però, tutti quegli elementi sparsi
trovano unità in un quadro inquietante che tiene insieme le mafie tutte, pezzi
deviati dei servizi, ambienti piduisti e galassia nera. Tutti responsabili –
affermano i magistrati di Reggio Calabria – di aver tentato di sovvertire
l’ordine repubblicano in Italia. Un piano che in Calabria è stato oggetto di
almeno tre riunioni, la prima al villaggio turistico Sayonara di Nicotera,
controllato dal clan Mancuso di Limbadi, legato a doppio filo al potentissimo
casato mafioso dei Piromalli, le altre due a Oppido Mamertina. Al tavolo,
c’erano i massimi esponenti dell’epoca della ‘ndrangheta calabrese e gli
“emissari” siciliani di Totò Riina. Storicamente legato ai Piromalli, storico
casato di ‘ndrangheta che vanta legami con la Sicilia fin dalle prime decadi del
Novecento, il boss siciliano si era rivolto a loro per “convincere” i massimi
vertici delle ‘ndrine ad aderire alla strategia degli attacchi continentali.
IL PROGETTO Questo tuttavia – emerge dall’indagine
della Dda reggina – non era che un aspetto parziale di un piano ben più ampio e
complesso, da maturare in più fasi, iniziato a maturare qualche anno prima. A
svelarlo negli anni scorsi erano stati collaboratori di giustizia come Antonio
Galliano e Pasquale Nucera, che avevano parlato ai magistrati del progetto delle
mafie di «destabilizzare lo Stato». Un progetto cui la ‘ndrangheta non ha
lavorato da sola.
«Parallelismo inquietante tra politica e
strategia stragista». Il procuratore aggiunto di
Reggio, Lombardo, durante la conferenza stampa sugli arresti di Filippone e
Graviano. «Dopo la vittoria Forza Italia diventa il referente delle mafie».
Curcio: «Vittime scelte perché simboli dello Stato». Roberti: «Con l’indagine si
è aperto uno squarcio di verità importante per la giustizia, le vittime e la
democrazia», scrive Mercoledì, 26 Luglio 2017, Alessia Candito su "Il Corriere
della Calabria". «Oggi collochiamo la ‘ndrangheta nel suo giusto ruolo». È
soddisfatto il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo. A poche ore
dall’esecuzione dell’indagine “Ndrangheta stragista”, dalle sue parole traspare
l’orgoglio per un’inchiesta complessa, da più parti osteggiata perché
considerata “visionaria” o “romanzata” ma in cui tanto la Dda reggina, come la
Procura nazionale antimafia, hanno sempre creduto. Un’inchiesta che oggi
riscrive un pezzo della storia dell’Italia repubblicana. Non è vero, come per
anni è stato da più parti sostenuto, che la ‘ndrangheta abbia detto no alle
richieste di partecipazione alla strategia stragista. Al contrario, vi ha
partecipato attivamente. E per una motivazione molto semplice. Quella lunga scia
di sangue voleva essere prodromica a un mantenimento dell’influenza delle mafie
tutte sullo scenario politico italiano. L’omicidio dei brigadieri Fava e
Garofalo e il tentato omicidio di altri quattro militari dell’Arma in quei
tumultuosi anni Novanta dovevano essere un messaggio, o meglio parte di un
messaggio. «Le vittime di quegli attentati non sono state scelte, al contrario
di quanto successo in passato, perché avessero svolto una particolare indagine o
avessero particolari meriti, ma perché - spiega il sostituto procuratore della
Dna, Francesco Curcio - erano un simbolo dello Stato». E quello Stato, che
all’epoca aveva il volto di una classe politica che proprio in quel momento
cadeva sotto i colpi di Tangentopoli, per i clan era sempre stato “cosa loro”. E
doveva continuare ad esserlo, nonostante i cambiamenti di facciata. «Uno degli
aspetti più inquietanti di questa ricostruzione – dice al riguardo il
procuratore aggiunto Lombardo - è la presenza di un parallelismo inquietante fra
vicende politiche di quegli anni e strategia stragista». Le bombe e i morti
degli anni delle stragi continentali, cui oggi si aggiungono anche gli attentati
ai carabinieri in terra calabrese, non sono dunque stati semplicemente
espressione della feroce reazione dei corleonesi all’arresto di Totò Riina. Per
le mafie tutte – e questo è uno dei più importanti dati che emerge
dall’inchiesta – erano funzionali ad un piano di lungo periodo. E che
interessava tutti i clan che già da tempo avevano iniziato a parlarsi e a
consorziarsi, soprattutto in territori di nuova colonizzazione come la
Lombardia. Per non pestarsi i piedi vicendevolmente, lì i clan avevano iniziato
a parlarsi. E in questo modo avevano capito di essere più forti insieme. Per
questo, quando gli storici referenti istituzionali del loro dominio iniziano a
venir meno è insieme che decidono di reagire. Si tratta di una strategia decisa
ai massimi livelli. È stata definita in una serie di incontri, organizzati in
Calabria e non solo, che hanno visto al tavolo i massimi vertici delle mafie. Ma
soprattutto si tratta di una strategia che doveva rimanere segreta. Non a caso,
molti di quegli omicidi e di quegli attentati sono stati firmati come “Falange
armata”. E non a caso la base, i picciotti, i piccoli capi di ‘ndrangheta non ne
hanno mai saputo nulla per scelta cosciente della direzione strategica dei clan.
«La logica – spiega Lombardo - era quella di gestire un discorso di livello
molto alto, dunque come aveva fatto Cosa Nostra, anche la ‘ndrangheta doveva
mantenere il segreto su quale fosse stato il suo ruolo in quella stagione».
Perché la “strage lenta” doveva rimanere segreta? In primo luogo, perché per
essere efficace doveva provocare un diffuso sentimento di instabilità e paura,
secondo perché solo in pochi, ben selezionati referenti dovevano essere in grado
di cogliere la portata e il reale messaggio sotteso a quell’attacco. «Ci
troviamo di fronte – dice Lombardo - a un’organizzazione criminale che tiene
conto delle evoluzioni politiche, che aderisce prima ai movimenti autonomisti,
fino alla riunione di Lamezia Terme del ’93, quindi abbandona il progetto
autonomista nel momento in cui la nuova formazione politica, quindi Forza Italia
diventa il referente di determinati ambienti e si avvia una stagione del tutto
nuova». Gli attentati si fermano, in Italia torna la pace, le mafie sembrano
ritirarsi in buon ordine. E non solo loro. Perché anche altri attori hanno
partecipato alla strategia stragista. Per i magistrati, anche settori dei
servizi di informazione un tempo legati a Gladio e al piano Stay behind, ben
conosciuti e comodi in ambiente piduista, nei tumultuosi anni Novanta stavano
vedendo crollare le fondamenta del loro potere. Il blocco sovietico si stava
liquefacendo, gli assetti internazionali stavano cambiando, dunque anche le
condizioni alla base del loro straordinario potere. Per questo, si ipotizza
nell’inchiesta della Dda reggina, anche loro, insieme alla galassia
dell’eversione nera con cui hanno sempre avuto contatti, hanno avuto interesse a
lavorare con le mafie alla strategia di destabilizzazione. A rivelarlo non sono
soltanto innumerevoli collaboratori che hanno presenziato agli incontri fra
uomini dei clan e agenti dei servizi, ma anche la stessa sigla Falange armata.
Presa in prestito forse dalla falange di franchista memoria. «Quando abbiamo
chiesto ad un collaboratore che aveva partecipato all’omicidio Mormile se
sapesse il significato della parola Falange, se il suo capo Domenico Papalia,
glielo avesse spiegato – ricorda Curcio - lui ci ha risposto “mi hanno detto di
rivendicare così”. Attraverso una serie di ulteriori dichiarazioni, abbiamo
scoperto che risultano contatti fra questo Domenico Papalia con soggetti
appartenenti ai servizi d'informazione dell'epoca». E non isolati ad un unico
caso o un unico omicidio. La conferma viene dall’interno degli stessi apparati
di intelligence. «Una straordinaria conferma è arrivata dall’ambasciatore Fulci,
capo del Cesis proprio in quel periodo storico, minacciato dalla Falange Armata
– spiega al riguardo il sostituto procuratore della Dna - Lui si convinse che
queste minacce provenissero proprio dall’interno dei servizi. Per questo il tema
di ulteriori indagini dovrà essere proprio questo: individuare i soggetti che si
sono incontrati con esponenti della criminalità organizzata, quanto meno per
suggerire strategie». Ma non è l’unico filone che i magistrati intendono
seguire. «Con quest’indagine – dice il procuratore nazionale antimafia, Franco
Roberti – è stato aperto uno squarcio estremamente importante di verità ed è
estremamente importante per la giustizia, per le vittime e per tutto il nostro
Paese e gli assetti democratici del nostro Paese. Fare chiarezza continuerà ad
essere nostro obiettivo e nostro dovere anche in riferimento ad altre vicende
che sono oggi oggetto di indagine e che si iscrivono in quella stagione, come
l’omicidio del collega Scopelliti». Per il procuratore capo della Dna «fu ucciso
in prevenzione, come alcuni anni prima era stato ucciso il collega Saetta».
Tutti tasselli – promette – «che vanno anche oltre la stagione stragista e si
vanno componendo».
Perquisizione per Bruno Contrada.
Il provvedimento rientra nell'inchiesta della Procura di Reggio Calabria sugli
attentati ai carabinieri Fava e Garofalo. Per l'ex numero due del Sisde la
Cassazione aveva revocato la condanna per concorso esterno in associazione
mafiosa, scrive Mercoledì, 26 Luglio 2017, "Il Corriere della Calabria". La
Procura di Reggio Calabria ha disposto una perquisizione in casa di Bruno
Contrada, ex numero 2 del Sisde condannato per concorso in associazione mafiosa
per cui, nelle scorse settimane, la Cassazione aveva revocato la condanna. La
perquisizione rientra nell'inchiesta calabrese sugli attentati ai carabinieri.
«Ci aspettavamo ed era ampiamente prevedibile - ha detto il legale di Contrada,
Stefano Giordano - una reazione da parte di chi ha perso e non si rassegna a
questa inesorabile sconfitta». «Contrada è sereno - ha aggiunto il legale - e
spera di non essere più disturbato nel sonno». Durante la perquisizione non
sarebbe stato sequestrato nulla. Nelle oltre mille pagine di ordinanza di
custodia cautelare, non appaiono rifermenti diretti all’ex numero 2 del Sismi.
Ma il suo nome c’è ed è legato a quello di Giovanni Pantaleone Aiello, ex agente
della Squadra Mobile di Palermo «legato al noto Bruno Contrada - sospettato di
avere avuto un ruolo in diverse eclatanti vicende stragiste nel contesto di
oscuri inquietanti rapporti fra criminalità organizzata (siciliana e calabrese)
e apparati statali deviati». Di Aiello hanno parlato dopo anni di esitazione per
serio timore di ritorsioni i collaboratori di giustizia Nino Lo Giudice,
Giuseppe Calabrò e Consolato Villani. «Lo Giudice era preoccupato non di un
fantasma, ma di un soggetto (e di tutti i collegamenti che a questo facevano
capo) in carne ed ossa che lui ben conosceva la cui pericolosità, evidentemente,
considerava ben maggiore di quella di tutti gli altri soggetti (che non erano
propriamente delle mammole) che, fino a quel momento, aveva chiamato in
correità». Per il collaboratore - si legge nelle carte - Aiello «risultava
essere un uomo che agiva nell'ombra, fra un lontano passato nello Stato ed in
campi d'addestramento militari, ed un passato più recente ed il presente, al
fianco del crimine organizzato e di pericolose entità deviate, non individuate».
L’ex agente – indagato e perquisito nell'ambito di questo procedimento – è stato
indicato da Villani e Lo Giudice come “Il mostro”, uomo legato ad ambienti dei
servizi che avrebbe avuto un ruolo in una serie di fatti di sangue.
A caccia di prove in casa Contrada.
Controlli e misteri: esito negativo, scrive
di Riccardo Lo Verso Mercoledì 26 Luglio 2017 su "Live Sicilia". I poliziotti
della Squadra mobile di Reggio Calabria sono piombati a casa palermitana di
Bruno Contrada nel cuore della notte. Quaranta minuti dopo le quattro. A caccia
della prova dei rapporti oscuri fra l'ex poliziotto e Giovanni Aiello,
soprannominato "faccia da mostro" per la profonda cicatrice che ne deturpa il
viso. Secondo i pm di Reggio Calabria, Aiello, oggi in pensione, presenza
costante nei misteri d'Italia, avrebbe convinto l'ex carabiniere Saverio
Tracuzzi Spadaro a mentire ai pm sul suo rapporto con Aiello e sul ruolo del
poliziotto nelle file della 'Ndrangheta. La perquisizione a casa Contrada, che
ha avuto esito negativo, rientra nell'inchiesta calabrese sugli attentati ai
carabinieri. Diversi i punti che hanno condotto i pm fino a casa dell'ex numero
tre del Sisde a cui la Cassazione ha di recente revocato gli effetti della
condanna a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Contrada è
risultato in contatto con l'ex agente di polizia Guido Paolilli che lo aveva
chiamato per commentare le sue dichiarazioni ai pm su Aiello. Sia "faccia da
mostro" che Paolilli sono stati indagati a Palermo per l'omicidio dell'agente
Nino Agostino, ucciso insieme alla moglie nel 1989. Per Paolilli, che rispondeva
di favoreggiamento, la Procura chiese ed ottenne l'archiviazione. Fu uno dei
primi a indagare sul delitto Agostino, privilegiando la pista passionale.
Aiello, accusato di omicidio, è ancora indagato dopo l'avocazione del fascicolo
da parte della procura generale, decisa dopo diverse richieste di archiviazione
da parte dei pm di Palermo. Contrada viene indicato dai magistrati reggini come
la persone “più strettamente legata ad Aiello nella polizia di Stato”. Fonte
dell'informazione sarebbe "una persona pienamente attendibile che non si nomina
per evidenti motivi di cautela processuale". In passato è stato il pentito Nino
Lo Giudice, detto il nano, a raccontare che Aiello gli fu presentato dal
capitano Tracuzzi della Dia, condannato in appello a 10 anni perché considerato
colluso con la 'Ndrangheta. Lo Giudice aggiunse che Aiello schiacciò il
telecomando che innescò l'esplosione per la strage di via D'Amelio, e di avere
saputo dallo stesso Aiello del suo ruolo nell'omicidio di Agostino e della
moglie. Solo che quando iniziò a riferirlo ai magistrati sarebbe stato
minacciato dagli uomini dei servizi segreti. «Ci aspettavamo ed era ampiamente
prevedibile - ha detto il legale di Contrada, l’avv. Stefano Giordano - una
reazione da parte di chi ha perso e non si rassegna a questa inesorabile
sconfitta». «Contrada è sereno - ha aggiunto il legale - e spera di non essere
più disturbato nel sonno». Durante la perquisizione non sarebbe stato
sequestrato nulla.
L’attacco allo Stato di ‘ndrangheta e
mafia siciliana, scrive Claudio Cordova Mercoledì, 26
Luglio 2017 su "Il Dispaccio". Un progetto mafioso e terroristico, per attentare
al cuore dello Stato, colpendo una delle istituzioni più amate, l'Arma dei
Carabinieri. Un progetto messo in piedi da 'ndrangheta e mafia siciliana, con
l'inquietante collaborazione di pezzi dello Stato: la Procura di Reggio Calabria
prova a riscrivere la storia d'Italia, partendo dagli attentati tre attentati
compiuti in danno dei Carabinieri di Reggio Calabria, in cui persero la vita, il
18 gennaio 1994, gli Appuntati Antonino Fava Fava e Giuseppe Garofalo; rimasero
gravemente feriti, l'1 febbraio 1994, l'Appuntato Bartolomeo Musicò e il
Brigadiere Salvatore Serra e rimasero miracolosamente illesi, l'1 dicembre 1994,
il Carabiniere Vincenzo Pasqua e l'Appuntato Silvio Ricciardo. Due i mandanti,
il boss siciliano, Giuseppe Graviano, e Rocco Santo Filippone, uomo forte della
'ndrangheta della Piana di Gioia Tauro, con importanti collegamenti con la
potente famiglia Piromalli. Omicidi e tentati omicidi che si inquadrano negli
anni della strategia stragista portata avanti da Cosa Nostra, ma che ora vede
anche la 'ndrangheta grande protagonista: un progetto eversivo, che infatti
spinge la Procura retta da Federico Cafiero De Raho a contestare anche
l'aggravante terroristica, oltre a quella mafiosa. La Dda di Reggio Calabria ha
ricostruito – attraverso l'apporto di nuovi e fondamentali elementi raccordati e
collegati tra loro – le causali degli attentati ai carabinieri, ma, soprattutto,
matrici e scopi sottesi a tali delitti, che vanno a collocarsi nel contesto
della strategia stragista nei primi anni '90 messa in atto dalle mafie, con il
coinvolgimento oscuro e inquietante di schegge di istituzioni deviate, a loro
volta collegate a settori della P2, ancora in cerca di rivincite nonostante
l'ufficiale scioglimento nel 1982. Costanti e inquietanti i riferimenti
investigativi alla figura del Venerabile Licio Gelli. A spingere gli inquirenti,
il procuratore Federico Cafiero De Raho, l'aggiunto Giuseppe Lombardo, il
sostituto Antonio De Bernardo, nonché il procuratore nazionale antimafia, Franco
Roberti, e il sostituto della DNA, Francesco Curcio, sulla matrice unica e sul
disegno volto in parte a destabilizzare e in parte a conservare lo status quo,
una serie di caratteristiche comuni sui tre delitti, a cominciare dall'utilizzo
dell'arma, un mitra M12. Si sarebbe trattato, dunque, di un progetto criminale,
la cui ideazione e realizzazione sarebbe maturata non all'interno delle cosche
di 'ndrangheta, ma si sarebbe sviluppata attraverso la sinergia, la
collaborazione e l'intesa di organizzazioni criminali, come Cosa Nostra e
'ndrangheta. Sulla scorta delle dichiarazioni di decine di collaboratori di
giustizia, gli inquirenti avrebbero scoperto come numerose riunioni – quasi
tutte nella zona tirrenica della provincia di Reggio Calabria – avessero ad
oggetto l'inquietante joint venture tra le due mafie: a fare da collante, Rocco
Santo Filippone, nonché Giuseppe Graviano, che con la sua famiglia ha avuto
negli anni il compito di saldare legami e alleanze con i calabresi. Così,
dunque, le mafie volevano partecipare a una vera e propria opera di
ristrutturazione egli equilibri di potere sul territorio nazionale: e tale
strategia appariva condivisa da pezzi deviati dello Stato, in contatto con il
piduismo. Sul punto le indagini hanno evidenziato come la stessa idea di
rivendicare con la sigla "Falange Armata" le stragi mafiose e vari delitti
compiuti dalle mafie sarebbe da far risalire a oscuri suggeritori appartenenti
ai servizi segreti e, comunque, alla massoneria deviata. Il disegno terroristico
mafioso era, dunque, servente rispetto ad una finalità "più alta", che prevedeva
la sostituzione di una vecchia ed inaffidabile classe politica con una nuova che
fosse diretta espressione delle mafie, e, in quanto tale, proiettata a garantire
e realizzare "i desiderata di Cosa Nostra". Si stava attraversando un periodo di
grandi cambiamenti a livello nazionale (ma anche internazionale) di natura
storica e politica, in cui tutte le organizzazioni criminali, dopo il tramonto
della c.d. "prima Repubblica", intendevano continuare a mantenere l'influenza
sulla classe politica proiettandosi su quella emergente nella nuova fase storica
che si stava delineando. Al culmine della strategia stragista del '93, a partire
dal mese di settembre, e quindi in epoca immediatamente successiva agli altri
attentati posti in essere nel continente (Roma, Firenze e Milano), era stata
organizzata una strage di proporzioni immani facendo saltare in aria alcuni
pullman dei Carabinieri in servizio a Roma allo stadio Olimpico in una delle
tante domeniche calcistiche particolarmente affollate, attentato che doveva
essere eseguito nella terza decade del Gennaio 1994 e che falliva soltanto per
un guasto tecnico al telecomando che avrebbe dovuto innescare l'ordigno. Ad
aprire squarci di luce agli inquirenti, un atto di impulso della Procura
Nazionale Antimafia, che segnala alla Procura di Cafiero De Raho le
dichiarazioni del collaboratore di giustizia siciliano, Gaspare Spatuzza, già
capo mandamento di Brancaccio, il quale ha vissuto dall'interno ed in modo
completo tutta la vicenda delle stragi del '93 e del '94, dai progetti condivisi
ai momenti esecutivi. Da qui il lavoro di raccolta delle dichiarazioni di altri
pentiti – alcune in parte già note, altre riattualizzate – e la costruzione
dell'impianto investigativo, inquietante e affascinante, quanto, secondo gli
inquirenti, solido. E subito, davanti agli occhi dei magistrati, appare come la
pista terroristica fosse coltivabile, ma, anche, fondata: pezzi importanti della
'ndrangheta tirrenica - d'intesa con esponenti reggini - diedero assicurazione
ai Corleonesi, rappresentati da Graviano - di aderire alla strategia
terroristica di Cosa Nostra che, dopo le stragi continentali, doveva prendere di
mira gli appartenenti alle forze dell'ordine e, in particolare, i Carabinieri.
Tali componenti 'ndranghetiste, a loro volta, delegarono i Filippone a
presiedere all'organizzazione degli attacchi ai Carabinieri in terra calabrese.
Quindi, i Filippone individuarono nel giovane Giuseppe Calabrò (nipote di Rocco
Santo Filippone, poiché figlio della sorella Marina), l'uomo che doveva
materialmente eseguire gli assalti, in quanto egli, dotato di una eccezionale
preparazione militare ed una straordinaria dimestichezza con le armi, era privo
di scrupoli ed ansioso di affermarsi in ambito criminale. Giuseppe Calabrò e
Consolato Villani (già condannati definitivamente come autori materiali
dell'omicidio di Fava e Garofalo) vennero poi aizzati a scatenare la strategia
di attacco contro i Carabinieri dal defunto Demetrio Lo Giudice classe 1937,
emissario della cosca Libri per il quartiere Reggio Campi di Reggio Calabria che
fece crescere da un punto di vista militare e criminale Calabrò e che infine lo
spinse ad eseguire i delitti oggi contestati; tale dato risulta coerente in
relazione alla posizione assunta dalle cosche di 'Ndrangheta di cui Filippone e
Lo Giudice erano, all'epoca, eminenti rappresentanti (vale a dire quella dei
Piromalli-Molè-Pesce, il primo e dei De Stefano-Libri-Tegano il secondo ) che,
non a caso, erano le famiglie di 'ndrangheta che, all'epoca, avevano manifestato
maggiore apertura nell'appoggio a Cosa Nostra nella strategia stragista. Un
soggetto importante, Filippone, la cui figura è stata per anni sottovalutata e,
con ogni probabilità coperta, anche dalla magistratura calabrese. E' lui l'uomo
che salda i rapporti con Cosa Nostra: così dunque, si può affermare che mafia
siciliana e 'ndrangheta non siano unite solo da progetti di natura economica, ma
anche da progetti di natura politica, attraverso spinte autonomistiche, non solo
in Sicilia, ma, ancor prima, in Calabria. Un'indagine su tre gravissimi fatti di
sangue, tre complessi attentati alle istituzioni democratiche, che, quindi, apre
scenari inquietanti almeno sugli ultimi 30 anni di storia d'Italia: la
'ndrangheta emerge non solo perché era in stretti rapporti con Cosa Nostra, ma
in quanto risultava particolarmente inserita in quei rapporti con la destra
eversiva e la massoneria occulta, proprio in quel periodo stragista in cui
entrambe le organizzazioni (Cosa Nostra e 'Ndrangheta) sostennero il disegno
federalista attraverso le leghe meridionali. "Oggi ricollochiamo la 'ndrangheta
nel suo giusto ruolo" dicono gli inquirenti, che sottolineano inquietanti
parallelismo tra le vicende politiche di quegli anni (nel 1994 verrà fondata
Forza Italia) e la strategia stragista. Il partito di Silvio Berlusconi sarebbe
così divenuto il referente di determinati ambienti, con l'abbandono del progetto
autonomista. A tal proposito, nella complessiva ricostruzione dei fatti, assume
inoltre particolare rilievo la vicenda della riunione intermafiosa di Nicotera
Marina (VV), avvenuta dopo gli attentati a Falcone e Borsellino, svolta
all'interno del villaggio turistico Sayonara, controllato dalla famiglia Mancuso
di Limbadi (VV), come noto legatissima a quella dei PiromallI che aveva come
tema proprio la questione stragista: non a caso, a Nicotera, per interloquire
con Cosa Nostra su questa delicatissima questione, vennero chiamati a
partecipare tutti i capi della 'ndrangheta, da Cosenza a Reggio Calabria, ciò a
dimostrazione della unitarietà della 'ndrangheta, ovvero del suo atteggiarsi a
forza mafiosa che verso l'esterno si presentava unita e compatta. Un'inchiesta
che svela i contatti stabili tra le due organizzazioni, l'esistenza di
componenti elevate e occulte e che si innesta nella seconda fase delle
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Consolato Villani e Nino Lo
Giudice: questi, infatti, scompare dalla località protetta in cui si trovata
(per poi essere catturato nuovamente dopo qualche mese) quando Villani inizia a
parlare dei mandanti degli attentati ai carabinieri. Entrambi collaboratori, non
avevano avuto il coraggio di rivelare i meccanismi in cui erano stati inseriti
negli anni '90. Lo Giudice sparisce quando la parte più importante della sua
carriera criminale sta per essere scoperta. "Perché, a distanza di 25 anni dalle
stragi esistono ancora zone d'ombra?" si chiede il procuratore nazionale
antimafia, Franco Roberti. Perché, come spiegano gli inquirenti, l'attenzione
ora è posta sulle connivenze istituzionali, su agenti segreti infedeli, massoni
che hanno controllato e controllano fette consistenti dell'Italia.
E il ruolo di Reggio Calabria e della 'ndrangheta
ora, finalmente, appare per quello che è sempre stato: cuore pulsante di alcune
delle vicende più oscure d'Italia.
Patto 'ndrangheta-mafia, il summit a
Nicotera Marina dopo la morte di Falcone e Borsellino,
scrive Mercoledì, 26 Luglio 2017 "Il Dispaccio". Esponenti di Cosa Nostra e
'ndrangheta si incontrarono in Calabria dopo gli attentati in cui persero la
vita i magistrati siciliani Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Lo affermano i
magistrati della Dda di Reggio Calabria, negli atti relativi all'operazione
"'Ndrangheta stragista" di oggi. Il summit si tenne a Nicotera Marina (Vv), a
all'interno del villaggio turistico "Sayonara", controllato dalla famiglia
Mancuso di Limbadi (Vv), legata a quella dei Piromalli, egemone nella piana di
Gioia Tauro (Rc). Al centro dell'incontro, la strategia stragista inaugurata dai
siciliani. Per interloquire con Cosa Nostra furono chiamati a partecipare tutti
i capi della 'ndrangheta, da Cosenza a Reggio Calabria, "cio' - secondo la
Procura antimafia - a dimostrazione della unitarietà della 'ndrangheta, ovvero
del suo atteggiarsi a forza mafiosa che verso l'esterno si presentava unita e
compatta". Sarebbe stato l'allora capo indiscusso della mafia siciliana,
Salvatore Riina, il promotore della richiesta alla 'ndrangheta di cooperare alla
strategia di Cosa Nostra, con l'individuazione degli obiettivi istituzionali da
colpire. Altre riunioni si sarebbero svolte nella zona del "mandamento
tirrenico" della 'ndrangheta (Rosarno, Oppido Mamertina, Melicucco), in ambiti
territoriali sottoposti alla giurisdizione criminale dei Mancuso, dei Piromalli,
dei Pesce e dei Mammoliti. Cosa Nostra, ipotizzano i magistrati, aveva
indirizzato proprio ai Piromalli/Molè, con i quali i rapporti erano
strettissimi, la richiesta di promuovere gli incontri "in vista di una adesione
generalizzata della 'ndrangheta alla strategia stragista che Cosa Nostra aveva
deciso di intraprendere". Diversi collaboratori di giustizia, aderenti alle
varie cosche di 'ndrangheta, avrebbero raccontato delle riunioni. Alle loro
dichiarazioni la Squadra Mobile avrebbe cercato riscontro attraverso
intercettazioni telefoniche, ambientali e di altra natura. (AGI)
Il patto 'ndrangheta-mafia: le strategie
eversive e i "suggeritori" istituzionali, scrive
Mercoledì, 26 Luglio 2017 "Il Dispaccio". C'era un vero e proprio patto
eversivo, suggellato da esponenti di Cosa Nostra e della 'ndrangheta reggina nel
corso di diversi summit, dietro agli attentati subiti in Calabria dall'arma dei
Carabinieri, costati la vita a due militari, gli appuntati scelti Vincenzo
Garofalo e Antonino Fava, uccisi a colpi di mitra il 18 gennaio 1994 lungo
l'autostrada A3 nel tratto Bagnara-Scilla, nel Reggino, ed il ferimento di altri
quattro militari. Queste le conclusioni a cui è' giunta la Dda di Reggio
Calabria che stamani ha emesso due provvedimenti restrittivi a carico di due
esponenti di spicco delle mafie calabresi e siciliana: Rocco Santo Filippone, 73
anni, di Anoia (RC), considerato capo del "mandamento tirrenico" della
'ndrangheta all'epoca degli attentati ai Carabinieri, e Giuseppe Graviano, 54
anni, palermitano, capo del mandamento mafioso di Brancaccio, coordinatore
riconosciuto con sentenze definitive delle cosiddette stragi "continentali"
eseguite da Cosa Nostra. Graviano era già detenuto nel carcere di Terni. Gli
omicidi e i tentati omicidi, commessi nella stagione degli attacchi mafiosi allo
Stato, sarebbero, secondo la Dda reggina, aggravati dalle circostanze dalla
premeditazione, in quanto pianificate nell'ambito di un più ampio disegno
criminoso di matrice stragista "ideato, voluto ed attuato - scrivono gli
inquirenti - dai soggetti di vertice delle organizzazioni di tipo mafioso
denominate Cosa Nostra e 'Ndrangheta". Gli inquirenti ravvisano anche finalità
di terrorismo e di eversione dell'ordinamento democratico, perchè Cosa Nostra e
'ndrangheta intendevano costringere lo stato italiano a rendere meno rigorose
sia la legislazione che le misure antimafia, ma soprattutto puntavano alla
sostituzione della vecchia classe politica, ormai giudicata inaffidabile, con
una nuova che fosse diretta espressione delle mafie, e, in quanto tale,
proiettata a garantire e realizzare "i desiderata di Cosa Nostra". Dunque, dopo
il tramonto della "prima Repubblica", i boss mafiosi intendevano continuare a
mantenere l'influenza sulla classe politica "proiettandosi su quella emergente
nella nuova fase storica che si stava delineando". Secondo la ricostruzione dei
magistrati, elementi importanti della 'ndrangheta tirrenica, d'intesa con
esponenti reggini, diedero assicurazione ai corleonesi, rappresentati da
Giuseppe Graviano, di aderire alla strategia terroristica di Cosa Nostra che,
dopo le stragi continentali, doveva prendere di mira gli appartenenti alle forze
dell'ordine e, in particolare, i Carabinieri. Queste componenti 'ndranghetiste,
a loro volta, delegarono i Filippone a presiedere all'organizzazione degli
attacchi ai Carabinieri in terra calabrese. Quindi, i Filippone avrebbero
individuato nel giovane Giuseppe Calabrò, nipote di Rocco Santo Filippone,
l'uomo che doveva materialmente eseguire gli assalti, essendo dotato di
un'eccezionale preparazione militare e di una straordinaria dimestichezza con le
armi, ma anche perchè era, nelle valutazioni della Dda, "privo di scrupoli ed
ansioso di affermarsi in ambito criminale". Filippone e Graziano sono accusati
di essere i mandanti, in concorso fra loro e con Giuseppe Calabrò e Consolato
Villani (entrambi già condannati in via definitiva come esecutori di dei
delitti) e Demetrio lo Giudice, detto Mimmo, del tentato omicidio ai danni dei
carabinieri Vincenzo Pasqua e Silvio Ricciardo, commesso in località Saracinello
di Reggio Calabria nella notte fra il 1° e il 2 dicembre 1993; dell'omicidio
degli appuntati Fava e Garofalo e del tentato omicidio di altri due militari
dell'Arma, Bartolomeo Musicò e Salvatore Serra, contro i quali furono sparati
numerosi colpi utilizzando un mitra M12 ed un fucile calibro 12. Serra e Musicò
rimasero feriti gravemente. Serra rispose al fuoco con l'arma d' ordinanza.
Anche quest'ultimo attentato avvenne a Reggio Calabria, in località Saracinello,
il primo febbraio 1994. I tre attacchi all'Arma, si sottolinea negli atti
dell'inchiesta, presentavano caratteristiche comuni. In primo luogo perchè
furono compiuti nella cintura periferica di Reggio Calabria, ma anche perchè, in
tutti gli episodi, era stata usata la stessa arma automatica (un mitra M 12), ai
danni di pattuglie automontate, che, di notte, erano impegnate in normali turni
di controllo del territorio. Sullo sfondo del patto stragista stretto da Cosa
Nostra e 'ndrangheta negli anni '90 "appare chiara la presenza di suggeritori
occulti da individuarsi in schegge di istituzioni deviate a loro volta collegate
a settori del piduismo ancora in cerca di rivincita". Lo scrive la Dda di Reggio
Calabria negli atti relativi all'inchiesta "'Ndrangheta stragista" nell'ambito
della quale la Polizia ha notificato oggi due ordinanze di custodia cautelare in
carcere a carico di un boss della 'ndrangheta e di uno, già detenuto, della
mafia. L'uccisione di due militari dell'Arma sull'autostrada A3 nel gennaio del
1994 ed il ferimento di altri militari sempre in Calabria, dunque, "vanno a
collocarsi - scrivono i magistrati reggini - nel contesto della strategia
stragista che ha insanguinato il Paese nei primi anni 90' e in particolare in
quella stagione definita delle "stragi continentali". Secondo l'impostazione
accusatoria, l'obiettivo strategico delle azioni contro i Carabinieri, al pari
di quello degli altri episodi stragisti verificatisi nel Paese, "era
rappresentato dalla necessità, per le mafie, di partecipare a quella complessiva
opera di vera e propria ristrutturazione degli equilibri di potere in atto in
quegli anni. E tale strategia - secondo gli inquirenti - appariva condivisa, da
schegge di istituzioni deviate, da individuarsi in soggetti collegati a servizi
d'informazione che ancora all'epoca mantenevano contatti con il piduismo". Dalle
indagini sarebbe emerso come la stessa idea di rivendicare con la sigla "Falange
Armata" le stragi mafiose e vari delitti compiuti dalle mafie, fra cui quelli
per cui è stata emessa l'ordinanza eseguita oggi, "è da farsi risalire a
suggeritori da individuarsi in termini di elevatissima gravità indiziaria, in
appartenenti ai servizi d'informazione dell'epoca, nei cui confronti, comunque,
le indagini proseguiranno". (AGI)
L'accorduni tra 'ndrangheta e Cosa
Nostra: attacco coordinato per le stragi degli anni '90,
scrive Mercoledì, 26 Luglio 2017 "Il Dispaccio". "Cade in maniera netta
l'assunto secondo cui la 'ndrangheta, o cosche di primo piano di essa, sia stata
totalmente estranea alla svolta stragista impressa da Cosa nostra negli anni
'90. Molti aspetti di queste torbide vicende saranno chiariti". É quanto si
apprende in ambienti investigativi che hanno coordinato l'inchiesta che ha
portato all'arresto di Rocco Santo Filippone e Giuseppe Graviano. Le
dichiarazioni di Gaspare Spatuzza hanno avuto l'effetto di un colpo di maglio su
oltre venti anni di storia criminale da cui la 'ndrangheta emerge come "alleato"
affidabile di Cosa nostra "nell'attacco coordinato allo Stato ed alle sue
istituzioni più rappresentative, come l'Arma dei Carabinieri". Gli inquirenti
parlano senza mezzi termini di "progetto di disarticolazione della democrazia e
delle istituzioni", in un quadro politico, come quello degli anni '90,
caratterizzato dall'instabilità istituzionale e dalla chiusura della Prima
Repubblica. "Sfuma così il tentativo - dicono gli inquirenti - di depotenziare
le responsabilità della 'ndrangheta, per come raccontato finora, a seguito del
rifiuto del boss Giuseppe De Stefano agli emissari di Cosa nostra negli anni '90
durante un incontro nella zona di Nicotera, che avrebbe sancito la contrarietà
della 'ndrangheta alle stragi. E invece l'accorduni prese corpo proprio con gli
autori dell'assassinio di don Pino Puglisi, ucciso dai Graviano a Brancaccio
perché 'disturbava' taluni equilibri e complicità in quel quartiere di Palermo".
Nel mosaico ricostruito dalla Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria
appaiono anche molti spunti di indagine chiuse frettolosamente negli anni '70 e
negli anni '80, omicidi e intimidazioni contro personaggi pubblici che alla luce
di quanto sta emergendo troverebbero una diversa valutazione, un filo di
interessi economici e di potere tra parti deviate di istituzioni, estremismo di
destra e, appunto, la 'ndrangheta.
Sinergie sempre più forti all’ombra della
massomafia. La stagione del “concorso esterno” ha
ormai lasciato il posto a quella della collusione. Il pacchetto di controllo
delle cosche e della malapolitica aumenta vertiginosamente con il crescente
astensionismo. Uno scenario rispetto al quale non può esserci una risposta solo
in termini di “politica giudiziaria”, scrive Paolo Pollichieni, Sabato 15 Luglio
2017, su "Il Corriere della Calabria". Funziona e regge. In una Calabria che si
presenta devastata nel suo reticolo produttivo e ridotta a mal partito in quanto
a rappresentanza politica, funziona e regge, anzi conosce una stagione di grande
prosperità, quell’area che ha ormai smesso di essere “grigia” per diventare
organica alla ‘ndrangheta nella gestione del territorio. Funziona e regge, in
sostanza, quella camera di compensazione allestita al riparo da logge massoniche
spurie dove potere criminale e potere politico si incontrano ed elaborano
strategie tese al consolidamento del loro potere. Funziona e regge, quel modello
criminale che affonda le radici già nelle cronache della prima indagine sulla
massoneria deviata, quella di Agostino Cordova. Modello che ricompare sull’asse
Lamezia-Vibo dieci anni più tardi, con la stagione delle “leghe” come veicolo
per il traghettamento verso la seconda repubblica. Modello cristallizzato
nell’indagine reggina denominata “Olimpia”, alla quale lavorarono Macrì e
Mollace, Cisterna e Pennisi, Verzera e Di Palma. Carte oggi riscoperte e
rivisitate ma che hanno stroncato più di una carriera e “mascheriato” più di un
magistrato inquirente. Oggi quel “modello criminale” appare scolpito e
scontornato nelle indagini di una magistratura meno aggredibile che, in uno con
una polizia giudiziaria più autonoma, ci consegna una serie di indagini che a
Vibo come a Lamezia, a Crotone come a Locri, a Gioia Tauro come a Reggio
Calabria, evidenziano sempre più come la stagione del “concorso esterno” ha
ormai lasciato il posto a quella della collusione e della sinergia criminale. Ci
sarebbe materia per una riflessione attenta da parte di quel che rimane in
Calabria di un ceto politico non cooptabile da parte della ‘ndrangheta. Anche il
crollo della partecipazione democratica conosciuto in queste ultime tornate
elettorali, oggi, si appalesa come funzionale agli interessi della massomafia:
il pacchetto di controllo delle cosche e della malapolitica aumenta di peso
vertiginosamente in presenza di un altrettanto vertiginoso calo delle
percentuali dei votanti. C’è questa voglia di riflettere da parte di quel che
resta della Politica con la P maiuscola, in Calabria? Dobbiamo imporci di
crederlo. Anche quando ti trovi a sbattere contro vicende come quelle reggine,
dove l’isolamento di un assessore viene motivato con la sua irriducibilità
davanti all’applicazione della legge. Anche quando devi prendere atto che la
transumanza delle baronie politiche, lungi dall’essere bandita, diventa oggetto
di adulazione da parte delle segreterie regionali più blasonate. Anche quando la
sottovalutazione regna sovrana nella mente di chi fa incetta di deleghe e potere
ritenendo che sigillare significa decidere. È questo lo scenario che abbiamo
davanti in Calabria. Uno scenario rispetto al quale non può esserci una risposta
solo in termini di “politica giudiziaria”; le indagini in corso, e quelle che
arriveranno, possono creare la precondizione per ripulire la casa e renderla
agibile ma sono ben altri i soggetti che debbono incaricarsi di evitare che
venga nuovamente sporcata sino all’inagibilità. Non lo si otterrà nominando
qualche magistrato in pensione al vertice della Stazione unica appaltante.
Questo semmai è il segno di un senile ricorso all’imbellettamento. Serve lasciar
spazio alle energie migliori e nella misura in cui questo si cercherà di fare
chiaramente lo spazio selettivo si restringe. Fino a fare apparire asfittici i
confini dettati dalla militanza storica in questo o quel movimento politico. È
tutta qui la vera lotta alla ‘ndrangheta ed è tutta qui la battaglia per il
cambiamento. Le cosche sono attrezzate per sostenerla. Gratteri lo ha ripetuto
anche di recente: investono meno in armi e più in settori di controllo sociale.
Dai media alla clientela, dall’imprenditoria al controllo del consenso.
Figurarsi che investono anche in “antimafia”.
Massoneria, coop rosse e consulenze: su
cosa indaga Catanzaro. Gli incroci con Consip sono
solo una piccola parte delle inchieste in corso. E riguardano gli affari della
“Sviluppo srl” e di Rocco Borgia. Nel mirino di due Procure i legami con Cmc e
aziende in procinto di chiudere affari con Regione, Anas e Sorical, scrive
Martedì, 25 Luglio 2017 Paolo Pollichieni su "Il Corriere della Calabria". Rocco
Borgia è un distinto signore, i suoi 74 anni li porta che è uno splendore.
Merito, assicura ai suoi potenti amici, della “dieta calabrese” alla quale resta
fortemente fedele, pur avendo lasciato la natia Melicucco da molti decenni.
Oggi, infatti, vive a Roma, si definisce imprenditore e non fa mistero del suo
alto grado in massoneria. Rimosso, invece, il suo passato da militante del
vecchio Partito comunista italiano. È un maniaco della riservatezza, il che però
non lo ha salvato da continue apparizioni nelle cronache giudiziarie del nostro
Paese. L’ultima lo vede, nel febbraio scorso, perquisito nell’ambito delle
indagini sulla Consip e sugli appalti da destinare al “Gruppo Romeo”. Una
perquisizione giustificata dal fatto che gli inquirenti messi alle calcagna di
Alfredo Romeo lo fotografano mentre va a pranzo con i vertici dell’Inps e poi a
colloquio con il tesoriere del Pd, al Nazareno. In Calabria due Procure si
occupano di lui ed entrambe seguendo il filo della cosiddetta “massomafia”, una
“supercupola” che si incarica di mediare affari miliardari selezionando la
classe dirigente locale, utilizzando le cosche per il controllo del territorio,
garantendo i patti con le maggiori imprese nazionali. Anche nel nuovo assetto
delle logge calabresi e nel voto per il rinnovo dei vertici nazionali, la
“massomafia” avrebbe avuto un ruolo di primo piano. Così, nel 2015, quando una
“cooperativa rossa” affidataria di lucrosi appalti pubblici sull’asse
Catanzaro-Cosenza deve scegliersi un “ambasciatore” che poi garantisca gli
accordi, avrebbe puntato proprio su Rocco Borgia. Vero? Falso? È quanto stanno
cercando di chiarire le indagini delle procure distrettuali di Reggio Calabria e
di Catanzaro. Quel che appare accertato è che la ingombrante figura del massone
Rocco Borgia spacca la sinistra italiana. Il suo nome, infatti, figura in due
articolate e durissime interrogazioni parlamentari. La prima risale alla scorsa
legislatura e vede come primo firmatario Elio Lannutti. Siccome rimase senza
risposta, ecco che viene riproposta nell’attuale legislatura, prima firmataria
Laura Castelli. Gli interroganti chiedono lumi sul ruolo avuto dal Borgia alla
guida di una missione italiana in Somalia. In particolare chiedono al ministro
degli Esteri chi aveva accreditato il Borgia nella Ong italiana Cins. Chiedono
anche di sapere se «l’alter ego apicale nel Cins, tale Umberto Santich sia lo
stesso Santich sotto processo a Roma per lo scandalo che costò il posto al capo
di Finmeccanica Orsi». Infine intendono sapere se i due, Borgia e Santich,
fossero consulenti della Farnesina. Il nostro ministero degli Esteri rispondere
che in effetti Umberto Santich lo è stato e anche Rocco Borgia, aggiungendo però
che «Rocco Borgia era tra i rinviati a giudizio per reati di cui agli articoli
54, 110 e 640bis del codice penale per truffa ai danni del ministero degli
Esteri».
In Calabria, a radicare attenzioni e competenze
delle locali Procure, opererebbe oggi la “Sviluppo Srl”, in cui il Borgia, pur
non comparendo come socio, avrebbe consolidati interessi, utilizzandola anche
per una serie di sinergie con le “cooperative rosse”. In questo contesto è
proprio l’indagine delle Procure calabresi a dar manforte all’inchiesta Consip,
per un motivo molto semplice: dimostrerebbe un rapporto stretto tra Rocco Borgia
e la Cmc, al punto da curarne le proiezioni e gli interessi in Calabria. La Cmc,
Cooperativa muratori e cementisti di Ravenna, è un colosso della cooperazione
rossa e in Calabria costruisce di tutto. Alfredo Romeo teme che il nuovo assetto
ai vertici dell’Inps possa nuocergli. Ne coglie le prime avvisaglie anche
rispetto a interessi che la sua azienda ha nella gestione del patrimonio
immobiliare dell’Inps in Calabria, Sicilia, Campania, Puglia e Lazio. Lo dice
chiaramente l’imprenditore amico di Tiziano Renzi, Francesco Russo mentre parla
con il Romeo: «A me mi stanno martellando, sono quelli di Cmc, incontrali,
incontrali, incontrali». E lui per “incontrarli” si rivolge a Rocco Borgia
concordando con lui una lauta consulenza attraverso, appunto, la Sviluppo Srl.
Chiacchiere? Non pare proprio, visto che nelle perquisizioni condotte salta
fuori una fattura intestata a Sviluppo Srl di 24.400 euro, versati dalla Romeo
Gestioni in un conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Bari, per
«attività di consulenza e assistenza in merito a possibilità di sviluppo
commerciale e partenariato in materia di efficentamento energetico». Identica
dizione e identica casuale di altre “consulenze” che le inchieste calabresi
troveranno nel corso delle loro indagini. Ovviamente cambiano i contraenti, non
più la “Romeo Gestioni” ma altre aziende in procinto di concludere affari con la
pubblica amministrazione e in particolare con Anas, Sorical e Regione Calabria.
Da ultimo, la Guardia di finanza, nel sequestrare un parco eolico da 300 milioni
di euro in quel di Isola Capo Rizzuto, perché riconducibile al clan
‘ndranghetistico degli Arena, rinviene e cataloga altre “consulenze”
riconducibili alla Sviluppo Srl. Comprensibile la furiosa reazione del
procuratore distrettuale Nicola Gratteri davanti a una “fuga di notizie” che
appare solo artatamente giustificata con le inchieste dei carabinieri del Noe
sulla Consip e sugli amici, veri e presunti, di Babbo Renzi.
Omicidio Mormile, "Umberto ucciso dalla
‘ndrangheta con il nulla osta dei servizi segreti",
scrive Antonella Beccaria il 26 luglio 2017 su "Il Fatto Quotidiano". “Mormile,
nonostante sia stato infangato come corrotto, venne ucciso perché rifiutò di
fare una relazione compiacente a Domenico Papalia”. A parlare è Vittorio
Foschini, ‘ndranghetista pentito che il 26 aprile 2015 ha detto anche altro:
Mormile sapeva di un patto tra criminalità organizzata calabrese e servizi
segreti. L’educatore carcerario lo disse chiaramente: “Io non sono dei servizi”,
quando gli venne chiesto un favore per il boss Domenico Papalia, e per questo –
anche per questo – morì. “Questa allusione sui rapporti servizi-Papalia, oltre
che al rifiuto di fare il favore, fu fatale al Mormile”, spiega infatti
Foschini.
Vediamo di capire meglio. Umberto Mormile, 37
anni, era un educatore in servizio nel carcere di Opera dopo essere stato
a Parma. Fu ammazzato l’11 aprile 1990 a Carpiano, nel milanese, mentre andava
al lavoro. Gli furono sparati sei colpi di 38 specialesplosi da un’Honda 600 che
aveva affiancato la sua Alfa 33. L’omicidio venne rivendicato dalla Falange
Armata – Falange Armata Carceraria, per la precisione – sigla che esordì proprio
con questo delitto (e sul punto torneremo). In via definitiva per l’omicidio
Mormile sono stati condannati come mandanti Domenico e Antonio Papalia e
come esecutori materiali Antonio Schettini e Nino Cuzzola. Nel corso del
processo, la memoria dell’educatore carcerario fu sporcata
da insinuazioni secondo cui avrebbe avuto una “condotta non specchiata” e troppo
propensa a prestare favori ai boss detenuti, sia a Parma che a Opera. Falso,
tanto che già nella stessa sentenza di condanna non lo si dava per certo, non
c’erano elementi per sostenerlo. Perché tornare a parlare adesso di tutto
questo? Per due ragioni. La prima è che il 19 luglio scorso, sul palco allestito
a Palermo, in via D’Amelio, per la commemorazione della strage in cui perse la
vita il giudice Paolo Borsellino 25 anni fa, sono saliti per la prima
volta Stefano e Nunzia Mormile, fratelli di Umberto. Insieme ad Armida Miserere,
la direttrice di carcere legata sentimentalmente all’educatore assassinato
e morta suicida a Sulmona il 19 aprile 2003, i fratelli hanno portato avanti per
anni ricerche in proprio e sono giunti a una conclusione: Umberto fu assassinato
perché testimone di una versione forse ante litteram del Protocollo Farfalla,
una sorta di accordo tra servizi segreti e amministrazione penitenziaria per
entrare in carcere e parlare con i boss al 41 bis, il regime di carcere duro.
Stefano e Nunzia Mormile lo hanno ripetuto pubblicamente pochi giorni fa in via
D’Amelio e lo hanno fatto in modo tanto vigoroso da essere stati avvicinati da
Nino Di Matteo, il pm palermitano oggi alla Direzione nazionale antimafia. La
seconda ragione per cui tornare a parlare di Umberto Mormile si lega alla prima,
l’esistenza di un antesignano del Protocollo Farfalla noto a Umberto e possibile
causa (o almeno concausa) del suo omicidio. Di questo si parla nell’ordinanza
‘Ndrangheta Stragista, quella che ipotizza (in realtà conferma aggiungendo nuovi
elementi rispetto a quelli già conosciuti) l’esistenza di un patto
terroristico tra malavita calabrese e Cosa nostra per destabilizzare lo Stato.
Proprio nelle 970 pagine dell’ordinanza compaiono le parole di Foschini e
a pagina 914 c’è un paragrafo che si intitola “Un filo rosso delle vicende
stragiste: le rivendicazioni Falange Armata. L’omicidio Mormile. La riunione di
Enna e le dichiarazioni di Cannella, Avola e Malvagna. Le dichiarazioni di
Foschini e Cuzzola. Il copyright della ‘ndrangheta e di settori deviati degli
apparati di sicurezza nazionale”. Sul delitto Mormile, che aveva già bloccato un
permesso di Domenico Papalia e stava rifiutando il secondo favore, intervennero
anche – scrive la gip di Reggio Calabria Adriana Trapani – i servizi segreti o,
più precisamente, “non identificati esponenti” degli apparati di sicurezza, che
suggerirono ai Papalia di usare la sigla Falange Armata per rivendicare il
delitto. Così successe e nell’ordinanza reggina si legge ancora (a parlare è
sempre Foschini): “Antonio Papalia, come ci disse (a me, a Flachi, a Cuzzola,
a Coco Trovato e altri) parlò con i servizi che, dando il nulla osta
all’omicidio Mormile, si raccomandarono di rivendicarlo con una ben precisa
sigla terroristica che loro stesso indicarono. Ecco la risposta alla domanda che
mi avete fatto con riferimento alla rivendicazione ‘Falange Armata’
dell’omicidio Mormile”. A questo proposito ha aggiunto il collaboratore di
giustizia Antonino Fiume: “Tutti gli omicidi di un certo tipo venivano decisi
dal ‘consorzio'”. Certo, affermazioni da riscontrare ancora, ma ce ne sarebbe
abbastanza per tornare a indagare sul delitto Mormile e sulle complicità di
uomini dello Stato in quell’omicidio. Per questo, forse, a processo ci fu chi
puntò sulla sua inesistente “condotta non specchiata”.
La Falange Armata: quell'abbraccio tra
mafie e servizi segreti, scrive Claudio Cordova
giovedì 27 luglio 2017 su "Il Dispaccio". La vicenda della Falange Armata,
collegata a centinaia di minacce, rivendicazioni, illecite inframmettenze nello
svolgimento di funzioni pubbliche di governo, ha generato lo svolgimento di
approfondite e complesse investigazioni in diversi Uffici Giudiziari. Va detto,
è questo è un dato giudiziariamente accertato, che, mai, seppure ipotizzata, è
stata trovata prova dell'esistenza di una vera e propria cellula
terroristica-eversiva, inquadrabile in una fattispecie associativa – con una sua
gerarchia interna, con una sua struttura, con un sua logistica, con armi, con
dei suoi mezzi economici, delle sue basi - che rispondesse al nome Falange
Armata. Essa è stata una sigla con la quale si sono, per un verso, rivendicati
stragi, delitti ed attentati fra il 1990 ed il 1994 organizzati e materialmente
eseguiti da soggetti non inquadrabili nella sedicente struttura in questione
(mafie, delinquenti comuni, ecc) e, per altro verso, anche, minacce, pressioni,
intimidazioni, calunnie, commesse in danno di esponenti istituzionali con
telefonate, missive, queste si confezionate da chi era intraneo alla sedicente
Falange. Dietro questa sigla, ovviamente vi erano persone. Più esattamente, un
gruppo - o forse, più di un gruppo - di soggetti che la utilizzavano per
raggiungere proprie finalità di natura politica e di destabilizzazione. Le
rivendicazioni avevano oggettivamente un fine chiaro ed evidente: colorando
della natura politico/terroristica fatti che non erano tali e la cui vera
finalità non poteva essere apertamente dichiarata (quella di ricattare le
istituzioni) servivano a creare un certo clima nel paese, evidentemente
favorevole alle finalità di chi poneva in essere le azioni criminali e dello
stesso gruppo che si nascondeva ed aveva intentato la sigla stessa. E il clima
che voleva crearsi era un clima di terrore. Dunque, più nel dettaglio,
l'intenzione di attribuire ad una organizzazione terroristica la responsabilità
di una serie di fatti anche gravissimi di sangue, aveva un duplice ordine di
ragioni: la prima, scontata, ragione (strumentale alla seconda) – che è
inevitabile conseguenza degli atti terroristici - era quella, come si è detto,
di creare paura nel paese. Che già conosceva il terrorismo e ne temeva la
ferocia. Tutto ciò per ottenere qualcosa.
Falange Armata – o almeno quel gruppo che aveva
inventato la sigla e la utilizzava secondo un preciso disegno – da un punto di
vista materiale, si limitava a rivendicare, minacciare, calunniare. La falange
armata, insomma, utilizzava le stragi e i gravissimi delitti commessi da altri
per rivendicarli (o farli rivendicare con tale sigla), per circonfondersi di un
alone di misterioso terrorismo, in grado di atterrire, intimidire, condizionare
e perseguire, per questa via, proprie finalità. Finalità che, stando alle
risultanze investigative, sarebbero esclusivamente di natura politica, quale
espressione di una (sordida) lotta per il potere. C'è un inquietante filo rosso
che lega le vicende stragiste. Alla fine del 2013, Tullio Cannella, le cui
dichiarazioni sono importanti con riferimento alla ricostruzione dei rapporti
anche di rilievo politico intercorrenti fra Cosa Nostra siciliana e 'Ndrangheta,
dichiarava: "...A questo punto della lettura del verbale si richiede al Cannella
se è in grado di meglio precisare cosa ebbe a sapere, nel contesto mafioso,
degli attentati del 92/93. Il Cannella dichiara: era il Luglio del 93, Leoluca
Bagarella era con me al villaggio Euromare di Buofornello. Era ora di pranzo ed
era accesa la televisione. Andò in onda il tg e diedero la notizia degli
attentati di Roma e Milano. A questo punto Bagarella che era proprio vicino a me
ad ascoltare il tg, disse con soddisfazione e con ironia:"vedi che ora queste
cose le "appioppano" alla falange armata" poi disse ancora con tono compiaciuto:
"...vedi ora come gli brucia il culo a questi politici!". Io gli dissi " ma
perché tu hai a che fare con i terroristi?". Bagarella rispose: "...Diciamo che
abbiamo avuto qualche contatto". La sera ricordo che Bagarella era di ottimo
umore. Gli avevo offerto i suoi sigari preferiti, i Barmorall. Se ne stava
compiaciuto a fumare. Ad un certo punto ritornò il discorso sugli attentati e
disse con tono serio "il "mio amico" ci ha a che fare con questi terroristi. Ma
devono fare quello che diciamo noi. Se sgarrano gli tagliamo la testa". Quando
Bagarella parlava con me del "suo amico" si riferiva univocamente a Provenzano
Bernardo. Di ciò sono certo. In particolare lui, come ho già detto, quando
doveva prendere una decisione importante mi diceva anche che ne doveva parlare
con il "suo amico". Capivo, intuitivamente, che l'unico amico che era al di
sopra di Bagarella, all'epoca (siamo dopo la cattura di Riina) era Provenzano.
Poi ne ebbi la certezza. Una volta, in quel periodo, mi disse che dovevo
risolvergli un problema del "suo amico" o meglio della moglie del suo amico e mi
diede dei documenti, non ricordo ora di che genere, che riguardavano Saveria
Palazzolo, moglie di Provenzano Bernardo. Insomma quando parlava del suo amico
era chiaro fra noi che si riferiva a Bernardo Provenzano. Quando con me parlava
dei Graviano, diceva: " quei cornuti dei Graviano". Diceva ciò in quanto sapeva
del mio rapporto conflittuale con i Graviano stessi.
ADR: dalle notizie che in quel momento passava il
tg, mi riferisco a quello di ora di pranzo che sentii con Bagarella, non si
faceva alcun riferimento alla Falange Armata. Dunque fu sicuramente Bagarella ad
introdurre il discorso sulla Falange Armata...omissis".
Cannella è stato il soggetto più vicino al boss di
Cosa Nostra Leoluca Bagarella nel periodo delle stragi. E' colui che, in
quell'epoca agevolava la latitanza del Bagarella, e, dunque, è colui che meglio
e più di qualsiasi altro collaboratore di giustizia è in grado di riferire le
reazioni, le frasi, i contatti, avuti dal Bagarella nel periodo della stragi
continentali. In primo luogo, dalle dichiarazioni di Cannella emergeva che lo
stesso Bagarella aveva affermato di avere rapporti con gli estremisti di destra.
E che tali rapporti, in particolare, erano riferibili (oltre che a lui stesso) a
Provenzano (il suo "amico"). In ogni caso gli estremisti dovevano fare quello
che dicevano "loro". Le carte dell'inchiesta "Ndrangheta stragista" si
soffermano sul fatto se i legami fra Cosa Nostra e la destra estrema - davvero
esistessero, in quanto gli ambienti deviati da cui derivava la sigla Falange
Armata, erano collegati e connessi alla destra eversiva. Nota la convergenza fra
Cosa Nostra, la destra eversiva di Stefano Delle Chiaie, la massoneria
controllata da Licio Gelli (i cui rapporti con la destra eversiva sono pure
stati ampiamente dimostrati) che si realizzò nei movimenti
autonomisti-separatisti, nei quali non a caso, proprio Bagarella e il suo uomo,
Tullio Cannella, ebbero ruolo significativo. E in effetti la sera del 14 Maggio
1993 e nella notte/mattina del 15 Maggio 1993, alcune ore dopo l'attentato di
via Fauro (che aveva come obbiettivo il giornalista Maurizio Costanzo) vennero
effettuate telefonate di rivendicazione "Falange Armata"; la mattina del
27.5.1993, dopo la strage di via dei Georgofili a Firenze, più telefonate
all'Ansa rivendicarono l'attentato a nome Falange Armata; dopo gli attentati di
Roma e Milano del Luglio 1993, furono effettuate rivendicazioni a nome Falange
Armata. E, tuttavia, il fatto che le gravissime attività stragiste in esame,
poste materialmente in essere da Cosa Nostra nel continente, fossero poi
rivendicate "Falange Armata", non sembra sia stato il frutto di un caso, di una
serie d' iniziative eterogenee e scoordinate fra loro che, però, hanno portato
ad un risultato omogeneo. Appare dimostrato, sulla base di convergenti (e
perfettamente sovrapponibili) dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia,
Salvatore Grigoli e Pietro Romeo, che Cosa Nostra, in persona di un uomo dei
Graviano, Giuliano Francesco detto "Olivetti", ebbe a rivendicare (anche se non
in tutti casi) con la sigla Falange Armata, gli attentati continentali. Questo
spiega agevolmente la ragione per la quale Bagarella sapesse di tale imminente
rivendicazione. E, come vedremo, si pone in perfetta coerenza e continuità con
quanto, già anni prima, Cosa Nostra, e prima ancora la 'Ndrangheta, avevano
concepito, programmato ed attuato. In particolare, Grigoli, il 26.3.2015, nel
riferire degli intensi rapporti fra la famiglia di Brancaccio ed i calabresi,
dichiarava:
"...A.D.R: Giuliano Francesco detto Olivetti -
durante un incontro a cui eravamo presenti io, il predetto, Spatuzza, Cosimo Lo
Nigro e forse altri, incontro durante il quale stavamo preparando, in un sito di
Palermo dalle parti di Corso dei Mille, l'esplosivo per lo Stadio Olimpico - ad
un certo punto, ci disse che era stato proprio lui a fare le rivendicazioni
"Falange Armata" relative ai precedenti attentati sul continente. Se non erro
disse che queste rivendicazioni le faceva da Roma. Ma non sono sicuro.
A.D.R: il Giuliano Francesco, di carattere è un
po' chiacchierone e a volte dice cose che non dovrebbero dirsi secondo le regole
di Cosa Nostra. Io ad esempio delle rivendicazioni al suo posto non ne avrei
parlato.
A.D.R: Ovvio che tale iniziativa, quella della
rivendicazione, era così delicata che il Giuliano (che seppure era chiacchierone
non era bugiardo) non poteva che averla presa se non a seguito di un ordine
superiore che non poteva che venire da Giuseppe Graviano (più che da Filippo).
Questo il Giuliano non lo disse espressamente o meglio non ricordo se lo disse o
no, ma è certo, in base alle nostre regole interne, che dovesse essere stato
Graviano Giuseppe che coordinava in modo puntuale tutta l'attività stragista a
dare questo ordine.
A.D.R: Effettivamente non so neanche io - e
certamente neppure lo sapeva il Giuliano - cosa fosse esattamente la "Falange
Armata". Io ritenevo fosse una sigla terroristica tipo Brigate Rosse ovvero
altra sigla anche di estrema destra, per me era lo stesso. Prendo atto ed
informazione dalla SV, che si tratta di una sigla che venne usata per la prima
volta in Spagna in epoca franchista. Se è così, e non ne dubito, si tratta di
una cosa molto raffinata e neppure Graviano Giuseppe, aveva una simile cultura.
Direi che in Cosa Nostra quello che aveva più cultura era Matteo Messina Denaro
che io ho personalmente conosciuto.
A.D.R: Io ho sempre pensato che fosse scontato che
la rivendicazione Falange Armata servisse a depistare le indagini e sono
convinto sia così anche in considerazione della vicenda Contorno. Non bisognava
capire, o almeno non doveva apparire una immediata riconducibilità degli
attentati di Roma, Firenze, Milano e dell'Olimpico a Cosa Nostra, mentre era
inevitabile pensare che l'attentato a Contorno era riconducibile a noi. Per tale
ragione, mentre facevamo uso di tritolo per gli attentati precedenti e fra
questi l'Olimpico, per l'attentato a Contorno usammo della gelatina ed un
esplosivo bianco, granuloso che noi chiamavamo dash, assai diverso dal tritolo.
Preciso a sua richiesta che, ovviamente, qualcuno doveva capire che c'entravamo
noi con questi attentati continentali, altrimenti che li facevamo a fare, ma non
doveva essere immediatamente visibile la nostra presenza, la nostra mano. Chi di
dovere doveva capire e venirci incontro riducendo il carcere duro e le altre
misure contro il crimine organizzato. Erano discorsi che facevamo sempre
all'interno del gruppo di Brancaccio che si occupava di queste vicende. Dovrei
avere parlato di questi fatti anche con Nino Mangano.
A.D.R: Vidi di persona, per una delle ultime volte
(o forse era anche l'ultima volta, ma a distanza di anni non posso essere
sicuro) Giuseppe Graviano a Roma più esattamente lo vidi in una villetta vicino
al mare in una località nei pressi di Roma che si chiama Torvajanica. Era un
giorno o forse due giorni (propendo più per due giorni) prima dell'attentato
fallito dell'Olimpico. Non ricordo esattamente l'ora in cui arrivò il Graviano
ma era buio, forse era sera o pomeriggio inoltrato. A vostra domanda escludo di
essere stato presente, sempre in quel giorno o anche il giorno prima o il giorno
dopo, in un locale di via Veneto a Roma di nome Donnay unitamente al Graviano
Giuseppe e allo Spatuzza. Escludo di essere mai stato con Graviano in locali di
Via Veneto. A sua domanda non posso escludere che prima o dopo il suo arrivo a
Torvajanica il Graviano si sia visto con lo Spatuzza nel predetto locale. Non
conosco la circostanza. Nel villino di Torvajanica quella sera iniseme a me e
Giuseppe Graviano c'erano Spatuzza, Giuliano, Lo Nigro, Benigno Salvatore,
Giacalone e forse altri. Forse, ma non sono sicuro, vi era anche Vittorio Tutino
ovvero Cristoforo, detto Fifetto, Cannella, unitamente al Graviano quali suoi
accompagnatori. A sua domanda preciso che non posso assolutamente escludere che
il Graviano giunse a Torvajanica anche insieme allo Spatuzza o con lo stesso.
Dato il tempo trascorso, di questi dettagli non ho ricordo preciso. A vostra
ulteriore domanda rispondo che non ricordo che nel villino, ovvero in altre
circostanze legate all'attentato alla FFOO dello Stadio Olimpico, si sia fatto
riferimento a vicende calabresi più o meno simili.
ADR: Ricordo che nel corso dell'incontro nel
villino in questione Giuseppe Graviano nel dire che bisognava concludere e
portare a conclusione, immediatamente, l'attentato all'olimpico da subito (già
il giorno dopo o forse quello ancora successivo) disse che bastavano quattro
persone per fare l'attentato, per cui invitò me e se non sbaglio il Giuliano a
ritornarcene in Sicilia. In effetti la mattina successiva partimmo per la
Sicilia io e probabilmente come ho detto il Giuliano...
ADR: Era il Lo Nigro che aveva stretti rapporti
con la 'ndrangheta come la vicenda del traffico di "erba" con la 'ndrangheta e
la sua partecipazione a cerimonie che si svolsero in Calabria, tipo matrimoni,
dimostrano (sono fatti di cui ho ampiamente già parlato). Ricordo che in questa
occasione di viaggio in Calabria il Lo Nigro venne anche fermato dalla polizia.
Può darsi, non posso escludere, che pure i Graviano avessero questi rapporti in
Calabria, ma non sono in grado di dire fatti specifici.
ADR: Non sono in grado di riferire di viaggi dei
Graviano in Calabria. Ricordo, invece, che Giacalone nel corso del 93/94, talora
andava a Milano, presso un Ristorante di cui non ricordo il nome su diretta
richiesta di Giuseppe Graviano e/o di Mangano per consegnare delle lettere al
proprietario di questo ristorante che non so dire chi sia. Forse potrebbe essere
anche un calabrese come la SV mi chiede. Giacalone che era mio socio in una
rivendita di auto e che era con me in grande confidenza, mi raccontava di questi
viaggi milanesi o spesso partiva organizzando proprio davanti a me il viaggio.
Mi disse che una volta si era trovato in mezzo ad una sparatoria in un bar o
comunque in un locale milanese in cui casualmente si trovava nel corso del
viaggio che aveva fatto per recapitare queste lettere. Non conosco il contenuto
di queste lettere.
ADR: La mia conoscenza dei fatti stragisti si
limita a ciò che avvenne in Cosa Nostra nel gruppo in cui operavo quello del
mandamento di Brancaccio in cui era inclusa la famiglia di Corso dei Mille cui
io appartenevo. Non so dire se vi furono condivisioni della strategia stragista
con entità criminali diverse da Cosa Nostra..."
A sua volta, il collaboratore di giustizia, Pietro
Romeo, il 26.3.2015, anche lui rimarcando i rapporti fra la famiglia di
brancaccio ed i calabresi, riferiva: "...A.D.R. Mi chiedete se nel contesto
della mia partecipazione ai fatti stragisti continentali ho avuto informazioni
sulle rivendicazioni "Falange Armata". Vi rispondo di sì. Premetto che io sono
uscito dal carcere tra la fine del 1993 e gli inizi del 1994. Quando uscii dal
carcere – ero detenuto per delle rapine che avevo fatto - non ero uomo d'onore
e, per la verità, non lo sono mai diventato. Tuttavia partecipai alle attività
del gruppo di Brancaccio. In pratica quando, dopo la mia scarcerazione incontrai
Giuliano Francesco, che io conoscevo come appartenente a Cosa Nostra, che faceva
capo a Tagliavia Francesco di Corso dei Mille/Via Messina Marina, figlio di
Giuliano Salvatore, esponente di rilievo della famiglia di Corso dei Mille. Del
gruppo del Tagliavia facevano parte anche il Cosimo Lo Nigro ed il Barranca
Giuseppe. Ebbene il Giuliano Francesco mi propose di entrare nel gruppo di fuoco
guidato all'epoca da Nino Mangano. Si tenga presente che all'epoca erano in
carcere sia i Graviano (capi di Brancaccio ma molto legati alle famiglie di
Corso dei Mille e via Messina Marina) che il Tagliavia. Io accettai e così andai
dalle parti di Roma ad aggregarmi al gruppetto che in quel momento doveva fare
l'attentato a Contorno in località Formello, vicende tutte su cui ho reso ampie
dichiarazioni. Venendo alla sua domanda le dico che il Giuliano che era persona
molto loquace, di sua iniziativa, non solo mi parlo degli attentati precedenti
(quelli di Roma, Firenze e Milano) ma mi raccontò anche che era stato proprio
lui a telefonare, dopo gli attentati, rivendicando gli stessi a nome Falange
Armata. Non ricordo a chi telefonò per fare le rivendicazioni. Mi disse,
comunque, che così gli avevano ordinato di fare e lui così fece ed anche se lui
non mi ha detto chi gli diede questo ordine, io penso che a darlo possano essere
stati solo i Graviano o il Tagliavia perché Giuliano prendeva ordini da loro e
comunque non poteva prendere una iniziativa così importante senza che i capi lo
autorizzassero. Il Giuliano mi spiegò che, seppure le stragi erano state volute
per affievolire il regime di carcere duro contro la criminalità organizzata e
per avere, più in generale, dallo Stato, un migliore trattamento, tuttavia non
si voleva – evidentemente da parte chi gli aveva dato l'ordine di fare le
rivendicazioni in questione (e quindi da chi stava sopra a chi gli aveva dato
tali ordini) - che fosse immediatamente ricollegata la strategia stragista a
Cosa Nostra. Insomma queste rivendicazioni servivano a "depistare". Per la
verità io dissi a Giuliano: ma tu pensi che facendo così lo Stato si arrende?
Non ricordo la sua risposta ma certo non mi disse nulla di significativo se no
lo ricorderei, almeno penso.
A.D.R: Giuliano, come ho detto era un
chiacchierone. Dunque parlava spesso di questi argomenti. Non posso dirle dove
esattamente mi disse queste cose. Direi sia in Sicilia che in Continente quando
eravamo insieme.
A.D.R: Era Cosimo Lo Nigro, che aveva rapporti
privilegiati con i calabresi. Ricordo che il Lo Nigro addirittura andava a dei
matrimoni o battesimi o comunioni, non ricordo, di questa famiglia di
'ndrangheta che si celebravano in Calabria, non ricordo dove. La cosa me la
disse lo stesso Lo Nigro. Inoltre come ho già ampiamente raccontato (su questi
fatti sono stati celebrati dei processi) Lo Nigro faceva affari di ogni genere,
sia nel settore della droga che delle armi, con i calabresi ed, in particolare,
con la famiglia di questo Peppe presso cui era anche andato in occasione delle
ricorrenze sopra indicate. Ho partecipato in prima persona e quindi rinvio alle
dichiarazioni rese an suo tempo in quanto ovviamente ricordavo meglio i
dettagli, a queste operazioni di traffico di droga e armi svolte insieme ai
calabresi. Il fatto più eclatante che ricordo fra i tanti è che il Lo Nigro,
sotto i miei occhi, mise 500 milioni in contanti all'interno dello sportella
della sua vettura smontando un pannello. Tali soldi li portò in Calabria da
Peppe o dai suoi amici per investirli in un ulteriore carico di droga. Erano i
calabresi che avevano i contatti con i produttori e dunque a loro ci si
rivolgeva. Tutto ciò avveniva subito dopo i fatti di Formello fra il 1994 ed il
1995. Ricordo anche di avere visto con i miei occhi il Peppe a Palermo vicino la
casa di famiglia di Cosimo Lo Nigro, con una Renault Clio Williams blu. Era una
vettura particolare dunque la ricordo. Portammo noi di Cosa Nostra, nel 94, dal
Marocco, "fumo" dei calabresi fino a Palermo. In cambio avemmo una parte del
carico ed il restante lo consegnammo alla famiglia di Peppe. Ricordo che tale
carico lo portarono a Milano, con un camion, Piero Carra e Cosimo Lo Nigro. Nel
traffico era implicato un altro calabrese, Giovanni detto "Virgilio", calabrese.
A.D.R: Non sono in grado di dire come il Lo Nigro
avesse stretto in modo così significativo i rapporti con i calabresi. Mi
chiedete se si trattava di amicizie dei Graviano ed io vi dico che non sono in
grado di rispondere.
A.D.R: Non sono in grado di riferirle se la
strategia delle stragi continentali ebbe un consenso anche da parte di altre
organizzazioni di tipo mafioso. Io non avevo rapporti con i capi di tali
organizzazioni. Neppure il Giuliano era all'altezza di avere questi rapporti i
vertici di altre entità criminali...omissis".
La sigla Falange Armata, che Cosa Nostra decise di
adottare ad Enna e che, quasi contestualmente (leggermente prima) la 'Ndrangheta
decise di adottare, richiamava coordinate e conoscenze storico/politiche
piuttosto ricercate . Il precedente più vicino (anzi, l'unico, per la verità,
nella storia contemporanea, moderna e medievale) ed anche più congruo, era
quello dei cd falangisti, della destra franchista spagnola del secolo scorso. In
particolare, come è noto agli storici, la "Falange Espanola de las J.O.N.S." fu
una formazione di ispirazione fascista fondata nella Spagna della Seconda
repubblica da Josè Antonio Primo de Rivera nel 1933. Nel 1937, in piena guerra
civile spagnola, si fuse con il movimento nazionalista e diede vita al partito
"Falange Espanola Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional
Sindicalista – FET y de las JONS", in cui confluirono le forze legate ai vecchi
valori monarchici, clericali e conservatori. Il generale Francisco Franco ne
assurse a leader indiscusso e, nel 1939, il "FET y de las JONS" diventa
"Movimento Nacional", partito unico franchista. Se vogliamo andare più dietro
nel tempo per trovare un altro riferimento alla Falange, è necessario affidarsi
alle reminiscenze degli studi classici, evocando la cd Falange Macedone. Si
tratta, come si vede, di riferimenti storici che, francamente, stridono con il
livello culturale ed il grado di conoscenza della storia e della politica,
antica e moderna, di Riina, Provenzano, Bagarella, Filippone, Papalia e
compagni. E allora, forse, vi sono delle menti ancor più sopraffine dietro.
Squarci di luce arrivano, ancora una volta, dalle dichiarazioni messe nero su
bianco in fase di indagine. A cominciare da Filippo Malvagna, nipote del noto
Giuseppe Pulvirenti detto "'u malpassotu". Egli, nel corso dell'interrogatorio
del 9 maggio 1994, confermava un dato fondamentale riguardante la genesi della
strategia terroristica di cui Cosa Nostra fu massima artefice: la riunione,
meglio, le riunioni "strategiche" di Enna della fine del 1991, in cui venne
decisa la necessità di dare uno scossone allo Stato, innescando una spirale del
terrore. Fatto di cui aveva riferito Leonardo Messina. E tuttavia, Malvagna,
disvelava un particolare di non secondario rilievo relativo a tali riunioni:
"...Girolamo Rannesi mi riferì della disponibilità offerta da Santo Mazzei a
partecipare ad attentati da eseguire in Toscana e a Torino. Questi attentati
rientravano in un grande programma di "guerra allo Stato" che cosa nostra per
volontà di Totò Riina stava ponendo in essere...
A.D.R: Come ho già dichiarato io ero bene a
conoscenza dell'esistenza di una strategia di Cosa Nostra volta a colpire lo
Stato sia in Sicilia che fuori dall'isola. Infatti, ritengo nei primi mesi del
1992, di aver saputo da Giuseppe Pulvirenti che qualche tempo prima e ritengo
pertanto verso la fine del 1991 si era svolta in provincia di Enna, in una
località che non mi venne indicata, una riunione voluta da Salvatore Riina alla
quale avevano partecipato rappresentanti ad alto livello di Cosa Nostra
provenienti da varie zone della Sicilia. Per Catania vi aveva partecipato
Benedetto Santapaola che aveva poi riferito ogni particolare dell'incontro al
Pulvirenti. Il Pulvirenti non mi raccontò chi fossero gli altri partecipanti
alla riunione alla quale comunque era presente Salvatore Riina in persona.
Ricordo che mi spiegò che la provincia di Enna veniva scelta di frequente per
questi incontri perché era una zona non molto presidiata dalle forze
dell'ordine. Ciò su cui il Pulvirenti fu più preciso riguardò l'oggetto della
riunione. Il Riina aveva fatto presente che la pressione dello Stato contro Cosa
Nostra si era fatta più rilevante e che comunque vi erano dei precisi segnali
del fatto che alcune tradizionali alleanze con i pezzi dello Stato non
funzionavano più. In pratica erano "saltati" i referenti politici di Cosa Nostra
i quali, per qualche motivo, avevano lasciato l'organizzazione senza le sue
tradizionali coperture...
A.D.R: Quanto alle ragioni dell'attacco allo Stato
voluto da Riina e su cui si erano trovati pienamente d'accordo Santapaola e gli
altri partecipanti alla riunione in provincia di Enna, il Malpassotu mi riferì
solo una frase che sarebbe stata pronunciata da Riina: "Si fa la guerra per poi
fare la pace" (N.d.PM : si tratta esattamente della ricostruzione operata nelle
sentenze fiorentine sulle stragi). Successivamente ebbi modo di discutere ancora
con il Pulvirenti riguardo alle finalità di questa strategia di Cosa Nostra.
Secondo il Malpassotu, ora che molti accordi con il potere politico erano venuti
meno bisognava fare pressione sulle Stato per altre vie sia allo scopo di
indurre gli apparati dello Stato anche a delle trattative con la mafia sia,
quanto meno, per allentare la pressione degli organi dello Stato su Cosa Nostra
e sulla Sicilia. Non posso essere più preciso su ciò, ma ricordo che il
Malpassotu mi raccontò che si era deciso che tutte le future azioni
terroristiche di Cosa Nostra venissero rivendicate con la sigla "Falange
Armata"..."
Malvagna, quindi, veniva nuovamente escusso il
20.5.2015: "...A.D.R: Secondo il racconto di mio zio Malpassotu, furono i
Corleonesi - ed in particolare Totò Riina - a dire, ad Enna, che tutti gli
attacchi allo Stato dovessero essere rivendicati "Falange Armata". Quando mio
zio disse questa sigla in compresi che si trattava di un qualcosa che doveva
rappresentare un riferimento ad una qualche organizzazione terroristica. Poi mio
zio mi spiegò ancora meglio. Mi disse che bisognava confondere le acque. Non
bisognava fare capire all'opinione pubblica e allo Stato che eravamo noi mafiosi
a sviluppare questa strategia terroristica ma dovevamo gettare sconcerto e
scompiglio fino ad indurre lo Stato a cercare una interlocuzione con noi. Mio
zio mi disse per farmi comprendere a cosa alludesse che bisognava fare come in
Colombia dove i trafficanti di cocaina quando erano stati duramente attaccati
dallo stato colombiano che veniva supportato dalla DEA e dagli americani, iniziò
a porre in essere, sotto mentite spoglie, una strategia di attentati
terroristici che indussero lo Stato a scendere a compromessi con loro. Non so
dire se questo esempio storico di mio zio sia corretto ma così mi disse. In ogni
caso mio zio mi spiegò che bisognava da subito attivarsi anche con atti soltanto
dimostrativi. Bisognava creare da subito un clima di paura. Fu così che
immediatamente presi la palla al balzo e chiesi a mio zio se potevo fare
giungere delle minacce all'allora sindaco di Misterbianco a nome Antonino Di
Guardo che era un sindaco "antimafia" che ci dava fastidio denunciando
pubblicamente il nostro sodalizio. Mio zio assentì e così io incaricai un
giovane di mia fiducia tale Alfio Adornetto che faceva parte del gruppo che io
dirigevo di telefonare a casa di questo sindaco e minacciarlo, rivendicando le
minacce con la sigla Falange Armata. La cosa avvenne (siamo nella primavera del
1992) e se non sbaglio questo Sindaco è stato pure ascoltato come teste nel
processo per la strage di Capaci nella quale pure io sono stato escusso. Ricordo
anche che venne fatto un attentato dimostrativo davanti alla Caserma di Piazza
Verga dei Carabinieri e anche in questo caso facemmo la rivendicazione Falange
Armata. Di questo attentato si occuparono gli uomini di D'Agata. In quello
stesso periodo erano in preparazione ma non ricordo se andarono ad effetto altre
minacce o atti intimidatori con le stesse modalità ai danni del giornalista
Claudio Fava, dell'avvocato Guarnera che difendeva i collaboratori di giustizia
e il Sindaco Bianco (non ricordo se all'epoca fosse o meno in carica). Tutto ciò
avveniva nello stesso periodo in cui il Santo Mazzei dava la disponibilità a
fare attentati in continente. A proposito di ciò ricordo che mio zio il
Malpassotu diceva che se il Mazzei fosse riuscito davvero ad eseguire gli
attentati che si riprometteva di compiere avrebbe fatto una carriere fulminate
superandoci nella gerarchia mafiosa. Ovviamente diceva ciò con preoccupazione in
quanto temeva che noi perdessimo potere...omissis....
Le affermazioni di Malvagna, trovavano, poi,
conferma nelle convergenti dichiarazioni di altro collaboratore di Giustizia
catanese, Maurizio Avola, che aveva già parlato della riunione di Enna del 1991
nella quale i vertici di Cosa Nostra siciliana avevano deciso di attaccare lo
Stato con atti terroristici in quanto i suoi rappresentanti non erano più
affidabili con la conseguente necessità di creare una situazione di panico
diffuso che avrebbe agevolato rivolgimenti politici favorevoli alle mafie. E
tuttavia, anche Avola, peraltro in piena consonanza con sue pregresse
dichiarazioni, nel corso dell'interrogatorio reso a questo Ufficio, in data
14.4.2015, dichiarava: "....ADR: Furono Aldo Ercolano e Marcello D'Agata che
dissero a noi della famiglia Santapaola, quando già Santo Mazzei era divenuto un
esponente di rilievo di Cosa Nostra catanese, in mia presenza, che laddove
fossero stati eseguiti gli attentati contro lo Stato che avevano deciso i
corleonesi, bisognava ricorrere a delle rivendicazione "di comodo" che non
dovevano consentire di collegare gli attentati a Cosa Nostra, che, infatti, non
rivendica mai le proprie azioni. Dissero che bisognava utilizzare la sigla
Falange Armata. A vostra domanda vi dico che non sono in grado di dire come sia
stata "inventata" questa sigla. Io pensavo che fosse una rielaborazione delle
"Falangi" con cui si denominavano gli ultras del tifo calcistico. Ma si tratta
di una mia ricostruzione e di una mia ipotesi. I miei capi non spiegarono
l'origine della sigla. Faccio presente che allorquando nel 1992 venne collocato
a Piazza Verga un ordigno di fronte ad una caserma dei CC da parte di Pippo
Ercolano, venne fatta una rivendicazione Falange Armata. L'atto intimidatorio
venne posto in essere dall'Ercolano perché all'epoca i CC indagavano su di una
sua impresa. A vostra domanda preciso che non posso né escludere né affermare
che fosse stato Santo Mazzei ad inventarsi questa sigla Falange Armata...".
Oscuri e inquietanti gli interrogativi su chi
inventò la sigla Falange Armata, l'esatta individuazione e collocazione nel
tempo delle modalità attraverso cui Cosa Nostra (e, soprattutto, la 'Ndrangheta)
decisero di utilizzare la rivendicazione "Falange Armata" in occasione di eventi
stragisti ovvero di delitti che, comunque, avevano come bersaglio figure
istituzionali o politiche, e la individuazione del momento in cui le mafie, e
non altri, iniziarono ad utilizzare concretamente la stessa. Oscuri e
inquietanti gli interrogativi sui suggeritori esterni. L'idea di rivendicare
minacce, attentati, delitti contro figure istituzionali con la sigla Falange
Armata è stata il parto di alcuni appartenenti a strutture deviate dello Stato –
il cui nucleo forte era costituito da una frangia del SISMI e, segnatamente, da
alcuni esponenti del VII Reparto cd "Ossi" che, fino alla caduta del muro di
Berlino (o, fino a pochi mesi dopo) si occupava di Stay Behind – che,
evidentemente, volevano destabilizzare il paese creando un nuovo allarme
terroristico; costoro – che non scordiamolo avevano operato per anni agli ordini
di Licio Gelli, suggerirono alla criminalità mafiosa e segnatamente, per primi,
agli uomini della 'Ndrangheta, di rivendicare un omicidio di un funzionario
dello Stato con la sigla "Falange Armata". Pochi mesi dopo, l'idea di usare
questa rivendicazione, venne fatto proprio anche da Cosa Nostra, nel corso della
riunione Enna. L'idea delle mafie di rivendicare le stragi con la sigla Falange
Armata non era una trovata bislacca e cervellotica dei capi delle mafie, ma
rispondeva perfettamente alle loro esigenze strategiche; era stata approvata da
Cosa Nostra, nel lontano 1991, ad Enna, nello stesso periodo storico in cui Cosa
Nostra e le altre mafie iniziarono a dare sostegno, con Gelli e l'estrema
destra, alle cd liste autonomiste; il loro concreto atturarsi in occasione delle
stragi continentali era noto e gradito al reggente di Cosa Nostra nel 1993
(Leoluca Bagarella) prima ancora che tali rivendicazioni fossero note. In tal
senso, non è affatto secondario il rilievo di quanto, sempre sul conto di
Bagarella, riferiva un collaboratore di giustizia siciliano, Emanuele Di
Filippo, alla fine del 2013: "...A.D.R.: Ho fatto parte, originariamente, del
gruppo di fuoco di Ciaculli nel corso dei primi anni 80'. Ero uomo d'onore ma
non ritualmente "punto". Il mio capo, all'epoca, era mio cognato Marchese
Antonino. Dopo il suo arresto avvenuto credo nel 1982, cominciai a prendere
ordini da Giuseppe Lucchese detto "lucchiseddu" con il quale ho commesso
numerosi omicidi per i quali sono già stato giudicato. Intorno alla metà degli
anni 80', precisamente intorno al 1985, riuscii a "sganciarmi" dal ruolo
"ingrato" di killer ed iniziai ad operare nel settore degli stupefacenti, delle
estorsioni e del contrabbando di sigarette. Come ho già ampiamente spiegato, per
svolgere tale mia ultima attività, nella quale sono stato impegnato fino al mio
arresto nel 1994 ( ho iniziato a collaborare nel 1995, e grazie alle mie
indicazioni e dichiarazioni venne catturato Leoluca Bagarella ) seppure rimanevo
"inquadrato" nella famiglia di Ciaculli, operativamente mi sono "spostato" nella
zona di Brancaccio/ Corso dei Mille, dunque, in tale contesto, facevo
riferimento ai fratelli Graviano anche se costoro, ovviamente, non erano i miei
capi.
ADR: Io avevo rapporti risalenti nel tempo e
consolidati con Leoluca Bagarella dovuti a motivi di parentela. In particolare
mia sorella si era sposata con Marchese Antonino che era il fratello della
moglie di Leoluca Bagarella che si chiamava Vincenzina. A ciò si aggiunga che i
rapporti fra i Graviano e Bagarella erano assai stretti e che io stesso facevo
da tramite fra il mio predetto cognato, detenuto a Voghera, e Totò Riina –
notoriamente vicinissimo a Bagarella di cui era cognato – facendogli pervenire
dei pizzini di Riina stesso, pizzini che mi venivano consegnati, chiusi e
sigillati, da Filippo Graviano...
ADR: Cesare Lupo era persona inserita in Cosa
Nostra, molto vicina ai Graviano, anche se operava principalmente con la
famiglia di Corso dei Mille (il cui territorio peraltro è limitrofo a quello di
Brancaccio). Ho conosciuto il Lupo da libero nei primi anni 90', ma si è
trattato di incontri occasionali. Mio fratello Pasquale, che pure collabora, ha
avuto, invece, con il Lupo, rapporti più intensi e penso possa dirle su di lui
qualcosa in più. Di seguito, in ogni caso, ebbi modo di rivedere ed incontrare
il Lupo presso il Carcere dell'Ucciardone. Mi sembra alla sezione seconda.
Eravamo nel 1994.
ADR: Mi si chiede se confermo quanto riferito alla
DDA di Firenze nel già citato interrogatorio, sul fatto che il Lupo mi parlò di
collegamenti fra il Leoluca Bagarella ed ambienti istituzionali deviati.
Rispondo che lo confermo. In pratica il Lupo, proprio mentre ci trovavamo
all'Ucciardone e parlavamo di pentiti, mi disse che Leoluca, prima o poi, li
avrebbe individuati grazie ad informazioni che riceveva da qualcuno dei servizi
segreti ....omissis".
Se, quindi, come risulta, vi erano rapporti o
contatti fra il Bagarella ed esponenti dei servizi si ha una ulteriore traccia -
coerente rispetto alle altre fonti di prova che consente di individuare in
alcuni esponenti deviati dei Servizi di Sicurezza, suggerì a Cosa Nostra - in
epoca antecedente e prossima alla riunione dell'estate 1991 ad Enna in cui la
sigla venne adottata dal sodalizio mafioso - di utilizzare, per la
rivendicazione delle stragi, la sigla Falange Armata. Specie se si considera che
proprio il Bagarella era ben consapevole della funzione e delle finalità della
strategia di rivendicazione delle stragi da parte di Falange Armata. Ed in
questo ambito è ben possibile, oltre che coerente, che in più ampio quadro
pattizio e, quindi, in un ambito in cui si erano individuati obbiettivi di
comune interesse, si fosse proceduto ad una divisione di impegni e compiti fra i
diversi partners, nel quale, le mafie, per la loro parte, si erano impegnate a
"fare rumore". E, ovviamente, si badi bene, non deve affatto pensarsi che Cosa
Nostra (e la 'Ndrangheta) avessero preso questi impegni controvoglia,
sottomettendosi ad altri. Anzi. Le Mafie intendevano ricattare ed atterrire lo
Stato con il terrorismo. Anche favorendo un ricambio della classe politica. In
particolare, è noto che anche Licio Gelli – ed un suo vasto entourage - avevano
preso parte, con ruolo di primario rilievo, al disegno di disgregazione del
panorama politico istituzionale della Prima Repubblica. Ma tornando alle
intelligenze fra Cosa Nostra e servizi deviati un importante elemento cognitivo,
pienamente convergente rispetto a quelli fino ad ora evidenziati e che rafforza,
quindi, la ricostruzione fino ad ora prospettata, proviene dalle affermazioni
del collaboratore di Giustizia Armando Palmeri, legato alla mafia di Alcamo, che
fin dall'inizio della sua collaborazione (nel 1998) aveva segnalato un episodio
davvero inquietante. In particolare all'inizio del luglio 2016, Palmeri
riferiva: "...ADR: Sono entrato in Cosa Nostra nel 1991. Nel 1995, avendo già
preso le distanze da Cosa Nostra, con la quale era però rimasto in contatti, ho
iniziato a collaborare informalmente con gli inquirenti, facendo in buona
sostanza l'informatore e, poi, nel 1998 ho formalmente iniziato collaborare con
la AG ottenendo il programma di protezione.
ADR: All'interno di Cosa Nostra non ero uomo
d'onore ufficialmente, ma ero persona "riservata" di Milazzo Vincenzo,
capo-mandamento di Alcamo. Mi spiego meglio: ero inizialmente e sono rimasto
amico personale di Milazzo fino a quando non è stato ucciso nell'estate del
1992. Eravamo amici da alcuni anni, un paio circa. Io ero persona di fiducia del
Milazzo, anche per gli affari di mafia del predetto. Spesso lo spostavo. Tenete
conto che da quando io ebbi a conoscerlo era già latitante. Preciso che non ero
stipendiato ma semplicemente molto legato al Milazzo. Ovviamente se e quando
chiedevo dei soldi in relazione alle mie necessità, Milazzo me li dava. Ma in
quel contesto più dei soldi contava la sincera amicizia. Io all'epoca ero
istruttore di nuoto presso la piscina Camping El Baira di S.Vito lo Capo e alle
Terme Segestane.
ADR: Con riferimento a contatti fra il Milazzo ed
esponenti di apparati statali o sedicenti tali, posso dire che nel 1991 e,
comunque, alcuni mesi prima dell'omicidio del Milazzo (non so dire se 1 anno, 6
mesi, 8 mesi prima o altro è passato troppo tempo) e comunque prima della strage
di Capaci accompagnai il Milazzo ad un incontro che si tenne nelle campagne di
Castellammare (svincolo che va a Scopello) in una villetta di pertinenza di tale
Manlio Vesco. In effetti, precisamente, la villetta, era in contrada Consa.
Costui, il Vesco, era un imprenditore amico del Milazzo, poi morto suicida, in
circostanze molto particolari. Appresi, infatti, che stranamente il Vesco, prima
di morire, aveva posteggiato la vettura lungo l'autostrada vicino lo svincolo di
Alcamo per poi percorrere chilometri e chilometri a piedi, per poi, infine,
lanciarsi nel vuoto. Ricordo che anche i mezzi d'informazione sottolinearono la
stranezza del fatto.
ADR: Ricordo che Milazzo in occasione di questo
primo incontro in contrada Consa, mi chiese di partecipare allo stesso. Io mi
rifiutai, non volevo espormi e preferivo rimanere nell'ombra. Allora Milazzo mi
disse di non entrare nella villetta ma di attenderlo fuori, rimanendo defilato
ed invisibile, avendo cura di controllare i movimenti che potevano esserci
intorno alla villa stessa. All'uopo mi diede anche un binocolo. Vidi arrivare
due vetture dopo l'arrivo del Milazzo da cui uscirono, da una, due persone che
non conoscevo (si trattava di persone ben vestite di circa 40 anni, che
escluderei potessero essere dei "picciotti") accompagnate dal dott. Baldassarre
Lauria, medico primario dell'Ospedale di Alcamo che io già conoscevo fisicamente
e che li seguiva o precedeva con l'altra macchina. A seguito dell'incontro
Milazzo mi apparve molto preoccupato e turbato. Lui aveva molta fiducia in me e
senza che io chiedessi nulla (in Cosa Nostra non si chiede) mi raccontò che le
due persone venute con il Lauria erano due dei servizi segreti i quali senza
giri di parole avevano richiesto al Milazzo di fare una attività di tipo
terroristico in continente per loro conto. Se non ricordo male gli chiesero di
fare degli attentati in continente. Non sono sicuro se in questa occasione si
parlò di Firenze, come uno dei luoghi in cui fare attentati o se invece con
riguardo a questo stesso argomento la città di Firenze non venne in
considerazione successivamente in quanto luogo ove si trovavano dei parenti
della famiglia Ferro che avrebbero potuto fare da appoggio per la commissione
dell'attentato. Su questo vi dirò in seguito procedendo con ordine. E' certo
che, comunque, questi attentati andavano fatti in continente e in tale contesto
in effetti, mi disse il Milazzo, che il dott. Lauria che partecipò alla
discussione con quelli dei servizi, tirò fuori l'idea di procedere anziché con
attentati dinamitardi con l'avvelenamento delle acque, a mezzo ii batteri.
Insomma secondo il Lauria era più agevole avvelenare l'acquedotto (ubicato,
forse, ma come ho detto non ricordo con certezza, a Firenze). Il Milazzo mi
disse che l'idea del Lauria della guerra batteriologico venne tuttavia subito
esclusa e rimase in campo solo l'idea degli attentati tradizionali con
esplosivo.
ADR: Secondo quanto mi disse il Milazzo, negli
intenti di costoro – e cioè di quelli dei servizi - vi era quello di
destabilizzare lo Stato. Non so dirvi perché volessero destabilizzare lo Stato
nel senso che Milazzo su questo aspetto nulla disse. Posso invece dirvi che il
Milazzo, all'esito di questo primo incontro si riservò di dare una risposta. In
ogni caso era davvero preoccupato e già mi disse che tendenzialmente non aveva
intenzione di farsi coinvolgere anche se forse lo avrebbe anche fatto – se io
non lo avessi dissuaso – perché, diceva di avere molta paura di questi soggetti
dei servizi. Ricordo le sue parole testuali: sono loro la vera mafia.
Insomma pur trovando folle il progetto, Milazzo
aveva timore di inimicarsi questi agenti dei servizi. Io, come ho detto, gli
spiegai che doveva astenersi e non farsi coinvolgere perché rischiava di
mettersi in guai ancora più grandi. Senza contare che afre attentati, uccidendo
anche perone innocenti, fra cui donne e bambini, non è da vero uomo d'onore. Lui
alla fine si convinse a non farsi coinvolgere ma nella consapevolezza che ciò
gli sarebbe costato la vita. Disse: va bene cerchiamo di non farci coinvolgere
ma moriremo. In effetti poi sia pure con cautela e con diplomazia riuscì a non
farsi coinvolgere.
ADR: Mi chiedete se sono a conoscenza della
vicenda del ritrovamento di un arsenale di armi nel 1993 nella villa di due
carabinieri, nei pressi di Alcamo. Nulla ne so, anche se ricordo l'episodio che
sicuramente non era ascrivibile a Cosa Nostra.
ADR: No so dirvi la ragione per la quale questi
sedicenti esponenti dei servizi si rivolsero per questo "affare" proprio al
Milazzo. Posso dirvi però che il Milazzo mi disse che questi due agenti sapevano
di me, sapevano cioè che io ero legato al Milazzo e che, come dissero al Milazzo
stesso, mi consideravano molto scaltro e capace verosimilmente in senso
criminale.
ADR: A seguito vi furono altri due incontri fra il
Milazzo con questi dei servizi (erano sempre le due stesse persone): uno si
svolse sempre in contrada Consa ma mi sembra in una casa diversa dalla prima e
l'ultimo, il terzo, nella casa di tale Senatore Corrao che si trova sulla cima
di un monte che si chiama Bonifato, nei dintorni di Alcamo.In entrambi questi
incontri si parlò ancora degli attentati in continente che quei due dei Servizi
volevano fossero fatti. In entrambi gli incontri io rimasi fuori a vigilare e in
un caso, addirittura, seguii e pedinai la vettura dei due agenti dei servizi
fino a Palermo, senza però scoprire nulla in quanto li persi in una rotatoria di
Via Belgio.
Fu quindi il Milazzo che mi raccontò lo
svolgimento dei due incontri spiegandomi che si era destreggiato nel senso pur
senza farsi direttamente coinvolgere come si era ripromesso, non rifiutò mai
esplicitamente un suo apporto a tali attentati. Prendeva tempo dando una
generica disponibilità. L'importante era non prendere impegni stringenti che
potevano costringerlo a dare attuazione al progetto stragista. Milazzo,
tuttavia, immaginava, per come mi disse, che quelli dei servizi potessero
sospettare o addirittura ritenere che lui voleva "sgusciare via e fare il
furbo". In proposito proprio l'incontro con Gioacchino Calabrò, che avvenne a
seguito di questi tre incontri, in un baglio sito vicino Calatafimi, può trovare
spiegazione proprio in questo atteggiamento attendista e ad un tempo
apparentemente compiacente del Milazzo nei confronti di quelli dei servizi. In
sostanza successe che io accompagnai il Milazzo a questo incontro e rimasi in
disparte mentre Milazzo parlava con il predetto Calabrò che era uomo d'onore di
Castellammare del Golfo. Tuttavia, io trovandomi a breve distanza dai due,
riuscii, comunque, a sentire aspetti salienti dei loro discorsi. In particolare
sentii che Milazzo ordinava a Calabrò di dire a Ferro Giuseppe (allora soldato
del Milazzo, ma successivamente divenuto, dopo la morte di Milazzo,
Capo-Mandamento) di ordinare ai suoi parenti che si trovavano a Firenze di
"mettersi a disposizione" di Cosa Nostra. Sul momento non misi a fuoco
esattamente il senso di quell'ordine. Quando, però, un anno e passa dopo vi fu
l'attentato di Firenze di via dei Georgofili, pensai che l'attentato e l'ordine
che aveva dato il Milazzo potessero avere un qualche oggettivo collegamento fra
loro ( tenete conto nel frattempo il Milazzo era morto e Ferro era il nuovo
capo-mandamento) e, quindi, in via logica, misi anche in collegamento gli
incontri con quelli dei servizi, in cui si parlò di attentati in continente, con
i due episodi in questione ( e cioè : ordine dato da Milazzo al Calabrò e
l'attentato di Firenze).
ADR: I proprietari delle tre abitazioni in cui si
svolsero gli incontri di cui ho parlato, non so se abbiano a meno partecipato
agli incontri ed alle discussioni con questi agenti dei servizi. Viglio dire che
io non li ho visti ma non posso escludere che nel momento in cui accompagnai
presso tali abitazioni il Milazzo, gli stessi potessero essere già lì presenti
per poi partecipare agli incontri. Preciso tuttavia che nella prime due
occasioni il Milazzo aveva le chiavi di casa e preciso che ricordo che il
Senatore Corrao di nome fa Ludovico. Ora che ricordo anche questo senatore è
morto di morte violenta ucciso dal suo domestico straniero.
ADR: il pedinamento fino a Palermo non ricordo se
fu mia iniziativa o se fu il Milazzo a dirmi di procedere in tale senso.
ADR: Ovviamente ho riferito di questa vicenda ai
PPMM di Palermo non appena ho iniziato a collaborare. In effetti mi vennero
anche sottoposti degli album fotografici ma fra le foto che mi sono state poste
in visione non vi erano quelle dei due soggetti dei servizi di cui sopra. Certo
è che almeno all'epoca avevo un ottimo ricordo delle fattezze dei due presunti
agenti. Non so dire se oggi, dopo tanti anni, sarei in grado di
riconoscerli...omissis".
Gli oscuri suggeritori sarebbero allora i Servizi
Segreti. La 7 Divisione del SISMI (si trattava della Divisione dell'ex servizio
di sicurezza che manteneva i collegamenti operativi con Gladio), il gruppo che
aveva creato la sedicente Falange Armata. Le prime rivendicazioni "Falange
Armata" fatte in Italia erano collegate all'omicidio dell'Educatore Carcerario
Umberto Mormile, avvenuto a Lodi l'11.4.1990 proprio per mano della 'ndrangheta.
In particolare varie telefonate venivano effettuate presso sedi Ansa e sedi di
Istituti Penitenziari. In un primo momento, nell'immediatezza, il giorno dei
fatti, con riferimenti alla riconducibilità ad azioni terroristiche dell'agguato
al Mormile e, poi, con riferimenti specifici alla Falange Armata carceraria che
diverrà, poi, ancora di seguito, semplicemente Falange Armata. Interessanti,
allora, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. A cominciare da
Vittorio Foschini, escusso a metà 2015: "...A.D.R: Sono entrato nella
'ndrangheta dopo avere lavorato, pur essendo calabrese, con Cosa Nostra ed i
siciliani. Io avevo lavorato nella droga con Biagio Crisafulli, palermitano, e,
quindi in collegamento con i Carollo e Luigi Bonanno, all'epoca contrapposti ai
corleonesi. I Fidanzati erano invece alleati ai Corleonesi. Fu Antonio Papalia
che decise di riunire tutti i calabresi, sia riggitani che catanzaresi, che
stavano in Lombardia. Ciò determinò anche il riconoscimento – avvenuto a seguito
di specifiche riunioni tenutesi in Calabria a Petilia Policastro fra componenti
della 'ndrangheta reggina e "milanese" e catanzeresi – delle famiglie
catanzaresi dalla "Madonna dell'Aspromonte" ciò significa l'ingresso ufficiale
nella vera e propria 'ndrangheta. Dunque questa riunione dei calabresi lombardi
sotto un'unica bandiera – eravamo tantissimi – determinò il sopravvento della
'ndrangheta in Lombardia. Fra i siciliani furono nostri alleati solo i
Crisafulli e anche, ma in modo meno intenso, i Carollo/Bonanno.
A.D.R: Al vertice, in Lombardia, c'erano Antonio e
Domenico Papalia, poi Coco Trovato. Con noi c'era anche il gruppo di
Anacondia...omissis...
A.D.R: Mormile, nonostante sia stato infangato
come corrotto, venne ucciso perché rifiutò di fare una relazione compiacente a
Domenico Papalia. Anzi nel rifiutare ad Antonio Papalia il favore per Domenico
Papalia (che se non sbaglio era detenuto per l'omicidio D'Agostino delitto nel
quale secondo quanto appresi da Antonio Papalia erano coinvolti anche i servizi
segreti), ancorchè ricompensato, disse ad alta voce, ad Antonio Papalia che lui
"non era dei servizi", alludendo ai rapporti fra Domenico Papalia e i servizi
che pure erano veri ed esistenti. Infatti nel carcere di Parma, in precedenza,
il Papalia Domenico aveva rapporti e colloqui con i servizi. Ciò mi venne detto
da Antonio Papalia che pure aveva rapporti con i servizi come pure lui stesso mi
confidò. Proprio questo rifiuto con l'allusione ai servizi fu fatale per il
Mormile. Insomma, questa allusione sui rapporti Servizi-Papalia, oltre che al
rifiuto di fare il favore, fu fatale al Mormile. Preciso meglio la sequenza dei
fatti come raccontatami da Papalia Antonio: prima Domenico in carcere chiese il
favore a Mormile, voleva una relazione addomesticata; Mormile rifiutò. Ciò
avvenne in quanto Mormile aveva già bloccato un permesso di Domenico Papalia. Ci
fu un diverbio. Domenico comunicò la cosa al fratello Antonio in un colloquio
dicendo al fratello di convincere il Mormile. Antonio nei giorni successivi,
subito fuori dal carcere, avvicinò il Mormile che si rifiutò di nuovo nonostante
la promessa di 20 milioni dicendo che lui non era dei servizi. Dio seguito
Antonio riferì al fratello Domenico, nel corso di un colloquio in carcere che il
Mormile non cedeva e che anzi aveva fatto allusioni ai servizi. Domenico si
preoccupò e deliberò l'omicidio. Antonio Papalia mi raccontò questo fatto subito
dopo il colloquio in carcere di cui ho appena detto. Preciso che secondo il
racconto fatto a me da Antonio Papalia, lo stesso Domenico Papalia, che disse
che, secondo lui, Mormile andava ucciso, precisò anche che bisognava parlare con
chi di dovere e cioè con i servizi vista l'allusione che era stata fatta e visto
che non si doveva sospettare di loro (cioè dei Papalia). Ne seguì che Antonio
Papalia, come ci disse (a me a Flachi, a Cuzzola, a Coco trovato ed altri) parlò
con i servizi che, dando il nulla osta all'omicidio Mormile si raccomandarono di
rivendicarlo con una ben precisa sigla terroristica che loro stesso indicarono.
Ecco la risposta alla domanda che mi avete fatto con riferimento alla
rivendicazione "falange armata" dell'omicidio Mormile. Fu Antonio Papalia allora
che ordinò a Brusca Totò (persona che comunque potrei riconoscere) di telefonare
ad un giornale e fare la rivendicazione a nome di questa presunta organizzazione
terroristica. Ciò avvenne sotto i miei occhi addirittura prima dell'omicidio. Il
Papalia Antonio, infatti, disse a questo Brusca che appena eseguito l'omicidio,
lui doveva fare la telefonata di rivendicazione...
A.D.R: La 'ndrangheta era contraria alla strategia
stragista dei corleonesi, e lo erano anche i Papalia e Coco Trovato. O meglio
divennero contrari quando si accorsero delle conseguenze che questa strategia
comportava. Papalia Antonio si mostrava preoccupato. Per la verità Antonio
Papalia brindò in occasione delle stragi, ma, lui e gli altri, poi, si sono
preoccupati per le conseguenze. Si cominciò a vedere e a temere che lo Stato
avrebbe svolto una azione repressiva assai dura......omissis".
Foschini svela che era stato lo stesso Antonio
Papalia, mandante del delitto, a ordinare la rivendicazione di tipo terroristico
"Falange Armata". Ma di più, Foschini chiariva che l'indicazione di utilizzare
la sigla in questione veniva dai servizi di sicurezza, o meglio dagli
appartenenti ai servizi che erano in contatto con i Papalia (Domenico ed
Antonio). Dunque, i casi sono due: o Papalia ebbe ad inventarla, a crearla, o
qualcuno lo imbeccò. La prima ipotesi è del tutto implausibile. Papalia era
persona scarsamente scolarizzata (aveva frequentato le scuole dell'obbligo) e
del tutto priva di strumenti culturali adatti a questo compito. Pensare che
potesse avere concepito una simile rivendicazione equivale a formulare un
periodo ipotetico del terzo tipo. Salvatore Pace, escusso dalla Dda, afferma:
"... ADR:...Papalia Antonio era molto ignorante,
rozzo, ma come ho detto un capo...."
E allora il suggeritore era in una posizione che,
per qualsivoglia motivo, dobbiamo ritenere sovra-ordinata rispetto a Papalia,
tale da poterlo determinare a seguire delle strategie che il suggeritore stesso
riteneva necessarie in quel momento. Un contributo, ancora più significativo sia
sulla causale del delitto che soprattutto, per ciò che rileva in questa sede,
sulla sua rivendicazione, veniva da altro soggetto che aveva partecipato alla
esecuzione del delitto agli ordini dei Papalia, Antonino Cuzzola: "...A.D.R:
Sono stato detenuto dal febbraio 1992 al febbraio 1993. Sono stato nuovamente
arrestato a Giugno 1993. Ho iniziato a collaborare nel 2004 da detenuto. Sono
stato ininterrottamente detenuto dal 1993 al 2007. Quando sono uscito dal
carcere nel 1993 (essendo stati arrestati Antonio Papalia e Franco Coco Trovato
nel settembre 1992) il reggente della famiglia Papalia, in Lombardia, era
Musitano di cui non ricordo il nome comunque era il nipote di Antonio Papalia,
figlio della sorella, all'epoca aveva 25/30 anni. Durante la rilettura del
verbale si dà atto che il collaboratore ricorda il nome di Musitano : Antonio.
Più importante di lui era Domenico Paviglianiti che però era latitante e stava
all'estero. Tenete presente però che Papalia Antonio era un "re" a San Vittore.
Dava ordini da lì. E comandava dal carcere. Passava gli ordini a Musitano che
andava a colloquio con lui. Le stesse guardie carcerarie avevano soggezione del
Papalia Antonio. Gli facevano fare quello che voleva. Ad esempio teneva in
carcere un congelatore tutto per lui. Cosa che non aveva nessuno.
A.D.R: In effetti come ho già detto in altri
processi, Domenico Papalia, fratello di Antonio, aveva rapporti con i Servizi
Segreti con i quali aveva colloqui nel carcere di Parma. Ciò appresi da Antonio
Papalia in occasione della preparazione dell'omicidio dell'educatore carcerario
Mormile. Mormile, a dire di Antonio Papalia, venne ucciso proprio perché si fece
sfuggire con un detenuto di questi colloqui fra Domenico Papalia e i Servizi
Segreti. Cuzzola ricostruisce nel dettaglio la dinamica dell'omicidio Mormile:
"Mi fate il nome Falange Armata. Vi dico, ora che ci penso che è proprio il nome
della formazione terroristica che avrebbe dovuto rivendicare l'omicidio Mormile.
Penso di averlo detto anche sul processo Mormile. Ora mi sfuggiva il nome.
Prendo atto che la prima telefonata fatta all'Ansa di Bologna in cui si parla di
"terrorismo" risale allo stesso giorno dell'omicidio. Prendo atto che sono
seguite altre telefonate di rivendicazione e che solo qualche mese dopo si fece
per la prima volta il nome Falange Armata. Vi dico, allora, che escludo ancora
che l'incontro al bar di Buccinasco si sia verificato il giorno stesso
dell'omicidio. Sono certo. Ritengo, allora, le possibilità sono tre: o quando
Papalia parlò della rivendicazione al bar di Buccinasco avrà detto che già aveva
fatto la stessa ed io ho capito male, oppure disse che aveva fatto la
rivendicazione ed io ricordavo male, oppure, ancora, disse, non so per quale
ragione, che avrebbe fatto la rivendicazione ma in realtà già l'aveva fatta.
Quanto alla sigla Falange Armata io ricordo di averla sentita fin dall'inizio.
Può essere che sia stata ideata all'inizio e poi utilizzata in concreto, solo in
un secondo momento, oppure può essere che io ricordi male sul momento esatto in
cui si fece per la prima volta il nome di questa formazione. Sono certo, però
che fu proprio Antonio Papalia a dirmi che le rivendicazioni sarebbero state
fatte, per depistare, dalla Falange Armata. Ricordo che fra i Papalia e Cosa
Nostra vi era un rapporto molto stretti. Posso dire, ad esempio, che con i
Madonia ed i Fidanzati i rapporti erano molto stretti. Dopo l'omicidio di
Corollo, eseguito su mandato di Riina o comunque di Cosa Nostra – Corollo era
uno che gestiva per Cosa Nostra il traffico di stupefacenti in Lomabardi – tutto
il traffico di stupefacenti che veniva gestito dal predetto Corollo venne
affidato ai Sergi per richiesta di Cosa Nostra stessa. Ciò a dimostrazione della
particolare vicinanza fra 'ndrangheta e Cosa Nostra. I Papalia diventarono i
responsabili della 'ndrangheta per la Lombardia con l'avallo di tutta la
'ndrangheta calabrese. Si sapeva che i Papalia e, in particolare, Domenico
papalia era in rapporti con i servizi segreti. Pino Piromalli me lo disse in
carcere a Cuneo nel 2000. Mi spiegò che la sua cosca era entrata in possesso di
documenti che comprovavano questo rapporto. Tuttavia nessuno contestò,
all'epoca, questa circostanza al Papalia. Posso presumere che la cosa fosse
gradita ai vertici della 'ndrangheta... Mi chiedete se il nome "Falange Armata",
particolarmente inconsuete, fosse "farina del sacco" di Papalia Antonio.
Rispondo che effettivamente Antonio Papalia non ha una grossa cultura. Io lo
conoscevo bene. Parlava un italiano molto stentato. Aveva la licenza media
inferiore. Il riferimento alla "Falange Armata" è troppo raffinato per lui.
Sicuramente qualcuno deve avergli suggerito questo nome. Anzi le dirò di più:
ricordo che Coco Trovato gli chiese, al Papalia, cosa fosse questa "Falange
Armata". Papalia disse "Mi hanno detto di fare questo nome". Non specificò chi
suggerì questa sigla....
ADR: In effetti Carmine e Peppe De Stefano dopo la
morte del padre, a partire dal 1986/87, stavano più a Milano – con i Papalia e
Coco Trovato – che a Reggio Calabria.
ADR: Ricordo che avevamo stretti rapporti anche
con i pugliesi e in particolare con il gruppo Anacondia. Ricordo questa stretta
frequentazione e alleanza a partire dalla fine degli anni 80'...
ADR: Ho assistito ad una visita fatta, intorno al
1989/90, dai Servizi Segreti a Domenico Paviglianiti a casa sua a Reggio
Calabria San Lorenzo. Vidi arrivare queste persone distinte a bordo di una Uno.
Non presenziai all'incontro. Quando se ne andarono chiesi a Paviglianiti chi
fossero. Mi disse che erano gente dei Servizi mandata da Don Mico Libri. Gli
avevano proposto di fare da confidenti in cambio di un aiuto che avrebbe avuto
sui processi. Posso anche dire che Barbaro Francesco ha ammesso di avere
contatti con i Servizi nel carcere dell'Aquila. Insomma era una cosa assai
diffusa nella 'ndrangheta quella di avere rapporti con i Servizi
Segreti...omissis".
Lo stesso Antonio Papalia, persona non istruita e
non in grado di escogitare un nome come Falange Armata, aveva detto che gli
avevano detto "di fare questo nome". Dal tenore delle dichiarazioni di Cuzzola e
di Foschini, si evince che, seppure il Papalia avesse un proprio interesse a
depistare le indagini e a confondere le acque, il suggerimento e, soprattutto,
il modo con il quale il suggerimento era stato dato e supinamente accettato
(...mi hanno detto di fare questo nome... ) davano conto di uno specifico e
convergente interesse dei suggeritori a propalare e diffondere la sigla in
questione come collegata ad una campagna terroristica che si andava avviando e
di una sorta di subalternità dei Papalia ai suggeritori. Ancor più inquietante è
collegare Falange ai servizi deviati e, in particolare, ad una frangia della 7
Divisione del Sismi, era quella che aveva rapporti operativi con Gladio e,
quindi, con Stay Behind. Agli atti dell'inchiesta "Ndrangheta stragista" c'è la
deposizione resa dall'ex Ambasciatore Paolo Fulci che era stato, dopo una lunga
e brillante carriera in diplomazia, Segretario Generale del Cesis – organismo di
controllo e coordinamento dei due servizi d'informazione "operativi" dell'epoca
(il Sisde ed il Sismi) - fra il Maggio 1991 e l'Aprile del 1993 e poi, dalla
DNA. Poi veniva acquisito un articolato carteggio, composto da informative della
Digos e documenti forniti alla AG dai servizi d'informazione e dal Cesis, che
riguardano il medesimo oggetto. Fulci, come risulta dall'ampio carteggio in
atti, poco dopo avere informato (in modo non dettagliato) il Comandante
dell'Arma dei carabinieri dell'epoca e, ben più sommariamente, i suoi referenti
politici – vale a dire i Presidenti del Consiglio in carica e quelli che gli
avevano dato il mandato (il Presidente Andreotti con l'avallo dell'allora
Presidente della Repubblica Cossiga) dopo che nell'Aprile 1993 lasciò l'incarico
si recò a svolgere funzioni diplomatiche oltre-oceano. Vennero sentiti, il suo
capo-gabinetto – Generale Nicola Russo – e altri collaboratori, dalla Digos di
Roma su delega della locale Procura. In buona sostanza, da quelle escussioni,
emerse che il Fulci, dopo accertamenti interni fatti svolgere da personale di
sua fiducia, avesse richiesto, al Comandante Generale dei CC, di dare impulso ad
attività d'indagine su circa 15 funzionari del Sismi, che prestavano servizio
presso il nucleo OSSI, una sorta di gruppo di elite della 7^ Divisione del
Sismi, in quanto a suo giudizio probabili o possibili appartenenti alla
sedicente Falange Armata (che pure aveva minacciato il Fulci ) sorta di
struttura occulta dei servizi deviati che svolgeva una campagna di
"intossicazione", disinformazione e aggressione ad esponenti istituzionali, che
si poneva in continuità con la politica piduista dei vecchi apparati Sid/Sifar.
Il Generale Russo, in particolare – che in tutta evidenza non aveva partecipato
alle attività di accertamento in questione, promosse da Fulci – in via generale,
nel corso della escussione del 3.7.1993 alla Digos di Roma, ribadiva che il
Fulci legava le attività di minaccia, rivendicazione ed intimidazione della
Falange, al tentativo di infangare e intimorire tutti i soggetti di rilievo
istituzionale o pubblico che avevano evidenziato perplessità sulla cd Operazione
Gladio individuando, anche legami fra, questa e la P2. Fulci riferirà di avere
svolto interamente la sua carriera – fino al momento della nomina al Cesis – in
diplomazia, dove da ultimo, prima era stato ambasciatore in Canada e, poi,
rappresentante italiano presso il Consiglio Atlantico (dove erano rappresentati
tutti i paesi Nato ; che nel contesto di tale incarico, dopo che Andreotti
nell'autunno 1990 aveva confermato l'esistenza di Gladio, aveva brillantemente
ricucito lo strappo fra il nostro paese e i partners atlantici, causato proprio
dalla pubblica ammissione dell'esistenza della struttura, riuscendo ad ottenere
una non-smentita delle dichiarazioni di Andreotti da parte della Nato; he a
seguito di ciò venne contattato dall'allora Presidente Cossiga, che gli
rappresentava che lui era pienamente d'accordo con Andreotti che lo voleva
nominare a capo del Cesis; che dopo qualche riluttanza accettò la nomina; che
senza ancora che la sua nomina avesse avuto una qualche risonanza mediatica ( in
realtà, anche in seguito ne ebbe poca) mentre occupava ancora il suo vecchio
incarico diplomatico, ebbe a ricevere la prime minacce Falange Armata; che tale
attività intimidatoria nei suoi confronti ebbe a proseguire. Inoltre nei primi
mesi si accorse che all'interno dell'abitazione dei servizi che lo ospitava a
Roma era intercettato da impianti e microspie di tipo ambientale che avevano
lasciato gli stessi servizi (Sismi) nonostante avesse chiesto una bonifica; che
la sua gestione si caratterizzò per particolare rigore in quanto per la prima
volta utilizzò i poteri del segretario generale di Cesis che permettono di
bloccare nomine e promozioni dei servizi e soprattutto di bloccare fondi, cosa
che fece in modo puntuale e sollecito; che continuando le minacce nei suoi
confronti e imperversando, comunque, le minacce, le rivendicazioni e
l'inquinamento informativo da parte di Falange Armata, delegò un suo dirigente
di massima fiducia, il De Luca (deceduto) a svolgere penetranti accertamenti
sulla provenienza di tali rivendicazioni/minacce Falange Armata; che all'esito
di tali indagini svolte sui tabulati che tracciavano la cella di provenienza
delle telefonate Falangiste, De Luca gli presentò due lucidi che contenevano due
mappe d'Italia. In una erano localizzate le celle di provenienza delle minacce
falangiste e nell'altra i luoghi d'incontro e le sedi periferiche ove operava il
Sismi; che effettivamente aveva segnalato al Comandante Generale dei CC la
vicenda in questione evidenziando che sulla base degli accertamenti svolti dal
suo staff i soggetti che, all'interno del Sismi, potevano avere maggiore
collegamento con le attività falangiste erano quelli inseriti nel Nucleo OSSI
della Settima divisione del Sismi. Un dato di evidente interesse e di
significato indiziario univoco è dato dalla circostanza che Fulci ebbe a
ricevere le prime minacce Falange Armate nel Maggio 1991 quando ancora non solo
non aveva preso servizio al Cesis, ma neppure era nota al pubblico la nomina.
Evidente che solo un soggetto che avesse un qualche interesse a fare la minaccia
e, al contempo, avesse l'informazione della nomina di Fulci, poteva essere
l'ignoto falangista. Il filone investigativo sul Sismi consente di precisare che
la struttura deviata si annidava all'interno della 7^ Divisione (sciolta nel
1993) del Sismi. Si trattava della Divisione che si occupava di Gladio e che,
non diversamente dalle mafie, vedeva messa in discussione la sua mission nel
nuovo periodo storico che si andava ad aprire nei primi anni 90. Non sappiamo
chi, all'interno di tale divisione abbia in concreto operato a tale fine, ma le
tracce processuali che si aveva il dovere di seguire portano fino a quella
porta. Questi soggetti, legati alle vecchie strutture dei servizi in mano a
Licio Gelli, che non a caso tutelavano, concordavano – fra il 1990 ed il 1991 –
con le principali mafie, Cosa Nostra e 'Ndrangheta l'utilizzazione della sigla
falange Armata nella rivendicazione di efferati delitti e stragi. Negli anni
successivi, ci sarebbero stati sia le stragi che le rivendicazioni. Il contatto
e l'accordo in questione era parallelo a quello politico che vedeva, ancora una
volta, protagonisti Gelli e le mafie, nel lancio delle cd liste autonomiste ed
andava oltre. Con riferimento agli attentati ai Carabinieri sul suolo calabrese,
uno degli esecutori materiali, Consolato Villani, avrebbe ricevuto dal complice
Giuseppe Calabrò l'incarico di rivendicare gli atti contro i militari dell'Arma
per darne una coloritura di tipo terroristico. Una traccia di rilievo che
consentiva di chiudere il cerchio e collegare gli assalti ai carabinieri, non
solo alla strategia delle stragi continentali eseguite dai Graviano, ma più
complessivamente alla strategia delle rivendicazioni falangiste, iniziate, a
livello nazionale, proprio con il delitto Mormile commesso, non a caso, dalla
cosca dei Papalia-Coco Trovato che era anche quella che, più delle altre
spingeva, per appoggiare la strategia stragista di Cosa proveniva da scrupolosi
accertamenti svolti nell'ambito dell'inchiesta. Almeno tre rivendicazioni erano
state effettuate in occasione degli attacchi ai carabinieri del periodo dicembre
1993 – febbraio 1994 a Reggio Calabria. In particolare: una rivendicazione
telefonica pervenuta ai CC di Scilla in data 20.1.1994 (in cui il telefonista
prometteva altri agguati); una ulteriore rivendicazione telefonica ai CC del
Rione Modena di RC in cui si parlava di fare "una strage" ; infine quella più
significativa, a firma Falange Armata, inviata con missiva scritta con
normografo ai CC di Polistena. Particolarmente di rilievo in quanto non solo,
per l'appunto, vi era la rivendicazione Falngista ma perché inviata presso una
Stazione dei CC che si trovava nella giurisdizione della 'Ndrangheta tirrenica
che tanta parte aveva avuto nelle oscure vicende oggetto dell'inchiesta. In
particolare, con riferimento a quest'ultima, si trattava di una lettera inviata
tramite servizio postale ai Carabinieri della Stazione CC di Polistena (spedita
da Polistena il 2.2.1994 e pervenuta in data 4.2.1994) e firmata "Falange
Armata", in cui si esprimeva compiacimento per la morte dei due carabinieri e si
auspicava che la stessa fine potessero fare tutti i militari in servizio presso
la citata Stazione. Si riporta il testo della missiva: "Quanto ci siamo
divertiti per la morte dei due carabinieri bastardi uccisi sull'autostrada è un
inizio di una lunga serie e mi auguro che a Polistena facciate tutti la stessa
fine cornuti e bastardi e figli di gran puttana".
Il terrore di “faccia da mostro” e del
passato con le istituzioni deviate: luce sulla fuga e i falsi memoriali di Nino
Lo Giudice, scrive Claudio Cordova Giovedì, 27 Luglio
2017, su "Il Dispaccio". La fuga, la ritrattazione, i video, i memoriali in cui
infanga magistrati e forze dell'ordine che hanno segnato una svolta a Reggio
Calabria. L'inchiesta "Ndrangheta stragista" si propone di fare luce anche sulla
fin qui inspiegabile vicenda di Antonino Lo Giudice, ex boss dell'omonima cosca
di 'ndrangheta, poi divenuto pentito e protagonista di un voltafaccia che farà
discutere per le gravi accuse (totalmente infondate) nei confronti dell'allora
capo della Procura, Giuseppe Pignatone, e di altri magistrati e membri delle
forze dell'ordine della sua squadra. Gli accertamenti fornivano significative
spiegazioni in ordine alla genesi dei suoi comportamenti culminati
nell'abbandono del domicilio protetto e nell'invio delle farneticanti missive in
cui ritrattava tutte le accuse. Rendendo così comprensibili condotte, quali la
fuga e la ritrattazione, che, altrimenti, si dovrebbero considerare insensati
atti autolesionistici, posto che, per un verso, non provocavano (e non potevano
provocare ) alcun vantaggio né al dichiarante stesso né ad altri, e, per altro
verso, determinavano la certa conseguenza della revoca del programma di
protezione e degli altri benefici connessi alla collaborazione (così come si è
puntualmente verificato, essendo ad oggi Lo Giudice privo di programma e mero
dichiarante) . E ciò in una situazione nella quale Lo Giudice, aveva ottenuto
anche gli arresti domiciliari in località protetta, dove scontava la custodia
cautelare (e in prospettiva avrebbe potuto scontare le pene definitive che gli
sarebbero state irrogate). In particolare da tali successivi interrogatori
venivano in rilievo spiegazioni che - sul solco di quanto già evidenziato nella
sentenza che si è appena riportata, che riconduceva, come si è detto, ad una
situazione di vero e proprio terrore che aveva determinato le condotte
scellerate del Lo Giudice – illuminavano ulteriori ed importanti dettagli della
vicenda. Segnatamente il Lo Giudice, nel corso dell'interrogatorio del 29.9.2014
reso alla Dda di Reggio Calabria e alla Procura di Catanzaro, riferiva: "...ADR:
In data 14.12.2012 ero con appartenenti alla Sezione Anticrimine (tale Stefano
Meo e tale Gabriele) in quanto ero collaboratore di giustizia e mi stavo recando
a Reggio Calabria per partecipare ad una udienza di persona. Arrivati nei pressi
di Termoli, Stefano ricevette una telefonata che preannunciava "dei problemi" a
Reggio. Ci siamo fermati presso un distributore di benzina e Stefano ricevette
un'altra telefonata ma mi disse di stare tranquillo. Siamo poi andati in albergo
a Roma e venne tenuta una video conferenza al posto dell'udienza tradizionale di
cui vi ho detto; dopo tutto ciò mi dissero che dovevo andare alla D.N.A. Abbiamo
atteso sino alle 17.00 in quanto ero atteso dal Dott. Donadio; il dott. Donadio
mi formulò delle domande; non comprendevo cosa volesse apprendere. Mi fece delle
domande su tale Giovanni AIELLO; io confermai di conoscerlo ma venni "tirato"
nel discorso senza conoscerne il motivo. Preciso che il Dott. Donadio non mi ha
costretto a dire nulla; mi ha solo "accompagnato" nel discorso
suggestionandomi...
ADR: Io mi sono spaventato di quanto riferito da
Donadio su Aiello, non mi sono fidato, seppi da Donadio che Aiello era uno dei
Servizi Segreti, era presente in via D'Amelio e mi sono spaventato.
Il verbale viene sospeso alle ore 15.40.
L'interrogatori viene ripreso alle ore 15.42.
ADR: quando parlava il Donando, io anticipavo le
risposte essendo intuitivo e pur non conoscendo l'Aiello ci azzeccavo, come voi
mi fate rilevare sulla vicenda del suo addestramento e del fatto che abitasse
sulla Ionica calabrese. Io mi sono anche preoccupato dopo l'accadere di diverse
situazioni strane che si verificarono dopo il predetto colloquio investigativo;
ricordo che una mattina, nel mese di febbraio 2013 e nel luogo di protezione, si
fermò una Fiat Punto. Un uomo in borghese che si qualificò come Carabiniere,
chiamandomi per nome, mi disse di salire a bordo. Con lui c'era un'altra
persona. Mi portarono fuori Macerata presso una Bravo marrone dove c'erano altri
due carabinieri, verosimilmente dei servizi, per come io ho capito. In macchina
vi erano due persone; quello lato passeggero mi disse di "stare attento" dato
che avevo parlato di Aiello di cui non avrei, invece, dovuto parlare. Nel
discorso io riferii di avere delle registrazioni che avevo fatto dopo il
colloquio con Donadio che dimostravano che io non avevo detto nulla su Aiello;
queste persone vennero a casa e presero queste registrazioni che io gli
consegnai. Ripeto: in quel giorno, io ero per strada, si avvicinò una Fiat Punto
di colore grigio e mi portarono fuori città dove vi era anche una Fiat Bravo di
colore marrone. La persona che mi agganciò, si qualificò come Carabiniere; era
alto, dall'età apparente di 35 anni. Sul sedile posteriore, ricordo, vi era il
lampeggiante. Ho notato, una volta salito in macchina, le due persone che erano
armate con pistole Beretta. Voglio rappresentare che 4 mesi fa, a giugno circa,
nel luogo di protezione, si sono presentate delle persone dove lavora la mia
compagna ed hanno chiesto informazioni sulla mia persona al datore di lavoro di
Laila come ho appreso nel corso di un colloquio anche telefonico...omissis...
Per tornare all'incontro preciso che i due sulla
Fiat Punto mi accompagnarono dove vi era una Bravo. Su detta macchina vi era una
persona pelata, con accento laziale, che formulava le domande di circa 40 anni.
Questi mi disse prima di stare tranquillo. Mi disse che sapeva che io aveva
parlato di Aiello e mi disse che dovevo stare attento specie nel futuro a
parlare di certi argomenti. Io dissi che a Donadio non avevo raccontato nulla di
Aiello; a questa persona io consegnai le registrazioni.
ADR: in quel giorno non avevo registratore e
telefonino al seguito. Dopo il colloquio investigativo ho iniziato a registrare
perché ero spaventato. Le udienze le registravo per comprendere,
nell'immediatezza, quello che avevo raccontato. Mi pare che l'incontro di cui vi
ho detto è occorso nel mese di febbraio. Preciso che in seguito successero altri
fatti strani. Vennero delle persone che volevano entrare nella mia casa nella
località protetta. Io non li conoscevo e disse che prima avrei chiamato ai miei
referenti di zona e loro preoccupati se ne andarono.
ADR: Ho diffidato di Donadio perché ho pensato che
il tutto, tutte le sue domande su Aiello, fossero correlate, una specie di
ritorsione, alle mie dichiarazioni rese sul conto del Dott. Cisterna pure lui
della Dna. Mi voleva mettere in difficoltà.
ADR: Mi chiedete se comunque io avevo mai sentito
parlare prima di allora, prima che Donadio mi facesse simili domande di Aiello.
Vi dico la verità: Aiello lo sentii nominare all'Asinara; ero stato lì detenuto
nel periodo 1992/1995...omissis....
ADR: Nessuno mi ha detto di scrivere quanto ho
scritto nei memoriali contro il Dott. PIGNATONE, PRESTIPINO e CORTESE. Mi sono
spaventato dato che, dal mese di giugno 2011 in poi, ai miei figli hanno
bruciato la macchina ed a mio fratello il furgone. Volevo ritrattare quanto già
raccontato ma volevo, nel contempo, aiutarvi. Nei due memoriali che ho scritto
ho cercato di fornirvi degli elementi che possano aiutarvi. Comunque le mie
accuse ai predetti inquirenti erano del tutto capziose e dettate dal momento di
sconforto.
ADR: I memoriali li ho scritti io. A conferma
della falsità di quelle accuse non ho mai confermato a verbale quanto ho scritto
su Pignatore e gli altri; ripeto li ho scritti perché avevo perso la
fiducia...omissis...
ADR: La mia compagna Laila vive in località
protetta; ho appreso da lei, al telefono, che pochi mesi fa a Giugno, si erano
presentati dal datore di lavoro della stessa, due persone qualificatesi come
Carabinieri. Questi hanno mostrato al datore di lavoro della mia compagna, delle
foto che la ritraevano ed hanno chiesto il motivo per il quale lavorava in quel
luogo. Per quanto mi è stato riferito, al datore di lavoro, che si intimorì,
venne indicato che era la mia compagna e che io ero un appartenente alla
'ndrangheta...omissis....
ADR: non ho raccontato di Aiello, nella prima fase
della mia collaborazione, perché avevo paura...mi è rimasta impressa la sua
freddezza. Sembrava non avesse mai emozioni. Spontaneamente: io temevo Aiello ed
ho paura anche ora, potrei morire anche in carcere, che ne so.
ADR: io chiesi ad Aiello della bruciatura che
aveva in volto e lui mi disse che era stata provocata durante una operazione,
dallo scoppio di un'arma, fucile o di una pistola, non ricordo...
ADR: nel terzo memoriale che io stavo scrivendo
prima del mio arresto, parlavo di Rocco FILIPPONE; questi è il responsabile, il
mandante, dell'omicidio dei Carabinieri eseguito da Villani e Calabrò. Ciò mi
venne detto da Villani. Ad Oppido Mamertina, intorno al 1991, così come Villani
mi raccontò nell'anno 2000 o 2001, si incontrarono Filippone, Giuseppe de
Stefano, Giuseppe GRAVIANO ed altri, per definire che si dovevano uccidere
nell'ambito di una strategia stragista, fra gli appartenenti alle FFOO, solo
appartenenti all'Arma dei Carabinieri.
ADR: sapevo che Filippone, di Melicucco, era uno
dei capi della Tirrenica.
ADR: preciso, a richiesta, che ho timore sia di
Aiello che della famiglia dei Condello. Ho più paura di Aiello perché è
esponente di un mondo che non conosco. Non so chi ci sia dietro...omissis..."
Nino Lo Giudice, il "Nano", è un boss della
'ndrangheta pentito. Che, però, scappa. E non lo fa nell'ambito della sua
carriera criminale e nemmeno quando, da collaboratore, accusa parenti stretti,
ma anche pezzi delle Istituzioni. Scappa quando la Direzione Nazionale Antimafia
gli chiede di Giovanni Aiello, il poliziotto dei servizi segreti noto come
"faccia da mostro". A quel punto, il "Nano" si terrorizza. Lo Giudice si
terrorizza e inizia a svalvolare, quando si parla di Aiello e quando inizia a
ricevere una serie di incursioni da soggetti ritenuti nell'orbita dei servizi
segreti. Ora, però, è possibile fare degli ulteriori passi in avanti verso una
più completa (anche se non ancora esaustiva) ricostruzione dei fatti che
indussero il Lo Giudice a fuggire. Quelle accuse alla squadra di Pignatone erano
false e attraverso le indagini sarà possibile comprendere quali ragioni, quali
forze, quali intimidazioni condizionarono il Lo Giudice, ma non sarà, invece,
possibile individuare e dare un nome ed un cognome a chi materialmente fece
sentire il Lo Giudice in una condizione di pericolo imminente. Il colloquio
investigativo svolto nel Dicembre del 2012 alla Dna, fu l'elemento, il fattore,
che innescò la spirale che condusse Lo Giudice alla fuga, ma non fu il colloquio
investigativo in sé, o meglio, le modalità di conduzione dello stesso da parte
della Dna, a spaventare il Lo Giudice - uomo che, deve ragionevolmente
ritenersi, per il suo passato e per la sua personalità, per terrorizzarsi, deve
essere sottoposto a ben altro che ad un, sia pure serrato, colloquio
investigativo. E invece si terrorizza.
Come si evince dallo stesso tenore delle
dichiarazioni di Lo Giudice, lo stesso ruotava intorno a due questioni: la
figura di Giovanni Pantaleone Aiello - ex poliziotto in servizio alla Squadra
Mobile di Palermo legato al noto Bruno Contrada - sospettato di avere avuto un
ruolo in diverse eclatanti vicende stragiste nel contesto di oscuri inquietanti
rapporti fra criminalità organizzata (siciliana e calabrese) e apparati statali
deviati; le vicende degli assalti ai Carabinieri oggetto dell'inchiesta.
Evidente che fossero questi i nervi scoperti di quella che, fino ad allora, era
stata, invece, la regolare e apparentemente completa collaborazione di Nino Lo
Giudice. Nervi scoperti che venivano colpiti non certo dalle modalità del
colloquio investigativo in Dna, visto che Lo Giudice, come si è detto, non solo
è stato un incallito criminale, ma aveva vasta esperienza di contro-esami
particolarmente incalzanti nel corso della sua non breve carriera di
collaboratore, ma, evidentemente, dagli argomenti, del tutto nuovi, che in
quella sede venivano affrontati. Invero, il "Nano", fino a quel momento, aveva
affrontato interrogatori e contro-esami assai spinosi, non solo su questioni e
delitti legati alla sua appartenenza alla 'ndrangheta, ma anche sulla
responsabilità ed il coinvolgimento di suoi congiunti in tali fatti, primo fra
tutti quello di suo fratello Luciano. Ma non solo. In tale contesto aveva anche
riferito dei contatti che lui e suo fratello Luciano avevano con appartenenti
alla magistratura ed alle Forze dell'Ordine. Eppure mai aveva ritrattato. Mai
aveva smesso di collaborare. E men che meno si era terrorizzato, aveva messo in
guardia i congiunti ed aveva tentato di fuggire. Né, mai, aveva manifestato agli
inquirenti, non solo espressamente, ma neppure per fatti concludenti,
preoccupazione per la sua incolumità e per quella dei suoi cari. Tanto meno, lo
aveva fatto in termini così drammatici. Evidente, allora, che Lo Giudice, fra i
diversi argomenti "scottanti" da lui affrontati, riteneva davvero pericolosi
(sia per lui che per i suoi cari) proprio quelli affrontati nel colloquio
investigativo del Dicembre 2012 alla Dna. E cioè quelli che lo portavano sul
terreno delle stragi e dei suoi possibili ulteriori protagonisti e quello dei
suoi rapporti (confermati peraltro, non solo dal Villani, ma, anche, da altri
elementi indiziari) con un soggetto quale Aiello, che sulla stessa base delle
dichiarazioni del Lo Giudice, risultava essere un uomo che agiva nell'ombra, fra
un lontano passato nello Stato ed in campi d'addestramento militari, ed un
passato più recente ed il presente, al fianco del crimine organizzato e di
pericolose entità deviate, non individuate.
E ciò, tuttavia, seppure poteva preoccupare il Lo
Giudice in misura fuori dall'ordinario (per usare un eufemismo) di fatto, non
era, ancora, sufficiente a terrorizzarlo e a fargli prendere le decisioni più
drammatiche e definitive, cioè la fuga dal luogo di protezioni e l'invio delle
missive di ritrattazione. Il turbamento del Lo Giudice, a seguito dello
svolgimento del colloquio investigativo, peraltro, lo si comprende appieno,
anche alla luce di un ulteriore fattore: la miscela fra gli argomenti trattati
nel corso del colloquio investigativo e l'appartenenza del Magistrato che
conduceva il colloquio – il dott. Gianfranco Donadio - alla Direzione Nazionale
Antimafia. Invero si trattava dello stesso Ufficio del quale, fino a pochi mesi
prima, aveva fatto parte il dott. Alberto Cisterna (che, come il dott. Donadio,
era Procuratore Aggiunto della Dna). Ed il dott. Cisterna, proprio a seguito
delle indagini seguite alle reiterate accuse dello stesso Lo Giudice - che
attribuiva al Cisterna comportamenti ambigui e collusivi con suo fratello
Luciano, indagato per gravissimi reati di criminalità organizzata – era stato
trasferito dal CSM, dalla Dna ad altra sede. A ciò si aggiunga che dalle
narrazioni di Lo Giudice, Cisterna e Aiello erano, sia pure indirettamente,
legati fra loro dal fatto che entrambi erano in rapporti con il Capitano Spadaro
Tracuzzi, Ufficiale di pg, condannato per avere concorso, da esterno,
nell'associazione mafiosa denominata cosca Lo Giudice. Si comprende, allora la
ragione per la quale Lo potesse essere impressionato e suggestionato dal
colloquio in questione anche in ragione del timore che Donadio, per motivi di
colleganza con il Cisterna e per una sorta di ritorsione contro lo stesso
collaboratore, volesse, attraverso il colloquio, esporlo a due pericoli
particolarmente gravi: quello derivante dall'evidenziare, dal rendere notori,
per la prima volta, in un atto d'indagine, le connessioni del Lo Giudice con
entità deviate dello Stato di eccezionale pericolosità, connessioni di cui,
però, fino a quel momento, Lo Giudice stesso (pur dovendolo fare) non aveva mai
riferito; metterlo nel mirino delle ritorsioni di Aiello e delle entità deviate
cui lo stesso Aiello era collegato, avendo disvelato, Lo Giudice, circostanze di
fatto pericolose proprio per i circuiti deviati in cui, l'Aiello, sarebbe
inserito. Lo Giudice spiegava che, non solo, aveva notato presenze inquietanti
nelle adiacenze della sua abitazione in località protetta e che vi erano stati
dei tentativi di contattarlo da parte di soggetti non meglio identificati, ma
che il contatto, infine, vi era stato e che, avvicinato e portato, manu
militari, in una macchina da sedicenti carabinieri, verosimilmente in servizio
presso qualche apparato di sicurezza, era stato ammonito a non parlare più di
Aiello. Lo Giudice, all'esito del colloquio investigativo con il dott. Donadio,
si era impegnato a fornire, non appena rientrato in località protetta, per il
tramite di Ufficiali di pg delegati, al Procuratore Nazionale Antimafia, una
copia cartacea di alcune foto di Aiello "faccia da mostro". Foto che aveva
custodito nel suo pc, di cui, a suo dire, disponeva, in quanto consegnategli dal
suo affiliato Antonio Cortese sottoposto a colloquio investigativo dal Pna).
Cortese, sempre secondo il racconto di Lo Giudice, aveva avuto, a sua volta, la
disponibilità di queste foto, in quanto, lo stesso Lo Giudice gli aveva ordinato
di scattarle (all'insaputa di Aiello) durante un pedinamento dello stesso Aiello
ordinato, sempre, dal Lo Giudice (che evidentemente non si fidava di Aiello, di
cui aveva, già allora, un chiaro timore) per avere una traccia dei luoghi e
delle persone frequentate da Aiello.
Così, dunque, nascono memoriali e video per
screditare il corso palermitano a Reggio Calabria. E tale filmato, girato la
sera del colloquio investigativo e cioè la notte fra il 14 ed 15 Dicembre 2012,
veniva, poi, inviato, su opportuno supporto informatico, a chi di dovere, alcuni
mesi dopo, in uno con i memoriali di ritrattazione. Che, peraltro, se, davvero,
nulla avesse avuto a che fare con Aiello, non si capisce perché si sarebbe
dovuto preoccupare tanto. Mentre, quella paura, quel terrore, quella
concitazione, potevano spiegarsi ed avere una loro logica solo se fossero
ricorse due condizioni: l'effettiva esistenza di tali rapporti e, al contempo,
la loro straordinaria pericolosità che consigliava di occultarli per quanto
possibile.
Nicola Calipari era nel mirino dei clan,
scrive Claudio Cordova Giovedì, 27 Luglio 2017 su "Il Dispaccio". In una
intercettazione ambientale del 12 febbraio 2016, i colloquianti compiono
espliciti riferimenti a soggetti di 'Ndrangheta di origine cosentina ed ai
propositi omicidiari di questi nei confronti del dott. Nicola Calipari,
all'epoca dirigente della Squadra Mobile di Cosenza. Da agente dei servizi
segreti, Calipari, reggino, morirà nel marzo del 2005 a Baghdad, in Iraq,
nell'operazione per liberare la giornalista Giuliana Sgrena. In sintesi Giuseppe
Graviano spiegava ad Adinolfi che i calabresi avevano richiesto a Cosa Nostra,
forti del legame ormai instaurato, di uccidere il funzionario della Mobile di
Cosenza Nicola Calipari approfittando della circostanza che lo stesso si recava
nella città di Palermo per ragioni di carattere sanitario (problemi di
fertilità) riguardanti sua moglie; in tale contesto dopo un iniziale assenso ed
una iniziale collaborazione fornita da Cosa Nostra, Graviano si vanta di aver
bloccato la esecuzione del delitto salvando la vita al Calipari; di rilievo
risulta anche la esatta indicazione della clinica presso la quale avvenivano le
visite della moglie di Calipari. Particolari inquietanti che arrivano dalle
affermazioni dei collaboratori di giustizia Nicola Notargiacomo e Dario
Notargiacomo. Il primo, esponente della 'Ndrangheta cosentina, aveva beneficiato
dell'ospitalità dei Graviano presso il Villaggio Euromare formalmente di Tullio
Cannella, ma di fatto nella disponibilità dei Graviano di Brancaccio. Premesso
che i rapporti dei Notargiacomo con esponenti di Cosa Nostra si estendevano
anche a Leoluca Bagarella e Nino Marchese, per rimanere ai personaggi di
maggiore spessore, risultava che Bagarella avesse stretto, durante le sue
carcerazioni, strettissimi rapporti con esponenti della destra eversiva, fra i
quali il Mario Di Curzio. Accertata la piena attendibilità del narrato dei
Notargiacomo e cioè, in primo luogo, i comuni periodi di detenzione fra gli
interssati, si rileva che il Di Curzio, pur non avendo precedenti per reati
"politici" effettivamente, in corso di detenzione si era avvicinato agli
ambienti della destra eversiva tanto che unitamente a Concutelli ea d altri,
partecipava, in ambiente carcerario a manifestazioni contro l'Amministrazione.
Alla luce del ruolo dei fratelli Notargiacomo, i riferimenti operati da Graviano
alla vicenda Calipari sono divenuti meritevoli di riscontro. Si è reso
necessario, in particolare, verificare i singoli passaggi del colloquio
intercettato partendo dalla escussione del collaboratore di giustizia Giovanni
Drago, per il ruolo di estremo rilievo dal predetto rivestito nel mandamento di
Ciaculli/Brancaccio, il quale il 4 maggio 2017 ha dichiarato quanto segue:
"Ricevo lettura del mio precedente interrogatorio del 22.11.2013:
"ADR: Per il tramite di Marchese Antonino e quindi
mio, i Graviano e in particolare Giuseppe strinsero i rapporti con alcuni gruppi
di 'ndrangheta. In particolare ricordo i fratelli Notargiacomo, certo Pino (non
ricordo se era un nome o cognome) e due che sono morti per lupara bianca. Con
loro trafficavamo in armi e droga. Ho riferito già a suo tempo di questi
rapporti. Posso dire che nel 1988/90 li abbiamo ospitati presso l'Eurovillage di
Buonfornello di Cannella. Erano scampati ad un agguato e, verosimilmente, o si
stavano nascondendo dai nemici o erano (anche) latitanti..."
Confermo pienamente quanto dissi a suo tempo nel
verbale sopra riportato. A vostra richiesta e domanda preciso che fu proprio
Marchese Antonino, forse, ma non sono sicuro, unitamente a suo fratello
Giuseppe, a conoscere per primo, fra noi di Cosa Nostra palermitana, i suddetti
Notargiacono. Ricordo che tale conoscenza avvenne nel carcere di Trani dove
Marchese Antonino, e forse Giuseppe, erano detenuti unitamente ai Notargiacomo.
In seguito a questo periodo di co-detenzione con il (o i) Marchese, i
Notargiacomo vennero scrarcerati prima del (o dei) Marchese suddetti (Marchese
che, infatti, per quanto mi risulta, negli anni successivi sono rimasti
detenuti). Fu quindi Gregorio Marchese, che invece era libero e non era stato
detenuto a Trani (ma se non erro in quel periodo non è mai stato detenuto)
fratello di Giuseppe e Antonino, nonché mio cugino, a presentarmi i
Nortargiacomo che io stesso ho poi presentato a Giuseppe Graviano. In tutta
evidenza, quindi, i Marchese detenuti (Antonino e, forse Giuseppe) avevano fatto
da tramite con il fratello Gregorio per metterlo in contatto con i Notargiacomo
e ritengo che ciò possa essere avvenuto nel corso di colloqui con i familiari
nel suddetto carcere di Trani. Preciso che Gregorio Marchese era uomo a nostra
disposizione, pur non essendo uomo d'onore. Egli faceva continuamente da tramite
fra noi del Mandamento di Ciaculli, i suoi fratelli detenuti - che invece, a sua
differenza, erano uomini d'onore - e altri esponenti anche di rilievo di Cosa
Nostra. In tale contesto il Gregorio Marchese ci presentò i Notargiacomo. Si
tenga presente che all'epoca ( siamo nella seconda metà degli anni 80') il
Mandamento di Ciaculli comprendeva anche la famiglia di Brancaccio, oltre che
quelle di Corso dei Mille e di Roccella, dunque per tale ragione è evidente che
la conoscenza con i Notargiacomo venne immediatamente fatta anche dal Graviano
Giuseppe che reggevano la famiglia di Brancaccio posto che io, come uomo
d'onore, facevo parte della famiglia di Brancaccio ed avevo un rapporto
quotidiano e fraterno con i Graviano stessi. Peraltro Giuseppe Graviano, dopo
l'arresto di Lucchese Giuseppe, che era il capo Mandamento di Ciaculli, divenne
colui che di fatto dirigeva il predetto Mandamento. Preciso che ero io stesso,
in prima persona, che, unitamente a Giuseppe Graviano, anche quando Lucchese era
libero, avevo rapporti con i Notargiacomo, dunque parlo di rapporti che ho
vissuto direttamente. In tale contesto si colloca la vicenda di Buonfornello di
cui ho detto e tutte quelle relative ai comuni traffici di armi e droga che
avevamo noi di Brancaccio con i tre fratelli Notargiacomo. Rapporti di cui ho
riferito ampiamente in precedenti verbali. A vostra richiesta, premesso che i
fratelli Notargiacomo erano tre, preciso che i rapporti li avevo solo con Nicola
e Dario Notargiacomo. Fra i loro sodali ho conosciuto anche i fratelli
Bartolomeo e un tale Pino, tutti calabresi (di Cosenza) come i Notargiacomo. A
vostra domanda vi dico che non ricordo con esattezza il nome del terzo fratello
Notargiacomo, che non ho mia conosciuto, forse si chiamava Roberto, ma non sono
sicuro. Colloco questi rapporti con i Notargiacomo ed i loro sodali in un
periodo che si è sviluppato fra il 1985/86 (comunque dopo la scarcerazione dei
Notargiacomo) fino all'inizio degli anni '90. Mi chiedete se i Notargiacomo si
siano mai lamentati dell'azione investigativa o comunque del comportamento di
qualche uomo dello Stato. Si ricordo bene questa circostanza. Mi pare di averne
già parlato in qualche verbale. In ogni caso ricordo che i Notargiacomo si
lamentavano, anche con me personalmente, sia del Direttore di un Carcere, che
operava dalle loro parti (direttore che, se non ricordo male, poi, è stato
ucciso) in quanto a loro dire pare fosse stato molto duro nei loro confronti ed
aveva fatto, sempre a loro dire, degli abusi contro di loro, che di un
funzionario di polizia, sempre operante delle loro parti, quindi a Cosenza, che
indagava con molta capacità e decisione su di loro. Con riferimento a questo
funzionario, ricordo che i Notargiacomo ci dissero che lo stesso veniva a
Palermo, mi pare con cadenza mensile, in quanto aveva la moglie in stato di
gravidanza che si faceva seguire da un noto ginecologo palermitano, mi pare, ma
non sono sicuro, tale dott. Cittadini. Ricordo che questo nome, quello del
ginecologo, è stato da me fatto ai PPMM, molti anni fa, a verbale, quando la mia
memoria era più fresca. In ogni caso i Notargiacomo ci dissero e lo dissero in
particolare a Graviano Giuseppe, essendo anche io presente, questo particolare
delle visite ginecologiche della moglie di questo funzionario, in quanto
volevano essere autorizzati dal Graviano Giuseppe ad uccidere detto funzionario
quando, accompagnando la moglie, veniva a Palermo. Se non ricordo male ci
dissero anche il tipo di macchina che utilizzava il funzionario per accompagnare
la moglie dal ginecologo. Questo ginecologo aveva lo studio a Palermo in zona
centrale, ma in territorio di competenza di mandamento diverso dal nostro. Mi
pare di avere specificato bene il luogo dove il funzionario si recava con la
moglie e quindi il luogo dove il predetto ginecologo faceva le visite alla
moglie del funzionario di polizia. Se non ricordo male, tale luogo è dalle parti
del Teatro Massimo e del Politeama. Questa richiesta o meglio questa richiesta
di essere autorizzati a commettere il delitto, venne fatta dai Notargiacomo
quando Lucchese Giuseppe era ancora libero. Ricordo che ricevuta la richiesta,
il Graviano ne parlò con Lucchese e ricordo che io presi parte alla
conversazione. Lucchese prese atto della richiesta e disse che ne doveva parlare
a Riina e, quindi, in Commissione. In seguito Graviano Giuseppe mi disse che di
quell'attentato al funzionario di polizia cosentino da farsi a Palermo non se ne
faceva nulla perché non era il momento di fare "chiasso" con un atto così
eclatante. Di seguito tale diniego venne comunicato dal Graviano ai
Notargiacomo. Quindi in effetti l'attentato non venne fatto.
ADR: Non ricordo assolutamente il nome del
funzionario di polizia che doveva essere ucciso dai Notargiacomo.
ADR: Non sono in grado di dire come i Notargiacomo
sapessero di queste visite a Palermo del funzionario di polizia e della moglie.
Forse avevano una talpa o forse qualcuno ne aveva seguito gli spostamenti.
ADR: questo episodio della richiesta di potere
uccidere a Palermo il funzionario di polizia è sicuramente precedente al
soggiorno dei Notargiacomo presso il villaggio Euromare di Buonfornello".
Le successive acquisizioni, provenienti
dall'apporto dichiarativo dei fratelli Notargiacomo, confermavano in pieno il
narrato di Drago. Il 4 maggio 2017, invero, Nicola Notargiacomo precisava:
"Ricevo lettura di stralcio del verbale da me reso in data 28.6.2016:
ADR: Ho conosciuto Giuseppe Graviano nel 1988
quando mi recai a Palermo insieme a Bortolomeo Stefano e mio fratello Dario.
Avevo rapporti con i siciliani in quanto in carcere a Trani, nel 1985 io e
Bartolomeo Stefano avevamo conosciuto Nino Marchese. Io all'epoca ero inserito
nel gruppo Perna operante nella zona del cosentino. La cosca Perna era
contrapposta a quella Pino/Sena. Non eravamo riconosciuti, come cosca, dal
crimine di Polsi, anche se eravamo operativi come locale di Cosenza ed avevamo
rapporti molto intensi, anche grazie a me, con i Nirta, gli Aricò (Destefaniani
di Reggio Calabria) e i Pelle.
ADR: Più precisamente fu Drago Giovanni che a sua
volta ci era stato presentato da un fratello di Nino Marchese, a presentarci
Giuseppe Graviano. Si instaurò un rapporto privilegiato proprio con Giuseppe
Graviano. Iniziammo a scambiarci, armi, esplosivi, droga. Più precisamente noi
vendevamo a Giuseppe Graviano e a tutta la famiglia di Brancaccio, armi
automatiche (UZI, kalashnikov, ecc), acidi, loro vendevano a noi stupefacenti
del tipo cocaina ed eroina, inoltre ebbero a regalarci del tritolo per un
quantitativo di circa 25 kg. Tutto ciò avvenne fra il 1988 ed il 1989, anno nel
quale, a seguito di un conflitto a fuoco nel quale Bartolomeo Stefano ebbe a
subire gravissime ferite, ci rifugiammo nel villaggio Euromare di Buonfornello.
Preciso che andammo presso questo villaggio in quanto Giuseppe Graviano ci aveva
detto che aveva dei medici che potevano curare il Bartolomeo Stefano. Ed in
effetti così fu. Al Villaggio Euromare abbiamo avuto rapporti diretti e
frequenti con Giuseppe Graviano (che io sapevo essere il vero titolare del
villaggio), Cristofaro Cannella, Tullio Cannella, Marcello e Vittorio Tutino,
Cesare Lupo, vero factotum dei Graviano, ed altri ancora. Ricordo anche uno che
faceva da supporto continuo a Bagarella Leoluca. Mi chiedete se questa persona
fosse tale Calvaruso. Si, lui, Toni Calvaruso. Andai con lui in barca all'isola
delle femmine.
ADR: In tale Villaggio rimanemmo fino ad Ottobre
1989 (eravamo arrivati nel Giugno dello stesso anno). Ricordo, circostanza che
mi indisse ad andare via, che Graviano Giuseppe mi disse che secondo un
"professore" che aveva visitato Stefano Bartolomeo, il predetto aveva oramai
riportato a seguito delle ferite, sotto un profilo psicologico, gravi e
permanenti conseguenze che lo avrebbero reso inaffidabile. Si erano, poi,
determinate ulteriori situazioni incresciose che incrinarono i nostri rapporti
con il Graviano. In particolare, a mia insaputa avevo intrecciato una relazione
con una ragazza che solo in un secondo momento venni a sapere trattarsi di una
cugina di Lupo Cesare. Poi Graviano reclamava (come mi disse Marcello Tutino nel
ristorante Happy Days di Giovanni Lombardo) una parte di pagamento non ancora
soddisfatto di un fornitura di cocaina.
ADR: Giuseppe Graviano è anche venuto a farci
visita a Cosenza con sua moglie, sua cognata e con Marcello Tutino, nell'estate
1988. Andammo insieme a Camigliatello Silano per fare una gita. Pernottarono
presso l'abitazione di Bartolomeo Stefano sita in Contrada Andreotta.
ADR: i nostri rapporti con Giuseppe Graviano, sia
pure in modo non traumatico, in concreto, si interruppero, quindi, nel 1989 a
seguito delle incomprensioni di cui ho detto.
ADR: Tutte le vicende relative ai rapporti
illeciti fra noi e i Graviano hanno avuto uno sviluppo processuale, con
condanne, a Palermo. Sono i processi cd "Ferryboat" che si sono chiusi più o
meno nel 1997/98.
ADR: Non ho mai parlato con Giuseppe Graviano dei
suoi rapporti con componenti della 'Ndrangheta diversi da noi. Certamente ne
aveva. Non gli mancavano. Ma non ne parlammo mai espressamente. Ora che ricordo,
per fare un esempio di quanto il Graviano potesse essere inserito in rapporti
con esponenti della 'Ndrangheta, una volta, lo stesso mi chiese se, per le
nostre esigenze a Cosenza, avessimo avuto bisogno di killer. In caso positivo,
aggiunse, poteva farmi entrare in contatto con i Facchineri di Cittanova che,
disse, erano suoi amici. Posso dire che Graviano aveva agganci
ovunque...omissis". Confermo tali dichiarazioni. Mi chiedete se nel corso della
nostra collaborazione criminale con i Graviano sia mai successo che noi abbiamo
richiesto l'autorizzazione a commettere un omicidio a Palermo. Rispondo di sì.
Si tratta di episodio che non ho vissuto direttamente ma che mi è stato
raccontato da mio fratello Dario. In effetti mio fratello Dario mi disse che era
stato a Palermo con Bartolomeo Stefano ed aveva richiesto a Graviano Giuseppe di
essere autorizzato ad uccidere un Ispettore di Polizia a nome Toni Provenzano,
che faceva servizio alla Questura di Cosenza. Il Provenzano aveva sposato la
sorella di una ex moglie di mio fratello Dario. Questa donna, cioè l'ex moglie,
si chiamava Caloiero Stefania. Il Provenzano ci dava fastidio. Spesso fermava
mio fratello, lo controllava. Abusava della sua divisa per motivi penso
personali. Insomma dava noia. Eccedeva. Era troppo zelante. Mio fratello mi
disse che il Provenzano per suoi motivi spesso andava a Palermo. Se non ricordo
male il Provenzano aveva in cura a Palermo qualche suo parente. Non ricordo che
parente fosse né di che tipo di cure avesse bisogno. A vostra domanda, che mi
chiedete perché scomodare Cosa Nostra per uccidere un Ispettore di Polizia a
Palermo, che facilmente avremmo potuto uccidere in Calabria, rispondo che
comunque a noi sembrava che ucciderlo a Palermo fosse la cosa migliore perché in
questo modo nessuno poteva sospettare di noi e soprattutto ci fidavamo dei
palermitani e dell'appoggio che avrebbero potuto darci. Ricordo che mio fratello
Dario mi disse che aveva chiesto l'autorizzazione a Giuseppe Graviano, che
all'epoca era capo-mandamento per commettere l'omicidio in questione e che il
Graviano, dopo essersi consultato con Riina, gli disse che non era il caso di
commettere questo delitto a Palermo perché in quel momento un delitto eclatante
avrebbe determinato conseguenze pregiudizievoli per cosa nostra. Questi fatti
sono avvenuti nel 1998 (in realtà è il 1988, come ricavabile dal certificato
storico di detenzione e dal fatto che lo stesso iniziò a collaborare con la
giustizia nel 1993 – n.d. PM), subito dopo la nostra scarcerazione.
ADR: Io non ho mai conosciuto Giuseppe Lucchese.
Conosco il nome, ma non l'ho mai visto. A vostra domanda chiarisco che, per
quanto mi risulta, quello del Provenzano è l'unico omicidio in relazione alla
cui esecuzione abbiamo richiesto l'autorizzazione a Graviano, ovvero la sua
collaborazione. A vostra domanda preciso che non ricordo proprio che noi abbiamo
richiesto la collaborazione di Cosa Nostra per uccidere un qualche Direttore di
Carcere.
ADR: Non ho un fratello a nome Roberto siamo solo
due fratelli io e Dario. Esiste un Roberto che è il fratello di Stefano
Bartolomeo".
Analogo apporto proviene dalle dichiarazioni di
Dario Notargiacomo, il quale sempre in data 4 maggio 2017 dichiarava: "Ricevo
lettura del mio verbale del 6.7.2016. "A sua domanda preciso di aver iniziato a
collaborare con la giustizia nel dicembre 1993, in un periodo in cui ero
sottoposto alla misura della semilibertà che ho in seguito violato a seguito di
alcuni episodi che mi hanno messo in allarme. Ho poi deciso di collaborare con
la giustizia in quanto ha avuto paura per la mia incolumità: per tali ragioni mi
sono trasferito a Roma, dove ho beneficiato dell'aiuto dei fratelli CARDELLI
attraverso i quali ho mantenuto rapporti con persone vicine al clan SENESE. Ho
conosciuto i fratelli GRAVIANO tramite Nino MARCHESE quando ci trovavamo tutti
insieme nel carcere di Trani. In quel periodo ho conosciuto anche Leoluca
BAGARELLA. I contatti con la famiglia MARCHESE erano tenuti anche da Stefano
BARTOLOMEO che aveva rapporti molto stretti anche con Giovanni DRAGO. I rapporti
con i GRAVIANO si instaurarono attraverso questo circuito e divennero
particolarmente stretti nel tempo tanto che Giuseppe GRAVIANO venne a trovarci a
Cosenza. A seguito di tali primi contatti, ai fratelli GRAVIANO abbiamo fornito
numerose armi, corte e lunghe, che venivano acquistate dai PARADISO di Lamezia
Terme. Le armi venivano vendute ai GRAVIANO ed ai MARCHESE: ricordo che i nostri
rapporti si sono estesi anche a Fifetto CANNELLA. Le armi che vendevamo ai
GRAVIANO, anche attraverso Stefano BARTOLOMEO ed il fratello Roberto, ci
venivano regolarmente pagate. Dai GRAVIANO invece noi acquistavamo sostanza
stupefacente del tipo eroina. Tutto questo si svolge nel periodo che va dal 1988
al 1990. A sua domanda confermo di essere stato ospite dei GRAVIANO in Sicilia
nel 1989 presso un villaggio turistico nei pressi di Termini Imerese, che mi
pare si chiamasse Euromare: tale villaggio era nella disponibilità di GRAVIANO
Giuseppe. In tale località ho incontrato oltre ai fratelli GRAVIANO anche
Giovanni DRAGO, Fifetto CANNELLA e Tullio CANNELLA. Il nostro soggiorno in
Sicilia avviene dopo il ferimento di Stefano BARTOLOMEO, in quanto avevamo
bisogno di un luogo tranquillo. Se non ricordo male lo spostamento in Sicilia
venne programmato dal BARTOLOMEO che aveva rapporti diretti con i GRAVIANO.
Intendo precisare che nel corso del soggiorno abbiamo avuto rapporti anche con
Vittorio TUTINO e Cesare LUPO. Il rapporto tra me ed i fratelli GRAVIANO è
sostanzialmente parificabile, anche se non sovrapponibile totalmente, a quello
che aveva anche mio fratello con i predetti. Oltre a noi i GRAVIANO avevano
rapporti con appartenenti alla 'Ndrangheta della zona di Polistena, di cui non
ricordo il nome. Questo riferimento venne fatto in relazione alla situazione di
Pino MARCHESE a cui non era stata riconosciuta la semi infermità mentale. Se non
sbaglio fecero riferimento ad una avvocato o magistrato operante in Calabria che
doveva interessarsi in Cassazione a favore del MARCHESE...omissis. Ricordo anche
che Giuseppe GRAVIANO ci chiese la disponibilità di un alloggio in Sila da
destinare alla latitanza di Totò RIINA: questo episodio è precedente al nostro
soggiorno presso il villaggio Euromare. Intendo precisare che noi facevano parte
del gruppo PERNA-PRANNO-VITELLI, in cui sono entrato nel 1981. Noi avevano una
certa indipendenza che ci aveva affidato Franco PERNA: ciò valeva per il
traffico di armi e di stupefacenti di cui parlavo prima. Questa indipendenza era
stata guadagnata da noi per la capacità di gestire un gruppo di fuoco
importante. È doveroso precisare, visto che me lo chiede, che Franco PERNA era a
conoscenza dei nostri rapporti con i GRAVIANO: ricordo di aver informato il
PERNA di tali rapporti nel corso della comune carcerazione in Pianosa nel 1986.
Sono a conoscenza che i PINO/SENA avevano rapporti con la cosca BONURA di
Palermo, come appresi da un certo Franco nel carcere di Cosenza nel 1990. Non
ricordo se mi vennero riferiti altri particolari in merito a tale
rapporto...omissis. I nostri rapporti con i GRAVIANO si interruppero nel 1990
con il nostro arresto. Nell'ultimo periodo i nostri rapporti si erano comunque
rovinati. Ho saputo da Stefano BARTOLOMEO che tutto quello che i GRAVIANO
facevano era conosciuto da Toto RIINA: mi disse in particolare che i GRAVIANO
erano particolarmente rispettosi della linea di comando...omissis. Confermo tali
dichiarazioni. Mi chiedete se nel corso della nostra collaborazione criminale
con i Graviano sia mai successo che noi abbiamo richiesto l'autorizzazione a
commettere un omicidio a Palermo. Rispondo di sì. In effetti successe che io
personalmente, accompagnato da Bartolomeo Stefano, parlai con Drago Giovanni -
non ricordo con certezza, nell'occasione, la presenza di Graviano Giuseppe che
non posso escludere, ma per noi era come se fosse presente perché era pacifico
che quello che dicevamo a Drago, questi lo doveva riportare a Graviano - di un
omicidio di un funzionario di Polizia, più esattamente di un Ispettore, tale
Toni Provenzano. Toni Provenzano era il marito della sorella della mia ex
moglie. La mia ex moglie si chiama Stefania Caloiero. Non ricordo il nome di sua
sorella, moglie del Provenzano. In effetti il Provenzano non voleva
imparentarsi, sia pure indirettamente, con un pregiudicato come me. Per questo
mi aveva preso di mira e mi controllava di continuo abusando della sua funzione.
Ciò sia prima della mia carcerazione a Trani (all'epoca ero già fidanzato con la
mia ex moglie) che dopo ( io mi sono sposato con la mia ex moglie nel
febbraio/marzo 1989 e mi sono separato di fatto da lei nel 1992) . Ricordo che
era ossessivo, mi fermava per strada, mi perquisiva la vettura e così via con
frequenza quasi quotidiana. Mi aspettava sotto casa. Insomma non ne potevo più.
Senza contare che questo atteggiamento a mio avviso generato da motivi
personali, arrecava danno alle attività criminali mie e del mio gruppo. Per
questo, avendo saputo che il Provenzano si recava a Palermo per accompagnare la
moglie da un noto ginecologo, chiesi (direttamente o indirettamente, non ricordo
come ho detto) unitamente al Bartolomeo, l'autorizzazione al Graviano di
commettere il delitto in questione. Ricordo che precisai ai siciliani che questo
Provenzano era un poliziotto della Questura di Cosenza, presso la quale come
capo della mobile operava dott. Calipari, buonanima. Ricordo che in un primo
momento il Graviano ci diede l'assenso nel senso che disse o ci fece dire che se
ne sarebbero "occupati loro". Una volta mi dissero, più esattamente fu il Drago
a dirmelo, che avevano pedinato il Provenzano e che questo era entrato in una
caserma per cui avevano interrotto il pedinamento. In un secondo momento
Graviano, direttamente o indirettamente per il tramite del Drago ora non ricordo
a distanza di tempo, mi disse o mi fece sapere che bisognava soprassedere alla
esecuzione del delitto in quanto lo stesso Riina riteneva che il momento storico
non era adatto, in quanto loro, dopo il delitto, avrebbero avuto la polizia
addosso. In realtà io penso che Riina non voleva fare eseguire il delitto in
questione in quanto rischiava di mettere in pericolo e quindi di bruciare il
canale che aveva con noi e quindi la nostra preziosa collaborazione. Senza
contare che vedeva a rischio anche la possibilità di avere rifugio nel cosentino
nella casa sulla Sila che noi volevamo mettergli a disposizione. Ovvio che
l'esecuzione dell'omicidio di un poliziotto cosentino a Palermo avrebbe potuto
fare pensare ad una alleanza fra noi (si tenga conto che peraltro il Provenzano
era quasi un mio parente) e Cosa Nostra e quindi il Riina.
ADR: Il dott, Calipari era un obbiettivo del
gruppo Perna e in particolare di Franco Perna che lo voleva morto. Ciò fin da
prima del nostro arresto e della nostra detenzione a Trani per l'omicidio
Cosmai. Il Calipari era un poliziotto che dava "fastidio", molto tenace e, in
particolare, aveva redatto dei rapporti indirizzati al Carcere di Cosenza e
quindi al Cosmai, nei quali evidenziava la pericolosità di Franco Perna al fine
di fargli revocare la semilibertà. Ciò in epoca antecedente e prossima al 1985.
Insomma Calipari era in pericolo. A vostra domanda non escludo affatto che noi
abbiamo parlato di queste intenzioni del Perna ai danni del Calipari anche con i
siciliani. Tenete conto che questo tipo di delitti in danno di rappresentanti
dello Stato, come il caso del Cosmai, agli occhi di Cosa Nostra era come se
fossero delle "stellette" dei veri e propri segni distintivi della nostra
capacità criminale e della nostra affidabilità. Dunque niente di più facile che
parlando con i siciliani sia a Trani che a Palermo del delitto Cosmai, si sia
fatto riferimento anche ai propositi del Perna (del cui gruppo abbiamo fatto
parte fino al 1989) di uccidere il Calipari. Si tenga anche presente che, nel
febbraio 1988, quando fummo scarcerati da Trani, il proposito del Perna di
uccidere il Calipari era ancora attuale e noi eravamo ovviamente coinvolti in
tale progetto posto che eravamo appartenenti alla cosca del Perna". La
intervenuta conferma dei propositi omicidiari da parte dei collaboratori di
giustizia ha imposto ulteriori approfondimenti di indagine attraverso la diretta
escussione del V.Q.A. Antonio Provenzano, certamente individuato dai fratelli
Notargiacomo come soggetto da uccidere in Palermo, e dell'On. Rosa Maria
Villecco, vedova di Nicola Calipari.
Provenzano, escusso in data 17 maggio 2017,
dichiarava: "ADR: Sono entrato in Polizia nel 1981. Ho preso servizio, nel 1985,
presso la questura di Cosenza quale Vice Ispettore in servizio presso il
dipendente Commissariato di Rossano Calabro. Nel 1985 ho preso servizio alla S.
Volante di Cosenza che dipendeva dalla S. Mobile (all'epoca diretta dal dott.
Nicola CALIPARI – n.d.P.M.). Sono stato due anni alle volanti (con intermezzi
alla Digos) e nel 1988 sono stato spostato stabilmente alla Digos dove dirigevo
una sezione. Sono rimasto alla Digos fino alla fine degli anni 90.
ADR: Mi sono sposato il 24.4.1983 con Caloiero
Giuliana. La stessa tuttora è mia moglie. Abbiamo cercato di avere figli nostri
nel 1983 e nel 1984. Mia moglie ha avuto due gravidanze ma – per interruzioni
involontarie delle stesse - abbiamo perso i figli, per problemi riguardanti la
salute di mia moglie. Infine abbiamo adottato.
ADR: Ovviamente abbiamo tentato di superare questo
problema di salute di mia moglie che non riusciva a portare a termine le
gravidanze facendoci assistere da specialisti. Ricordo in particolare che
andammo a Palermo dal dott. Cittadini che ha una clinica, a nome Candela, alle
spalle di piazza Politeama. Non ricordo esattamente le date delle visite. Certo
iniziarono dopo le gravidanze interrotte e per alcuni anni continuarono fino
alla fine anni 80', inizi 90'. Mi chiedete di essere più preciso sulle date ed
io vi dico che consultando la documentazione a casa potrei risalire alle date
esatte. Mi rappresentate che nel corso di questi miei viaggi a Palermo sono
stato pedinato e ho rischiato un agguato. Mi chiedete di conseguenza di riferire
chi fosse a conoscenza di questi miei viaggi a Palermo con mia moglie. Vi
rispondo, in primo luogo, che non avevo mai sospettato di potere essere oggetto
di tali attenzioni e poi che io non ho mai detto a nessuno, per ovvie ragioni di
riservatezza, di questi miei viaggi a Palermo. A vostra domanda vi dico che non
posso escludere che mia moglie abbia potuto riferire degli stessi a suoi
congiunti, con particolare riferimento alla madre. Escludo che possa essersi
confidata con le sorelle perché non si parlavano, se non con Anna Franca, con la
quale aveva rapporti, invece.
ADR: In effetti la sorella di mia moglie, a nome
Caloiero Stafania è stata sposata, per un breve periodo, con Dario Notargiacomo
noto criminale della zona di Cosenza. Poi si sono separati.
ADR: E' vero che quando operavo alle volanti ho
sottoposto in più circostanze i fratelli Notargiacomo a controlli anche molto
puntuali e serrati. Preciso che questo era il mio modus operandi che attuavo in
modo costante con tutti i pregiudicati. Faccio presente che avevo una mia
tecnica particolare nel fare questi controlli. Ad esempio: notavo il
pregiudicato x in una certa via e lo controllavo. Se lo vedevo tre ore dopo in
altro luogo lo controllavo di nuovo. Era una cosa che faceva molto irritare i
pregiudicati, non solo per il fastidio che procuravano, ma anche perché se il
controllo evidenziava che più pregiudicati si accompagnavano fra loro, poteva
scattare la diffida del Questore che poi poteva determinare il ritiro della
patente. Per loro è una grave deminutio.
ADR: Mi chiedete se durante i miei viaggi a
Palermo sia mai entrato in strutture militari o di polizia. Rispondo di sì. In
una circostanza, non ricordo quando, per risparmiare, dormii in alcuni alloggi
di servizio della Polizia di Stato (mia moglie era rimasta a dormire in Clinica)
che si trovava dalle parti di una struttura sportiva. Il complesso era chiamato
Le Tre Torri ed ospitava, mi sembra, più forze di polizia. Vi era sicuramente un
posto di Polizia all'ingresso. Ricordo, inoltre, che in altre circostanze ho
mangiato alla mensa utilizzata dalla PdS di Palermo. Non ricordo dove si
trovava.
ADR: A Palermo io e mia moglie andavamo in
automobile, la mia Fiat Uno. Partivamo la mattina presto da Cosenza in modo da
arrivare lo stesso giorno in tempo per la visita del dott. Cittadini. In alcuni
casi ritornavamo a Cosenza in giornata, ciò quando la visita era veloce e non
richiedeva una presenza continuativa per un tempo apprezzabile di mia moglie.
Quando invece era necessario che mia moglie si trattenesse per un tempo più
lungo presso la Clinica del Cittadini, allora io pernottavo a Palermo. Come ho
detto una volta presso un alloggio di servizio, altre volte in una pensione che
stava a 50 metri dalla clinica, sullo stesso marciapiede.
ADR: Apprendo, più nel dettaglio, che la
'ndrangheta cosentina aveva richiesto, per il tramite dei Notargiacomo, a Cosa
Nostra di procedere alla mia eliminazione quando soggiornavo a Palermo e che poi
per ragioni indipendenti dalla volontà dei Notargiacomo l'attentato non ebbe
luogo. Mi chiedete se sono in grado di spiegare questa volontà di eliminarmi da
parte dei Notargiacomo e della 'ndrangheta cosentina. Mi chiedete se posso
ricordare qualche specifico episodio che possa avere determinato tanto odio nei
miei confronti. Rispondo che proprio il mio modo di fare ha determinato questo
odio. Io ero "energico" con tutti nello stesso modo. Con i mafiosi, con i pezzi
da 90 e con i ladruncoli da strada. Questo umiliava gli 'ndranghetisti che
pretendono un rispetto anche formale dalla polizia anche per fare vedere alla
popolazione che sono "importanti". Ritengo, per quella che è stata la mia
esperienza, che, non molti, in Polizia a Cosenza, all'epoca, avevano il "fegato"
per essere così inflessibili. Pochi si sottraevano alla debolezza di essere
forti con i deboli e deboli con i forti. Io ero "forte" con tutti. Compreso con
quelli della 'ndrangheta. Compreso con i Notargiacomo con cui evitavo
accuratamente di avere rapporti e a cui riservavo un trattamento inflessibile
come a tutti gli altri della 'ndrangheta.
ADR: Ero molto legato da un punto di vista
professionale al dott. Calipari che è stato dirigente della Mobile a Cosenza
anche quando le Volanti erano una sezione della S.Mobile. Ricordo che Calipari
mi stimava molto. Non sono a conoscenza di progetti omicidiari in danno di
Caliapari da parte della 'ndrangheta.
ADR: Tra i soggetti che ho controllato in modo
inflessibile vi è stato anche BAROLOMEO Stefano. Non ricordo episodi particolari
in relazione a tale soggetto". La definitiva conferma della reale situazione di
pericolo vissuta da Nicola Calipari, la si otteneva in data 16 giugno 2017 da
Rosa Maria Villecco, la quale a distanza di molti anni era in grado di fornire
particolari certamente utili a riscontrare il contenuto dei colloqui di Graviano
Giuseppe oggetto di intercettazione ambientale:
"ADR: Mio marito Nicola Calipari, è stato capo
della Squadra Mobile di Cosenza fino al Maggio 1989. Aveva avuto l'incarico di
funzionario della Mobile di Cosenza nel Luglio del 1982, ufficio che iniziò a
dirigere nel 1984, dopo che il suo superiore aveva avuto un trasferimento.
ADR: In effetti mio marito a partire dall'estate
del 1987 (ma potrei sbagliare di qualche mese) ebbe la scorta. Avevamo la
volante fissa sotto casa (a Rende) e due uomini seguivano Nicola ovunque. Ebbe
anche una vecchia blindata. Mio marito mi nascose inizialmente la situazione di
pericolo. Mi disse, infatti, che tutti i capi delle Squadre Mobili calabresi
avevano avuto precauzionalmente la scorta. Poi mi disse la verità. Aveva avuto
minacce dalla 'Ndrangheta. Era una cosa che mi disse perché io venni avvicinata
da una vicina di casa che mi disse che tutti sapevano che la scorta mio marito
l'aveva avuta in quanto minacciato (peraltro la vicina mi fece intendere che
sarebbe stato gradito un nostro trasferimento in altro condominio perché tutti,
nel palazzo, erano preoccupati, specie per la sicurezza dei bimbi). A questo
punto, come ho detto, chiesi conto a mio marito della effettiva situazione che
riguardava la sua e la nostra sicurezza. Allora Nicola mi disse che era la
'Ndrangheta ad avercela con lui. Erano state spedite lettere di minaccia contro
mio marito C'era stata una perquisizione fatta da mio marito al Perna Franco
stesso o a qualche suo accolito nel corso della quale doveva essere successo
qualcosa che aveva ulteriormente determinato o rafforzato il risentimento dei
Perna contro Nicola. La situazione era diventata particolarmente pericolosa e
così nel febbraio del 1988 mio marito, proprio per farlo allontanare da Cosenza,
venne mandato in missione in Australia. Così per qualche mese andammo in
Australia, dove c'era sto un caso di lupara bianca in danno un italiano. Era un
fatto legato alla 'Ndrangheta. Lui doveva partecipare e partecipò ad una
struttura interforze (tipo Dia, mi pare si chiamasse NCA) in cui erano presenti
lui e alcuni funzionari di polizia australiani e un magistrato australiano. Ci
trasferimmo in Australia, io, Nicola e nostra figlia, per alcuni mesi. Poi
tornammo in Italia, ancora Cosenza (cosa inspiegabile da un punto di vista della
sicurezza di mio marito) e poi, nel Maggio 1989, ottenemmo il trasferimento a
Roma (dopo che a mio marito era stato anche proposto di andare a dirigere la
Mobile di Reggio Calabria, ma in questo caso io mi opposi decisamente dicendogli
che era non lo avrei seguito).
ADR: Mio marito era molto legato al povero dott.
Cosmai, Rimase molto scosso per la sua morte. Nicola diceva che il Cosmai aveva
cercato di innovare nella gestione del carcere di Cosenza eliminando privilegi
che alcuni detenuti in precedenza avevano e facendo anche, all'uopo, del
"repulisti" interno. Mi disse che Cosmai venne ucciso perché alcuni agenti della
penitenziaria, infedeli, avevano sparso la voce che Cosmai nel carcere era molto
duro con gli appartenenti alla cosca dei Perna (ovvero di altra cosca) mentre
agevolava la cosca avversa. Insomma fecero ingiustamente credere che il Cosmai
si era schierato con una delle cosche in quel momento in guerra.
ADR: Nicola non mi parlò mai di sue indagini su
Cosa nostra, né dei rapporti fra Cosa Nostra e la Ndrangheta. Né mi risulta che
Cosa Nostra ebbe a rivolgergli delle minacce.
ADR: Fatti salvi alcuni giorni a Taormina, non
siamo mai stati in Sicilia altre volte, in quegli anni (gli anni 1982/89) né,
tanto meno, a Palermo.
ADR: Ricordo il nome di Provenzano come
collaboratore di mio marito, ma nulla più. Il funzionario e collega di cui più
si fidava mio marito era l'Ispettore Pirozzidella sezione omicidi. Aveva un
ottimo rapporto anche con l'Ispettore Pugliese. Inoltre era molto legato al
dott. D'Alfonso Alfonso, che dirigeva la Criminalpol della Calabria ed il dott.
Blasco che dirigeva la Squadra Mobile di Reggio Calabria".
“Bisognava agire per dare il colpo di
grazia allo Stato, i calabresi già si erano mossi”,
scrive Claudio Cordova mercoledì, 26 Luglio 2017 su "Il Dispaccio". La prima
traccia pubblica delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia palermitano,
Gaspare Spatuzza, sul coinvolgimento della 'ndrangheta nella strategia stragista
dei primi anni '90, si ha davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Reggio
Calabria, il 18 giugno 2009. Sono proprio le dichiarazioni di Spatuzza il punto
di partenza da cui muove la Dda di Reggio Calabria nell'inchiesta "Ndrangheta
stragista", che ha portato all'arresto del boss siciliano Giuseppe Graviano e di
Santo Filippone, uomo forte della 'ndrangheta della Piana di Gioia Tauro. Ecco
la deposizione di Spatuzza, del giugno 2009: ...omissis...Avv. Gatto - senta
signor Spatuzza lei ha mai sentito parlare dell'omicidio dei Carabinieri
avvenuto nel 1994 sull'autostrada di Reggio Calabria e precisamente in località
Scilla? Spatuzza Gaspare – e dottore guardi io purtroppo non posso rispondere
perché su queste…su questi fatti in cui già ho reso abbondantemente
dichiarazione, ci sono delle fasi uhm…delle indagini in corso per cui io intendo
avvalermi della facoltà di non rispondere, quindi però in queste condizioni non
posso farlo però ehm...mettetevi nelle mie condizioni..
Avv. Gatto - si, le chiedo scusa...
Spatuzza Gaspare – non posso rispondere...
Avv. Gatto - le chiedo scusa signor Spatuzza,
tanto lo chiederà anche il Procuratore e il Presidente...ma lei è stato sentito
da parte della Procura di Reggio Calabria in ordine a questo episodio?
Spatuzza Gaspare – in ordine a questo episodio
direttamente diciamo che la Procura di Caltanissetta, Firenze e di Palermo e
sono stato anche ascoltato dalla Procura di Reggio Calabria...
Avv. Gatto – signor Spatuzza le chiedo scusa, lei
ha avuto mai contatti con i fratelli Graviano?
Spatuzza Gaspare – i fratelli Graviano diciamo che
sono i capi famiglia della famiglia di Brancaccio a cui io appartenevo...
Avv. Gatto - ed è il mandamento di cui faceva
parte lei?
Spatuzza Gaspare – del mandamento io ho fatto
parte e poi ho gestito il mandamento come reggente dal '96 al '97...
Avv. Gatto - senta le notizie che lei ha avuto dai
fratelli Graviano, sono notizie che ho avuto in maniera diciamo da tutte e tre i
fratelli oppure da uno specifico dei fratelli?
Spatuzza Gaspare – no da Giuseppe Graviano...
Avv. Gatto - ricorda l'epoca in cui ha avuto
questa notizia?
Spatuzza Gaspare – come?
Avv. Gatto - ricorda l'epoca in cui ha avuto
questa notizia dei Carabinieri, dell'omicidio dei Carabinieri?
Spatuzza Gaspare – la notizia entra in un contesto
di cui io ho diciamo che...comunque in un contesto in cui mi è stata fatta
questa confidenza che erano stati uccisi questi due Carabinieri...
Avv. Gatto - senta, le faccio la domanda
secca...rientra questo omicidio nella strategia della tensione?
Spatuzza Gaspare – ehh...credo di si, in base alle
mie... (pausa)
Avv. Gatto - Presidente io avrei altre domande da
fare sull'attendibilità del teste però...
Dott. Finocchiaro – sì ma noi ancora…non sappiamo
ancora con precisione che cosa gli ha detto Graviano, quando glielo ha detto,
dove glielo ho detto...
Avv. Gatto - eh...
Dott. Finocchiaro – a noi queste cose qua
interessano...
Avv. Gatto - eh, io potrei continuare però mi
dovrei...
Dott. Finocchiaro – signor Spatuzza mi scusi...
Avv. Maffei – però Presidente io insi...
Dott. Finocchiaro – qua c'è qua...appunto dobbiamo
stabilire un poco i termini...
Avv. Maffei – Presidente, il signor Spatuzza...nel
mio modestissimo...
Dott. Finocchiaro – ...del...di questo esame...a
noi interessa sapere soltanto le confidenze, il contenuto delle confidenze che
il signor Spatuzza avrebbe ricevuto, questo a noi è noto diciamo soltanto sulla
base delle notizie giornalistiche, avrebbe ricevuto in ordine a questo omicidio
per cui lui non è imputato, non è nulla...per cui dovrebbe soltanto riferire
quello che ha saputo da altre persone; non vedo quindi su queste circostanze
perché si dovrebbe avvalere della facoltà di non rispondere..a noi soltanto
questo ci interessa perché noi stiamo procedendo nei confronti di due minori che
sono imputati per l'omicidio di questi Carabinieri; se lui ha saputo qualche
cosa in ordine a questo omicidio, è tenuto a rispondere..ha capito avvocato?
Spatuzza Gaspare – e allora mi scusi...
Dott. Finocchiaro – avvocato...
Avv. Maffei – però parla con me Presidente
immagino?
Dott. Finocchiaro – si, si parlo...parlavo con
lei, si...visto che è intervenuta...
Avv. Maffei – Presidente...
Dott. Finocchiaro – ha capito quali sono i termini
della questione?
Avv. Maffei – si ho capito, però se non è neanche
assistito...
Dott. Finocchiaro – come?
Avv. Maffei – si, si io sono d'accordo, ho capito
perfettamente ma se non è neanche assistito da un difensore, cioè voglio
dire...e questa è anche una situazione un po'...un po' particolare...
Dott. Finocchiaro – guardi...
Avv. Maffei – o no?
Dott. Finocchiaro – lui oggi poteva anche essere
sentito senza...senza difensore...se è stato dato avviso, è stato dato avviso
soltanto per un massimo di garanzia proprio per evitare che possa andare
incontro ad altre, però lei ben capisce che in questa situazione, lui ricopre la
veste di teste puro e semplice...siamo d'accordo?
Dott. Di Landro – dovremmo esserlo...
Avv. Maffei – Presidente io mi rimetto alla sua
decisione, non sono d'accordo però mi rimetto alla sua decisione, non...mi
sembra che non posso fare diversamente; essere d'accordo no perché comunque è
una persona che ha fatto...è stato capo di un mandamento cioè non è che ha
saputo queste notizie diciamo fuori da un contesto mafioso, ha conosciuto…ha
saputo questa notizia all'interno di un contesto mafioso, quindi...
Dott. Finocchiaro – ma guardi io non lo so come le
ha avute le notizie, quindi...
Avv. Gatto - sinceramente a me non è mai successo
però...
Dott. Finocchiaro – noi non sappiamo proprio
nulla, abbiamo letto un articolo di giornale che ci è stato prodotto dalla
difesa in cui si dice che il signor Spatuzza avrebbe anche...
Avv. Maffei – sì! sì, sì...
Dott. Finocchiaro – ...ricevuto delle confidenze
in ordine a questo omicidio, stop…poi non sappiamo nulla...
Avv. Maffei – si...
Dott. Finocchiaro – se il signor Spatuzza ci
chiarisce le idee, poi potremo essere in condizioni di dire se è un teste pure e
semplice, un testimone assistito, se non...se si può avvalere della facoltà di
non rispondere, tutte queste cose sono da...da verificare, non lo possiamo
stabilire a priori. Procuratore Generale come...
Dott. Di Landro – niente, a me pare...a me pare
che tutto quello che lei ha detto sia condivisibile al cento percento, volevo
soltanto aggiungere una nota di chiarezza, qua si tratta soltanto di sapere se
il signor Spatuzza sa e che cosa sa di questo omicidio, punto e basta; è inutile
che facciamo tutta questa confusione...mandamento, non mandamento, chi era il
capo, chi era il sottocapo, o…e tutti i contorni della vicenda...questi non ci
interessano, è un teste e noi abbiamo bisogno di avere il suo contributo se ce
lo può dare con riferimento a questo omicidio...se ce lo può dare, nessuno è qui
né a tormentarlo, né a volere per forza una risposta perché non possiamo stare
nemmeno appresso alle dicerie, a que...al sentito dire, noi abbiamo bisogno di
fatti concreti con riferimento ad una situazione grave qual è quella di cui ci
stiamo occupando, quindi se ha dati precisi, concreti, fattuali che possono
essere utili ai fini della verità, li dica sennò tanti saluti, lo ringraziamo
e...e via, andiamo avanti...
Dott. Finocchiaro – perfetto...
Avv. Priolo - Presidente se mi concede una parola
solo un momento, perché mi pare che si sia tutti d'accordo, perché cosa
principalmente il difensore del signor Spatuzza la interpretazione che lei ha
fatto del tutto, quindi mi pare che allo stato si possa andare a fare...mi pare
siamo tutti d'accordo compreso l'avvocato di Spatuzza, quindi...
Dott. Finocchiaro – va beh, allora avvocato...
Avv. Gatto - per me non ci sono problemi...
Dott. Finocchiaro – dico se lei fa le domande
specifiche...
Avv. Gatto - si io le faccio specifiche...
Dott. Finocchiaro – ecco...
Avv. Gatto - per me non ci sono problemi, per
questo...
Dott. Finocchiaro – sennò appunto...
Avv. Gatto - no, no per me non ci sono problemi,
io...le domande sono specifiche, proprio...
Dott. Finocchiaro – perfetto...
Avv. Gatto - ...però voglio dire...signor Spatuzza
senta, le fu...le ripeto la domanda in modo da riannodare i fili, lei ebbe
notizia sull'attentato ai Carabinieri avvenuto nel gennaio '94 in Reggio
Calabria, sulla...l'autostrada allo svincolo di Scilla?
Spatuzza Gaspare – a gennaio del '94 io ho..sono
stato incaricato di portare un...di compiere un attentato su Roma contro a dei
Carabinieri, quindi siccome io sto cercando di..di sospendere questo attentato
contro i Carabinieri perché ho intenzione di colpire un altro obiettivo...
Dott. Finocchiaro – non ho capito...
Spatuzza Gaspare – ...di cui il Giuseppe Graviano
capo del mandamento di Brancaccio mi dice che non può essere che…fare
l'attentato che io ho in mente ma si devono colpire i Carabinieri anche perché
in Calabria altre persone si erano mossi..difatti in quei giorni in Calabria
erano stati uccisi due Carabinieri, ora non so se questo contesto dei
Carabinieri di Calabria entra nel contesto della strage che dovevo compiere io
su Roma...
Avv. Gatto – questa è stata sola ed unica notizia
che lei ha avuto da Graviano?
Spatuzza Gaspare – si, si precisamente...
Avv. Gatto – dopo di questa vicenda non ne parlò
più?
Spatuzza Gaspare – no perché tra l'altro poi lui è
stato arrestato quindi...
Dott. Finocchiaro – è stato arrestato...
Spatuzza Gaspare – ...poi la nostra missione, un
po' si...si conclude...
Avv. Gatto – è a conoscenza se Graviano avesse
contatti in Calabria?
Spatuzza Gaspare – ma in Calabria nella nostra
storia, noi abbiamo avuto diversi contatti con i calabresi...
Avv. Gatto - che ha detto?
Dott. Finocchiaro – non abbiamo sentito mi scusi,
se può ripetere...
Spatuzza Gaspare – per la nostra storia, abbiamo
avuto sempre diversi contatti con le famiglie calabresi...
Avv. Gatto - non ho altre domande, grazie
Presidente...
Dott. Di Landro – nessun'altra domanda, la
ringrazio (incomprensibile).
Dott. Finocchiaro – va beh signor Spatuzza lei è
stato abbastanza ora...ora chiaro, quindi non abbiamo altre domande da porgerle
perché lei in effetti ora si è limitato a dire soltanto che ha avuto
questo...c'è stato questo richiamo, questo riferimento fatto da...dal Graviano e
basta, non sa nient'altro su questo omicidio per cui la disturbiamo più e
possiamo anche e...oncludere l'esame, la ringraziamo...avvocato
arrivederci....omissis".
Agli inquirenti fiorentini, nisseni e milanesi,
Spatuzza parla di vicende che non avevano mai incrociato sotto il profilo
professionale essendo vicende che appartenevano alla competenza della AG
reggina. Erano, episodi che, all'epoca delle appena riportate dichiarazioni,
risalivano ad oltre 14 anni prima, a cui, peraltro, non solo, non era stato
attribuito, in senso assoluto, il rilievo che meritavano, ma che, neppure, erano
mai stati collegati al contesto delle attività stragiste di quegli anni e,
quindi, ricollegate a quel programma criminale che Cosa Nostra siciliana aveva
ispirato. Dunque, Spatuzza introduce, del tutto spontaneamente, una vicenda di
cui, assolutamente, nessun collaboratore di giustizia siciliano aveva mai
riferito prima, e, soprattutto, l'aveva riferita in una prospettiva del tutto
nuova, per chiunque. E ciò senza essere, in alcun modo, sospettabile, per le
ragioni sopra spiegate, di essersi determinato a riferirla per venire incontro
ad aspettative degli inquirenti. Soprattutto, la fonte di Spatuzza era quella
più qualificata fra tutte quelle ipotizzabili per deporre su queste vicende:
invero, se esisteva – all'epoca – qualcuno, in Cosa Nostra, che poteva riferire
dei fatti in esame ebbene questi era proprio Gaspare Spatuzza, per anni mafioso
del quartiere Brancaccio. E ciò per un duplice ordine di ragioni: egli, in primo
luogo, era stato, proprio nel periodo stragista, il vero e proprio punto di
contatto e collegamento fra i vertici della famiglia di Brancaccio - e, dunque,
i Graviano ed il loro "vice" Nino Mangano (che prenderà il posto dei Graviano
dopo il loro arresto) e i gruppo degli esecutori delle stragi continentali –
composto da persone di fiducia di Riina-Bagarella-Graviano, anche non
formalmente "combinate". Ciò risulta pacificamente dalle sentenze emesse in
primo e secondo grado dalle Corti fiorentine sule stragi di Via dei Georgofili,
Velabro, San Giovanni in Laterano, Via Palestro, Stadio Olimpico, Formello tutte
in atti allegate; ha dimostrato, come si è visto, specie in materia stragista,
una prodigiosa memoria ed una particolare serietà ed attendibilità. L'uomo del
quartiere Brancaccio, quindi, delinea uno scenario stragista intimamente
connesso con gli attentati terroristici eseguiti da Cosa Nostra sul continente,
che, come oramai pacificamente accertato dalle Corti fiorentine, tendevano – in
un periodo storico caratterizzato da cambiamenti politici epocali, non solo in
Italia, ma sull'intero scacchiere internazionale – a mettere alle corde lo Stato
per indurlo a concessioni su particolari temi della giustizia quali il 41 bis
OP, le leggi sui collaboratori di Giustizia, ed altro ancora. Concessioni,
peraltro, che, a ben vedere, solo per uno strabismo valutativo, solo per un
inspiegabile errore di prospettiva (che si è perpetuato nel tempo) sono state
ritenute concessioni in favore di Cosa Nostra siciliana, laddove, invece, si
trattava di concessioni, di aperture, che, ove accolte, avrebbero portato
beneficio all'intero sistema criminale, e, dunque, fra le altre mafie, anche
alla 'ndrangheta. Su questo specifico aspetto, ovviamente, torneremo in modo più
ampio ed approfondito in seguito. In questa sede basterà anticipare che plurimi,
eterogenei e convergenti elementi di prova, dimostrano, invece, che tutte le
mafie nazionali, d'intesa, in quegli anni, perseguivano quell'obbiettivo. In
tale scenario – alla stregua delle propalazioni di Spatuzza – la 'ndrangheta si
era incaricata, attraverso un'intesa con Cosa Nostra, di mandare, anche lei,
seppure in modo meno eclatante, come era più congeniale al suo modo di agire (e
come, strategicamente, risulterà ben più remunerativo) un messaggio allo Stato,
attaccando reiteratamente uno dei suoi simboli: l'Arma dei Carabinieri. Simbolo
che, del resto, non era per nulla eccentrico rispetto alla complessiva strategia
stragista posto che, proprio nel periodo in cui venivano eseguiti a Reggio
Calabria i tre attacchi ai Carabinieri, Cosa Nostra stava organizzando quello
che poteva essere il più grave degli attentati di quella tragica stagione:
l'attentato, con auto-bomba, ai carabinieri in servizio di ordine pubblico allo
Stadio Olimpico di Roma, attentato che avrebbe determinato decine e decine di
morti. Circa un anno prima rispetto all'escussione a Reggio Calabria, nel luglio
2008, l'ex uomo dei Graviano rendeva dichiarazioni davanti alla Dda di Firenze:
P.M. DOTT. CRINI: Quindi siamo nel mese di
gennaio.
P.M. DOTT. NICOLOSI: Ma quanto tempo, come eravate
rimasti d'accordo con Graviano... cioè, Graviano sapeva il giorno in cui avreste
fatto l'attentato?
SPATUZZA GASPARE: No, lui sa che ci stiamo
spostando su Roma, quindi là poi teniamo un appuntamento su Roma. Quindi noi
andiamo là per trovare l'obiettivo Carabinieri. Quindi quando lui viene già noi
abbiamo detto: "Senti, l'abbiamo trovato, c'è il problema dell'Olimpico e
siamo..." poi noi abbiamo scelto la data. Quindi lui siccome doveva
transitare... e non lo so se sta venendo dalle Calabrie. Che là (incompr.) il
discorso che già altri si erano mossi, che in Calabria erano stati uccisi due
carabinieri. Quindi questi due carabinieri sono stati uccisi o in quel giorno o
il giorno prima. Questo è anche...
P.M. DOTT. CRINI: Un ulteriore elemento.
SPATUZZA GASPARE: Un ulteriore elemento.
P.M. DOTT. CRINI: Perché parlate del fatto che c'è
stato un altro...
SPATUZZA GASPARE: Perché io sto facendo leva...
P.M. DOTT. CRINI: ...uccisione di Carabinieri...
SPATUZZA GASPARE: Sto facendo leva io per
Contorno.
P.M. DOTT. CRINI: Certo, sì, sì.
SPATUZZA GASPARE: E lui mi dice: "No."
P.M. DOTT. CRINI: "Ci sono altri impegni."
SPATUZZA GASPARE: Il problema dell'esplosivo. "Ci
sono altri impegni e poi c'è il problema dell'esplosivo...omissis"
Pochi mesi dopo, siamo a dicembre, Spatuzza viene
sentito anche dai magistrati di Caltanissetta: "...Attentato all'Olimpico. Per
tale episodio delittuoso vi fu un incontro con Giuseppe Graviano in cui
manifestammo il nostro disagio per aver ucciso una bambina nell'attentato a
Firenze. In quell'occasione ci fin detto che dovevamo proseguire con la nostra
strategia perché sollecitare "chi si doveva muovere". Nacque in quella riunione
l'idea di colpire un pullman di carabinieri sicché pensammo di agire nuovamente
a Roma che è luogo pieno di caserme. A Roma andammo io Lo Nigro, Giuliano
Francesco, Giacalone Luigi, Salvatore Grigoli, Salvatore Benigno. Il supporto
logistico ce lo diede ancora una volta Scarano ed un amico di quest'ultimo di
nome Bizzoni. Ricordo che approntammo l'ordigno anche con dei tondini di ferro
affinché si potesse fare più danno possibile e scegliemmo come obiettivo lo
stadio Olimpico. Nel frattempo era salito a Roma anche Giuseppe Graviano, per
discutere della possibilità di uccidere Contorno che avevo individuato a Roma.
Il Graviano mi disse che non era possibile dovendosi utilizzare per Contorno un
altro esplosivo e poi perché quello stesso giorno o il giorno prima erano stati
uccisi due carabinieri in Calabria e, dunque, mi disse che già "gli altri si
erano mossi". A Roma operammo io, Benigno, Lo Nigro e Giacalone, mentre gli
altri erano riscesi a Palermo. L'attentato non andò a buon fine poiché non
funzionò il telecomando...omissis".
Poi, proprio nel periodo in cui viene ascoltato in
contraddittorio a Reggio Calabria, il collaboratore rende dichiarazioni anche
davanti alla Dda di Milano: "...omissis... SPATUZZA – Noi abbiamo in cantiere,
non dimentichiamo le torri(?) di via del Fante, Commissariato Brancaccio,
l'autocivetta della Polizia; quindi siamo ben proiettati per fare veramente del
male, però c'è questo cambiamento di rotta quindi andiamo su Roma, Milano,
quello che sia. Abbiamo noi Napoli, c'è la questione dei Carabinieri in
Calabria, che entra nel contesto dell'Olimpico. Quindi a questo punto... non so
questa la ricollego io a questa situazione di quello che mi dice Giuseppe
Graviano in quell'incontro che avviene a Campofelice.
P.M. – Cioè... Vada avanti e poi le farò delle
domande.
SPATUZZA – Quindi il momento che io gli dico che
siamo lì noi per mettere in cantiere l'attentato contro i Carabinieri, non
contro l'Olimpico, quindi io lo colloco nel novembre/dicembre del '93, perché
poi a gennaio sono stati arrestati i fratelli Graviano; quindi lo colloco a fine
del '93. Quindi quando si mette in cantiere questo attentato contro i
Carabinieri più ne possiamo prendere e meglio è, siccome il mio pensiero andava
sempre a quella bambina, la piccola Nadia...
P.M. – Di via dei Gergofili.
SPATUZZA – Di via dei Gergofili, (inc.) si
chiama... Quindi lì dico a Giuseppe Graviano che ci stiamo portando dietro
persone che non c'entrano niente, perché per la nostra mentalità è...possiamo
sposare noi Capaci, per noi quella schifezza andava bene, via d'Amelio, per
quella schifezza... secondo quella mentalità eravamo a posto, non siamo più a
posto quando entriamo noi sul tessuto sociale, quando diventiamo dei terroristi.
Quindi là c'è questa esternazione, esternazione parliamo, che io non potevo fare
ma siccome mi potevo permettere di dire questa cosa a Giuseppe Graviano, anche
perché tra i ragazzi c'era qualche tentennamento, che ci stiamo spingendo oltre.
Quindi gli dissi che il mio pensiero andava pensando a questa cosa e gli dissi
"Ci stiamo portando dietro persone che non c'entrano niente".
Lui ha capito un po' questa mia debolezza, se così
possiamo chiamare, quindi ci disse che è bene che ci portiamo dietro alcuni
morti così si danno una smossa, una spinta. A quel punto ci chiede a me e a Lo
Nigro se capivamo qualche cosa di politica. Io non ne ho capito mai niente,
neanche ho avuto mai modo di avvicinarmi a questa cosa, la stessa cosa il Lo
Nigro, e lui ci spiega che lui è abbastanza preparato di questa materia. Quindi
ci spiega che c'è in atto una situazione che se va a buon fine ne avremo tutti
dei benefici, a cominciare dai carcerati. Quindi lì si chiude la situazione e ci
spingiamo per l'attentato all'Olimpico, che poi grazie a Dio è fallito.
P.M. – Attentato all'Olimpico che significava allo
stadio?
SPATUZZA – Lo Stato...
P.M. – Lo stadio.
SPATUZZA – Lo stadio... No, le persone comuni.
P.M. – Le persone comuni?
SPATUZZA – I Carabinieri, però parliamo (inc.) dei
Carabinieri.
P.M. – Cioè di fare molto danno, un'espressione...
detto nella vostra...
SPATUZZA – Sì. E se noi pensiamo che il Totuccio
Contorno è un nostro nemico, a me mi lega per una questione familiare quindi ho
dedicato tutta la mia vita, disgraziatamente, per seguire a 'sti soggetti. Se
noi accantoniamo il Totuccio Contorno, che quando c'è l'appuntamento su Roma con
Giuseppe Graviano che vado a prendere (inc.) nella Capitale, io faccio pressione
per dirci "Colpiamo Contorno e…una volta che siamo tutti". Lui disse che
innanzitutto non si deve fare Contorno per due motivi: uno per l'esplosivo, che
si deve fare con l'esplosivo diverso di quello che già si è adoperato, e poi
perché si erano mossi i calabresi; infatti quel giorno e il giorno prima era
stato commesso un attentato contro due Carabinieri a Reggio Calabria. Quindi se
noi pensiamo Giuseppe Graviano c'ha un conto aperto, in sospeso con Totuccio
Contorno, perché Totuccio Contorno ha ucciso il padre di Giuseppe Graviano.
Quindi com'eravamo noi accaniti... ora se noi pensiamo che Giuseppe Graviano
accantonare una questione perché persona... vai a vedere quello che c'è dietro.
P.M. – Quindi, per ricapitolare, lei dice "Oggi
che leggo, che mi si dice per la prima volta qual è il contenuto di questa
missiva", e cioè saranno collocate altre bombe, ci saranno centinaia di morti,
lei dice "Non è che ora capisco, cioè questa è la riprova di quello che noi
stavamo facendo"...omissis".
Spatuzza, dunque, del tutto spontaneamente,
introduce riferimenti agli attentati in Calabria ai danni dei carabinieri. E lo
fa in quel contesto in cui riferisce della programmazione (la cui esecuzione era
prevista per il mese di gennaio 1994) dell'attentato (poi fallito per il mancato
funzionamento del telecomando ovvero dell'innesco dell'ordigno, che impedì
l'esplosione di 120 kilogrammi di esplosivo collocati all'interno di una vettura
opportunamente posizionata) ai carabinieri in servizio di ordine pubblico allo
Stadio Olimpico di Roma, che avrebbe comportato decine e decine di morti,
fornendo, in tal modo, una causale comune di tale episodio con quelli avvenuti
in Calabria. Tale matrice comune consiste proprio nella comunanza delle vittime,
in qualità di rappresentanti dello Stato, ma anche nella comunanza temporale
degli episodi, in quanto, nell'arco temporale in cui furono commessi i delitti
in Calabria, era in fase di programmazione l'attentato allo Stadio Olimpico di
Roma. Atteso il tenore dell'atto d'impulso, le indagini – che, per una parte,
erano svolte in stretto collegamento investigativo con le DDA di Catania e
Caltanissetta (e, per diversi motivi, con quella di Palermo) che, in quel
periodo, pure svolgevano indagini su connessi episodi stragisti di matrice
mafiosa – non potevano che partire da un nuovo ed approfondito esame di Gaspare
Spatuzza (il rilievo della cui collaborazione è stato esaminato in precedenza).
E così, in data 8.10.2013, si procedeva all'esame del collaboratore: "...Mi
richiedete di ricostruire in sintesi il mio percorso criminale e collaborativo e
rispondo che pur senza essere "combinato" negli anni '80 sono entrato in Cosa
Nostra e, segnatamente, nella famiglia Graviano operante in Brancaccio agli
ordini di Giuseppe GRAVIANO. Per tutti gli anni '80 ho operato nel descritto
contesto criminale effettuando anche per conto della famiglia svariati omicidi.
Solo agli inizi degli anni '90, fatto insolito fino a quel momento, sono stato
incaricato di reperire materiale esplosivo senza che mi fosse spiegato il perché
dal predetto GRAVIANO Giuseppe. Ovviamente in seguito compresi la ragione di
tale attività in quanto, con un ruolo più defilato a Capaci e con un ruolo più
incisivo a via D'Amelio partecipai alla stagione stragista avendo un ruolo anche
nei successivi attentati nel Continente. A vostra domanda preciso che non sono
in grado di stabilire con esattezza la ragione per la quale non ero stato ancora
"combinato". Diciamo che siccome operavo sempre all'interno del Mandamento di
Brancaccio non se ne sentiva la necessità. Indubbiamente, peraltro, questa
circostanza mi consentiva di operare in maniera più efficace, cioè in modo
coperto e discreto. Tornando alla concatenazione dei fatti che riguardano la mia
biografia criminale preciso che il 27 gennaio 1994 furono arrestati Giuseppe e
Filippo GRAVIANO nella città di Milano, essendo i predetti latitanti. Mi fu
detto che da quel momento avrei dovuto prendere gli ordini da Nino MANGANO che
diventava il reggente del Mandamento; nel 1995, precisamente a giugno, venne
arrestato anche Nino MANGANO. Due mesi o tre mesi dopo ebbi un incontro nel
trapanese con Matteo MESSINA DENARO, BRUSCA ed altri esponenti di Cosa Nostra.
All'esito di questo incontro essendo stato deciso che toccava a me reggere il
Mandamento di Brancaccio venni anche formalmente "combinato". Nel 1997 sono
stato arrestato e il mio pensiero fu quello di collaborare con la giustizia.
Resistenze e problemi familiari mi impedirono di concretizzare questa scelta.
Nel 2000 incontrai in carcere Giuseppe GRAVIANO nella casa circondariale di
Tolmezzo. Avendo maturato una forte ripensamento sul mio passato gli comunicai
che da quel momento mi doveva considerare dissociato da Cosa Nostra. Nel 2008 mi
sono finalmente deciso ed ho iniziato a collaborare con la giustizia essendo in
seguito riconosciutomi il programma speciale di protezione. Mi chiedete se ho
conosciuto Gioacchino PENNINO e vi rispondo che l'ho conosciuto egli era
vicinissimo ai fratelli Graviano così come lo era Sebastiano LOMBARDO che era
l'anello di congiunzione tra i Graviano ed il dott. PENNINO. Io stesso quando
ebbi un problema di famiglia, dovevo far riassumere mia nipote che era stata
licenziata dal dott. PENNINO, entrai in contatto con quest'ultimo tramite Iano
LOMBARDO. Mi viene chiesto di riferire tutto quanto è a mia conoscenza, sia
diretta che de relato, sui rapporti fra Cosa Nostra e la 'Ndrangheta calabrese.
Rispondo che ebbi conoscenza dell'esistenza di tali rapporti a metà degli anni
'80 in particolare venni a sapere dai fratelli Graviano che i "calabresi" ed in
particolare sentii il nome di due fratelli mi sembra che di nome facciano
Notargiacomo rifornivano di armi la nostra famiglia. Parliamo di un traffico di
"armi pesanti" cioè mitragliatori ed altre armi da guerra. In questo contesto
venni a sapere da Vittorio TUTINO che era ed è un componente della famiglia
GRAVIANO, che peraltro partecipava in prima persona a questo traffico di armi,
che i fratelli NOTARGIACOMO erano coinvolti in una faida in Calabria durante la
quale uno dei fratelli era stato ferito. Il TUTINO mi disse che i due fratelli
si erano rifugiati presso il villaggio "eurovillage" ubicato a Campo Felice di
Roccella villaggio gestito da Tullio CANNELLA che alla fine di una complessa
vicenda di cui ho già parlato divenne anche proprietario del villaggio che,
comunque, era un bene della famiglia Graviano. Su questo traffico di armi potrà
probabilmente riferirvi sia Emanuele DE FILIPPO che DRAGO Giovanni entrambi
collaboratori di giustizia della famiglia di Brancaccio. Altro episodio che
collega Cosa Nostra alla 'Ndrangheta, da quello che ho appreso nel corso della
mia detenzione nell'anno 1998. Successe che nell'ambito del noto procedimento
Golden Market da cui sono derivati numerosi stralci dei diversi processi si era
arrivati almeno per quello che riguarda il filone in cui ero imputato al grado
di appello. All'epoca ero detenuto a Tolmezzo insieme a Giuseppe e Filippo
GRAVIANO. In tale contesto i Graviano, da una parte, mi dissero che dovevo
ricusare il presidente della Corte di Assise di Palermo proprio all'ultima
udienza, cosa che io feci e che determinò lo stralcio della mia posizione cui
seguì tempo dopo la mia condanna solo per associazione e qualche reato satellite
con l'assoluzione per gli omicidi, dall'altra mi dissero che due tranche di 500
milioni di lire l'una per il tramite di AGATE Mariano erano state messe a
disposizione degli amici calabresi che "avrebbero" aggiustato un processo che io
dedussi essere uno dei filoni del Golden Market. In particolare si trattava di
aggiustare questo processo in Cassazione e Giuseppe GRAVIANO mi spiegò che gli
amici calabresi, in particolare il riferimento era alla cosca Molé-Piromalli si
sarebbero mossi su richiesta di Mariano AGATE. Mariano AGATE esponente di
vertice di Cosa Nostra è certamente da considerarsi, così come mi spiegarono i
fratelli Graviano e così come ho compreso stando in Cosa Nostra, l'anello di
congiunzione fra Cosa Nostra e la 'Ndrangheta. Questa informazione che ho avuto
a suo tempo mi è stata confermata nel corso degli anni durante i quali sono
stato sottoposto al 41 bis. In particolare ho potuto rilevare come tutti
indistintamente i capi 'Ndrangheta a partire da Mommo MOLE'avessero una
venerazione per Mariano AGATE. Voglio anche ricordare come Pasquale TEGANO con
me detenuto ad Ascoli Piceno unitamente a Mariano AGATE così come lo stesso
Franco COCO TROVATO quando si rivolgevano a Mariano AGATE mostravano un rispetto
che si riserva ai capi. Lo chiamavano "zu Mariano. Lo stesso ARENA detenuto ad
Ascoli quando si rivolgeva a Mariano AGATE lo chiamava vossia. Mi chiedete se
AGATE fosse massone vi rispondo che ho informazioni in questo senso.
Segnatamente tra il 1995 ed il 1996 ebbi ad incontrarmi con Mariano ASARO.
Eravamo entrambi latitanti e questa latitanza la trascorrevamo insieme dormendo
negli stessi rifugi in località Marausa. Entrammo in grande confidenza e l'ASARO
nel riferirmi delle grandi opportunità che derivavano da Cosa Nostra dai
rapporti con la massoneria mi disse che Mariano AGATE massone ne era un esempio.
Prima di riferirvi della vicenda degli attentati dei carabinieri in Calabria
posso riferirvi di un altro episodio che evidenzia i collegamenti tra Cosa
Nostra e la Ndrangheta. In particolare mi riferisco ad un traffico di armi e
droga che nel corso del '93 la famiglia Graviano sviluppò in sinergia con i
calabresi appartenenti della famiglia Nirta. Preciso che il contatto con NIRTA
(ho conosciuto due fratelli NIRTA di circa trent'anni all'epoca di cui uno
chiamato Pino) fu ottenuto grazie ai buoni uffici di SCARANO Antonio colui che
si occupò di approntare le basi logistiche per gli attentati a Roma, persona di
origine calabrese. Il traffico avviato dai GRAVIANO si concluse quando divenne
reggente Nino MANGANO. Il trasporto dell'hashish che arrivava dalla Spagna
giungeva via mare a Palermo grazie all'imbarcazione messa a disposizione da
Cosimo LO NIGRO. A Palermo lo stupefacente veniva suddiviso tra noi ed i
calabresi. Parliamo di quintali di hashish. Quanto alle armi era tale Pietro
CARRA che mi risulta essere attualmente collaboratore di giustizia che ne curava
il trasporto con un camion. Le armi erano da guerra mini uzi ed altro. Preciso
che Giuseppe GRAVIANO mi disse di andarci piano con i Nirta in quanto noi
avevamo un rapporto privilegiato con un'altra famiglia calabrese contrapposta ai
Nirta che operava nel medesimo territorio. Venendo ora alla vicenda degli
attentati, successe che verso la fine del '93 io e Cosimo LO NIGRO che era il
"bombarolo" utilizzato da Cosa Nostra anche per precedenti fatti stragisti,
fummo incaricati da Giuseppe GRAVIANO di individuare nella città di Roma un
obiettivo che ci consentisse di uccidere molti carabinieri. Io e LO NIGRO
iniziammo subito a preparare l'esplosivo. Ricorremmo al materiale esplodente che
ci rifornirono i pescatori che reperivano con la pesca a strascico pescando
vecchi ordigni bellici mentre come detonatori ci rifornimmo di un salsicciotto
di gelatina e di un altro detonatore confezionato con un involucro di strisce
rosse. Di seguito trasportammo il materiale esplodente in Roma ed iniziammo i
sopralluoghi per individuare il luogo dove piazzare l'ordigno. Tenga presente
che Giuseppe GRAVIANO ci aveva detto che dovevamo fare alla svelta ma che prima
di muoverci dovevamo parlare con lui direttamente. La cosa era insolita perché
normalmente quando partivamo per fare gli attentati il GRAVIANO ci indicava
direttamente giorno, luogo ed ora in cui effettuare l'attentato. Dopo che
individuammo lo stadio olimpico quale luogo ideale per fare la strage vi fu
l'incontro nel Donay bar in via Veneto a Roma tra me e Giuseppe GRAVIANO. Da lì
ci muovemmo per andare in un villino a Torvaianica dove c'era il gruppo di
fuoco. Nel corso di questo incontro GRAVIANO Giuseppe mi disse che avevamo
ottenuto quello che volevamo, riferendosi all'accordo con dei nuovi referenti
politici da individuarsi in DELL'UTRI e BERLUSCONI, ma che bisognava dare
comunque il colpo di grazia allo Stato. Io cercai di convincere GRAVIANO, visto
che avevamo ottenuto quello che volevamo, di lasciar perdere con l'attentato ai
carabinieri e di procedere invece all'eliminazione di Totuccio CONTORNO che
casualmente io e Cosimo LO NIGRO avevamo individuato in Roma località Formello
riuscendo anche a capire quale era la sua abitazione. Feci leva sul fatto che il
CONTORNO era un nemico mortale sia mio che di Giuseppe GRAVIANO in quanto
ritenuto responsabile sia della morte di mio fratello che della morte del padre
di GRAVIANO Giuseppe. Giuseppe GRAVIANO fu irremovibile. Mi obiettò in primo
luogo che per ammazzare CONTORNO non si sarebbe potuto utilizzare l'esplosivo
che avevamo preparato per i Carabinieri in quanto del tutto analogo a quello
usato nei precedenti attentati sul continente sicchè si sarebbero immediatamente
individuati nei nemici di CONTORNO gli autori delle stragi sul continente, poi
mi disse, in secondo luogo, che bisognava agire per dare il colpo di grazia allo
Stato e che i calabresi già si erano mossi. Non mi specificò che genere di
attività contro lo Stato avessero fatto i calabresi. Lo compresi giorni dopo non
ricordo come dell'attentato in cui erano morti due carabinieri in Calabria.
Preciso che l'incontro con GRAVIANO Giuseppe di cui ho detto sopra si è svolto
con certezza nella settimana precedente il giorno 22 gennaio del 1994. Ciò è
certo in quanto il giorno dell'attentato programmato all'olimpico era proprio il
22 gennaio data che è stata anche individuata sulla base della circostanza che
la targa da collocare sull'auto bomba venne rubata, come di consueto (vedi
strage di Via d'Amelio) il giorno prima del programmato attentato e il giorno in
cui venne rubata la targa è stato individuato proprio nel giorno 21 gennaio
1994. A vostra domanda preciso che non mi fu specificato dal GRAVIANO quale
gruppo calabrese si fosse mosso, nè con chi lui avesse preso accordi. Io capii
che il duplice omicidio dei carabinieri era quello commesso dalla 'Ndrangheta
d'intesa con Cosa Nostra – episodio cui genericamente aveva fatto riferimento il
GRAVIANO con quella frase che ho detto sopra - in quanto proprio in quel periodo
anche noi eravamo impegnati a fare attentati contro i carabinieri. La conferma
di un complessivo accordo tra Cosa Nostra ed altre organizzazioni di stampo
mafioso nel periodo delle stragi ho potuto dedurlo in quanto, nel 1998, nel
carcere di Tolmezzo Filippo GRAVIANO ebbe a dirmi a seguito di quanto io stesso
gli avevo detto circa le rimostranza degli affiliati alla 'Ndrangheta ed alla
Camorra sulla durezza del 41 bis da imputarsi alla strategia stragista di Cosa
Nostra. Filippo GRAVIANO mi disse che questi soggetti avevano ben poco che
lamentarsi e che potevano chiedere spiegazione di quello che era successo ai
loro "padri"...omissis. Dei rapporti con i calabresi potrebbe forse riferire
notizie utili Giovanni GAROFALO, mio uomo di fiducia, ed ora collaboratore di
giustizia; era lui che curava i rapporti con i NIRTA.
Si dà atto che viene consegnato, priva di legenda,
al collaboratore di giustizia, fascicolo fotografico composto da nr. 46 foto
confezionato dai C.C. della D.N.A. (album che viene allegato all'interrogatorio
) depositato in data 7.10.2013. Il collaboratore dopo aver visionato
attentamente l'album per maggiore speditezza indica le sole foto dei soggetti
che ha riconosciuto: riconosco la foto nr. 25 che rappresenta TEGANO Pasquale
che ho conosciuto ad Ascoli Piceno nel 2007-2008 prima della mia collaborazione.
L'Ufficio da atto che così è.
Adr: Il TEGANO, come mi sembra di aver già detto,
aveva un totale rispetto verso Mariano AGATE. Entrambi facevano insieme i
colloqui familiari circostanza significativa perché potevano così scambiarsi
notizie ed informazioni...omissis..."
La pur Spatuzza raccolta da questo Ufficio sul
punto specifico del tema degli attacchi in Calabria ai Carabinieri (...bisognava
agire per dare il colpo di grazia allo Stato e che i calabresi già si erano
mossi...") secondo elementari principi di logica, che tengano conto sia del
tenore letterale della frase che del contesto e del momento in cui la stessa
venne pronunciata da Graviano, postula l'esistenza di una intesa fra Cosa Nostra
ed i calabresi che avevano disposto, ordinato ed organizzato gli assalti ai
Carabinieri avvenuti fra il dicembre 1993 ed il febbraio 1994 nel reggino. Nel
momento in cui Graviano pronunciava la frase in questione, per un verso, il suo
gruppo aveva commesso in "continente", nei mesi precedenti, una serie di atti
criminali di cui era evidente la finalità terroristica tesa a fiaccare la
resistenza dello Stato e, per altro verso, il medesimo gruppo, stava per
commettere un ulteriore atto terroristico a Roma, dove ci sarebbe stato un
massacro di decine e decine di militari italiani appartenenti all'Arma, che non
avrebbe avuto pari nella storia repubblicana, tanto che, per trovare precedenti
analoghi, bisognava risalire all'ultimo conflitto mondiale. Dunque Graviano e i
suoi uomini – su mandato dei vertici di Cosa Nostra – in quel periodo non solo
si stavano muovendo, inequivocabilmente, in una direzione chiara, quella
dell'attacco frontale allo Stato, ma agivano nell'ambito di una strategia
(esclusivamente) terroristica, ancorchè di matrice mafiosa. In questo contesto
Graviano, per fare comprendere a Spatuzza (cioè a colui che più di ogni altro
aveva collaborato con lui, coordinando e svolgendo materialmente le attività
criminali connesse alla esecuzione delle stragi continentali) che non si poteva
più indugiare oltre e che si doveva procedere, celermente, alla esecuzione
dell'attentato allo Stadio Olimpico, faceva il (noto) riferimento alla
consumazione (appena avvenuta) degli omicidi dei Carabinieri commessi in
Calabria, atto che imponeva, per l'appunto, una rapida esecuzione dell'attentato
romano. Dunque, alla stregua del riferimento fatto da Graviano, gli omicidi dei
Carabinieri in Calabria erano un antecedente logico che fungeva da fattore di
accelerazione di un altro e più eclatante delitto (l'attentato contro decine di
carabinieri allo stadio olimpico) sicchè i due episodi (quello calabrese e
quello romano) risultavano, alla stregua di una lettura logica e
"contestualizzata" della frase del Graviano, programmati all'interno di una
strategia omogenea ed unitaria ( e, del resto, a contrario, se gli episodi
calabresi si fossero collocati in un contesto non omogeneo rispetto
all'attentato dell'Olimpico e rispetto a questo fossero stati eccentrici e,
quindi, estranei alla strategia terroristica in atto, il riferimento fatto dal
Graviano a Spatuzza sarebbe stato privo di senso). Ne segue, già in via logica,
che non appare neppure astrattamente ipotizzabile che tasselli di rilievo di
tale strategia, quali (alla stregua della esposta ricostruzione) furono gli
attentati calabresi - che, non a caso, erano sia perfettamente calibrati
cronologicamente con l'eclatante attentato programmato a Roma che omogenei a
questo quanto all'obbiettivo attinto o da attingere ( i Carabinieri) - fossero
stati concepiti senza un previo concerto con chi aveva organizzato il predetto
attentato romano e, cioè, con Giuseppe Graviano. Nel momento in cui Graviano
parlava a Spatuzza degli omicidi dei carabinieri in Calabria (notizia, peraltro,
che, di norma, sarebbe passata inosservata agli occhi di un mafioso di
Brancaccio) e cioè il giorno dopo la consumazione del duplice omicdio
Fava-Garofalo, nulla, concretamente, ancora si sapeva, da un punto di vista
investigativo in ordine alla loro effettiva natura, alle loro esatte modalità,
alla loro scaturigine, ai loro autori, ed in cui, addirittura, non solo, non era
stato ancora fatto dagli inquirenti il collegamento fra quel duplice omicidio
(di cui parlava il Graviano) ed il duplice tentato omicidio del 2.12.1993.
Graviano, invece, nonostante questa assenza d'informazioni anche in capo agli
inquirenti, mostrava di conoscere benissimo il contesto in cui era avvenuto il
duplice omicidio, chi fossero gli autori (gli amici calabresi) e soprattutto che
si trattava non di un "normale" anche se tragico, conflitto a fuoco fra forze
dell'ordine e malviventi ma di una azione eversiva/terroristica contro i
Carabinieri, omogenea a quella in programmazione a Roma. E solo chi (come
evidentemente il Graviano) era stato in diretto contatto con gli organizzatori
di quell'agguato, poteva immediatamente, il giorno dopo i fatti, e senza indugi,
collocare tale vicenda in un contesto terroristico/eversivo, che, peraltro, solo
oggi appare palese. Del resto, anche esaminando gli episodi calabresi e quello
dello Stadio Olimpico, in modo asettico, senza tenere conto cioè delle
propalazione di Spatuzza, non può non essere rilevata una loro perfetta e non
casuale coerenza all'interno di un disegno criminale che, nella sua ferocia, era
chiaro e lineare. E ciò si rileva già sul piano dell'uso della violenza. Che,
simmetricamente ma in modo progressivamente più incisivo e grave, doveva colpire
l'Arma dei Carabinieri. Prima in Calabria e, poi, al cuore, a Roma, dove ci
sarebbe stato un vero e proprio massacro di militari italiani.
C'era una volta a Enna: così nacque la
strategia stragista di Cosa nostra e 'ndrangheta,
scrive Claudio Cordova Mercoledì, 26 Luglio 2017, su "Il Dispaccio". Elemento
di conferma sul diverso ma rilevantissimo versante della genesi della stagione
stragista, proveniva dalle convergenti propalazioni di collaboratori catanesi
che pure avevano riferito delle riunioni di Enna come quelle in cui, Cosa
Nostra, deliberò la stagione stragista del '92-'93 nel contesto di una strategia
"politico-eversiva". Come indicato da Leonardo Messina, Riina ed i suoi uomini
soggiornarono per un periodo piuttosto lungo ad Enna, a cavallo fra la metà del
1991 e gli inizi del 1992.
Importanti le dichiarazioni di Filippo Malvagna,
nipote del noto Giuseppe Pulvirenti detto "'u malpassotu" che
nell'interrogatorio del 9 maggio 1994, confermava la riunione "strategica" di
Enna della fine del 1991, di cui aveva riferito Leonardo Messina: "...Girolamo
Rannesi mi riferì della disponibilità offerta da Santo Mazzei a partecipare ad
attentati da eseguire in Toscana e a Torino. Questi attentati rientravano in un
grande programma di "guerra allo Stato" che cosa nostra per volontà di Totò
Riina stava ponendo in essere...
A.D.R: Come ho già dichiarato io ero bene a
conoscenza dell'esistenza di una strategia di Cosa Nostra volta a colpire lo
Stato sia in Sicilia che fuori dall'isola. Infatti, ritengo nei primi mesi del
1992, di aver saputo da Giuseppe Pulvirenti che qualche tempo prima e ritengo
pertanto verso la fine del 1991 si era svolta in provincia di Enna, in una
località che non mi venne indicata, una riunione voluta da Salvatore Riina alla
quale avevano partecipato rappresentanti ad alto livello di Cosa Nostra
provenienti da varie zone della Sicilia. Per Catania vi aveva partecipato
Benedetto Santapaola che aveva poi riferito ogni particolare dell'incontro al
Pulvirenti. Il Pulvirenti non mi raccontò chi fossero gli altri partecipanti
alla riunione alla quale comunque era presente Salvatore Riina in persona.
Ricordo che mi spiegò che la provincia di Enna veniva scelta di frequente per
questi incontri perché era una zona non molto presidiata dalle forze
dell'ordine. Ciò su cui il Pulvirenti fu più preciso riguardò l'oggetto della
riunione. Il Riina aveva fatto presente che la pressione dello Stato contro Cosa
Nostra si era fatta più rilevante e che comunque vi erano dei precisi segnali
del fatto che alcune tradizionali alleanze con i pezzi dello Stato non
funzionavano più. In pratica erano "saltati" i referenti politici di Cosa Nostra
i quali, per qualche motivo, avevano lasciato l'organizzazione senza le sue
tradizionali coperture...
A.D.R: Quanto alle ragioni dell'attacco allo Stato
voluto da Riina e su cui si erano trovati pienamente d'accordo Santapaola e gli
altri partecipanti alla riunione in provincia di Enna, il Malpassotu mi riferì
solo una frase che sarebbe stata pronunciata da Riina: "Si fa la guerra per poi
fare la pace". Successivamente ebbi modo di discutere ancora con il Pulvirenti
riguardo alle finalità di questa strategia di Cosa Nostra. Secondo il
Malpassotu, ora che molti accordi con il potere politico erano venuti meno
bisognava fare pressione sulle Stato per altre vie sia allo scopo di indurre gli
apparati dello Stato anche a delle trattative con la mafia sia, quanto meno, per
allentare la pressione degli organi dello Stato su Cosa Nostra e sulla
Sicilia...omissis...
Tali dichiarazioni venivano confermate e
dettagliate nel corso di un successivo interrogatorio svolto nel 2015.
"A.D.R: Sono in protezione dal marzo del 1994. Ho
iniziato a collaborare più esattamente in data 11.3.94. Quando ho iniziato a
collaborare ero detenuto presso il carcere Bicocca di Catania. Ero stato
arrestato il 25.3.1993. In particolare da quel giorno sono stato detenuto prima
a Rebibbia, poi a Catanzaro e infine a Catania. Fino al momento della mia
collaborazione ho fatto parte di Cosa Nostra catanese ed in particolare della
famiglia Santapaola/Pulvirenti. Io ero il nipote del noto Pulvirenti Giuseppe
detto il malpassotu.
A.D.R: Girolamo Rannesi, era un uomo d'onore di
Cosa Nostra catanese gruppo Pulvirenti, ed era stato "combinato" insieme a Santo
Mazzei detto "O'Caccagnusu". La cerimonia in questione si svolse a Catania alla
presenza dei corleonesi ed in particolare alla presenza di Nino Gioè di
Altofonte e di Leoluca Bagarella. Ovviamente erano presenti anche gli uomini
d'onore di Catania e fra questi in primo luogo Nitto Santapaola. Era presente
anche un uomo d'onore di Trapani tale Giovanni Bastone, quest'ultimo molto amico
di Mazzei. Tutto ciò mi venne raccontato dal Rannesi, che è colui che nella
primavera del 1992 mi raccontò dei propositi stragisti di Santo Mazzei da
attuarsi in Toscana e a Torino attraverso una serie di attentati. Mazzei vantava
una serie di appoggi in Toscana e a Torino e per questo si era offerto ai
corleonesi per compiere tali attentati.
A.D.R: La confidenza sulla disponibilità di Mazzei
a fare attentati in Toscana e a Torino il Rannesi me la fece quando era già uomo
d'onore.
A.D.R: Quando si tenne la riunione di Enna nella
seconda metà del 1991/ fine 1991, di cui ho ampiamente riferito in altri
verbali, la sentenza della Cassazione sul maxi-processo non era stata ancora
emessa. Ricordo tuttavia che già si sapeva che il Maxi sarebbe andato male.
Infatti ricordo che proprio Nitto e Salvatore
Santapaola ed Aldo Ercolano, non so sulla base di quali informazioni, dicevano
in mia presenza che quel processo sarebbe andato male per Cosa Nostra. Più
esattamente dicevano che non erano riusciti ad "aggiustarlo".
A.D.R: Nulla posso dire delle cd liste autonomiste
ovvero delle Leghe Meridionali che all'inizio degli anni 90' si presentavano
alle elezioni. Neppure ovviamente sono in grado di riferire sui rapporti
eventualmente esistenti fra tali formazioni politiche e Cosa Nostra. Posso dire
che poche settimane prima che io iniziassi a collaborare e comunque prima che a
livello mediatico si sapesse con certezza della cd "discesa in campo" di
Berlusconi – in ogni caso fra il Gennaio ed il Febbraio del 1994 – quando ero
detenuto alla Bicocca, tale Marcello D'Agata che era "consigliere familiare" dei
Santapaola, mi disse, allorchè io gli rappresentai che nonostante tutto quello
che avevamo fatto ( mi riferivo implicitamente alla strategia stragista di Cosa
Nostra) eravamo nei "guai" a livello giudiziario, lui mi rispose di stare
tranquillo perché gli amici palermitani ci avevano fatto sapere che tutto si
sarebbe risolto con l'avvento di una nuova formazione politica guidata da Silvio
Berlusconi. Mi invitò a fare sapere a tutti quelli che potevo raggiungere di
votare per Berlusconi poiché il suo partito avrebbe risolto i nostri guai.
Sempre in quel periodo alla Bicocca le parole del D'Agata mi furono confermate
da Gaetano Asaro - che pur non essendo uomo d'onore era molto addentro al nostro
gruppo tanto che era colui che si era occupato di garantire la latitanza di mio
zio Malpassotu. Il Gaetano Asaro che veniva dalla libertà ed aveva notizie
"fresche" mi confermò che bisognava appoggiare il nuovo partito che Berlusconi
stava creando. Disse. "Berlusconi è la nostra salvezza". Avrebbe abolito il
carcere duro e la legge sui pentiti.
A.D.R: Confermo integralmente quanto ebbi a dire
nel verbale del 9.5.1994 di cui ricevo lettura...omissis.
A.D.R: Preciso che il vero episodio che aveva
indotto i corleonesi e quindi il Riina a ritenere che erano venuti a mancare i
nostri referenti politici e bisognava fare la guerra alla stato così come ho
sopra detto, era il fatto che non eravamo riusciti o meglio che non riuscivamo
ad aggiustare il Maxi-processo in Cassazione. Faccio presente che fino
all'estate del 1991 Pulvirenti Malpassotu stesso mi diceva che il Maxi sarebbe
andato bene. Nell'autunno si acquisì la consapevolezza contraria. Come sempre mi
diceva mio zio il Malpassotu. Questo fu determinante...omissis.
A.D.R: Con riferimento ai rapporti che all'epoca,
esistevano fra organizzazioni criminali e massoneria, posso dirvi solo un fatto
preciso e netto: nella primavera del 1992, prima delle stragi, Aldo Ercolano in
persona, mi convocò per darmi un incarico. Mi disse che bisognava convincere i
proprieta000ri di una certa villa dalle parti di Taormina – villa che mi sembra
di avere anche indicato quando feci i primi sopralluoghi investigativi - a
cederla o in affitto o in vendita. Mi spiegò che questi proprietari erano
riottosi e bisognava convincerli. Sempre l'Ercolano mi spiegò che questa villa
doveva diventare la sede di una sorta di associazione – una specie di Rotary o
di Massoneria – che doveva comprendere sia uomini insospettabili che uomini di
Cosa Nostra. Lo scopo di questa associazione era quello di fare affari insieme e
soprattutto di procurare sempre nuovi affari a Cosa Nostra. Mi disse che
l'elemento di spicco di questa associazione era il Cattafi di Barcellona Pozzo
di Gotto. A detta dell'Ercolano questo Cattafi era un uomo d'onore molto vicino
a Bagarella. Io accettai l'incarico ed individuai anche la villa. Non avevo
ancora avvicinato i proprietari che, in seguito, l'Ercolano Aldo quando io gli
dissi che ero in difficoltà a muovermi poiché avevano arrestato il mio
inseparabile amico Salvatore Grazioso mi disse che non serviva più quella villa
perchè disse "avevano risolto il problema" Ciò avvenne sempre in epoca
precedente alle stragi siciliane del 92. In seguito seppi da Aldo Ercolano che,
sempre in zona di Taormina, e poi altrove, dalle parti di Barcellona Pozzo di
Gotto, si erano svolti degli incontri di questa associazione del Cattafi. Non mi
disse cosa si era detto o concluso in queste riunioni. Certo è che a dire
dell'Ercolano queste riunioni riservate oltre a uomini di Cosa Nostra vedevano
protagonisti imprenditori, politici e uomini delle istituzioni..."
Malvagna precisava anche che Cosa Nostra catanese
aveva posto in essere, nel quadro della stessa strategia, atti intimidatori nei
confronti del sindaco pro-tempore di Misterbianco Antonio Di Guardo, del
giornalista Claudio Fava, e perfino un attentato avente come obiettivo il
Palazzo di Giustizia di Catania. Né può essere sottovalutato un ulteriore
rilevante profilo delle dichiarazioni rese dal Malvagna a questo Ufficio : il
riferimento ai rapporti fra Cosa Nostra e Massoneria – ampiamente evidenziati in
modo convergente dal Pennino e dal Gran Maestro Di Bernardo – e soprattutto il
riferimento al ruolo chiave che in tale contesto aveva Rosario Cattafi, legato
ad Ordine Nuovo, che – come pure risulta dagli atti dell'indagine "sistemi
criminali" – anche il collaboratore di Giustizia Maurizio Avola indicava come
soggetto "esterno", suggeritore delle strategie di Cosa Nostra. Anche nel caso
di Maurizio Avola, la Dda di Reggio Calabria, il 14.5.2015, provvedeva ad una
nuova escussione del collaboratore, nella corso della quale, il predetto, oltre
a confermare pienamente quanto aveva a suo tempo riferito, e si è sopra
riportato, evidenziava due circostanze di rilievo: come, da un punto di vista
criminale, i rapporti fra 'Ndrangheta – e in particolare le famiglie De
Stefano-Piromalli – fossero intensi, continui ed abituali; il ruolo di Sante
Mazzei, uomo di Bagarella inserito nella famiglia di Catania di Cosa Nostra per
agevolare le strategie corleonesi sulle stragi. Mazzei fu protagonista del
fallito attentato del 1992 a Firenze nei giardini di Boboli:
"ADR: Sono collaboratore di Giustizia dal giorno
8.3.1994 venni arrestato nel marzo 1993. Nel 1997 mi è stato revocato il
programma per delle infrazioni comportamentali ma ho continuato a rendere
dichiarazioni alla AG.
ADR: Facevo parte di cosa nostra catanese ed in
particolare facevo capo a Nitto Santapaola.
ADR: Ho già reso dichiarazioni sui rapporti fra il
gruppo Santapaola e la 'ndrangheta sia alla AG catanese che a quella reggina. In
particolare ho riferito dei comuni traffici di stupefacenti che vennero
organizzati da Paolo De Stefano ed Ercolano Salvatore. In particolare io stesso
accompagnai Ercolano Salvatore a Reggio Calabria ad incontri con il predetto De
Stefano. Ciò avvenne fra il 1983 ed il 1984. Poi Nitto Santapaola mi disse che
non dovevo più occuparmi di queste faccende per cui mi sono astenuto. Il
problema era fra Nitto Santapaola e Salvatore Ercolano. In sostanza i rapporti
fra i Santapaola e i De Stefano continuavano, ma Nitto non voleva che tali
rapporti fossero portati vanti da Salvatore Ercolano. Rappresento che in quel
periodo il processo per la sparatoria avvenuta a Catania a via delle Olimpiadi
era stato trasferito a Reggio Calabria, non ricordo per quale ragione. Poiché
erano imputati Antonino Santapaola, Salvatore Pappalardo e Natale Di Raimondo
(oggi collaboratore, Nd.PM: le cui dichiarazioni saranno viste a breve), Aldo
Ercolano (rappresentante all'epoca della famiglia Santapaola) ebbe contatti con
Paolo De Stefano affinchè quest'ultimo cercasse di fare "aggiustare" il
processo. So di questa vicenda in quanto, di questo interessamento, me ne parlò
lo stesso Aldo Ercolano. Non so dire come sia andato a finire questo
interessamento. Certo è che nel 1986 i tre imputati vennero scarcerati. Posso
dire, inoltre, che alcuni calabresi, non so chi, chiesero, nel 1990, a Nitto
Santapaola il permesso di rapire Pippo Baudo. Nitto Santapaola negò il permesso.
Questo fatto mi venne riferito da Samperi Claudio oggi collaboratore.
ADR: Non sono in grado di riferire della esistenza
di eventuali rapporti fra Cosa Nostra e 'ndrangheta riguardanti la cd strategia
stragista.
ADR: Conosco per averne letto in un secondo
momento sui giornali (all'epoca io ero già detenuto) del fallito attentato alla
stadio olimpico organizzato dai palermitani, attentato che doveva colpire i
carabinieri. Nulla so, però, della contestuale serie di attacchi ai CC avvenuta
in Calabria nel dicembre 93 e Gennaio –febbraio del 1994. Come ho detto ero
detenuto.
ADR: Come ho spiegato nel corso di più verbali la
strategia della tensione che Cosa Nostra aveva pianificato contro lo Stato
risaliva al 1991 più esattamente al Settembre- Ottobre 1991. Ricordo che il
vice-rappresentante provinciale di Catania di Cosa Nostra, Eugenio Galea, dopo
un incontro con i corleonesi, venne a comunicarci a noi di Catania che era stata
stabilita, con i corleonesi, questa strategia di attacco generalizzato allo
Stato. Bisognava fare attentati a tralicci, traghetti, forze dell'ordine e tutto
ciò che era ricollegabile allo Stato. Prima di iniziare, però, ci disse che
bisognava aspettare il via. Insomma in quel momento bisognava solo prepararsi.
ADR: Dopo la morte di Paolo De Stefano, i
referenti calabresi di Cosa Nostra catanese divennero le famiglie De
Stefano-Piromalli. Preciso meglio: per un periodo successivo alla morte di Paolo
De Stefano i rapporti si raffreddarono. Evidentemente attesa la guerra in corso
non si sapeva con chi parlare, poi dai discorsi che facevano i miei capi, mi
riferisco agli Ercolano ed ai Santapaola, capivo che se c'era un problema da
risolvere in Calabria i referenti erano sia i De Stefano che i Piromalli. Non so
specificare chi dei De Stefano e chi dei Piromalli. Si faceva riferimento a
queste due famiglie. Ritengo che Natale Di Raimondo, collaboratore di giustizia,
possa conoscere meglio queste dinamiche in quanto conosceva bene la Calabria ove
era stato in soggiorno obbligato.
ADR: Santo Mazzei era molto vicino ai corleonesi
più esattamente era un uomo di fiducia di Bagarella. Al contempo era uno storico
rivale di Nitto Santapaola. Santo Mazzei era uno dei principali fautori della
strategia stragista ed era soggetto dalle forti simpatie di destra, meglio di
estrema destra. Santapaola era contrario alla strategia stragista. Per questo i
corleonesi volevano che Santapaola fosse sostituito da Mazzei al vertice di Cosa
Nostra catanese. Questa indicazione i corleonesi – e cioè che Nitto Santapaola
fosse "posato" – i corleonesi non la diedero espressamente ma la fecero capire
allorquando il Mazzei, nel 1991 venne "combinato" uomo d'onore direttamente da
Bagarella a Palermo (i due si erano conosciuti a Porto Azzurro), nonostante il
Mazzei fino a quel momento fosse stato uno dei "cursoti" dunque soggetto
estraneo a Cosa Nostra. Era una vera e propria investitura che poi, in seguito,
qualche tempo dopo, venne formalizzata allorquando il Mazzei venne presentato a
Catania dai corleonesi e precisamente da Bagarella in persona allo stesso Nitto
Santapaola e agli Ercolano. Ciò avvenne sempre fra la fine del 1991 e gli inizi
del 1992, in epoca successiva alla elaborazione della cd strategia stragista ma
prima di una rapina miliardaria che feci alla sede centrale della Banca di
Ragusa che feci ad Aprile/Maggio 1992 proprio con uomini di Mazzei. Rappresento,
poi, che nel 1992 su ordine di Bagarella collocò un ordigno a Firenze nei
giardini di Boboli dopo gli attentati di Palermo. Poi alla fine del 1992 il
Mazzei venne arrestato..."
Già nella seconda metà del 1991, i vertici di Cosa
Nostra, nel corso delle riunioni di Enna, avevano deliberato di attaccare lo
Stato per ragioni di strategia politica. I Corleonesi, si spesero presso le
famiglie e le organizzazioni alleate per concertare, avere il consenso ed
ottenere, da ciascuna, un apporto autonomo nella creazione di un clima di paura
e terrore nel paese. Tutto ciò rappresenta una importante premessa per
comprendere la coerenza, con tale modus operandi, dell'interazione fra Cosa
Nostra e Ndrangheta nella complessiva strategia terroristica e nella esecuzione
degli attacchi ai CC. La vicenda criminale veniva chiarita nella sua effettiva
causale dal collaboratore di Giustizia Natale Di Raimondo, sulle cui
dichiarazioni si sono fondate le condanne per il delitto in esame comminate dal
Gup di Catania e poi confermate. Escusso il 20.4.2015, il Di Raimondo, riferiva:
"...ADR: Sono collaboratore di Giustizia dal
28.10.1998. All'epoca ero detenuto al Carcere di Cosenza. Ero detenuto in questo
carcere dal Luglio 1993 (fatti salvi gli spostamenti per i processi che avevo a
Catania) in precedenza ero stato detenuto, da Marzo 1993 ad Augusta -Catania.
Prima di marzo 93 ero libero e lo ero dal 1988. Io ero appartenente ai
Santapaola dal 1980 ma non ero "combinato". Nel 1987, invece, venni fatto uomo
d'onore insieme al mio carissimo amico Pappalardo Salvatore (ucciso in un
agguato nel 1999 a Catania).
ADR: Non è esatto che io sia stato in soggiorno
obbligato in Calabria. Lo è stato invece il mio amico Salavatore se non ricordo
male in un periodo che ruota intorno al 1988. Stava a Melito Porto Salvo. Entrò
in ottimi rapporti con gli Iamonte, che, peraltro, io stesso avevo conosciuto
nel carcere di Reggio Calabria nel 1985. In particolare conobbi Iamonte Natale
il vecchio, Vincenzo Iamonte, il genero di Natale Iamonte di cui non ricordo il
cognome ma solo il nome, Pietro. Conobbi anche in quel contesto Pasquale
Condello, Totò Polimeni, Pasquale Tegano, Orazio De Stefano il Libri uccisi in
carcere, mi pare a nome Pasquale, tale Labbate mi sembra Pietro, come voi mi
chiedete, Paolo e Mico Serraino. Io godevo di una buona reputazione criminale,
in quanto ero imputato di una grave fatto di sangue, vale a dire la strage di
via delle Olimpiadi. Per questa ragione i suddetti esponenti della 'ndrangheta
mi diedero subito fiducia e credito, anche perché sapevano che io appartenevo ai
Santapaola che mi dissero erano loro alleati ed amici, tanto da fare insieme il
traffico di stupefacenti. Protagonisti di questi accordi in materia di
stupefacenti erano i Ferrera – cugini dei Santapaola – da un lato e gli Iamonte
ed i De Stefano dall'altra. Fu Natale Iamonte che, in carcere, mi raccontò
questi affari di droga, dicendo che era grato ai catanesi che in questo ambito
gli avevano fatto fare parecchi soldi. Preciso che durante la guerra di mafia
seguita all'omicidio di paolo De Stefano, ovviamente non si potevano fare affari
come prima e comunque mantenemmo una posizione neutrale. Tuttavia i rapporti
cordiali continuammo a tenerli con i De Stefano/Tegano. Io stesso nel 1990,
quando la guerra stava per finire, andai a Reggio Calabria per parlare con
Tegano Domenico "Mimmo" e Pasquale Tegano di una impresa catanese a nome Palmeri
che stava ristrutturando un palazzo pubblico a Reggio Calabria. Bisognava
accordarsi per la tangente da pagare. Ricordo che i due Tegano avevano dei
documenti da cui potevano ricostruire il margine di guadagno della ditta
catanese. Non venne fatto un rapporto di particolare favore a questa nostra
ditta. Spontaneamente: nel 1990/91 io Umberto Di Fazio e Salvatore Pappalardo
andammo ad eseguire un omicidio nell'ospedale di Melito Porto Salvo su richiesta
di Natale Iamonte. Fu Il Pappalardo che portò la richiesta dello Iamonte a Turi
Santapaola. Questi autorizzò il nostro intervento. Io e Pappalardo rimanemmo in
macchina sotto l'ospedale e Di Fazio, guidato da uno degli Iamonte, tale
Remingo, salì in Ospedale ed uccise con colpi di pistola silenziata, la vittima
che ricoverato in questo ospedale. Non sapevamo neanche all'epoca la casuale
dell'omicidio. Per noi era un favore agli Iamonte e basta.
ADR: Nulla so dell'omicidio del Giudice
Scopelliti.
ADR: Santo Mazzei era uomo di Bagarella. Lui venne
introdotto nel gruppo Santapaola da Bagarella. Io ero presente quando, dopo
Capaci, Brusca Giovanni, Gioè e Bagarella vennero a Catania e io Enzo Aiello ed
Eugenio galea li portammo da Nitto Santapaola in una tenuta di Aiello. Lì venne
chiesto da Bagarella a Nitto di fare il Mazzei uomo d'onore come da richiesta di
Totò Riina. Disse che il Mazzei a Rimini aveva già fatto due omicidi per "loro".
Questa conoscenza Mazzei-Bagarella era nata in carcere negli anni precedenti. Il
Mazzei prima non era di Cosa Nostra. In effetti Mazzei venne poi fatto uomo
d'onore. Abbiamo poi capito che i corleonesi volevano in seguito accantonare il
Santapaola e mettere al vertice della famiglia di Catania il Mazzei. Mazzei era
davvero agli ordini di Bagarella. Lo so perché ero io incaricato da Nitto
Santapaola di dargli assistenza e di controllarlo. Mazzei aveva fiducia in me e
per questo si confidava. Si vantò, infatti, con me di avere messo l'ordigno nel
giardino di Boboli a Firenze su richiesta dei Corleonesi. La cosa la fece
all'insaputa di Nitto Santapaola come lo stesso Santapaola mi disse quando io
gli raccontai il fatto. Nell'occasione del loro arrivo a Catania (dopo Capaci ma
prima dell'attentato di via D'Amelio) Bagarella e gli altri due chiesero a noi
catanesi ed, in particolare, a Nitto di aderire alla strategia che in seguito
sarebbe stata ulteriormente portata avanti da loro, contro lo Stato. Ci chiesero
di uccidere magistrati, esponenti delle forze dell'ordine, di fare attentati e
"fare rumore". Ciò dovevamo fare in provincia di Catania. Ricordo che Nitto e
Turi Santapaola, in loro presenza, dissero che avrebbero aderito a questa
strategia, poi quando i corleonesi se ne andarono, manifestarono ai noi
affiliati le loro perplessità. Tuttavia bisognava fare credere ai Corleonesi che
seguivamo quelle indicazioni e, per questo, nel Luglio 1992, venne ucciso,
subito dopo via D'Amelio, l'Ispettore di PS Lizio. Questo Ispettore venne
prescelto da noi e dai Santapaola, come vittima designata, essendo un
funzionario molto chiacchierato, rispetto al cui omicidio, ritenevamo che non vi
sarebbe stato il clamore che, invece, ci sarebbe stato se fosse stato ucciso un
poliziotto integerrimo ed impegnato sul fronte antimafia. Insomma, con questo
omicidio, volevamo, da una parte, fare credere ai Corleonesi che li seguivamo
nell'azione contro lo Stato, ma, nel contempo, non volevamo fare una azione
troppo eclatante che richiamasse l'attenzione dell'opinione pubblica e delle
forze dell'ordine su noi catanesi. Nitto Santapaola era rimasto "scottato" per
la vicenda dell'omicidio Dalla Chiesa e per l'omicidio Ferlito che determinò la
strage di tuta la scorta che portava il Ferlito dal carcere di Enna a quello di
Trapani o Favignana. In pratica il Santapoala era convinto che in entrambi i
casi – materialmente eseguiti dai corleonesi - ci fosse lo zampino dei servizi
deviati in quanto nel caso di Ferlito era evidente che vi era stata una soffiata
da qualcuno interno alle istituzioni che aveva avvisato del momento della
traduzione del Ferlito e nel caso di Dalla Chiesa era lo stesso in quanto
risultò in seguito che era stato utilizzato lo stesso mitragliatore usato per la
strage della circonvallazione in cui perì Ferlito e la sua scorta. Ripeto che
questa era la convinzione di Nitto Santapaola per queste due vicende che mi
esternò a suo tempo e che io mi limito a riportare alle SSVV come ho già fatto
rendendo dichiarazioni alla AG di Catania, Palermo, Firenze. Dunque per questi
precedenti che, ad avviso di Nitto Santapaola, deponevano per l'esistenza di
collegamenti fra corleonesi ed apparati o elementi deviati dello Stato, lo
stesso Nitto Santapaola diffidava dei Corleonesi. Ciò anche perché nei due
precedenti casi che ho indicato (Ferlito e Dalla Chiesa) gli attentati li
avevano fatti i Corleonesi e poi era stato implicato lui stesso che ne era
estraneo. Nitto, quindi, temeva che così, anche per le stragi che i Corleonesi
stavano eseguendo in Sicilia, poteva succedere e che cioè, noi, nostro malgrado,
fossimo implicati nelle stesse a livello giudiziario..."
Il pentito Scriva: “Il procuratore Tuccio
mi disse che Filippone era amico di un suo amico…”. E
il nome del boss della Piana scompare dal verbale…, scrive Claudio Cordova
mercoledì 26 luglio 2017 su "Il Dispaccio". Sarebbe un uomo molto influente
della 'ndrangheta della Piana di Gioia Tauro, l'elemento di raccordo tra la
cosca Piromalli e Cosa Nostra nella strategia stragista. Eppure per anni, Rocco
Santo Filippone (arrestato oggi nell'ambito dell'inchiesta "Ndrangheta
stragista") sarebbe rimasto immune alle indagini. Sono tanti i collaboratori di
giustizia che parlano, ma le dichiarazioni più pregnanti arrivano dal
collaboratore di giustizia Pino Scriva. Elementi utilissimi, peraltro, per
comprendere che i rapporti sono diretti e di particolare rilievo fiduciario,
vista la gestione di parte della latitanza del collaboratore di giustizia da
parte della persona sottoposta ad indagini:
"A.D.R: Ho iniziato a collaborare con la giustizia
nel 1983. Ho fatto parte di una famiglia di 'ndrangheta che porta il mio stesso
nome. Anzi, posso dire che sono stato il primo a spiegare all'A.G. cosa è la
'Ndrangheta. Preciso che dal 1968 al 1983 sono stato quasi sempre detenuto salvo
alcuni periodi in cui ero latitante in quanto ero riuscito ad evadere. Nel
periodo in cui ero detenuto e quindi tra il 1969 e il 1983 i rapporti tra noi
della 'Ndrangheta e quelli di Cosa Nostra erano cordiali, ma noi eravamo una
cosa e loro un'altra. Non posso dire cosa è successo dopo il 1983 poiché ho
interrotto qualsiasi rapporto con gli ambienti criminali di provenienza. Ho
conosciuto tutti i principali esponenti della 'Ndrangheta della zona Tirrenica e
anche Ionica. Ricordo BELLOCCO Umberto detto "asso di mazzo" cl.1937, Nino PESCE
"testuni", Mommo PIROMALLI, il vecchio, morto nel 1979 che era il Capo dei Capi
e la sua parola valeva in Calabria in Sicilia e altrove, Peppe PIROMALLI
cl.1921, Pino PIROMALLI "facciazza". Quelli della famiglia PESCE li conoscevo
praticamente tutti compreso Peppe il vecchio ed anche i MOLE'. Mi chiedete se ho
conosciuto persone di 'ndrangheta a Melicucco ed io vi faccio i nomi di tali
PRONESTI' e Rocco FILIPPONE. Mi chiedete di soffermarmi principalmente su
quest'ultimo ed io vi dico che per la prima volta entrai in contatto con Rocco
FILIPPONE quando mio cugino Rocco SCRIVA – 'ndranghetista responsabile
dell'omicidio di Domenico CUNZOLO – doveva appoggiarsi in un posto sicuro per
trascorrere la latitanza. Per tale ragione mio padre SCRIVA Francesco, mi disse
di portare mio cugino Rocco presso il FILIPPONE. Il FILIPPONE aveva la
disponibilità di una abitazione (non so se fosse sua o meno) nel Comune di Anoia
vicino a Melicucco. In questa casa trascorsero la latitanza non solo mio cugino
Rocco ma anche MAESANO Domenico "Mico" e Giuseppe ROTOLO di Rizziconi,
compaesano del primo. Costatai la presenza di questi ultimi proprio
accompagnando mio cugino in questa abitazione di FILIPPONE che a sua volta
abitava dalle parti di Melicucco in un'altra casa. Ciò avvenne nel 1965. Circa
dieci anni dopo, nel 1975, essendo io latitante a seguito di una evasione,
costatata la disponibilità del FILIPPONE in precedenza, trascorsi circa nove
mesi della mia latitanza appoggiandomi a Rocco FILIPPONE che mi "teneva" in una
Masseria di campagna poco prima di Melicucco. Passavamo molto tempo insieme nel
senso che lui mi accompagnava nei miei spostamenti. Tenga presente che all'epoca
vi era una guerra tra le famiglie FACCHINERI e RASO-ALBANESE, tutte di
Cittanova. Luigi FACCHINERI uccise il 19 marzo uno degli ALBANESE e scoppiò la
faida.
Le parole di Pino Scriva sono gravissime, non solo
circa l'appartenenza di Filippone alla 'ndrangheta, ma anche circa le presunte
coperture di cui avrebbe goduto e, in particolare, quelle dell'allora
procuratore di Palmi, Giuseppe Tuccio, oggi alla sbarra nel processo "Gotha",
celebrato contro la masso-ndrangheta: "Voglio precisare un particolare su Rocco
FILIPPONE: non è la prima volta che parlo di lui, feci il suo nome indicandolo
come 'ndranghetista all'allora Procuratore di Palmi, dott. Giuseppe TUCCIO.
Quando questi sentì questo nome, mi guardò e mi disse: "Rocco FILIPPONE è amico
di un mio amico di Reggio Calabria". Capii al volo che Rocco FILIPPONE poteva
dormire sonni tranquilli ed in effetti non solo non è mai stato processato negli
anni a seguire per reati associativi legati alla 'ndrangheta ma, non fu scritto
neanche il suo nome nel Verbale redatto dal dott. TUCCIO in occasione
dell'interrogatorio che io resi al predetto negli anni 1983-1984 presso la
Caserma dei Carabinieri di Tropea. Mi chiedete se dopo aver fatto il suo nome
rileggendo il verbale ho notato che lo stesso non era riportato, e vi dico che
così ricordo. Certo è che Rocco FILIPPONE non venne processato e il Procuratore
TUCCIO mi disse chiaramente che era un amico di un amico.
A.D.R: Nel corso della mia latitanza presso il
FILIPPONE ho visto con i miei occhi che lo stesso disponeva di armi, in
particolare sia armi lunghe che corte.
A.D.R: Il Procuratore TUCCIO non mi disse chi era
l'amico del FILIPPONE.
Stragi, l’attacco ai carabinieri e le
parole su Berlusconi: così Graviano divenne l’uomo cerniera tra ‘ndrangheta e
mafia. La procura di Reggio Calabria accusa il boss di
Brancaccio di essere il mandante di un duplice omicidio: quello dei carabinieri
Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, massacrati a colpi di mitraglietta
sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria. . Un assassinio che per anni era stato
considerato come un fatto di sangue isolato. E che invece è da ricondurre alla
strategia intrapresa da Cosa nostra proprio in quei primi giorni del 1994,
scrive Giuseppe Pipitone il 26 luglio 2017 su "Il Fatto Quotidiano". Non
solo il capomafia di Brancaccio, non soltanto il “coordinatore” delle “stragi
continentali” e il boss che si era “messo il Paese nelle mani” grazie ad accordi
mai dimostrati con Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi. Quello che emerge
dall’ultima inchiesta della procura di Reggio Calabria è un nuovo profilo
di Giuseppe Graviano. Una ruolo interpretato dal padrino di Brancaccio fino ad
oggi mai approfondito dalle indagini e dalle rivelazioni dei pentiti: quello di
“uomo cerniera” tra Cosa nostra e la ‘ndrangheta. È Graviano, infatti, l’uomo
che coinvolge i calabresi nella strategia stragista progettata da Cosa
nostra già nell’inverno del 1991 nel caso in cui la Cassazione avesse fatto
diventare definitive le condanne del Maxi processo. Cosa che avvenne
effettivamente in quella che è probabilmente la data che cambia la storia
d’Italia: il 30 gennaio del 1992 è un giovedì e a Roma la Suprema
cortestabilisce per la prima volta il carcere a vita per i boss mafiosi. Da quel
momento l’Italia viene stravolta da un’escalation a colpi di bombe e tritolo che
prima elimina i nemici storici di Cosa nostra, e poi si concentra su obiettivi
più simili ad un attacco terroristico: è quello che è stato ribattezzato
come l’attacco allo Stato di Cosa nostra. Al quale, però, hanno partecipato
anche i calabresi. Graviano, uomo cerniera tra due mafie – “La presente indagine
ha dimostrato come, non solo la pista terroristica fosse coltivabile, ma, anche,
fondata: pezzi importanti della ‘ndrangheta tirrenica — d’intesa con esponenti
reggini — diedero assicurazione ai corleonesi, rappresentati da Giuseppe
Graviano, di aderire alla strategia terroristica di Cosa Nostra, che, dopo le
stragi continentali, doveva prendere di mira gli appartenenti alle forze
dell’ordine e, in particolare, i Carabinieri. Tali componenti `ndraghetiste, a
loro volta, delegarono i Filippone a presiedere alla organizzazione degli
attacchi ai carabinieri in terra calabrese”, scrivono gli investigatori
coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo. La procura di Reggio
Calabria, infatti, accusa Graviano (e il calabrese Rocco Santo Filippone) di
essere il mandante di un duplice omicidio: quello dei carabinieri Antonino
Fava e Vincenzo Garofalo, massacrati a colpi di mitraglietta il 18 gennaio del
1994 sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, all’altezza dell’uscita di Scilla.
Un assassinio che per anni era stato considerato come un fatto di sangue
isolato. E che invece è da ricondurre alla strategia intrapresa da Graviano
proprio in quei primi giorni del 1994.
Spatuzza e l’accordo coi calabresi – L’indagine
degli investigatori calabresi, infatti, ha il merito di rileggere e mettere
ordine tra un numero indefinito di episodi, racconti di collaboratori di
giustizia, rivelazioni. Il risultato è un’unica ricostruzione dei fatti che – in
un modo o nell’altro – portarono alla nascita della Seconda Repubblica. Un
racconto ben sintetizzato dalle dichiarazioni che Gaspare Spatuzza ha messo a
verbale davanti agli inquirenti, confermando l’esistenza di un accordo tra Cosa
nostra e ‘ndrangheta. “La conferma di un complessivo accordo tra Cosa nostra ed
altre organizzazioni di stampo mafioso nel periodo delle stragi – dice – ho
potuto dedurlo in quanto, nel 1998, nel carcere di Tolmezzo, Filippo
Gravianoebbe a dirmi a seguito di quanto io stesso gli avevo detto circa le
rimostranza degli affiliati alla ‘ndrangheta e della camorra sulla durezza
del 41 bis da imputarsi alla strategia stragista di Cosa nostra. Filippo
Graviano mi disse che questi soggetti avevano ben poco che lamentarsi e che
potevano chiedere spiegazione di quello che era successo ai loro padri”. Come
dire: se il regime di carcere duro per detenuti mafiosi è stato inasprito dopo
le stragi la colpa è anche dei calabresi che a quelle stragi hanno partecipato.
Il processo aggiustato e l’anello di congiunzione
– Ma non solo. Perché Spatuzza è anche testimone diretto dei buoni rapporti tra
piovre calabresi e siciliane. E in un caso probabilmente beneficiario. “Altro
episodio che collega Cosa Nostra alla ‘ndrangheta – mette a verbale il pentito –
posso riferirlo da quello che ho appreso nel corso della mia detenzione
nell’anno 1998. Successe che nell’ambito del noto procedimento Golden Market i
Graviano (detenuti con lui a Tolmezzo all’epoca ndr) mi dissero che dovevo
ricusare il presidente della corte d’Assise di Palermo proprio all’ultima
udienza, cosa che io feci e che determinò lo stralcio della mia posizione, cui
seguì tempo dopo la mia condanna solo per l’associazione e qualche reato
satellite con l’assoluzione per gli omicidi, dall’altra mi dissero che due
franche di 500 milioni di lire l’una per il tramite di Agate Mariano erano state
messe a disposizione degli amici calabresi che avrebbero ‘aggiustato‘ un
processo che io dedussi essere uno dei filoni del Golden Market. In particolare
si trattava di aggiustare questo processo in Cassazione e Giuseppe Graviano mi
spiegò che gli amici calabresi, in particolare il riferimento era alla
cosca Molé-Piromalli si sarebbero mossi su richiesta di Mariano Agate esponente
di vertice di Cosa Nostra è certamente da considerarsi, l’anello di congiunzione
fra Cosa Nostra e la ‘ndrangheta”.
Il colpo di grazia e l’attacco ai carabinieri – Al
netto dei rapporti tra calabresi e siciliani, però, i racconti del pentito di
Brancaccio sono importanti soprattutto per un motivo: collegano tra loro i vari
attentati compiuti contro i carabinieri. “Nel corso di questo incontro Graviano
Giuseppe mi disse che avevamo ottenuto quello che volevamo, riferendosi
all’accordo con dei nuovi referenti politici da individuarsi
in Dell’Utri e Berlusconi, ma che bisognava dare comunque il colpo di grazia
allo Stato e i calabresi già si erano mossi. Non mi specificò che genere di
attività contro lo Stato avessero fatto i calabresi. Lo compresi giorni dopo non
ricordo come dell’attentato in cui erano morti due carabinieri in Calabria”, ha
raccontato il killer di Brancaccio riferendosi al famoso colloquio del bar
Doney, in via Veneto a Roma, il 21 gennaio del 1994. Quello in cui Graviano
“era molto felice” e “fa il nome di Berlusconi” del “nostro compaesano
Dell’Utri” sottolineando che “grazie a loro c’eravamo messi il Paese nelle mani.
E per Paese intendo l’Italia”. Prima, però, c’è da dare il colpo di grazia,
visto che “i calabresi si erano già mossi”. “Io capii che il duplice omicidio
dei carabinieri era quello commesso dalla ‘ndrangheta d’intesa con Cosa Nostra –
episodio cui genericamente aveva fatto riferimento il Graviano con quella frase
che ho detto sopra – in quanto proprio in quel periodo anche noi eravamo
impegnati a fare attentati contro i carabinieri“, dice l’uomo al quale era stato
affidato “il colpo di grazia”: un’autobomba piena di tondini di ferro piazzata
vicino all’autobus dei carabinieri che curavano l’ordine pubblico davanti
allo Stadio Olimpico di Roma. Un attentato terroristico mafioso” (copyright
dello stesso Spatuzza) che non verrà mai eseguito a causa del forfait del
telecomando del detonatore. Il colpo di grazia salta anche per un altro motivo:
il 27 gennaio vengono arrestati a sorpresa sia Giuseppe che Filippo Graviano. Il
giorno prima, invece, Berlusconi aveva ufficializzato la sua discesa in
campo con il famoso messaggio agli italiani. Da quel momento in poi, le stragi
finiscono. L’egemonia politica e Forza Italia – A questo proposito, i pm
annotano: “Ulteriore elemento di rilievo va considerato il riferimento, anche in
questo caso confermativo dei passaggi dichiarativi del collaboratore di
giustizia Gaspare Spatuzza, alla circostanza che, poco prima dell’arresto del
Graviano, le entità superiori che avevano inteso spingere mafie sul crinale
della strategia stragista, avessero, poi deciso di interromperla. Ciò si spiega
ove ci si ponga nella prospettiva dell’avvenuto raggiungimento dell’egemonia
politica che doveva essere acquista attraverso il sostegno al nuovo
partito Forza Italia”. Insomma: l’ipotesi è che gli attentati ai carabinieri
siano stati una sorta di ultimo atto di una strategia della tensione da
perseguire finché un nuovo ordine non fosse stato raggiunto. E proprio sul ruolo
di Forza Italia e dei rapporti tra i Graviano, Dell’Utri e Berlusconi, la
procura di Reggio Calabria ha utilizzato per la sua inchiesta anche le varie
intercettazioni ambientali captate dai colleghi di Palermo durante l’ora d’aria
che il padrino di Brancaccio ha trascorso con il codetenuto Umberto Adinolfi.
Le intercettazioni di Graviano – Gli investigatori
reggini accreditano la genuinità delle dichiarazioni di Graviano, le considerano
di “assoluto interesse gravemente indiziario” e le inseriscono nella loro
ricostruzione, commentandole passo passo. “Berlusconi pigliò le distanze, fece
il traditore”, dice Graviano intercettato il 19 gennaio 2016. “Dato questo – si
legge nell’ordinanza – che conferma la convergenza, che si determinò nel 1994,
fra le mafie e Forza Italia e, quindi, il passaggio che queste fecero dal
progetto separatista a quello forzista; di rilievo vanno considerati anche i
passaggi della conversazione aventi ad oggetto il mancato rispetto degli accordi
fra Berlusconi e le mafie”. Tre giorni dopo, invece, il boss di Brancaccio
dice: “Nel 1993 ci furono le stragi e le cose migliorarono tutte di un colpo. Io
poi andai a Pianosa e non ti toccavano (si riferisce al fatto che prima — nel
1992/93 – venivano malmenati nelle carceri ndr). Nel 1994 lo stavano proprio
togliendo il 41 bis c’era la Maiolo...poi arrivò Bossi”. Conversazioni che per
gli inquirenti confermano “come l’accordo mafie/Forza Italia ruotasse intorno
alla eliminazione del 41 bis”. Il passaggio forse più interessante delle
intercettazioni di Graviano è, però, un altro. “Nel 1992 Berlusconi voleva già
scendere”, dice il boss. Per gli inquirenti “si tratta di passaggio di rilievo
in quanto dimostrativo dei rapporti consolidati fra Berlusconi e Graviano
(evidentemente tramite Dell’Utri); rilevante anche il fatto che verosimilmente
nel periodo immediatamente successivo e, comunque, in collegamento con la
volontà di Berlusconi di scendere in campo, questi chiese a Graviano una
cortesia; Berlusconi che aveva tutta la popolazione con lui, disse al Graviano
ci vorrebbe una bella cosa e questo avveniva quando mi incontravo con lui. Il
boss di Brancaccio, poi, dice anche altro. Dice, per esempio che poi loro “non
volevano più le stragi”. “L’apporto dichiarativo – annotano i pm reggini – non
consente di comprendere appieno se chi non voleva più le stragi (e che, quindi,
prima le voleva) fosse Berlusconi”. Un interrogativo non da poco.
Il fantasma dello "stalliere" di Arcore,
scrive il 27 luglio 2017 Enrico Bellavia su "La Repubblica". Per anni ci siamo
concentrati tutti sul fatto dimenticandone gli sviluppi. A cosa avrebbe portato
tutto il lavoro di Paolo Borsellino? Un suo fidato collaboratore che avrebbe
conosciuto l’infamia di un’accusa di mafia, il maresciallo, poi tenente Carmelo
Canale, ha rivelato che Borsellino avrebbe arrestato il procuratore Pietro
Giammanco se solo gliene avessero lasciato il tempo. Rivelò anche che furono
alcuni colleghi dell’ufficio a sconsigliare al procuratore capo di presenziare
alle esequie di Salvo Lima. Stando a Canale, Paolo Borsellino avrebbe voluto
farsi raccontare da Giammanco cosa sapeva dell’omicidio dell’europarlamentare.
Ora fermiamoci un attimo e riannodiamo i fili. Borsellino indaga sugli appalti,
a due cronisti francesi andati a intervistarlo, due giorni prima della strage di
Capaci, parla a sorpresa di Vittorio Mangano, lo sconosciuto stalliere di
Arcore. Il suo capo lo osteggia in ogni modo e, dopo la morte di Lima, il
procuratore aggiunto confida a un suo uomo di fiducia che vuole arrestare il suo
capo. Cosa aveva intravisto Borsellino tracciando un ideale filo che collegava
il mandamento mafioso di Porta Nuova, a Palermo nientemeno che ad Arcore? Perché
aveva chiesto a Canale di rintracciargli un vecchio rapporto sulla Duomo
Connection? Perché nel suo ragionamento con i giornalisti francesi sente la
necessità di far riferimento a una vicenda che riguarda molto da vicino due
fratelli palermitani che hanno fatto fortuna al Nord, Marcello e Alberto
Dell’Utri? L’ultima intervista di Borsellino, sepolta negli archivi della Rai,
che ebbe copia di una sintesi trasmessa con ritardo per il pubblico italiano,
nasconde proprio quelle domande. E se ne aggiungono altre di domande. Cosa era
Palermo nel 1992? Dove erano arrivati i “contadini” di Corleone? Di quali
appoggi godevano a Palazzo? Ecco se il tritolo di via D’Amelio non avesse
fermato Borsellino, dove sarebbe arrivato il magistrato? Davvero avrebbe
arrestato il procuratore capo Pietro Giammanco? Davvero le indagini su mafia e
appalti lo avrebbero portato fino ad Arcore? Che significato dare alla inusuale
telefonata a casa Borsellino fatta da Giammanco la mattina del 19 luglio del
1992? Che peso dare alle sue parole: Paolo hai la delega per Palermo, spero che
questo chiuda la partita? E che peso dare alla risposta di Borsellino: “Questo
riapre la partita, anziché chiuderla”. A cosa alludeva Borsellino, a quali
conclusioni era giunto? Perché era così impellente fermarlo quel giornoe e a
quell’ora e con quei mezzi a 57 giorni dalla strage di Capaci?
'Ndrangheta, Cosa Nostra, servizi segreti
e massoneria: dalle spinte autonomiste alla scommessa su Forza Italia,
scrive Claudio Cordova Mercoledì, 26 Luglio 2017 su "Il Dispaccio". L'indagine
"Ndrangheta stragista", oltre a ricostruire gli attentati ai carabinieri sul
suolo calabrese, ricostruisce le premesse criminali e politiche della stagione
stragista, ma anche idee e liste autonomiste e leghiste. Apporto rilevante al
costrutto accusatorio, proviene dalle dichiarazioni del collaboratore di
giustizia Tullio Cannella. A suo tempo particolarmente legato a uno dei grandi
capi di Cosa Nostra, il corleonese Leoluca Bagarella, cognato e massimo uomo di
fiducia di Salvatore Riina, di cui, Cannella, proprio durante il periodo
stragista, per un lungo periodo, garantì la latitanza. In primo luogo Cannella
sapeva, per averle vissute in prima persona, delle sinergie puramente criminali
fra i Graviano e la 'Ndrangheta. In secondo luogo Cannella (all'epoca
insospettabile imprenditore) fu uno degli animatori e presentatori, nel 1993/94,
di una movimento leghista meridionale (poi divenuto anche lista elettorale)
denominata "Sicilia Libera" che era la continuatrice di analogo movimento, che,
in Sicilia – fra il 1990 ed 1992 - e nel resto del paese era rappresentato dalla
"Lega Meridionale" ispirata, da Licio Gelli, movimento cui, pure, Cosa Nostra
aveva aderito in uno con le altre mafie. Del resto la presenza e l'influenza,
anche indiretta, sulle dinamiche criminali calabresi del Maestro Venerabile
Licio Gelli, veniva evocata da diverse fonti di prova: «la stanza dei bottoni
che comanda sulla 'ndrangheta militare, è quella di cui facevano parte l'Avv. DE
STEFANO, Paolo ROMEO e l'on. LIGATO, ucciso per indebolire proprio i DE STEFANO:
tale sistema è necessario anche al fine di controllare gli esponenti politici
compiacenti. Tanto l'Avv. Paolo ROMEO che l'Avv. Giorgio DE STEFANO[1] facevano
parte della P2 di Licio GELLI che spesso si recava a Reggio Calabria: ciò mi è
stato detto da Nino Lo GIUDICE e Peppe RELIQUATO». Quanto sopra veniva
dichiarato dal collaboratore Consolato Villani, nel contesto delle sue
propalazioni su Lodovico, che sarebbe stato «ucciso per indebolire proprio i DE
STEFANO» e che faceva parte della «stanza dei bottoni che comanda sulla
'ndrangheta militare» insieme «all'Avv. DE STEFANO» e «Paolo ROMEO. Elementi di
conferma all'appartenenza dei due legali (Romeo e De Stefano) alla «P2 di Licio
GELLI» o, comunque della loro contiguità alla stessa, si traevano dalle
dichiarazioni del collaboratore di giustizia Filippo Barreca, che, nel verbale
d'interrogatorio del 24.01.1995, riferiva sull'esistenza, sin dai «primi mesi
dell'anno'79», di «una loggia segreta a Reggio Calabria... a cui appartenevano
professionisti, rappresentanti delle istituzioni, politici e, come detto,
'ndranghetisti». Sempre il collaboratore Barreca, dichiarava che, «loggia
segreta» di «Reggio Calabria» era stata costituita inizialmente da «Franco
FREDA...nel contesto di quel più ampio progetto nazionale» al quale avevano
aderito «le più importanti personalita' cittadine» tra cui anche «Lodovigo
Ligato, l'onorevole Paolo ROMEO, l'avvocato Giorgio DE STEFANO... e taluni
componenti della loggia appartenevano anche alla P/2...la loggia, peraltro,
aveva stretti rapporti con la massoneria ufficiale». Continuando il
collaboratore chiariva che: «Le competenze della loggia, come detto, si
fondavano su una base eversiva. Ma, prevalentemente, la loggia mirava: ad
assicurarsi il controllo di tutte le principali attività economiche, compresi
gli appalti, della provincia di Reggio Calabria; il controllo delle Istituzioni
a cui capo venivano collocate persone di gradimento e facilmente avvicinabili;
l'aggiustamento di tutti i processi a carico di appartenenti alla struttura.
Tornando, ora, alle dinamiche politiche dell'epoca, risultava che Sicilia
Libera, operava in modo coordinato con analoghi movimenti leghisti meridionali
(Calabria Libera, ecc) che, come il movimento siciliano, erano sostenuti dalle
organizzazioni mafiose radicate nei rispettivi territori. Ed il momento più alto
di questa collaborazione interleghista benignamente accompagnata da Cosa Nostra
e 'Ndrangheta fu la riunione di Lamezia Terme. Tale progetto, peraltro, proprio
nei primi mesi del 1994, poco prima delle elezioni politiche che si svolsero
quell'anno, venne accantonato dalle mafie, che, oramai (come evidenziato non
solo da Gaspare Spatuzza ma da molti altri collaboratori quali lo stesso Tullio
Cannella, Angelo Siino, Giovanni Brusca, Maurizio Avola, Salvatore Cucuzza e
Giuseppe Ferro) ritenevano di avere trovato altri e più solidi accordi con la
nuova formazione politica guidata da Silvio Berlusconi (che in Sicilia, per
aspetti significativi, da un punto di vista organizzativo e personale aveva
elementi comuni con la vecchia "Sicilia Libera"). Dunque, sotto questo aspetto,
Cannella si rivelerà, non solo, fonte qualificatissima, ma, anche, depositario
di specifiche informazioni dimostrative degli stretti legami che pure esistevano
fra Cosa Nostra e 'Ndrangheta, sul versante del comune sostegno ai medesimi
soggetti politici. La strategia stragista postulava, una analisi, una
convinzione da parte di chi le aveva promosse ed organizzate. Che cioè le forze
politiche che governavano lo Stato non erano più affidabili. E se questa era
l'analisi, meglio, il presupposto delle azioni stragiste, sempre partendo dalla
ragionevole idea che chi le aveva progettate non si impegnasse, poi, su diverso
fronte per raggiungere scopi opposti, deve ritenersi che, sul versante politico,
gli stragisti ( o i futuri stragisti) non potessero appoggiare - facendogli
conseguire una vittoria elettorale - quegli stessi politici che, in definitiva,
stimavano inaffidabili, volevano mettere alle corde ed erano i destinatari
ultimi del messaggio stragista. Spatuzza ed altri collaboratori di giustizia
spiegheranno che, pochi mesi prima delle elezioni del 1994, i vertici di Cosa
Nostra cambiarono, quasi in corsa, cavallo, abbandonando il progetto autonomista
di Sicilia Libera, poiché ritennero di avere avuto sufficienti garanzie da un
nuovo soggetto politico (che, in effetti, poi, avrebbe vinto le elezioni
politiche) sicchè è a questo nuovo movimento, Forza Italia, che andò il loro
appoggio. Ma questo dato non sposta, ma, anzi, conferma, i termini della
questione che qui rileva, che cioè la strategia politico/elettorale di Cosa
Nostra fu complementare e pienamente coerente a quella stragista che tendeva a
mettere con le spalle al muro la vecchia classe politica. Ed è di straordinario
interesse ai fini della presente indagine, rilevare che, nello stesso periodo,
sul fronte calabrese e, quindi, della 'Ndrangheta (ma non solo) – rompendosi una
tradizione ultra quarantennale - vennero adottate scelte politico/elettorali – a
partire dall'appoggio alle leghe meridionali – in piena sintonia con quelle di
Cosa Nostra e, dunque, complementari e di sostegno alla strategia stragista, che
aveva la sua ragion d'essere nell'attacco alla vecchia classe politica. Insomma,
se risulta dimostrato che, dopo quarant'anni di sostegno ai vecchi partiti, Cosa
Nostra e 'Ndrangheta, compirono, d'improvviso, contemporaneamente ed
all'unisono, non solo la scelta di abbandonare i vecchi referenti ma, anche,
quella di dare sostegno ai medesimi nuovi soggetti, esclusa una involontaria e
potente telepatia fra i capi dei due sodalizi, risulta evidente l'esistenza di
una comune strategia di attacco e ribellione alla vecchia classe politica da
parte di Cosa Nostra e 'Ndrangheta, che, sul fronte più strettamente criminale,
aveva come sua logica prosecuzione l'attuazione della strategia terroristica.
Strategia che, in questo quadro di complessiva concertazione ed allineamento fra
le due organizzazioni criminali sulla posizione da prendere nei confronti dello
Stato e della vecchia classe politica, ben difficilmente, poteva essere portata
avanti in assoluta solitudine da Cosa Nostra. Queste le dichiarazioni rese da
Cannella il 17.10.2013: "...omissis.... ADR: circa i miei trascorsi criminali
posso dire che non ho mai fatto parte come uomo d'onore di Cosa Nostra. Ero
molto legato a Leoluca Bagarella sia per motivi di amicizia che per motivi di
interesse nel senso che lui per me, che ero un imprenditore, era un
"salvacondotto". Ho ospitato e dato appoggio a Leoluca Bagarella durante la sua
latitanza durata fino al luglio del 1995. Io venni arrestato un paio di
settimane dopo Bagarella. Iniziai a collaborare quasi subito, poche settimane
dopo il mio arresto. La mia attività era quella di imprenditore edile e
sviluppavo anche delle importanti iniziative in questo settore, fra le altre
ricordo la costruzione di circa trecento villette in zona Buonfornello vicino
Cefalù. Proprio nel corso di tale attività costruttiva, che ebbe inizio nel
1985, ebbi modo di entrare in contatto con Filippo, Giuseppe e Benedetto
GRAVIANO, anche loro di Brancaccio come me. Avevo fino a quel momento una
conoscenza superficiale dei Graviano anche se, devo dire, che furono loro a fare
da tramite fra me e Leoluca Bagarella, facendomelo così conoscere nel 1993. Con
riferimento alla vicenda dei villini a Cefalù, in sostanza i Graviano mi
estorsero circa due miliardi e mezzo delle vecchie lire. I rapporti tra me e i
Graviano potevano apparire all'esterno come di reciproca amicizia, in realtà io
ero una loro vittima. A sua domanda chiarisco che sono già stato condannato per
416 bis o per concorso esterno, non ricordo, nel processo a Palermo.
ADR: con riferimento alle mie attività in ambito
politico riferisco che negli anni 70 militavo nella Democrazia Cristiana ed in
tale contesto ebbi a conoscere il defunto Vito Ciancimino. In seguito, tra la
fine del 93 e l'inizio del 94, in ogni caso pochi mesi prima delle elezioni
politiche del 94 in cui si impose Forza Italia ed anche prima delle comunali che
a Palermo si tennero poco tempo prima delle Politiche di cui ho detto sopra, su
richiesta di Leoluca Bagarella, fui l'organizzatore del movimento politico
Sicilia Libera. Sottolineo che a Palermo fui io ad organizzare questo movimento
insieme a Bagarella. Nel periodo precedente alle elezioni di cui sopra, proprio
nella qualità di esponente di vertice di Sicilia Libera, partecipai alla
riunione di tutte le leghe autonomistiche italiane che si tenne a Lametia Terme.
Prima ancora di partecipare a tale riunione, o forse subito dopo, conobbi un
esponente di rilievo della Lega Nord che era parlamentare europeo o comunque
così mi fù presentato, si tratta di circostanza da verificare. Si trattava di
una signora di circa 40/50 anni che conobbi in una sala di un albergo di Palermo
in cui parlammo di questioni politiche e di possibili alleanze elettorali...Si
dà atto che alle ore 17.15 si allontana il dr. GIANNINI.... A sua domanda
preciso che questa leghista non sapeva che ero referente politico di Bagarella e
di Cosa Nostra. Chi invece alla fine scoprì che io rappresentavo gli interessi
di Cosa Nostra in ambito politico, fù il principe Orsini. Costui in un primo
momento, fu da me avvicinato per coinvolgerlo nel nostro movimento politico. Non
gli dissi nulla, naturalmente, dei miei collegamento con Cosa Nostra. Senonchè,
quando si approssimarono le elezioni politiche del 94, gli proposi di candidarsi
per noi nel collegio di Brancaccio-Ciaculli e zone limitrofe. A questo punto gli
dovetti spiegare che lì l'elezione poteva essere assicurata con l'appoggio degli
"amici" facendo chiaro riferimento Cosa Nostra. Il principe Orsini si
impressionò e si fece da parte dicendomi che non era più interessato.
ADR: venendo alla riunione di Lametia Terme cui io
stesso partecipai, preciso che la stessa si tenne in un luogo che adesso non
ricordo esattamente, forse era una grande sala di un albergo o un centro
congressi, non so essere più preciso. Alla stessa riunione parteciparono un po'
tutti gli esponenti delle leghe autonomiste. Ricordo ad esempio rappresentanti
di "Basilicata Libera", "Calabria Libera", della Lega Nord e di altri movimento
analoghi. Della Lega Nord era presente un certo Marchioni che all'epoca si
presentò come un componente della segreteria della Lega. All'esito della
riunione si decise che bisognava costituire a sud una confederazione di tutte
queste leghe meridionali, il cui nome non ricordo, mi si chiede se fosse "Lega
Mediterranea" ed io ricordo che era proprio questo il nome. Faccio presente,
anche, che a Lametia Terme erano presenti pure esponenti di "Sicilia Libera"
catanesi. In particolare per Sicilia Libera catanese era presente tale dr.
Platania che come ho già riferito in altri interrogatori era vicino a Cosa
Nostra catanese. In particolare Leoluca Bagarella, prima della riunione di
Lametia Terme, mi mise in contatto con un emissario catanese di Sicilia Libera,
di cui non ricordo il nome. Costui mi disse che a Catania il punto di
riferimento del movimento era certo dr. Platania, persona vicina ad un mafioso
di nome Ferlito.
ADR: mi viene chiesto se a seguito di questi fatti
o contestualmente agli stessi, ebbi rapporti con il defunto Vito Ciancimino.
Rispondo che effettivamente ebbi ad incontrare, ma in seguito, il Ciancimino.
Ciò avvenne nel corso della mia detenzione presso il carcere di Rebibbia tra
luglio e Agosto del 95. Io già collaboravo con la giustizia. Ricordo che un
giorno, quando le porte di legno delle celle erano aperte, rimanendo chiuse
quelle di ferro, nella cella proprio di fronte alla mia vidi Vito Ciancimino.
Ricordo che esclamai:" zu Vito!". Lui mi pregò di non chiamarlo così dicendomi
di chiamarlo sig. Ciancimino. Mi chiedete se, come risulta da miei pregressi
interrogatori ho parlato della questione delle leghe meridionali con il
Ciancimino e vi dico che adesso lo ricordo. Confermo che Ciancimino allorquando
io gli parlai di Sicilia Libera si mostrò al corrente di questo progetto
politico. Il Ciancimino mi disse che questa Sicilia Libera gli appariva una cosa
di poco conto, mentre il progetto autonomista più serio era quello ispirato da
Bernardo Provenzano, quello della Lega Meridionale nella quale dovevano
partecipare tutti i "nostri amici" meridionali tra cui gli amici della
'ndrangheta calabrese che erano molto influenti. Mi si rappresenta che in
precedenti interrogatori ho specificato cha a detta di Ciancimino la 'ndrangheta
calabrese era forte anche in virtù dei suoi rapporti con la massoneria ed i
servizi segreti ed io confermo pienamente questa circostanza che ora ricordo e
che all'epoca riferii immediatamente alla AG procedente avendo la memoria più
fresca. Devo precisare, peraltro, che il fatto che pure dietro Sicilia Libera e
comunque dietro questi progetti autonomisti ci fosse Bernardo Provenzano, io già
lo avevo intuito quando con Bagarella parlavamo di organizzare sul territorio, a
Palermo, Sicilia Libera. Bagarella, infatti, capitava che mi dicesse, quando
sorgeva un problema relativo alla organizzazione del movimento, che doveva,
prima, "parlare con un amico" e poi poteva decidere. Presumo che questo amico
dovesse essere proprio Provenzano anche perché all'epoca già era stato arrestato
Totò Riina e l'unico elemento di Cosa Nostra che potesse dare consigli o
disposizioni a Bagarella era Provenzano.
ADR: circa i rappresentanti della "Lega
Calabrese", ora mi viene in mente un nome: Di Donno o qualcosa del genere. Mi
chiedete se potrebbe essere tale DONNICI e io rispondo che potrebbe essere
questo il nome. Anzi penso proprio di si, mi ricordo che assai probabilmente
questo DI DONNO o meglio DONNICI, aveva una carica all'interno della Regione.
Non sono in grado di dire, però, se questo soggetto avesse contatti con la
criminalità organizzata calabrese, certo io non mi sono presentato a lui come
referente di Cosa Nostra.
DOMANDA: lei ha conosciuto il dr. Gioacchino
PENNINO?
RISPOSTA: lo conoscevo fin da quando ero ragazzo.
Era persona legata a Cosa Nostra ed alla massoneria come lui stesso mi disse.
Era storicamente della famiglia di Brancaccio fin dai tempi di Giuseppe DI
MAGGIO. In seguito naturalmente passò con i GRAVIANO. A sua domanda le dico che
conoscevo anche Sebastiano LOMBARDO detto "Iano", legato ai Graviano e persona
che si muoveva a suo tempo in ambienti politici democristiani quando la
DC.......... Si dà atto che arriva una telefonata e si sospende il verbale alle
ore 17.50....... Si riprende alle ore 17.55........ "governava" a Palermo.
.......
ADR: il progetto di Sicilia Libera, che era un pò
la continuazione dei precedenti progetti autonomisti delle leghe meridionali,
era coltivato da Cosa Nostra e voluto da Leoluca BAGARELLA poiché già da tempo
mi diceva che non si fidava più dei vecchi politici, diceva che non li
controllavamo più, per cui dovevamo avere dei nostri uomini che si candidavano
direttamente alle diverse cariche rappresentative fossero esse in comuni, in
regioni o nel parlamento nazionale. Mi chiedete se fra questa strategia politica
autonomistica, se non addirittura separatista (perché era questo il punto di
arrivo, se le cose fossero andate bene) e quella delle stragi del 92-93 vi fosse
un collegamento. Mi si rappresenta che in pregressi interrogatori ho riferito di
tale collegamento e che in particolare la costituzione dei movimenti leghisti al
sud era legata anche alla strategia stragista nel senso che entrambe servivano a
creare le condizioni politiche per mettere in ginocchio lo stato unitario ed
arrivare in tempi rapidi ad una sostanziale autonomia del sud rispetto al nord e
che l'inaffidabilità dei politici dell'epoca era anche testimoniata dal fatto
che Martelli, una volta vicino a Cosa Nostra, era diventato politico nelle mani
di Giovanni Falcone. Dichiaro in proposito che non sono in grado di precisare le
esatte fonti da cui poteva dedursi questo progetto complessivo, probabilmente,
ho messo insieme una serie di indicazioni che adesso, essendo passati venti
anni, non sono in grado di ricordare. Certamente confermo di averle riferite, ma
adesso non ricordo bene. Con riferimento, quindi, a queste vicende relative alle
stragi, a FALCONE e a MARTELLI, preciso che si trattava di informazioni che ho
riferito all'AG di Palermo sulla base di ciò che ascoltavo in ambienti mafiosi
senza che ne possa in alcun modo confermare la veridicità, in particolare il
riferimento a Martelli che feci a quel tempo derivava da semplici sentito dire.
Dunque si tratta di fatti tutti da verificare Tutte le altre circostanze di cui
ho detto sopra, che mi hanno riferito Bagarella o Ciancimino, o che ho vissuto
personalmente le confermo e posso attestarne la verità con serenità.
ADR: agli inizi del 1994, o alla fine del 93,
ricordo che era il periodo durante il quale stavo organizzando Sicilia Libera
anche in vista della raccolta delle firme ( mi sembra per le elezioni comunali)
per presentare le liste (non ricordo esattamente quando iniziai tale raccolta),
Leoluca BAGARELLA mi disse che seppure dovevo continuare in questa attività
politica ed organizzativa, tuttavia, nell'immediato, Cosa Nostra riteneva fosse
cosa più proficua appoggiare, alle elezioni politiche, un nuovo partito che
sarebbe nato a livello nazionale, più esattamente mi disse che in questo nuovo
partito sarebbero stati candidati degli "amici" (ovvio che si riferisse ad amici
di lui stesso e di Cosa Nostra) che l'organizzazione avrebbe appoggiato al
momento delle elezioni. Mi sembra, che, in quel momento, non mi disse il nome di
questa nuova formazione politica, più probabilmente, in seguito, mi disse che si
trattava di Forza Italia. Mi spiegò che il progetto di Sicilia Libera doveva
considerarsi un progetto a lunga scadenza e che l'importante era aver costituito
il partito e presentarlo alle elezioni. In effetti diceva che poteva sempre
tornare utile avere un movimento politico su cui contare al cento per cento per
evitare di trovarsi un domani con politici inaffidabili come era successo in
quel periodo.
ADR: prendo atto che nel corso di pregresso
verbale ho riferito di un incontro avvenuto con Filippo Graviano nel corso del
quale mi fece capire, rivolgendosi a me come organizzatore di Sicilia Libera,
che potevo lasciar perdere perchè c'era lui che ci pensava ad avere rapporti ad
alto livello con i politici e che, grazie a tali rapporti si sarebbe risolto il
problema dei pentiti. Confermo le precedenti dichiarazioni rese quando avevo la
memoria più fresca. Preciso che effettivamente incontravo Filippo Graviano,
anche se in quel periodo era latitante, perché i Graviano continuavano a
chiedermi i soldi. Ora che ricordo bene, però, mi sono venute in mente le
circostanze di cui sopra in cui Graviano mi riferì dei suoi rapporti politici e
dell'inutilità dei miei sforzi organizzativi per Sicilia Libera. L'incontro non
avvenne perché dovevo dargli dei soldi, ma perchè Bagarella mi disse che per il
tramite di Graviano potevo ottenere uno sconto all' hotel San Paolo Palace di
via Messina Marina di Palermo dove avevo svolto un convegno di Sicilia Libera.
Incontrai il Graviano a Palermo, non ricordo esattamente dove, per chiedergli
questo intervento ed avere, così, lo sconto e lui con tono di consiglio mi
disse. "ma chi te lo fa fare......" e via di seguito, facendo poi il discorso
relativo ai suoi rapporti politici ad alto livello.
Si dà atto che viene mostrato sul pc, per
consentirne una migliore visione, priva di legenda, al collaboratore di
giustizia, fascicolo fotografico composto da nr. 46 foto confezionato dai C.C.
della D.N.A. (album che viene allegato all'interrogatorio) depositato in data
7.10.2013. Il collaboratore dopo aver visionato attentamente l'album per
maggiore speditezza indica le sole foto dei soggetti che ha riconosciuto: non
riconosco alcuna delle persone effigiate. L'album viene allegato al presente
verbale.
ADR: oltre a quanto mi riferì Ciancimino in modo
piuttosto generico, null'altro posso precisare sui rapporti tra 'ndrangheta e
massoneria.
ADR: nulla so dirle su eventuali rapporti tra tali
movimenti autonomisti e leghisti meridionali e Stefano DELLE CHIAIE, anzi, non
ho mai sentito parlare di Stefano DELLE CHIAIE...omissis".
Significativa, conferma alle propalazioni del
Cannella - conferma che, fra l'altro, aveva, anch'essa il pregio di evidenziare,
in modo convergente, le sinergie e la comunione d'interessi che, all'epoca,
anche sul piano politico, erano riscontrabili fra Cosa Nostra e 'Ndrangheta –
proveniva dal collaboratore di Giustizia Gioacchino Pennino, alto borghese
palermitano, medico, che era stato, ad un tempo, legato alla massoneria e uomo
d'onore della famiglia di Brancaccio. Famiglia, di cui, come noto, erano capi
indiscussi Filippo e Giuseppe Graviano. Pennino iniziava a collaborare con la
Giustizia in data 20.8.1994 Ritenuto pienamente attendibile e rilevante, specie
nel descrivere i rapporti fra Cosa Nostra e i poteri esterni che alla stessa si
collegavano, veniva sottoposto a programma di protezione in data 19.10.1994.
Viene ascoltato dalla Dda di Reggio Calabria il 25.2.2014:
"...ADR: Ho personalmente conosciuto Rocco e
Domenico "Mimmo" Musolino. Si tratta di una conoscenza che è maturata nel corso
degli anni 80'. Devo rappresentare che sia io che mio fratello buonanima Aldo –
deceduto pochi giorni or sono – eravamo appassionati di tiro al volo. Per tale
ragione frequentavamo, fra gli altri, anche lo "stand" di Gambarie, frazione di
S.Stefano d'Aspromonte. Questo stand – cioè il campo di tiro – era gestito da
Mimmo Musolino, fratello più giovane di Rocco. Tramite Mimmo conoscemmo Rocco.
Rocco Musolino era persona che era circondata da una vera e propria venerazione,
un rispetto enorme, non solo da parte del fratello e dei familiari (era
sicuramente persona che ricopriva il ruolo di vero e proprio capofamiglia) ma
anche da parte di tutti coloro che frequentavano Gambarie. Da questi
comportamenti capivo, comprendevo, che Rocco Musolino era un uomo d'onore della
'ndrangheta calabrese. Ho poi avuto modo di frequentare Rocco Musolino in
quanto, ad esempio, insieme al predetto, al fratello, al mio amico defunto
Antonino Schifaudo, ex funzionario regionale a Palermo nonché massone, a mio
fratello ed altri facemmo anche, sul finire degli anni 80' un viaggio negli Usa,
andando a NY e Las Vegas. Si trattava di un viaggio di piacere.
ADR: Non sono a conoscenza - anche se non posso
escluderlo - del fatto che il Musolino Rocco sia massone. Ritengo che sia
possibile che certo Pizza, che mi sembra che in qualche modo collaborò con la
AG, essendo originario di S.Stefano d'Aspromonete possa riferire tali
particolari sul Musolino Rocco. Tuttavia, come ebbi già a riferire a suo tempo,
mi risulta, per averlo appreso da tale Martorano (si tratta di un imprenditore
calabrese), che il Musolino Rocco unitamente all'On Misasi, uomo politico
corpulento calabrese, il dott Donnici, pure lui politico calabrese, ed altri
ancora, faceva parte di un comitato d'affari che era pienamente attivo in
Calabria e che ricomprendeva, come mi pare volesse fare intendere il Martorano,
'ndrangheta, massoneria e politica.
ADR: Martorano o Marturano lo conobbi in quanto
frequentatore del tiro al volo di Gambarie. In effetti il Martorano intendeva
chiedermi una raccomandazione presso un mio conoscente, tale Alfredo Li Vecchi,
professore universitario di estrazione DC. Costui era componente del CdA delle
Ferrovie dello Stato. In pratica Martorano voleva ottenere degli appalti dalle
FFSS. Io per la verità non me ne interessai in quanto sapevo che il Li Vecchi
era uomo molto serio ed incorruttibile.
ADR: Posso dire che il rispetto di cui godeva
Rocco Musolino era, per le modalità con cui si manifestava, in tutto simile a
quello di cui godeva mio zio Gioacchino Pennino, uomo d'onore della famiglia di
Brancaccio.
ADR: Confermo che mio zio Gioacchino Pennino mi
confidò di essere stato da latitante, negli anni 60', ospite dei Nuvoletta nel
napoletano. La cosa non deve sorprendere in quanto Cosa Nostra, 'Ndrangheta e
Sacra Corona Unita, sono da sempre unite fra loro. Sarebbe meglio dire sono una
"cosa sola". Da lì mio zio, come mi raccontò, si recava in Calabria dove, mi
disse, che aveva messo insieme Massoni, Ndrangheta, servizi segreti, politici
per fare affari e gestire il potere. Una sorta di comitato d'affari perenne e
stabile. In seguito, essendone molto amico, pochi mesi prima della sua morte,
nel 1980/ 1981, mi trovai a parlare con Stefano Bontate. Nel corso di questo
incontro Bontate mi disse che avrebbe avuto molto piacere se lo avessi aiutato a
continuare "quel progetto di tuo zio" (il comitato d'affari fra criminali,
massoni e servizi) non solo in Calabria, dove si era consolidato, ma anche in
Sicilia dove il progetto era ancora in fase embrionale. Io con molta diplomazia
riuscii a svicolare e a declinare l'invito. Non volevo assumere questo ruolo e
non mi interessava farlo.
ADR: Giuseppe Di Maggio era il rappresentante
della famiglia di Brancaccio fra i 70' e gli 80'. Dopo la morte di Bontate venne
destituito da tale ruolo e in seguito ucciso. Egli sicuramente conosceva bene il
Provenzano e per questo, così come dissi a suo tempo nel corso di un precedente
interrogatorio, fu in grado di farmi delle confidenze sulla vicinanza del
Provenzano alla destra eversiva ed ai servizi segreti nonché alla 'ndrangheta
calabrese. Devo dirvi, tuttavia che era voce diffusa il fatto che il Provenzano
giocasse su più tavoli, non solo quello di Cosa Nostra. In ogni caso in
proposito non posso che confermare quanto disse il Di Maggio e null'altro posso
aggiungere.
ADR: Conoscevo bene Tullio Cannella. Era, in
origine, un democristiano come me. Se non sbaglio era consigliere
circoscrizionale a Brancaccio. Unitamente ai Graviano ospitò presso un villaggio
turistico nei pressi di Cefalù alcuni esponenti della 'ndrangheta. Questo a
dimostrazione del rapporto molto stretto fra le due organizzazioni. Tullio
Cannella era animatore del progetto politico, voluto da Leoluca Bagarella, di
tipo separatista. In particolare era dirigente a Palermo di "Sicilia Libera".
Cannella manteneva anche la latitanza di Bagarella. La circostanza che dietro a
Bagarella, in questo progetto politico, vi fosse Provenzano era una mia mera
supposizione che, verosimilmente, peraltro, alla luce, dei fatti non mi sembra
neppure esatta. Confermo, invece, che proprio Vito Ciancimino inizialmente
sostenne il progetto separatista/autonomista. Ciò mi venne confidato da Giuseppe
Lisotta, parente di Vito Ciancimino, oltre che mio collega, con il quale ero in
buoni rapporti. All'epoca se non sbaglio si faceva riferimento alla Lega
Meridionale.
ADR: Sebastiano Lombardo, detto Iano, era uomo
d'onore della famiglia di Brancaccio che effettivamente mi propose di andare a
Lametia Terme a questo incontro fra leghe autonomiste. Egli in tale occasione si
fece latore di una richiesta dei Graviano che volevano coinvolgermi
evidentemente in questo progetto. Ovvio che la stessa circostanza che sia stato
proprio Iano Lombardo a parlarmi di questo incontro di Lametia Terme mi fece
comprendere che si trattava di una iniziativa a cui era fortemente interessata
la criminalità organizzata non solo siciliana. Confermo che anche il già
indicato Donnici doveva partecipare a tale incontro di Lametia Terme così come
riferitomi dal Lombardo. A vostra domanda vi dico che questo Donnici non l'ho
mai conosciuto.
ADR: In effetti il De Bernardo, che era stato al
vertice del Grande Oriente d'Italia, a seguito delle sue dimissioni – cui seguì
la creazione della Grande Loggia Regolare d'Italia – come appresi da Lisotta,
Giuseppe Ciaccio (uomo d'onore e massone) e Schifaudo, disse che non poteva
capeggiare una organizzazione al cui interno vi erano soggetti che organizzavano
- con le organizzazioni criminali - attentati contro lo Stato. Cosa che aveva
compreso svolgendo il suo ruolo. Ciò avvenne nel 1993. Sempre i predetti e forse
anche altri, mi dissero che il De Bernardo disse tali circostanze anche al
vertice della Grande Loggia d'Inghilterra a cui era affiliato il Grande Oriente
d'Italia. All'epoca era il Duca di Kent il vertice inglese della Grande Loggia
d'Inghilterra. Proprio per questo la Grande Loggia d'Inghilterra non riconobbe
più il Grande Oriente d'Italia...omissis".
Vicende politiche, che si legano in maniera oscura
con il mondo della massoneria. E così tanto Pennino quanto Cannella, riferivano
dell'incontro strategico di Lamezia Terme, non a caso, svoltosi, per l'appunto,
proprio in Calabria che, già all'epoca, era una sorta di laboratorio
politico/criminal/massonico. Convergenze nelle affermazioni dei collaboratori di
giustizia, ma ance in quanto racconta, il 6 marzo 2014, l'ex gran maestro del
Grande Oriente d'Italia, Giuliano Di Bernardo:
"......ADR: Entrato in massoneria nel 1961, nel
1993, dopo essere fuoriuscito dal GOI (in cui ero stato nominato Gran Maestro),
fondai La Gran Loggia Regolare d'Italia nel 2002 in quanto rimasi deluso anche
di questa nuova esperienza. La Gran Loggia Regolare d'Italia è stata
riconosciuta dalla massoneria inglese. Il GOI disconosciuto. In relazione a
queste vicende ho avuto diretti contatti con il Duca di Kent che è al vertice
della Massoneria Inglese che è la vera Massoneria. Ettore Loizzo, ingegnere di
Cosenza, mio vice nel GOI, persona che per me era il più alto rappresentante del
GOI, nel corso di una riunione della Giunta del Grande Oriente d'Italia ( una
sorta di CdA del GOI in cui era presente anche il mio successore Gustavo Raffi,
attuale Gran maestro del GOI ) che io indissi con urgenza nel 1993 dopo l'inizio
dell'indagine del dott. Cordova sulla massoneria, a mia precisa richiesta, disse
che poteva affermare con certezza che in Calabria, su 32 logge, 28 erano
controllate dalla 'ndrangheta. Io feci un salto sulla sedia. Gli dissi subito: e
cosa vuoi fare di fronte a questo disastro. Lui mi rispose: nulla. Io ancora più
sbigottito chiesi perché. Lui mi rispose che non poteva fare nulla perché
altrimenti lui e la sua famiglia rischiavano gravi rappresaglie. Fu questo che
mi indusse prendere contatti con il Duca di Kent a cui esposi la suddetto
situazione. Lui mi disse che già sapeva questa situazione tramite notizie da lui
avute dall'Ambasciatore in Italia e dai servizi di sicurezza inglese. Io feci
espresso riferimento alla commistione fra criminalità organizzate e GOI. Faccio
presente che in precedenza, intorno al 1990, poco dopo la mia nomina, nel corso
di una mia visita in Sicilia seppi da Massimo Maggiore, palermitano presidente
del più alto organo della Giustizia massonica (la Corte Centrale) che il più
alto esponente della circoscrizione del GOI di Mazara del Vallo era mafioso,
nonché, numerosissimi esponenti del GOI siciliani, e specie nel trapanese, erano
mafiosi. Dunque, capii che davvero, come diceva Cordova, il GOI era una
"palude". Fu il duca di Kent che mi suggerì di uscire dal GOI e creare un nuovo
Ordine. Faccio presente che la questione calabrese era molto più preoccupante in
quanto la massoneria calabrese era ben più ramificata e potente di quella
siciliana.
ADR: Con riguardo al periodo 1990/93, non ho
elementi diretti per collegare attacco allo stato (e quindi stagione stragista)
criminalità organizzata, separatismo, massoneria. Però era un collegamento che
in via deduttiva facevo (e che continuo a fare). Ciò rappresentavo anche
all'esterno, con le dovute cautele naturalmente, come mia argomentazione.
Sicuramente al Duca di Kent feci questi ragionamenti.
ADR: Seppi dai miei referenti calabresi e non
solo, di cui non ricordo i nomi, ma che potrei riconoscere, che all'interno del
GOI all'inizio degli anni 90, vi erano soggetti che sostenevano i movimenti
separatisti siciliani e meridionali in generale. Reggio Calabria era il centro
propulsore, l'origine di tali movimenti autonomisti che trovavano sostegno in
numerosi esponenti della massoneria e più esattamente del GOI. Ero molto
preoccupato da questa situazione. Nel nord vi era la Lega Nord, a sud si stavano
creando questi movimenti separatisti. Vedevo il nostro paese a rischio. In tutto
questo, avevo accertato che assai probabilmente la precedente gestione del Gran
Maestro del GOI era al centro di un traffico di armi con paesi extra-europei. Si
dà atto che il Di Bernardo riferisce di due specifici episodi in materia,
direttamente da lui constatati.
ADR: Alla riunione nella quale venne riferito
della presenza della 'ndrangheta nelle logge calabresi erano presenti oltre ai
soggetti sopra indicati Eraldo Ghinoi, ligure e il Gran Segretario, di origine
abruzzese, di cui non ricordo il nome.
ADR: Non conosco quali massoni, tali, Lisotta,
Giuseppe Ciaccio e Schifaudo. Non escludo che fossero massoni ma non li ricordo
questi nomi. Sapevo che il noto Gioacchino Pennino era massone. Mi dicevano, non
ricordo chi me lo disse, che era persona pericolosa in quanto legato alla
criminalità organizzata. In seguito seppi che collaborò con la giustizia.
Mandalari me lo volevano presentare ma io non volli conoscerlo...omissis".
Di Bernardo conferma quindi l'esistenza di
intrecci criminalità organizzata e Massoneria, ma, con specifico riguardo alla
criminalità calabrese, rappresentava una situazione di quegli anni che sarebbe
più esatto definire come di vera e propria colonizzazione della Massoneria da
parte della 'Ndrangheta, colonizzazione, evidentemente, funzionale ad interessi,
affari e progetti che non potevano essere sviluppati, con le sue forze, dal solo
mondo criminale (che, altrimenti, avrebbe evitato di perdere tempo ed energie
nei rituali massonici) ma che, invece, necessitavano di più ampie sinergie. E
certamente, fra questi progetti, per così dire, di più ampio respiro, che
necessitavano di una più vasta alleanza fra diverse forze che intendevano
capovolgere l'attuale ordinamento costituzionale, vi era quello
separatista/autonomista, sul quale convergevano gli interessi non solo di Cosa
Nostra e 'Ndrangheta, ma anche di soggetti legati alla Massoneria del GOI. Le
dichiarazioni del Di Bernardo, del Cannella e del Pennino, laddove evidenziavano
a cavallo fra 1990 ed il 1993, sinergie 'Ndrangheta-Cosa
Nostra-Massoneria-Destra eversiva, sul fronte separatista si saldano
perfettamente con le propalazioni rese, in epoca non sospetta e partendo da
punti di osservazione del tutto disomogenei, da due affidabili collaboratori di
Giustizia calabresi, Filippo Barreca e Cosimo Virgiglio.
Partiamo da Filippo Barreca. Si tratta di uno dei
principali collaboratori di Giustizia reggini degli anni 90', le cui
dichiarazioni sono state utilizzate in numerosi, "storici", procedimenti contro
la 'ndrangheta, fra questi il noto procedimento Olimpia. Egli era stato, per
anni, il capo della locale di 'ndrangheta di Pellaro, santista e massone. Si
tratta, dunque, di un soggetto perfettamente inserito in quel crocevia fra
'ndrangheta, servizi deviati, e massoneria e, come vedremo, destra eversiva, nel
quale la vicenda relativa al sostegno fornito dalla 'ndrangheta per garantire la
latitanza di Franco Freda era assolutamente emblematica. Voluta dalla destra
eversiva e gestita dalla 'ndrangheta e mediata dai esponenti delle istituzioni
deviate, la vicenda Freda è fra quelle che più di altre consentono di
comprendere la peculiarità del retroterra criminale calabrese e la sua
particolare e specifica attitudine ad avere interlocuzione con ambienti politici
ed istituzionali. Ecco, le dichiarazioni del Barreca rese alla DDA di Reggio
Calabria, utili a comprendere i rapporti fra Cosa Nostra Siciliana e
'Ndrangheta, fra entità criminali e politiche ed il cd "progetto separatista".
Il 3.2.1993: "...Quando, nei verbali precedenti, ho parlato di collegamenti di
alcune famiglie della 'ndrangheta reggina con Cosa Nostra siciliana, non ho
inteso fare riferimento ad un rapporto di vera e propria affiliazione. In realtà
io intendevo concettualizzare che le famiglie della 'ndrangheta da me indicate
erano i referenti di Cosa Nostra siciliana in un rapporto di reciprocità.
Chiarisco meglio il mio pensiero. Cosa Nostra siciliana è (N.d.PM: più
esattamente sarebbe da dire: ha) una sorta di vertice, o Cupola, che aggrega le
famiglie mafiose più prestigiose e rappresentative; pertanto, non ogni mafioso o
famiglia mafiosa siciliana appartiene a Cosa Nostra bensì quel vertice che è
esponenziale delle famiglie più potenti e prestigiose. Nella provincia reggina,
ove opera la 'ndrangheta, fino ad alcuni anni orsono non si era riprodotta una
situazione analoga, dal momento che le singole cosche operavano in proprio e,
pur mantenendo fra loro collegamenti ed alleanze, non presentavano una struttura
di tipo piramidale al cui vertice esistesse una cupola. Tale situazione si è
ribaltata a decorrere dall'inizio del '91, come ho illustrato nei precedenti
verbali, e cioè da quando, anche per dirimere la guerra di mafia in corso tra le
cosche reggine, si è costituita in tutta la provincia una vera e propria cupola
di modello analogo a Cosa Nostra siciliana. Tale cupola esercita poteri di
intervento su tutte le organizzazioni della 'ndrangheta; controlla tutte le
attività illecite ed, in generale, interferisce con l'autorevolezza di un vero e
proprio potere gerarchico sopra ordinato. La costituzione, anche presso la
'ndrangheta calabrese, di una struttura di tipo piramidale modellata su quella
siciliana, ha reso certamente più agevole e più pericoloso il rapporto fra le
due organizzazioni, dal momento che adesso Cosa Nostra siciliana ha un solo
interlocutore, di ampiezza provinciale, cui rivolgersi, laddove in passato il
rapporto intercorreva invece soltanto con talune delle famiglie della
'ndrangheta che avevano assunto la qualità di interlocutori privilegiati. Il
riferimento, da me fatto poc'anzi, ad una maggiore pericolosità che scaturisce
dalla coesistenza di due strutture ampie, articolate e similari fra loro, deriva
anche dalla circostanza che l'anello di congiunzione fra le due strutture è
rappresentato (quanto meno lo è stato) da un personaggio politico che ha fatto
parte della struttura Gladio e che è stato eletto nell'ultima legislatura al
Parlamento con l'appoggio anche delle cosche mafiose del reggino; personaggio
che ha peraltro acquisito indubbi meriti, agli occhi delle organizzazioni
'ndranghetiste e mafiose, per la sua attività di mediazione finalizzata a
risolvere lo stato di belligeranza fra le cosche reggine. .......... "
Il 5 maggio 1993: "...Confermo quanto dichiarato
nel verbale del 03.02. u.s. di cui mi viene data lettura. E' vero che ho parlato
di un personaggio che fa od ha fatto da collegamento tra Cosa Nostra siciliana e
la 'ndrangheta reggina. Sono ora disposto a fare il nome di questa persona e
posso dire che si tratta dell'avv. ROMEO Paolo. A mio avviso costui rappresenta
l'anello di congiunzione tra la struttura mafiosa e la politica. Volendo fare un
paragone potrei dire che è il "LIMA" reggino. Il suo ruolo è sicuramente
superiore a quello dell'avv. DE STEFANO Giorgio ed è stato determinante nelle
trattative per il raggiungimento della pace. Non so dire con chi l'avv. ROMEO
tenga i collegamenti in Sicilia ma credo che si tratti di personaggi politici
che alloro volta sono collegati con Cosa Nostra. Sapevo da varie fonti che
l'avv. ROMEO è massone ed apparteneva alla struttura GLADIO. Egli inoltre era
collegato con i servizi segreti ma non so dire in che modo. Egli però ebbe a
dire ad un mio parente che aveva a disposizione i servizi. So anche che era
interessato ad un progetto politico che puntava alla separazione delle regioni
meridionali dal resto del paese ma anche su questo non so fornire ulteriori
particolari. Tale progetto era già di mia conoscenza e mi fu confermato da
ROSMINI Diego in carcere nel periodo in cui eravamo insieme nel carcere di
Palmi. Anche ROSMINI riferiva di tale progetto all'avv.
ROMEO...omissis...Tornando all'avv. ROMEO Paolo il suo rapporto con i DE STEFANO
è molto remoto e risale alla rivolta di Reggio. Probabilmente nasce dal fatto
che ROMEO e DE STEFANO (intendo dire Paolo e l'avv. Giorgio) erano collegati con
i servizi segreti ...... Mi risulta inoltre che l'avv. ROMEO fosse legato ai
LATELLA di Ravagnese in favore dei quali spese il suo interessamento in
occasione dei processi in cui erano imputati. I LATELLA in cambio favorirono
elettoralmente l'avv. ROMEO procurandogli un gran numero di voti nella loro zona
così come fecero i DE STEFANO-TEGANO ad Archi. Ciò spiega anche i risultati
elettorali conseguiti dal ROMEO anche nella Piana di Gioia Tauro. Mi riservo di
fornire ulteriori indicazioni su tutti gli argomenti sinora trattati in un
prossimo interrogatorio.
A.D.R.: Mi risulta che a Reggio Calabria esiste
più di una loggia massonica coperta di cui fanno parte professionisti reggini a
tutti i livelli e di cui mi riservo di fare i nomi di persone che ne potrebbero
fare parte. Ne potrebbero far parte anche rappresentanti di alto livello delle
istituzioni e della politica...omissis Posso anche affermare con certezza, anche
questa assoluta, che i sequestri di persona avevano una componente "eversiva e
politica". Essi infatti erano finalizzati da una parte a stornare l'attenzione
dell'opinione pubblica da altre vicende criminali più importanti e dall'altra a
rafforzare quel progetto separatista di cui ho parlato all'inizio. La regia di
questo disegno è da ricercarsi a Milano dove avviene l'incontro tra i gruppi
calabresi (PAPALIA) ed i gruppi siciliani...omissis...
A.D.R.: Quando mi riferisco ai PAPALIA intendo
dire dei tre fratelli Domenico, Rocco, Antonio; e dico proprio Domenico quello
condannato all'ergastolo per omicidio il quale pure ha sempre partecipato in una
posizione di supremazia ai traffici della sua famiglia, anche quando si trovava
in semi-liberta', come so benissimo...omissis....
Importante era la posizione dei PAPALIA che
provvedevano a convogliare i soldi provento dei sequestri di persona per
utilizzarli per gli acquisti delle sostanze stupefacenti. E' appena il caso di
ricordare come la esecuzione dei sequestri di persona rispondesse ad una unica
centrale, come per altri già affermato......"
Il 18.5.1993: "...Tornando alla vicenda di FREDA
ed, in particolare, alla sua fuga da Catanzaro, voglio precisare che per
accompagnare FREDA a Reggio Calabria furono il Dr. ZAMBONI di Modena, medico a
Roma ed un Generale, direttore dell'Artiglieria del Museo di Gerusalemme in
Roma. Questo generale era parente dei fratelli Dante ed Eugenio SACCA'. Non so'
presso chi venne portato FREDA inizialmente. So soltanto che venne accompagnato
a casa mia da MARTINO Paolo, dall'avv. ROMEO Paolo e dall'avv. DE STEFANO
Giorgio. Mentre era a casa mia scrisse una lettera indirizzata a DE STEFANO
Paolo, che all'epoca si trovava in carcere a Reggio Calabria. Io avrei dovuto
consegnare la lettera a MARTINO Paolo perchè la facesse recapitare a DE STEFANO
Paolo ma io non lo feci. Nella lettera FREDA ringraziava DE STEFANO Paolo per il
trattamento ricevuto a Reggio Calabria. La lettera è stata allegata agli atti
relativi all'arresto di ROMEO Paolo. Sono stato io stesso a consegnare la
lettera al dr. CANALE della Questura di Reggio Calabria e servì per la
comparizione della calligrafia di FREDA. FREDA rimase a casa mia per circa 4
mesi ed io protestavo perchè ero sorvegliato speciale e non volevo correre
rischi, fu così che venne trasferito in una casa di VADALA' Carmelo di San
Lorenzo; la casa in questione si trovava a Reggio, vicino alla caserma dell'ex
208. Dopo poco tempo FREDA venne accompagnato dallo stesso VADALA' a
Ventimiglia, presso altri calabresi che avrebbero dovuto farlo espatriare in
Francia. Fu lo stesso FREDA a dirmi che era stato accompagnato a Reggio dal
generale e dal Dr. ZAMBONI, credo che il suo primo rifugio a Reggio fu la casa
di VERNARECI Pippo, amico di ROMEO Paolo, e DE STEFANO Giorgio e MARTINO Paolo.
Fu io stesso a ricevere da FREDA Franco, che a sua volta li aveva ricevuti da
ROMEO Paolo e MARTINO Paolo, marchi tedeschi per un valore di circa 40.000.000
di lire italiane; io cambiai i marchi attraverso il direttore della Banca di
Credito e Sovvenzioni di Pellaro, Dr. AMODEO Paolo. So' che AMODEO per ragioni
tecniche cambiò i marchi a Reggio presso la Direzione dell'Istituto. Più volte
FREDA mi disse che se non fosse riuscito ad uscire dal processo di Piazza
Fontana avrebbe fatto saltare l'Italia intendo dire che avrebbe fatto
rivelazioni sconvolgenti sul ruolo di apparati dello Stato che non so meglio
specificare. Nessun alto venne a trovare FREDA in quel periodo, ma so' che era
in contatto telefonico con un avvocato di Modena o di Bologna di cui non ricordo
il nome...omissis...DE STEFANO Paolo era anche legato a CONCUTELLI e a quanto io
ho saputo fu' lo stesso DE STEFANO a fare da delatore per il suo arresto.
Ricordo adesso un altro episodio molto significativo. Nel '74 mi trovavo a
Crotone insieme a DE STEFANO Giovanni che dopo poco tempo sarebbe stato ucciso
al Roof Garden. In quella città' Giovanni mi presentò alcuni esponenti della
massoneria tra cui un commerciante di pneumatici di cui non ricordo il nome; si
trattava di persone e che mostravano di conoscere bene DE STEFANO Giovanni e
probabilmente era massone anche lui. Durante quel viaggio DE STEFANO Giovanni mi
disse che da lì a qualche giorno sarebbe dovuta scoppiare una bomba alla Standa
o all'Upim di Reggio Calabria, cosa che avvenne veramente. La bomba doveva
servire a creare una situazione di terrore, Giovanni mi disse che la bomba
sarebbe stata collocata da loro su incarico di personaggi di primissimo
piano...Tornando al discorso della massoneria di cui ho parlato nei precedenti
interrogatori posso dire che tradizionalmente ci sono stati ottimi rapporti tra
'ndrangheta e massoneria. I rapporti erano sostanzialmente di reciproca
solidarietà. Sulla Jonica tali rapporti erano tenuti da personaggi quali Don
STILO e NIRTA Antonio, sulla tirrenica da BELLOCCO Giuseppe, mentre a Reggio
tali rapporti erano tenuti dall'avv. DE STEFANO Giorgio e dell'avv. ROMEO. Tutte
le persone da me indicate appartengono contemporaneamente sia alla 'ndrangheta
anche alla massoneria. Sono sicuro che esistono logge coperte alle quali
aderiscono questi personaggi..."
Ecco le dichiarazioni rese da Barreca ai
magistrati di Palermo in data 12.9.1996:"...omissis...
P.M.S.: Senta signor Barreca il problema è farle
alcune domande in relazione a precisazioni ed approfondimento di alcune
dichiarazioni da lei già rese in data 5 Maggio 1993 alla Procura di Reggio
Calabria, in particolare modo volevamo chiederle una...notizie più precise circa
questo avvocato Paolo Romeo che lei in quel verbale indica come anello di
congiunzione tra struttura mafiosa e politica, e la politica e inoltre come
soggetto legato all'omicidio e a personaggi collegati con "Cosa Nostra". Cos'ha
da riferire di preciso?
B: Dunque, dell'avvocato Paolo Romeo ho parlato
ampiamente in dei verbali, svariate volte, alla procura Distrettuale di Reggio
Calabria, in particolare, come ebbi già a dire, è un personaggio che io
definirei il Lima reggino, il Lima reggino lo definisco perchè è il personaggio
chiave della struttura della 'ndrangheta....omissis... è un uomo che passò dal
mondo MSI alla Social Democrazia e prima di questo proprio per un intoppo che è
avvenuto dietro una mia..., dietro la cattura di Franco Freda, la cattura di
Franco Freda avviene, mi pare, se non ricordo male, nel maggio, giugno 1979, lui
portò Franco Freda, lui portò a casa mia Franco Freda, che lo tenni circa...
P.M.S: Chi?
B: Paolo Romeo, l'avvocato Paolo Romeo, mi portò
assieme al gruppo De Stefaniano, quindi per conto di Paolo De Stefano e di Paolo
Martino, mi portarono a casa mia il famoso Franco Freda che nel maggio del 79 è
stato catturato in Costa Rica. E questo tipo di... diciamo per la cattura di
Freda venne incriminato il Romeo che subito dopo...
P.M.S: Per favoreggiamento...omissis...
P.M.S: Si. Senta, lei sempre in questo
interrogatorio del 5 maggio, ha detto in particolare di sapere, di avere saputo
da Araniti che l'avvocato Romeo è massone ed è appartenente alla struttura di
Gladio, nonchè collegato con i Servizi Segreti, da chi è che ha appreso queste
notizie?
B: Guardi io avevo un buon rapporto con Araniti
Santo che tra l'altro è stato quello che mi... infatti c'è uno dei miei figli,
Vincenzo, che eravamo imputati nello stesso procedimento, in quel famoso
processo "Droga 2", dopo di che, lui essendo a casa mia... di cui... con le
forze di polizia, siccome io avevo un nascondiglio, in buona sostanza, salvai
l'Araniti e mi feci arrestare io...omissis.., quindi questa riconoscenza ha,
come dire, permesso all'Araniti di avere una più ampia fiducia nei mei
confronti, perchè in buona sostanza, avrei potuto tranquillamente rischiare
anch'io e mettermi nello stesso nascondiglio, ma una volta che le forze di
polizia avevano arrestato me, il problema in casa mia si era
risolto....omissis...
B: Di conseguenza questo episodio, quando poi nel
1986 io sono uscito dalla...diciamo, uscito da questo processo, la Cassazione mi
ha scarcerato per scadenza dei termini massimi di custodia cautelare, abbiamo
intrapreso nuovamente i rapporti con l'Araniti anche se lui era, diciamo, da
tanto tempo latitante, dall'83. Nel 1988/87/88 e per questo errore mi mandò a
chiamare perchè voleva, ha voluto, che gli dessi una mano per l'uccisione
dell'Onorevole Ligato....omissis... a un certo punto mi ha, diciamo il discorso
scaturì da quello che era l'andamento della situazione reggina, cioè sia reggina
che nazionale, in particolare lo sunto l'abbiamo preso nel momento in cui si
parlò di quello che poteva essere e che era lo scalpore che aveva suscitato
l'uccisione dell'Onorevole Ligato e in particolare lì, nella zona locale
della..., ma dove io ero uno dei personaggi, sicuramente, più importanti o il
personaggio più importante, a un certo punto dice... dice; "La guerra, in questo
frangente l'hanno persa" dice "anche perchè ora non so come si mette paolo
Romeo. Il discorso scaturì su Paolo Romeo perchè secondo quello che mi dice
Araniti, il Romeo era il personaggio che assieme a Ligato e assieme agli altri
era il più vicino al gruppo dei Rosmini. Parlammo di un progetto che loro
avevano, cioè il cugino di Araniti, Arnone Pietro, onorevole della... del
partito Repubblicano passò, doveva passare, con la uccisione doveva passare
alla, al mondo della Democrazia Cristiana, cioè doveva essere, una volta ucciso
Ligato, il personaggio più rappresentativo dell'intera provincia di Reggio
Calabria. Per quanto riguarda il progetto di separatismo che io ho parlato dei
miei...
P.M.S: In quello stesso verbale lei ha fatto
riferimento ad un interessamento dell'avvocato Romeo per questo...
B: Ad un interessamento di questo, l'avvocato
Romeo, io so che nell'ultimo periodo, da quello che mi diceva sempre Reni, aveva
preso contatti con personaggi del mondo politico, certamente io non so chi sono
i personaggi.
P.M.S: Chi aveva preso contatto?
B: Il Romeo.
P.M.S: Il Romeo.
B: Il Romeo aveva preso contatti per formare delle
Leghe ecc..
P.M.S: Che anno siamo più o meno?
B: ma, guardi, già nel 1990/91, questi sono i
periodi, questo è il periodo.
P.M.S.: ... sempre da Araniti giusto?
B: Quindi il progetto, in poche parole, consisteva
nel fatto di fare la separazione dell'Italia in tre regioni, quella del Nord,
quella del Sud, e quella del Centro, questo era in sintesi...
P.M.S: E rispetto a questo progetto, cioè era
un'iniziativa dell'avvocato Romeo a titolo individuale o c'erano interessi della
‘ndrangheta o di altri...?
B: Certamente, certamente l'interessamento era un
interessamento non solo dell'avvocato Romeo ma era un interessamento non solo
dell'avvocato Romeo ma era un interessamento a più alto, a più ampio, diciamo,
spazio. Perchè dico questo? Perchè successivamente a questi fatti anche in
carcere, io siccome poi fui arrestato nel ... il 4 di gennaio del 1991, anche in
carcere con il gruppo dei Rosmini, non avevamo le idee chiare sulla... su questo
tipo di progetto, però il ...il più grande me ne parlò.
P.M.S: Che si chiama come?
B: Si chiama, uno dei più grandi, il più grande
dei Rosmini mi pare, ora in questo momento non me lo ricordo.
P.M.S: Va be, va bene.
B: Com'è che si chiama, comunque mi pare, bè
non....
P.M.S: Va bè, non ha importanza.
B: Non me lo ricordo, in questo momento non me lo
ricordo.
P.M.S: Il più grande cosa le disse?
B. Parlava di un discorso dell'avvocato Romeo,
della potenza che poteva avere per far tacere, dice: "Non vi preoccupate che qui
l'avvocato Romeo ci mette in condizioni a tutti di potere uscire, quindi di
potere essere nelle condizioni che i processi si debbono aggiustare, quindi..."
P.M.S: Ma questo in relazione alle iniziative
dell'avvocato Romeo? o in relazione al progetto, cioè ci entrava o non...?
B: No, assolutamente, questo era un discorso che
era la potenza dell'avvocato Romeo.
P.M.S: Ho capito.
B: Certamente su un progetto separatista, io non è
che so di più, so che c'era questo interessamento da parte dell'avvocato Romeo
a, diciamo, a separare l'Italia, so che l'interessamento c'era, che c'era
interessata anche la massoneria su questo progetto, ma di più...
P.M.S: Che c'era interessata anche la massoneria
da chi l'ha appreso?
B: Ma, sempre da Araniti, cioè parlavamo, cioè nel
momento in cui abbiamo parlato, dice: "...qui c'è un discorso molto importante,
cioè c'è un discorso che sono interessate alte personalità e c'è un discorso che
c'è la massoneria dietro questo..." Anche per rafforzare ancora di più questo
progetto c'era la massoneria.
P.M.S: E' Araniti che è un esponente di spicco
della 'ndrangheta.
B: E' uno dei personaggi credo, più importanti
all'interno anche della politica, perchè il cugino, non va dimenticato, che era
Onorevole e Consigliere Regionale, svariate volte.
P.M.S: Dico, era Araniti, era lui personalmente
interessato, quindi la 'ndrangheta era personalmente interessata a questo
progetto separatista tramite l'avvocato...
B: Che era anche, era, era naturalmente,
l'avvocato com'era rappresentava la ‘ndrangheta, voglio dire, voglio dire che
questo l'avvocato Romeo era un personaggio che veniva portato dalla ‘ndrangheta,
non è che era un personaggio che veniva così, quindi il progetto che riguardava
l'avvocato Romeo, riguardava anche la 'ndrangheta.
P.M.S: Benissimo. Senta lei poi successivamente,
quando poi è stato arrestato, ha saputo più nulla di questo progetto
separatista, se è andato avanti, non è andato avanti, se venne abbandonato?
B: Io per quello che so, era un progetto che non
poteva fermarsi, ma che doveva necessariamente andare avanti. Cioè ci furono le
aspettative.
P.M.S: Perchè, ci furono momenti di contrasto
all'interno della 'ndrangheta'.
B: Certo. Poi c'è stato un momento in cui si
composero questi contrasti interni alla ‘ndrangheta, grazie anche
all'interessamento dei Siciliani, debbo dire, perchè....
P.M.S: Questo avvenne mentre lei è detenuto?
B: Questo mentre io sono detenuto sì. Dico…
P.M.S: Quindi questo, questo favorì rapporti più
stretti tra la 'ndrangheta e i Siciliani e "Cosa Nostra", lei sa se in qualche
modo si è riflettuto su…sul progetto separatista? Dico... se ha avuto notizie lo
accenni.
B: Io...? Notizie per quello che abbiamo parlato
ripeto con il....
P.M.S:" Ma so che aveva dei rapporti anche con il
mondo politico, anche Siciliano il...l'avvocato Romeo. "Con chi in particolare
del mondo Siciliano?
B: All'interno so della Democrazia Cristiana era
il...diciamo il rapporto che aveva era con il mondo della Democrazia Cristiana.
P.M.S: Siciliana?
B: Siciliana.
P.M.S: Lei sa con chi in particolare?
B: In particolare non lo so. Comunque della
Democrazia Cristiana.
P.M.S: Sa se c'erano alcune zone in particolare
della Sicilia, nella quale, nelle quali, l'avvocato Romeo, aveva rapporti più
stretti? Alcune provincie, alcune zone, zona di Catania, zona di Palermo, zona
di Messina.
B: Guardi sicuramente Catania come, che io ebbi a
dichiarare anche nei verbali, se lei può vedere parlare proprio di un... di una
loggia che è stata istituita nel momento in cui c'era il gruppo, nel momento in
cui c'era diciamo il gruppo a cui faceva parte sia l'avvocato Romeo, sia altri
personaggi, una loggia che veniva istituita, è stata istituita a Catania una
loggia, una loggia super segreta a Catania. Questo già nel 1979…omissis...
P.M.S: senta in questo stesso verbale lei fà
riferimento per quanto riguarda...le avevo fatto precedente la domanda della
appartenenza alla struttura Gladio dell'avvocato Romeo, questo lo ha appreso
sempre da Araniti?
B: Ma guardi, questo è uno dei fattori più
diciamo, ne parlai a Vario titolo con svariati personaggi, tra questi anche
Araniti. Poi io so che, anche, con altri parlammo, che in questo momento io non
ricordo, anche con altri personaggi abbiamo parlato proprio in riferimento
all'avvocato Romeo, in particolare proprio con uno dei miei cugini, mi parlò di
un discorso di appartenenza della... diciamo che aveva nelle mani i Servizi di
Sicurezza, cioè aveva rapporti di grande intimità con i Servizi e poteva
manovrare come voleva all'interno, anche del... condizionale.
P.M.S: con chi in particolare, le venne detto?
B: ma guardi, in particolare non mi venne detto
chi, ma so che errano interessati sia i due Servizi, che... sia il SISMI che il
SISDE.
P.M.S: Il nome di Gladio glielo fece
espressamente?
B: Si, il nome di Gladio si, espressamente sì.
P.M.S: E lei capì che cosa era la nostra... ma lei
lo sapeva già...
B: No, era una struttura che serviva anche per...
P.M.S: Questa era una sua considerazione, o
l'appresa pure da...
B: No, no era per tenere a bada nel caso in cui ci
fosse un, una entrata al Governo di Comunisti, questo quello che…
P.M.S: Questo glielo disse Venuta?
B: Si.
P.M.S: E lei non lo sapeva per i fatti suoi prima.
B: Ma, nel mondo politico non è che mi interessava
tanto, ma comunque ecco.
P.M.S: Senta comunque qualche accenno leggendo
appunto il verbale del 5 maggio 93, lei dichiarò qualche cenno Rosmini glielo
fece del progetto separatista, cioè questo progetto...
B: Con Rosmini abbiamo anche parlato del progetto
separatista proprio per quel discorso che io avevo fatto precedentemente con
Araniti, cioè che io innescai il discorso e lo stesso Rosmini mi disse: "Compare
c'è un progetto separatista che deve essere necessariamente portato avanti, per
fare in modo che dobbiamo avere più comando, più per essere qui da noi insomma
ecco". Avere più controllo come si suol dire per avere più…le cose più da
vicino, cioè....
P.M.S: insomma è chiaro.
B: Ma questo era il senso della...cioè che avevo
il controllo della... dell'intera provincia e il controllo soprattutto del mondo
politico.
P.M.S: E le spiegarono com'è che questo progetto
separatista, doveva arrivare a questo obiettivo così ambizioso? Attraverso quale
itinerario, perchè non è che sia facile mettere su un soggetto politico,
arrivare a conquistare posizioni di potere. Quale doveva essere l'itinerario, se
lei lo sa, se non lo sa, non lo sa?
B: Non lo so.
P.M.S: Non lo sa, va bene. Senta lei in questo
stesso verbale ha fatto riferimento alla...rileggiamo: "Io posso affermare
che... persone comprendono... eversiva e politica". Sempre nel verbale del 5
maggio 93, disse: "Finalizzato da una parte a stornare l'attenzione
dell'opinione pubblica dalle altre vicende criminali più importanti, dall'altra
a rafforzare quel progetto separatista di cui ho parlato all'inizio. La regia
del disegno è da ricercarsi a Milano dove avviene l'incontro tra i gruppi
Calabresi... e i gruppi Siciliani. Mi rendo perfettamente conto che un disegno
di questo genere non può essere esclusivamente mafioso, non so dare indicazioni
sulla matrice politica": Ora la domanda è se questa considerazione, cioè, anzi
queste due considerazioni, primo la componente eversiva-politica di queste
persone e secondo che fosse in qualche modo anch'essa in relazione al progetto
separatista, è una notizia che lei ha appreso da qualcuno o...
B: E' una ...sono delle notizie che io attraverso
un mio bagaglio di conoscenze feci, io personalmente.
P.M.I: Cioè, proviamo a spiegarlo, cioè come
arriva, cioè è una conclusione sua?
B: E' una conclusione che non ha assolutamente,
voglio dire, è una delle mie conclusioni.
P.M.S: Che arrivano sulla base di quali dati?
B: Sulla base dei dati che... all'interno,
diciamo...
P.M.S: Interrompiamo un attimo alle ore 17:19 per
sostituire il nastro. Alle ore 17:27 si riprende la registrazione. Quindi la
domanda che le avevo rivolto, signor Barreca, era di precisare, sulla base di
quali elementi, di quali dati, cioè di conoscenze svariate, di fatto lei
perveniva, lei poi è venuto alla conclusione che vi fossero... dei sequestri di
persona dell'organizzazione "'ndrangheta", definita "'ndrangheta", che aveva una
componente eversiva e politica in qualche modo, che sia rafforzare il progetto
separatista di cui diceva prima.
B: Cioè questa è stata una mia deduzione, sulla
base di quelle che erano le mie conoscenze, e le mie conoscenze anche in un
mondo dei sequestri di persona che ho dedotto che potevano essere ricollegati a
quel progetto, ma è solo una mia, ripeto, esclusiva deduzione, che non altro.
P.M.S: ma dico, all'interno della 'ndrangheta che
vi fosse, a parte il collegamento del progetto separatista, una componente,
diciamo, eversiva nei sequestri di persona. Va...
B: Veda, io su questo, va, l'ho appreso
all'interno della 'ndrangheta, questo sì, ora non so con chi ne abbiamo parlato,
ma....
P.M.S: Sequestri di dodici persone, commessi in
quale periodo?
B: ma, nei periodi 198... dall'85 in poi...
sequestro Casella, ha avuto uno dei periodi più culminanti del.... perchè?
Perchè per quello che io ebbi già a dichiarare nel... nei svariati verbali il
sequestro Casella è stato fatto dai... dal gruppo che facevano capo ai Papalia,
ai Sergi, e poi concluso in Calabria con la mediazione dell'avvocato Romeo,
omonimo dell'avvocato Paolo Romeo, e nella ... Servizi di Sicurezza.
P.M.I: E da chi' Se lei ne è a conoscenza.
B: Ma guardi, personalmente da quello che mi è
stato riferito, si interessò il SISMI alla liberazione della... del ragazzo di
Papalia, di quel ragazzo che, ha liberato poi, successivamente per l'avvocato
Rotolo che era stato preso dai Sergi...
P.M.I: Ma lei sa in virtù di quali rapporti?
B: Ma, io so che avevano dei buoni rapporti,
istauratisi prima con il…diciamo con la... con il vecchio Nirta, inteso vecchio
non di età, chiamato "Due nasi", il quale era in buoni rapporti con... da quello
che si diceva in carcere, che poi è stato, diciamo, riconosciuto come uno dei
delatori del Generale Delfino e quindi diciamo è stato messo da parte ed è stato
pure esautorato, veniva chiamato Dottore Nirta "Due nasi". E a un certo punto
questo "due nasi" è stato messo da parte anche in carcere nonostante fosse il
personaggio, diciamo, che era, nonostante fosse il nipote, diciamo, del vecchio
Dottor Nirta, personaggio di spicco, importante nel mondo della 'ndrangheta, e
perchè secondo quello che mi diceva Giovanni Vottari nel carcere di Messina, il
"Due nasi" era in contato con un Generale dei carabinieri, il Generale Delfino.
il quale, diciamo, faceva la doppia situazione, da una parte chiudeva gli occhi
nei suoi confronti, dall'altra gli dava una mano, al "Due nasi"
all'intimidazioni dei sequestrati, per quello che io so il discorso poi è
ricaduto con il gruppo dei Papalia che era molto, poi da quello che si sa, era
...azienda per le...
P.M.I: Senta, lei in questo verbale ha parlato di
incontri che avvenivano a Milano fra i gruppi calabresi, il gruppo Papalia e i
gruppi Siciliani, ma chi si riferisce come gruppi Siciliani che si incontravano
e avevano contatti a Milano con i Papalia? Cioè lo sa innanzitutto?
B: Si, da quello che mi diceva Peppe Zacco, e per
quello che erano naturalmente le mie conoscenze, Peppe Zacco, che ci incontrammo
nel carcere di Pisa nel 93, 92 scusi.
P.M.I: Che è originario, di dov'è?
B: Che è originario di Palermo, di, di è stato,
era il compare di Paolo De Stefano, era personaggio che è stato imputato nel
famoso processo "Pizza connection", con molto... che era molto vicino al mondo
imprenditoriale Milanese, più precisamente al gruppo dei Socialisti, da quello
che lui diceva, e che tutti gli appalti che venivamo effettuati nella zona di
Milano venivano controllati da "Cosa Nostra" e dalla "'ndrangheta".
P.M.I: E quindi lei stava dicendo, Peppe Zacco
fece riferimento a contatti con i Calabresi, "Cosa Nostra", ma come punti di
riferimento Siciliano a Milano, che avevano questi contatti, questi rapporti
intensi con i calabresi, le fece riferimenti specifici a parte, cosa le disse?
B: Io per quello che parlammo con Peppe Zacco, io
mi trovavo pure nel carcere di Messina, sempre di conoscere un personaggio con
cui ebbi anche un rapporto che poi l'ho già dichiarato in altri, nei precedenti
verbali, con il... con il... con uno dei personaggi Siciliani vicino al... molto
vicino a "Cosa Nostra" ed era... in questo momento non mi viene il nome
comunque...
P.M.I: Va bè, se non le viene il nome, poi se lo
ricorda me lo dirà.
B: Si in questo momento non...
P.M.I: Senta, e per quanto riguarda i Papalia le
risulta in qualche modo, per quello che le disse, che le dissero Araniti con
Rosmini, che fossero anch'essi interessati al progetto separatista?
B: Si, in questo momento non...
P.M.I: Senta, e per quanto riguarda i Papalia le
risulta in qualche modo, per quello che le disse, che le dissero Araniti con
Rosmini, che fossero anch'essi interessati al progetto separatista?
B: Si, so che fossero, che erano interessati anche
il gruppo dei Papalia a questo progetto...omissis"
Il Barreca, infine, escusso dalla Dda di Reggio
Calabria, in data 20.2.2014, riferiva: "...omissis....
ADR: i rapporti fra i De Stefano e Concutelli, di
cui ho riferito nei verbali resi a suo tempo, si originano dai rapporti
strettissimi fra i De Stefano e i servizi segreti che, non a caso avevano
originato anche i rapporti fra Freda e De Stefano – Romeo. Io Concutelli non
l'ho mai conosciuto ma dei rapporti fra quest'ultimo e i De Stefano e della loro
genesi ho saputo direttamente da Paolo De Stefano...omissis....
ADR: Era Paolo Romeo il deputato (eletto con i
nostri voti, gladiatore e che rappresentava l'anello di congiunzione fra Cosa
Nostra e 'Ndrangheta) di cui riferisco nel verbale del 3.2.1993 alla DDA di
Reggio Calabria.
ADR: Confermo che a Milano – grazie ai Papalia, mi
riferisco a Rocco e Domenico che ho personalmente conosciuto – si rinsaldarono i
rapporti fra Cosa Nostra e 'Ndrangheta. Ciò avvenne sulla base di comuni
interessi nel settore del traffico di sostanze stupefacenti. Su questa base di
rapporti oramai saldi e pienamente operativi si innestò il cd progetto
"separatista" voluto e sponsorizzato da Cosa Nostra e dalla 'Ndrangheta. I
collegamenti fra cosa nostra e 'ndrangheta si intrecciavano in modo coordinato a
Milano grazie ai Papalia e a Reggio Calabria grazie a Paolo Romeo. Insomma Paolo
Romeo e i Papalia agivano, in questo ambito, come un'unica persona, in
esecuzione di un unico disegno. Tutte queste sono circostanze che appresi dai De
Stefano. Al momento non ricordo da chi di loro esattamente...omissis
ADR: Fu Freda che per primo mi parlò della
Massoneria mi diede anche copia dei rituali di affiliazione passaggio di grado.
Esibisco tali rituali. L'Ufficio da atto che vengono esibite della pagine su cui
sono riportate le "Istruzioni per il grado di Maestro" con varie formule
rituali...omissis"
Dichiarazioni, rese nell'arco di un ventennio, che
mostrano ancora una volta la joint venture tra 'ndrangheta e Cosa Nostra, ma
anche i collegamenti istituzionali e paraistituzionali, soprattutto con il mondo
della massoneria e dei servizi segreti. E, ancora, la piena adesione della
'ndrangheta al progetto separatista dell'inizio anni 90', che sappiamo,
condivideva, con Cosa Nostra siciliana e, in particolare, con i Graviano
direttamente incaricati di tirare le fila di tali movimenti in ambito
palermitano; la finalità ultima del progetto leghista che consisteva nel creare
delle macro-regioni, dove, in quella meridionale, le organizzazioni di tipo
mafioso potevano meglio controllare il quadro politico di governo e godere,
quindi, di una sorta di immunità e salvacondotto permanenti. Il quadro dei
rapporti fra 'Ndrangheta e massoneria, veniva, infine, da ultimo compiutamente
descritto dal collaboratore di Giustizia Cosimo Virgiglio. uomo di fiducia dei
Molè per conto dei quali movimentava imponenti capitali che venivano investiti
nel settore della contraffazione e delle importazioni tramite il Porto di Gioia
Tauro, professionista colto, già massone di provata fede ( appartenente alla
Loggia "Garibaldini d'Italia") ecco un estratto delle sue dichiarazioni:
Virgiglio Cosimo 24.3.2015 ".....omissis...Si dà atto che a questo punto il
Virgiglio riferisce dei rapporti fra la Loggia Garibaldini d'Italia, la loggia
coperta di Ugolini Giacomo Maria denominata Grande Oriente di San Marino e i
Molè/Piromalli. Riferisce del ruolo avuto da lui stesso e dal Cedro Carmelo ed i
suoi fratelli. Riferisce che lui è uscito da tale contesto quando si stava
concretizzando l'alleanza fra Garibaldini/Molè e Grande Oriente di San
Marino...omissis....Riferisce del progetto di pilotare la scarcerazione di Mommo
Molè per motivi di salute attraverso Cesare Previti ed il dott. Ceraudo/Ceravolo
medico del Dap, Boccardelli segretario di Ugolini condannato per 416 bis c.p. in
Appello nell'operazione Maestro e Balestrieri ex piduista presidente del Rotary
di New York uomo di punta della loggia di Ugolini...(N.d PM: Giorgio Hugo
Balestrieri, già Ufficiale della Marina Militare, già iscritto alla Loggia
Propaganda 2, come risulta dagli atti della Commissione Parlamentare d'Inchiesta
presieduta dall'On.le Tina Anselmi, è attualmente imputato innanzi al Tribunale
di Palmi, per rispondere del delitto di concorso esterno nella cosca Molè, reato
per il quale è stato raggiunto da misura cautelare, confermata in sede di
gravame. Non rileva, ovviamente in questa sede l'esito del procedimento. Ciò che
qui conta è l'esistenza di rapporti documentati fra il piduista e la
'ndrangheta, al di là del fatto che questi rapporti possano, o meno, essere
inquadrati nella fattispecie contestata di concorso esterno). Riferisce del
ruolo di grande influenza in Calabria, in quanto legatissimo a Licio Gelli, di
tale ...omissis...di Cosenza, persona inserita nel contesto della loggia di
Ugolini che può a sua volta considerarsi una sorta di continuazione della loggia
Propaganda 2 in quanto connotata dai medesimi obiettivi di potere e soprattutto
dalla struttura "coperta" e "segreta", senza contare i legami personali fra
Licio Gelli, Ugolini e Balestrieri ed i medesimi legami che la loggia di Ugolini
aveva, al pari della P2, con gli ambienti e la finanza vaticana ( non a caso
Ugolini era ambasciatore di S. Marino presso il Vaticano, anzi decano degli
ambasciatori di tutto il mondo presso il Vaticano). La 'ndrangheta utilizzava
tale struttura per ripulire il denaro garantendo in cambio la gestione a favore
di tale struttura segreta dei flussi elettorali a favore dei soggetti politici".
Ancora Virgiglio il 29.4.2015. "...ADR: Sono
entrato o meglio mi sono avvicinato alla massoneria per il tramite del messinese
Carmelo Ugo Aguglia, nobile messinese, intorno alla fine degli anni 80'. Io
frequentavo l'università di Messina. Per la verità iniziai a frequentare il
Rotary. Il Rotary era una trampolino di lancio per entrare nei GOI. Il tempio di
Messina che si trovava nella zona del Papardo. Ricordo che fra gli altri
frequentatori di questo ambienti massonici di Messina vi era Franco Sensi,
presidente della Roma Calcio. Nel 92/93 arrivò a Messina, da Reggio Calabria, la
soffiata su di una indagine sulla massoneria. In quello stesso periodo Aguglia
mi fece entrare nell'Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro, che è un sodalizio
organico al Vaticano. A capo di tale Ordine vi era Mons. Montezemolo. Zio di
secondo grado del più noto Luca Cordero. La cerimonia di iniziazione si celebra
in chiesa. All'interno dell'Ordine vi era Matacena Elio.
Virgiglio riferisce ancora che la struttura
massonica calabrese era molto ampia ed era composta da una parte visibile ed una
invisibile; che nel 2004/05 Franco Labate, medico di Reggio Calabria, si era
rivolto a Peppe Piromalli di creare un punto di contatto con Licio Gelli. Dalle
dichiarazioni del Virgiglio, che, come si è visto, oltre ad avere un comprovato
rapporto organico con la cosca Molè-Piromalli, era documentatamente, un massone
di lungo corso (produceva anche la sua lettera di dimissioni dalla Loggia
Garibaldini d'Italia del 2006 ) dunque, oltre ad essere lui stesso la prova
vivente della commistione fra le due militanze, quella massonica e quella
mafiosa, era la persona che più di qualsiasi altra, era in grado di riferire dei
rapporti fra le due entità, oltre confermare (sul solco di Di Bernardo, Lauro,
Barreca ed altri ancora) la commistione fra le due entità, specificava come
Gelli ed i suoi uomini avessero un ruolo attivo non solo nei contesti massonici
che operavano in Calabria, ma anche nei rapporti con le cosche e in particolare
quelle tirreniche dei Molè/Piromalli, di cui l'indagato Filippone sarebbe
l'elemento di collegamento.
Fiammetta Borsellino, massoneria e verità
negata sulla strage di Via D’Amelio. La “massoneria mafiosa di Stato” nelle
parole dei pentiti, scrive il 27 luglio 2017 Roberto
Galullo su "Il Sole 24 ore". Amati lettori di questo umile e umido blog,
continuo ad onorare la memoria del giudice Paolo Borsellino (e dunque anche del
suo collega di vita e di morte Giovanni Falcone, unitamente alle loro scorte)
con una nuova analisi. Anche quella odierna (così come quella di ieri e quella
di domani) trae spunto dalle dichiarazioni, rese per il venticinquennale della
strage di via D’Amelio, da Fiammetta Borsellino, figlia del giudice, secondo la
quale, come ha dichiarato al giornalista del Corriere della Sera Felice
Cavallaro, «questo abbiamo avuto: un balordo della Guadagna (Vincenzo
Scarantino, ndr) come pentito fasullo e una Procura massonica guidata all’epoca
da Gianni Tinebra che è morto, ma dove c’erano Annamaria Palma, Carmelo
Petralia, Nino Di Matteo,altri…». Quel riferimento alla massoneria non era
casuale e ieri abbiamo visto come – nell’indagine “Sistemi criminali” della
Procura di Palermo poi archiviata il 21 marzo 2001 – il ruolo della massoneria
capitanata da Licio Gelli fosse stato ritenuto fondamentale nel tentativo di
stravolgere l’ordine democratico del Paese, far nascere una nuova forma di Stato
(anche attraverso la secessione). Un ruolo deviato che si cementava con la
strategia stragista dell’ala corleonese di Cosa nostra e (per altri e più
raffinati versi) della ‘ndrangheta. E vediamo, a questo punto che cosa dichiarò
alla Commissione Parlamentare antimafia il 4 dicembre 1992 il pentito di San
Cataldo (Caltanissetta, una provincia culla delle più raffinate strategie
massonico deviate) Leonardo Messina. Il pentito parlava della riunione dei
vertici di Cosa Nostra, svoltasi alla fine del 1991 nelle campagne di Enna, in
cui si sarebbe parlato del progetto eversivo. «Molti degli uomini d’onore – dirà
testualmente Messina – cioè quelli che riescono a diventare dei capi,
appartengono alla massoneria. Questo non deve sfuggire alla Commissione, perché
è nella massoneria che si possono avere i contatti totali con gli imprenditori,
con le istituzioni, con gli uomini che amministrano il potere diverso di quello
punitivo che ha Cosa nostra». Secondo Messina, il progetto, per finanziare il
quale sarebbe stata stanziata la somma di mille miliardi (di vecchie lire), fu
concepito dalla massoneria con l’appoggio di potenze straniere e coinvolgeva non
solo uomini della criminalità organizzata e della massoneria, ma anche esponenti
della politica, delle istituzioni e forze imprenditoriali.
Non so se è sufficientemente chiaro: delle
Istituzioni e tra queste, ovviamente anche la magistratura. O si deve pensare
che la magistratura (la quota marcia, ovviamente) fosse o sia ancora oggi
immune? Messina va avanti come un treno e allo stesso Scarpinato, il 3 giugno
1996, dirà ancora: «Il progetto era stato concepito dalla massoneria. A tal
riguardo, intendo chiarire che Cosa Nostra e la massoneria, o almeno una parte
della massoneria, sono stati sin dagli anni ’70 un’unica realtà criminale
integrata». E questo lo dice nel ’96 e non si riferisce certo solo al passato.
Vogliamo andare avanti con altre sponde che portano sempre alla stessa
direzione? Bene (si fa per dire). Dalle dichiarazioni del pentito
calabrese Pasquale Nucera è emersa una specifica conferma delle dichiarazioni
dell’altro pentito calabrese Filippo Barreca, ma anche di alcuni altri
collaboratori di giustizia palermitani (in particolare Gioacchino Pennino): al
più alto e ristretto livello della gerarchia della ‘ndrangheta appartengono
anche elementi della massoneria deviata e – ha aggiunto Nucera – anche dei
“servizi deviati”. Una commistione, che – sempre secondo le dichiarazioni
di Nucera – sarebbe conseguenza di una iniziativa di Licio Gelli che, per
controllare i vertici della ‘ndrangheta, aveva fatto in modo che ogni componente
della “santa”, ovvero la struttura di vertice dell’organizzazione criminale,
venisse inserito automaticamente nella massoneria deviata. Ma vorrei chiudere la
puntata odierna con un finale che racchiude il senso di quanto al momento
scritto e anticipa quanto scriverò domani: sapete Messina quando e con chi fece
cenno, per la prima volta, della riunione di Enna, seppur senza riferire del
progetto eversivo? Risposta: il 30 giugno 1992 al procuratore aggiunto di
Palermo Paolo Borsellino. Poteva quel sistema massonico deviato – infiltrato
ovunque, a partire dalle Istituzioni statali, magistratura, uffici giudiziari e
investigativi inclusi – lasciare in vita Paolo Borsellino? La risposta la
conoscete, come la conosce purtroppo Fiammetta e tutta la famiglia Borsellino. E
la risposta sta tutta nella “massoneria mafiosa di Stato” – come potremmo
definirla a posteriori – che all’epoca imperversava e continuò a farlo anche
negli anni successivi. Ma non crediate che le cose, oggi, siano migliorate.
Quei magistrati calabresi iscritti alla
massoneria. Tre dossier che scottano per un unico
filone investigativo. Al centro i rapporti inconfessabili tra 'ndrangheta,
politica e istituzioni all'ombra delle logge, scrive Paolo Pollichieni il 09
gennaio 2016 su ilVelino/AGV NEWS. Un filone investigativo che scotta quello che
si ritrovano in mano diversi magistrati calabresi: porta a rivisitare e
riattualizzare i rapporti tra l'élite della 'ndrangheta e pezzi importanti del
mondo massonico. Non bastasse, ecco ricomparire anche il nodo dell'appartenenza
alla massoneria, in maniera diretta o velata ("all'orecchio"), di magistrati con
ruoli particolarmente delicati dentro le strutture giudiziarie della Calabria e
non solo della Calabria. Singoli filoni che fin qui non hanno avuto una lettura
unitaria, tracce e piste seguite dalle inchieste condotte da Nicola Gratteri,
procuratore aggiunto della Dda reggina, da Giuseppe Lombardo, della stessa Dda
reggina, e da Pierpaolo Bruni, che invece lavora alla Dda di Catanzaro. Va
ribadito che affiliarsi alla massoneria non è reato, in quanto la massoneria non
è tra le "associazioni segrete" proibite dalla Costituzione italiana con
l'articolo 18 («Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere
militare»). Diverso è dimostrare che alcune logge massoniche, magari sfuggite al
controllo della fratellanza universale, fanno da punto di ritrovo per rapporti e
sinergie inconfessabili tra mafiosi, politici e rappresentanti delle
istituzioni. A questo lavorano le singole inchieste e su questo stanno tornando
a rendere dichiarazioni importanti faccendieri che hanno rappresentato la
cerniera tra nomine, affari, appalti e riciclaggio riconducibili al mondo
criminale. Ma quando ci si imbatte nel nome di magistrati affiliati alla
massoneria il discorso cambia, perché se pure non si può qualificare
l'affiliazione massonica come reato, c'è tuttavia quanto statuito dal Consiglio
superiore della magistratura che ha affermato con chiarezza «l'incompatibilità
fra affiliazione massonica e l'esercizio delle funzioni di magistrato», perché
le caratteristiche delle logge massoniche sono quelle di «un impegno solenne di
obbedienza, solidarietà, e soggezione a principi e a persone diverse dalla
legge» e determinano perciò «come conseguenza inevitabile una menomazione grave
dell'immagine e del prestigio del magistrato e dell'intero ordine giudiziario».
A dare manforte al Csm c'è anche una sentenza della Suprema corte: «Il giudice
massone può essere ricusato dall'imputato, in quanto l'appartenenza a logge
preclude "di per sé l'imparzialità" del magistrato» (la Cassazione, 5a sezione
penale numero 1563 / 98), in altre parole, perché – come ha detto il giudice
Alfonso Amatucci – «essere iscritti alla massoneria significa vincolarsi al bene
degli adepti, significa fare ad ogni costo un favore. E l'unico modo nel quale
un magistrato può fare un favore è piegandosi a interessi individuali
nell'emettere sentenze, ordinanze, avvisi di garanzia». Come regolarsi, dunque,
se nell'acquisizione di documenti o nella raccolta di deposizioni sotto
giuramento, arriva sul tavolo del magistrato inquirente il nome di un collega
indicato come affiliato alla massoneria? Se lo stanno chiedendo in queste ore
all'interno delle Procure calabresi più esposte sul fonte delle indagini sui
rapporti apicali tra 'ndrangheta, politica e affari. I dossier che scottano sono
sostanzialmente tre. Il primo trae origine dalle denunce incrociate tra il gran
maestro Gustavo Raffi e uno dei massimi esponenti storici della massoneria
calabrese, il gran maestro Amerigo Minnicelli. Quest'ultimo, in sostanza, ha
accusato pubblicamente il Grande Oriente di aver consentito una dilatazione
delle iscrizioni in Calabria al fine di condizionare l'esito dell'elezione del
nuovo gran maestro Stefano Bisi, giornalista e vicedirettore de Il Corriere di
Siena, scelto da Raffi e vittorioso grazie al fatto che attorno a lui si sono
schierate compatte le logge calabresi, forti di 2mila maestri votanti. I rivali
di Bisi non hanno apprezzato il sostegno plebiscitario di una regione, la
Calabria, che durante la gestione Raffi ha acquisito un peso elettorale e
politico pari a quello di Toscana e Piemonte, molto più popolate e di lunga
tradizione massonica, e molto superiore a regioni molto più estese come la
Sicilia o la Lombardia. Un contenzioso interno? Non più, dopo le feroci critiche
del fratello calabrese Amerigo Minnicelli, che ha denunciato brogli alle
elezioni precedenti ed è stato trascinato davanti al tribunale, prima massonico
poi ordinario. «Raffi ha ritenuto di ampliare la base», dice Minnicelli, «e
questo non è certo un delitto. Ma l'esplosione degli iscritti nella mia regione
fa riflettere. E l'operazione "Decollo money" che ha portato in carcere nel 2011
l'imprenditore Domenico Macrì, calabrese con residenza in Umbria e agganci in
banca a San Marino, amico personale di Raffi, lambisce la Gran maestranza».
Raffi ha risposto a modo suo. Ha sospeso Macrì ma ha espulso Minnicelli.
Illuminanti, invece, sono le parole di Pantaleone Mancuso (alias "Vetrinetta"),
mammasantissima del crimine calabrese, deceduto il 3 ottobre scorso, che ha
teorizzato la confluenza della 'ndrangheta nella massoneria. Una preziosa
intercettazione ambientale, infatti, ci consegna il boss mentre spiega che la
'ndrangheta «non esiste più», è roba da paese, la 'ndrangheta vera si è
trasferita all'interno della massoneria, anzi è «sotto la massoneria». Un poco
quanto va spiegando, e siamo al secondo filone investigativo, in queste ore ai
magistrati reggini un altro esponente di spicco della massoneria che ha ripreso
a collaborare con la magistratura. Spiega perché, negli anni, il potere in
Calabria si è concentrato sull'asse Reggio-Gioia Tauro-Vibo e nel farlo chiama
in causa anche magistrati che avrebbero agito a protezione del "sistema" ogni
qualvolta le inchieste si sono avvicinate pericolosamente a tale cabina di
comando criminale. Il terzo nasce dal materiale sequestrato dal pm Pierpaolo
Bruni in casa e nei locali che ospitano la loggia massonica fondata da Paolo
Coraci, originario di Messina e residente a Roma, ma con amicizie salde nel
Vibonese e nel Reggino, tra queste quelle con alcuni magistrati calabresi.
Dall'archivio del gran maestro Coraci sono saltate fuori anche le schede di
valutazione e i curricula di adepti da segnalare per l'ingresso nei consigli
d'amministrazione di 15 enti pubblici. Non solo, anche tre Questure sarebbero
state elevate al livello di dirigenza generale attraverso un intreccio di
interessi tra la loggia, un sacerdote ed esponenti politici. L'intervento della
loggia massonica avrebbe riguardato due Questure del sud Italia e una in una
regione del Centro. Secondo la Dda di Catanzaro, la loggia massonica fondata da
Coraci aveva interesse a creare un intricato sistema di potere che portava anche
alla nomina di consiglieri d'amministrazione in enti pubblici. C'è quanto basta
a mettere in fibrillazione più di un "palazzo", più di una "loggia" e più di una
"cosca", specialmente alla vigilia di una serie di scelte importanti che proprio
il Consiglio superiore della magistratura è chiamato a compiere per via del
turnover ai vertici di uffici giudiziari delicatissimi, quali ad esempio le
procure di Catanzaro e Cosenza.
Strage via D’Amelio, Rita Borsellino: “25
anni di giustizia negata”, scrive Sky tg24 il 19
luglio 2017. La sorella del magistrato ucciso dalla mafia parla ai microfoni di
Sky TG24 durante la cerimonia di commemorazione a Palermo: “In tanti sanno la
verità. Perché nelle istituzioni non parla nessuno?”. Il fratello Salvatore:
“Vogliamo sapere dov’è l’agenda di Paolo". “Parliamo di giustizia che non c’è,
di 25 anni di giustizia negata”. Rita Borsellino, sorella di Paolo, ha
partecipato alla cerimonia di commemorazione per i 25 anni dalla strage di via
D’Amelio, in cui il magistrato perse la vita insieme a 5 agenti della sua
scorta. Ai microfoni di Sky TG24 dice: “Vorremmo sapere perché è negata questa
giustizia? Chi non vuole che questa verità venga fuori? La verità c’è e la sanno
in tanti”. Rita Borsellino ha citato Fiammetta, figlia del magistrato ucciso
dalla mafia, che dopo anni di silenzio ha rilasciato un’intervista al Corriere
della Sera in cui ha parlato di “25 anni di schifezze e menzogne”. In una
recente commemorazione, ricorda Rita Borsellino, “Fiammetta, alla battuta di
Grasso che disse "ci dobbiamo aspettare un altro pentito" commentò "un pentito
lo vogliamo nelle istituzioni" e aveva ragione. Perché nelle istituzioni non
parla nessuno?”.
Alla cerimonia era presente anche Salvatore
Borsellino, fratello del magistrato. “C’era qualcuno in questa via che aspettava
l’esplosione. Qualcuno si è avvicinato alla macchina di Paolo, ha preso la borsa
e si è allontanato. Non sappiamo a chi l’abbia portata. Quando quella borsa è
stata rimessa nel sedile posteriore dell’auto, l’agenda non c’era più. Forse
speravano che la macchina prendesse fuoco e si perdesse anche il ricordo di
questa agenda. Ma non si è perso”. Salvatore Borsellino ha aggiunto a Sky TG24:
“Ci sono foto che mostrano un capitano dei carabinieri che si allontana con la
borsa. È stato assolto ma vogliamo sapere a chi ha portato quella borsa, chi ha
preso l’agenda e dove si trova oggi. Sui contenuti dell’agenda penso si reggano
i ricatti incrociati che legano il sistema di potere della seconda Repubblica,
che ha le fondamenta intrise di sangue”.
IL FATTO DEL GIORNO di Giorgio Dell'Arti 19 luglio
2017. Borsellino e la strage di via D’Amelio 25 anni fa. Stasera, alle nove e
mezza, Raiuno manda in onda Adesso tocca a me, fiction sul giudice Borsellino,
ammazzato dalla mafia il 19 luglio 1992, venticinque anni fa oggi. Raimovie a
sua volta mostra il film Era d’estate di Fiorella Infascelli. Si raccontano i 58
giorni che Falcone e Borsellino passarono, per ordine superiore, nel carcere
dell’Asinara, con le mogli e Borsellino anche con i tre figli. Era la vigilia
del maxi-processo e i due dovevano concludere le memorie e predisporre gli atti
relativi: 474 mafiosi si sarebbero trovati, tutti insieme, sul banco degli
imputati, 360 saranno condannati. Ai due giudici, dopo, lo Stato presentò il
conto: mezzo milione da rimborsare, per l’alloggio nel carcere e i pasti. Nel
film della Infascelli Borsellino è Beppe Fiorello. Nella fiction di Raiuno è
Cesare Bocci, il poliziotto-seduttore delle avventure del commissario
Montalbano.
Lei parla, come al solito, immaginando che
tutti sappiano chi sia Paolo Borsellino.
Si tratta di un giudice. Stando a Palermo,
indagava sulla mafia, insieme con Giovanni Falcone. Risultati notevolissimi, di
cui beneficiamo ancora oggi. Falcone, 53 anni, l’avevano ammazzato col tritolo
due mesi prima. Borsellino, nel luglio 1992, di anni ne aveva 52. Un uomo
distratto, imprudente, in qualche modo, specie dopo il fatto di Falcone,
rassegnato. Fumatore accanito (una sigaretta dietro l’altra). Durante la
settimana aveva tre appuntamenti fissi: il Palazzo di giustizia, la chiesa di
Santa Luisa di Marillac, la visita all’anziana madre. Gli avevano assegnato sei
agenti di scorta. Il 19 luglio era una domenica. Borsellino passò la mattinata
in casa di Giuseppe Tricoli, con la moglie Agnese e i due figli Manfredi e Lucia
(la terza figlia, Fiammetta, era in vacanza all’estero). A un certo punto prese
da parte questo amico suo Tricoli e gli disse: «Il tritolo per me è arrivato».
Nel pomeriggio, portandosi dietro i sei agenti di scorta, andò a trovare la
madre. La madre si chiamava Maria Lepanto e abitava in via D’Amelio. Ed ecco la
sequenza. Il giudice e i sei della scorta arrivano sul posto alle 16.55.
Borsellino scende dalla Croma, s’avvicina al portone, punta il dito sul
campanello e in quel momento esplode una Fiat 126 parcheggiata davanti al civico
21 e imbottita di 90 chili di tritolo. Il giudice è fatto a pezzi, il suo
collega Giuseppe Ayala, accorso sul posto, quasi inciamperà nel suo naso. Altri
raccontano d’averne riconosciuta la testa, di aver creduto di scorgere, sotto i
baffi, un leggero sorriso. L’esplosione gli aveva tranciato di netto braccia e
gambe.
La scorta?
Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Cosina,
Claudio Traina, Emanuela Loi. Era la prima volta che mettevano una donna a far
la scorta. Tutti morti. I vigili del fuoco si affrettarono a raccoglierne i
resti e a ficcarli nei secchi prima che arrivassero i cani randagi. Un sesto
agente, Antonino Vullo, stava manovrando una delle macchine che seguivano il
magistrato e la scampò. Stasera, nella fiction su Raiuno, lo sentiremo dire: «Si
capisce che non ci fu solo la mafia all’interno della strage di via D’Amelio.
Sicuramente ci vorrebbe un pentito di stato per andare avanti con le indagini e
arrivare alla verità».
Non ci sono state le indagini? Non c’è stato un
processo?
Quattro processi, se è per questo. I primi tre
determinati da un pentito fasullo, di nome Vincenzo Scarantino. Accusati da
Scarantino, undici morti di fame si sono fatti un sacco d’anni di galera. Poi
saltò fuori un altro pentito, di nome Gaspare Spatuzza, che accusò se stesso
della strage, mentre il vecchio falso pentito confermava che era proprio così,
l’assassino vero era Spatuzza. I mandanti sarebbero stati i fratelli Graviano,
su mandato di Berlusconi e Dell’Utri. Di questa tesi gli inquirenti di Palermo
si sono innamorati, facendone il perno della teoria relativa alla
trattativa-stato mafia.
Come sempre, nelle storie italiane, superato il
racconto della pura cronaca, si entra nella città dei misteri.
Lo so. La tesi, mai dimostrata, è la seguente: la
mafia stava trattando con lo Stato perché il vecchio regime democristiano era
crollato e bisognava intendersi con i nuovi padroni, cioè con il ceto politico
di Berlusconi (che però, nel 1992, non era ancora sceso in campo). Falcone,
Borsellino e le stragi del 1993 servivano a convincere la controparte. I
politici, a trattare, ci stavano. Senonché Borsellino si mise di traverso: con i
criminali, diceva, non si deve trattare. Per questo Totò Riina incaricò i due
Graviano di sistemare la cosa e mettere il tritolo in via D’Amelio.
Un anticipazione dei verbali di Paolo
Borsellino al Csm: “Stanno smantellando il pool antimafia”,
scrive il 19 luglio 2017 “Il Corriere del Giorno”. L’audizione desecretata per
la prima volta dal Consiglio Superiore della magistratura a 25 anni dalle
stragi. Sono parole pesanti quelle che Paolo Borsellino pronunciò il 31 luglio
del 1988 davanti al Comitato antimafia del Consiglio Superiore della
Magistratura per spiegare alcune sue dichiarazioni, che aveva rilasciate
precedentemente in un evento pubblico e due interviste. “Ho senza esitazione
parlato di segnali di smobilitazione del pool antimafia, nè temo mi si possa
rispondere che il pool è stato anzi arricchito di nuovi elementi, poichè non si
arricchisce certo un pool, se la sua essenza rettamente si intende, aumentando
il numero dei suoi magistrati senza gli opportuni criteri di scelta e
contemporaneamente disattendendo le ragioni stesse della creazione di tale
organismo”. Il giudice Borsellino come emerge dall’audizione disponibile
integralmente per la prima volta, dopo la desecretazione degli atti disposta da
Palazzo dei Marescialli in occasione del 25esimo anniversario della strage di
via D’Amelio, in cui Borsellino e la sua scorta vennero uccisi dalla mafia, così
definiva il pool antimafia di Palermo, di cui aveva fatto parte prima di essere
nominato procuratore capo a Marsala: “allo stato rappresenta l’unico organismo
di indagine ancora efficace in materia di criminalità mafiosa, stante la carenza
indubitabile delle forze di Polizia“. Ecco un’anticipazione degli atti:
Borsellino accese i riflettori sul fatto che “quando un pool sostanzialmente non
è messo in condizione di rispondere alla sua attività, a quelle che sono le
ragioni fondamentali della sua esistenza, difficili da cogliere se maturate in
lunghi anni di funzionamento, e sostanzialmente è ridotto soltanto a un numero
di tre, quattro, cinque magistrati che lavorano assieme, non è più un pool”. Al
termine dell’audizione durata 4 ore Paolo Borsellino disse che all’interno
dell’Ufficio Istruzione “c’è una persona che di entusiasmo ne sa vendere a tutti
e in tutti i modi e, pertanto, io sono rimasto sinceramente preoccupato nel
momento in cui l’entusiasmo gliel’ho visto perdere. Mi riferisco a Giovanni
Falcone”. L’audizione di Borsellino dinnanzi al CSM avvenne qualche mese dopo la
nomina di Antonino Meli come consigliere istruttore a Palermo, che venne
preferito a Giovanni Falcone, prendendo di fatto il posto e ruolo che era stato
di Antonino Caponnetto. “Non ho riferito le confidenze dei colleghi –
spiegò Borsellino in merito alle preoccupazioni che aveva espresso sullo
‘smantellamento’ del pool – ma mi sono formato una convinzione sulla base di
colloqui con persone con cui ho lavorato a lungo, con le quali ho un’intesa
perfetta, su quella che era la situazione”. Ed aggiunse: “ho quindi riferito
questa situazione che mi sembra fosse importantissimo riferire”, affermò il
giudice nella sua audizione, perchè “o parliamo per enigmi o per allusioni e
diciamo che c’è una caduta di tensione o che manca la volontà politica e la
gente non capisce bene che cosa significa, oppure se questi problemi li dobbiamo
affrontare concretamente dobbiamo citare fatti e mettere il coltello nella piaga
e dire: ‘c’è un organismo centrale nelle indagini antimafia che in questo
momento non funziona più“.
Borsellino, lo sfogo della figlia: i suoi
colleghi non ci frequentano. Stavolta il suo 19 luglio
non lo passa a Pantelleria, lontana dai riflettori, per ricordare il padre con
una messa solitaria nella chiesetta di contrada Khamma. Perché Fiammetta
Borsellino, dopo due clamorosi passaggi tv e Internet con Fabio Fazio e Sandro
Ruotolo, si prepara oggi a una audizione in Commissione antimafia, a Palermo.
Per tuonare contro «questi 25 anni di schifezze e menzogne».
Cosa dirà alla commissione presieduta da Rosi
Bindi?
«Più che dire consegnerò inconfutabili atti
processuali dai quali si evincono le manovre per occultare la verità sulla trama
di via D’Amelio», spiega la più piccola dei tre figli del giudice Borsellino, 44
anni.
Si riferisce ai quattro processi di
Caltanissetta?
«Questo abbiamo avuto: un balordo della Guadagna
come pentito fasullo e una Procura massonica guidata all’epoca da Gianni Tinebra
che è morto, ma dove c’erano Annamaria Palma, Carmelo Petralia, Nino Di Matteo,
altri…».
Sottovalutazione generale?
«Chiamarla così è un complimento. Mio padre fu
lasciato solo in vita e dopo. Dovrebbe essere l’intero Paese a sentire il
bisogno di una restituzione della verità. Ma sembra un Paese che preferisce
nascondere verità inconfessabili».
Di Matteo, il pm della «trattativa», era
giovane allora.
«So che dal 1994 c’è stato pure lui, insieme a
quell’efficientissimo team di magistrati. Io non so se era alle prime armi. E
comunque mio padre non si meritava giudici alle prime armi, che sia chiaro».
Che cosa rimprovera?
«Ai magistrati in servizio al momento della strage
di Capaci di non avere mai sentito mio padre, nonostante avesse detto di volere
parlare con loro».
E poi?
«Dopo via D’Amelio, riconsegnata dal questore La
Barbera la borsa di mio padre pur senza l’agenda rossa, non hanno nemmeno
disposto l’esame del Dna. Non furono adottate le più elementari procedure sulla
scena del crimine. Il dovere di chi investigava era di non alterare i luoghi del
delitto. Ma su via D’Amelio passò la mandria dei bufali».
Che idea si è fatta della trama sfociata nella
strage?
«A mio padre stavano a cuore i legami tra mafia,
appalti e potere economico. Questa delega gli fu negata dal suo capo, Piero
Giammanco, che decise di assegnargliela con una strana telefonata alle 7 del
mattino di quel 19 luglio. Ma pm e investigatori non hanno mai assunto come
testimone Giammanco, colui che ha omesso di informare mio padre sull’arrivo del
tritolo a Palermo…».
Giammanco o altri si sono fatti vivi con voi?
«Nessuno si fa vivo con noi. Non ci frequenta più
nessuno. Né un magistrato. Né un poliziotto. Si sono dileguati tutti. Le persone
oggi a noi vicine le abbiamo incontrate dopo il ’92. Nessuno di quelli che si
professavano amici ha ritenuto di darci spiegazioni anche dal punto di vista
morale».
Compresi i magistrati?
«Nessuno. E con la morte di mia madre, dopo che
hanno finito di controllarci, questo deserto è più evidente».
Ha suscitato grande emozione il suo intervento
la sera del 23 maggio durante la diretta di Fabio Fazio.
«Dopo la mia esternazione non c’è stato un cane
che mi abbia stretto la mano. Fatta eccezione per alcuni studenti napoletani e
Antonio Vullo, l’agente sopravvissuto in via D’Amelio. Grande la sensibilità di
Fazio. Ma nelle due ore successive mi sono seduta e ho ascoltato. Non sono
Grasso che arriva, fa l’intervento e va. C’erano giornalisti, uomini delle
istituzioni, intellettuali palermitani. Da nessuno una parola di conforto». Di
Felice Cavallaro Fonte Corriere della Sera Palermo, 19 luglio 2017
Borsellino, ecco perché ci vergogniamo.
Ventiquattro anni dopo la strage il processo sta facendo emergere molti punti
oscuri che riguardano investigatori e uomini delle istituzioni che non avrebbero
fatto bene il proprio dovere e molti di loro, chiamati a testimoniare, hanno
ripetuto ai giudici di non ricordare, scrive Lirio Abbate il 18 luglio 2016 su
"L'Espresso". Siamo arrivati a 24 anni dalla strage di via D'Amelio alla
celebrazione del quarto processo per esecutori e depistatori, dopo aver avuto
quello per i mandanti ed organizzatori di questo attentato avvenuto il 19 luglio
1992, in cui sono stati uccisi il procuratore aggiunto di Palermo, Paolo
Borsellino e gli agenti di polizia Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li
Muli. Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. La verità però ancora non emerge su
molti aspetti di questa strage. Non emergono i motivi dei depistaggi, i motivi
che hanno spinto piccoli pregiudicati a diventare falsi collaboratori di
giustizia, perché ci sarebbero stati "suggerimenti" investigativi che hanno
spostato l'asse delle indagini lontano da quelle reali. Sono interrogativi a cui
si deve dare ancora una risposta, ma che hanno portato nei giorni scorsi Lucia
Borsellino, figlia del magistrato ucciso, a sostenere davanti alla Commissione
antimafia presieduta da Rosi Bindi che "quello che sta emergendo in questa fase
processuale (è in corso a Caltanissetta il quarto procedimento sulla
strage, ndr) ci si deve interrogare sul fatto se veramente ci si possa fidare in
toto delle istituzioni". Parole pesanti, che sembrano essere scivolate nel
silenzio mediatico e politico. Il processo sta facendo emergere molti punti
oscuri che riguardano investigatori e uomini delle istituzioni che non avrebbero
fatto bene il proprio dovere e molti di loro, chiamati a testimoniare, hanno
ripetuto ai giudici di non ricordare. "Il semplice sospetto che uomini dello
Stato abbiamo potuto tradire un altro uomo dello Stato e lo dico da figlia, mi
fa vergognare", ha detto Lucia Borsellino ai commissari antimafia, ai quali ha
precisato: «Nel caso della strage che ha tolto la vita a mio padre e agli uomini
della scorta non è stato fatto ciò che era giusto si facesse, se siamo arrivati
a questo punto vuol dire che qualcosa non è andata. Ci sono vicende che gridano
vendetta anche se il termine non mi piace». Per poi concludere: «Mi auguro
questa fase processuale tenti di fare chiarezza sull’accaduto, pensare ci si
possa affidare ancora a ricordi di un figlio o una figlia che lottavano per
ottenere un diploma di laurea è un po’ crudele, anche perché papà non riferiva a
due giovani quello che stava vivendo. Non sapevo determinati fatti, è una
dolenza che vivo anche da figlia e una difficoltà all’elaborazione del lutto».
Oggi le indagini della procura di Caltanissetta hanno svelato che a premere il
pulsante che ha fatto esplodere l'auto carica di esplosivo è stato Giuseppe
Graviano, ma non si conosce il motivo che ha portato ad accelerare la strage. Si
è scoperto che nei 57 giorni che separano gli attentati di Capaci e via d'Amelio
uomini delle istituzioni hanno parlato con i mafiosi, ma non si sa a cosa abbia
portato questo "dialogo". Si è scoperto che le indagini dopo l'attentato del 19
luglio 1992 sono state depistate, ma non è stato individuato il movente. Nemmeno
quello che ha portato tre pregiudicati a raccontare bugie ai giudici, ad
autoaccusarsi della strage e rischiare il carcere a vita, a diventare falsi
collaboratori di giustizia. I magistrati, grazie alla collaborazione di Gaspare
Spatuzza (senza le cui dichiarazioni, riscontrate in tutti i punti, non sarebbe
stato possibile avviare la nuova inchiesta dopo le sentenze definitive sulla
strage) e Fabio Tranchina, un fedelissimo di Graviano, sono riusciti a trovare
alcune tessere del mosaico che dal '92 avevano impedito di ricostruire la trama
dell'attentato. Un attentato che a 24 anni di distanza ci continua a far star
male, come dice Lucia Borsellino, "per il semplice sospetto che uomini dello
Stato abbiamo potuto tradire un altro uomo dello Stato" e questo ci fa
vergognare.
«Darei un premio speciale a Silvio Berlusconi e al
suo governo per la lotta alla mafia. Ha introdotto delle leggi che ci hanno
consentito di sequestrare in tre anni moltissimi beni ai mafiosi. Siamo arrivati
a quaranta miliardi di euro». Lo dice il procuratore nazionale antimafia Pietro
Grasso alla Zanzara su Radio 24 del 12 maggio 2012. «Poi su altre cose che
avevamo chiesto, norme anticorruzione, antiriciclaggio, stiamo ancora
aspettando». Ma chi voterà come sindaco di Palermo? «Un magistrato - dice Grasso
A Radio 24 - non deve far conoscere le sue preferenze politiche. Al primo turno
delle comunali mia moglie mi ha chiesto per chi avessi votato e io le ho
risposto: non te lo dico. Si è pure arrabbiata». Poi Grasso critica il pm
Antonio Ingroia: «Fa politica utilizzando la sua funzione, è sbagliato. Come ha
sbagliato ad andare a parlare dal palco di un congresso di partito (comunisti
italiani). Deve scegliere. E per me è tagliatissimo per fare politica».
Un'intervista, quella al procuratore nazionale antimafia, che alcuni hanno letto
come il preludio di un suo impegno diretto in politica. Ma la reazione dei
magistrati di sinistra, (come quella di Marco Travaglio che li osanna) che sono
poi quelli che detengono le redini della magistratura, o comunque che fanno più
rumore, non si fanno attendere. Per Magistratura Democratica sono 'sconcertanti'
le parole del Procuratore Nazionale Antimafia Pietro Grasso sulla politica del
governo Berlusconi in tema di lotta alla mafia. «Sui sequestri -dice Piergiorgio
Morosini, segretario generale di Magistratura Democratica- ci sono leggi
collaudate già da qualche decennio e gli esiti positivi degli ultimi anni, in
materia di aggressione ai patrimoni mafiosi, sono dipesi dallo spirito di
abnegazione e dalla capacità professionale delle forze dell'ordine e della
magistratura. Dobbiamo ricordarci, in proposito, che la denigrazione sistematica
del lavoro dei magistrati non può essere certo annoverata tra le azioni
favorevoli alla lotta alla mafia. Il Codice Antimafia, poi, varato nel biennio
2010-2011, a detta di esperti, a livello accademico e giudiziario, brilla per
inadeguatezze e lacune. Inoltre -continua- il governo Berlusconi non ha fatto
nulla in tema di evasione fiscale e lotta alla corruzione che sono i terreni su
cui attualmente si stanno rafforzando ed espandendo i clan. Per non parlare
delle leggi che hanno agevolato il rientro in Italia di capitali mafiosi
nascosti all'estero e della mancata introduzione di norme in grado di colpire le
alleanze nell'ombra tra politici e boss. Si aggiunga che non c'è stata nessuna
novità in tema di lotta al riciclaggio e ci sono stati reiterati tentativi per
indebolire il decisivo strumento investigativo delle intercettazioni. In altri
termini -conclude Morosini- la politica antimafia del centrodestra ricorda
piuttosto il titolo di un noto brano del cantautore emiliano Ligabue “Tra palco
e realtà”: tanti proclami e poca sostanza». «Grasso non fa che affermare una
evidente verità. È stato tutto il centrodestra a condurre una rigorosa e seria
azione legislativa e politica antimafia che la sinistra non si è mai sognata di
realizzare - ha commentato il presidente dei senatori del Pdl, Maurizio Gasparri
- Voglio ricordare che abbiamo rafforzato il 41bis garantendo l’applicazione del
carcere duro in maniera ampia, a differenza di quanto fecero Mancino, Scalfaro,
Ciampi e Amato che arresero lo Stato alla mafia - ha proseguito Gasparri -. E
vedere poi Giuliano Amato, sotto il cui regno il 41bis veniva cancellato.
Riina in carcere ordina l'attentato a Di
Matteo. "Deve succedere un manicomio...",
scrive “La Repubblica”. I colloqui del "Capo dei capi" con il boss della Sacra
corona unita Alberto Lorusso: "Perché questo Di Matteo non se ne va, gli hanno
rinforzato la scorta, e allora se fosse possibile ucciderlo, un'esecuzione come
a quel tempo a Palermo, con i militari". "Berlusconi perché si è andato a
prendere lo stalliere?" Ecco le intercettazioni.
Parla il boss: "Io, il mio dovere l'ho fatto. Ma
continuate, continuate... qualcuno, non dico magari tutti, ma qualcuno,
divertitevi...". Divertirsi per Totò Riina significa fare stragi. E uccidere i
magistrati che indagano su di lui nell'inchiesta sulla trattativa fra Stato e
mafia. Divertirsi per lui significa anche far fuori "tutte le paperelle " che
stanno intorno ai giudici, gli agenti delle scorte. "Qua qua qua", ripete il
capo dei capi di Cosa nostra mentre passeggia all'ora d'aria in un camminatoio
del carcere milanese di Opera con un compagno detenuto, Alberto Lorusso,
ufficialmente solo un affiliato alla Sacra Corona Unita, in realtà un
personaggio forse legato agli apparati polizieschi. Gli dice Riina: "Deve
succedere un manicomio, deve succedere per forza, se io restavo sempre fuori, io
continuavo a fare un macello, continuavo al massimo livello". Gli ribatte
Lorusso: "Noi abbiamo un arsenale". Noi chi? È quello che stanno cercando di
scoprire in Sicilia. Queste sono le prime intercettazioni del boss sulle minacce
ai pm di Palermo, depositate agli atti del processo sulla trattativa.
SERVE UN'ESECUZIONE. Il 16 novembre 2013, alle ore
9.30, Totò Riina ordina l'eliminazione del pubblico ministero Nino Di Matteo
"che deve fare la fine dei tonni". Intima: "E allora organizziamola questa
cosa... Facciamola grossa e non ne parliamo più". Una telecamera nascosta
riprende il boss mentre esce la mano sinistra dal cappotto e mima il gesto di
fare in fretta. Aggiunge: "Perché questo Di Matteo non se ne va, gli hanno
rinforzato la scorta, e allora se fosse possibile ucciderlo, un'esecuzione come
a quel tempo a Palermo, con i militari". Riina ha un odio viscerale contro
questo pubblico ministero, che con i suoi colleghi (Del Bene, Tartaglia e
Teresi), sta scavando dentro i misteri della trattativa: "Vedi, vedi... si mette
là davanti, mi guarda con gli occhi puntati ma a me non mi intimorisce, mi sta
facendo uscire pazzo... come ti verrei ad ammazzare a te, come a prendere tonni.
Ti farei diventare il primo tonno, il tonno buono. Ancora ci insisti?
Minchia...perché me lo sono tolto il vizio? Me lo toglierei il vizio? Inizierei
domani mattina".
LA TRATTATIVA E LO STATO. Il capomafia di Corleone
- che non ha mai perso un'udienza del processo per la trattativa - sembra
furioso per come l'hanno trascinato nell'inchiesta sui patti fra lo Stato e Cosa
nostra a cavallo delle stragi del 1992. E ancora una volta la sua ira si scatena
contro il pm palermitano: "Questo Di Matteo, questo disonorato, questo prende
pure il presidente della Repubblica... Questo prende un gioco sporco che gli
costerà caro, perché sta facendo carriera su questo processo di trattativa... Se
gli va male questo processo lui viene emarginato ". E prevede: "Io penso che lui
la pagherà pure... lo sapete come gli finisce a questo la carriera? Come
gliel'hanno fatta finire a quello palermitano, a quello... Scaglione (il
procuratore ucciso a Palermo nel 1970 ndr), a questo gli finisce lo stesso". Poi
Lorusso lo informa di quanto ha sentito in televisione: "Dicevano che il
presidente della Repubblica non deve andare a testimoniare, ci sono un sacco di
politici, partiti, che dicono che non deve andare a testimoniare". Gli risponde
Riina: "Fanno bene, fanno bene…ci danno una mazzata... ci vuole una mazzata
nella corna a quelli di Palermo". Lorusso incalza: "Sono tutti con Napolitano,
lui è il Presidente della Repubblica e non ci deve andare". Riina azzarda: "Io
penso che qualcosa si è rotto...".
SILVIO E I GRAVIANO. Il 6 agosto, Riina chiede a
Lorusso cosa dicono i telegiornali di quel "buffone" di Berlusconi. Il boss
pugliese risponde che a Roma "stanno vedendo come fare per salvarlo ". E a
questo punto Riina si lancia in un'altra delle sue invettive: "Noi su Berlusconi
abbiamo un diritto: sapete quando? Quando siamo fuori lo ammazziamo". E subito
dopo: "Non lo ammazziamo però perché noi stessi non abbiamo il coraggio di
prenderci il diritto". Il 25 ottobre il boss di Corleone ritorna a parlare del
Cavaliere. E anche dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, i boss di
Brancaccio sospettati di avere avuto molti contatti economici con
l'imprenditoria di Milano. Di loro dice: "Avevano Berlusconi... certe volte...".
Segue un'altra parola, incomprensibile. Ma, adesso, Riina lascia intendere che
ha qualche riserva anche sui suoi fedelissimi di un tempo, i Graviano.
LE RISERVE SULL'EREDE. C'è grande fibrillazione al
vertice di Cosa nostra. Non sono soltanto i Graviano a preoccupare Riina. A lui
non piace neanche la strategia del superlatitante Matteo Messina Denaro: "A me
dispiace dirlo, questo signor Messina Denaro, questo che fa il latitante, questo
si sente di comandare, ma non si interessa di noi". È davvero un giudizio duro.
"Questo fa i pali della luce - aggiunge, riferendosi al business dell'energia
eolica in cui Messina Denaro è coinvolto - ci farebbe più figura se se la
mettesse in culo la luce". E lo accusa di interessarsi solo ai suoi affari. "Fa
pali per prendere soldi", dice.
CAPACI E VIA D'AMELIO. "Loro pensavano che io ero
un analfabeticchio, così la cosa è stata dolorante, veramente fu tremenda,
quanto non se lo immaginavano". Sono le parole con le quali Totò Riina rievoca i
giorni della strage di Capaci. "Abbiamo cominciato a sorvegliare, andare e
venire da lì, dall'aeroporto... siamo andati a Roma, non ci andava nessuno, non
è a Palermo...fammi sapere quando può arrivare in questi giorni qua. Andammo a
tentoni, fammi sapere quando prende l'aereo ". Ma resta un discorso a metà. Da
chi i mafiosi dovevano sapere dell'arrivo di Falcone a Palermo? Lo stesso
mistero resta nei discorsi che Riina fa sulla strage Borsellino: "Cinquantasette
giorni dopo, minchia, la notizia l'hanno trovata là dentro... l'hanno sentita
dire... domenica deve andare da sua madre, deve venire da sua madre... gli ho
detto... ah sì, allora preparati, aspettiamolo lì". Chi aveva comunicato ai
mafiosi che Borsellino sarebbe andato da sua madre domenica pomeriggio? Riina fa
riferimento a "quello della luce... anche perché ... sistemati, devono essere
tutte le cose pronte, tutte, tutte, logicamente si sono fatti trovare pronti.
Gli ho detto: "Se serve mettigli qualche cento chili in più...". E dopo la
strage del 19 luglio, il mistero della scomparsa dell'agenda rossa di Paolo
Borsellino. "Si fottono l'agenda, si fottono l'agenda". Ma chi? Anche questo
resta un mistero.
IL PAPA E LA GRAZIA. "Non gliene capiteranno più
di nemici, così, come me. Gliene è capitato uno e gli è bastato, se ne devono
ricordare per sempre... gli ho fatto ballare la samba", dice Riina parlando di
se stesso. Poi, scherza: "Io cerco la grazia, ma chi me la deve dare la grazia?
Come me la devono dare? Minchia loro non sanno, non sanno, ma il Signore gliela
paga, gliela ripaga pure a loro". E alla fine cita il Pontefice "Questo è buono,
questo papa è troppo bravo ".
LA MAIL SEGRETA. Totò Riina e Alberto Lorusso sono
a conoscenza di una mail girata riservatamente sui pc di tutti i procuratori di
Palermo. Ne fanno cenno, ricordando che i magistrati - qualche mese fa -
volevano arrivare tutti in aula al processo sulla trattativa per solidarietà con
Nino Di Matteo. Notizia segretissima. Eppure Totò Riina e il suo amico Lorusso,
tutti e due al 41 bis, la conoscevano.
I GUAI DI BERLUSCONI. In una conversazione
avvenuta il 20 settembre 2013, i due parlano dei "guai" dell'ex premier. Non si
sa se guai giudiziari o di carattere politico. Rispondendo alle parole di
Alberto Lorusso, che lo aggiorna sulle ultime notizie su Berlusconi, il
capomafia di Corleone scuote la testa e dice: "Se lo merita, se lo merita. Gli
direi io “ma perchè ti sei andato a prendere lo stalliere? Perchè te lo sei
messo dentro?”. Secondo gli investigatori, Riina fa riferimento a Vittorio
Mangano, lo stalliere di Arcore, condannato per mafia, morto qualche anno fa.
Sempre parlando di Mangano, Riina in quella stessa conversazione, parte della
quale omissata dai magistrati della Dda, aggiunge poi: "Era un bravo picciotto
(uomo ndr.) mischino (poverino ndr), poi si è ammalato ed è morto".
IL FATTO DEL GIORNO di Giorgio Dell'Arti 19 luglio
2017. Borsellino e la strage di via D’Amelio 25 anni fa. Stasera, alle nove e
mezza, Raiuno manda in onda Adesso tocca a me, fiction sul giudice Borsellino,
ammazzato dalla mafia il 19 luglio 1992, venticinque anni fa oggi. Raimovie a
sua volta mostra il film Era d’estate di Fiorella Infascelli. Si raccontano i 58
giorni che Falcone e Borsellino passarono, per ordine superiore, nel carcere
dell’Asinara, con le mogli e Borsellino anche con i tre figli. Era la vigilia
del maxi-processo e i due dovevano concludere le memorie e predisporre gli atti
relativi: 474 mafiosi si sarebbero trovati, tutti insieme, sul banco degli
imputati, 360 saranno condannati. Ai due giudici, dopo, lo Stato presentò il
conto: mezzo milione da rimborsare, per l’alloggio nel carcere e i pasti. Nel
film della Infascelli Borsellino è Beppe Fiorello. Nella fiction di Raiuno è
Cesare Bocci, il poliziotto-seduttore delle avventure del commissario
Montalbano.
Lei parla, come al solito, immaginando che tutti
sappiano chi sia Paolo Borsellino.
Si tratta di un giudice. Stando a Palermo,
indagava sulla mafia, insieme con Giovanni Falcone. Risultati notevolissimi, di
cui beneficiamo ancora oggi. Falcone, 53 anni, l’avevano ammazzato col tritolo
due mesi prima. Borsellino, nel luglio 1992, di anni ne aveva 52. Un uomo
distratto, imprudente, in qualche modo, specie dopo il fatto di Falcone,
rassegnato. Fumatore accanito (una sigaretta dietro l’altra). Durante la
settimana aveva tre appuntamenti fissi: il Palazzo di giustizia, la chiesa di
Santa Luisa di Marillac, la visita all’anziana madre. Gli avevano assegnato sei
agenti di scorta. Il 19 luglio era una domenica. Borsellino passò la mattinata
in casa di Giuseppe Tricoli, con la moglie Agnese e i due figli Manfredi e Lucia
(la terza figlia, Fiammetta, era in vacanza all’estero). A un certo punto prese
da parte questo amico suo Tricoli e gli disse: «Il tritolo per me è arrivato».
Nel pomeriggio, portandosi dietro i sei agenti di scorta, andò a trovare la
madre. La madre si chiamava Maria Lepanto e abitava in via D’Amelio. Ed ecco la
sequenza. Il giudice e i sei della scorta arrivano sul posto alle 16.55.
Borsellino scende dalla Croma, s’avvicina al portone, punta il dito sul
campanello e in quel momento esplode una Fiat 126 parcheggiata davanti al civico
21 e imbottita di 90 chili di tritolo. Il giudice è fatto a pezzi, il suo
collega Giuseppe Ayala, accorso sul posto, quasi inciamperà nel suo naso. Altri
raccontano d’averne riconosciuta la testa, di aver creduto di scorgere, sotto i
baffi, un leggero sorriso. L’esplosione gli aveva tranciato di netto braccia e
gambe.
La scorta?
Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Cosina,
Claudio Traina, Emanuela Loi. Era la prima volta che mettevano una donna a far
la scorta. Tutti morti. I vigili del fuoco si affrettarono a raccoglierne i
resti e a ficcarli nei secchi prima che arrivassero i cani randagi. Un sesto
agente, Antonino Vullo, stava manovrando una delle macchine che seguivano il
magistrato e la scampò. Stasera, nella fiction su Raiuno, lo sentiremo dire: «Si
capisce che non ci fu solo la mafia all’interno della strage di via D’Amelio.
Sicuramente ci vorrebbe un pentito di stato per andare avanti con le indagini e
arrivare alla verità».
Non ci sono state le indagini? Non c’è stato un
processo?
Quattro processi, se è per questo. I primi tre
determinati da un pentito fasullo, di nome Vincenzo Scarantino. Accusati da
Scarantino, undici morti di fame si sono fatti un sacco d’anni di galera. Poi
saltò fuori un altro pentito, di nome Gaspare Spatuzza, che accusò se stesso
della strage, mentre il vecchio falso pentito confermava che era proprio così,
l’assassino vero era Spatuzza. I mandanti sarebbero stati i fratelli Graviano,
su mandato di Berlusconi e Dell’Utri. Di questa tesi gli inquirenti di Palermo
si sono innamorati, facendone il perno della teoria relativa alla
trattativa-stato mafia.
Come sempre, nelle storie italiane, superato il
racconto della pura cronaca, si entra nella città dei misteri.
Lo so. La tesi, mai dimostrata, è la seguente: la
mafia stava trattando con lo Stato perché il vecchio regime democristiano era
crollato e bisognava intendersi con i nuovi padroni, cioè con il ceto politico
di Berlusconi (che però, nel 1992, non era ancora sceso in campo). Falcone,
Borsellino e le stragi del 1993 servivano a convincere la controparte. I
politici, a trattare, ci stavano. Senonché Borsellino si mise di traverso: con i
criminali, diceva, non si deve trattare. Per questo Totò Riina incaricò i due
Graviano di sistemare la cosa e mettere il tritolo in via D’Amelio.
Graviano intercettato: adesso Firenze e
Caltanissetta valutano se riaprire le indagini su Berlusconi per le stragi.
Nei mesi scorsi i due uffici inquirenti, titolari
delle inchieste sugli eccidi del 1992 e 1993, hanno partecipato a una serie di
riunioni di coordinamento convocate dalla Direzione nazionale Antimafia. I pm
della procura di Palermo, infatti, gli hanno girato le intercettazioni del boss
di Brancaccio in carcere. Cinquemila pagine di registrazioni in cui il padrino -
secondo gli investigatori - assegna all'ex premier il ruolo di ispiratore delle
bombe del primi anni '90: accusa per la quale è già stato indagato e archiviato,
scrive Giuseppe Pipitone il 9 giugno 2017 su "Il Fatto Quotidiano". Adesso
bisognerà vedere se la procura di Firenze o quella di Caltanissetta decideranno
di riaprire le indagini su Silvio Berlusconi. Nei mesi scorsi i due uffici
inquirenti, titolari delle inchieste sulle stragi del 1992 e 1993, hanno
partecipato a una serie di riunioni di coordinamento convocate dalla Direzione
nazionale Antimafia.
Alfa e Beta, Autore 1 e Autore 2 – Attraverso la
coordinazione della Dna, infatti, il procuratore aggiunto di Palermo Vittorio
Teresi e i sostituti Nino Di Matteo, Roberto Del Bene e Roberto Tartaglia, hanno
girato ai pm fiorentini e nisseni le intercettazioni dei colloqui tenuti in
carcere dal boss Giuseppe Graviano, iscritto nel registro degli indagati per
violenza o minaccia ad un corpo politico dello Stato nel fascicolo stralcio
dell’inchiesta sulla Trattativa. Più di cinquemila pagine di conversazione,
tutte registrate tra il 19 gennaio 2016 e il 29 marzo del 2017 in cui il mafioso
di Brancaccio si confida con il camorrista Umberto Adinolfi. Quindici mesi in
cui i due malavitosi parlano di tutto, dal calcio alla politica, ma è quando
Graviano apre bocca che gli investigatori della Dia sottolineano in grassetto i
brogliacci riepilogativi. Sì, perché il boss condannato per le stragi del 1992 e
1993 tira in ballo spesso proprio il nome di Berlusconi. Tra il 1996 e il
1998 l’ex premier e il suo braccio destro, Marcello Dell’Utri – sotto gli
acronimi di Autore 1 e Autore 2 – sono stati indagati dalla procura di
Firenze per concorso nelle stragi del 1993 in via dei Georgofili, in via Fauro a
Roma e in via Palestro a Milano. Tra il 1998 e il 2002, invece, Berlusconi e
Dell’Utri vennero iscritti nel registro degli indagati della procura nissena –
indicati come Alfa e Beta – per concorso nella strage di via d’Amelio, dove il
19 luglio del 1992 vennero uccisi il giudice Paolo Borsellino e i cinque uomini
della sua scorta.
La cortesia con urgenza – Sulla base delle
intercettazioni di Graviano, dunque, i pm toscani e siciliani dovranno valutare
se chiedere al gip di riaprire o meno le indagini su Berlusconi. Secondo gli
investigatori palermitani nelle intercettazioni in carcere il boss di Brancaccio
assegna all’ex premier il ruolo di ispiratore delle stragi del 1992 e 1993. Gli
investigatori hanno puntato gli occhi soprattutto su una frase pronunciata dal
mafioso in carcere: “Berlusca mi ha chiesto questa cortesia. Per questo è stata
l’urgenza”, dice Graviano il 10 aprile del 2016. Poi aggiunge: “Nel ’92 già
voleva scendere. Lui voleva scendere, però in quel periodo c’erano i vecchi e
lui mi ha detto ci vorrebbe una bella cosa”. Un linguaggio che gli inquirenti
interpretano come un’allusione alle stragi del 1992, in particolare a quella
di via d’Amelio, con l’allora imprenditore Berlusconi che sarebbe già stato
intenzionato a scendere in campo. Una ricostruzione avanzata più volte in tutti
questi anni ma mai dimostrata, come testimoniano le archiviazioni di Firenze e
Caltanissetta, ma anche la sentenza Dell’Utri che assolve definitivamente
l’inventore di Forza Italia per i fatti successivi proprio all’anno zero della
Repubblica: il 1992. Eppure è proprio dal marzo del 1992, poco dopo l’assassinio
di Salvo Lima, che Dell’Utri incarica il politologo Ezio Cartotto: dovrà
cominciare a studiare l’operazione Botticelli, dalla quale sarebbe poi
nata Forza Italia. Il 21 maggio 1992, invece, Paolo Borsellino rilascia la
famosa intervista al giornalista francese Fabrizio Calvi, quella in cui parla
per la prima volta di Vittorio Mangano, lo stalliere di Arcore. Meno di due mesi
dopo, il 19 luglio del 1992 ecco il botto di via d’Amelio: a schiacciare il
telecomando che fece esplodere la Fiat 126 ci sarebbe stato – secondo il
pentito Gaspare Spatuzza – proprio Giuseppe Graviano. È questa la “cortesia” di
cui parla il capomafia di Brancaccio? E quale sarebbe stata l’urgenza? Forse le
indagini di Borsellino su Mangano?
“Non volevano più le stragi” – O forse Graviano
parla di altro? “Nel ’93 ci sono state altre stragi ma no che era la mafia. Loro
dicono che era la mafia”, dice in un altro passaggio delle intercettazioni il
boss. Ma se non erano stragi di mafia, di chi erano allora quelle bombe che
vedono la piovra colpire per la prima volta fuori dalla Sicilia? Riferendosi
all’epoca successiva, cioè al 1994, Graviano racconta al suo codetenuto:
“Dovevamo accordare, alla fine c’erano tanti punti da risolvere invece si
proseguì con questo. E intanto poi: è successo quello che è successo. Non
volevano più le stragi allora io ho imboccato un altro “. Un altro chi? E chi
sono quelli che non volevano più le stragi? Un passaggio che per gli inquirenti
è da ricollegare ad un’altra conversazione: quando il 22 gennaio del 2016
Graviano si vanta con Adinolfi. “Lo sai cosa scrivono nelle stragi? Nelle
sentenze delle stragi, che poi sono state assoluzione la Cassazione e compagnia
bella: le stragi si sono fermate grazie all’arresto del sottoscritto”,
dice portando la mano sinistra sulla pancia e indicando se stesso. E in effetti
Graviano viene arrestato il 27 gennaio del 1994: da allora non un solo colpo
sarà sparato nella Penisola, nuovo regno della pax mafiosa.
Il colpetto e lo stadio Olimpico – È per questo
motivo che gli investigatori collegano queste conversazioni al fallito attentato
dello stadio Olimpico, che doveva essere compiuto nelle prime settimane del
1994. È il “colpetto” che secondo il pentito Spatuzza si doveva dare per ordine
dello stesso Graviano. Il collaboratore ha raccontato di aver incontrato il suo
capomafia a Roma il 21 gennaio 1994. “Incontrai Giuseppe Graviano all’interno
del bar Doney in via Veneto, a Roma. Graviano era molto felice, come se avesse
vinto al Superenalotto, una Lotteria. Poi mi fece il nome di Berlusconi. Io gli
chiesi se fosse quello di Canale 5 e lui rispose in maniera affermativa.
Aggiunse che in mezzo c’era anche il nostro compaesano Dell’Utri e che grazie a
loro c’eravamo messi il Paese nelle mani. E per Paese intendo l’Italia. Quindi
mi spiega che grazie a queste persone di fiducia che avevano portato a buon fine
questa situazione, che non erano come quei quattro crasti (cornuti ndr) dei
socialisti”. A quel punto arriva la richiesta: “Graviano mi dice che
l’attentato ai carabinieri si deve fare lo stesso perché gli dobbiamo dare
il colpo di grazia”. Il riferimento è proprio all’attentato allo stadio
Olimpico contro il pullman dei carabinieri che mantengono l’ordine pubblico
durante le partite di calcio. Sarebbe stata l’ennesima strage di quel biennio:
per fortuna salta, perché a detta di Spatuzza ci fu un problema al telecomando
collegato all’autobomba.
“Si preoccupava: se questo parla a me mi arrestano
subito” – Nello stesso periodo in cui Graviano incontra Spatuzza a Roma, proprio
Dell’Utri si trova nella capitale a pochi metri dal bar Doney: il 22 gennaio
1994, infatti, era in programma una convention di Forza Italia all’hotel
Majestic, sempre in via Veneto. Secondo gli accertamenti della Dia l’arrivo
dell’ex senatore in albergo – a circa 50 metri dal bar Doney – è registrato il
18 gennaio. È possibile che Graviano abbia incontrato Dell’Utrinegli stessi
giorni in cui dava quegli ordini a Spatuzza? Su Dell’Utri, Graviano ricorda
soprattutto un episodio recente. “Noi – racconta al compagno d’ora d’aria –
eravamo a testimoniare nel processo di Dell’Utri nel 2009. Perché si
preoccupava. Dice: se questo parla a me mi arrestano subito. Umbè, ha fatto
tutte cose così. Ora a me non mi interessa più niente”. Parole che fanno il paio
con quello che Graviano rivolge sempre a Berlusconi. “Mi è successa una
disgrazia, mi arrestano, tu cominci a pugnalarmi, per che cosa? Per i soldi,
perché tu ti rimangono i soldi. Dice: non lo faccio uscire più, perché sa che io
non parlo, perché sa il mio carattere”. Come dire: l’ex premier può stare
tranquillo perché Giuseppe Graviano non è tipo da pentirsi.
“Ho messo mia moglie incinta al 41 bis”
– Ovviamente c’è da capire se il boss di Brancaccio sapesse o meno di essere
intercettato: se abbia cioè utilizzato le cimici della Dia a suo piacimento per
inquinare le indagini. Per i pm della procura di Palermo non è così ed il
motivo è da ricercare in un particolare abbastanza angosciante: passeggiando con
Adinolfi, infatti, Graviano torna più volte sull’argomento della
sua paternità. Ufficialmente nel 1996 Giuseppe Graviano e il fratello Filippo –
detenuti al 41 bis già dal 1994 – sarebbero riusciti a fare uscire dal carcere
le provette con il proprio liquido seminale, senza alcuna autorizzazione. È in
quel modo misterioso che le loro mogli, Rosalia e Francesca, partorirono due
bambini nati a distanza di poco più di un mese l’uno dall’altro.
“Nascosta tra la biancheria” – Una versione –
quello del figlio in provetta – che viene adesso messa in dubbio da Graviano:
secondo le confidenze fatte dal boss al suo compagno d’ora d’aria, sarebbe
riuscito a mettere incinta la moglie all’interno del carcere. Alla donna sarebbe
stato permesso di entrare nel penitenziario per giacere col marito. La stessa
cosa sarebbe riuscita anche al fratello di Filippo. “Dormivamo nella cella
assieme”, dice Graviano. “Mio figlio è nato nel ’97 – racconta – ed io nel ’96
ero in mano loro. Ti debbo fare una confidenza: prima di nascere il bambino,
prima di incontrarmi con mia moglie, siccome una cosa del genere mi era successa
in altre occasioni pure, io ho detto: no ci devo provare. Io sapevo che doveva
venire la situazione, io tremavo…poi ad un certo punto … lei venne nascosta ni
robbi (nascosta nella biancheria ndr) e dormivamo nella cella assieme. Cose da
pazzi, tremavo. Quando è uscita incinta mi è finito quel tremolizzo, l’ansia che
avevo”.
Ragionamenti genuini – I pm della procura di
Palermo hanno scoperto che effettivamente per un periodo del 1996 i due fratelli
Graviano furono detenuti nello stesso carcere, l’Ucciardone di Palermo. Il 28
marzo del 2017, quando vanno a interrogare Graviano gli contestano quindi anche
quelle parole sulla paternità. Il boss non ha risposto alle domande dei pm e il
giorno dopo l’interrogatorio torna a passeggiare con Adinolfi. Una volta nel
cortile gli racconta che gli investigatori li intercettano da 15 mesi. “È
sempre un fastidio – dice Adinolfi – ma noi non lo sapevamo, Però proprio
perché non lo sapevamo, alla fine si ritrovano la genuinità dei ragionamenti che
abbiamo fatto”. Poi a favore di cimice Graviano torna a parlare delle sua
paternità, spiega al codetenuto che i pm “gli hanno contestato anche il fatto
del figlio”. Quindi rilancia la storia delle provette e dice: “Capirono male”.
Paolo Borsellino, l'ultima intervista due
mesi prima di morire. A 25 anni dall'attentato di Via
D'Amelio, la trascrizione del colloquio tra il magistrato antimafia e due
giornalisti francesi di Canal+. Il 21 maggio del 1992 raccontava i rapporti tra
l'entourage di Silvio Berlusconi e Cosa Nostra. Due anni dopo l'Espresso ne
pubblicava la trascrizione. Che oggi vi riproponiamo, scrive Fabrizio Calvi e
Jean Pierre Moscardo il 18 luglio 2017 su "L'Espresso". «Gli imputati del
maxiprocesso erano circa 800: furono rinviati a giudizio 475». Scelta
l'inquadratura – Paolo Borsellino è seduto dietro la sua scrivania - Jeanne
Pierre Moscardo e Fabrizio Calvi cominciano l'intervista domandando al giudice i
dati sul maxiprocesso di Palermo del febbraio '86. Il giudice ricorda con
orgoglio di aver redatto, nell'estate dell'85, la monumentale sentenza del
rinvio a giudizio. Subito dopo, i due giornalisti chiedono notizie su uno di
quei 475, Vittorio Mangano. E' solo la prima delle tante domande sul mafioso che
lavorava ad Arcore: passo dopo passo, Borsellino - che con Giovanni Falcone
rappresentava un monumentale archivio di dati sulle cosche mafiose- ricostruisce
il profilo del mafioso. Racconta dei suoi legami, delle commissioni e delle sue
telefonate intercettate dagli inquirenti in cui si parla di "cavalli". Come la
telefonata di Mangano all’attuale presidente di Publitalia, Marcello Dell’Utri
[dal rapporto Criminalpol n. 0500/C.A.S del 13 aprile 1981 che portò al blitz di
San Valentino contro Cosa Nostra, ndr]. E ancora: domande sui finanzieri Filippo
Alberto Rapisarda e Francesco Paolo Alamia, uomini a Milano di Vito Ciancimino.
Infine sullo strano triangolo Mangano, Berlusconi, Dell’Utri. Mentre di Mangano
il giudice parla per conoscenza diretta, in questi casi prima di rispondere
avverte sempre: «Come magistrato ho una certa ritrosia a dire le cose cli cui
non sono certo... qualsiasi cosa che dicessi sarebbe azzardata o non
corrispondente a verità». Ma poi aggiunge particolari sconosciuti: «...Ci sono
addirittura delle indagini ancora in corso... Non sono io il magistrato che se
ne occupa...». A quali indagini si riferisce Borsellino? E se dopo quasi due
anni non se n'è saputo nulla è perché i magistrati non hanno trovato prove
sufficienti? Quel pomeriggio di maggio di due anni fa, Paolo Borsellino non
nasconde la sua amarezza per come certi giudici e certe sentenze della Corte di
Cassazione hanno trottato le dichiarazioni di pentiti come Antonino Calderone (
«...a Catania poi li hanno prosciolti tutti... quella della Cassazione è una
sentenza dirompente che ha disconosciuto l’unitarietà dell’organizzazione
criminale di Cosa Nostra...» ), ma soprattutto, grazie alle sue esperienze di
magistrato e come profondo conoscitore delle strategie di Cosa Nostra, l'unico
al quale Falcone confidava tutto, Borsellino offre una chiave di lettura
preziosa della Mangano connection che sembra coincidere con le più le più
recenti dichiarazioni dei pentiti. Quella che segue è la trascrizione letterale
(comprese tutte le ripetizioni e le eventuali incertezze lessicali tipiche del
discorso diretto) di alcuni capitoli della lunga intervista filmata, quasi
cinquanta minuti di registrazione.
Tra queste centinaia di imputati ce n'è uno che
ci interessa: tale Vittorio Mangano, lei l'ha conosciuto?
«Sì, Vittorio Mangano l'ho conosciuto anche in
periodo antecedente al maxiprocesso, e precisamente negli anni fra il '75 e
1'80. Ricordo di avere istruito un procedimento che riguardava delle estorsioni
fatte a carico di talune cliniche private palermitane e che presentavano una
caratteristica particolare. Ai titolari di queste cliniche venivano inviati dei
cartoni con una testa di cane mozzata. L'indagine fu particolarmente fortunata
perché – attraverso dei numeri che sui cartoni usava mettere la casa produttrice
- si riuscì rapidamente a individuare chi li aveva acquistati. Attraverso
un'ispezione fatta in un giardino di una salumeria che risultava aver acquistato
questi cartoni, in giardino ci scoprimmo sepolti i cani con la testa mozzata.
Vittorio Mangano restò coinvolto in questa inchiesta perché venne accertata la
sua presenza in quel periodo come ospite o qualcosa del genere - ora i miei
ricordi si sono un po' affievoliti - di questa famiglia, che era stata l'autrice
dell'estorsione. Fu processato, non mi ricordo quale sia stato l'esito del
procedimento, però fu questo il primo incontro processuale che io ebbi con
Vittorio Mangano. Poi l'ho ritrovato nel maxiprocesso perché Vittorio Mangano fu
indicato sia da Buscetta che da Contorno come uomo d'onore appartenente a Cosa
Nostra».
Uomo d'onore di che famiglia?
«L'uomo d'onore della famiglia di Pippo Calò, cioè
di quel personaggio capo della famiglia di Porta Nuova, famiglia alla quale
originariamente faceva parte lo stesso Buscetta. Si accerta che Vittorio Mangano
- ma questo già risultava dal procedimento precedente che avevo istruito io, e
risultava altresì dal cosiddetto "procedimento Spatola" [il boss Rosario
Spatola, potente imprenditore edile, ndr] che Falcone aveva istruito negli anni
immediatamente precedenti al maxiprocesso - che Mangano risiedeva abitualmente a
Milano città da dove, come risultò da numerose intercettazioni telefoniche,
costituiva un terminale dei traffici di droga che conducevano alle famiglie
palermitane».
E questo Vittorio Mangano faceva traffico di
droga a Milano?
«Il Mangano, di droga ... [Borsellino comincia a
rispondere, poi si corregge, ndr], Vittorio Mangano, se ci vogliamo limitare a
quelle che furono le emergenze probatorie più importanti, risulta
l'interlocutore di una telefonata intercorsa fra Milano e Palermo nel corso
della quale lui, conversando con un altro personaggio delle famiglie mafiose
palermitane, preannuncia o tratta 1'arrivo di una partita d'eroina chiamata
alternativamente, secondo il linguaggio che si usa nelle intercettazioni
telefoniche, come "magliette" o "cavalli". Il Mangano è stato poi sottomesso al
processo dibattimentale ed è stato condannato per questo traffico cli droga.
Credo che non venne condannato per associazione mafiosa - beh, sì per
associazione semplice – riporta in primo grado una pena di 13 anni e 4 mesi di
reclusione più 700 milioni di multa… La sentenza di Corte d'Appello confermò
questa decisione di primo grado... ».
Quando ha visto per la prima volta Mangano?
«La prima volta che l'ho visto anche fisicamente?
Fra il '70 e il '75».
Per interrogarlo?
«Sì, per interrogarlo».
E dopo è stato arrestato?
«Fu arrestato fra il '70 e il '75. Fisicamente non
ricordo il momento in cui l'ho visto nel corso del maxiprocesso, non ricordo
neanche di averlo interrogato personalmente. Si tratta di ricordi che cominciano
a essere un po' sbiaditi in considerazione del fatto che sono passati quasi 10
anni».
Dove è stato arrestato, a Milano o a Palermo?
«A Palermo la prima volta [è la risposta di
Borsellino; ai giornalisti interessa capire in quale periodo il mafioso vivesse
ad Arcore, ndr]».
Quando, in che epoca?
«Fra il '75 e 1'80, probabilmente fra il'75 e
l'80».
Ma lui viveva già a Milano?
«Sicuramente era dimorante a Milano anche se
risulta che lui stesso afferma di spostarsi frequentemente tra Milano e
Palermo».
E si sa cosa faceva a Milano?
«A Milano credo che lui dichiarò di gestire
un'agenzia ippica o qualcosa del genere. Comunque che avesse questa passione dei
cavalli risulta effettivamente la verità perché anche nel processo, quello delle
estorsioni cli cui ho parlato, non ricordo a che proposito venivano fuori i
cavalli. Effettivamente dei cavalli, non "cavalli" per mascherare il traffico
cli stupefacenti».
Ho capito. E a Milano non ha altre indicazioni
sulla sua vita, su cosa faceva?
«Guardi: se avessi la possibilità di consultare
gli atti del procedimento molti ricordi mi riaffiorerebbero... ».
Ma lui comunque era già uomo d'onore negli anni
Settanta?
«...Buscetta lo conobbe già come uomo d'onore in
un periodo in cui furono detenuti assieme a Palermo antecedente gli anni
Ottanta, ritengo che Buscetta si riferisca proprio al periodo in cui Mangano fu
detenuto a Palermo a causa cli quell'estorsione nel processo dei cani con la
testa mozzata… Mangano negò in un primo momento che ci fosse stata questa
possibilità d'incontro... ma tutti e due erano detenuti all'Ucciardone qualche
anno prima o dopo il '77».
Volete dire che era prima o dopo che Mangano
aveva cominciato a lavorare da Berlusconi? Non abbiamo la prova...
«Posso dire che sia Buscetta che Contorno non
forniscono altri particolari circa il momento in cui Mangano sarebbe stato fatto
uomo d'onore. Contorno tuttavia - dopo aver affermato in un primo tempo, di non
conoscerlo - precisò successivamente di essersi ricordato, avendo visto una
fotografia di questa persona, una presentazione avvenuta in un fondo di
proprietà di Stefano Bontade [uno dei capi dei corleonesi, ndr]».
Mangano conosceva Bontade?
«Questo ritengo che risulti anche nella
dichiarazione di Antonino Calderone [Borsellino poi indica un altro pentito ora
morto, Stefano Calzetta, che avrebbe parlato a lungo dei rapporti tra Mangano e
una delle famiglie di corso dei Mille, gli Zanca, ndr]... ».
Un inquirente ci ha detto che al momento in cui
Mangano lavorava a casa di Berlusconi c'è stato un sequestro, non a casa di
Berlusconi però di un invitato [Luigi D'Angerlo, ndr] che usciva dalla casa di
Berlusconi.
«Non sono a conoscenza di questo episodio».
Mangano è più o meno un pesce pilota, non so
come si dice, un'avanguardia?
«Sì, le posso dire che era uno di quei personaggi
che, ecco, erano i ponti, le "teste di ponte" dell'organizzazione mafiosa nel
Nord Italia. Ce n'erano parecchi ma non moltissimi, almeno tra quelli
individuati. Un altro personaggio che risiedeva a Milano, era uno dei Bono,
[altri mafiosi coinvolti nell'inchiesta cli San Valentino, ndr] credo Alfredo
Bono che nonostante fosse capo della famiglia della Bolognetta, un paese vicino
a Palermo, risiedeva abitualmente a Milano. Nel maxiprocesso in realtà Mangano
non appare come uno degli imputati principali, non c'è dubbio comunque che... è
un personaggio che suscitò parecchio interesse anche per questo suo ruolo un po'
diverso da quello attinente alla mafia militare, anche se le dichiarazioni di
Calderone [nel '76 Calderone è ospite di Michele Greco quando arrivano Mangano e
Rosario Riccobono per informare Greco di aver eliminato i responsabili di un
sequestro di persona avvenuto, contro le regole della mafia, in Sicilia, ndr] lo
indicano anche come uno che non disdegnava neanche questo ruolo militare
all'interno dell’organizzazione mafiosa».
Dunque Mangano era uno che poi torturava anche?
«Sì, secondo le dichiarazioni di Calderone».
Dunque quando Mangano parla di "cavalli"
intendeva droga?
«Diceva "cavalli" e diceva "magliette", talvolta».
Perché se ricordo bene c'è nella San Valentino
un'intercettazione tra lui e Marcello Dell'Utri, in cui si parla di cavalli (dal
rapporto Criminalpol: "Mangano parla con tale dott. Dell'Utri e dopo averlo
salutato cordialmente gli chiede di Tony Tarantino. L'interlocutore risponde
affermativamente... il Mangano riferisce allora a Dell'Utri che ha un affare da
proporgli e che ha anche "Il cavallo" che fa per lui. Dell'Utri risponde che per
il cavallo occorrono "piccioli" e lui non ne ha. Mangano gli dice di farseli
dare dal suo amico "Silvio". Dell'Utri risponde che quello lì non "surra"[non
c'entra, ndr]”).
«Sì, comunque non è la prima volta che viene
utilizzata, probabilmente non si tratta della stessa intercettazione. Se mi
consente di consultare [Borsellino guarda le sue carte, ndr]. No, questa
intercettazione è tra Mangano e uno della famiglia degli Inzerillo... Tra
l'altro questa tesi dei cavalli che vogliono dire droga è una tesi che fu
asseverata nella nostra ordinanza istruttoria e che poi fu accolta in
dibattimento, tant'è che Mangano fu condannato».
E Dell'Utri non c'entra in questa storia?
«Dell'Utri non è stato imputato nel maxiprocesso,
per quanto io ricordi. So che esistono indagini che lo riguardano e che
riguardano insieme Mangano».
A Palermo?
«Sì. Credo che ci sia un'indagine che attualmente
è a Palermo con il vecchio rito processuale nelle mani del giudice istruttore,
ma non ne conosco i particolari».
Dell'Utri. Marcello Dell'Utri o Alberto
Dell'Utri? [Marcello e Alberto sono fratelli gemelli, Alberto è stato in carcere
per il fallimento della Venchi Unica, oggi tutti e due sono dirigenti Fininvest,
ndr].
«Non ne conosco i particolari. Potrei consultare
avendo preso qualche appunto [Borsellino guarda le carte, ndr.], cioè si parla
di Dell'Utri Marcello e Alberto, entrambi».
I fratelli?
«Sì».
Quelli della Publitalia, insomma?
«Sì».
E tornando a Mangano, le connessioni tra
Mangano e Dell'Utri?
«Si tratta di atti processuali dei quali non mi
sono personalmente occupato, quindi sui quali non potrei rivelare nulla».
Sì, ma quella conversazione con Dell'Utri
poteva trattarsi di cavalli?
«La conversazione inserita nel maxiprocesso, se
non piglio errori, si parla di cavalli che dovevano essere mandati in un albergo
[Borsellino sorride, ndr.]. Quindi non credo che potesse trattarsi
effettivamente di cavalli. Se qualcuno mi deve recapitare due cavalli, me li
recapita all'ippodromo, o comunque al maneggio. Non certamente dentro
l'albergo».
In un albergo. Dove?
«Oddio i ricordi! Probabilmente si tratta del
Pinza [l'albergo di Antonio Virgilio, ndr] di Milano».
Ah, oltretutto.
«Sì».
C'è una cosa che vorrei sapere. Secondo lei
come si sono conosciuti Mangano e Dell'Utri?
«Non mi dovete fare queste domande su Dell'Utri
perché siccome non mi sono interessato io personalmente, so appena... dal punto
di vista, diciamo, della mia professione, ne so pochissimo, conseguentemente
quello che so io è quello che può risultare dai giornali, non è comunque una
conoscenza professionale e sul punto non ho altri ricordi».
Sono di Palermo tutti e due...
«Non è una considerazione che induce alcuna
conclusione... a Palermo gli uomini d'onore sfioravano le 2000 persone, secondo
quanto ci racconta Calderone, quindi il fatto che fossero di Palermo tutti e
due, non è detto che si conoscessero».
C'è un socio di Dell'Utri tale Filippo
Rapisarda [i due hanno lavorato insieme; la telefonata intercettata di Dell'Utri
e Mangano partiva da un'utenza di via Chlaravalle 7, a Milano, palazzo di
Rapisarda, ndr] che dice che questo Dell'Utri gli è stato presentato da uno
della famiglia di Stefano Bontade [i giornalisti si riferiscono a Gaetano Cinà
che lo stesso Rapisarda ha ammesso di aver conosciuto con Il boss del
corleonesi, Bontade, ndr].
«Beh, considerando che Mangano apparteneva alla
famiglia cli Pippo Calò... Palermo è la città della Sicilia dove le famiglie
mafiose erano le più numerose – almeno 2000 uomini d’onore con famiglie
numerosissime - la famiglia cli Stefano Bontade sembra che in certi periodi ne
contasse almeno 200. E si trattava comunque di famiglie appartenenti a un'unica
organizzazione, cioè Cosa Nostra, i cui membri in gran parte si conoscevano
tutti e quindi è presumibile che questo Rapisarda riferisca una circostanza
vera... So dell'esistenza di Rapisarda ma non me ne sono mai occupato
personalmente...».
A Palermo c'è un giudice che se n'è occupato?
«Credo che attualmente se ne occupi..., ci sarebbe
un'inchiesta aperta anche nei suoi confronti...».
A quanto pare Rapisarda e Dell'Utri erano in
affari con Ciancimino, tramite un tale Alamia [Francesco Paolo Alamia,
presidente dell'immobiliare Inim e della Sofim, sede di Milano, ancora in via
Chiaravalle 7, ndr].
«Che Alamia fosse in affari con Ciancimino è una
circostanza da me conosciuta e che credo risulti anche da qualche processo che
si è già celebrato. Per quanto riguarda Dell'Utri e Rapisarda non so fornirle
particolari indicazioni trattandosi, ripeto sempre, di indagini di cui non mi
sono occupato personalmente».
Si è detto che Mangano ha lavorato per
Berlusconi.
«Non le saprei dire in proposito. Anche se, dico,
debbo far presente che come magistrato ho una certa ritrosia a dire le cose di
cui non sono certo poiché ci sono addirittura... so che ci sono addirittura
ancora delle indagini in corso in proposito, per le quali non conosco
addirittura quali degli atti siano ormai conosciuti e ostensibili e quali
debbano rimanere segreti. Questa vicenda che riguarderebbe i suoi rapporti con
Berlusconi è una vicenda - che la ricordi o non la ricordi -, comunque è una
vicenda che non mi appartiene. Non sono io il magistrato che se ne occupa,
quindi non mi sento autorizzato a dirle nulla».
Ma c'è un'inchiesta ancora aperta?
«So che c'è un'inchiesta ancora aperta».
Su Mangano e Berlusconi? A Palermo?
«Su Mangano credo proprio di sì, o comunque ci
sono delle indagini istruttorie che riguardano rapporti di polizia, concernenti
anche Mangano».
Concernenti cosa?
«Questa parte dovrebbe essere richiesta... quindi
non so se sono cose che si possono dire in questo momento».
Come uomo, non più come giudice, come giudica
la fusione che abbiamo visto operarsi tra industriali al di sopra di ogni
sospetto come Berlusconi e Dell'Utri e uomini d'onore di Cosa Nostra? Cioè Cosa
Nostra s'interessa all'industria, o com'è?
«A prescindere da ogni riferimento personale,
perché ripeto dei riferimenti a questi nominativi che lei fa io non ho
personalmente elementi da poter esprimere, ma considerando la faccenda nelle sue
posizioni generali: allorché l'organizzazione mafiosa, la quale sino agli inizi
degli anni Settanta aveva avuto una caratterizzazione di interessi
prevalentemente agricoli o al più di sfruttamento di aree edificabili.
All'inizio degli anni Settanta Cosa Nostra cominciò a diventare un'impresa
anch'essa. Un'impresa nel senso che attraverso l'inserimento sempre più
notevole, che a un certo punto diventò addirittura monopolistico, nel traffico
di sostanze stupefacenti, Cosa Nostra cominciò a gestire una massa enorme di
capitali. Una massa enorme di capitali dei quali, naturalmente, cercò lo sbocco.
Cercò lo sbocco perché questi capitali in parte venivano esportati o depositati
all'estero e allora così si spiega la vicinanza fra elementi di Cosa Nostra e
certi finanzieri che si occupavano di questi movimenti di capitali,
contestualmente Cosa Nostra cominciò a porsi il problema e ad effettuare
investimenti. Naturalmente, per questa ragione, cominciò a seguire una via
parallela e talvolta tangenziale all'industria operante anche nel Nord o a
inserirsi in modo di poter utilizzare le capacità, quelle capacità
imprenditoriali, al fine di far fruttificare questi capitali dei quali si erano
trovati in possesso».
Dunque lei dice che è normale che Cosa Nostra
s'interessi a Berlusconi?
«E' normale il fatto che chi è titolare di grosse
quantità di denaro cerca gli strumenti per potere questo denaro impiegare. Sia
dal punto di vista del riciclaggio, sia dal punto di vista di far fruttare
questo denaro. Naturalmente questa esigenza, questa necessità per la quale
l'organizzazione criminale a un certo punto della sua storia si è trovata di
fronte, è stata portata a una naturale ricerca degli strumenti industriali e
degli strumenti commerciali per trovare uno sbocco a questi capitali e quindi
non meraviglia affatto che, a un certo punto della sua storia, Cosa Nostra si è
trovata in contatto con questi ambienti industriali».
E uno come Mangano può essere l'elemento di
connessione tra questi mondi?
«Ma guardi, Mangano era una persona che già in
epoca ormai diciamo databile abbondantemente da due decadi, era una persona che
già operava a Milano, era inserita in qualche modo in un'attività commerciale.
E' chiaro che era una delle persone, vorrei dire anche una delle poche persone
di Cosa Nostra, in grado di gestire questi rapporti».
Però lui si occupava anche di traffico di
droga, l'abbiamo visto anche In sequestri di persona...
«Ma tutti questi mafiosi che in quegli anni -
siamo probabilmente alla fine degli anni ‘60 e agli inizi degli anni ‘70 -
appaiono a Milano, e fra questi non dimentichiamo c'è pure Luciano Liggio,
cercarono di procurarsi quei capitali, che poi investirono negli stupefacenti,
anche con il sequestro di persona».
A questo punto Paolo Borsellino consegna dopo
qualche esitazione ai giornalisti 12 fogli, le carte che ha consultato durante
l’intervista: «Alcuni sono sicuramente ostensibili perché fanno parte del
maxiprocesso, ormai è conosciuto, è pubblico, altri non lo so ...». Non sono
documenti processuali segreti ma la stampa dei rapporti contenuti nella memoria
del computer del pool antimafia di Palermo, in cui compaiono i nomi delle
persone citate nell’intervista: Mangano, Dell'Utri, Rapisarda Berlusconi,
Alamia.
E questa inchiesto quando finirà?
«Entro ottobre di quest'anno...».
Quando è chiusa, questi atti diventano
pubblici?
«Certamente ...».
Perché servono per un'inchiesta che stiamo
cominciando sui rapporti tra la grossa industria...
«Passerà del tempo prima che ...», sono le ultime
parole di Paolo Borsellino. Palermo, 21 maggio, 1992.
Paolo Borsellino, i segreti
dell’intervista su Berlusconi e gli interessi di Canal Plus. Parla l’autore: “È
la mia maledizione”. Parla Fabrizio Calvi, il
giornalista italo francese che il 21 maggio del 1992 intervistò il giudice
palermitano nella sua casa nel capoluogo siciliano. E racconta i retroscena su
quel colloquio in cui si parla per la prima volta delle indagini su Vittorio
Mangano e Marcello Dell'Utri. "Come nacque quell'intervista? Canal Plus era
interessato ai rapporti tra il padrone della Fininvest e la mafia. Questo perché
Berlusconi era azionista di La Cinq ed era entrato in concorrenza con loro.
Perché non venne pubblicata? Dopo l'omicidio non vollero sentirne più parlare",
scrive Giuseppe Pipitone il 19 luglio 2017 su "Il Fatto Quotidiano". “Ci sono
storie maledette, quella dell’intervista a Paolo Borsellino è la mia”. Parola
di Fabrizio Calvi, il giornalista italo francese che il 21 maggio del 1992
insieme al collega Jean Pierre Moscardo intervista il giudice palermitano nella
sua casa nel capoluogo siciliano. Il contenuto di quell’incontro è clamoroso e
ampiamente conosciuto: a 48 ore dall’omicidio di Giovanni Falcone e a meno di
due mesi dal suo, Borsellino parla per la prima volta dei rapporti tra Vittorio
Mangano, Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi. Altrettanto noto è il difficile
percorso che porterà quell’intervista prima ad essere pubblicata in forma
scritta dall’Espresso nella primavera del 1994 (al settimanale era stata fornita
una sintesi video a garanzia dell’autenticità) e poi alla messa in onda – sempre
in forma breve – su Rainews 24 nel 2000 tra le polemiche e le tensioni della
televisione di Stato. Per la pubblicazione integrale, invece, bisognerà
attendere il 2009, quando Il Fatto Quotidiano la diffonde in dvd. Quello che
invece fino a oggi era meno conosciuto – se non totalmente ignoto – è
il prequel di quell’intervista: come nasce, i motivi per cui venne commissionata
e quindi mai mandata in onda. A venticinque anni dalla strage di via d’Amelio,
Calvi ha accettato di parlare con ilfattoquotidiano.it, ripercorrendo i giorni
precedenti e successivi a quell’incontro con Borsellino, che doveva fare parte
di un film inchiesta da lui oggi ha definito come “la mia maledizione”.
Calvi, perché quel film è la sua maledizione?
«Perché me lo
porto dietro praticamente da sempre e per un motivo o per un altro non è mai
uscito integralmente. Ci sono storie maledette, quella dell’intervista a Paolo
Borsellino è la mia».
Come nasce l’idea d’intervistare Borsellino?
«Conoscevo da
anni Paolo Borsellino, lo seguivo dagli anni ’80. Me lo aveva presentato Rocco
Chinnici anche prima che Borsellino facesse parte del pool antimafia. Tutti
correvano dietro a Giovanni Falcone, a me è sembrata una buona idea correre
dietro a Borsellino. Avevamo un ottimo rapporto. Non so se di amicizia, ma
sicuramente un ottimo rapporto. Così visto che dovevamo fare un film su Silvio
Berlusconi e la mafia ho pensato di andarlo a intervistare».
Quel film nasce già come un’inchiesta su
Berlusconi e la mafia?
«Assolutamente
sì. Io avevo avuto notizia delle indagini su Vittorio Mangano e Marcello
Dell’Utri. Avevamo sentito tutti i protagonisti del blitz di San Valentino a
Milano, poi siamo andati in Sicilia per ricostruire i percorsi di Marcello e
Alberto Mangano».
E perché si rivolge a Borsellino?
«Io non avevo
idea che lui si fosse occupato di Mangano per una storia di estorsioni. Sono
andato a trovarlo in procura qualche giorno prima dell’intervista e mi dice: Sì,
su Mangano ho delle cose da dire. Io ero andato spesso in procura in passato ma
ricordo che all’epoca ho trovato l’ambiente un po’ cupo, pesante. Non si sapeva
ancora ma col senno di poi era il momento in cui stavano cambiando le cose».
A quel punto lei propone un’intervista a
Borsellino su Mangano.
««E lui
accetta di farla davanti alle telecamere. Però mi dà appuntamento a casa sua. Un
dettaglio che già al momento mi colpì perché di interviste a casa sua non ne
avevo mai fatte».
Perché non si fece intervistare in procura?
«Onestamente,
non lo so. Perché non voleva essere sentito, ascoltato o visto in procura?
Questo non lo so. D’altra parte era un’intervista video».
La novità di quell’intervista è il collegamento
Mangano-Dell’Utri-Berlusconi.
«Due cose mi
hanno colpito di quel colloquio. La prima è che Borsellino parla di inchieste in
corso a Palermo su Dell’Utri, è quella era per me era una novità. C’erano
procedimenti su Mangano ma a Milano e si trattava sempre del blitz di San
Valentino, che credo fosse già finito in Cassazione quindi non lo definirei in
corso. Ma non si sapeva niente di indagini aperte a Palermo. Non ho mai capito
cosa fossero quelle inchieste in corso».
Non si è veramente mai capito neanche dopo: la
prima indagine ufficiale su Dell’Utri da parte della procura di Palermo è del
1994.
«Quando già
Berlusconi era sceso in politica. Ma lì eravamo prima della stagione di Forza
Italia, anche se era il momento in cui la mafia aveva già mollato la Dc».
Quale è la seconda cosa che l’ha colpita
dell’intervista?
«Il tono usato
da Borsellino, lui parla in un modo molto forte e diretto: ha quelle carte
davanti che sta guardando e le cita in continuazione. Poi avremmo capito che
quello era il fascicolo processuale delle inchieste su Mangano, Dell’Utri e
Berlusconi, cioè tutte le volte che erano stati citati in rapporti di polizia.
Lui riguarda questo elenco e alla fine me lo dà davanti alla telecamera,
dicendo: basta che non dice che gliel’ho dato io. Francamente mi ha stupito:
queste cose non le faceva mai».
Era come se volesse parlare di quell’argomento
a tutti i costi, cioè di Berlusconi, Mangano e Dell’Utri? Ha avuto questa
sensazione?
«Lui voleva
parlare, questo è chiaro. Voleva parlare e voleva parlare di questi soggetti.
Perché in quella fase non sarei capace di dirlo. A Palermo era uno strano
momento: di quieta inquietudine direi. Era già morto Salvo Lima, che aveva dato
la disponibilità ad essere intervistato da noi e si sapeva che qualcosa si stava
muovendo. Ma la città in quel momento era tranquilla anche se lui era inquieto».
Ma dopo l’omicidio Borsellino, come mai
l’intervista non è stata mandata in onda? Era un documento straordinario da
diffondere dopo la strage di via d’Amelio.
«Perché bisogna
capire come nasce l’intervista a Borsellino».
Come nasce?
«Io lavoravo
per una casa di produzione indipendente e c’era un interesse di Canal Plus per
Berlusconi e la mafia. Questo perché Berlusconi era azionista di La Cinq e la
voleva trasformare in una tv criptata, entrando in concorrenza diretta con Canal
Plus».
Quindi c’era un interesse affaristico di Canal
Plus. Sono loro a commissionarvi l’inchiesta o l’avete proposta voi?
«No, noi
abbiamo proposto a Canal Plus delle storie sulla mafia. Le nostre fonti ci
avevano segnalato che c’erano storie su Berlusconi e la mafia e Canal Plus ci ha
detto: questa ci interessa. Il problema è che quando il film era finito, per
Canal Plus non era più una storia utile: La Cinq era fallita, Berlusconi non
investiva in Francia e loro non volevano più sentirne parlare».
Addirittura non volevano sentirne parlare? Ma
quello, però, era comunque uno scoop. Non solo per i contenuti ma perché è
probabilmente una delle ultime interviste a Borsellino prima di morire: che
senso ha non volerne sentire più parlare?
«Non lo so, ma
Canal Plus era ed è una televisione che si occupa soprattutto di cinema, di
sport e soltanto in parte di documentari. E documentari non vuol dire attualità.
E poi Canal Plus non sapeva neanche che dentro il nostro girato c’era tutta
quella storia di Borsellino. Magari avevano saputo dell’omicidio, però per loro
era un’operazione che non interessava più».
Come mai non ha proposto a qualche altra
emittente di mandare in onda quell’intervista?
«Perché sono
subito partito per girare una lunga serie sui servizi segreti nella seconda
Guerra Mondiale. E quindi ho messo da parte tutto il capitolo sulla mafia. E poi
onestamente non mi andava di pubblicare quest’intervista con la chiave: ecco
perché Borsellino è stato ucciso. Non mi piaceva».
Ha mai pensato che uno dei motivi per cui
Borsellino muore è proprio perché sapeva quelle cose su Mangano e Dell’Utri?
«Cioè per
l’intervista?»
Non per l’intervista, ma per quello che dice
nell’intervista.
«Ma quello che
dice nell’intervista non è stato pubblicato e quindi non era pubblico. Magari
qualcuno l’ha saputo ma io penso proprio di no. Io penso che l’omicidio fosse
stato già deciso quando uccisero Falcone. Poi da quello che ho sentito, ma non
ho seguito direttamente, so che Borsellino era stato ucciso perché si era messo
in mezzo alla Trattativa».
Recentemente, però, Giuseppe Graviano –
intercettato in carcere – parla di una “cortesia” fatta “al Berlusca” che voleva
scendere già in politica nel 1992. Registrazioni che alcuni inquirenti collegano
alla strage Borsellino.
«L’ipotesi che
lega l’intervista all’omicidio direi che non è credibile. Anche perché ho letto
che Graviano sapeva di essere intercettato. Le connessioni tra Berlusconi,
Dell’Utri, Mangano erano già saltate fuori. La novità che portava Borsellino era
una novità importante ma come documentaristica perché dà un’altra luce alla
faccia di Dell’Utri e Mangano ma non è secondo me una luce fondamentale»».
In ogni caso, però, quell’intervista, non venne
comunque diffusa per due anni e l’intero film non è mai uscito: non è strano?
«Sì e per
questo che io considero questa storia la mia storia maledetta. L’intervista,
come è noto è stata pubblicata dall’Espresso nel 1994 e poi da voi in forma
integrale, mentre il film ho praticamente finito di montarlo. Negli anni
successivi l’ho proposto a vari network ai quali invece non interessava. Ma se
non è mai uscito è stato per una serie di circostanze che non reputo strane o
inquietanti o meglio non spinte dall’alto. Varie volte ho sentito il fiato sul
collo in certe storie che seguivo, ma devo dire che non è questo il caso».
Cosa c’entra Spatuzza con Berlusconi.
Il mafioso che ha rivelato l'organizzazione della strage di via D'Amelio ha
raccontato anche un pezzo della lunga storia di accuse sui rapporti tra
Berlusconi e la mafia, scrive giovedì 13 luglio 2017 "Il Post". In
un interrogatorio con i magistrati del 16 giugno 2009, Gaspare
Spatuzza descrisse quello che a oggi è uno degli episodi più concreti della
lunga storia di rapporti reali, raccontati e presunti di Silvio Berlusconi con
la mafia: stando al racconto di Spatuzza, un mafioso che si era da un anno
dichiarato “collaboratore di giustizia” dopo undici anni in carcere, il suo boss
Giuseppe Graviano gli diede un appuntamento all’inizio di gennaio del ’94 al bar
Doney di via Veneto a Roma, alla vigilia dell’attentato poi fallito allo stadio
Olimpico di Roma (e anche dell’arresto dello stesso Graviano a Milano). Questo è
il racconto di Spatuzza, ripetuto in successivi processi. Aveva un’aria gioiosa
e mi disse che avevamo ottenuto tutto quel che cercavamo grazie a delle persone
serie che avevano portato avanti la cosa. Io capii che alludeva al progetto di
cui mi aveva parlato già in precedenza, in un altro incontro a Campofelice di
Roccella (…) Poi aggiunse che quelle persone non erano come quei quattro
crasti dei socialisti che prima ci avevano chiesto i voti e poi ci avevano fatto
la guerra (…) Ve l’avevo detto che le cose sarebbero andate a finire bene (…)
Poi mi fece il nome di Berlusconi. Io gli chiesi se fosse quello di Canale 5 e
lui rispose in maniera affermativa. Aggiunse che in mezzo c’era anche il nostro
compaesano Dell’Utri e che grazie a loro c’eravamo messi il Paese nelle mani.
Quando a Spatuzza fu contestato a processo di avere aggiunto questo racconto
alle sue altre confessioni e testimonianze solo un anno dopo la formalizzazione
del suo “pentimento” – la legge gli toglierebbe quindi ogni validità, perché per
evitare mercanteggiamenti impone che un collaboratore dica le cose che ha da
dire entro sei mesi – la sua spiegazione fu che si era allora appena insediato
il quarto governo Berlusconi e questo lo aveva preoccupato sull’ottenimento del
regime di protezione richiesto dal suo status di “collaboratore”, e che si era
deciso a parlare di Berlusconi solo una volta ottenutolo, mesi più tardi. Le
indagini sui rapporti con la mafia di Silvio Berlusconi hanno una storia lunga e
controversa. A oggi, il loro risultato più rilevante e definitivo è
la sentenza (definitiva nel 2014) che ha condannato il principale collaboratore
di Berlusconi, Marcello Dell’Utri, a sette anni di carcere per concorso esterno
in associazione mafiosa e che ha stabilito che negli anni Settanta lo stesso
Dell’Utri fece da tramite in una trattativa tra alcuni boss mafiosi e Berlusconi
culminata in una riunione a Milano, con la quale Berlusconi acconsentì di pagare
per la protezione sua e della famiglia dai sequestri che allora temeva, o da
altro. Dice tra l’altro la sentenza di Cassazione: In tale occasione veniva
concluso l’accordo di reciproco interesse, in precedenza ricordato, tra “cosa
nostra”, rappresentata dai boss mafiosi Bontade e Teresi, e l’imprenditore
Berlusconi, accordo realizzato grazie alla mediazione di Dell’Utri che aveva
coinvolto l’amico Gaetano Cinà, il quale, in virtù dei saldi collegamenti con i
vertici della consorteria mafiosa, aveva garantito la realizzazione di tale
incontro.
L’assunzione di Vittorio Mangano (all’epoca dei
fatti affiliato alla “famiglia” mafiosa di Porta Nuova, formalmente aggregata al
mandamento di S. Maria del Gesù, comandato da Stefano Bontade) ad Arcore, nel
maggio-giugno del 1974, costituiva l’espressione dell’accordo concluso, grazie
alla mediazione di Dell’Utri, tra gli esponenti palermitani di “cosa nostra” e
Silvio Berlusconi ed era funzionale a garantire un presidio mafioso all’interno
della villa di quest’ultimo. In cambio della protezione assicurata Silvio
Berlusconi aveva iniziato a corrispondere, a partire dal 1974, agli esponenti di
“cosa nostra” palermitana, per il tramite di Dell’Utri, cospicue somme di denaro
che venivano materialmente riscosse da Gaetano Cinà. (…) In proposito la Corte
d’appello di Palermo ha, con motivazione esente da vizi logici e giuridici,
dimostrato, con i ragionamenti probatori in precedenza illustrati, che, anche
nel periodo compreso tra il 1983 e il 1992, l’imputato, assicurando un costante
canale di collegamento tra i partecipi del patto di protezione stipulato nel
1974, protrattosi da allora senza interruzioni, e garantendo la continuità dei
pagamenti di Silvio Berlusconi in favore degli esponenti dell’associazione
mafiosa in cambio della complessiva protezione da questa accordata
all’imprenditore, ha consapevolmente e volontariamente fornito un contributo
causale determinante, che senza il suo apporto non si sarebbe verificato, alla
conservazione del sodalizio mafioso e alla realizzazione, almeno parziale, del
suo programma criminoso, volto alla sistematica acquisizione di proventi
economici ai fini della sua stessa operatività, del suo rafforzamento e della
sua espansione. Il tema dell' “estorsione” praticata dalla mafia nei confronti
di Berlusconi è molto delicato e controverso. È quello che permette che non ci
siano state fino a oggi condanne nei confronti di Berlusconi per i suoi rapporti
con la mafia, malgrado la sentenza su Dell’Utri e le molte accuse che questo
rapporto sia stato spesso di collaborazione complice. La storia più nota e
rilevante in questo senso è quella del rapporto con Vittorio Mangano, il mafioso
che in virtù dell’accordo citato sopra prese residenza nella villa di Arcore di
Berlusconi negli anni Settanta (come “stalliere” dei cavalli secondo Berlusconi)
e costruì con Berlusconi e Dell’Utri un rapporto molto intenso e continuato (che
poi si interruppe e ha come episodio più famoso la strana telefonata tra
Berlusconi e Dell’Utri dopo un attentato di cui lo credono responsabile).
Le prime indagini su Berlusconi e la mafia
risalgono ufficialmente al 1996, anche se c’è una mai chiarita questione delle
indagini a Palermo citate in un’intervista da Paolo Borsellino nel 1992 e di cui
non c’è traccia ufficiale (l’unica spiegazione, non del tutto convincente, è che
si trattasse di indagini su fatti che lo coinvolgevano senza che fosse
indagato). Nel 1996 Berlusconi fu indagato a Palermo per concorso esterno in
associazione mafiosa, e negli anni successivi fu indagato a Firenze e a
Caltanissetta rispettivamente per la campagna di stragi del 1992-1994 e per
quelle in cui vennero uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Tutte le
inchieste furono archiviate. Le grandi ipotesi accusatorie – mai dimostrate, mai
giunte a condanne, sostenute solo da dichiarazioni non riscontrate
di diversi collaboratori di giustizia – sono state fino a oggi: che Berlusconi
abbia – nell’ambito degli accordi di cui sopra – usato grandi investimenti della
mafia per avviare e sostenere le sue imprese, soprattutto nel settore delle
costruzioni; che abbia usato il sostegno della mafia al momento della sua
candidatura in politica nel gennaio 1994 e per la sua vittoria successiva; e che
abbia avuto delle complicità di qualche tipo con i boss Graviano nel periodo in
cui questi organizzavano la serie di attentati mafiosi in tutta Italia tra il
1992 e il 1994 (periodo in cui stando a quell’intervista di Borsellino qualcuno
in Sicilia stava indagando già su Berlusconi e Dell’Utri). È realisticamente a
quest’ultima ipotesi (“abbiamo un quadro in mente, ma che abbiamo bisogno di
verificare”, dicono) che lavorano Pier Luigi Vigna e Pietro Grasso – a capo
della Direzione Nazionale Antimafia – quando nel 1998 interrogano in carcere
Gaspare Spatuzza e gli chiedono di un soggiorno dei Graviano in Sardegna, di una
vacanza “in una barca con belle donne e la personalità”, se l’attentato contro
Maurizio Costanzo avesse a che fare con Fininvest, se a Milano fosse stato
ospitato da “uno che era al maneggio dei cavalli”, se “la discesa in campo di
nuove forze politiche” fosse stata considerata al tempo degli attentati.
Spatuzza risponde di no o di non saperne niente:
nel 2009 giustificherà con i timori per la sua famiglia il non aver parlato
allora, ma per avvalorare il suo racconto su Graviano e Berlusconi sosterrà di
avervi già alluso quanto secondo lui bastava in un colloquio investigativo con
Pier Luigi Vigna nel 1997 (cita anche la presenza di Grasso, su cui però ha dato
versioni diverse). Nel 1997, anni prima di cominciare a collaborare, durante un
colloquio investigativo con l’allora procuratore nazionale antimafia Pierluigi
Vigna e con Piero Grasso, dissi “fate attenzione a Milano 2”. Stavamo per
salutarci e io mi sentivo di dire qualcosa anche se ancora non ero
pentito. Intendevo dare in modo soft, come avevo fatto per il furto della 126
usata per la strage di via D’Amelio, un’indicazione. Parole di cui però allora
non fu comprovata la presenza in nessun verbale di colloquio investigativo (oggi
non possono essere confermate da nessuno di persona: Grasso escluse di averle
mai ascoltate ma non sappiamo se abbia partecipato a tutti i colloqui, Pier
Luigi Vigna è morto nel 2012).
Il Csm condanna Palermo,
scrive Franco Coppola su "La Repubblica" il 27 giugno 1985. La perdita di sei
mesi di anzianità per Carlo Palermo, il giudice della maxi inchiesta sul
traffico di armi e droga, il giudice che ha chiesto e ottenuto di essere
trasferito a Trapani, nella sede cioè più calda d’ Italia. Una sanzione
disciplinare, quella decisa a mezzanotte dopo una camera di consiglio
insolitamente lunga (sette ore) dall’apposita sezione del Consiglio superiore
della magistratura, ritenuta troppo severa per chi vede in Carlo Palermo una
sorta di Robin Hood senza macchia e senza paura, troppo blanda per quanti lo
dipingono come un giustiziere-panzer, privo di scrupoli e di regole. Una
sanzione, a ben guardare, che potrebbe anche essere considerata equilibrata, se
su tutta la vicenda non pesasse l’ombra di una discutibile iniziativa presa da
Bettino Craxi non come privato cittadino ma nella veste di presidente del
Consiglio, alla quale ha fatto seguito una inusitata solerzia da parte del
procuratore generale Giuseppe Tamburrino, titolare dell’azione disciplinare. Per
tutta la giornata di ieri c’è stata battaglia a palazzo dei Marescialli intorno
alla posizione di Carlo Palermo, un magistrato tra i più coraggiosi, scampato il
2 aprile scorso a un attentato mafioso nella sua nuova sede di Trapani, da lui
stesso richiesta per continuare, in una zona quanto mai calda e al posto di
Antonio Costa, giudice finito in galera per collusioni con la mafia, quella
battaglia intrapresa anni prima a Trento contro la mafia della droga e delle
armi. Battaglia che ha avuto come protagonisti prima Guido Guasco e Giovanni
Tranfo, sostituti procuratori generali della Cassazione che ieri fungevano
rispettivamente da accusatore e da difensore di Palermo, poi i nove componenti
la sezione disciplinare del Csm, tutt’altro che d’accordo sulla eventuale
sanzione da infliggere all’incolpato. Guasco ha parlato in mattinata per due ore
sostenendo la “responsabilità” di Palermo per cinque dei sei capi d’incolpazione
e sollecitando la sanzione della perdita di sei mesi d’anzianità. Secondo il Pg,
infatti, il magistrato andava prosciolto dalla seconda “accusa”, quella di aver
bloccato un telegramma con cui l’avvocato Roberto Ruggiero raccomandava al suo
cliente Vincenzo Giovannelli, imputato nel processo per il traffico di armi e
droga, di presentare ricorso per Cassazione contro il provvedimento del
tribunale della libertà di Trento. Il Csm, invece, lo ha “condannato” per cinque
capi di accusa prosciogliendolo dalla “incolpazione” di aver interrogato degli
imputati in assenza dei loro difensori. Più o meno tutte di questo calibro –
Craxi a parte – sono le incolpazioni contestate a Palermo, fatti cioè che,
secondo il Pg, integrerebbero l’accusa di “essere venuto meno ai propri doveri
funzionali, così compromettendo il prestigio dell’ordine giudiziario”: accuse
all’avvocato Ruggiero di avvalersi di “metodi disonesti” e di “modalità
vergognose”, interrogazioni di imputati senza la presenza dei difensori;
l’arresto di un testimone per reticenza a cui è seguito il proscioglimento da
parte della corte d’appello; proseguimento delle indagini sul conto di imputati
dichiarati dal Pm estranei al traffico di armi e droga. Poi c’era l’ “affare
Craxi”, anzi l’”affare Craxi-Pillitteri”. Siamo nel 1983. Carlo Palermo,
affondando il bisturi nel magma ribollente del mercato dell’eroina, arriva alla
pista bulgara, al traffico internazionale delle armi, al “SuperEsse”, alla P2.
Con gli avvocati di alcuni imputati i rapporti si fanno tesi; due di essi,
Roberto Ruggiero e Bonifacio Giudiceandrea, finiscono in carcere per
favoreggiamento. Palermo non c’entra. All’origine dell’accusa sono delle
trascrizioni errate di intercettazioni telefoniche. Quando i due legali vengono
scarcerati arriva puntuale la denuncia contro il magistrato. Si apre
un’inchiesta, affidata alla magistratura veneziana che, nel febbraio scorso,
rinvia a giudizio Palermo per interesse privato in atti d’ufficio. E’ questa
anche la settima incolpazione di stampo disciplinare sulla quale, però, il Csm
non si è pronunciato in attesa della definizione del procedimento penale. Alla
fine di quell’anno, Palermo ordina la perquisizione di varie società
finanziarie, alcune delle quali risultano legate al Psi o fanno capo al
finanziere socialista Ferdinando Mach di Palmstein. Alcuni testimoni hanno fatto
il nome di Craxi e del cognato Paolo Pillitteri. Nei decreti di perquisizione,
allora, Palermo raccomanda a chi li eseguirà di fare attenzione se, nei
documenti delle società in questione, compaiono quei nomi eccellenti. E’ in quel
momento che Palermo si gioca l’inchiesta. Il 15 dicembre ’83, Craxi scrive al Pg
Tamburrino per lamentare che il magistrato ha citato il suo nome in un mandato
di perquisizione senza avvertirlo; nell’esposto, il capo del governo parla di
“gravissime violazioni di legge”, di comportamento “di eccezionale gravità…
inaudito”. E’ la fine dell’inchiesta sul traffico di armi e droga. Prende vigore
l’indagine penale a Venezia per l’arresto degli avvocati, Tamburrino investe
subito il Csm della procedura disciplinare, la Cassazione dirotta a Venezia
tutte le inchieste di Palermo. Il giudice fa appena in tempo a firmare
un’ordinanza di rinvio a giudizio, a spedire al Parlamento tutti gli atti
relativi a Craxi e Pillitteri (e l’Inquirente archivia il “caso”, proseguendo
però nell’indagine sulle società finanziarie del Psi) e a chiedere di essere
trasferito ad altra sede. Infine, il procedimento disciplinare, fissato per il
12 aprile e rinviato d’autorità, senza neppure interpellare l’interessato, dopo
l’attentato del 2 di quel mese.
La profezia americana sul
processo Andreotti,
scrive il 17 luglio 2017 "Piccole Note". Sulla Repubblica del 17 luglio, Attilio
Bolzoni e Salvo Palazzolo pubblicano documenti riservati dell’ambasciata
americana a Roma relativi agli anni delle stragi di mafia e a un incontro
riservato con il presidente del consiglio Giulio Andreotti. Pur se un po’
(inevitabilmente) pervaso dall’aura che circonda la figura di Andreotti, la
leggenda nera alimentata da decenni di narrativa ostile, l’articolo offre spunti
interessanti. Nel report dell’ambasciata si legge che l’uomo politico
democristiano critica sia Luciano Violante che Leoluca Orlando, suoi grandi
accusatori (particolare in realtà di secondo piano). Più interessante il cenno
che inquadra le accuse a lui rivolte come risposta a sue iniziative contro la
mafia, la quale quindi si starebbe «vendicando», accusando lui di collusioni con
la stessa. Non solo la mafia italiana, secondo Andreotti: «Con ogni probabilità
sono coinvolti anche mafiosi americani e possibili spezzoni “deviati” dei
servizi segreti italiani oltre che dello United States Marshall Service». Accuse
più che circostanziate, soprattutto quella rivolta all’United Sates Marshall
Service, un’Agenzia con compiti di vigilanza giudiziaria davvero poco nota alla
cronaca. Evidentemente con quel cenno tanto particolare Andreotti vuole indicare
ai suoi interlocutori di avere informazioni molto dettagliate sulle trame ordite
contro di lui. Nel report americano non c’è traccia di domande da parte
americana sul punto: gli interlocutori di Andreotti cioè non chiedono
spiegazioni, cosa che invece dovrebbe essere più che doverosa. Semplicemente
lasciano cadere la cosa, come argomento di nessuna importanza. Forse avevano
paura che quelle accuse trovassero un qualche riscontro? Poi, a un certo punto,
Andreotti inizia a fare domande. Così viene segnalato nel report: «“Ha chiesto
informazioni sulla diffusione da parte del governo americano di un dispaccio del
1984 proveniente dal nostro Consolato di Palermo, nel quale viene riferito che,
se i presunti legami di Lima con la mafia fossero confermati, allora sia
Andreotti che l’intero regime politico italiano si troverebbero in seri guai”.
«Gli americani gli dicono che quella profezia in qualche modo è stata confermata
dagli eventi successivi, ma gli spiegano pure “che è stato un errore» aver
diffuso quella nota”. Andreotti si mostra preoccupato che altri messaggi possano
essere resi pubblici”. Messaggi con sue conversazioni “di alto livello e
sensibili”». Accennando alla “profezia” del consolato di Palermo, Andreotti di
fatto accusa gli Stati Uniti, alcuni ambiti ovviamente, di aver costruito il
processo a suo carico, creando quei pentiti che lo avrebbero poi portato alla
sbarra (davvero tanti i pentiti di quella stagione: un fenomeno unico, per le
sue proporzioni, nella storia d’Italia; ma magari nel processo sulla trattativa
Stato mafia, semmai andrà a compimento, si troverà qualche risposta a tale
inspiegabile anomalia). Nella loro risposta, di fatto gli americani accusano
Andreotti di aver reso noto quel documento: e ciò secondo loro sarebbe stato un
“errore”. Strana protesta data la natura del documento in questione. In realtà
quella americana sembra più un “avviso” rivolto al loro interlocutore a non
prendere altre iniziative simili. Minaccia alla quale Andreotti risponde per le
rime, accennando alla possibilità che possano sfuggirgli altre rivelazioni
“sensibili”. Al di là dello scambio di battute finale, che di questo si tratta
nella sostanza, resta la clamorosa vena profetica del documento del consolato
Usa a Palermo, in particolare sulla genesi della legione di pentiti che
avrebbero poi accusato Andreotti passando per Lima, il politico siciliano della
sua “corrente” (pentiti che non potevano essere ignorati dalla magistratura).
Val la pena ricordare, en passant, che già prima che iniziasse il processo
Andreotti, un pentito aveva provato ad accusare Lima di collusioni con la mafia:
tal Giovanni Pellegriti. Era il 1989 allora e Falcone lo accusa del reato di
calunnia aggravata e continuata in concorso con ignoti. Gli ignoti evocati da
Falcone non furono individuati, ma il magistrato riuscì egualmente a condannare
Pellegriti per calunnia. Poi Falcone verrà assassinato… il resto è storia. Una
storia ad oggi scritta dai vincitori di allora, ma che, come si evince da questi
cenni, riserva ancora sorprese.
«L’Italia è incapace di
reagire ai boss».
I dossier segreti Usa sulle stragi di mafia, scrivono Attilio
Bolzoni e Salvo Palazzolo su "La Repubblica" il 17 luglio 2017. Il dispaccio
indirizzato a Washington è del 23 luglio 1992, quattro giorni dopo l’uccisione
del procuratore Paolo Borsellino: «L’ultimo massacro della mafia contro il
simbolo delle speranze dei siciliani ha scioccato e ulteriormente infiammato la
gente, ormai stanca dell’influenza mafiosa che pesa sul futuro». Il console
generale americano a Palermo Mann nel suo messaggio (numero “P231430Z Jul 92”,
from Amconsul Palermo to AmEmbassy Rome and SecState WashDc) avverte la
segreteria di Stato: «Sono il governo e il sistema politico, che la gente valuta
nel loro fallimento... La reputazione internazionale dell’Italia, già messa a
dura prova dall’omicidio di Falcone, viene ulteriormente scalfita dall’uccisione
di Borsellino e dall’apparente incapacità del governo e delle istituzioni
politiche nel definire un piano d’azione contro la minaccia». Carteggi riservati
sull’Italia delle stragi. Le bombe di mafia commentate dagli americani in una
serie di comunicazioni che cominciano il 26 maggio 1992 – appena dopo Capaci – e
si chiudono il 2 luglio 1993, quando sono passati meno di due mesi dal massacro
di via dei Georgofili. Ci sono dentro i morti di mafia ma ci sono anche
personaggi sospettati di mafiosità come Giulio Andreotti. Documenti riservati e
recuperati al Dipartimento di Stato americano dal professore Andrea Spiri della
Luiss di Roma, una ricostruzione di quei mesi di terrore vista con gli occhi
degli americani. A Roma tremano, a Washington mettono in allarme tutte le sedi
consolari in Italia. L’ambasciatore Peter Secchia – è il 20 luglio 1992, il
giorno dopo la strage di via D’Amelio – incontra il nuovo procuratore capo di
Caltanissetta Giovanni Tinebra (il magistrato che deve indagare sulle uccisioni
di Falcone e Borsellino) e riferisce al governo americano: «Non ha nascosto di
essere sotto pressione…». E informa Washington che il procuratore ha chiesto
l’intervento dell’Fbi nelle indagini sugli attentati. Da Palermo è ancora il
console Mann che, il 20 luglio, inoltra un altro dispaccio alla segreteria di
Stato: «Borsellino era stato identificato poco prima dell’omicidio Falcone come
l’obiettivo di un assassinio commissionato dalla mafia stessa, stando alle
rivelazioni di mafioso in carcere che sta collaborando con le autorità
giudiziarie». Borsellino, un delitto annunciato. L’Italia è nel caos. Passano
alcuni mesi e alla procura di Palermo mettono sotto accusa per mafia l’ex
presidente del Consiglio Giulio Andreotti. È il 27 marzo del 1993, la richiesta
di autorizzazione a procedere al Senato è datata 14 aprile. L’uomo politico
italiano più importante dal dopoguerra – 7 volte capo del governo e 21 volte
ministro della Repubblica – chiede un incontro con l’ambasciata americana. Il
primo luglio del ‘93, «l’incaricato d’affari riceve a pranzo il presidente
Andreotti e il suo ex capo di gabinetto, Riccardo Sessa». Per gli americani, è
un incontro riservato. Annotano all’ambasciata di via Veneto nel dispaccio
numero P021616Z: «Abbiamo spiegato in modo chiaro che il pranzo doveva
intendersi come un incontro privato e che non avrebbe dovuto essere
strumentalizzato per scopi mediatici». Il report ha questo titolo: «L’accusato.
Parla Andreotti». Il testo riportato è all’inizio una lunga autodifesa:
«Andreotti ha fatto presente che negli anni ‘70, nelle sue vesti di presidente
del Consiglio, ha fatto trasferire i principali detenuti per mafia (compreso il
pentito Buscetta, uno dei suoi attuali accusatori) da Palermo in un carcere di
massima sicurezza. Egli era a capo del governo anche nel momento in cui il
giudice antimafia Falcone fu portato a Roma come funzionario del ministero della
Giustizia. Più tardi, sulla scia dell’assassinio di Falcone, il suo governo ha
varato la normativa che si è rivelata così efficace negli ultimi mesi. La mafia,
ha detto Andreotti, si sta vendicando di lui». Poi gli americani annotano altre
parole di Andreotti: «Questa vendetta viene sfruttata dai politici della Rete di
Orlando, alcuni dei quali egli ha descritto come molto vicini alla mafia, e da
vecchi comunisti implacabili come il presidente della Commissione parlamentare
antimafia (Luciano Violante, ndr)...». Le accuse dell’ex presidente del
Consiglio non si fermano lì: «Con ogni probabilità sono coinvolti anche mafiosi
americani e possibili spezzoni “deviati” dei servizi segreti italiani oltre che
dello United States Marshall Service». Gli americani chiedono ad Andreotti se è
ancora convinto, dopo l’esecuzione di Salvo Lima, dell’estraneità agli ambienti
mafiosi del suo amico siciliano: «Lui ha risposto di non avere mai avuto prova
evidente di un simile rapporto, sostenendo che le dichiarazioni sul punto rese
dai pentiti non sono chiare e convincenti». Ma ad un certo punto è Andreotti a
fare domande. Viene segnalato nel report: «Ha chiesto informazioni sulla
diffusione da parte del governo americano di un dispaccio del 1984 proveniente
dal nostro Consolato di Palermo, nel quale viene riferito che, se i presunti
legami di Lima con la mafia fossero confermati, allora sia Andreotti che
l’intero regime politico italiano si troverebbero in seri guai». Gli americani
gli dicono che quella profezia in qualche modo è stata confermata dagli eventi
successivi, ma gli spiegano pure «che è stato un errore» aver diffuso quella
nota. Andreotti si mostra preoccupato che altri messaggi «possano essere resi
pubblici». Messaggi con sue conversazioni «di alto livello e sensibili».
Così il Divo fregò anche
gli Usa. Dai
file rivelati da WikiLeaks emerge come la diplomazia americana non riuscisse a
capirci molto del potente politico democristiano: e alla fine, estenuata dai
suoi misteri, preferiva puntare su Forlani e Cossiga, scrive Stefania Maurizio
il 7 maggio 2013 su “L’Espresso". Per tutti è l'uomo dei misteri d'Italia. E
Giulio Andreotti resta un personaggio difficilmente decifrabile anche quando si
hanno in mano le carte per raccontarlo. Settecentocinquantanove documenti
contenuti nel giacimento dei "Kissinger Cables" di WikiLeaks, che vanno dal 1974
al 1976 e che "l'Espresso" pubblica in esclusiva per l'Italia in collaborazione
con "Repubblica", ne restituiscono – manco a dirlo - un'immagine enigmatica. Non
è il leader democristiano che ha una strategia di lungo corso che gli americani
combattono con le unghie e con i denti, com'è Aldo Moro (che la diplomazia Usa
vede come fumo negli occhi per il suo dialogo con il Pci). Non è il cavallo di
razza della Dc con cui gli americani hanno un rapporto di complicità, comE
Francesco Cossiga, con cui via Veneto si appassiona a ragionare delle strategie
migliori per evitare l'infiltrazione dei comunisti negli apparati dello Stato
(dai servizi segreti all'Arma dei carabinieri). Non è «l'italiano più
profondamente morale che l'ambasciata abbia mai conosciuto», come è il Dc
Benigno Zaccagnini, un nemico per gli Usa perché troppo vicino a Moro e al
portare al "compromesso storico". E allora chi è il Giulio Andreotti che esce
dai "Kissinger Cables"? Un grigio sacerdote del potere. Intelligente, certo. Ma
piatto come un contabile e sprovvisto di quell'arguzia che, da noi, lo ha reso
celebre per battute memorabili. L'uomo che ha incarnato il Potere granitico e
immarcescibile, il depositario dei segreti della Repubblica, esce dai "Kissinger
Cables" come un personaggio evanescente. Non un file che lo sorprenda a parlare
con gli americani con slancio, come fa Cossiga. Non un documento che colpisca
per una sua analisi, un'invettiva o anche un commento velenoso contro un
avversario politico. Dov'è il Belzebù, il luciferino custode degli arcana
imperii? Nel database non c'è traccia. Tutto quello che i cablo ricompongono è
un mosaico di mosse, riti e trattative quotidiane, che parcellizzano l'enorme
potere del personaggio: Andreotti sembra riuscire a camuffarlo e farlo sparire
anche da qui. Per gli americani, certo, è un amico. Quando nel 1974 la Grecia,
appena uscita dalla stagione dei Colonnelli, minaccia di uscire dalla Nato, gli
Usa si affidano alla mediazione dell'allora ministro della Difesa, Giulio
Andreotti: «Uno dei nostri migliori amici in Italia", scrive l'ambasciatore John
Volpe al Dipartimento di stato. E poi: «Sono fiducioso che lui voglia
sinceramente essere utile". Il segretario Henry Kissinger, allora, autorizza via
Veneto a fare un briefing con il ministro sulla vicenda, ma senza lasciargli in
mano alcun documento. Forse anche gli americani temevano i suoi archivi. Sono
anni di scandali, stragi e trame. La diplomazia americana non gli perdona il suo
comportamento nello scandalo del Sid, i potenti servizi segreti di Vito Miceli,
al centro di mille disegni eversivi. «La gestione di Andreotti dell'affare Sid,
che ha portato all'arresto dell'ex capo Miceli", scrivono, "ha provocato
notevoli critiche da parte dei circoli moderati e conservatori e militari, come
anche un violento attacco da parte del partito neofascista Msi". Secondo quanto
riportato sui cablo, è per questa gestione che Andreotti viene fatto fuori come
ministro della Difesa nel 1974. E gli americani non sembrano affatto
dispiaciuti. Tutti gli arresti che ruotano intorno all'eversione di destra - da
Amos Spiazzi, dell'organizzazione neofascista "Rosa dei Venti", fino quella di
Miceli - irritano moltissimo gli americani, convinti che «questa caccia alle
streghe in corso» avvantaggi la sinistra, che può usarla a livello mediatico.
Sull'anticomunismo di Andreotti, però, gli Stati Uniti non hanno dubbi: «E' uno
dei pochi leader Dc che ha la capacità di guidare nel migliore dei modi la Dc
contro i piani del compromesso storico con il Pci», scrivono. Allo stesso tempo,
però, sono consapevoli che, politicamente, è un realista, «un politico furbo»,
con cui devono relazionarsi in modo «franco ed energico». Dopo le elezioni del
giugno 1976, quelle del rischio del "sorpasso storico" del Pci di Berlinguer
sulla Dc, «Andreotti sottolinea che è necessario guardare alla realtà della
politica italiana e che la Dc di trova ora davanti alla possibilità che il
Partito comunista formi un governo con i socialisti, i socialdemocratici, i
repubblicani, i radicali e democrazia proletaria. Di fronte a questa situazione
la Dc o lavora a un accordo con il Pci, o va all'opposizione o indice nuove
elezioni». Ma poiché né Andreotti né i colleghi credono che le ultime vie
alternative siano percorribili, «sarebbe meglio cercare di accomodarsi con il
Pci in un modo che non implichi alcun ruolo di governo per i comunisti in
Italia». Di fronte a questo lucido realismo, gli americani replicano in modo
franco ed fermo, giocando la carta del ricatto finanziario: «Sarebbe molto
difficile per gli Stati Uniti e, presumibilmente, per gli altri partner europei
fornire assistenza economica e di altro tipo all'Italia nel caso in cui il Pci
avesse un importante ruolo nella formazione del governo», chiarisce
l'ambasciatore Usa con Andreotti, sottolineando che la politica dell'America
rimarrà la stessa negli anni a venire, indipendentemente da un'amministrazione
democratica o repubblicana. Giulio Andreotti ne prende atto e consiglia agli
americani di coltivarsi Bettino Craxi e i socialisti in funzione anticomunista.
Proprio quel Craxi che poi lo ribattezzò 'Belzebù' per le sue trame
luciferine. Il database non lascia dubbi su chi sono gli uomini su cui, nel '76,
punta la diplomazia americana per tenere l'Italia al riparo dai comunisti:
Andreotti, Craxi e Forlani, quest'ultimo è il leader che vogliono alla guida
della Dc. Non l'onestissimo Zaccagnini, pericolosamente vicino a Moro. Puntano
su Forlani, ma non vogliono «appoggiarlo apertamente, perché sarebbe
controproducente» e forse «verrebbe usato per confermare le speculazioni che nel
1972, quando era segretario di partito, ha avuto a che fare con la Cia». Quanto
a Craxi, gli Usa sembrano prendere sul serio i consigli di Andreotti e sono
particolarmente soddisfatti che «il suo [di Bettino] viscerale anticomunismo sia
ben nascosto dall'occhio pubblico». Trenta anni dopo questi cablogrammi,
Andreotti, Craxi e Forlani sono tramontati. E del 'divo Giulio' nei file di
WikiLeaks che vanno dagli anni 2002 al 2010, si ricordano appena le sue
traversie giudiziarie e che «è strettamente associato al Vaticano».
Nel labirinto delle stragi,
scrive Attilio Bolzoni il 16 luglio 2017 su "La Repubblica". In quei due mesi è
accaduto molto ma non tutto. Dal 23 maggio al 19 luglio 1992, cinquantasette
giorni, bombe e autobombe, ucciso Giovanni Falcone, ucciso Paolo Borsellino.
Tanti i segreti che sono stati seppelliti in questo quarto di secolo, tante le
verità che ancora l'Italia non conosce. A farci entrare nel labirinto delle
stragi per il blog Mafie è Enrico Bellavia, giornalista di Repubblica che con il
suo sapere ci accompagna dall'Addaura ai grandi misteri che ancora si inseguono
dopo venticinque anni. E' un lungo racconto ma non è solo un racconto. E' anche
un ragionamento intorno a fatti e trame che portano Bellavia a un convincimento:
per capire cosa è avvenuto nell'estate del 1992 non bisogna guardare indietro ma
bisogna guardare avanti: «Non a quello che le vittime avevano fatto ma a quello
che avrebbero potuto fare». Delitti preventivi. Una ricostruzione divisa in una
ventina di capitoli, vicende tutte legate una all'altra anche se lontane nel
tempo. C'è l'intrigo della trattativa Stato-mafia e c'è l'oscura parentesi della
dissociazione "morbida" che avrebbero voluto alcuni boss dopo la repressione
poliziesca-giudiziaria che ha colpito Cosa Nostra, ci sono i retroscena di quel
rapporto sugli appalti dei carabinieri dei reparti speciali con le grandi
aziende del Nord in affari con Totò Riina, c'è il ricordo degli ultimi giorni
del procuratore Borsellino che riceve le confidenze di Gaspare Mutolo e di
Leonardo Messina. Un'estate del 1992 sospesa nel prima e nel dopo. Con eventi
ancora oggi indecifrabili. Le telefonate di rivendicazione della famigerata
Falange Armata. E il "suicidio" nel carcere di Rebibbia di Antonino Gioè, uno di
quei mafiosi che partecipò alle fasi preparatorie dell'attentato di Capaci e che
fu trovato cadavere ventiquattro ore prima delle esplosioni - il 27 luglio del
1993 - in via Palestro a Milano e davanti alle basiliche romane. Con
l'apparizione improvvisa di personaggi che hanno depistato le inchieste sino ad
affossarle. Come Vincenzo Scarantino, il "pupo vestito", il pentito fasullo di
via D'Amelio creduto oltre ogni ragionevole limite da qualche poliziotto e da
schiere di magistrati. Come Massimo Ciancimino, il figlio dell'ex sindaco
mafioso di Palermo che ha spacciato informazioni tarocche per conto proprio o
per conto terzi. Venticinque anni dopo - nonostante le inchieste giudiziarie e
gli ergastoli che hanno rinchiuso per sempre nelle segrete del 41 bis i capi
della Cupola - siamo ancora dentro il labirinto. Enrico Bellavia ci fornisce una
guida per muoverci fra le ombre, ci fa capire qualcosa di più.
Quei delitti "preventivi",
scrive Enrico Bellavia, Giornalista di Repubblica, il 16 luglio 2017. Nel
rosario di sangue della Sicilia Anni Novanta è difficile rintracciare il primo
dei grani. Figuriamoci l’ultimo. Ma da dove partire, però, se non dall’Addaura,
dal fallito attentato a Giovanni Falcone: 21 giugno 1989. L’anno della grande
delegittimazione di un bersaglio che su quella scogliera incontrò per la prima
volta il tritolo: 58 candelotti in una borsa da sub. Immaginatela ora così la
lenta agonia di un uomo che sa che la sua ora è arrivata con i boia, per
coincidenze o deliberato calcolo, gli lasciano ancora tre anni di vita. Se vita
è girare con la morte addosso. E con la danza macabra dei detrattori intorno. A
Falcone avevano negato ogni cosa, una promozione, un incarico, un
riconoscimento, perfino un salvacondotto. E quando, nel 1991 se lo era trovato
da solo andandosene a Roma, al ministero di Grazia e Giustizia, direttore degli
Affari Penali, ecco che il ballo era ripreso con più vigore. Archiviato in un
soffio quel vento di libertà che il primo maxiprocesso, la sua creatura, frutto
del suo metodo, aveva regalato al Paese, Falcone era tornato ad essere solo e
unicamente un bersaglio. Dei nemici, di tanti colleghi, della politica. Mafia e
antimafia erano lì a disputarsi le sue spoglie in vita. A parare e a schivare, a
rispondere anche per lui, uno dei pochi, pochissimi amici, che gli fosse davvero
rimasto accanto: Paolo Borselllino. Ma Falcone, era deciso, doveva morire: per
il maxiprocesso, certo, ma per impedire che potesse colpire ancora e più in alto
di prima. Guardiamo ai morti di mafia sposando sempre la tesi della vendetta,
sicuri che al passato bisogna guardare per capire, quasi che l’omicidio trovi
all’indietro la ragione della sua essenza. Non rendendocene conto, ricalchiamo
ciò che accade in Cosa Nostra quando i bravi ragazzi credono o fingono di
credere a ciò che i capi raccontano. Così il piombo è sempre una risposta, la
reazione, legittima dal loro punto di vista, a un’offesa pregressa. E invece
nelle stragi, in quella di Capaci e ancora di più in quella di via d’Amelio, è
avanti che bisogna guardare per capire. Non a quello che le vittime avevano
fatto ma a quello che avrebbero potuto fare. Delitti preventivi, sì. Questo sono
state le stragi e le premesse che le hanno rese possibili sono lì a raccontarlo.
Molte, troppe domande, lungo questa storia sono senza risposta. Ma proviamo a
ripassarle. Perché ogni interrogativo è uno snodo, un bivio di quel labirinto
nel quale ogni anfratto è un capitolo che rimanda agli altri. Che si porta
dietro dubbi collegati ad altri dubbi. Incarnati dai personaggi noti e meno noti
che però hanno lasciato le loro impronte in più di un passaggio di questo
dedalo.
Talpe, spie e traditori,
continua Enrico Bellavia - Giornalista di Repubblica. L’Addaura, partiamo allora
da lì, lasciando in ombra il contesto e tirando fuori alcuni fatti e alcune
domande irrisolte. Chi avvertì i sicari di Cosa nostra che il giudice avrebbe
fatto ritorno a casa a quell’ora - nella sua villa sul litorale di Palermo per
concedersi una pausa e deliziare i suoi ospiti durante una rogatoria - con i
magistrati elvetici che indagavano sul riciclaggio della mafia in Svizzera? Chi
fu la talpa che corse a informare lo squadrone di sub pronti all’attacco che sì
il tritolo poteva essere piazzato a quell’ora in riva al mare, nel punto in cui,
Falcone si sarebbe immerso? Sappiamo adesso, perché lo disse Falcone, che a
salvargli la vita fu un giovane poliziotto che lavorava al commissariato San
Lorenzo. Si chiamava Nino Agostino. Lo uccisero il 5 agosto 1989, quarantasei
giorni dopo il fallito attentato dell’Addaura. Dal suo armadio sparirono delle
carte importanti che un collega confessò al telefono di aver distrutto. Il padre
si ricordò di aver visto una settimana prima nei pressi di casa del figlio uno
strano personaggio, uno con "la faccia da mostro", presentatosi a cercarlo
insieme con un collega poliziotto. Bisogna tenere bene a mente questo
particolare perché avremo modo di tornarci. Con Agostino morì la moglie incinta,
Ida Castelluccio. E, uccidendola, eliminarono con ogni probabilità l’unica
testimone diretta dell’avventura umana di un servitore dello Stato al lavoro
nell’avamposto più ostile e infido che si potesse immaginare.Talpe e spie
dappertutto intorno ad Agostino, pronte a impedirgli di rivelare in che modo si
fosse imbattuto nella notizia che gli permise di evitare la strage dell’Addaura.
Un altro ragazzo ci rimise la vita: si chiamava Emanuele Piazza. Lavorava già
nei "servizi". Ma i suoi capi per lungo tempo hanno negato. Era agli inizi, in
prova, e si era gettato nell’impresa di dare la caccia ai latitanti. Faceva base
al commissariato San Lorenzo, lo stesso in cui lavorava Agostino. In palestra,
Piazza aveva agganciato Francesco Onorato, il pugile, superkiller della cosca
dei Madonia di San Lorenzo e dei Galatolo, loro fidi alleati: due piedi nella
mafia ma, come vedremo, molte orecchie tra gli sbirri. Ligio al dovere, Piazza,
passava le informazioni ai superiori. Dopotutto era stato il superpoliziotto
Luigi De Sena, al vertice del Sisde, poi anche parlamentare del Pd, a
ingaggiarlo. Glielo aveva presentato il suo autista, un ispettore che finirà
condannato per aver favorito i Graviano di Brancaccio. Un giorno di marzo del
1990, Piazza lasciò la porta di casa aperta come se fosse uscito con qualcuno
che conosceva per rientrare poco dopo. Non tornò più. Chi tradì Piazza? Chi
tradì Agostino? E chi aveva tradito una prima volta Falcone?
Speciale Via D'Amelio.
Storia di un colossale depistaggio,
scrive il 17 Luglio 2017 Gea Ceccarelli su "Articolo 3". E' passato alla storia
come il più grande depistaggio avvenuto in Italia, e non è un'iperbole. Si
tratta della ragnatela di mezze verità, omissioni e menzogne che, dal '92 a
oggi, hanno vorticato attorno alla strage di Via D'Amelio, avvenuta il 19 luglio
di quell'anno. Lì, sotto la casa della madre del giudice Paolo Borsellino,
un'autobomba esplose, facendo saltare in aria il magistrato e gli uomini della
scorta. Si trattava del secondo attentato dinamitardo in meno di due mesi:
cinquantasette giorni prima, a Capaci, moriva nel cosiddetto “attentatuni” il
collega e amico di Borsellino, Falcone. E' in questo contesto che bisogna
immaginare sia nata l'idea del depistaggio. Il tentativo di coprire
probabilmente i veri responsabili e, al contempo, tranquillizzare la
popolazione. Il come era semplice: trovando un capro espiatorio perfetto. Le
indagini sulla strage di via D'Amelio vennero subito assegnate al
“superpoliziotto” Arnaldo La Barbera. Capo della squadra mobile di Palermo, con
un passato all'interno del Sisde, con il nome in codice di Catullo. Una
personalità controversa, quella di “Arnold”, come lo chiamavano in Questura.
Quando morì, nel 2002, per un tumore al cervello, i giornali non persero tempo a
dipingerlo come uomo tutto di un pezzo. Almeno finché, con nuovi processi, nuovi
procedimenti e nuove indagini, alcune ombre cominciarono a intaccarne
l'integrità morale. Secondo quanto ricostruito dal collaboratore di
giustizia Franco Di Carlo, per esempio, La Barbera era uno dei tre agenti
segreti che si recarono da lui in visita, in carcere, per chiedere un aiuto atto
ad allontanare Falcone da Palermo, dove “stava facendo troppi danni”. Una visita
che si colloca temporalmente poco prima del fallito attentato all'Addaura, il 21
giugno dell'89. Una provocazione o un tentativo di omicidio, quello, di cui si
occuparono anche i “cacciatori di latitanti” Emanuele Piazza e Nino Agostino,
uccisi poco dopo, entrambi in circostanze misteriose. Il secondo, in
particolare, venne freddato assieme alla moglie incinta: subito si parlò di
delitto passionale, pista avallata anche da La Barbera, ma clamorosamente falsa.
Agostino, nei giorni prima di morire, stava indagando su quei candelotti
esplosivi rinvenuti sulla spiaggia di fronte alla villa di Falcone: secondo il
pentito Oreste Pagano, pertanto, venne ucciso poiché “aveva scoperto i
collegamenti fra le cosche ed alcuni componenti della questura”. Chi siano
questi “componenti” non è dato saperlo: certo è che subito dopo l’assassinio
dell’agente, La Barbera inviò un suo uomo di fiducia a compiere una
perquisizione non autorizzata in casa della vittima, facendo sparire documenti
che Agostino stesso aveva indicato come importanti al fine dell’emersione della
verità. Ma di tutto questo, nel '92, non si sapeva nulla. E il superpoliziotto
venne incaricato di indagare proprio sulla strage di via D'Amelio. Indagini
frenetiche, talvolta grottesche, certo anomale: diversi testimoni non vennero
ascoltati, il consulente informatico Gioacchino Genchi venne estromesso dalle
indagini improvvisamente, nessuno si interrogò su dove fossero finite la borsa e
l'agenda rossa di Paolo Borsellino. Ciononostante, a settembre, venne fatto per
la prima volta il nome del colpevole della strage: Vincenzo Scarantino, 27 anni,
nipote di un boss della Guadagna: era stato lui a rubare la Fiat 126 poi
detonata. Giustizia compiuta. O quasi: più iniziavano a emergere dettagli sulla
figura di Scarantino, più tutto appariva incredibile. Era un piccolo
delinquente, non affiliato a Cosa Nostra, che si era auto-accusato della strage,
cambiando diverse volte versione. I pm di Palermo, che lo ascoltarono per altri
procedimenti, lo giudicarono totalmente inattendibile; diversa opinione per
quelli di Caltanissetta, che lo giudicavano perfettamente credibile. E così fu.
La sua versione venne, nonostante tutto, avvallata in tre diversi processi: il
Borsellino 1, Borsellino 2, Borsellino ter. Nove persone vennero condannate per
la strage. E a nessuno, o quasi, importò più che, nel frattempo, Scarantino
avesse cominciato a rendere pubbliche le sue denunce: era stato costretto a
mentire, anche da La Barbera, era stato vessato e torturato affinché sostenesse
di essere lui il colpevole.
Nel frattempo, La Barbera
proseguì nella sua scalata professionale, fino alla prematura morte. Un eroe,
per tutti, almeno fino al 2008, quando, sulla scena non comparve Gaspare
Spatuzza. Fu lui a squarciare il velo: era stato lui a organizzare la strage di
via D'Amelio. La verità, quella vera, riemerge dal passato. Lo fa, stavolta, in
maniera inattaccabile. Spatuzza ricostruisce tutto in maniera precisa, decisa,
fornisce prove e riscontri alle proprie dichiarazioni. Grazie a lui, gli
innocenti vengono scarcerati, sebbene si sia dovuto attendere fino al 13 luglio
scorso, prima che venissero definitivamente assolti nella revisione del processo
a loro carico. Nel frattempo, ad aprile, il Borsellino Quater, avviato nel 2012
proprio a seguito delle dichiarazioni rilasciate da Spatuzza, si conclude con
una sentenza quantomeno storica: Scarantino è stato “indotto a mentire” da
“apparati di polizia”. Il timore è che, adesso, tutta la responsabilità verrà
scaricata su La Barbera, dimenticando gli altri. Colleghi e sottoposti del
superpoliziotto, certo, ma anche giudici e pm che hanno, di fatto, avallato per
decenni una menzogna. Per Salvatore Borsellino, due nomi su tutti: Tinebra e
Palma. Per altri, più che altro detrattori del processo sulla trattativa
Stato-mafia, anche il giudice Di Matteo. Ma era stato proprio Salvatore
Borsellino, mesi fa, a denunciare come i primi due avessero impedito a
Scarantino di raccontare la verità al terzo pm, ricordando anche le
dichiarazioni di questi al processo: “Lo dicevo sempre che non sapevo niente
sulla strage e Tinebra mi disse che questa storia della collaborazione dovevo
prenderla come un lavoro”, aveva spiegato il falso pentito della Guadagna, in
quell'occasione.
E riguardo Annamaria Palma,
che, secondo le dichiarazioni dell'uomo, avrebbe consegnato ad uno dei
poliziotti addetti a Scarantino dei verbali d'interrogatorio con espliciti
appunti? Anche lei: lo avrebbe rassicurato di non preoccuparsi di accusare
innocenti in quanto “se non hanno fatto questo hanno fatto altro”. Il falso
pentito, ascoltato dai giudici in aula, aveva anche raccontato di aver avuto i
numeri di cellulare dei due magistrati: “Li sentivo. Avevo i numeri di cellulare
di Tinebra, della Palma, di Petralia”. Ma non di Di Matteo. Lui, (Di Matteo ndr)
aveva rivelato Scarantino, “l’ho incontrato una volta e non gli ho mai detto che
gli imputati erano innocenti”. D'altronde, “non è che ho fatto tanti
interrogatori con lui perché li facevo sempre con Palma e Petralia. Per quello
che ricordo però a Di Matteo non dissi nulla, anche perché lo vedevo più rigido
e meno disponibile degli altri”. Escluso Di Matteo, resta comunque lunga lista
di presunti responsabili, i cui nomi - si spera - riemergeranno dal passato
grazie a nuove indagini. Nel frattempo, altri due ne sono già spuntati, anche se
piuttosto in sordina. Li cita Enrico Deaglio, sul Post, ricordando un episodio
eclatante del 2013, quando, durante un'audizione del processo Borsellino Quater,
il legale Flavio Sinatra, difensore degli imputati Salvino Madonia e Vittorio
Tutino, controinterrogò Spatuzza, domandandogli, tra l'altro, se avesse già
raccontato a qualcuno, prima del 2008, l'estraneità di Scarantino alla strage.
Il collaboratore negò e, in quel momento, Sinatra estrasse un verbale di
interrogatorio datato 1998, in cui l’allora capo della Procura nazionale
antimafia Pier Luigi Vigna (morto nel 2012) e il suo vice, Piero Grasso,
raccoglievano diverse informazioni da parte di Spatuzza. Tra queste, appunto che
Scarantino era un falso pentito, inventato dalla polizia.
Proprio come confermato
dall'ultima sentenza; solo, 19 anni dopo.
Borsellino, la trattativa e
il più grande depistaggio di sempre,
scrive ancora Gea Ceccarelli su "Articolo 3" a luglio 2016. Ventiquattro anni.
Tanto tempo è passato da quel 19 luglio 1992, quando, in via D'Amelio, a
Palermo, una 126 imbottita di tritolo fece saltare in aria il giudice Paolo
Borsellino e cinque ragazzi della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi,
Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina. A tanti anni di distanza,
però, i motivi della strage, così come i veri colpevoli, sono ancora nell'ombra.
Per anni si sostenne che Borsellino fosse stato ammazzato perché scomodo, perché
giudice antimafia, perché, come Giovanni Falcone, perseguiva un ideale di
giustizia. Perchè troppo esposto, magari proprio da chi, come Scotti, l'aveva
candidato pubblicamente al vertice della Superprocura Antimafia. Ed è vero. Ma
sono anche tanti, ora, che si domandano se non c'entri, in quell'eccidio così
frettoloso, anche qualcosa riguardante la trattativa Stato-mafia: era possibile,
infatti, che Paolo Borsellino avesse scoperto come lo Stato avesse contattato
Cosa Nostra per raggiungere un accordo, e si fosse messo di traverso? Non appare
un'eventualità così impossibile. Paolo Borsellino il giorno prima di morire,
parlando con la moglie Agnese, rivelò di sapere che, a ucciderlo, non sarebbe
stata soltanto la mafia. In un'altra occasione, in quei 57 giorni che separano
la strage di Capaci da quella di via D'Amelio, venne trovato a piangere,
sostenendo di esser stato tradito da un amico. E ancora: al ritorno da un
viaggio a Roma (in quel periodo si moltiplicarono), si sfogò spiegando di aver
visto, nella capitale, il vero volto della mafia. C'è, in particolare, uno di
quei viaggi nella città eterna, a restar impresso più di altri. Lo racconta il
pentito Gaspare Mutolo, che, quel giorno, era interrogato da Borsellino. Era il
primo luglio e il giudice venne interrotto da una telefonata dal Ministero
dell’Interno: il neoministro Nicola Mancino, subentrato a Scotti, voleva
conferire con lui. Secondo quanto riportò Mutolo, all’incontro Mancino e
Borsellino non erano soli: “Borsellino tornò dopo circa due ore – ricordò
infatti – non commentò niente, ma era molto arrabbiato. Io mi misi a ridere
perché aveva due sigarette accese contemporaneamente, una in bocca e l’altra nel
posacenere, tanto era agitato. Poi ho capito perché mi disse che dopo aver
parlato con il ministro incontrò Vincenzo Parisi (allora capo della Polizia) e
Bruno Contrada (numero tre nella catena di comando del Sisde ndr) che gli
avevano detto di sapere del mio interrogatorio. Contrada mostrò di sapere
dell’interrogatorio in corso con me che doveva essere segretissimo. Anzi gli
disse: so che è con Mutolo, me lo saluti”. Mancino, però, negli anni successivi,
smentirà il tutto, sostenendo di non aver mai incontrato il magistrato e che, a
quel tempo, non sapeva nemmeno che faccia avesse. Ancor prima, nell'ultima
settimana di giugno, il capitano del Ros De Donno avvicinò Liliana Ferraro,
stretta collaboratrice di Giovanni Falcone, per informarla dei contatti presi
con Vito Ciancimino tramite suo figlio Massimo nell'ottica di creare un canale
di dialogo con Cosa Nostra. Da parte sua, la Ferraro riferì il tutto al ministro
della Giustizia Martelli e a Paolo Borsellino, il quale organizzò subito un
incontro con i carabinieri del Ros, De Donno, ma anche Mori, che si tenne il 25
giugno. Di cosa parlarono, è impossibile saperlo. Certo è che pochi giorni dopo,
a Palermo, venne denunciato il furto di una 126. E' quindi possibile che, dietro
la strage, ci siano ombre istituzionali? Di questo era convinto per esempio Totò
Riina che, nel 2009, riferendosi a Borsellino, sosteneva: "L'hanno ammazzato
loro. Lo può dire tranquillamente a tutti, anche ai giornalisti. Io sono stanco
di fare il parafulmine d'Italia". Quando poi tornò a parlare, nel 2013, con il
suo compagno d'aria Alberto Lorusso, aggiunse: "L'agenda rossa?", diceva,
intercettato. "I servizi segreti, gliel'hanno presa". L'agenda rossa è un altro
dei misteri che gravitano attorno la strage di via D'Amelio. Per quasi due
mesi Borsellino non fece altro che ripetere di voler essere interrogato dalla
Procura di Caltanissetta, quella titolare delle indagini sulla strage di Capaci.
Voleva riferire quanto aveva scoperto, quanto sapeva e che non poteva render
pubblico, per il segreto d'inchiesta. Nessuno lo volle ascoltare. E' presumibile
che avesse comunque segnato tutto sulla sua agenda, che aveva con sé anche quel
19 luglio, e che non fu mai più ritrovata. Ma, oltre a Riina, anche Gaspare
Spatuzza ha parlato di servizi segreti. Lui, uno dei veri esecutori della
strage, sostenne infatti che, all'interno del garage in cui era stata portata la
126 per imbottirla di tritolo, si trovava anche un uomo estraneo a Cosa Nostra,
un agente dei servizi. Fu una delle tante, importanti, rivelazioni che Spatuzza
offrì, permettendo di riscrivere la storia giudiziaria di via D'Amelio e
smantellare il più grande depistaggio di sempre, quello del falso pentito
Vincenzo Scarantino, che aveva portato alla condanna di
innocenti. Successivamente, Scarantino sostenne di esser stato costretto a
mentire, dal super poliziotto Arnaldo La Barbera -colui che, secondo l'ex boss
Di Carlo si recò nelle carceri inglesi in cui si trovava recluso per avere un
contatto con Cosa Nostra per allontanare Falcone- e magistrati, tra cui Palma e
Tinebra: questi, raccontò Scarantino, lo avrebbero anche invitato a prendere
"questa cosa della collaborazione come un lavoro", e di star tranquillo,
nell'accusare innocenti, perché "se non hanno fatto questo, hanno fatto altro".
Le ultime dichiarazioni, Scarantino le ha rilasciate qualche anno fa, dagli
studi di Servizio Pubblico. Fuori dallo studio, però, lo attendevano le forze
dell'ordine per arrestarlo. Ha parlato e, con tempistiche quantomeno anomale, è
finito con l'essere arrestato con l'accusa di stupro; una storia di cui non
s'era mai avuta notizia prima e che, l'anno scorso, s'è conclusa con la sua
assoluzione. Intanto, però, il messaggio di tacere era stato inviato.
La storia del depistaggio
su Via D’Amelio,
scrive Enrico Deaglio il 13 luglio 2017 su “Il Post". Come la procura di
Caltanissetta si ostinò per anni a proteggere un'accusa falsificata, facendo
condannare persone estranee all'attentato a Paolo Borsellino. Questo articolo è
parte di uno speciale sul depistaggio con cui agenti di polizia e magistrati
costruirono e portarono a sentenza una versione falsa sui responsabili della
morte del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, e
sul documento investigativo del 1998 – reso pubblico per un “disguido” nel 2013
– che suggeriva questa tesi. Il 23 maggio scorso, in occasione del 25esimo
anniversario della strage di Capaci, la RAI ha organizzato un “evento” per
ricordare i tre eroi nazionali, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo
Borsellino, uccisi dalla mafia insieme alle loro scorte in due successivi
attentati nel 1992: il primo sull’autostrada all’altezza di Capaci, vicino a
Palermo, dove fu fatta esplodere l’auto del magistrato Giovanni Falcone
uccidendo lui e sua moglie, anche lei magistrato, e tre uomini della scorta; il
secondo a Palermo in via D’Amelio, dove un’altra esplosione uccise il magistrato
Paolo Borsellino e cinque uomini della sua scorta. La serata televisiva è stata
guidata da Fabio Fazio che si è avvalso di molti contributi di personaggi
famosi. I contatti televisivi sono stati 13 milioni, a dimostrazione
dell’affetto che gli italiani continuano ad avere per i loro eroi uccisi, e ha
scontato, come spesso accade in queste rievocazioni, la retorica e
l’autoglorificazione delle cariche presenti che hanno assicurato: “non sono
morti invano, non accadrà mai più”. A un certo punto, però, qualcosa ha guastato
la celebrazione unanime. Sul palco è comparsa la signora Fiammetta Borsellino,
la figlia minore del magistrato, che nel 1992 aveva 19 anni. Negli anni, gli
italiani hanno imparato a conoscere e ad apprezzare la famiglia: Rita, la
sorella, che si è sobbarcata l’onere della testimonianza politica, come
europarlamentare e candidata a governatore della Sicilia; Lucia, la figlia
maggiore, già assessora regionale alla sanità, costretta alle dimissioni dopo
minacce disgustose e completamente false; Manfredi, il figlio, valente e schivo
commissario di polizia di Termini Imerese e Salvatore, il fratello, che guida un
movimento che chiede la verità sulle stragi. La moglie del giudice, la signora
Agnese, morta nel 2013, ha testimoniato negli ultimi anni della sua vita i
sospetti che il marito aveva sulle istituzioni (dicendo tra l’altro: «Paolo mi
confidò, sconvolto, che il generale dei Ros Antonio Subranni era “punciutu”»,
affiliato alla mafia). E dunque, Fiammetta, ora diventata una signora di 44
anni, con i capelli corti, vestita casualmente, è apparsa per la prima volta su
un palco; e con molta emozione, ha detto: Credo che ricordare la morte di mio
padre, di Giovanni Falcone, di Francesca e degli uomini della scorta, possa
contribuire a coltivare il valore della memoria. Quel valore necessario per
proiettarsi nel futuro con la ricchezza del passato significa anche dire in
maniera ferma da che parte stiamo, perché noi stiamo dalla loro parte, dalla
parte della legalità e della giustizia per le quali sono morti. Credo che con
questa stessa forza dobbiamo pretendere la restituzione di una verità che dia un
nome e un cognome a quelle menti raffinatissime che con le loro azioni e
omissioni hanno voluto eliminare questi servitori dello stato, quelle menti
raffinatissime che hanno permesso il passare infruttuoso delle ore successive
all’esplosione, ore fondamentali per l’acquisizione di prove che avrebbero
determinato lo sviluppo positivo delle indagini. Quelle prove a cui mio padre e
Giovanni tenevano così tanto. Tutto questo non può passare in secondo piano, e
non può passare in secondo piano che per via di false piste investigative ci
sono uomini che hanno scontato pene senza vedere in faccia i loro figli, come
quei giovani che sono morti nella strage di Capaci. Questa restituzione della
verità deve essere anche per loro. La verità è l’opposto della menzogna,
dobbiamo ogni giorno cercarla, pretenderla e ricordarcene non solo nei momenti
commemorativi. Solo così, guardando in faccia i nostri figli, potremmo dire loro
che siano in un paese libero, libero dal puzzo del potere e del ricatto mafioso.
Anche Fabio Fazio si era
commosso, e ha dato a Fiammetta Borsellino un’empatica carezza sulla schiena. Ma
evidentemente nemmeno Fazio ha il potere di far parlare i muti e l’appello non è
stato ripreso. La signora Fiammetta Borsellino si riferiva al fatto che, a
distanza di un quarto di secolo, non solo non si conosce quasi nulla del delitto
Borsellino, ma è tuttora in pieno svolgimento il più lungo depistaggio –
qualsiasi siano le ragioni che lo hanno determinato, probabilmente più d’una –
che la storia della nostra Repubblica ricordi; un depistaggio che ha
ostinatamente impedito la ricerca della verità, che ha mandato all’ergastolo (e
al 41 bis, il carcere severissimo) nove persone estranee a quell’accusa per 11
anni e ha coinvolto – restituendoli al mondo corrotti e umiliati di fatto, ma
fieri e soddisfatti pubblicamente – decine di investigatori, di magistrati e di
uomini delle istituzioni. Seguo questa storia dal giorno dello scoppio di via
D’Amelio, sono testimone del depistaggio fin dalle sue origini e cinque anni fa
ho pubblicato un libro che si chiama “Il vile agguato”, che parlava di tutto
ciò. Credo che questa vicenda sia la più grave – e tuttora molto oscura – della
recente storia d’Italia. Ora poi c’è molto di più. Esistono delle cose provate e
delle notizie che rispondono all’appello per la verità di Fiammetta Borsellino,
ma non ne parla nessuno.
La prima versione sulla
strage di via D’Amelio.
Le indagini sulla strage di via D’Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992, vennero
assegnate al “gruppo Falcone-Borsellino” guidato dal capo della Squadra Mobile
di Palermo Arnaldo La Barbera. L’iniziativa (confermata da un decreto urgente
della presidenza del consiglio) fu del prefetto Luigi De Sena, all’epoca capo
del Sisde, in seguito diventato senatore del PD, che è morto nel 2015: Arnaldo
La Barbera, che aveva trascorsi di carriera in Veneto come lui, era un suo
vecchio amico ed era stato anche suo confidente al Sisde, il servizio segreto
del ministero degli Interni. Ovvero: il Sisde affidò le indagini a un uomo del
Sisde (il servizio segreto aveva avuto anche un controverso accidente del caso:
il dirigente del Sisde Bruno Contrada, con il suo fedele assistente Lorenzo
Narracci, era casualmente in vacanza su una barca a vela di fronte al porto al
momento dello scoppio; furono tra i primi a esserne informati – con una
tempistica così rapida da essere oggetto di sospetti e accuse mai provate – e
poi ad arrivare sul posto). I giorni seguenti la strage di via D’Amelio –
causata da un’autobomba fatta esplodere davanti alla casa della madre di Paolo
Borsellino al momento dell’arrivo di quest’ultimo – furono di grande angoscia.
Magistrati e poliziotti di Palermo erano in rivolta, la famiglia Borsellino
aveva rifiutato i funerali di Stato, l’esercito italiano stava per scendere in
forze in Sicilia, la lira stava crollando sui mercati, il “nemico” (ma chi era?)
sembrava in grado di condurre a termine inaudite operazioni militari. C’era
bisogno di rincuorare l’opinione pubblica e di trovare un colpevole rapidamente.
La polizia comunicò immediatamente che la bomba era stata messa in
un’utilitaria. Già il 13 agosto il Sisde di Palermo annunciò di aver individuato
l’automobile usata e la carrozzeria dove era stata preparata; alla fine di
settembre venne nominato il “colpevole”, nella persona di Vincenzo Scarantino,
27 anni: era stato lui a organizzare il furto della Fiat 126. Lo accusavano
altri tre delinquenti arrestati un mese prima per violenza carnale. (Un mese
dopo, intanto, in seguito ad un’indagine collegata agli ultimi impegni
investigativi di Borsellino e sulla base delle dichiarazioni di alcuni pentiti,
venne arrestato per il reato di “concorso esterno in associazione mafiosa” il
numero tre del Sisde, Bruno Contrada, l’uomo che veleggiava e i cui uomini
avevano per primi intuito la pista Scarantino: sarebbe stato condannato con
sentenza definitiva nel 2006, ma dichiarata “ineseguibile” nei giorni scorsi in
seguito ai dubbi espressi dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sulla
validità del reato di “concorso esterno in associazione mafiosa”). Le prime
indagini furono, effettivamente, scandalose per una quantità enorme di omissioni
e di iniziative grottesche, quali quella di riempire 56 sacchi neri di detriti
dell’esplosione e di spedirli a Roma per farli valutare dall’FBI. Vennero
interrogati pochissimi testimoni, in particolare non vennero interrogati alcuni
inquilini del palazzo che dopo vent’anni si scoprì essere stati molto
importanti; il consulente informatico della polizia, Gioacchino Genchi, venne
estromesso dalle indagini da La Barbera; non si seppe nulla per tre mesi e mezzo
della borsa di Paolo Borsellino, che era rimasta sul sedile posteriore dell’auto
che lo trasportava e poi depositata in una questura. I familiari denunciarono
subito la scomparsa di un’agenda di colore rosso che il giudice portava sempre
con sé. Ma c’era Scarantino, e questo contava. Il suo arresto era stato
annunciato così dal procuratore Tinebra: «Siamo riusciti con un lavoro
meticoloso e di gruppo, con la partecipazione di magistrati, tecnici e
investigatori, che hanno lavorato in sintonia, a conseguire un risultato
importante quale l’arresto di uno degli esecutori della strage di via D’Amelio».
Appena di Scarantino si seppe qualcosa di più, fu però una vera delusione, tanto
apparve fasullo. Era un ragazzo, di bassissimo livello intellettuale, piccolo
spacciatore, non affiliato a Cosa Nostra benché nipote di un boss della
Guadagna, il quartiere meridionale di Palermo dove era conosciuto come lo scemo
della borgata. Però aveva confessato, e nei mesi seguenti questo personaggio
così improbabile, da semplice ladro d’auto che scambiava con qualche dose di
eroina, si trasfigurò in astuto organizzatore, reclutatore di un piccolo
esercito, stratega militare, partecipante di prestigio alle riunioni della
Cupola. Ma già di fronte alle obiezioni dei giornalisti nella prima conferenza
stampa il procuratore Tinebra aveva risposto: «Scarantino non è uomo di
manovalanza». Come denunciò subito l’avvocato Rosalba De Gregorio, difensore di
alcuni imputati coinvolti da Scarantino: «Scarantino era un insulto alla nostra
intelligenza». Messo a confronto con due grossi boss collaboranti, questi stessi
si indignarono che la polizia potesse pensare che Cosa Nostra si avvalesse di un
personaggio simile («Ma veramente date ascolto a questo individuo?»). I verbali
con gli esiti di quei confronti, sparirono: non li fecero sparire però i
servizi, ma i pm. L’inchiesta marciava spedita con molta hybris da parte di La
Barbera, sicuro che sarebbe riuscito a piazzare un prodotto che lui per primo
non avrebbe comprato. Il ragazzo stesso, peraltro, si smentiva, ritrattava,
denunciava, piangeva, ma nessuno gli dava retta malgrado emergessero via via
testimonianze di violenze e pressioni sulla sua famiglia, dei verbali ritoccati
e concordati, degli interrogatori condotti in modi anomali: le sue ritrattazioni
erano «tecniche di Cosa Nostra che conosciamo bene», scrisse il pm Nino Di
Matteo, che in una requisitoria sostenne che «la ritrattazione dello Scarantino
ha finito per avvalorare ancor di più le sue precedenti dichiarazioni»; «dietro
questa ritrattazione c’è la mafia» disse il pm Palma. Intanto, il procuratore di
Palermo Sabella che aveva interrogato Scarantino su altro lo aveva invece
ritenuto «fasullo dalla testa ai piedi»: «decidemmo di non dare alcun credito
alle sue rivelazioni». In tre successivi processi – il Borsellino 1, il
Borsellino 2, il Borsellino Ter – l’attendibilità di Scarantino venne
certificata da un’ottantina di giudici, tra Assise, Appello e Cassazione. Il
ragazzo aveva intanto denunciato torture a Pianosa, promesse, inganni, – arrivò
persino a fuggire dal suo rifugio e a telefonare al tg di Italia1 per denunciare
la sua situazione – ma i magistrati non vollero credergli e Scarantino riuscì a
ottenere solo pesanti condanne per calunnia. Arnaldo La Barbera, intanto, per
meriti scarantiniani, diventò prima Questore di Palermo e di Napoli, poi
Prefetto, poi capo dell’Ucigos, l’Ufficio centrale per le investigazioni
generali e per le operazioni speciali, un ufficio centrale della polizia di
stato. L’ultima immagine ce lo mostra con casco e scarpe da tennis all’assalto
della scuola Diaz durante il G8 del 2001 nella “giornata nera” della polizia
italiana. Allontanato dall’incarico dopo quello scandalo, La Barbera morì per un
tumore al cervello nel 2002 a soli 60 anni. Tutta la “baracca Scarantino”,
intanto, continuò placidamente fino al 2008, senza che nessuno – giornalisti,
politici, mafiologi, commissione antimafia, CSM – trovasse strano che, in mezzo
a tanti discorsi su strategie, trattative, struttura di Cosa Nostra, eccetera,
la realizzazione della strage di via D’Amelio fosse stata affidata a un ragazzo
bocciato tre volte in terza elementare; un ragazzo che non era stato neppure
ricompensato per la sua impresa, ma che dopo il “colpo del secolo” aveva
continuato a tramestare nel suo quartiere rubando gomme.
La seconda versione sulla
strage di via D’Amelio (quella vera).
Nel 2008 compare sulla scena lo spietato assassino di don Puglisi – un parroco
ucciso dalla mafia nel 1993 a Palermo – toccato improvvisamente dalle fede. Si
chiama Gaspare Spatuzza e, oltre a raccontare tutta la stagione delle stragi di
mafia degli anni Novanta di cui è stato protagonista, candidamente afferma:
«Scarantino non c’entra, la strage l’ho organizzata io». E fornisce prove,
indirizzi, particolari completamente diversi da quelli che fino ad allora una
schiera di magistrati aveva valutato “perfettamente riscontrati” con il pentito
“attendibilissimo” Scarantino (in sostanza, non avevano riscontrato un bel
niente: alla prima verifica sul campo di quello che disse Spatuzza sul furto
dell’auto si capì che quella verifica non era mai stata fatta sulla versione di
Scarantino). Così facendo, Spatuzza sta quindi dando dei fessi – nel migliore
dei casi – ad alcune decine di magistrati. Comunque, pur nell’imbarazzo, gli
ergastolani vengono scarcerati (alcuni hanno invece addirittura già scontato
tutta la pena per la collaborazione alla preparazione dell’attentato): ma non
assolti, si badi. Nove anni dopo, la revisione del loro processo si è conclusa
oggi, 13 luglio 2017 con l’assoluzione di tutti gli imputati. A Caltanissetta,
nel 2012, inizia invece il “Borsellino quater”, nato dalle confessioni di
Spatuzza e terminato il 18 aprile scorso con alcuni altri ergastoli e la
conferma della condanna per calunnia (nei confronti dei suoi coimputati) a
Scarantino, prescritta grazie all’attenuante di «essere stato indotto a
commettere il reato» da non meglio identificati «apparati di polizia». Si
aspettano, dopo 25 anni, le motivazioni, ma probabilmente le aspettative saranno
deluse: la colpa delle ingiuste condanne precedenti sarà addossata al defunto La
Barbera, nessun magistrato complice del depistaggio – in buona o cattiva fede –
sarà coinvolto. Dei poliziotti si dirà che sì, forse, avranno torturato un po’,
ma che le accuse contro di loro non avrebbero retto in aula. La gran parte
dell’informazione giornalistica continua a raccontare il depistaggio come “una
serie di bugie” del “falso pentito” Scarantino, che avrebbe ingannato decine di
esperti poliziotti e magistrati. Questo è lo scenario al momento del
“venticinquennale” e della serata RAI.
Intanto si aggiungono
ancora cose.
Ma intanto la procura di Palermo, dopo aver scovato un super pentito in Massimo
Ciancimino (infine completamente screditato, lui e il fantomatico “signor
Franco”, malgrado l’estesa promozione ricevuta da una affezionata parte
dell’informazione), dopo aver raccolto propositi implausibili dal vecchio Riina,
accusato il presidente della Repubblica di losche manovre (fino ad andare a
interrogare in modo inaudito il presidente al Quirinale), all’inizio di giugno
2017 diffonde un altro scoop. Breaking news su tutti i telefonini: Giuseppe
Graviano, il dimenticato boss di Brancaccio, è stato intercettato per ben un
anno nel solito cortiletto della cella del 41 bis, mentre colloquia con il
solito “detenuto civetta” incaricato di farlo parlare. E cosa dice? Prima di
tutto che ha messo incinta sua moglie in cella – mentre era in teoria
severamente ristretto al 41 bis – e poi che Silvio Berlusconi è un ingrato
traditore. Che lui lo ha fatto ricco, e poi gli ha fatto un “gran favore”. Ma
poi venne arrestato, proprio a Milano, pochi giorni prima delle elezioni del
1994 e quell’ingrato non è stato in grado di farlo uscire di galera, mentre
invece spendeva i suoi soldi (forse i soldi di Graviano stesso) con le puttane.
Pronta la smentita dell’avvocato di Berlusconi, Ghedini, e le ricostruzioni che
in gran parte concordano sul fatto che Graviano sapesse di essere intercettato e
quindi va’ a sapere cosa fosse vero e cosa no: ma intanto nei giorni scorsi
quelle conversazioni registrate sono state ammesse agli atti del processo in
corso sulla cosiddetta “trattativa tra Stato e Mafia”, e Graviano sarà
ascoltato. Il processo sulla “trattativa Stato-mafia” si trascina da anni, ne
durerà ancora molti e ha diviso l’opinione pubblica, in queste proporzioni: il
90 per cento se ne frega; il 5 per cento pensa che il pm Nino De Matteo che la
conduce sia il nuovo Falcone e un perfetto ministro nel prossimo governo Cinque
Stelle; il restante 5 per cento pensa sia una cialtronata (chi scrive appartiene
all’ultima categoria). E comunque, dopo decenni si riparla delle stragi, dei
Graviano e di Berlusconi: di cui parlava Borsellino nella sua ultima intervista
nel 1992, di cui parlarono nel 1998 due importantissimi magistrati con Gaspare
Spatuzza.
La cosa che era successa in
mezzo, e non si sapeva.
E arriviamo a un elemento centrale della storia, nuovo o
seminuovo, che infatti in parte raccontai così sul Venerdì di Repubblica nel
luglio del 2013, durante il processo “Borsellino quater”, che la stampa aveva
seguito molto svogliatamente. Il 12 giugno la corte di Caltanissetta si è
trasferita a Roma per ascoltare il famoso pentito. Quel giorno, nella routine
delle videoconferenze e dei paraventi, è però successo un “incidente”.
L’avvocato Flavio Sinatra, difensore degli imputati Salvino Madonia e Vittorio
Tutino, sta controinterrogando il teste Spatuzza. Gli domanda se avesse già
detto in passato a qualcuno, quello che lo rese famoso nel 2008. Spatuzza nega.
L’avvocato gli domanda se avesse parlato della strage di via D’Amelio con altri
magistrati e il pentito si innervosisce. “Non ricordo”. Ed ecco il colpo di
scena: si materializza un verbale di interrogatorio di Gaspare Spatuzza reso nel
1998 nientemeno che all’allora capo della Procura nazionale antimafia Pier Luigi
Vigna (morto nel 2012) e al suo vice, Piero Grasso, l’attuale presidente del
Senato. Contenuto? Beh, diciamo: esplosivo. Sconcerto in aula. Da dove salta
fuori il verbale? Nientemeno che dal fascicolo del pubblico ministero, dove
risulta protocollato nel 2009, ma nessuno, prima dell’avvocato Sinatra, si era
mai accorto della sua esistenza. L’avvocato Sinatra chiede che il verbale sia
messo agli atti; la parte civile della famiglia Borsellino si associa; lo stesso
fa quella del Comune di Palermo. La Procura invece si oppone perché il verbale
non porta la firma del pentito, e quindi è un documento senza valore
giudiziario. La Corte le dà ragione e non lo ammette. Il presidente del Senato
chiese allora al Venerdì che si facesse chiarezza sul documento (era, più
esattamente, un verbale di “colloquio investigativo”) e una corretta
interpretazione dei fatti venne affidata all’allora procuratore di Caltanissetta
Sergio Lari, raccolta dal giornalista Piero Melati per il Venerdì: «Copia del
verbale e il file della registrazione sono stati trasmessi a Caltanissetta nel
dicembre 2008 dal procuratore antimafia Grasso per verificare l’attendibilità
dello Spatuzza che, come noto, nel giugno del 2008 aveva cominciato a
collaborare. Per un mero disguido il verbale e il file con la registrazione sono
stati inseriti nel fascicolo del pm del processo Borsellino Quater, piuttosto
che nel fascicolo della DNA (Direzione Nazionale Antimafia) dove andavano
custoditi gli atti non processualmente utilizzabili sulle stragi del 1992». E
della cosa non si parlò più. Alcuni mesi fa, però, dopo 4 anni (i processi
durano molto, in Italia), l’avvocato Sinatra è tornato alla carica e questa
volta – eravamo nelle fasi finali del dibattimento – la Corte gli ha dato
ragione: il verbale non è stato più considerato impresentabile, ma
è ufficialmente entrato a far parte degli atti pubblici (il file pare di no,
piuttosto illogicamente). Troppo tardi per discutere del loro contenuto (almeno
in quel processo), però almeno questo permette ora a chi scrive di pubblicare
quei testi senza essere accusato di violazione di alcunché; a chiunque di poter
leggere e farsi un’idea; e a chi riesca a ottenere la registrazione audio di far
ascoltare al vasto pubblico quanto possa essere drammatico un colloquio
investigativo, del quale qui pubblichiamo la trascrizione.
Cosa sappiamo e cosa manca,
nel 2017.
Stiamo parlando di una cosa piuttosto importante. Siamo nel 1997. Arnaldo La
Barbera lascia la Questura di Palermo e si trasferisce a quella di Napoli. Il
suo posto viene preso da Antonio Manganelli. Sotto la sua direzione avviene
l’arresto di Gaspare Spatuzza, il terribile killer di don Puglisi, il 2 luglio
1997. Un arresto anomalo per la città di Palermo: scontro a fuoco, cento bossoli
sul terreno, lo stesso arrestato ferito. Secondo alcune ricostruzioni, Spatuzza
parla subito e racconta dei legami tra il suo capo, Giuseppe Graviano e Silvio
Berlusconi, oltreché della strage di via D’Amelio. Secondo altre, lo fa solo
qualche mese dopo. Chi l’abbia ascoltato, non si sa. L’unico reperto storico che
abbiamo è proprio il famoso verbale, “colloquio investigativo” a cui Spatuzza
partecipa (ma non firmerà) nel carcere dell’Aquila il 26 giugno 1998. Lo
interrogano Pier Luigi Vigna, procuratore generale antimafia e Piero Grasso, suo
vice. In realtà, il colloquio sembra svolgersi secondo certi riti siciliani, ed
è quindi condotto quasi esclusivamente da Grasso. Si capisce che non è la prima
volta che i tre si parlano. E anche che non sarà l’ultima. Nel colloquio Vigna e
Grasso cercano conferme su una serie di cose che hanno in testa («abbiamo un
quadro in mente, ma che abbiamo bisogno di verificare») legate alla campagna di
attentati mafiosi tra il 1992 e il 1993: La logistica dei vari attentati a Roma,
Milano, Firenze.
I legami dei boss Graviano
con Fininvest, Dell’Utri, Berlusconi (sui rapporti tra la mafia e Berlusconi e
Dell’Utri si indagava già da alcuni anni).
Le modalità dell’arresto dei fratelli Graviano a Milano, ritenuti mandanti delle
stragi, per capire se l’arresto sia stato deciso e accelerato da qualcuno in
quel determinato momento. Spatuzza non risponde a tutte le domande. Sta
trattando. Nel 2014 spiegherà in aula che «allora la mia non era una
collaborazione. Avevo solo mostrato disponibilità perché dentro di me mi ero
ravveduto». Ma sulla strage di via D’Amelio offre notizie assolutamente inedite
e che anni dopo verranno confermate: – l’esplosivo usato non è Semtex, ma un
residuato bellico fornito da un pescatore palermitano, recuperato in mare dove
ce n’è molto. Lo stesso esplosivo è stato usato anche per la strage di Capaci e
per altri attentati. – Scarantino è un falso pentito inventato dalla polizia. Le
persone che Scarantino ha accusato e che sono state condannate non c’entrano con
la strage di via D’Amelio. Il colloquio si chiude con il rifiuto di Spatuzza a
controfirmarlo – a ulteriore garanzia della sua informalità – e con il rinvio
della discussione a un prossimo appuntamento, che non sappiamo se ci sia stato.
Cosa è successo, dopo? Tutto e niente: tutto, intorno alle indagini e ai
processi che hanno ribaltato in quasi vent’anni le tesi e le condanne iniziali;
niente intorno a quelle rivelazioni di Spatuzza del 1998, sparite fino al
ritrovamento del verbale, quasi un fossile riemerso da un’altra era, per un
«mero disguido», sedici anni dopo nelle carte di un pm di Caltanissetta.
In concreto – nei dieci anni
trascorsi tra il 1998 e il 2008 – nulla è successo per impedire che il
depistaggio proseguisse. La magistratura di Caltanissetta non ha preso la minima
iniziativa, anzi ha semplicemente passato gli anni a cercare di impedire che il
depistaggio (e il suo ruolo in esso) venissero rivelati. Anche nei successivi
altri nove anni (dal 2008, data del pentimento ufficiale di Spatuzza ad oggi,
2017), è successo molto poco. I magistrati che avevano sposato la falsa pista si
sono tutti autoassolti. I poliziotti accusati di torture sono stati
“archiviati”. E nessun particolare passo avanti – indagini patrimoniali,
ricerche di conferme, uso di intercettazioni, collocamento di microspie o
quant’altro e neppure altri “colloqui investigativi” – risulta sul contesto del
delitto Borsellino e della campagna delle stragi indicati da Spatuzza. Le
indagini hanno piuttosto preso – incredibilmente – altre strade. La mancanza di
indagini e di risultati – in ben 19 anni – mi fa concludere che il depistaggio
sia riuscito perfettamente e sia ancora in corso.
Quegli ''innominati''
dietro la scomparsa dell'agenda rossa,
scrive il 17 Luglio 2017 Giorgio Bongiovanni e Lorenzo Baldo. L'imputazione
coatta nei confronti di Arcangioli viene accolta dalle aspre polemiche dei suoi
difensori. Il 27 febbraio 2008 gli avvocati Diego Perugini e Sonia
Battagliese depositano una memoria difensiva con la richiesta di audizione di
numerosi uomini delle istituzioni tra cui l'ex presidente della
Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, i generali dei carabinieri Antonio
Subranni e Domenico Cagnazzo, l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro e molti
altri. I legali di Arcangioli premono per risalire ai nominativi degli uomini
dei Servizi presenti in via d'Amelio il giorno della strage e chiedono
ugualmente di sentire pentiti del calibro di Gaspare Mutolo, Salvatore Cancemi,
Giovanni Brusca, Antonino Giuffrè ed altri. Il 5 marzo 2008 i pm avanzano la
richiesta di rinvio a giudizio per Arcangioli. Martedì 1° aprile 2008 si svolge
l'udienza preliminare davanti al Gup di Caltanissetta, Paolo Scotto Di Luzio. A
metà pomeriggio viene emessa la sentenza di non luogo a procedere «per non avere
commesso il fatto». Un mese dopo le motivazioni sono depositate in cancelleria.
Tra le 27 pagine del documento il Gup traccia un'ombra ambigua sull'esistenza
stessa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino. Per il giudice la circostanza che
Arcangioli sia stato filmato nell'atto di portare la borsa appartenuta a
Borsellino non consente di stabilire «che la borsa contenesse l'agenda che poi
sarebbe stata fatta scomparire», poi poche righe più sotto rimarcando
che «nemmeno è possibile sostenere che la borsa contenesse sicuramente l'agenda
in questione». Il 13 maggio la procura nissena impugna la sentenza e ricorre in
Cassazione. I pm Renato Di Natale e Rocco Liguori, firmatari del ricorso,
illustrano le contraddizioni espresse in sentenza, così come la illogicità delle
motivazioni e soprattutto il travisamento della prova. In merito alla
considerazione alquanto azzardata del Gup che mette in dubbio la presenza
dell’agenda rossa all’interno della borsa del giudice, vengono poste di
contraltare le dichiarazioni (rese nel corso della fase istruttoria) della
signora Agnese Piraino Leto, del figlio Manfredi e della figlia Lucia che in
particolare ricorda nettamente come l’agenda rossa del padre, quel mattino
poggiata sulla sua scrivania, non vi era più quando questi si era recato a
Villagrazia di Carini. Di Natale e Liguori smontano pezzo per pezzo le evidenti
incongruenze della sentenza di proscioglimento per Arcangioli. L'ipotesi
ventilata dal giudice della «presenza simultanea di due borse, entrambe nella
disponibilità del Dr. Borsellino» contrasta decisamente con le testimonianze dei
familiari che mai ne hanno denunciato la scomparsa, come al contrario hanno
fatto per l’agenda rossa. L'eventualità ipotizzata dal Gup che Paolo
Borsellino avesse potuto stringere in una mano l'agenda rossa nel momento stesso
che si accingeva a citofonare alla madre viene contraddetta dalla logica dei
fatti. «Dalla corretta (e in questo caso non controversa) ricostruzione degli
eventi - scrivono i magistrati nel documento - si ricava, infatti, come il Dr.
Borsellino si trovasse alla guida della vettura blindata (era di domenica
pomeriggio e quindi non c'era l'autista del Ministero della Giustizia) mentre la
borsa si trovasse nel pianale posteriore (dove fu poi ritrovata dopo
l'esplosione)»; «Ne consegue - sottolineano i magistrati - che risulta alquanto
improbabile (oltre che complicato) che il magistrato abbia fatto uso della
borsa (o peggio abbia estratto l'agenda dalla borsa) durante il tragitto per Via
d'Amelio (mentre si trovava alla guida), né tanto meno si spiegherebbe perché il
Dr. Borsellino avrebbe dovuto portare con sé l'agenda rossa (che di certo non
utilizzava per gli appunti quotidiani, quali appuntamenti, spese ed altro) una
volta arrivato in via d'Amelio, considerato che era sceso dall'autovettura solo
per citofonare alla madre che avrebbe dovuto accompagnare da un medico per una
visita prenotata da tempo». In un dedalo di interpretazioni e travisamenti della
prova il dott. Paolo Scotto Di Luzio mette in dubbio le stesse riprese
televisive che inquadrano Arcangioli mentre si allontana da via d'Amelio. Per il
Gup le immagini non sarebbero in grado di restituire con esattezza il preciso
percorso del tenente. «Seppur non essendo dato conoscere, sulla base del
filmato, la destinazione finale del percorso di Arcangioli - scrivono i pm nel
loro ricorso - né il tempo esatto del possesso della borsa, è ancora errato e
illogico trarne conclusioni in termini indiziari assolutamente neutri, senza
considerare sia il luogo dell'ultima immagine dell'Arcangioli (già di per sé
fortemente sospetto), sia la direzione (altrettanto sospetta), che la
circostanza che per sottrarre un'agenda da una borsa (possibilmente
consegnandola a terzi) non necessitano né ore, né minuti, ma solo pochi
secondi». La procura nissena smonta ulteriormente il teorema del Gup sulla
possibile presenza di «due borse» appartenenti a Borsellino e sull'eventualità
che Arcangioli potesse essere giunto successivamente all'assistente di
polizia, Francesco Paolo Maggi. «Tale assunto - ribadiscono i pm Di Natale e
Liguori - travisa completamente il dato probatorio e contrasta inevitabilmente
sia con gli accertamenti della Dia di Caltanissetta, che hanno concluso per
l'identità della borsa trovata dal Maggi con quella raffigurata nella foto
dell'Arcangioli, che con le dichiarazioni dei familiari del Dr. Borsellino che
hanno riconosciuto in quella repertata l'unica borsa di cuoio utilizzata quel
giorno dal magistrato»; «Inoltre - sottolineano i magistrati nisseni - la
ricostruzione cronologica riportata in sentenza si pone in insanabile contrasto
con le dichiarazioni dei soggetti venuti in qualche modo a contatto con la borsa
del magistrato». Nel ricorso in Cassazione vengono messe a confronto tutte le
contraddizioni emerse dalle dichiarazioni di Giuseppe Ayala e lo stesso
Arcangioli a dimostrazione della necessità assoluta di celebrare un dibattimento
per chiarire definitivamente ogni dubbio su una materia tanto delicata come la
sparizione dell'agenda di Paolo Borsellino. I giudici nisseni concludono
affermando che la sentenza del Gup «ha avuto la pretesa di giudicare sulla
colpevolezza/innocenza dell'imputato come se si trattasse di un giudizio
abbreviato, e ha concluso tentando di porre una pietra tombale su una delle
vicende giudiziarie più inquietanti degli ultimi tempi». Ma quella «pietra
tombale» sul mistero della scomparsa dell'agenda rossa verrà messa proprio dalla
VI sezione Penale della Corte di Cassazione, presieduta da Giovanni De
Roberto il 17 febbraio 2009. Pochi minuti basteranno agli ermellini per
scrollarsi di dosso una vicenda ritenuta decisamente fastidiosa. Un caso da
seppellire al più presto nei caotici archivi di una cancelleria istituzionale.
Nell'aula austera del «palazzaccio» la presenza di un carabiniere in borghese,
qualificatosi come «colonnello», non passa inosservata. In un luogo normalmente
inaccessibile per chiunque non sia coinvolto nel processo celebrato, quell'uomo
è lì ed assiste al pronunciamento della sentenza. Il procuratore generale, Carlo
di Casola, chiede inaspettatamente il rigetto del ricorso della procura nissena.
Identica richiesta viene avanzata dal difensore di Arcangioli l'avv. Adolfo
Scalfati. L'avvocato di parte civile, Francesco Crescimanno, è l'unico a
chiedere la possibilità di avere un regolare processo per chiarire il mistero
del furto dell'agenda rossa. Ma rimane in minoranza. La Corte dichiara
inammissibile il ricorso della procura di Caltanissetta. E il proscioglimento
del colonnello Arcangioli diventa definitivo. L'ombra di una «ragione di Stato»
si allunga sulla sentenza di un processo abortito ancor prima di iniziare. Nelle
quattro paginette della motivazione della sentenza l'ignominia di uno Stato che
non vuole processare se stesso prende forma. Il punto più alto dell'indecenza lo
si raggiunge nel momento in cui viene messa nuovamente in dubbio l'esistenza
stessa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino. Nel citare le testimonianze
dell'ispettore Maggi, dell'appuntato Farinella, del dott. Teresi e dell'on
Ayala, gli ermellini sottolineano come da «nessuna di queste fonti, i cui
contributi vengono puntualmente riportati e criticamente analizzati, è
desumibile l'esistenza dell'agenda nella borsa maneggiata dall'Arcangioli e meno
che mai si può ritenere la sottrazione ad opera di quest'ultimo dall'interno
della borsa». L'evidente strumentalizzazione delle relative testimonianze assume
i contorni di una decisione già concordata e che doveva essere solo
formalizzata. Nella motivazione della sentenza di Cassazione il presidente della
VI sezione penale si avvale per buona parte delle motivazioni del Gup di
Caltanissetta concludendo che «gli unici accertamenti compiuti in epoca prossima
ai fatti portavano addirittura ad escludere che la borsa presa in consegna dal
Capitano Giovanni Arcangioli contenesse un'agenda». Sconcerto, delusione e
soprattutto rabbia quella di Salvatore e Rita Borsellino alla notizia del
proscioglimento di Arcangioli con una simile motivazione. «A questo punto -
scrive provocatoriamente Salvatore Borsellino sul suo sito - non resta che
trarre le inevitabili conseguenze da questa sentenza della Corte di Cassazione,
incriminare la moglie del Giudice per falsa testimonianza e processare tutti i
familiari del Giudice, figli, moglie, fratelli e sorelle per la sottrazione e
l'occultamento dell'Agenda». «Dato che Paolo non se ne separava mai - rimarca
con sdegno e rabbia il fratello di Borsellino - solo i suoi familiari possono
averla sottratta e occultata. Contro la madre del Giudice non si potrà procedere
per sopravvenuta morte dell'imputato». «Il momento attuale è peggiore del '92 -
dirà successivamente Rita Borsellino - allora sapevano chi erano gli amici e chi
i nemici, con tutti i limiti del caso si sapeva a chi affidare la propria
fiducia. Oggi non è così. Sappiamo che non possiamo fidarci praticamente di
nessuno. Per anni ci sono state dette bugie proposte come verità. Oggi sappiamo
che non c'è verità. La caparbietà dei magistrati che continuano a cercarla è il
modo più bello per raccogliere l'eredità di Paolo». Nei computer dei magistrati
nisseni restano archiviati i file delle dichiarazioni dei protagonisti di questa
vicenda incredibile. Chiuse nelle cartelline rimangono scritte le loro ambigue
contraddizioni. Ed è rileggendole che il fumo nero di via d'Amelio si dipana.
Dietro quelle nebbie si intravedono ora i volti degli «innominati» di questa
epoca. Ma anche questa volta è una questione di tempo. E il timer è già
scattato.
“Già si cominciava a parlare
della scomparsa dell’agenda rossa di Borsellino. Lavoravamo al nostro archivio,
volevamo catalogare le immagini più emblematiche delle stragi di mafia. Quella
foto in realtà era una diapositiva, con le lenti d’ingrandimento passavamo in
rassegna gli scatti di via D’Amelio prima di scansionare e conservarli in
formato digitale. La nostra attenzione si fissò su quella borsa, invitammo
alcuni colleghi a visionarla. Il responso fu unanime, poteva trattarsi della
borsa di Borsellino. Non si fece in tempo a venderla (la foto, ndr), avevamo
contatti con L’Espresso, Panorama e Repubblica per la cessione in esclusiva ma
un collega giornalista ci tradì, la notizia uscì su Antimafia 2000 a firma di
Lorenzo Baldo. Pochi giorni dopo bussarono alla porta dello studio gli uomini
della Dia e sequestrarono la foto. Ci fu proibito persino di parlare del
sequestro”. A parlare al Gazzettino di Sicilia è il fotografo Michele Naccari,
collega di Franco Lannino (colui che materialmente ha scattato la foto che
ritrae l’allora capitano dei Carabinieri Giovanni Arcangioli). Una precisazione:
il primo lancio della notizia di quella fotografia non è uscito sul nostro
giornale, bensì su l’Unità. La vicenda della scomparsa dell’agenda rossa
di Paolo Borsellino, che ci ha visto testimoni diretti per quanto riguarda il
ritrovamento dell’immagine di Arcangioli, merita quindi di essere raccontata per
intero. A futura memoria. «Esiste una foto dove si vede un ufficiale dei
carabinieri che si allontana da via d'Amelio pochi minuti dopo lo scoppio della
bomba reggendo la borsa di Paolo Borsellino». Per un attimo rimango in
silenzio**. Ma poi torno alla carica. «E chi sarebbe questo carabiniere?».
«Giovanni Arcangioli, nel '92 aveva il grado di capitano». Sono gli ultimi mesi
del 2004 quando ricevo questa segnalazione da una persona decisamente
attendibile che conosciamo da diversi anni. Gli chiedo altri dettagli. Voglio
vederci chiaro. «La foto è custodita dal fotografo palermitano Franco
Lannino». La conversazione finisce lì. Dopo una rapida consultazione in
redazione telefono al funzionario della Dia di Caltanissetta Ferdinando Buceti.
Il vice questore si occupa delle nuove indagini sui mandanti occulti nelle
stragi del '92 sotto il coordinamento della procura nissena. Non mi interessa
fare alcun tipo di “scoop” per Antimafia Duemila. La precedenza va all'autorità
giudiziaria. Punto. Buceti prende nota per poter verificare gli elementi
ricevuti. Nel frattempo mi accorgo che Giovanni Arcangioli è lo stesso ufficiale
che nell'estate del 2004 ha freddato a Roma il serial killer Luciano Liboni,
soprannominato «il lupo». Un osso duro, Arcangioli, che nel frattempo è
diventato tenente colonnello. Successivamente il funzionario della Dia scopre da
riscontri incrociati che il 19 luglio 1992 risulta confermata la presenza di
Arcangioli in via d'Amelio. Ma è il secondo passo quello determinante. In una
sorta di «irruzione» vera e propria cinque agenti della Dia piombano nello
studio dal fotografo Franco Lannino. Devono visionare il suo archivio. Subito.
La cartellina delle immagini della strage di via d'Amelio viene analizzata
minuziosamente fotogramma per fotogramma. La foto del carabiniere che regge la
valigetta di Borsellino esce fuori dall'album. E' stata scattata tra le 17,20 e
le 17,30 del 19 luglio 1992. E' lui. E' Giovanni Arcangioli, all'epoca
comandante della sezione Omicidi del Nucleo Operativo dei Carabinieri di
Palermo. Il reperto fotografico viene acquisito immediatamente dall'autorità
giudiziaria. E' la prova documentale della segnalazione giunta in redazione. La
macchina investigativa ha acceso i suoi motori. E' l'alba del 27 gennaio 2005
quando parto per Roma. L'appuntamento è per le ore 11 agli uffici della Dia. La
verbalizzazione ufficiale della nostra segnalazione sulla fotografia di
Arcangioli è prevista per quella mattina. L'indicazione fornita telefonicamente
poche settimane prima al dott. Buceti viene trascritta in un verbale che
confluisce nel fascicolo sulla scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino.
In quel momento l'opinione pubblica ignora ancora la notizia del ritrovamento
della foto. Ma è solo questione di un paio di mesi. Il 26 marzo l'Unità pubblica
un articolo a firma di Marzio Tristano. Il ritrovamento della foto del
carabiniere con la valigetta di Paolo Borsellino diventa di dominio pubblico. Da
un dispaccio Ansa del 19 maggio si scopre che Giovanni Arcangioli è stato
interrogato un paio di settimane prima per una foto che lo ritrae con in mano la
borsa del giudice Borsellino. Domenica 5 febbraio 2006 le agenzie diramano la
notizia che la Dna ha segnalato alla procura di Caltanissetta l'esistenza di un
vecchio verbale del 1998 di Giuseppe Ayala sul ritrovamento della borsa del
giudice Borsellino. I dispacci riportano che Ayala e Arcangioli sono stati
sentiti sul punto specifico dall'autorità giudiziaria. Passano solamente quattro
ore e le agenzie battono la notizia di un nuovo interrogatorio di Giovanni
Arcangioli previsto nei giorni successivi. Ed è nella data di martedì 8 febbraio
che quell'interrogatorio avviene negli uffici romani della Dia. Quello stesso
giorno viene sentito nuovamente anche Giuseppe Ayala. I due verranno messi a
confronto e le rispettive versioni non coincideranno. Inizia così una sfida a
colpi di memoria. Giocata su più tavoli. Primi vagiti di un depistaggio.
Consapevole o non. Ma di certo non innocente. Cinque mesi dopo, nell'edizione
delle ore 20, il Tg1 trasmette un servizio di Maria Grazia Mazzola sulla strage
di via d'Amelio. Per la prima volta in assoluto un canale nazionale,
nell'edizione di punta del proprio telegiornale, manda in onda il video di quel
frangente. Nel filmato il capitano dei carabinieri avanza spedito reggendo in
mano la borsa di cuoio di Borsellino. Dietro di lui si intravedono le auto in
fiamme e i pompieri che si affannano a spegnerle. La telecamera insiste
implacabile sull'ufficiale. Ma è questione di pochi secondi. Con grandi falcate
Arcangioli esce dal quadro delle riprese allontanandosi da via d'Amelio. Riparte
il filmato, questa volta a rallentatore. Il volto del carabiniere non tradisce
alcuna emozione. La valigetta è stretta nella sua mano destra. Poi più nulla.
Nel servizio l'intera vicenda viene sintetizzata sotto la scure dei tempi
televisivi. Ma è la novità di quel video ad attirare tutta l'attenzione. La
consacrazione definitiva a livello pubblico della scomparsa dell'agenda rossa è
avvenuta. Nell'immaginario collettivo la figura di colui che preleva la
valigetta di Paolo Borsellino ha finalmente un volto, un corpo e un'anima.
La pietra tombale sulla
scomparsa dell'agenda rossa. “Etica è innamorarsi del destino degli altri e
Palermo è uno dei pochi luoghi etici rimasti in questo Paese perchè si è
costretti a scegliere: o stai con gli assassini, oppure no, o stai da una parte
oppure dall'altra, anche se poi è difficile vivere questa scelta”. Un cielo
grigio avvolge la città di Caltanissetta. Ripenso a quelle parole pronunciate
diversi anni fa da Roberto Scarpinato, attuale procuratore generale di quella
città, mentre mi dirigo verso il palazzo di giustizia. E' il 24 febbraio 2006,
alle ore 11 è prevista la mia audizione come persona informata sui fatti.
L'inchiesta sulla scomparsa dell'agenda rossa procede in un percorso a ostacoli.
Il procuratore capo Francesco Messineo e l'aggiunto Renato Di Natale si fanno
ripetere sostanzialmente tutto l'iter della segnalazione giunta in redazione.
Passano poi agli approfondimenti. Ma l'interrogativo che pesa maggiormente nella
sala riunioni della procura nissena riguarda l'identificazione della «fonte». Il
procuratore intende sapere se quella segnalazione provenga da ambienti
«istituzionali» o meno. Ribadisco ai magistrati la provenienza «non
istituzionale» della segnalazione. Sono però costretto a ricorrere al «segreto
professionale» sull'identità dell'autore per una precisa volontà dello stesso.
Messineo e Di Natale non battono ciglio e procedono alla verbalizzazione. Sabato
25 febbraio il quotidiano La Repubblica anticipa l'iscrizione nel registro degli
indagati di Giovanni Arcangioli per false dichiarazioni al pubblico ministero.
La miccia è stata accesa. E' come se una scintilla cominciasse a percorrere un
lungo filo prima di arrivare all'esplosivo. Non passa nemmeno un mese e i
difensori di Arcangioli chiedono di spostare la competenza dell'indagine a Roma.
Secondo i legali il reato ipotizzato sarebbe stato commesso a Roma e di
conseguenza i giudici naturali sarebbero quelli della Capitale. La procura di
Caltanissetta oppone un fermo rifiuto in quanto i reati sarebbero stati commessi
nel territorio di competenza della procura nissena. Un braccio di ferro che
termina con un risultato a favore della procura. L'inchiesta resta a
Caltanissetta. Il fascicolo in cui si ipotizza il reato di furto resta a carico
di ignoti; l'ufficiale dei carabinieri viene iscritto nel registro degli
indagati per false dichiarazioni ai pm. Nel mese di ottobre del 2006 si conclude
l'indagine su Arcangioli. Da quel momento attorno al caso della sparizione
dell'agenda rossa si apre una danza schizofrenica a suon di carte giudiziarie.
Il 3 novembre del 2006 i pm titolari dell'inchiesta, Renato Di Natale e Rocco
Liguori, chiedono per l'ufficiale dei carabinieri una prima archiviazione.
L'istanza viene rigettata dal Gip Ottavio Sferlazza che, il 21 luglio 2007,
ordina di integrare il quadro probatorio con ulteriori accertamenti. Il 28
settembre 2007 una nuova richiesta di archiviazione da parte della procura
nissena viene depositata in cancelleria. Poche pagine che racchiudono tra le
righe una piccola nota in fondo al testo che apre ulteriori scenari. «Da
indagini parallele in altro procedimento penale - si legge nel documento
- emergeva comunque come la borsa (di Paolo Borsellino, nda) fosse stata
consegnata al Dr. Giovanni Tinebra il giorno dopo l'attentato dal Dr. Arnaldo La
Barbera». Il 5 novembre il Gip rigetta nuovamente la richiesta di archiviazione
e ordina un supplemento di indagine. Il 14 gennaio 2008 viene reiterata dalla
procura la terza richiesta di archiviazione. Il giorno 1° febbraio 2008 il Gip
impone ai Pm l'iscrizione nel registro degli indagati di Giovanni Arcangioli con
l'accusa di furto pluriaggravato. Nell'ordinanza il Gip Sferlazza illustra una
per una le gravi contraddizioni emerse nelle dichiarazioni di Arcangioli
mettendole a confronto con le testimonianze di Giuseppe Ayala, altrettanto
altalenanti, così come con quelle di Vittorio Teresi. «Contrariamente
all'assunto del ten. col. Arcangioli - si legge nel documento - a nessuno dei
magistrati presenti, chiamati in causa dal predetto ufficiale, fu affidata,
anche temporaneamente, la borsa in questione». «L'allora capitano Arcangioli -
che in un determinato contesto spazio-temporale certamente si trovò ad operare
da solo - rimase per un apprezzabile lasso di tempo nella disponibilità della
borsa, come documentalmente provato dai fotogrammi che lo ritraggono con la
borsa in mano nell'atto di allontanarsi fin quasi l'incrocio con Via Autonomia
Siciliana dove la telecamera cessa di inquadrarlo». Secondo il Gip Giovanni
Arcangioli si allontana «ingiustificatamente di ben 60 metri dalla zona
maggiormente interessata dall'esplosione (portineria e cratere) e dai rilievi in
corso».Per Ottavio Sferlazza la direzione di marcia dell'ufficiale sembra
piuttosto «funzionale all'esigenza di allontanarsi da quello spazio per
controllare personalmente la presenza dell'agenda lontano da occhi indiscreti e
per farla sparire, affidandola ad altri o nascondendola in una autovettura
parcheggiata nei pressi, per poi fare ritorno verso via d'Amelio dove la borsa
potè essere agevolmente riposta nell'autovettura del Dr. Borsellino ma ormai
priva del suo prezioso documento». In totale antitesi con le registrazioni video
che lo smentiscono in pieno Arcangioli aveva invece detto di essersi
spostato «sul lato opposto della via d'Amelio rispetto alla casa del Dr.
Borsellino» dove avrebbe aperto la borsa per esaminarne il contenuto. Per il Gip
di Caltanissetta «appare evidente che, fallito clamorosamente il tentativo di
precostituirsi una prova “autorevole” e “tranquillizzante” proveniente da fonte
qualificata - costituita dalla asserita verifica da parte dei magistrati
presenti, nell'immediatezza del prelievo della borsa dall'autovettura e sotto il
loro controllo visivo, dell'assenza di una agenda all'interno della borsa stessa
- all'Arcangioli, ripreso dalle telecamere in quell'atteggiamento univocamente
indiziante, non rimaneva che negare di “avere mai superato, portando la borsa,
il cordone di polizia che sbarrava l'accesso alla via d'Amelio”». Sferlazza
sottolinea che in realtà c'era una sorta di corridoio libero che non era
sbarrato da alcun cordone di polizia e che comunque per Arcangioli, munito di
distintivo al petto, non era certo difficile attraversare quel tratto di strada
per dirigersi verso la via Autonomia Siciliana «dove certamente sostavano molte
autovetture di servizio in cui ben potè operare indisturbato, e fare poi ritorno
in via d'Amelio senza destare alcun sospetto». Il Gip nisseno definisce
«alquanto singolare» che il capitano Arcangioli non abbia redatto alcuna
relazione di servizio «su un episodio di indubbia rilevanza investigativa, quale
il rinvenimento di una borsa appartenuta al Dr. Borsellino», nemmeno «l'asserita
consegna della borsa ai magistrati presenti […] avrebbe giustificato l'omessa
redazione di una annotazione di servizio su un episodio tanto
significativo». Nel documento viene riportata la dichiarazione di un superiore
di Arcangioli, il ten. col. Marco Minicucci il quale, sul punto specifico,
sottolinea che «sarebbe stato normale per un ufficiale che preleva la borsa che
era contenuta nell'auto di Paolo Borsellino immediatamente dopo la strage
redigere una relazione di servizio». Ma Arcangioli misteriosamente non redige
alcun rapporto. Per il Gip «non può dubitarsi della esistenza dell'agenda
all'interno della borsa né della attribuibilità al solo Arcangioli, almeno in
una prima fase, di una condotta di sottrazione della stessa». Sferlazza
evidenzia le circostanze dei diversi ritrovamenti della borsa di Paolo
Borsellino all'interno della sua auto. La prima persona che recupera la borsa
«sul sedile posteriore» è l'agente di scorta di Giuseppe Ayala, Rosario
Farinella. Successivamente l'ispettore Francesco Paolo Maggi asserisce di averla
trovata «sul pianale posteriore dietro il sedile passeggeri». I due diversi
ritrovamenti costituiranno i pilastri del mistero che ruota attorno alla
scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino. Secondo il Gip nisseno la
sparizione dell'agenda «va collocata in una fase certamente precedente
all'intervento dell'ispettore Maggi ed appare chiaramente ascrivibile
all'ufficiale dell'Arma dei carabinieri Arcangioli Giovanni». «E quale altra
funzione - scrive Sferlazza nell'ordinanza - può avere avuto la successiva
ricollocazione della borsa all'interno dell'autovettura se non quella di
consentirne un successivo recupero, dopo averla fraudolentemente privata di quel
documento approfittando della confusione che regnava in quella fase concitata e
confidando sul fatto che il successivo repertamento della stessa avrebbe destato
ben minori sospetti rispetto ad un suo eventuale e definitivo mancato
rinvenimento?!». In merito ai risvolti legati a quanto vi possa essere scritto
nell'agenda scomparsa il Gip di Caltanissetta punta dritto verso quegli organi
di Stato «infedeli». «E' evidente - ribadisce Sferlazza - che il suo
contenuto (dell'agenda rossa, nda) dovette subito apparire di estremo interesse
al punto di suggerirne una definitiva e deliberata sottrazione ad ogni possibile
sviluppo e/o doveroso approfondimento investigativo da parte dell'A.G.
funzionalmente competente, mentre fu privilegiata, in sedi che non è dato
conoscere ma certamente da parte di organi dello Stato infedeli, la definitiva
espunzione di quel documento da un quadro probatorio complessivo, fin
dall'inizio di difficile ricostruzione e lettura, che avrebbe potuto essere
arricchito e reso più decifrabile». «Diversamente opinando - conclude il Gip
- non si comprenderebbe perché quell'agenda non sia stata - si ribadisce,
neppure tardivamente - mai più restituita alla famiglia Borsellino, sia pur, in
ipotesi, dopo averne fotocopiato ed acquisito “clandestinamente” il contenuto,
al di fuori delle corrette regole procedurali, tanto più ove si consideri che
ciò avrebbe potuto essere fatto anche soltanto il giorno dopo senza destare
alcun sospetto, mentre si è scelta la strada della criminosa e definitiva
sottrazione del documento a qualunque verifica probatoria».
«Non ho un ricordo molto
nitido, però, relativamente alla borsa ho un flash che posso spiegare in questi
termini». Le parole dell'ispettore Giuseppe Garofalo, in servizio il 19 luglio
1992 alla Sezione Volanti della Questura di Palermo, infittiscono le nubi su via
d'Amelio. I magistrati lo ascoltano attentamente. «Ricordo - racconta Garofalo
- di avere notato una persona, in abiti civili, alla quale ho chiesto
spiegazioni in merito alla sua presenza nei pressi dell’auto. A questo proposito
non riesco a ricordare se la persona menzionata mi abbia chiesto qualcosa in
merito alla borsa o se io l’ho vista con la borsa in mano o, comunque, nei
pressi dell’auto del giudice. Di sicuro io ho chiesto a questa persona chi fosse
per essere interessato alla borsa del giudice e lui mi ha risposto di
appartenere ai Servizi. Sul soggetto posso dire che era vestito in maniera
elegante, con la giacca, di cui non ricordo i colori. Ritengo che se mi venisse
mostrata una sua immagine potrei anche ricordarmi del soggetto». I funzionari
della Dia sottopongono quindi all'attenzione dell'ispettore Garofalo il video
che riprende Giovanni Arcangioli. Ma l'ispettore esclude che si tratti della
stessa persona in quanto l'abbigliamento del personaggio appartenente ai Servizi
era completamente diverso dallo stile casual di Arcangioli. Il 16 novembre 2005
davanti agli inquirenti Garofalo ravvisa «forti somiglianze tra l'Adinolfi (il
tenente colonnello del Ros di Palermo Giovanni Adinolfi, nda) e il soggetto
qualificatosi in forza ai Servizi ed interessatosi della borsa», poi però in
data 20 gennaio 2006, visionando nuovamente insieme agli investigatori le
immagini dell'attentato Garofalo «non riconosceva nessuno (neanche
l'Adinolfi) ravvisando somiglianze con un soggetto (non meglio identificato) non
corrispondente alla figura dell'Adinolfi». Dal canto suo il col. Adinolfi
ribadirà quanto già riferito all'autorità giudiziaria di Caltanissetta
nell'aprile del 2006 in ordine alla sua presenza in via d'Amelio il 19 luglio
1992 ma «seppur riconoscendosi nel soggetto con giacca e occhiali scuri più
volte ripreso vicino al col. Arcangioli». I magistrati riportano che nelle
successive deposizioni lo stesso Adinolfi «nulla aggiungeva (rispetto alle
precedenti dichiarazioni) con riferimento a qualsivoglia circostanza attinente
la presenza della borsa appartenuta in vita al Dr. Borsellino». Le asserzioni
dell'isp. Garofalo si intersecano in maniera inquietante con quelle dell'agente
della Volante San Lorenzo, Salvatore Angelo, tra i primi ad arrivare in via
d'Amelio. In mezzo a quella bolgia l'agente Angelo riconosce il
collega Salvatore Mannino in servizio fino a qualche tempo prima al
commissariato San Lorenzo. Mannino era stato poi trasferito a Firenze poiché una
nota del Sisde lo aveva descritto come in pericolo di vita perché minacciato
dall’organizzazione mafiosa, ma era anche sospettato di essere stato una «talpa»
del commissariato. Non appena individuato Mannino, Salvatore Angelo resta
interdetto. «Mi ha colpito addirittura un abbigliamento consuetudinario a lui -
ricorda l'agente Angelo - giacca e pantaloni colore cammello e questo ha fatto
scattare l’interrogativo di dire: ma 'sta persona qua che ci fa? Proprio perché
il soggetto era quello che io ricordavo da sempre. Io poi l’ho perso con lo
sguardo, perché come lui ha attraversato ancora c’era il fumo, c’erano le... le
auto in fiamme, cioé non era facile seguire le persone all’interno della via
D’Amelio. Ripeto, sono attimi in cui la cosa era ancora abbastanza fresca».
Successivamente le dichiarazioni dell'artificiere antisabotaggio, Francesco
Tumino, all'epoca in servizio presso il Nucleo Operativo del Comando Provinciale
dei carabinieri di Palermo, creano ulteriore confusione nelle indagini degli
investigatori. «Per il mio specifico compito cominciai ad attenzionare il
cratere provocato dall’esplosione - racconta Tumino - se ben ricordo erano le
19.00 circa, allorquando notai la borsa che mi mostrate in foto in mano ad un
tale ben vestito che, attraversato il cratere, si diresse verso un capannello di
persone ove vi erano i più alti esponenti delle forze dell’ordine. Tale
circostanza mi colpì poiché la borsa risultava per un lato bruciata e per
l’altro integro e bagnata. Non conosco il tale che teneva in mano questa borsa e
non mi sono accorto a chi l’abbia consegnata. Escludo, tuttavia, che potesse
trattarsi di un nostro ufficiale poiché l’avrei riconosciuto». Viene quindi
verbalizzata una ricostruzione alquanto discordante dalle altre testimonianze.
Ma Francesco Tumino è lo stesso artificiere dei carabinieri coinvolto nei
misteri del fallito attentato all'Addaura del 1989. Ed è lo stesso brigadiere
che verrà condannato in appello per calunnia nell'ambito dell'inchiesta sul
fallito attentato a Falcone per aver accusato l'allora capo della Criminalpol di
Palermo, Ignazio D'Antone, di essersi appropriato di alcuni reperti recuperati
dopo la disattivazione dell'ordigno esplosivo. Tumino morirà nel mese di gennaio
del 2006 portando con sé ambiguità e segreti. Nel frattempo i misteri si
intensificano. La relazione di servizio del ritrovamento della valigetta di
Borsellino viene inspiegabilmente redatta dall'ispettore Maggi il 21 dicembre
1992 e consegnata al magistrato titolare delle indagini, Fausto Cardella, otto
giorni dopo. Per cinque mesi non esiste quindi alcun atto di polizia giudiziaria
inerente il ritrovamento della borsa del giudice. Un'incomprensibile e
irragionevole vuoto temporale. Un enigma che alcuni protagonisti dell'epoca
riescono ulteriormente a ingarbugliare con i propri vuoti di memoria. Il
funzionario della Mobile di Palermo, Paolo Fassari, viene indicato da Francesco
Maggi come il comandante che gli ordina di portare la valigetta di Borsellino in
questura. Fassari, sentito successivamente dall'autorità giudiziaria, riferisce
di non ricordarsi bene della presenza di Maggi in via d'Amelio, né tanto meno
rammenta di avergli impartito l'ordine di recarsi in questura una volta
rinvenuta la borsa del giudice. Fassari tuttavia non esclude che si siano
verificate tali circostanze «in considerazione del notevole tempo trascorso e
della grandissima confusione che era scaturita, in quei frangenti, in via
d'Amelio». Dal tenente colonnello Marco Minicucci (all'epoca Comandante del
Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri Palermo I, nda), dipendevano cinque
Sezioni Operative, a capo di una delle quali, la prima, era il capitano Giovanni
Arcangioli. Ed è proprio Minicucci, interrogato dagli inquirenti nel 2005, a
fornire un'ennesima versione dei fatti. «Ricordo in merito alla valigetta, molto
vagamente, atteso i tredici anni trascorsi, che il collega (Giovanni
Arcangioli, nda) fu incaricato da uno dei magistrati presenti sul posto, del
quale non ricordo il nome, di prelevare dall’interno dell’auto del Procuratore
Borsellino la valigetta dello stesso all’interno della quale mi ricordo che era
contenuto un Crest araldico, se non erro dell’Arma, questo sulla base dei
racconti che mi erano stati fatti dal Capitano Arcangioli». «In merito alla
valigetta - specifica Minicucci - non ricordo altro e ritengo di potere
escludere che siano stati redatti verbali da personale dipendente poiché
l’attività tecnica sul luogo fu lasciata nelle competenze della Polizia di Stato
in segno di rispetto per le perdite subite. Non so aggiungere altri particolari
e dettagli in merito alla valigetta poiché non ho vissuto materialmente il
prelievo ed il controllo della stessa ma ne sono venuto a conoscenza dal collega
successivamente e limitatamente alla parte che ho appena narrato». Gli
investigatori confrontano le diverse dichiarazioni e tornano a sentire
l'appuntato Farinella che non ha alcun problema a confermare quanto
precedentemente riferito. «Io ricordo perfettamente - ribadisce Farinella - che
appena notata la borsa il vigile ha cercato di spegnere le fiamme esterne ed
insieme abbiamo tentato, fino a riuscirci, di aprire la portiera che permetteva
di prendere la borsa. Ricordo altrettanto bene - sottolinea l'appuntato dei
carabinieri - che abbiamo aperto una delle portiere posteriori, ma non so dire
se la sinistra o la destra, proprio perché abbiamo fatto diversi tentativi.
Inoltre, quando io ho prelevato la borsa la stessa era perfettamente asciutta,
diversamente sarebbe dovuta essere inzuppata d’acqua». L'ipotesi della borsa
bagnata è uno dei punti nevralgici delle contraddizioni emerse dalle differenti
dichiarazioni dei testimoni. In totale contrapposizione alle affermazioni
di Rosario Farinella, Francesco Maggi riferisce che la borsa era inzuppata
d'acqua in quanto un pompiere l'aveva bagnata per impedire il principio di un
incendio che si stava formando all'interno dell'autovettura. Di fatto Farinella
e Maggi prelevano la borsa in tempi diversi. Nel primo caso non c'è alcun
incendio all'interno della Croma, così come testimonia il pompiere che aiuta
l'appuntato Farinella ad aprire l'auto. Mentre quando Maggi preleva la valigetta
un altro pompiere ha appena colpito con un getto d'acqua l'interno della
vettura. Ad avallare le dichiarazioni di Farinella si aggiungono quelle del
vigile del fuoco Giovanni Farina che materialmente lo aiuta ad aprire la
portiera della macchina blindata di Borsellino. «Il giorno della strage -
racconta Farina agli inquirenti il 26 ottobre 2005 - ero funzionario di servizio
e subito dopo la richiesta d'intervento sono stato tra i primi ad intervenire in
via d'Amelio. Al momento del nostro arrivo, al quale seguiva immediatamente
l'arrivo di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento portuale, ho
notato che sul posto vi erano già delle auto delle forze dell'ordine che
impedivano l'accesso alla gente che sopraggiungeva». «Preciso che in quella
prima fase - sottolinea il vigile del fuoco - non sapevamo ancora quali fossero
lo cause di quello scenario che si presentava davanti a noi. Ricordo, però che
quando siamo arrivati ciò che c'era in via d'Amelio era completamente oscurato
dal fumo. Inizialmente, accorgendoci che diverse macchine erano in fiamme
abbiamo provveduto a spegnerle». A quel punto Giovanni Farina mette a fuoco il
ricordo della macchina del giudice. «In tale circostanza ho notato che vi era
una Fiat Croma di colore blu scuro alla quale non riuscivamo ad aprire le
portiere. Nel tentativo di rompere un deflettore posteriore mi sono accorto che
era un'auto blindata». «Successivamente - evidenzia il pompiere Farina - grazie
all'intervento di qualcuno appartenente alle forze dell'ordine siamo riusciti ad
aprire le portiere e verificare che non vi fosse nessuno al suo interno. Preciso
che l'autovettura in questione era posizionata quasi al centro della strada,
quasi all'altezza del portone d'ingresso della madre del giudice Borsellino». Il
vigile del fuoco spiega successivamente agli inquirenti di aver appreso
direttamente da Giuseppe Ayala, circa 30 minuti dopo «che si era trattato di un
attentato al giudice Borsellino». Quando i magistrati mostrano a Rosario
Farinella la foto del capitano Arcangioli per un'identificazione, l'appuntato
dei carabinieri dichiara di non essere in grado di riconoscere la persona nella
fotografia. «Posso aggiungere però - conclude Farinella - che non ricordo
assolutamente che la persona alla quale ho consegnato la borsa avesse una placca
metallica di riconoscimento; di questo particolare ritengo che mi ricorderei».
Dai principali protagonisti della scena del prelevamento, Giovanni Arcangioli e
Giuseppe Ayala, si susseguono una serie di affermazioni, rivedute e corrette
fino allo sfinimento. Arcangioli chiama addirittura in causa magistrati che non
ci sono mai stati in via d'Amelio quel 19 luglio come Alberto Di Pisa (che
minaccia querele per essere stato citato inopportunamente), e cita ugualmente
chi vi è arrivato solamente nel tardo pomeriggio come Vittorio Teresi. Il 12
luglio 2005 il procuratore aggiunto di Palermo racconta agli investigatori la
sua versione dei fatti. «Non posso precisare l'ora in cui arrivai in via
d'Amelio - dichiara Teresi agli investigatori - ma probabilmente era trascorsa
un'ora e un quarto o un'ora e mezza dall'esplosione. Mi fermai per qualche
minuto ad osservare il terribile spettacolo dei corpi straziati tra i quali
quello di Paolo Borsellino, e poi, mi andai a collocare sul marciapiede opposto
alla cancellata del palazzo, in posizione però spostata verso l'imbocco di via
d'Amelio». «Nel medesimo luogo - sottolinea il magistrato palermitano - credo di
ricordare di avere visto i colleghi Ingroia e Natoli e forse Patronaggio e
Ayala. Ricordo anche che altri colleghi erano sul posto ma non riesco a
ricordare chi fossero». A quel punto gli inquirenti chiedono a Vittorio
Teresi se ricorda di aver incontrato in quella circostanza Giovanni
Arcangioli. «Non ricordo, in quella circostanza - replica Teresi - di essere
stato avvicinato dal capitano Arcangioli né di avere comunque parlato con lo
stesso. Chiarisco che io conoscevo e conosco benissimo il capitano Arcangioli
con il quale avevo svolto alcune indagini, ma non ricordo che in via d'Amelio lo
stesso mi abbia avvicinato o in qualsiasi modo interpellato». «Naturalmente -
evidenzia il procuratore aggiunto di Palermo - non mi sento neanche di escludere
che ciò sia avvenuto, perché, come ho detto, mi trovavo in uno stato di grande
confusione e prostrazione psichica». Ai magistrati presenti Vittorio
Teresi illustra minuziosamente la sua versione sul ritrovamento della valigetta
di Paolo Borsellino. «Escludo in modo più assoluto come fatto materiale -
sottolinea Teresi - che il capitano Arcangioli abbia esibito qualsivoglia borsa
ed a maggiore ragione che io abbia aperto tale borsa, o comunque che una borsa
sia stata aperta in mia presenza o anche da un altro. Peraltro io non avevo
alcuna veste istituzionale, non essendo il sostituto di turno e quindi non avrei
potuto ricevere alcun reperto, cosa questa che il capitano Arcangioli assai
esperto doveva sapere». Prima di concludere il verbale di
interrogatorio Vittorio Teresi dichiara agli investigatori di ricordarsi della
presenza dell'agenda rossa del giudice assassinato «sul tavolo di Paolo
Borsellino sino a venerdì o sabato (prima della strage, nda)», ma di non poter
sapere se tale agenda fosse quella scomparsa. Il 13 dicembre dello stesso anno
gli investigatori interrogano Mario Bo, funzionario della Squadra Mobile di
Palermo nel '92 (all'epoca dirigente della II° sezione investigativa antirapina
e successivamente componente del gruppo investigativo Falcone-Borsellino
coordinato da Arnaldo La Barbera), che cinque anni dopo sarebbe stato indagato
nella nuova inchiesta sul depistaggio nelle indagini per la strage di via
d'Amelio. Mario Bo racconta agli investigatori di avere ricevuto la notizia
della strage di via d'Amelio mentre si trovava al mare all'Addaura. Bo specifica
di essersi immediatamente recato sul posto, ma di esservi rimasto per poco tempo
a causa del suo abbigliamento troppo informale, di essere quindi passato a casa
sua per cambiarsi prima di recarsi agli uffici della Mobile e solo
successivamente in via d'Amelio. Gli investigatori mostrano a quel punto alcune
fotografie della borsa di Paolo Borsellino e chiedono all'ex funzionario della
Mobile se ricordi averla vista in via d'Amelio. «Dopo aver visionato le foto -
risponde il dott. Bo agli inquirenti - debbo dire che, nonostante l'enorme lasso
di tempo intercorso, sarebbe assai improbabile non aver mantenuto il ricordo di
un oggetto così particolare. In effetti, non posso escludere di avere avuto modo
di vederla, ma non riesco a contestualizzare il latente ricordo». «La mia
difficoltà, in questo momento - evidenzia l'attuale capo della Squadra Mobile di
Trieste - è accentuata dal fatto di non averne memoria neppure in relazione alle
indagini sull'attentato in questione ed alle quali io ho partecipato a partire
dal mese di giugno 1993, allorquando entrai a far parte del gruppo investigativo
Falcone-Borsellino, diretto dal dott. La Barbera». In ultimo gli investigatori
chiedono a Bo se l'assistente Maggi gli abbia mai parlato della borsa in
questione. Dal funzionario di polizia giungerà l'ennesima risposta negativa. Dal
canto suo Giuseppe Ayala cambierà versione progressivamente. Come una tela di
Penelope il racconto del ritrovamento della valigetta di Borsellino assumerà
forma e sostanza mutevole. A seconda della testimonianza si allungherà in
dettagli fuorvianti, o si accorcerà dietro inquietanti omissioni. Tratto dal
libro “Gli ultimi giorni di Paolo Borsellino” (G. Bongiovanni e L. Baldo,
Aliberti)
Graviano: un messaggio che nasconde i
destinatari, scrive il 10/06/2017 Francesco La Licata
su "la Stampa". Il nastro si riavvolge e il film comincia daccapo. Le stragi
mafiose del ‘92 e del ‘93 hanno rappresentato per 25 anni e rappresentano ancora
l’autentico tormentone che ha accompagnato il passaggio dalla prima alla seconda
Repubblica. Un tormentone che ruota attorno alla discesa in campo di Silvio
Berlusconi e alla nascita di Forza Italia. Quest’ultima rivelazione di Giuseppe
Graviano, curiosamente tanto istupidito da non sospettare di essere intercettato
in carcere, arriva proprio nel momento in cui la storia italiana del ‘92 e del
‘93 sembra essere già archiviata e relegata persino al ruolo di fiction, come
abbiamo avuto modo di vedere seguendo l’ultima serie tv su Sky. Di Berlusconi e
di Dell’Utri (quest’ultimo in carcere per concorso esterno) hanno parlato
schiere di pentiti. Lo stesso Graviano, alla udienza in cui testimoniò a Torino
il collaboratore Gaspare Spatuzza, si diede molto da fare nel lanciare messaggi
e minacciare ricatti. Facendo intendere anche di essere pronto a qualche
“sacrificio” (lui e forse il fratello, Filippo) pur di ricevere un allentamento
del carcere duro. Sono passati otto anni e non sembra esser accaduto nulla, se
non il “beneficio” di aver potuto ingravidare le rispettive mogli. Si era
pensato che questo “evento” potesse essere stata conseguenza di una complicità
del suo avvocato, immaginato come “trasportatore” del loro seme dal carcere ad
un laboratorio per l’inseminazione. Apprendiamo oggi, per bocca di Giuseppe
Graviano, che l’inseminazione avvenne per contatto diretto. Un “premio” per il
suo silenzio, mentre gli si chiedeva di confermare le dichiarazioni di Spatuzza
a proposito dei rapporti tra la mafia di Brancaccio e Berlusconi e Dell’Utri?
Questo, Graviano non lo dice ma lo fa intendere. Ecco forse è questa la chiave
dei colloqui intrattenuti in carcere, con un detenuto che non è neppure mafioso.
Una sorta di replay dell’ “incidente” occorso a Totò Riina che si è fatto
sorprendere dalle “cimici” carcerarie mentre parlava con un altro “signor
nessuno”, appartenente ad una improbabile mafia pugliese. Insomma, questi boss
quando hanno qualcosa da dire, da suggerire, da sussurrare e finanche da
ammettere, sembrano voler scegliere la strada del “parlare” ma senza pentirsi.
Una bella intercettazione e via. Resta da capire chi sono i destinatari dei
messaggi. Berlusconi non sembra in grado di poter dare grandi aiuti a
chicchessia, soprattutto se non si tratta di soldi. Dell’Utri sta anche peggio,
immobilizzato in un reparto di cardiologia del carcere di Parma. Forse ci sono
verità che ancora faticano a guadagnare la luce. Nel ‘92 certamente è accaduto
qualcosa di poco commendevole nella terra di mezzo fra politica e alta finanza.
Il proliferare delle Leghe, a Nord e a Sud, la svolta stragista di Cosa nostra,
la fine dei partiti storici italiani. Le paure di Ciampi che, la notte delle
bombe, convoca lo Stato Maggiore e si chiude a Palazzo Chigi. Se Graviano ha
qualcosa da chiedere, potrebbe cominciare a parlare sul serio.
La verità per disguido,
scrive giovedì 13 luglio 2017 "Il Post". Non è possibile che la storia delle
stragi mafiose sia scritta a forza di documenti nascosti, sentenze sbagliate e
sensazionalismi giornalistici (ovvero: Cos'è questo speciale). Alcune settimane
fa Enrico Deaglio ha proposto al Post di raccontare di nuovo, per i 25 anni
della strage di via D’Amelio, la storia più recente delle tante legate a
quell’attentato e ai suoi misteri: quella di un documento investigativo rivelato
per un “disguido” nel 2013 che mostrava delle cose nuove e gravi sul depistaggio
con cui agenti di polizia e magistrati costruirono e portarono a sentenza una
versione falsa sui responsabili della strage. La storia di quel documento era
già stata raccontata, ma senza grandi attenzioni o rilievi, anche dallo stesso
Deaglio, anche sul Post. Ci siamo convinti che la scarsa attenzione fosse dovuta
a una generale indifferenza e stanchezza nazionale nei confronti dei grandi
“misteri d’Italia”; a una retorica commemorativa benintenzionata ma in cui
restano imballati e sepolti fatti, spiegazioni, ricostruzioni; a un’incapacità
dei media di rinnovarli e trasmetterli, nel groviglio di versioni e processi e
cose false e vere che sono stati questi 25 anni. Come se non ce ne
importasse più, per umane fatica e rimozione, anche se non lo ammetteremmo mai.
Così abbiamo pensato di fare su quella storia il lavoro che al Post viene più
spesso riconosciuto e richiesto, quello della spiegazione, della ricostruzione,
del mettere in ordine storie e informazioni daccapo. E quello che
pubblichiamo in questo speciale – una serie di diversi articoli legati tra loro
– è il risultato di questo lavoro che abbiamo provato a fare per mettere quella
storia in un contesto che aiuti a capirla, senza sconfinare negli ambiti più
estesi e approfonditi su cui hanno scritto in tanti ed esperti. Ma mentre
leggevamo ricostruzioni, articoli, verbali, e ascoltavamo registrazioni di
udienze, e guardavamo video di interviste o di rovine di bombe, abbiamo anche
iniziato a riflettere sulla contraddizione tra la tanto ripetuta “ricerca della
verità” da parte delle istituzioni e da parte delle persone, e la continua
sottrazione di pezzi di verità da parte delle istituzioni e da parte delle
persone. Sono passati 25 anni da quando vennero uccisi il magistrato Paolo
Borsellino e cinque agenti della sua scorta. 25 anni in cui si è chiesta mille
volte “la verità” e quello che si è ottenuto è:
1. Una storia falsa spacciata per vera dal 1992
fino al 2008, col concorso di magistrati e ufficiali di polizia, su chi avesse
compiuto quell’attentato: che ha prodotto, oltre a una falsificazione storica,
la condanna e la detenzione per molti anni di nove persone estranee
all’attentato (per le quali si è conclusa oggi la revisione del processo, con
tutti gli imputati infine assolti, dopo 25 anni). Per quella falsificazione –
una volta rivelata, nel 2008 – sono stati condannati solo gli imputati che
avevano dichiarato il falso, malgrado siano certe le pressioni e le violenze da
parte degli investigatori per ottenere quelle confessioni, confermate persino da
una sentenza e da queste parole recenti del procuratore aggiunto di
Caltanissetta Paci: “C’è traccia di abusi, di contatti irrituali e connivenze
tra investigatori e indagati per la ricerca di elementi che sostenessero una
pista investigativa che all’epoca era plausibile, ma si ignorarono i campanelli
di allarme che arrivavano dalle dichiarazioni contraddittorie di Scarantino
sulla strage di via D’Amelio”.
2. La ripetuta dimostrazione dell’ostilità da
parte dei magistrati che avallarono e difesero quella falsificazione a prendere
in considerazione le molte prove che la dimostravano tale, e i pareri in questo
senso di altri magistrati.
3. Una nuova versione divenuta pubblica solo nel
2008 e che ha portato alle condanne degli organizzatori ed esecutori della
strage, senza chiarire le ragioni di quello e degli altri attentati di cui la
mafia fu responsabile tra il 1992 e il 1994, in una campagna di violenze unica e
anomala nella storia della mafia.
4. Una serie di indizi e dichiarazioni mai
riscontrati sui rapporti dei boss organizzatori delle stragi con Silvio
Berlusconi e Marcello Dell’Utri, a tutt’oggi in bilico tra il credibile,
l’incredibile, il molto raccontato e il poco provato.
Come si vede, su tutti questi quattro fronti
nessuna “verità” è arrivata senza lasciarne altrettante da spiegare.
Chi e come ha indotto i “falsi pentiti” ad
accusarsi e accusare altri falsamente, in un gravissimo e criminale depistaggio?
Quali responsabilità, omissioni, intenzioni, hanno avuto i magistrati che hanno
difeso con insistenza una storia falsa e fuorviante? Quali obiettivi ebbe, e
quali sviluppi, la campagna di attentati tra il 1992 e il 1994? Hanno
qualche fondamento le accuse contro Silvio Berlusconi? Quattro anni fa c’è stato
un piccolo fatto nuovo che ha rivelato delle cose e ha fatto sospettare ce ne
siano altre ancora rivelabili: un documento altrimenti “segreto” perché
destinato solo alle indagini e non utilizzabile a processo, è diventato pubblico
per un “disguido”, e ha svelato che Gaspare Spatuzza, il “collaboratore di
giustizia” che svelò e fece smontare la falsificazione nel 2008, l’aveva già
dichiarata falsa nel 1998, seppure con meno riscontri alla sua versione: ma
nessuna indagine fu fatta sulle sue dichiarazioni. Quel documento è pubblico da
tre anni ma è stato molto trascurato nelle ricostruzioni e nelle narrazioni,
forse perché sembra certificare ulteriormente l’ostinazione dei magistrati di
Caltanissetta nel proteggere la versione falsa. Ma quel documento è anche una
traccia solo parziale di tutto quello che può essere stato già evocato e
raccontato vent’anni fa ed è stato taciuto e mai verificato: ci sono altre cose
dette in quello e in altri “colloqui investigativi” con i magistrati che
continuano a essere riservate. Il Presidente del Senato Pietro Grasso, che da
magistrato è stato uno dei personaggi di queste storie, ed è stato
protagonista di grandi impegni giudiziari contro la mafia, ha appena pubblicato
un libro sulle sue esperienze e sulla sua amicizia con i magistrati Falcone e
Borsellino. Tra le altre cose, Grasso ricorda del suo auspicio, appena eletto
senatore, di “una commissione parlamentare d’inchiesta sulle stragi”: Ci sono
troppi profili di quel tragico disegno stragista che restano ancora oscuri.
Bisogna insistere perché gli eventi vengano ricostruiti in tutte le loro
implicazioni e sfaccettature. Le dichiarazioni rilasciate dal pentito e gli
elementi da lui forniti alle Procure di Firenze, Caltanissetta e Palermo hanno
consentito di ristabilire finalmente alcune verità sulle stragi. Occorre seguire
un metodo preciso nella ricostruzione delle vicende, lo stesso metodo che ha
ispirato la mia carriera di magistrato: credere solo a quello che è
riscontrabile, provato, offrire elementi di conoscenza, anche piccoli, che
aggiungano tasselli al quadro, senza cadere nella tentazione di dipingere
scenari opinabili, anche se suggestivi, ipotetici e non dimostrabili. Se si
vuole chiarezza, si deve partire da ciò che è accertato, senza smettere di
sollevare interrogativi e sottolineare i punti oscuri che richiedono
un’ulteriore riflessione. Grasso ha ragione su entrambe le cose: la legislazione
sui collaboratori di giustizia ha prodotto risultati riconosciuti e fondamentali
ma anche disastri e inganni, come ogni regola emergenziale. Il depistaggio sulla
strage di via D’Amelio è frutto per prima cosa di un abuso di quelle regole,
mentre il loro uso più coerente ha prodotto lo svelamento di quel depistaggio. E
la confusione tra presunte verità giornalistiche e verità giudiziarie è alla
base di storture quotidiane nell’amministrazione della giustizia, della politica
e della società italiane. Sono tutte ragioni per essere cauti. Però Grasso ha
ragione anche quando parla di “offrire elementi di conoscenza, anche piccoli,
che aggiungano tasselli al quadro” (la storia del documento di cui parliamo è
uno di questi) e quando chiede di continuare a “sollevare interrogativi”. La
prudenza non può diventare silenzio. È già successo una volta, con un pezzo di
questa storia, che informazioni utili a capire come fossero andate le cose siano
state trascurate e che si sia lavorato con insistenza a una falsificazione: e se
Spatuzza non avesse deciso di collaborare, visto che per 11 anni in carcere non
aveva mai voluto farlo? E se non avesse potuto esibire il riscontro sulla
riparazione dei freni dell’autobomba che lo ha reso credibile a processo?
Sarebbero rimaste solo le sue parole del 1998, nascoste in un archivio, non
indagate, ignote, rimpiazzate da una sentenza sbagliata su una delle stragi più
gravi e importanti della storia italiana. Quelle parole le abbiamo conosciute
poi per un “disguido”: forse è meglio che per tutte le altre che sono state
dette si creino allora le condizioni per conoscerle legalmente, deliberatamente,
completamente. I “segreti di Stato” sono connaturati agli stati, però non
bisogna farli diventare una condizione ordinaria e permanente: ma nemmeno
investire i magistrati del ruolo degli storici – idea che ha fatto già, e fa
tuttora, abbastanza danni – o per contro aspettare gli storici del XXII secolo
col loro utile distacco. Può darsi che debba essere la commissione Antimafia, o
la commissione chiesta da Pietro Grasso, ad avere accesso a tutti i documenti e
a trovare il modo di rispondere pubblicamente a quelle domande: o può darsi che
chiunque sia stato protagonista del bene o del male di questi 25 anni debba
decidersi a raccontare delle altre cose, con prudenza ma senza omertà. Noialtri
intanto facciamole, le domande, poi facciamo il punto di quello che sappiamo, e
stiamo in guardia su falsificazioni e depistaggi di ogni genere.
I falsi pentiti e i loro portavoce: Pm e
giornalisti, scrive Tiziana Maiolo il 20 luglio 2017
su "Il Dubbio". L’inaudito caso di Enzo Scarantino, costretto a “collaborare” a
calci e pugni, ad autoaccusarsi e ad accusare deviando le indagini. Gli
incredibili “errori” dei magistrati, tra i quali Di Matteo. Adesso lo dicono
tutti, anche Sergio Mattarella: nel 1992, quando fu ucciso Paolo Borsellino, ci
fu qualcosa di sbagliato nelle indagini e nei processi che seguirono. In realtà
non ci fu nessun “errore”, ma il fatto banale che nessuno si curò della verità
sulla morte di Paolo Borsellino. Magistrati vanesi e investigatori senza
scrupoli volevano in fretta una qualunque verità. Persino quella di Enzo
Scarantino. Il “pentito” costruito a tavolino, come dice oggi la figlia del
magistrato ucciso. Erano passati pochi giorni dal “pentimento” di Enzo
Scarantino quando la moglie Rosalia mi scriveva una lettera nella quale mi
raccontava che il marito era stato portato per mano, a calci e pugni e con vere
torture a confessare un delitto che non aveva commesso, l’omicidio del
magistrato Paolo Borsellino. Ci sono voluti venticinque anni e una sordità
colpevole e senza precedenti da parte delle istituzioni per arrivare alle parole
di una donna coraggiosa come la figlia di Borsellino che denuncia i “pentiti
costruiti a tavolino”. E fa nomi e cognomi, senza paura. Quei nomi e cognomi che
non ha potuto fare (se non su personaggi non di primo piano) la corte d’assise
di Caltanissetta che nei mesi scorsi, nella sentenza al quarto processo per la
strage di via D’Amelio, ha sancito che Enzo Scarantino è stato indotto al
depistaggio dagli investigatori. Quali investigatori? Fiammetta Borsellino
ricorda chi erano i procuratori dell’epoca: il capo Tinebra, i sostituti
Annamaria Palma. Carmelo Petralia, Nino di Matteo… Questi sono i magistrati
ingenui, quelli che hanno creduto (creduto?) che un picciotto della Guadagna, un
piccolo spacciatore vanitoso e ignorante e un bel po’ spaccone, potesse aver
partecipato, con il furto di un’auto da imbottire con 90 chili di tritolo, a una
delle stragi del secolo. Hanno continuato a credere (credere?) a quelle prime
parole del “pentito” anche quando lui stesso, anche a costo di rinunciare alla
libertà, aveva continuato a dire che quella specie di verità gli era stata
estorta. Estorta come? La moglie di Scarantino aveva puntato il dito contro
Arnaldo La Barbera, il superpoliziotto che conduceva le indagini sulle stragi e
gestiva i collaboratori di giustizia. E del resto sarebbe bastato ascoltare le
testimonianze (o magari rispondere alle interrogazioni parlamentari che nel
corso degli anni deputati come me e Enzo Fragalà presentavano caparbiamente) di
chi aveva constatato sui corpi dei detenuti di Pianosa e Asinara le conseguenze
delle torture, per capire in che modo si costruivano i “pentiti”. I magistrati
non volevano vedere e tiravano dritto, osannati da una grande fanfara mediatica
e sostenuti da un partito, il Pds, che voleva fare dell’” antimafia”, di
quell’antimafia messa all’indice da Leonardo Sciascia, la propria identità. Di
quel che succedeva nelle carceri, pochi si curavano. I radicali e qualche
“matto” isolato in Parlamento e nell’opinione pubblica. La storia veniva scritta
dai “pentiti” attraverso i loro portavoce, Pm e famosi giornalisti. Scarantino
raccontava che prima di ogni interrogatorio, di ogni udienza, veniva
ammaestrato, nomi e cognomi delle persone da accusare e far arrestare gli
venivano suggeriti. Proprio come era già capitato con i 17 finti pentiti che
accusavano Enzo Tortora. Ma nel caso Scarantino si è fatto di peggio, perché si
scopriranno anni dopo addirittura appunti vergati a mano dalla grafia di qualche
inquirente. E si andrà avanti così, di processo in processo, per anni e anni,
fino al 2008. Con gli ergastoli che erano fioccati nei confronti di persone
innocenti. Quando arriva il “pentito d’oro” Gaspare Spatuzza a dire che tutto
era sbagliato, che i colpevoli erano altri, solo allora si era sbaraccato tutto
il castello costruito in 16 lunghi anni. Oggi lo dicono tutti, che era stato
tutto sbagliato. E sarebbe facile prendersela con persone che non ci sono più,
come Arnaldo La Barbera o Tinebra. Ma dove sono tutti gli uomini di governo che
hanno chiuso gli occhi, tutti i giudici delle corti d’assise che facevano i
portavoce dei Pubblici ministeri e gli investigatori che svolgevano colloqui
riservati nelle carceri e gli “sbirri” delle squadrette di picchiatori? C’è una
responsabilità collettiva in tutto ciò. Basta fiaccolate, commemorazioni e
agendine rosse. Facciamo nomi e cognomi per favore (come ci sta insegnando
Fiammetta Borsellino), magari anche di qualcuno che nel frattempo ha fatto
carriera o sta sognando di diventare ministro di giustizia.
Da Lima al bacio di Andreotti tutte le
invenzioni dei pentiti, scrive Stefano Zurlo, Sabato
28/11/2009, su "Il Giornale". L'alfa e l'omega dei pentiti. E delle bugie a
distanza di tanti anni. Le storie si ripetono e si inseguono. Inquietanti, come
i doppifondi che nascondono. Vincenzo Scarantino e Salvatore Candura entrano nel
libro mastro dei collaboratori che hanno spacciato menzogne come, a suo tempo,
Giovanni Pellegriti, uno dei primi, se non il primo in assoluto, a passare dalla
parte dello Stato. Pellegriti accusa, nientemeno, Salvo Lima, a quel tempo
proconsole di Giulio Andreotti a Palermo, di essere il mandante di uno dei tanti
omicidi eccellenti, quello del presidente della Regione Sicilia Piersanti
Mattarella. Giovanni Falcone, sempre evocato e qualche volta pure a sproposito,
corre nel carcere di Alessandria a interrogarlo e capisce subito che il pentito
mente. Non sa nulla di Mattarella né dei suoi assassini. Dovrebbe far arrestare
Lima e mandare un avviso di garanzia ad Andreotti, invece incrimina per calunnia
Pellegriti e lo fa condannare a quattro anni. Quattro anni per aver venduto
menzogne allo Stato. Un caso unico che ora potrebbe ripetersi. Tanti anni e
tanti pentiti dopo. Falcone, purtroppo, non c’è più, ma c’è un nuovo dichiarante
- strana crisalide sul punto di trasformarsi a tutti gli effetti in pentito doc
- che porta acqua al mulino delle accuse a Silvio Berlusconi. È Gaspare
Spatuzza, il killer di don Puglisi, pentito, convertito e addirittura aspirante
teologo. Spatuzza riporta le confidenze dei boss di Brancaccio, Giuseppe e
Filippo Graviano, sui rapporti di Cosa nostra col premier: dunque diventa
importante, credibile, persino autorevole. Ma, incidentalmente, sconfessa anche
Candura e Scarantino che si erano accusati di aver rubato la 126 usata per la
strage di via DAmelio e la morte di Paolo Borsellino. Che fare? Tagliare a
fette, come un prosciutto, il racconto di Spatuzza? No, non si può avallare lo
Spatuzza che parla del premier e cancellare lo Spatuzza che riscrive via
D’Amelio. E allora si buttano nel cestino Scarantino e Candura, anche se i
racconti dei due sono serviti per costruire una verità processuale che ha retto
a tutti i gradi di giudizio. Per via DAmelio sono fioccate condanne, condanne
pesantissime. Non importa. Ora la coppia Scarantino-Candura è indagata per
calunnia e autocalunnia. Ma le prove dov’erano? E i riscontri? E gli elementi
oggettivi a cui ancorare quelle pagine? Non c’erano, ammettono oggi i giudici.
Ma ieri, con l’illustre eccezione del pm Ilda Boccassini, nessuno aveva seguito
per via D’Amelio il metodo Falcone. Quei verbali erano tappeti volanti che
portavano i magistrati lontano, dove non sarebbero mai arrivati. E si faceva la
gara per salirci sopra. Certo, era più semplice dare la parola come fosse un
conferenziere, a chi raccontava e riaggiustava a ruota libera la storia
d’Italia. Un innamoramento sconsiderato, come è stato spesso eccessivo, senza
filtri critici, l’amore dei nostri investigatori per le nuove tecnologie
scientifiche, per i test del Dna, per le elaborazioni alla Csi. Col risultato di
avere un alto numero di delitti irrisolti. Il pm di Bologna Libero Mancuso ha
composto una sorta di fenomenologia del pentito, o almeno di un certo
pentitismo, incarnato da Angelo Izzo, lo stupratore del Circeo, uno dei più
fecondi inventori di storie a cavallo di criminalità comune e criminalità
organizzata: «Si intuiva la volontà di soddisfare chi lo interrogava, al di là
di quello che lui sapeva. Era come se prevedesse quello che l’inquirente voleva
sentirsi dire e si adeguasse a questa previsione, per far contento il
magistrato». Come un cinico seduttore che ha fatto i suoi calcoli. Così è
proprio Izzo a ispirare Pellegriti che però trova sulla sua strada Falcone.
Altri hanno fabbricato di tutto pur di continuare a coltivare, come tanti dottor
Stranamore, i propri affari criminali sotto il velo del pentimento. Per cinque
anni nessuno si accorge della doppia vita del siciliano Pierluigi Sparacio che
non ha mai smesso di gestire gli interessi della sua cosca. Giacomo Lauro,
padrino della ndrangheta, da pentito si dedica al narcotraffico e, colto con le
mani nel sacco, si giustifica candidamente: «Mio fratello Bruno non è in grado
di mantenersi se non spacciando droga. Cosa dovrei fare, non dovrei aiutarlo?».
Come si fa a prendere a scatola chiusa, come pure talvolta è accaduto,
personaggi di questo spessore? Giuseppe Ferone fa di più: nel 96 ordina
addirittura una strage vicino al cimitero di Catania. E Balduccio Di Maggio, il
principe dei collaboratori, quello del bacio da fiction tra Andreotti e Riina,
andrà avanti per anni a organizzare indisturbato, se non sotto protezione,
attentati, estorsioni, persino consulenze per un traffico di droga. L’unica
chance con i pentiti è quella di pesarli, con le loro verità e le loro menzogne,
sulla bilancia dei riscontri. Come insegna una memorabile udienza del processo
Andreotti, dove un grappolo di collaboratori - perché uno non basta mai -
ipotizzava un abboccamento fra il sette volte presidente del Consiglio e il capo
della mafia catanese Nitto Santapaola. Alla fine, messi alle strette dopo un
estenuante batti e ribatti, i collaboratori indicarono la data del presunto
summit. Peccato che quel giorno Andreotti avesse stretto la mano a Mikhail
Gorbaciov.
Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti
gli altri posti erano occupati. Ci sono uomini che lottano un giorno e sono
bravi, altri che lottano un anno e sono più bravi, ci sono quelli che lottano
più anni e sono ancora più bravi, però ci sono quelli che lottano tutta la vita:
essi sono gli indispensabili. Citazioni di Bertolt Brecht.
Il Prefetto (poco perfetto) del Bunga Bunga.
Guarda un po’: il prefetto Carlo Ferrigno, uno dei testi chiave dell’atto di
accusa di "papponaggio" a Berlusconi (“A casa di Berlusconi c’era pure la
Minetti, col seno da fuori, che baciava Berlusconi in continuazione. Che
puttanaio…”), è un esperto della materia: risulta iscritto nel registro degli
indagati per violenza sessuale da sette donne: ricattate in cambio di pompini…,
scrive “Dagospia”.
1 - IL PREFETTO SOTTO INCHIESTA PER VIOLENZA
SESSUALE...Franco Bechis per "Libero". Uno dei testi chiave dell'atto di accusa
a Silvio Berlusconi, il prefetto Carlo Ferrigno, è stato intercettato non su
ordine di Ilda Boccassini e dei pm di Milano che stavano indagando sui festini
di Arcore, ma del pm Stefano Civardi, che lo ha iscritto nel registro degli
indagati per ipotesi di reato gravissime, fra cui la violenza sessuale. Il
clamoroso particolare filtra con discrezione dal palazzo di Giustizia di Milano,
e fa leggere sotto altra luce l'inchiesta principale. Ferrigno infatti è
protagonista delle 389 pagine di intercettazioni telefoniche che Milano ha
inviato in parlamento per inchiodare Berlusconi. Lo è perché Ferrigno è prefetto
della Repubblica, e fra il 2003 e il 2006 è stato anche commissario anti-racket
nominato dal governo Berlusconi. È attraverso le sue parole intercettate in tre
telefonate che gli inquirenti e la stampa hanno disegnato il quadro delle feste
di Arcore. Ferrigno non ha avuto mezze parole. È stato lui a definirle «un
puttanaio» e a dare questo quadro alla stampa nelle prime ore. Lui a giudicare -
alla luce dei festini - «un uomo di merda» il presidente del Consiglio,
raccontando: «[...] tutte ragazze che poi alla fine erano senza reggipetto, solo
le mutandine, quelle strette [...], capito? Bella roba, tutta la sera [...],
pensa un po', che fa questo signore [...], ma che schifo quell'uomo».
Trattandosi di un prefetto, di «un servitore dello Stato», quel giudizio è stato
la chiave di lettura di quelle carte. Nessuno degli inquirenti però, inviandole
a Montecitorio, si è premurato di fare sapere i guai giudiziari in cui il
prefetto che si scandalizzava è incappato, e per cui il suo telefonino era sotto
controllo del pm. Ferrigno è stato denunciato nel febbraio scorso dal presidente
di Sos usura, Frediano Manzi, e dal presidente della Associazione Sos Italia
Libera, Paolo Bocedi. Alla denuncia erano allegate sette testimonianze di donne
che raccontavano ricatti e violenze sessuali subìte dal prefetto per sbloccare i
loro mutui dal fondo anti-usura. Fatti avvenuti anche dopo l'abbandono
dell'incarico di commissario, perché a loro dire il prefetto Ferrigno sosteneva
di avere ancora in mano il commissariato. Le sette donne sono state convocate in
procura e hanno confermato parola per parola i fatti. Una vittima dell'usura
aveva consentito di filmare la sua denuncia, chiedendo di oscurare il volto. Il
filmato è visionabile sul nostro sito. In procura sono arrivate altre due testi
di accusa nei confronti di Ferrigno che hanno raccontato episodi di violenza
sessuale svoltisi negli uffici o nelle abitazioni di Torino, di Milano e di Roma
in cui si trovava il prefetto. Tutti e nove i verbali sono stati segretati dalla
procura che ancora ha indagini in corso. Le accuse delle testi - lo capisce bene
chi può visionare il video - sono gravissime. I presunti ricatti subiti sono di
incredibile e odiosa violenza, le parole crude. Ferrigno - secondo il racconto -
imponeva rapporti sessuali completi e talvolta orali in cambio dello sblocco dei
mutui. E minacciava le malcapitate di non fare denuncia, perché tanto lui aveva
relazioni con molti pm e molte procure e non le avrebbero mai prese sul serio.
Il pubblico ministero Civardi invece le ha prese molto sul serio e così è nata
l'inchiesta. Quando sono emerse le prime notizie, Ferrigno ha negato ogni
responsabilità, sostenendo che le signore si erano inventate tutto. Sfortuna
vuole che pochi giorni dopo, in tutt'altra procura - quella di Fermo - ma per
episodi non dissimili si sia presentato un imprenditore, G.G., denunciando di
avere subito analoghi ricatti dal prefetto per sbloccare la somma da lui attesa
dal fondo anti-usura. Ha raccontato di avere dovuto pagare 5 mila euro per una
serata che Ferrigno voleva trascorrere con alcune ragazze di un night club della
riviera marchigiana. Il prefetto anche in questo caso è stato iscritto nel
registro degli indagati, non per reati sessuali ma per corruzione. Entrambe le
indagini sono ancora in corso, e per Ferrigno vale naturalmente la presunzione
di innocenza. Anche se sembra singolare la sua inclinazione allo scandalo per le
feste di Berlusconi. È curioso però come i verbali di intercettazione di
Ferrigno siano finiti dentro un altro faldone che poco aveva a che vedere con il
prefetto. Ferrigno infatti ha solo sfiorato le feste di Arcore, grazie a un suo
rapporto assai stretto con una ballerina marocchina, Maria Makdoum, che la sera
del 13 luglio ballò ad Arcore e nel cuore della notte telefonò a Ferrigno per un
resoconto. Di quella telefonata ci sono solo i tabulati. Ma è citata come fosse
avvenuta il giorno precedente in altre due telefonate, contenute in un
brogliaccio di intercettazioni relative a telefonate che il prefetto ha fatto a
un amico e al figlio il 22 e il 29 settembre 2010, a due mesi e mezzo dai fatti.
Un giallo ulteriore che dovrà essere chiarito.
2 - LE INTERCETTAZIONI...Da "Libero". Che uomo di
merda (...) Praticamente questo sai che faceva? Facevano le orge lì dentro, non
con droga, non mi risulta, capito? E facevano quel lavoro lì. Bevevano tutte
mezze discinte, e poi lui è rimasto con due o tre di queste (...) tutte ragazze
che poi alla fine erano senza reggipetto, solo le mutandine quelle strette (...)
capito? Bella roba, tutta la sera (...) pensa un po\', che fa questo signore
(...) ma che schifo quell'uomo.
La testimone X.Y su Ferrigno...Sua Eccellenza il
prefetto Carlo Ferrigno mi chiamò a Roma per vedere la mia pratica perché diceva
che c'erano novità. Mi mandò a prendere da Tonino, il suo autista. Suonai. Mi
venne ad aprire Sua Eccellenza e io ero un po' imbarazzata perché lo vidi in
accappatoio. (...) La situazione era imbarazzante perché era nudo. Lui lasciava
aperto l'accappatoio e quindi si vedevano i genitali. Cominciò con dei
convenevoli (...) mi chiese di toccarlo. Mi disse proprio "Mi fai il favore di
toccarmi?". Dissi che non ci pensavo proprio. Lui reagì sostenendo che non avevo
capito, non dovevo pensare male... Mi prese per mano e mi portò in camera da
letto... (...) Mi prese le mani e le mise sui suoi genitali... Io mi ritrassi.
Lui disse che non avevo capito niente, (...) ma che ero abbastanza intelligente
per capire che questa situazione mi avrebbe portato dei benefici. Lui (il
prefetto Carlo Ferrigno) chiuse la porta dietro di me a chiave. Mi sono sentita
sicuramente in trappola (...). Mi disse che non pretendeva tanto, che gli
bastava anche un rapporto orale. Gli dissi che non se ne parlava proprio. Lui mi
spinse sul letto e mi infilò la mano nei calzoni. Nel frattempo si era slacciato
i suoi e aveva fuori il pene e i testicoli (...) Mi disse che le pratiche
potevano restare ferme fino alla prescrizione, che lui aveva tanti amici nelle
procure e anche fra i giudici e che la mia denuncia sarebbe finita in niente...
Mi portò nei sotterranei... Mi prese la mano, la portò sui calzoni. Si slacciò
la cerniera e in quella occasione mi disse che era la soluzione a tutti i miei
problemi... se non vuoi avere un rapporto con me possiamo avere almeno un
rapporto orale. Chiaramente mi rifiutai e lui mi disse che avevo deciso comunque
la mia fine...
Ferrigno su Berlusconi. A casa di Berlusconi c'era
pure la Minetti, col seno da fuori, che baciava Berlusconi in continuazione,
insomma, senti, proprio un puttanaio eh? Quella Minetti lì, dice che poi non è
nemmeno tanto bella, quella sera che c'erano tutte donne, Emilio Fede, Lele e
lei, c'era anche la Minetti (...) quella mi chiamava, pur essendo lei una
puttanella è rimasta esterrefatta quando stavano tutte discinte con le mutande,
mezze ubriache, in braccio a Berlusconi e se le baciava tutte, le toccava
tutte....
Si chiama «Lady Mafia», è una serie a fumetti noir
che vede protagonista una donna del Sud a metà tra mala, sete di vendetta e
voglia di giustizia. Il fumetto è in edicola da neanche 48 ore ed è già
diventato un caso, scrive Alessandro Fulloni su “Il Corriere della Sera”. Tanto
da essere bocciato dalla commissione parlamentare Antimafia che, per bocca del
deputato Pd Davide Mattiello, parla di «operazione editoriale offensiva che deve
essere sospesa», siamo davanti a un albo «che non trova di meglio che esaltare
la violenza mafiosa come una risposta alla violenza mafiosa». Dello stesso
tenore il comunicato di Libera, l’associazione antimafia fondata da don Ciotti.
«Ancora una volta si gioca con le parole e si sfrutta il “fascino” della mafia
per un’attività commerciale che di educativo e formativo non ha nulla». Ma cos’è
Lady Mafia? L’albo ammicca alle suggestioni del fumetto noir anni
Sessanta/Settanta, Diabolik in testa. Formato bonelliano, 132 pagine bimestrali.
Una programmazione di 10 uscite. Pubblicato dalla «Cuore Noir Edizioni», casa
editrice pugliese che ora prova l’esperimento dell’edicola. Per ora Lady Mafia
ha ricevuto recensioni e anticipazioni lusinghiere dalle riviste specializzate.
La storia è quella di una ragazza del Sud, che nella fantasia dell’autore,
Pietro Favorito, prende il nome di Veronica De Donato. Una storia dura, una saga
familiare che mescola sangue e violenza. Alle spalle una famiglia distrutta
dalla mafia in modo truce. E un presente volto a cercare una giustizia che sa
molto di vendetta. Feroce. Libera però ritiene l’uscita di questo albo
«un’operazione che ferisce la memoria di tante donne vittime delle mafie e dei
loro familiari, impegnati a promuovere con le loro testimonianze il valore della
giustizia contro la barbarie anche culturale della vendetta». Non solo. «Nel
paese di Lea Garofalo e di tante donne come lei che hanno scelto, anche a prezzo
della vita - si legge in un comunicato - il coraggio della denuncia, il fumetto
Lady Mafia rappresenta un vero e proprio insulto alla loro memoria». Lo
sceneggiatore dell’albo Favorito replica così alle accuse: «Innanzitutto teniamo
a precisare che non è nelle nostre intenzioni ferire nessuna delle tante donne
vittime della mafia - dice a Corriere.it - né tantomeno oltraggiare la loro
memoria. Ma certe accuse arrivano da chi il fumetto non lo ha nemmeno letto. La
violenza? Il nostro obiettivo è quello di demistificarla raccontandola».
L’autore spiega che «Lady Mafia è un fumetto noir, che si tinge di tinte forti
come previsto dal filone narrativo cui fa capo, e le parole Lady Mafia altro non
vogliono essere che un sostantivo femminile della parola boss. Se invece di
chiamarlo Lady Mafia, il nostro fumetto l’avessimo chiamato mister mafia,
avremmo fatto lo stesso scalpore?».
Berlusconi come Riina: «Pedinate chiunque
passi per Arcore», scrive Giovanni M. Jacobazzi il 7
Aprile 2017 su "Il Dubbio". Così la Guardia di Finanza controllava gli amici del
Cavaliere: si appostavano davanti villa San Martino con microcamere a infrarossi
nascoste in un auto civetta. «Interesse investigativo». In questi termini, senza
aggiungere altro, il maresciallo della guardia di finanza di Milano Emiliano
Talanga, rispondendo ad una domanda della difesa, ha spiegato il perché del
pedinamento del generale dei carabinieri Vincenzo Giuliani che andava ad
incontrare Silvio Berlusconi ad Arcore. La circostanza è emersa la scorsa
settimana durante l’udienza nel processo in corso davanti alla quarta sezione
penale del tribunale di Milano, presidente Giulia Turri, a carico del
consigliere regionale lombardo Mario Mantovani (FI), imputato per reati contro
la Pubblica amministrazione. Nel mese di ottobre del 2013, all’epoca dei fatti
contestati, Mantovani ricopre la carica di vice presidente ed assessore alla
Salute della Regione Lombardia, nonché quella di coordinatore regionale del
Popolo delle Libertà. Il suo telefono è intercettato. Come anche quello del suo
segretario particolare Giacomo Di Capua. I finanzieri del gruppo Tutela Spesa
Pubblica di Milano, coordinati dal sostituto procuratore Giovanni Polizzi,
sospettano che i due, fra le tante cose, condizionino alcuni appalti nella
sanità lombarda. Agli inizi di ottobre di quell’anno, Di Capua viene contattato
dal colonnello dei carabinieri Giovanni Balboni, aiutante di campo del generale
Vincenzo Giuliani. I due si conoscono da diverso tempo. Giuliani è al massimo
della carriera. Nominato generale di corpo d’armata, è stato appena mandato a
comandare l’interregionale carabinieri “Pastrengo”, uno degli incarichi più
prestigiosi d’Italia, con competenza sul Piemonte, la Lombardia e la Liguria. Di
Capua e Balboni decidono di organizzare un incontro fra Giuliani e Berlusconi ad
Arcore. Mantovani, in qualità di coordinatore regionale del Pdl, si occuperà di
prendere un appuntamento con lo staff di Berlusconi. I carabinieri sono di casa
ad Arcore, svolgendo ininterrottamente dal 2000 un servizio di vigilanza fissa
intorno a villa San Martino. Servizio che non è stato interrotto neppure quando
Berlusconi non era più Presidente del Consiglio. Sono telefonate frenetiche
quelle fra Di Capua e Balboni. L’agenda di Berlusconi è fitta di impegni. I due
si vedono anche presso la sede del comando interregionale “Pastrengo” in via
Marcora nel centro di Milano. Tramite il cellulare intercettato di Di Capua,
Giuliani parla in diverse occasioni direttamente con Mantovani. Ad uno di questi
incontri fra Di Capua e Balboni si presentano anche i finanzieri. Nascosti nel
parcheggio antistante la sede di via Marcora, registrano e fotografano tutto.
Uno spazio nell’agenda di Berlusconi si libera per il 14 ottobre. Nel
pomeriggio. Recarsi ad Arcore è un sorta di “porta fortuna” per i comandanti
dell’interregionale “Pastrengo”: i predecessori di Giuliani, il generale Luciano
Gottardo e il Generale Gianfrancesco Siazzu, dopo quell’incarico furono nominati
comandanti generali dell’Arma. Per il 14 ottobre è tutto pronto. La finanza
organizza nei confronti di Giuliani un servizio che nel gergo tecnico si chiama
Ocp (osservazione, controllo e pedinamento). Con delle micro telecamere ad
infrarosso nascoste in un’auto “civetta”, i finanzieri si appostano davanti
villa San Martino e riprendono il generale che arriva nei pressi della residenza
dell’ex premier con l’autovettura di servizio. Fino a quando, come si legge nel
verbale, parcheggiato il veicolo nei pressi della villa, «scendeva dalla propria
auto in dotazione all’Arma ed entrava nella auto Bmw grigia con a bordo
l’assessore Mantovani, la quale ripartiva per entrare» nella residenza. Il
filmato integrale, con tanto di audio, è agli atti d’indagine. Cosa si siano
detti Giuliani e Berlusconi non è dato sapere visto che le riprese si
interrompono davanti al cancello di villa San Martino. Difficilmente si saprà
qualcosa dai diretti interessati in quanto sia Giuliani che Berlusconi non sono
nella lista testi. Giuliani, però, quando alcuni atti di questo incontro
finirono sui giornali, diede la sua versione dell’accaduto. «Quando arrivai in
Regione, Mantovani (che conoscevo in Piemonte quando era sottosegretario alle
Infrastrutture) mi chiese se avessi piacere di salutare Berlusconi. Io accettai
anche perché avrei voluto dire al presidente che era appena cambiata tutta la
catena gerarchica, e indicare gli interlocutori per qualunque inconveniente
relativo ai servizi dell’Arma attorno alla villa». Ma perché il trasbordo
sull’auto di Mantovani? «Si offrì lui di portarmi sulla sua auto, che presumo
fosse più conosciuta dai guardiani di Arcore. Io valutai di entrarvi non in
divisa e non sulla mia auto per non allarmare nessuno: questione di
riservatezza, non di carboneria. Non chiesi alcunché a Berlusconi, né l’ho più
incontrato». Tranne, appunto, il 14 ottobre del 2013 in un incontro definito dai
finanzieri di Milano di “interesse investigativo”.
La mafia è cosa seria: non
lasciamola all’antimafia…scrive
Piero Sansonetti il 22 luglio 2017 su "Il Dubbio". Diceva Georges Clemenceau,
statista francese di inizio novecento: «La guerra è una cosa troppo seria per
lasciarla ai militari». Già, aveva ragione. Con la mafia – anzi, con la lotta
alla mafia – più o meno è la stessa cosa. È roba troppo seria per lasciarla
all’antimafia. La mafia è una organizzazione criminale potente e strutturata che
ha dominato – nelle sue varie espressioni l’economia, e in parte anche la
politica, nel Mezzogiorno d’Italia, per almeno per un secolo. Negli anni ottanta
fu combattuta a fondo da un gruppo coraggiosissimo di magistrati e da settori
onesti e seri della politica, e subì una sconfitta dalla quale non si è ripresa.
Oggi la mafia non è più la feroce e potente organizzazione che era trent’anni
fa, tuttavia esiste ancora e controlla la parte maggiore dell’attività criminale
in quasi tutte le regioni del Sud. Ha perso molto del suo potere militare e
della sua egemonia culturale, gode di protezioni assai più limitate di un tempo,
ha difficoltà a permeare la società civile. La mafia è una cosa seria, non
lasciamola all’antimafia. Però è viva, è pericolosa, funziona ancora molto bene
e ancora dispone di legami sociali forti e anche di agganci politici. Sarebbe
una follia smettere di combatterla. Sul piano giudiziario e sul piano politico.
È possibile oggi combattere la mafia, così come negli anni ottanta la
combatterono Falcone e Borsellino? È possibile, ma c’è un ostacolo nuovo:
l’antimafia. Capisco che è un paradosso, ma è così. Esiste un settore molto
largo dell’intellighenzia, dell’informazione, della politica, della
magistratura, della Chiesa, e anche della società civile, che da una ventina
d’anni ha messo in piedi un apparato ramificato di organizzazioni antimafia, le
quali hanno trasformato in un grande affare il lavoro di quelli che trent’anni
fa erano in prima linea. Oppure lo hanno trasformato in ideologia, o in
un’occasione di lotta politica. Questa antimafia, che pure trae origine dalla
lotte aspre e coraggiose combattute tanti anni fa, è diventata il primo ostacolo
alla lotta alla mafia, perché ha smesso di occuparsi della mafia come fenomeno
sociale e criminale, e l’ha trasformata in “bersaglio ideologico”, da usare per
finalità del tutto diverse dalla lotta per ristabilire la legalità. La stessa
legalità è diventata una specie di feticcio, oppure di clava, che si adopera per
lo svolgimento di battaglie politiche puramente di potere. Il primo a denunciare
questo fenomeno, in tempi non sospetti, e molto prima che il fenomeno assumesse
le dimensioni larghissime e di massa che ha oggi, fu Leonardo Sciascia. E
Leonardo Sciascia era stato precedentemente l’intellettuale italiano che aveva
lanciato nel deserto, nel silenzio generale, i primi anatemi contro Cosa Nostra.
«Il Giorno della civetta» è un romanzo che Sciascia scrisse nel 1961. In quel
periodo i giornali non parlavano mai di mafia. Molti negavano che esistesse.
Molti politici e molti magistrati avevano la stessa posizione: la mafia è
un’invenzione della letteratura. Leonardo Sciascia, che la Sicilia la conosceva
bene, sosteneva il contrario e, come sempre nella sua vita, era ascoltato quasi
da nessuno. Il suo libro diventò un film solo sette anni dopo la sua
pubblicazione, per merito di un regista come Damiano Damiani. Il film ebbe
successo, ma come film di avventura non come film di denuncia. Beh, è stato
proprio Sciascia, quasi trent’anni più tardi, a indicare il fenomeno emergente
dei professionisti dell’antimafia. E, quando lo fece, rimase di nuovo isolato.
Oggi esistono due modi sbagliati per fare
antimafia. Il primo è politico, il secondo è giudiziario.
L’antimafia politica è quella della retorica e
della criminalizzazione. Ci sono dei gruppi che si autoproclamano sacerdoti del
tempio, e dispensano condanne e assoluzioni. Pretendono l’esclusiva
dell’autografo antimafia. Se ne infischiano della necessità di colpire
l’organizzazione mafiosa e usano la lotta alla mafia per ottener vantaggi
politici, per colpire gli avversari, per scomunicare, per guadagnare potere.
Qualche esempio? Basta seguire l’attività dell’antimafia della Bindi, che non ha
niente a che fare con una commissione d’inchiesta parlamentare e appare sempre
di più un gruppo politico d’assalto, molto spregiudicato. Com’era
l’Inquisizione.
L’antimafia giudiziaria è quella di chi usa la
“mafiosità” come reato politico per dare peso e spettacolarità alle indagini,
oppure, semplicemente, per renderle più facili. Il caso più clamoroso,
naturalmente, è quello dell’eterno processo di Palermo alla cosiddetta
trattativa stato- mafia. Un processo che sul piano giudiziario non sta in piedi
neppure con il vinavil, ma che ha reso celebri i Pm che ne sono stati
protagonisti e ne ha irrobustito le carriere. Il processo sulla trattativa
inesistente, per anni, fino ad oggi, ha preso il posto alle grandi e vere
inchieste antimafia. Che sono scomparse. Se pensate alle inchieste di Falcone e
Borsellino, costruite sul lavoro duro, e che portarono alla condanna di tutto il
gotha di Cosa Nostra, e le confrontate con la messa in scena dello Stato- Mafia,
capite bene quale è la differenza tra un’inchiesta giudiziaria e la giustizia-
spettacolo. E qual è la differenza tra la lotta alla mafia e l’antimafia-
Barnum. Poi c’è un secondo modo sbagliato di usare l’antimafia. Certo più
sostanzioso, meno vanesio, ma anche questo scorretto. È l’abitudine di usare
comunque l’aggravante mafiosa, anche in processi alla delinquenza comune, per la
semplice ragione che così si possono applicare norme e leggi speciali che
altrimenti sarebbero inutilizzabili. È la famosa questione del doppio binario
della giustizia. L’abbiamo vista bene anche in occasione del processo di Roma
(mafia capitale), quello che si è concluso l’altroieri con molte condanne ma con
la proclamazione che la mafia non c’entra. Il fine giustifica i mezzi? No,
almeno nel campo del diritto, il fine non giustifica i mezzi. Se non ci
convinciamo della necessità di farla finita con l’antimafia professionale, non
riusciremo mai più a riprendere in mano la lotta alla mafia. Cioè alle cosche
reali. Quelle che esistono, che operano, che si organizzano, che inquinano
l’economia e la vita civile. Per riprendere questa battaglia bisogna avere il
coraggio di dire apertamente che l’antimafia professionale va spazzata via –
nelle Procure, nei partiti e soprattutto nel giornalismo – e che l’uso
dell’antimafia come strumento per lotte politiche di potere è un atteggiamento
devastante per la società, più o meno come lo è l’atteggiamento della mafia. A
chi tocca aprire questa battaglia? Alla politica. Toccherebbe alla politica e
all’intellettualità. Voi vedete in giro qualche esponente politico che abbia il
coraggio di avviare una battaglia di questo genere? O qualche intellettuale?
PARLIAMO DI MASSONERIA E DI CHI COMANDA IL
MONDO.
Caccia agli elenchi degli iscritti. La
mossa di Bindi agita i massoni. Grande Oriente d’Italia, Antimafia pronta al
sequestro. Loro: «I nomi saranno tutelati?», scrive
Fabrizio Caccia il 19 gennaio 2017 su "Il Corriere della Sera". Ora i «fratelli»
sono tutti preoccupati, dice Stefano Bisi, Gran maestro del Grande Oriente
d’Italia, la comunione massonica più vasta del nostro Paese, con le sue 850
logge e i quasi 23 mila iscritti. Rosy Bindi, la presidente della commissione
parlamentare Antimafia, sembra decisa a far sequestrare entro fine mese (dalla
Guardia di Finanza) gli elenchi del Grande Oriente d’Italia per chiarire i
rapporti tra mafia e massoneria, specie in Sicilia, dalle parti di
Castelvetrano, la terra di Matteo Messina Denaro, il capo dei capi di Cosa
Nostra, dove da anni, insieme alle zagare, fioriscono anche le logge. «Ma chi ci
garantisce che tutti i nomi presenti nei nostri elenchi verranno effettivamente
tutelati? — protesta il Gran maestro Bisi —. Se uno è massone e lo vuole dire
pubblicamente, d’accordo. Ma se uno non lo vuol dire, perché dev’essere
obbligato? In Italia, mi pare, esiste il diritto alla privacy...». Già, diritto
sacro e inviolabile. Anche se i massoni del Terzo Millennio ormai vanno in
televisione, scrivono libri, organizzano convegni e appongono grandi targhe sui
loro portoni («Avete visto la scritta che abbiamo messo davanti alla sede di
Milano, vicino alla Stazione Centrale? Se la batte con la pubblicità dello Stock
84...», Bisi dixit). Insomma, la segretezza è diventata un optional. Tanto che
quando è stato arrestato il «fratello» Giulio Occhionero con l’accusa di aver
rubato migliaia di file dalle mail di politici e manager di Stato, oltre a
essere entrato nei sistemi informatici di numerose aziende, in molti hanno
sentito il bisogno di rilasciare interviste a giornali e tv. Ora invece si
dicono preoccupati: «Se escono gli elenchi, specie in una città papalina come
Roma, con un’antica tradizione antimassonica, sono in tanti a temere
conseguenze, qualcuno potrebbe finire addirittura licenziato...», afferma
l’ingegner Giacomo Manzo, 90 anni, membro del Goi del Lazio, che dopo lo
scandalo dei presunti cyber spioni non ha voluto comunque lasciare la loggia
«Paolo Ungari-Nicola Ricciotti – Pensiero e azione» di Roma, di cui era stato
«maestro venerabile» proprio Occhionero, ancora a Regina Coeli.
L’accostamento massone-mafioso, però, lo trovano
offensivo: «Noi a Castelvetrano - dice il Gran maestro del Goi - abbiamo una
sola loggia, la “Francisco Ferrer”, composta di 40 fratelli. E sono già stati
loro, spontaneamente, a consegnare alla Digos i registri. Ma io non mi posso
portare il peso sulle spalle anche di quelli che non conosco: in Italia ci sono
almeno un’ottantina di altre obbedienze massoniche e sta alla polizia, alla
magistratura, andare a scandagliarle. Noi che c’entriamo?».
Si mette sulla stessa lunghezza d’onda Gioele
Magaldi, Gran maestro del Grande Oriente d’Italia Democratico, movimento
massonico d’opinione, di natura più trasversale e sovranazionale: «Le comunioni
massoniche sono tutte associazioni legali — obietta Magaldi, autore nel 2014 del
libro Massoni società a responsabilità illimitata — e lo stato di diritto che si
vuole garantire con la lotta alla mafia si tutela pure con il rispetto della
privacy di chi troppo spesso in Italia è stato oggetto di demonizzazione e
caccia alle streghe. I mafiosi, peraltro, si possono annidare anche in
organizzazioni religiose, cui però non si chiedono liste...». «E già — ancora il
Gran maestro Bisi — ci vedono come tanti piccoli Licio Gelli che stanno sempre a
tramare nell’ombra coi loro guanti e coi loro grembiulini. Invece non sapete
niente di noi, delle nostre raccolte fondi per illuminare il campo sportivo di
Norcia o per ricostruire il liceo musicale di Camerino. E non ci sono logge,
badate!, a Norcia e a Camerino. La fratellanza, da sempre, vuol solo dare una
mano al mondo e lavorare per la gloria del grande architetto dell’universo, il
Dio che ogni massone si porta dentro...».
Addirittura si vanta perché c’è una nuova
iniziativa, quella del camper odontoiatrico dei «fratelli dentisti» pronto a
partire oggi stesso da Torino per girare l’Italia offrendo cure gratis ai
profughi, «ma la burocrazia ce lo impedisce». E tanto basta a dimostrare che di
segretezza neanche a parlarne visto che gli appuntamenti sarebbero nelle piazze.
La verità sull’articolo censurato da
Caccia riportata dal Sito “Grande Oriente d’Italia Democratico”.
Intervista integrale concessa dal Gran Maestro Gioele Magaldi al Corriere della
Sera su perquisizioni e demonizzazioni antimassoniche propugnate da Rosy Bindi e
dalla Commissione antimafia. GOD diffida Rosy Bindi e la Commissione antimafia
dal proseguire nella caccia alle streghe contro i massoni peones delle Comunioni
ordinarie e invita piuttosto ad indagare i livelli massonici sovranazionali
neoaristocratici, che hanno devastato e devastano l’interesse pubblico e
popolare mediante leggi costituzionali nefaste e attività bancarie verminose.
Caccia antimassonica alle Streghe di Rosy Bindi e Commissione antimafia:
l’intervista di Gioele Magaldi al Corriere della Sera, e rendiamo pubblico, per
la prima volta, il testo integrale dell’Intervista concessa dal Gran Maestro del
GOD al giornalista Fabrizio Caccia, del Corriere della Sera. Testo integrale che
non è stato mai pubblicato, limitandosi, il suddetto Caccia, nel corpo
dell’articolo: “Caccia agli elenchi degli iscritti. La mossa di Bindi agita i
massoni”, articolo di Fabrizio Caccia per il Corriere della Sera. A riportare
queste sintetiche e incomplete valutazioni:
Si mette sulla stessa lunghezza d’onda Gioele
Magaldi, Gran maestro del Grande Oriente d’Italia Democratico, movimento
massonico d’opinione, di natura più trasversale e sovranazionale: «Le comunioni
massoniche sono tutte associazioni legali — obietta Magaldi, autore nel 2014 del
libro Massoni società a responsabilità illimitata — e lo stato di diritto che si
vuole garantire con la lotta alla mafia si tutela pure con il rispetto della
privacy di chi troppo spesso in Italia è stato oggetto di demonizzazione e
caccia alle streghe. I mafiosi, peraltro, si possono annidare anche in
organizzazioni religiose, cui però non si chiedono liste...».
Invece, il testo delle dichiarazioni integrali
rilasciate da Magaldi era il seguente e faceva seguito a queste domande, inviate
per iscritto, da Fabrizio Caccia:
(FABRIZIO CACCIA) “Allora: viene prima il diritto
alla privacy del massone o l’interesse dello Stato a sapere se negli elenchi si
cela un mafioso? E’ possibile dire quanti sono i massoni in Italia? Quante
obbedienze? Si è prevenuti verso i massoni? C’è una sorta di pregiudizio
negativo o è colpa della troppa segretezza? Guanti, grembiuli, squadra e
compasso non sono un po’ superati?
(GIOELE MAGALDI): “Dal punto di vista giuridico,
ha detto bene il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, Stefano Bisi: non si
capisce perché la commissione antimafia pretenda gli elenchi degli iscritti al
GOI e non anche quelli dei partiti o dei sindacati. Sono tutte associazioni
legali e lo stato di diritto che si vuole garantire con la lotta alla mafia, si
tutela anche con il rispetto della privacy di chi - i massoni ordinari e per lo
più inoffensivi - troppo spesso in Italia sono stati oggetto di demonizzazione e
caccia alle streghe. I mafiosi, peraltro, si possono annidare anche in
organizzazioni religiose, cui però non si chiedono liste. Piuttosto, inviterei
Rosy Bindi a chiedere conto al senatore a vita Mario Monti e all’ex presidente
Giorgio Napolitano delle influenze nefaste che le loro rispettive superlogge di
appartenenza “Babel Tower” e “Three Eyes” hanno avuto sulla vita istituzionale e
socio-economica dell’Italia. In effetti, citando esplicitamente e mettendo agli
atti il mio libro “Massoni. Società a responsabilità illimitata. La scoperta
delle Ur-Lodges, Chiarelettere, senatori (Laura Bottici in particolare) e
deputati M5S hanno presentato interrogazioni parlamentari sugli inquietanti
legami massonici sovranazionali di ispirazione neoaristocratica che hanno
ispirato l’incarico di governo dato dal ‘fratello’ Napolitano al ‘fratello’
Monti nel 2011, inaugurando uno degli esecutivi più rovinosi della storia della
repubblica. Le principali Comunioni massoniche in Italia sono il GOI, la Gran
Loggia d’Italia, la Gran Loggia Regolare d’Italia e la Camea, guidata dal mio
fraterno amico Roberto Luongo. Poi vi sono una moltitudine di
Comunioni/Obbedienze minori, per un totale di qualche decina di migliaia di
massoni ordinari. Ma, in Italia, come altrove, a contare davvero non sono più
queste Comunioni (federazioni di logge su base nazionale), bensì le reti delle
superlogge sovranazionali (Ur-Lodges). Di tali reti ho parlato nel best-seller
“Massoni”, edito nel novembre 2014 in Italia, che il 7 febbraio 2017 verrà
pubblicato in traduzione spagnola da Kailas Editorial e in via di pubblicazione
anche in lingua francese, inglese, tedesca, russa, cinese, araba, ecc. Per
capire la natura e le ragioni storiche dei pregiudizi italioti verso la
Massoneria e soprattutto per comprendere come i massoni delle reti
sovranazionali abbiano costruito la contemporaneità, le società aperte, libere,
democratiche, laiche, tolleranti e fondate sullo stato di diritto, oltre che
l’attuale società globalizzata (nel bene e nel male), e infine per capire come
il back o high-office del potere globale sia tuttora costitutivamente massonico,
invito alla lettura di “Massoni”, il cui sottotitolo “Società a responsabilità
illimitata” lascia intuire qualcosa su cui i media faranno bene a riflettere con
minore superficialità di quella adottata sinora”.
Massoni: Società a Responsabilità
Illimitata - Libro. La Scoperta delle Ur-lodges, Laura
Maragnani, Gioele Magaldi. Gioele Magaldi è uno storico, politologo e filosofo,
ex Maestro Venerabile della loggia "Monte Sion di Roma" (Goi), già membro della
Ur-Lodge "Thomas Paine”, è Gran Maestro del movimento massonico “Grande Oriente
Democratico” (God). Fautore di un impegno solare e progressista della
massoneria, ha dato vita anche a “Democrazia Radical Popolare” (Drp) e al
"Movimento Roosevelt" (Mr). Esperto di filosofia e cultura rinascimentale, è
anche studioso delle correnti spirituali eterodosse ed esoteriche nell’Europa
moderna e contemporanea. Tra le sue pubblicazioni: Ut Philosophia
poesis (Pericle Tangerine) e Alchimia. Un problema storiografico ed
ermeneutico (Mimesis).
Descrizione. Sedetevi e fate un bel respiro: qui
trovate storia, nomi e obiettivi dei massoni al potere in Italia e nel mondo,
raccontati da autorevolissimi insider del network massonico internazionale, che
per la prima volta aprono gli archivi riservati delle proprie superlogge
(Ur-Lodges). Le liste che leggerete sono sconvolgenti. Una battaglia per la
democrazia. Tra le Ur-Lodges neoaristocratiche, che vogliono restaurare il
potere degli oligarchi, e quelle progressiste, fedeli al motto "Liberté Égalité
Fraternité", è in corso una guerra feroce. L'ultimo atto è già iniziato, come
rivela Magaldi con la rottura della pax massonica stilata nel 1981: il
patto "United freemasons for globalization". Una rilettura esplosiva del
Novecento nei suoi momenti più drammatici - la guerra fredda, gli omicidi dei
fratelli Kennedy e di M. L. King, gli attentati a Reagan e a Wojtyla - arrivando
fino al massacro dell'11 settembre 2001 e all'avanzata dell'Isis. "Massoni.
Società a responsabilità illimitata. "La scoperta delle Ur-Lodges" è il primo
volume di una trilogia che offre un'inedita radiografia del potere.
Sedetevi e fate un bel respiro: qui trovate
storia, nomi e obiettivi dei massoni al potere in italia e nel mondo, raccontati
da autorevolissimi insider del network massonico internazionale, che per la
prima volta aprono gli archivi riservati delle proprie superlogge (ur-lodges).
Le liste che leggerete sono sconvolgenti. Lo sapevate che Angela Merkel e
Vladimir Putin sono stati iniziati alla stessa ur-lodge, la golden eurasia? e
che l’isis è manipolato da superfratelli assolutamente indifferenti all’islam?
da Barack Obama a Xi Kimping, da Mario Draghi a Giorgio Napolitano, da Christine
Lagarde a Pier Carlo Padoan, passando per Gandhi, Reagan, Mandela, Agnelli,
Clinton e Blair, ecco i grembiulini che hanno segnato la storia del novecento e
dei primi anni duemila. Una battaglia per la democrazia. Tra le ur-lodges
neoaristocratiche, che vogliono restaurare il potere degli oligarchi, e quelle
progressiste, fedeli al motto liberté égalité fraternité, è in corso una guerra
feroce. L’ultimo atto è già iniziato, come rivela magaldi per la prima volta,
con la rottura della pax massonica stilata nel 1981: il patto united freemasons
for globalization. Una rilettura esplosiva del novecento nei suoi momenti più
drammatici – la guerra fredda, gli omicidi dei fratelli Kennedy e di M.L. King,
gli attentati a Reagan e a Wojtyla – arrivando fino al massacro dell’11
settembre 2001 e all’avanzata dell’isis in questi giorni. Massoni società a
responsabilità illimitata. La scoperta delle ur-lodges è il primo volume di una
trilogia che offre un’inedita radiografia del potere.
Massoneria, libro shock del gran maestro
Magaldi: “Ecco i potenti nelle logge”. Centinaia di
nomi, tra cui Napolitano, Obama, Draghi, Bin Laden e Papa Giovanni XXIII. Tutti
"fratelli" secondo l'autore del volume presentato domani a Roma. Che però dice:
"Le prove le esibiscono soltanto se me le chiede il giudice", scrivono Gianni
Barbacetto e Fabrizio Desposito il 19 novembre 2014 su "Il Fatto Quotidiano".
Esistono i massoni e i supermassoni, le logge e le superlogge. Gioele Magaldi,
quarantenne libero muratore di matrice progressista, ha consegnato
all’editore Chiarelettere (che figura tra gli azionisti di questo giornale) un
manoscritto sconcertante e che sarà presentato domani sera alle 21 a Roma, a
Fandango Incontro. Il libro, anticipato ieri dal sito affaritaliani.it, è
intitolato Massoni società a responsabilità illimitata, ma è nel sottotitolo la
chiave di tutto: La scoperta delle Ur-Lodges. Magaldi, che anni fa ha fondato in
Italia il Grande Oriente Democratico, in polemica con il Grande Oriente
d’Italia, la più grande obbedienza massonica del nostro Paese, in 656 pagine
apre ai profani un mondo segreto e invisibile: tutto quello che accade di
importante e decisivo nel potere è da ricondurre a una cupola di
superlogge sovranazionali, le Ur-Lodges, appunto, che vantano l’affiliazione
di presidenti, banchieri, industriali. Non sfugge nessuno a questi cenacoli. Le
Ur-Lodges citate sono 36 e si dividono tra progressiste e conservatrici e da
loro dipendono le associazioni paramassoniche tipo la Trilateral Commission o
il Bilderberg Group. Altra cosa infine sono le varie gran logge nazionali, ma
queste nel racconto del libro occupano un ruolo marginalissimo. Tranne in un
caso, quello della P2 del Venerabile Licio Gelli. I documenti che mancano sono a
Londra, Parigi e New York. Prima però di addentrarci nelle rivelazioni clamorose
di Massoni è d’obbligo precisare, come fa Laura Maragnani, giornalista
di Panorama che ha collaborato con Magaldi e ha scritto una lunga prefazione,
che l’autore non inserisce alcuna prova o documento a sostegno del suo libro,
frutto di un lavoro durato quattro anni, nei quali ha consultato gli archivi di
varie Ur-Lodges. Tuttavia, come scrive l’editore nella nota iniziale, in caso di
“contestazioni” Magaldi si impegna a rendere pubblici gli atti
segreti depositati in studi legali a Londra, Parigi e New York. Detto questo,
andiamo al dunque non senza aver specificato che tra le superlogge progressiste
la più antica e prestigiosa è la Thomas Paine (cui è stato iniziato lo stesso
Magaldi) mentre tra le neoaristocratiche e oligarchiche, vero fulcro del volume,
si segnalano la Edmund Burke, la Compass Star-Rose, la Leviathan, la Three Eyes,
la White Eagle, la Hathor Pentalpha. Tutto il potere del mondo sarebbe contenuto
in queste Ur-Lodges e finanche i vertici della fu Unione Sovietica, a partire da
Lenin per terminare a Breznev, sarebbero stati superfratelli di una loggia
conservatrice, la Joseph de Maistre, creata in Svizzera proprio da Lenin. Può
sembrare una contraddizione, un paradosso, ma nella commedia delle apparenze e
dei doppi e tripli giochi dei grembiulini può finire che il più grande
rivoluzionario comunista della storia fondi un cenacolo in onore di un caposaldo
del pensiero reazionario. In questo filone, secondo Magaldi, s’inserisce pure
l’iniziazione alla Three Eyes, a lungo la più potente Ur-Lodges conservatrice,
di Giorgio Napolitano, attuale presidente della Repubblica e per mezzo secolo
esponente di punta della destra del Pci: “Tale affiliazione avvenne nello stesso
anno il 1978, nel quale divenne apprendista muratore Silvio Berlusconi. E mentre
Berlusconi venne iniziato a Roma in seno alla P2 guidata da Licio Gelli nel
gennaio, Napolitano fu cooptato dalla prestigiosa Ur-Lodge sovranazionale
denominata Three Architects o Three Eyes appunto nell’aprile del 1978, nel corso
del suo primo viaggio negli Stati Uniti”. Altri affiliati: Papa Giovanni XXIII,
Bin Laden e l’Isis, Martin Luther King e i Kennedy. C’è da aggiungere, dettaglio
fondamentale, che nel libro di Magaldi la P2 gelliana è figlia dei progetti
della stessa Three Eyes, quando dopo il ‘68 e il doppio assassinio di Martin
Luther King e Robert Kennedy, le superlogge conservatrici vanno all’attacco con
una strategia universale di destabilizzazione per favorire svolte autoritarie e
un controllo più generale delle democrazie. “Il vero potere è massone”. E
descritto nelle pagine di Magaldi spaventa e fa rizzare i capelli in testa.
Dal fascismo al nazismo, dai colonnelli in Grecia alla tecnocrazia dell’Ue,
tutto sarebbe venuto fuori dagli esperimenti di questi superlaboratori
massonici, persino Giovanni XXIII (“il primo papa massone”), Osama bin Laden e
il più recente fenomeno dell’Isis. In Italia, se abbiamo evitato tre colpi di
Stato avallati da Kissinger lo dobbiamo a Schlesinger jr., massone progressista.
L’elenco di tutti gli italiani attuali spiccano D’Alema, Passera e Padoan. Il
capitolo finale è un colloquio tra Magaldi e altri confratelli collaboratori con
quattro supermassoni delle Ur-Lodges. Racconta uno di loro, a proposito
del patto unitario tra grembiulini per la globalizzazione: “Ma per far
inghiottire simili riforme idiote e antipopolari alla cittadinanza, la devi
spaventare come si fa con i bambini. Altrimenti gli italiani, se non fossero
stati dei bambinoni deficienti, non avrebbero accolto con le fanfare i tre
commissari dissimulati che abbiamo inviato loro in successione: il
fratello Mario Monti, il parafratello Enrico Letta, l’aspirante fratello Matteo
Renzi”. Per non parlare del “venerabilissimo” Mario Draghi, governatore della
Bce, affiliato a ben cinque superlogge. Ecco l’elenco degli italiani nelle
Ur-Lodges: Mario Draghi, Giorgio Napolitano, Mario Monti, Fabrizio Saccomanni,
Pier Carlo Padoan, Massimo D’Alema, Gianfelice Rocca, Domenico Siniscalco,
Giuseppe Recchi, Marta Dassù, Corrado Passera, Ignazio Visco, Enrico Tommaso
Cucchiani, Alfredo Ambrosetti, Carlo Secchi, Emma Marcegaglia, Matteo Arpe,
Vittorio Grilli, Giampaolo Di Paola, Federica Guidi. Berlusconi, invece, avrebbe
creato una Ur-Lodge personale, la Loggia del Drago. Bisognerà aspettare le
“contestazioni”, per vedere le carte di Magaldi. Da Il Fatto Quotidiano del 19
novembre 2014
Giuseppe Garibaldi, mercenario dei
due mondi. Scritto da Alessandro Lattanzio, il
24/6/2011 su “Aurora”. Per mettere un pietra tombale sul mito di Garibaldi. I
festeggiamenti per il 200° anniversario della nascita di Giuseppe Garibaldi, e
per il 150° anniversario dallo sbarco a Marsala e dalla proclamazione della
cosiddetta Unità d’Italia, pur con tutto lo stantio corteo di corifei e
apologeti, non hanno suscitato dibattiti né analisi sul processo di unificazione
dell’Italia. Questi eventi non sono diventati occasione per affrontare i nodi
della storia italiana, o meglio italiane. Niente di niente. Neanche gli atenei o
le accademie, né ricercatori e né docenti, hanno avuto il coraggio di
affrontare, in modo serio e complessivo, la natura del processo storico italiano
che va dall’Unità ad oggi. Anzi, il General Intellect italiano, a ennesima
dimostrazione della sua subalternità e del suo provincialismo, ha solo prodotto
qualche raccolta di ‘memorie’ dei garibaldini, veri o presunti poco importa,
spacciandola come lavoro storico e di analisi storica. Nulla di più falso,
poiché ogni vero storico sa che la memorialistica è altamente inaffidabile; e
l’Italia è la patria delle ‘memorie’ scritte per secondi fini
politico-personalistici. Inoltre, voler costruire la storia patria raccogliendo
le memorie di una parte sola, che ha una memoria… appunto parziale, ha più il
sapore dell’opera di indottrinamento e della retorica, piuttosto che della
onesta e disinteressata ricerca storica. Capisco che in questi anni di
disfacimento nazionale, di contestazione dell’Italia quale nazione unica, e
dell’italianità quale sentimento patriottico, alcuni settori ideologicamente e
strumentalmente legati al cosiddetto risorgimento sentano il bisogno di
ravvivare un patriottismo nazionale che almeno salvaguardi la concezione,
attualmente propagandata nelle scuole e nei media, che si ha della storia
italiana. Soprattutto proprio quella riguardante il periodo della costituzione
della sua statualità unitaria. Ma il fatto è che, con il riproporsi di schemi
patriottardi e di affabulazioni devianti, non si renda proprio un buon servizio
neanche alla storia dell’Italia. La figura di Giuseppe Garibaldi, in tal caso, è
centrale; non in quanto super-uomo o eroe di uno o più mondi. Ma in quanto
strumento di forze superiori, ma non sto parlando della Storia con la S
maiuscola, ma più prosaicamente di mercati, risorse, capitali, commerci, banche
e finanza, ecc. Insomma, delle regole e dinamiche dettate dai rapporti di forza
tra potenze coloniali, tra i nascenti imperialismi, l’equilibrio tra potenze
regionali e mondiali. E in questo contesto deve essere inserita, appunto, la
figura di Garibaldi. Lasciamo agli affabulatori e agli annebbianti i raccontini
sull'eroe dei due mondi e sul Cincinnato di Caprera. Partiamo, quindi,
dall’analizzare il ruolo e la posizione dell’obiettivo principe della più
notoria spedizione dell’avventuriero nizzardo: la Sicilia. La Sicilia, granaio e
giardino del Regno di Napoli (o delle Due Sicilie), oltre ad avere una economia
agricola abbastanza sviluppata, almeno nella sua parte orientale, ovvero una
agrumicoltura sostenuta e avanzata, necessaria ad affrontare il mercato
internazionale, sbocco principale di tale tipo di coltura; possedeva una forte
marineria, assieme a quella di Napoli, tanto da essere stata una nave siciliana
la prima ad inaugurare una linea diretta con New York e gli Stati Uniti
d’America. Marineria avanzata per sostenere una avanzata produzione agrumicola
destinata al commercio estero, come si è appena detto. Capitalismo, altro che
gramsciana arretratezza feudale. Ma il fiore all’occhiello dell’economia
siciliana era rappresentata da una risorsa strategica, all’epoca, ovvero lo
zolfo. Lo zolfo e i prodotti solfiferi, erano estremamente necessari per il
nascente processo di industrializzazione. Lo zolfo veniva utilizzato per la
produzione di sostanze chimiche, come conservanti, esplosivi, fertilizzanti,
insetticidi; oltre che per produrre beni di uso quotidiano, come i fiammiferi.
Era insomma il lubrificante del motore dell’imperialismo, soprattutto di quello
inglese. Con la rivoluzione nella tecnologia navale, ovvero la nascita della
corazzata, e la diffusione delle ferrovie in Europa, e non solo, ne fanno
montare la domanda e, quindi, la necessità di sempre maggiori quantità di
acciaio, ferro e ghisa. Perciò, i processi produttivi connessi richiedono sempre
più ampie quantità di zolfo; cosi come la richiedono l’economia moderna tutta,
industriale e commerciale. Tipo quella dell’Impero Britannico. La Sicilia, alla
luce dei mutamenti epocali che si vivevano alla metà dell’800, diventa un
importante obiettivo strategico, un asset geo-politicamente e geo-economicamente
cruciale. Difatti l’Isola possedeva 400 miniere di zolfo che, all’epoca,
coprivano circa il 90% della produzione mondiale di zolfo e prodotti affini.
Come poteva, l’Isola, essere ignorata dai centri strategici dell’Impero di Sua
Maestà? Come potevano l’Ammiragliato e la City trascurare la posizione della
Sicilia, al centro geografico del Mediterraneo, proprio mentre si stava
lavorando per realizzare il Canale di Suez? La nuova via sarebbe divenuta
l’arteria principale dei traffici commerciali e marittimi dell’Impero
Britannico. Come potevano ignorare tutto ciò i Premier e i Lord, gli
imperialisti conservatori e gli imperialisti liberali, i massoni e i missionari
d’Albione? Come? E come potevano dimenticare che, all’epoca, il Regno di Napoli
e le marinerie di Sicilia e della Campania, marinerie mediterranee, fossero dei
temibili concorrenti per la flotta commerciale inglese? Come potevano?
Il General Intellect dell’imperialismo inglese, il maggiore dell’epoca, non
poteva certo ignorare e trascurare simili fattori strategici. Loro no. Semmai a
ignorarlo è stato tutto il circo italidiota dei cantori del Peppino
longochiomato e barbuto. Tutti i raccoglitori di cimeli garibaldineschi, più o
meno genuini, non hanno mai avuto il cervello (il cervello appunto!) di capire e
studiare questi trascurabili elementi. La Sicilia è terra di schiavi e di
africani, barbara e senza storia, non vale certo un libro che ne spieghi anche
solo il valore materiale. Così vuole la vulgata dei nostrani storici accademici;
o di certe ‘storiche’ contemporanee venete che, invece delle vicende
dell’assolata terra triangolata, preferiscono dedicarsi alle memorie della
masnada di mercenari vestiti delle rosse divise destinate, non a caso, agli
operai del mattatoio di Montevideo. Tralasciando la biografia e gli interessi
dei fratelli Rubattino, che attuarono quella vera e propria False Flag
Operation detta Spedizione dei Mille, giova ricordare che Garibaldi, dopo la
riuscita missione (covert operation), venne accolto presso la Loggia Alma
Mater di Londra. Vi fu una festa pubblica, di massa, che lo accolse a Londra e
lo accompagnò fino alla sede centrale della massoneria anglo-scozzese. La più
grande pagliacciata a cui abbia mai assistito scrisse un testimone diretto
dell’evento. Un tal Karl Marx. Giuseppe Garibaldi venne scelto da Londra, poiché
si era già reso utile alla causa dell’impero britannico. In America Latina,
quando gli inglesi, tramite l’Uruguay, favorirono la secessione della provincia
brasiliana di Rio Grande do Sul dall’impero brasiliano, alimentandola guerra
civile in Brasile, Garibaldi venne assoldato per svolgere il ruolo di raider,
ovvero incursore nelle retrovie dell’esercito brasiliano. Il suo compito fu di
sconvolgere l’economia dei territori nemici devastando i villaggi, bruciando i
raccolti e razziando il bestiame. Morti e mutilati tra donne e bambini
abbondarono, sotto i colpi dei fucili e dei machete dei suoi uomini. Durante
quelle azioni, Garibaldi ebbe la guida delle forze navali riogradensi. “Il 14
luglio 1838, al comando della sua nave, la Farroupilha, affrontò la navigazione
sull’Oceano Atlantico, ma a causa del mare in tempesta e dell’eccessivo carico a
bordo, la Farroupilha si rovesciò. Annegarono sedici dei trenta componenti
dell’equipaggio, tra cui gli amici Mutru e Carniglia; il nizzardo fu l’unico
italiano superstite.” Dimostrando, così, il suo vero valore sia come comandante
militare, che come comandante di nave. Per la sua inettitudine e crudeltà, tanti
di coloro che lo circondavano morirono per causa sua. Il compito svolto da
Garibaldi rientrava nella politica di intervento coloniale inglese nel
continente Latinoamericano; la nascita della repubblica-fantoccio del Rio Grande
do Sul, rientrava nel processo di controllo e consolidamento del flusso
commerciale e finanziario di Londra verso e da il bacino del Rio de la Plata; la
regione economicamente più interessante per la City. Escludere l’impero
brasiliano dalla regione era una carta strategica da giocare, perciò Londra,
tramite anche Garibaldi, al soldo dell’Uruguay, provocò la guerra civile
brasiliana. La borghesia compradora di Montevideo era legata da mille vincoli
con l’impero inglese. Ivi Garibaldi svolse sufficientemente bene il suo compito.
Divenne un bravo comandante militare, sia grazie ai consigli di un carbonaro suo
sodale, tale Anzaldo, e sia perché si trovò di fronte i battaglioni brasiliani
costituiti, per lo più, da schiavi neri armati di picche. Facile averne ragione,
se si disponeva della potenza di fuoco necessaria, che fu graziosamente concessa
dalla regina Vittoria. Ma alla fine la guerra fu persa, e nel 1842 Garibaldi si
rifugiò in Uruguay, dove ottenne il comando della insignificante flotta
locale. “Il diplomatico inglese William Gore Ouseley lo assolda assieme ad altri
marinai per fare razzie e impedire i traffici marini degli stati
latinoamericani. Erano tutti vestiti con camicie rosse.” Tentò di pubblicare
il Legionario Italiano, ma la sua distribuzione venne vietata in Uruguay: si era
attirato l’odio della popolazione locale; per i continui massacri di inermi
cittadini veniva visto come il demonio. E’ grazie agli articoli di quel
giornale, da lui stesso pubblicato, che nacque la leggenda dell’Eroe dei due
mondi. Tra l’altro, l'anticlericale Garibaldi, nel 1847 scrisse al cardinal
Gaetano Bedini, nunzio in Brasile, per “offrire a Sua Santità (Pio IX) la sua
spada e la legione italiana per la patria e per la Chiesa cattolica” ricordando
“i precetti della nostra augusta religione, sempre nuovi e sempre immortali” pur
sapendo che “il trono di Pietro riposa sopra tali fondamenti che non abbisognano
di aiuto, perché le forze umane non possono scuoterli”. La sua proposta di
mettersi al soldo del cupolone venne respinta. Qualche anno dopo, l’eroe dei due
mondi venne richiamato a Londra, distogliendolo dal suo ameno lavoro: il
trasporto di coolies cinesi, ovvero operai non salariati, da Hong Kong alla
California. La carne cinese era richiesta dal capitale statunitense per
costruire, a buon prezzo, le ferrovie della West Coast. Garibaldi si prodigava
nel fornire l’‘emancipazione’ semischiavista agli infelici cinesi, in cambio di
congrua remunerazione dai suoi presunti ammiratori yankees. Coloro che
richiesero l’intervento di Garibaldi, in Sicilia, effettivamente furono due
siciliani, Francesco Crispi e Giuseppe La Farina. Crispi venne inviato a Londra,
presso i suoi fratelli di loggia, per dare l’allarme al gran capitale inglese:
Napoli stava trattando con una azienda francese per avviare un programma per
meccanizzare, almeno in parte, le miniere e la produzione dello zolfo. Il
progettato processo di modernizzazione della produzione mineraria siciliana,
avrebbe alleviato il popolo siciliano dalla piaga del lavoro minorile
semischiavistico delle miniere di zolfo. Ma i baroni proprietari delle miniere,
stante l’alto margine di profitto ricavato dal lavoro non retribuito, e timorosi
che l’interventismo economico della ‘arretrata amministrazione borbonica’,
potesse sottrarre loro il controllo dell’oro rosso, decisero di chiedere
l’intervento britannico, allarmando Londra sul destino delle miniere di zolfo.
Non fosse mai che lo stolto Luigi Napoleone potesse controllare il 90% di una
materia prima necessaria alle macchine e alle fornaci del capitale imperiale
inglese. Tutto ciò portò alla chiamata alle armi del loro eroe dei due mondi. E
i ‘carusi’ delle miniere solfifere devono ringraziare Garibaldi, e i suoi amici
anglo-piemontesi, se la loro condizione semischiavista si è protratta fino agli
anni ’50 del secolo scorso. Le due navi della Rubattino, della Spedizione dei
Mille, arrivarono a Marsala l’11 maggio 1860. Ad attenderli non vi erano unità
della marina napoletana o una compagnia del corpo d’armata borbonico, forte di
10000 uomini, stanziata in Sicilia e comandata dal Generale Landi. In compenso
era presente una squadra della Royal Navy, la Argus e l‘Intrepid, posta nella
rada di Marsala, a vigilare affinché tutto andasse come previsto. I 1089
garibaldini, di cui almeno 19 inglesi. In realtà, erano solo l’avanguardia del
vero corpo d’invasione; tra giugno e agosto, infatti, sbarcò in Sicilia
un’armata anglo-piemontese di 21000 soldati, per lo più mercenari
anglo-franco-piemontesi, che attuarono, già allora, la tattica di eliminare
qualsiasi segno di riconoscimento delle proprie forze armate. Il corpo era
costituito, in maggioranza, da carabinieri e soldati piemontesi, momentaneamente
posti in congedo o disertori riarruolati come volontari nella missione
d’invasione, e anche da qualche migliaio di ex zuavi francesi, che avevano
appena esportato la civiltà nei villaggi dell’Algeria e sui monti della Kabilya.
Anche nei pressi di Pachino, sbarcò un piccolo corpo di spedizione garibaldino,
costituito da 150 uomini, che trasportavano in Sicilia i quattro cannoni
acquistati a Malta dagli sponsor inglesi dell’invasione. Inoltre, erano presenti
dei veri e propri volontari/mercenari, finanziati per lo più dall’aristocrazia e
dalla massoneria inglesi; si trattava di un misterioso reggimento di uomini in
divisa nera, comandati da tal John Dunn. Infine, i 21000 invasori furono
protetti da ben quaranta tra vascelli e fregate della Mediterranean
Fleet della Royal Navy. Il primo scontro a fuoco, tra garibaldini e l’8.vo
battaglione cacciatori napoletani, del 15 maggio, si risolse ufficialmente nella
sconfitta di quest’ultima. Fatto sta che nella breve battaglia di Calatafimi, a
fronte delle perdite dell’esercito napoletano, che ebbe una mezza dozzina di
feriti, i garibaldini vennero letteralmente sbaragliati, subendo circa 30 morti
e 100 feriti. In realtà, nella mitizzata battaglia di Calatafimi, i soldati
napoletani che cozzarono con l’avventuriero Garibaldi dovettero sì abbandonare
il campo, ma perché il comandante di Palermo, generale Landi, aveva loro negato
l’invio di rifornimenti e di munizioni, costringendo la guarnigione borbonica
non solo a smorzare l’impeto con cui affrontarono i garibaldini, ma anche ad
abbandonare il terreno, quindi, lasciando libero Garibaldi nel proseguire
l’avanzata su Palermo. L’armata di Landi, di circa 16000 uomini, era accampato
nei pressi di Calatafimi, ma il generale napoletano preferì ritirarsi e
rinchiudersi a Palermo. A Palermo, il 28 maggio 1860, dopo due gironi di scontri
presso Porta Termini, nell’allora periferia della capitale siciliana, contro un
centinaio di soldati napoletani, i garibaldini entrarono in città. Il comandante
della guarnigione borbonica, Generale Lanza, sebbene avesse il comando di ben
24000 uomini e fosse sostenuto dall’artiglieria della pirofregata Ercole, li
fece invece asserragliare nel palazzo del governatore, e quando parte delle
truppe napoletane respinsero i garibaldini, arrivando a cento metri dal posto di
comando di Garibaldi, ricevettero l’ordine di ritirata dal Lanza stesso, che l’8
giugno decise di consegnare la città agli anglo-garibaldini. Contribuì alla
decisione, probabilmente, la consegna da parte inglese di un forziere carico di
piastre d’oro turche. La moneta franca del Mediterraneo. Il 31 maggio, a
Catania, sebbene i garibaldini occupassero la città, nell’arco di ventiquattrore
vennero sloggiati dalle truppe napoletane comandate da Ruiz-Ballestreros. Ma
anche costui ricevette l’ordine di ritirata dal comandante della piazza di
Messina, generale Clary, che a sua volta, col pieno appoggio del corrotto e
fellone ministro della guerra di Napoli, Pianell, abbandonò Messina il 24
luglio. Rimase a resistere la cittadella, che cadde quando cedette anche Gaeta.
L’avanzata dei garibaldini, rincalzati dal corpo d’invasione che li seguiva,
incontrò un ostacolo quasi insormontabile presso Milazzo. Qui, il 20 luglio, la
guarnigione napoletana impose un pesante pedaggio ai volontari di Garibaldi.
Infatti la battaglia di Milazzo ebbe un risultato, per Garibaldi, peggiore di
quella di Calatafimi. A fronte dei 120 morti tra i napoletani guidati dal
Colonnello Beneventano del Bosco, le ‘camicie rosse’ al comando del primo
luogotenente di Garibaldi, Medici, subirono ben 800 caduti in azione. La
guarnigione napoletana si ritirò, in buon ordine e con l’onore delle armi da
parte garibaldina! Ma solo quando, all’orizzonte sul mare, si profilò una
squadra navale anglo-statunitense, con a bordo una parte del vero e proprio
corpo d’invasione mercenario, e dopo che la pirocorvetta ex-napoletana Veloce,
ribattezzata Tukory, al comando del disertore Amilcare Anguissola, bombardasse
parte delle truppe napoletane schierate sulla spiaggia. Inoltre, le navi
napoletane, lasciarono che il corpo anglo-piemontese sbarcasse alle spalle della
guarnigione nemica di Milazzo. Va sottolineato che i vertici della marina
borbonica, come quelli dell’esercito napoletano, erano stati corrotti con
abbondanti quantità di oro turco e di prebende promesse nel futuro regno unito
sabaudo. Così si spiega il comportamento della marina napoletana, che alla
vigilia dello sbarco di Garibaldi, sequestrò una nave statunitense carica di non
meglio identificati soldati (i notori mercenari), ma che subito dopo la
rilasciò. Così come, nello stretto di Messina, la squadra napoletana
(pirofregata Ettore Fieramosca, pirocorvette L’Aquila e Fulminante) evitò di
ostacolare, ai garibaldini, il passaggio del braccio di mare, permettendo a
Garibaldi e a Bixio, a bordo dei piroscafi Torino e Franklin (battente bandiera
statunitense), di sbarcare il 18 agosto, a Mileto Porto Salvo, in Calabria. La
guarnigione di Reggio si arrese senza sparare un colpo, mentre il generale
napoletano Briganti venne fucilato a Mileto dalla sua truppa, per fellonìa. Dal
reggino in poi, fu una corsa fino all’entrata ‘trionfale’ a Napoli, dove
Garibaldi fece subito assaggiare il nuovo ordine savoiardo: i suoi ufficiali
fecero sparare sugli operai di Pietrarsa, poiché si opponevano allo
smantellamento delle officine metalmeccaniche e siderurgiche fatte costruire
dall'arretrata amministrazione borbonica. Certo, il regno delle Due Sicilie era
fu reame particolarmente limitato, almeno sul piano della politica civica, ma
nulla di eccezionale riguardo al resto dei regni italiani. Di certo fu che la
monarchia borbonica, dopo il disastro della repressione antiborghese della
rivoluzione partenopea del 1799, avviò una politica che permise il prosperare,
nell’ambito della proprio apparato amministrativo e di governo, degli elementi
ottusi, malfidati e corrotti. Condizione necessaria per poter perdere, in modo
catastrofico, la più piccola delle guerre. In seguito ci fu la battaglia del
Volturno, già perduta dai borbonici, poiché presi tra due fuochi: i mercenari di
Garibaldi a sud e l’esercito piemontese a nord. E quindi l’assedio di Gaeta e
Ancona, e poi la guerra civile nota come Guerra al Brigantaggio. Una guerra che
costò, forse, 300000 vittime. Prezzo da mettere in relazione con i 4000 morti,
in totale, delle tre Guerre d’Indipendenza italiane. Solo tale cifra descrive la
natura reale del processo di unificazione italiana. La Sicilia, in seguito,
venne annessa con un plebiscito farsa; poi nel 1866 scoppiò, a Palermo, la
cosiddetta Rivolta del Sette e mezzo, che fu domata tramite il bombardamento dal
mare della capitale siciliana. Bombardamento effettuato dalla Regia Marina che
così, uccidendo qualche migliaio di palermitani in rivolta o innocenti si
riscattò dalla sconfitta di Lissa, subita qualche settimana prima e da cui stava
ritornando. Poco dopo esplose, a Messina, una catastrofica epidemia di colera,
la cui dinamica stranamente assomigliava alla guerra batteriologica condotta
dagli yankees contro gli indiani nativi d’America. Migliaia e migliaia di morti
in Sicilia. Tralasciamo di spiegare il saccheggio delle banche siciliane, che
assieme a quelle di Napoli, rimpinguarono le tasche di Bomprini e di altri
speculatori tosco-padani, ammanicati con le camarille di Rattazzi e Sella; la
distruzione delle marineria siciliana; lo stato di abbandono della Sicilia per
almeno i successivi 40 anni; la feroce repressione dei Fasci dei Lavoratori
siciliani; l’emigrazione epocale che ne scaturì. Infine un novecento siciliano
tutto da riscrivere, dall’ammutinamento dei battaglioni siciliani a Caporetto
alle vicende del bandito Giuliano, uomo forse legato al battaglione Vega della
X.ma MAS, e che fu al servizio degli USA e del sionismo; per arrivare alla
vicenda del cosiddetto Milazzismo e a una certa professionalizzazione
dell'antimafia (che va a braccetto con quella di certo antifascismo) dei giorni
nostri. Garibaldi, una volta sistematosi a Caprera, aveva capito che la Sicilia
e il Mezzogiorno d’Italia, non gli avrebbero perdonato ciò che gli aveva fatto.
Rendiamoci conto di una cosa; Garibaldi non agiva in quanto massone, ma in
quanto agente dell’impero inglese. Tra l’altro come afferma Lucy Riall,
Garibaldi era una aderente alla setta cristologica di Saint Simon. Ora, come
spiega benissimo lo Storico dell’Economia Paul Bairoch, la setta cristologica
(nemica del papato) guidata dal guru Saint Simon, aveva come scopo occulto il
favoreggiamento dell’imperialismo londinese. Nel saggio di Bairoch, Economia e
Storia Mondiale Garzanti, a pag. 38 si può leggere: “Quel che i protezionisti
francesi (…) chiamarono Coup d’état fu rivelato da una lettera di Napoleone III
al suo ministro di stato. Ciò rese pubblici i negoziati segreti, che erano
cominciati nel 1846, con l’incontro a Parigi tra Richard Cobden (apostolo
inglese del libero scambio, legato all’industria inglese) e Michel Chevalier,
seguace di Saint Simon e professore di economia politica. Il trattato
commerciale tra Inghilterra e Francia venne firmato nel 1860 (notare la data), e
doveva durare 10 anni. Fu trovato il modo di eludere la discussione al
parlamento (francese), che probabilmente sarebbe stata fatale per il progetto di
legge. Perciò un gruppo di teorici riuscì a introdurre il libero scambio in
Francia e, di conseguenza, nel resto del continente, contro la volontà della
maggior parte di coloro che guidavano i diversi settori dell’economia. La
minoranza a favore del liberoscambismo, che era energicamente sostenuta da
Napoleone III (un vero utile idiota, NdR), il quale era stato convertito a
questa dottrina durante le sue lunghe permanenze in Inghilterra e che vedeva le
implicazioni politiche del trattato. Il trattato anglo-francese, che fu
rapidamente seguito da nuovi trattati tra la Francia e molti altri paesi,
condusse a un disarmo tariffario dell’Europa continentale… Tra il 1861 e il
1866, praticamente tutti i paesi europei entrarono in quella che fu definita ‘la
rete dei trattati di Cobden’.” Garibaldi, seguace della setta di SaintSimon, a
sua volta legata ai circoli dominanti inglesi, effettuò l’azione contro il Regno
delle Due Sicilie, con il preciso scopo sia di possedere un’Isola (la Sicilia)
strategica sia sul piano geo-economico che geo-strategico, ma anche di eliminare
un concorrente, Napoli, che aveva le carte in regola per non cadere nella rete
di Cobden. Il resto, sulle gesta di Garibaldi, dell’assassino schiavista Nino
Bixio, ecc., è solo fuffa patriottarda italidiota.
Quando Garibaldi, i garibaldini e l’Unità
d’Italia legittimarono mafia e camorra, scrive il 26
agosto 2016 Ignazio Coppola su "Time Sicilia". Ieri, nella quarta puntata della
Controstoria dell’impresa dei Mille, abbiamo sottolineato il ruolo di Garibaldi
e dei garibaldini in quella che, alla fine, è stata la prima trattativa tra
Stato italiano allora nascente e mafia. Oggi approfondiamo l’argomento
avvalendoci della testimonianza di storici e valenti magistrati che si sono
occupati di mafia e di rapporti tra la stessa mafia e lo Stato. Quando oggi
parliamo di trattativa “Stato-mafia”, non possiamo non andare indietro nel tempo
e riferire questo vituperato ed aborrito binomio alle origini del nostro Paese
inteso nella sua accezione unitaria. In parole povere, questo sodale rapporto
tra la mafia e lo Stato nasce con l’Unità d’Italia o, peggio ancora, con la mala
unità d’Italia e sin dai tempi dell’invasione garibaldina che si servì per le
sue discusse e dubbie vittorie del contributo determinante della mafia in
Sicilia e della camorra a Napoli. In Sicilia in quel lontano maggio del 1860
infatti accorsero, con i loro “famosi picciotti” in soccorso di Garibaldi i più
autorevoli capi-mafia dell’epoca come Giuseppe Coppola, di Erice; i fratelli
Sant’Anna di Alcamo; i Miceli di Monreale; il famigerato Santo Mele così bene
descritto da Cesare Abba, Giovanni Corrao, referente delle consorterie mafiose
che operavano a Palermo nel quartiere del Borgo vecchio e che poi addirittura
diverrà generale garibaldino e che verrà ucciso 3 anni dopo nell’agosto del 1863
nelle campagne di Brancaccio in un misterioso ed enigmatico agguato a fosche
tinte mafiose. Un apporto determinante degli “uomini d’onore” di allora che farà
dire allo storico Giuseppe Carlo Marino, nel suo libro” Storia della mafia”, che
Garibaldi senza l’aiuto determinante dei mafiosi in Sicilia non avrebbe potuto
assolutamente fare molta strada. Come, del resto, lo stesso Garibaldi sarebbe
incorso in grandi difficoltà logistiche se, quando giunto Napoli, nel settembre
del 1860, non avesse avuto l’aiuto determinante dei camorristi in divisa e la
coccarda tricolore che, schierandosi apertamente al suo fianco, gli assicurarono
il mantenimento dell’ordine pubblico con i loro capi bastone Tore De Crescenzo,
Michele “o chiazziere”, Nicola Jossa, Ferdinando Mele, Nicola Capuano e tanti
altri. Aiuti determinanti e fondamentali che, a ragion veduta, piaccia o no, a
Giorgio Napolitano in testa e ai risorgimentalisti di maniera, ci
autorizzerebbero a dire che la mafia e la camorra diedero, per loro convenienze,
il proprio peculiare e determinante contributo all’Unità d’Italia. Un vergognoso
e riprovevole contributo puntualmente e volutamente ignorato, per amor di
patria, dai libri di scuola e dalla storiografia ufficiale. Che la mafia ebbe
convenienza a schierarsi con Garibaldi ce ne dà significativa ed ampia
testimonianza il mafioso italo-americano originario di Castellammare del Golfo,
Giuseppe Bonanno, meglio conosciuto in gergo come Joeph Banana, che nel suo
libro autobiografico Uomo d’onore, a cura di Sergio Lalli a proposito
della storia della sua famiglia, a pagina 35 del libro in questione, così
testualmente descrive l’apporto dato dalla mafia all’impresa garibaldina: “Mi
raccontava mio nonno che quando Garibaldi venne in Sicilia gli uomini della
nostra “tradizione” (= mafia) si schierarono con le camicie rosse perché erano
funzionali ai nostri obbiettivi e ai nostri interessi”. Più esplicito di così, a
proposito dell’aiuto determinante dato dalla mafia a Garibaldi, il vecchio boss
non poteva essere. Con l’Unità d’Italia e con il determinante contributo dato
all’impresa dei Mille la mafia esce dall’anonimato e dallo stato embrionale cui
era stata relegata nella Sicilia dell’Italia pre-unitaria e si legittima a tutti
gli effetti, effettuando un notevole salto di qualità. Da quel momento diverrà,
di fatto, una macchia nera indelebile e un cancro inestirpabile nella
travagliata storia della Sicilia e del nostro Paese. E di questa metamorfosi
della mafia, dall’Italia pre-unitaria a quella unitaria, ne era profondamente
convinto Rocco Chinnici, l’ideatore del pool antimafia dei primi anni ’80 del
secolo passato, una delle più alte e prestigiose figure della magistratura
siciliana, ucciso il 29 luglio 1983 davanti la sua abitazione in un sanguinoso
attentato in via Pipitone Federico a Palermo. Rocco Chinnici, oltre che valente
magistrato, in qualità di capo dell’ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo
– ed ideatore come anzidetto del pool antimafia di cui allora fecero parte, tra
gli altri, gli allora giovani magistrati come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino
e Giuseppe Di Lello – fu anche un profondo studioso e conoscitore del fenomeno
mafioso e delle sue criminali dinamiche storiche. Da studioso fu relatore e
partecipò a numerosi convegni organizzati in materia di mafia. In uno di questi,
promosso a Grottaferrata il 3 luglio 1978 dal Consiglio Superiore della
Magistratura così, a proposito dell’evolversi della mafia in Sicilia, ebbe
testualmente a pronunciarsi: “Riprendendo le fila del nostro discorso prima di
occuparci della mafia del periodo che va dall’unificazione del Regno d’Italia
alla prima guerra mondiale e all’avvento del fascismo, dobbiamo brevemente, ma
necessariamente premettere che essa come associazione e con tale denominazione,
non era mai esistita in Sicilia. La mafia nasce e si sviluppa in Sicilia –
affermò Chinnici in quell’occasione, a conforto da quanto da noi sostenuto – non
prima, ma subito dopo l’unificazione del Regno d’Italia”. Ed ancora, in una
successiva intervista rilasciata ad alcuni organi di stampa a proposito della
mafia legittimatasi con la venuta e con l’aiuto determinante dato a Garibaldi e,
successivamente, con l’Unità d’Italia, Rocco Chinnici ebbe a dire: “La mafia è
stata sempre reazione, conservazione, difesa e quindi accumulazione di risorse
con la sua tragica, forsennata, crudele vocazione alla ricchezza. La mafia
stessa è un modo di fare politica mediante la violenza, è fatale quindi che
cerchi una complicità, un riscontro, un’alleanza con la politica pura, cioè
praticamente con il potere”. Ed è questo “patto scellerato” tra mafia, potere
politico e istituzioni, tenuto a battesimo prima dall’impresa garibaldina e poi,
come sosteneva Rocco Chinnici, dall’Unità d’Italia che dura, tra trattative,
connivenze e papelli di ogni genere, senza soluzione di continuità, sino ai
nostri giorni. Una lunga sequela di tragici avvenimenti che, sin dagli albori
dell’Unità d’Italia, ha insanguinato la nostra terra per iniziare con la stessa
uccisione del generale Giovanni Corrao a Brancaccio, poi i tragici e misteriosi
avvenimenti dei pugnalatori di Palermo, il delitto Notarbartolo e il caso
Palazzolo, la sanguinosa repressione dei Fasci Siciliani in cui la mafia recitò
il proprio ruolo, la strage di Portella della Ginestra, le stragi di Ciaculli e
di Via Lazio, le uccisioni di Carlo Alberto Dalla Chiesa e di tanti servitori
dello Stato e di tanti magistrati che della lotta alla mafia ne hanno fatto una
ragione di vita e, purtroppo, anche di estremo sacrificio, sino alla morte. Per
arrivare alle stragi di Capaci e di Via D’Amelio dove persero la vita Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino e gli uomini e le donne delle rispettive scorte. Su
Paolo Borsellino le nuove risultanze processuali hanno fatto giustizia di
ignobili e criminali depistaggi. Così abbiamo appreso che si era opposto con
tutte le sue forze ad ogni ipotesi di trattativa tra “Stato e mafia”. Per
essersi opposto alle connivenze tra mafia, servizi segreti deviati e omertà di
Stato ha pagato con la vita il suo atto di coraggio. Una lunga scia di sangue e
di turpitudini che ha visto da sempre protagonisti, in una sconvolgente
continuità storica, un mix di soggetti: Stato, mafia, banditismo (nel caso di
Salvatore Giuliano), potere politico, servizi segreti, massoneria deviata e
quant’altro. Connivenze criminali che hanno ammorbato e continuano ad ammorbare,
da 153 anni a questa parte, in un percorso caratterizzato, troppo spesso, da una
criminale politica eversiva, la vita dei siciliani onesti. Quando ce ne potremo
liberare? Con l’aria che tira sarà difficile.
La politica usa la storia
tra feste nazionali e memoria "di Stato".
La proliferazione di
ricorrenze e leggi chiude la porta a letture differenti dei fatti. E lo dice un
uomo che ha subito il peso della Shoah..., scrive Francesco Perfetti, Sabato
14/05/2016, su "Il Giornale". Alcuni anni or sono Pierre Nora, il grande storico
accademico di Francia e capostipite di un filone storiografico basato sui
«luoghi della memoria», fu l'animatore insieme a René Rémond di un'associazione
chiamata «Liberté pour l'histoire» che promosse un appello contro i rischi della
«moralizzazione retrospettiva della storia e di una censura intellettuale». Quel
documento, firmato da un gruppo di studiosi di formazione diversa da Pierre
Milza a Mona Ozouf, da Marc Ferro a Paul Veyne , sosteneva che «la storia non
deve essere schiava dell'attualità né essere scritta sotto dettatura da memorie
concorrenti» e si rivolgeva ai politici di ogni schieramento perché
comprendessero che «se hanno l'obbligo di custodire la memoria collettiva, con
devono istituire, con una legge e per il passato, delle verità di Stato la cui
applicazione giudiziaria» avrebbe potuto avere «gravi conseguenze per il
mestiere dello storico e per la libertà intellettuale in generale». Il documento
suscitò molte polemiche ma riscosse anche molti consensi, ed era un autorevole
atto d'accusa contro ogni forma di «storia ufficiale» o ideologica, contro la
gestione politica della memoria collettiva. Nora è uno studioso di origine
ebraica che ha saputo coniugare l'attività di ricerca accademica con il lavoro
di direttore editoriale di una importante casa editrice francese. La sua
preoccupazione principale è sempre stata quella di contribuire al recupero del
senso di appartenenza nazionale da parte dei francesi, troppo a lungo
indottrinati dalla versione resistenziale della guerra imposta alla memoria
collettiva e nazionale dal generale Charles de Gaulle in un famoso discorso in
cui aveva sostenuto che, con l'eccezione di poche pecorelle smarrite, tutta la
Francia era entrata nella Resistenza. Per Nora ciò non era vero perché un tale
approccio metteva in ombra o sottovalutava tradizioni storiche diverse. Il punto
fondamentale, tuttavia, era che l'imposizione di questa vulgata implicava una
«politicizzazione della storia» sotto «il peso della contemporaneità» e con una
«chiusura nel presente»: si consumava un «allontanamento dal passato» e si
realizzava «il consumo generalizzato di una storia senza nessun possibile
ricorso alla minima forma di discriminazione critica». In un piccolo ma succoso
libro, introdotto da Antoine Arjakosky, dal titolo Come si manipola la memoria.
Lo storico, il potere, il passato (La Scuola, pagg. 96, euro 8,50), Nora
sottolinea, con riferimento alla Francia (ma il discorso può essere esteso ad
altri Paesi), come fossero apparsi nell'ultimo ventennio due fenomeni, paralleli
e in certa misura collegati, rivelatori della tendenza mistificatrice a leggere
e considerare il passato con gli occhi della contemporaneità e della visione
politica dominante. I due fenomeni sono la proliferazione delle ricorrenze
nazionali e le leggi sulla memoria storica. Nora ricorda come, fra il 1880 e il
1990, fossero state istituite soltanto sei festività a carattere nazionale (tra
le quali quella del 14 luglio e quella dedicata a Giovanna d'Arco), mentre nel
solo periodo 1990-2005 ne fossero state create altre sei (come quelle che
ricordano le persecuzioni antisemite o la fine della guerra d'Algeria). La
differenza tra le prime e le seconde è, a parere dello studioso, netta e
sostanziale: «le sei grandi manifestazioni nazionali del XIX e XX secolo
costituivano grandi momenti collettivi di tregua nazionale; le sei più recenti
non mobilitano che gruppi ristretti ed esprimono soltanto la pressione sul
potere da parte dei militanti e il successo delle rivendicazioni sostenute dalle
loro associazioni». Il discorso potrebbe essere traslato nella realtà italiana
con riferimento a date si pensi, per esempio, al 25 aprile o al 2 giugno che per
molti potrebbero apparire più divisive che unificanti. Il secondo fenomeno
denunciato da Nora è quello delle cosiddette «leggi sulla memoria» volute o
dalla sinistra o dalla destra, gli interventi legislativi cioè che puniscono la
negazione del genocidio degli ebrei o condannano lo schiavismo e la tratta degli
schiavi e via dicendo. Si tratterebbe, secondo Nora, di una deriva legislativa
inquietante e pericolosa, sia perché rischia di «paralizzare la ricerca» e di
«ricordare in modo spiacevole le logiche totalitarie», sia perché appare
contraria a ogni forma di approccio storiografico. Scrive Nora che questa deriva
legislativa esprime «la tendenza a leggere e a riscrivere l'intera storia dal
punto di vista esclusivo delle vittime e una propensione, inaccettabile, a
proiettare sul passato dei giudizi morali che non appartengono che al presente,
senza tenere nella minima considerazione quella differenza tra periodi storici
che è lo stesso oggetto della storia, la ragione del suo apprendimento e del suo
insegnamento». Naturalmente Nora, la cui esistenza è stata marcata profondamente
dalla Shoah, pur diffidando della legislazione francese contro il negazionismo,
non propone una messa in discussione di tale normativa, perché questa ipotesi
potrebbe essere vista come un incoraggiamento per chi nega il genocidio. Avverte
però che il rapporto fra storia e politica è molto delicato. I politici, a suo
parere, hanno il dovere di interessarsi del passato per comporre la memoria
collettiva riparando i torti subiti dalle vittime e onorandone la memoria, ma
«non attraverso leggi che definiscano i fatti e ne scrivano la storia». Il
compito di stabilire i fatti e di cercare la verità è essenzialmente dello
storico. Quella di Nora è una riflessione sofferta da parte di uno studioso di
grande e riconosciuto spessore il quale, partito dalla storiografia delle
Annales, è approdato, attraverso la critica alla storiografia positivistica e a
quella marxista, ai lidi di una Nouvelle Histoire dai confini più ampi che
recupera l'insegnamento di Marc Bloch. È una riflessione che, rifiutando le
vulgate storiografiche di ogni colore e volendo liberare la ricerca dai
condizionamenti del potere politico, nasce da profondo di uno spirito
autenticamente libero e liberale.
Il plebiscito del Veneto fu
una truffa ma la sinistra non vuole dirlo.
Un saggio diffuso dalla Regione Veneto dice la verità sul plebiscito di
annessione del 1866. Ed è subito polemica, scrive Carlo Lottieri, Venerdì
02/09/2016, su "Il Giornale". È polemica: ed è bene che sia così. La diffusione
di un volume di Ettore Beggiato (1866: la grande truffa. Il plebiscito di
annessione del Veneto all'Italia, Editrice Veneta) sul modo in cui il Veneto 150
anni fa è stato «italianizzato» dopo la terza guerra d'indipendenza, a seguito
di un referendum truffaldino, disturba gli intellettuali progressisti. Sul
quotidiano veronese L'Arena ieri si riportavano alcune prese di posizione
negative nei riguardi del libro. Secondo Carlo Saletti saremmo di fronte a «un
uso distorto della storia», piegata a ragioni politiche. Una tesi condivisa da
Federico Melotto, direttore dell'Istituto veronese della storia della
Resistenza, per il quale con questo volume «si vuole dare un messaggio politico
partendo dal plebiscito per lanciare una critica all'Italia di oggi». Il tono è
di contestazione, ma con ogni probabilità l'autore sarebbe in parte d'accordo.
Già assessore regionale e appassionato cultore della storia della Serenissima,
Beggiato si propone di smontare la lettura tradizionale di una popolazione
veneta ben felice di lasciare l'Impero asburgico per unirsi alle popolazioni
italiche. Il volume è tutt'altro che paludato: vuole interessare e farsi
leggere. Chi l'ha scritto, per giunta, non cela in alcun modo la propria
speranza che Venezia e gli altri territori possano presto decidere del proprio
futuro (con un referendum democratico), tornando indipendenti come furono per
secoli. Beggiato ha insomma esaminato il passaggio storico del 21 e 22 ottobre
1866 per illuminare l'attualità: per far comprendere ai veneti di oggi per quale
motivo devono pagare le tasse a Roma, e non a Vienna. Guarda il passato per
criticare il presente, senza dubbio. Ma dove sarebbe il problema? Non è forse
utile leggere la storia per capire il nostro tempo? I due studiosi evocano
controverse questioni di metodologia, ma le loro parole lasciano perplessi:
specie pensando che per Benedetto Croce ogni storiografia è contemporanea, dato
che il passato ci interessa in quanto esso ha di tuttora vivo. Una cosa non
viene detta da Saletti, né da Melotti: che Beggiato racconti falsità. Il libro,
in effetti, è inattaccabile e il plebiscito fu un inganno da ogni punto di
vista. Non fu garantito l'anonimato, votarono soggetti che non ne avevano titolo
(i soldati italiani di stanza in Veneto, ad esempio) e, soprattutto, i dati resi
noti non possono corrispondere ai voti reali. È significativo che gli storici
«accademici» nulla contestino, sul piano dei fatti, a quanto Beggiato afferma,
né difendano la regolarità del referendum: anche perché si renderebbero
ridicoli. Di fronte a risultati ufficiali che parlano di 647.246 voti favorevoli
e solo 69 voti contrari (l'equivalente del 99,9%), chi conosce cosa sia l'errore
statistico sa che l'annessione del Veneto all'Italia fu costruita su un
imbroglio. Un argomento è usato dai due storici contro il volume di Beggiato: ed
è la decisione della Regione di regalarlo alle biblioteche del Veneto, anche
scolastiche. La critica potrebbe avere una sua plausibilità (può un ente
pubblico sostenere un'iniziativa culturale di parte?) se solo non sapessimo che
le scuole pubbliche sono «apparati ideologici di Stato», per usare la formula
del marxista Louis Althusser: sono da sempre realtà schierate a difesa del
potere vigente e delle sue retoriche (dal Risorgimento alla Resistenza,
dall'ecologia all'Europa, dalla solidarietà alla legalità). È allora soltanto
positivo che una pecora nera come Beggiato trovi spazio tra tante pecore
bianche, che belano tutte nello stesso modo. È poi interessante rilevare come
per Melotto il referendum fosse sì ridicolo, ma perché tale doveva essere:
«L'annessione fu decisa dal punto di vista diplomatico», dato che «il plebiscito
serviva a sancire una situazione di fatto». Fu insomma una truffa, come dice
Beggiato, ma «non può essere definito scandaloso questo modo di procedere perché
nell'800 era la diplomazia a prendere le decisioni, non il popolo». Per Melotto
non ci si deve proprio scandalizzare se nell'Ottocento la gente non contava e
neppure a questo punto se in varie parti del mondo c'era ancora la schiavitù. Se
però i veneti conoscessero meglio la loro storia, forse anche certa retorica
nazionalista avrebbe assai meno presa. E questo sarebbe solo positivo.
Così l'Italia vinse la guerra perdendo
tutte le battaglie. Grazie alla Prussia ottenemmo il
Veneto e parte del Friuli. Ma il disastro militare ci segnò per sempre, scrive
Matteo Sacchi, Mercoledì 20/07/2016 su "Il Giornale". Si può vincere una guerra
perdendone quasi tutte le battaglie. Si può anche scatenare, a cose fatte, uno
psicodramma che trasformi due scontri finiti male, ma senza reali conseguenze,
in un dramma nazionale con tanto di processi eccellenti, e privi di qualunque
equità. Poi si può continuare a sentirsi defraudati per anni della dignità
nazionale e mascherare il tutto sotto un'enorme dose di retorica che esalti il
sacrificio, senza però prendersi la briga di indagare sulle magagne della
propria macchina bellica. Andò così nella Terza guerra di indipendenza italiana
(durata dal giugno all'ottobre 1866) di cui ricorrono i 150 anni. Una bella e
approfondita analisi di quel conflitto la compie Hubert Heyriès (storico
militare dell'università Montpellier III) nel suo Italia 1866. Storia di una
guerra perduta e vinta (Il Mulino, pagg. 348, euro 25). Il saggio racconta come
l'Italia fu abile diplomaticamente a intuire le potenzialità della montante
tensione tra l'Austria e la Prussia del cancelliere Bismarck (1815-98). Era
l'occasione giusta per liberarsi della presenza asburgica nella Penisola. Con i
buoni uffici di Napoleone III, il conte Giulio Cesare di Barral e il generale
Giuseppe Govone apposero la loro firma, in nome dell'Italia, su un trattato
offensivo valido unicamente per 3 mesi. Era l'8 aprile 1866. L'Austria si
sarebbe trovata chiusa in mezzo a una tenaglia di ferro. Combattere su due
fronti l'avrebbe quasi di sicuro costretta alla sconfitta. Sin qui la parte
logica del piano, a prescindere delle immediate diffidenze tra Firenze (allora
era la capitale) e Berlino. Così il 20 giugno Vittorio Emanuele II diede
ottimisticamente il via alle ostilità: «Voi potete confidare nelle vostre forze,
italiani, guardando orgogliosi il florido esercito e la formidabile marina...».
E su questo ottimismo si allineò subito tutta la nazione. L'entusiasmo portò con
sé - come spiega Heyriès - due ulteriori buoni risultati. La mobilitazione fu
rapidissima e Garibaldi si vide piombare addosso un gran numero di volontari che
usò nel modo che gli era più consono: attaccare verso in Trentino in un
territorio frastagliato e montagnoso. Per un genio indiscusso della guerriglia
era l'ideale. Ma fuori dalle montagne trentine la macchina bellica italiana
iniziò a mostrare tutti i suoi limiti. La Prussia premeva per un attacco rapido.
Per colpire efficacemente a nord le serviva che le truppe austriache fossero
impegnate a sud. Ma gli italiani si trovavano di fronte le fortezze del
Quadrilatero e nessuno aveva sviluppato un vero piano per superarle. Un attacco
dal mare con sbarco, a partire dalla netta superiorità navale italiana, era un
qualcosa di cui si era solo fantasticato. Le nostre navi erano eterogenee
(quanto gli equipaggi nati fondendo tre marine) e non certo adatte a un attacco
di questo tipo. Così l'enorme esercito italiano (per la prima volta il Paese
aveva un esercito di massa) nel dubbio e senza un chiaro piano d'attacco fu
schierato in due tronconi. Centoventimila fanti e 7mila cavalieri sul Mincio
comandati dal generale La Marmora. Altri 64mila fanti e 3500 cavalieri affidati
invece al generale Enrico Cialdini sulla linea del Po. Gli Austriaci erano in
netta minoranza numerica ma ebbero così la possibilità di giocare sulla velocità
per colpire uno dei due tronconi. A questo si sommò la deficienza logistica
degli italiani. Risultò un problema persino fornire le coperte. Oltre il fatto
che molti soldati non avevano mai combattuto, o soltanto contro i «briganti». In
più, la litigiosità degli alti ufficiali...Le truppe di La Marmora, mentre
cercavano di sorprendere gli austriaci oltre l'Adige, si fecero sorprendere dal
nemico appena passato il Mincio. Ne nacque uno scontro disordinato: la seconda
battaglia di Custoza. Nonostante tutto gli italiani si batterono bene. Gli Ulani
del battaglione «Conte di Trani» e la brigata di Cavalleria di Ludwig von Pulz
vennero massacrati a Villafranca dal quadrato di fucilieri comandato dal
principe Umberto. I granatieri sul Monte Torre e sul Monte Croce fecero pagare
agli austriaci ogni palmo di terra. Ma nel momento più critico alcuni ufficiali,
come il generale Della Rocca, non inviarono rinforzi, seppur richiesti nella
zona più a rischio, Custoza. Il risultato fu che le truppe italiane dovettero
ritirarsi. Gli austriaci non le inseguirono: avevano subito colpi altrettanto
gravi. Gli italiani avevano perso tra morti, feriti, e prigionieri 7.403 uomini.
Gli austriaci 7.956. Ma era il morale degli italiani a essere crollato. E le
cose peggiorarono ancora quando i Prussiani travolsero gli austriaci a Sadowa,
il 3 luglio. Ne nacque una sorta di psicosi: bisognava vincere «qualcosa» al più
presto. E così ci si rivolse alla Marina. Gli italiani cercarono di attirare la
flotta del contrammiraglio Tegetthoff verso Ancona. L'austriaco sapeva fare il
suo mestiere e non uscì dal porto. Allora il ministro Depretis piombò ad Ancona
e «sobillò» contro l'ammiraglio Carlo Pellion di Persano i suoi diretti e
gelosissimi sottoposti, l'ammiraglio Vacca e l'ammiraglio Albini. Il risultato
fu che venne allestito in fretta e furia l'attacco all'isola di Lissa che era
ben fortificata e per di più collegata via telegrafo. Fu lì che la flotta
austriaca subito allertata piombò sulle navi italiane. Anche in questo caso lo
scontro (l'anniversario è oggi, 20 luglio) non era perduto a priori, anzi,
alcune navi austriache come la «S.M.S. Kaiser» se la videro brutta. Ma se i
rapporti tra Persano, Albini e Vacca erano pessimi in condizioni normali, si
rivelarono tragici in battaglia. Le reazioni di Persano furono confuse, ma anche
quando diede ordini chiari i suoi sottoposti si sforzarono di eluderli. Bilancio
di 37 minuti di battaglia: l'affondamento della «Re d'Italia» e della «Palestro»
e la morte di 638 marinai. Se Custoza era una quasi sconfitta trasformata in
disfatta dalla stampa, Lissa fu una sconfitta senza se senza ma. Lo choc fu
fortissimo e non bastarono i successi di Garibaldi in Trentino ad
anestetizzarlo. Men che meno l'annessione del Veneto e del Friuli
sprezzantemente ceduti dall'Austria alla Francia e dalla Francia a noi (a mezzo
plebiscito) che pure fu indubitabilmente un grandissimo passo verso la completa
unificazione del Paese. Gli italiani incorporarono un senso di fragilità
militare che non hanno mai smesso di portarsi dietro. E per colmarlo misero
sotto processo l'ammiraglio Persano che fu radiato dalla Marina. Ma quale fosse
la differenza tra lui e gli altri ammiragli che gli avevano messo i bastoni tra
le ruote nel bel mezzo dello scontro non fu mai chiarito. Sulle responsabilità
degli ufficiali del Regio esercito invece ci si limitò alle polemiche velenose.
Anche questo lavacro di coscienza collettivo a mezzo capro espiatorio si
trasformò in una brutta prassi nazionale. Anzi forse è il cascame, sociologico,
più grave di questa guerra vinta senza vincere.
La truffa dell’Unità d’Italia.
La propaganda è sempre esistita ogni qual volta c'è stato un
potere organizzato che ha operato su una massa di popolazione relativamente
concentrata. Poteva trattarsi o d'integrare maggiormente i gruppi e gli
individui nella società, o di stabilire la legittimità del potere politico, o di
ottenere un determinato numero di comportamenti e di adesioni, o infine di
lottare contro le influenze esterne. La propaganda delle società tradizionali,
tuttavia, non presentava gli stessi caratteri della propaganda moderna. Si
trattava allora di una propaganda generalmente legata a una persona, un capo
carismatico, un propagandista che agiva per intuizione, per abilità personale.
Era dunque un fenomeno occasionale e limitato, che appariva e scompariva a
seconda delle circostanze. Si trattava sempre d'interventi circoscritti, fondati
spesso su sentimenti religiosi, e che non presentavano nessun carattere di
razionalità o, ancora meno, di tecnicità. (Enciclopedia Traccani)
Si dice che Mazzini sia stato anti
monarchico e anti Savoia, scrive Giovanni Greco, su
questo nutro dubbi in quanto lo reputo un massone per conto della Regina in Gran
Bretagna! Un paradosso tutto Repubblicano; comunque Mazzini, ad esempio,
appoggiò moralmente la spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi, che egli
considerava una valida opposizione a Cavour. Quindi si giungerà all'Unità
d'Italia. In seguito numerosi repubblicani confluiranno nei Fasci di
combattimento di epoca ormai Mussoliniana. E se ho ricostruito bene i fatti - mi
auguro di non sbagliare - il progetto mazziniano era teso a favorire gli
interessi inglesi nei traffici commerciali del tempo, che erano legati ai
cavalli, alle carrozze, alle mongolfiere, alle navi e ai treni. Infatti il
predominio nelle comunicazioni era di fondamentale importanza per l'epoca oltre
ad essere stata una decisione iniziale delle famiglie di banchieri
ebreo/tedesche/americane dei Rothschild e dei Rockefeller, i quali avevano
finanziato la Regina inglese per l'invasione del Regno dei Borbone. Bene
Mazzini, dopo la conquistata del Regno delle Due Sicilie, potè favorire i
commerci della famosa "Valigia delle Indie"; e il re Borbone e le sue terre
infatti erano l'unico impedimento al progetto originario dei Rothschild. Gli
stessi Rothschild che con il gruppo Bilderberg regnano tutt'ora le pagine della
real politik e delle primavere arabe e degli autunni italiani del III millennio.
Ciò che la storia ha sempre cercato di
insabbiare. Tutti noi siamo soliti considerare l’Unità
d’Italia una grande impresa e Giuseppe Garibaldi un grande eroe. Ma è davvero
così? Scrive Enrico Novissimo per Collana Exoterica. Il processo che portò
all’Unità d’Italia vide come protagonisti una lunga fila di uomini più o meno
celebri, i cosiddetti padri del Risorgimento. Ancora oggi infatti, se si va dal
nord al sud dell’’Italia, troviamo piazze o vie principali che si fregiano di
nomi illustri come Garibaldi, Mazzini, Cavour, Vittorio Emanuele ecc …
Consideriamo infatti questi personaggi dei veri eroi, raffigurati dagli artisti
che ne esaltano il loro valore in maniera da rafforzare il mito che li circonda;
innumerevoli sono infatti le opere d’arte che ritraggono l’eroe dei due Mondi
ora a cavallo, ora in piedi che impugna alta la sua spada, alcune volte
indossando la celebre camicia rossa, altre volte reggendosi su un paio di
stampelle come un martire. Tuttavia un ritratto che di certo non vedremo mai
vorrebbe il Gran Maestro massone, Giuseppe Garibaldi (ebbene sì, che lo crediate
o no era massone, così come Cavour e forse Mazzini), privo dei lobi delle
orecchie. Sembra incredibile eppure la vicenda sembra vera. Al nostro “falso”
eroe furono davvero mozzate le orecchie; la mutilazione avvenne esattamente in
Sud America, dove l’intrepido Garibaldi fu punito per furto di bestiame. Dunque
il grande Garibaldi, icona della spedizione dei Mille e dell’’Unità italiana
sarebbe stato un ladro di cavalli? Difficile crederlo. Naturalmente nessuna
fonte ufficiale racconta questa vicenda. È dunque lecito chiedersi quante altre
accuse infanghino le gesta degli eroi risorgimentali? Quante altre macchie
vennero lavate a colpi d’inchiostro da una storiografia corrotta e pilotata? Ma
soprattutto, quale fu il ruolo dei banchieri Rothschild nel processo di Unità
d’Italia? La Banca Nazionale degli Stati Sardi era sotto il controllo di Camillo
Benso conte di Cavour, grazie alle cui pressioni divenne una autentica Tesoreria
di Stato; difatti era l’unica banca ad emettere una moneta fatta di semplice
carta straccia. Inizialmente la riserva aurea ammontava ad appena 20 milioni di
lire, ma questa somma ben presto sfumò perché reinvestita nella politica
guerrafondaia dei Savoia. Il Banco delle Due Sicilie, sotto il controllo dei
Borbone, possedeva invece un capitale enormemente più alto e costituito di solo
oro e argento: una riserva tale da poter emettere moneta per 1.200 milioni ed
assumere così il controllo dei mercati. Cavour e gli stessi Savoia avevano ormai
messo in ginocchio l’economia piemontese, si erano indebitati verso i Rothschild
per svariati milioni e divennero in breve due burattini nelle loro mani. Fu così
che i Savoia presero di mira il bottino dei Borbone. La rinascita economica
piemontese avvenne mediante un operazione militare espansionistica a cui fu dato
il nome in codice di Unità d’Italia, un classico esempio di colonialismo
mascherato però come un movimento patriottico. L’intero progetto fu diretto
dalla massoneria britannica, vero collante del Risorgimento. Non a caso i
suddetti eroi furono tutti rigorosamente massoni. La storia ufficiale racconta
che i Mille guidati da Giuseppe Garibaldi, benché disorganizzati e privi di
alcuna esperienza in campo militare, avrebbero prevalso su un esercito di
settanta mila soldati ben addestrati e ben equipaggiati quale era l’esercito
borbonico. In realtà l’impresa di Garibaldi riuscì solo grazie ai finanziamenti
dei banchieri Rothschild; attraverso i soldi dei Rothschild, infatti, i Savoia
corruppero gli alti ufficiali dell’esercito borbonico che alla vista dei Mille
batterono in ritirata, consentendo così la disfatta sul campo. Dunque non ci fu
mai una vera battaglia. Neppure la storiografia ufficiale ha potuto insabbiare
le prove del fatto che molti ufficiali dell’esercito borbonico furono condannati
per alto tradimento alla corona. Il Sud fu presto invaso e depredato di ogni
ricchezza: in questa situazione gli stupri, le esecuzioni di massa e le violenze
di ogni genere erano all’ordine del giorno. L’unica alternativa per scampare a
questo fu l’emigrazione. Il popolo cominciò così a lasciare le campagne per
trovare altrove una via di fuga. Ben presto il malcontento generale fomentò la
ribellione dei sopravvissuti; si trattava di poveri contadini e gente di fatica
che la propaganda savoiarda bollò con il dispregiativo di “briganti”, così da
giustificarne la brutale soppressione. A 150 anni di distanza si parla ancora di
“questione meridionale”. Enrico Novissimo per Collana Exoterica
Cavour e gli stessi Savoia avevano messo
in ginocchio l’economia piemontese, indebitata verso i Rothschild per svariati
milioni, scrive Enrico Novissimo. Divennero due
burattini nelle loro mani. Fu così che i Savoia presero di mira il bottino dei
Borbone. La rinascita economica piemontese avvenne mediante un operazione
militare espansionistica a cui fu dato il nome in codice di Unità d’Italia, un
classico esempio di colonialismo sotto mentite spoglie. L’intero progetto fu
diretto dalla massoneria britannica, vero collante del Risorgimento. Non a caso
i suddetti eroi furono tutti rigorosamente massoni. "I Mille" guidati da
Giuseppe Garibaldi, benché disorganizzati e privi di alcuna esperienza in campo
militare, avrebbero prevalso su un esercito di settanta mila soldati ben
addestrati e ben equipaggiati quale era l’esercito borbonico. In realtà
l’impresa di Garibaldi riuscì solo grazie ai finanziamenti dei Rothschild, con i
loro soldi i Savoia corruppero gli alti ufficiali dell’esercito borbonico che
alla vista dei Mille batterono in ritirata, consentendo così la disfatta sul
campo. Dunque non ci fu mai una vera battaglia, neppure la storiografia
ufficiale ha potuto insabbiare le prove del fatto che molti ufficiali
dell’esercito borbonico furono condannati per alto tradimento alla corona. Il
sud fu presto invaso e depredato di ogni ricchezza, l’oro dei Borbone scomparve
per sempre. Stupri, esecuzioni di massa, crimini di guerra e violenze di ogni
genere erano all’ordine del giorno. L’unica alternativa alla morte fu
l’emigrazione. Il popolo cominciò a lasciare le campagne per trovare altrove una
via di fuga. Ben presto il malcontento generale fomentò la ribellione dei
sopravvissuti, si trattava di poveri contadini e gente di fatica che la
propaganda savoiarda bollò con il dispregiativo di “briganti”, così da
giustificarne la brutale soppressione.
La spedizione dei Mille è stato uno degli
eventi cruciali per l’unificazione d’Italia. Ai tempi
non c'era internet ma il telegrafo, Parigi era la Borsa di riferimento e i
prestiti erano erogati dalle grandi famiglie dei banchieri e non dall’Fmi.
Eppure mercati finanziari e debito pubblico ebbero un ruolo nello sgretolamento
del regno borbonico e nel successo dei garibaldini. E, col senno di poi, è un
po’ come se Garibaldi avesse detto obbedisco! non solo al re Vittorio Emanuele,
ma anche ai Rothschild, scrive Luciano Canova. Studiando la serie storica delle
quotazioni del debito pubblico borbonico, durante il 1860, è possibile
rispondere a una domanda assai interessante, anche per i suoi riflessi attuali:
i mercati finanziari dell’epoca avevano scontato la spedizione dei Mille?
Indubbiamente, i mercati anticipano accadimenti incerti, che valutano attraverso
la lente deformante delle aspettative. Se, però, nell’era di Internet, i mezzi
di comunicazione consentono un aggiornamento immediato di quello che avviene ai
piani alti, è lecito chiedersi se le cose funzionassero in modo simile anche in
passato, in particolare per un evento che ha segnato la storia di questa
penisola. Un’analisi è possibile andando a recuperare le quotazioni giornaliere
della rendita di Sicilia del 1860, pubblicate sulla pagina commerciale del
quotidiano dei Borbone, Il Giornale Ufficiale del Regno delle Due Sicilie,
conservate presso l’Archivio storico municipale del comune di Napoli e presso
l’Archivio storico della Fondazione Banco di Napoli. Come riportato dal lavoro
La borsa di Napoli di Maria Carmela Schisani, anche nel diciannovesimo secolo
esisteva una borsa valori in cui venivano negoziati titoli, prevalentemente del
debito pubblico, dei vari stati. La borsa venne istituita a Napoli nel 1788 da
Ferdinando I di Borbone e attraversò la storia del regno delle Due Sicilie fino
al 1860, con la caduta di Francesco II. Il titolo del debito pubblico era emesso
in ducati, la moneta del regno, e aveva una rendita fissa del 5 per cento alla
scadenza. Parigi costituiva la Wall Street dell’epoca e sui suoi valori
risultavano agganciate le quotazioni dei titoli napoletani. Come a dire che lo
spread si sarebbe misurato sui titoli francesi. La finanza, allora, era
organizzata attorno a grandi famiglie: un ruolo di primo piano, in particolare,
fu esercitato dai Rothschild, che erogarono ai Borbone diversi prestiti nel
corso della loro storia. In sostanza, la famiglia di banchieri agiva come una
sorta di Fondo monetario internazionale ante litteram, che garantiva prestiti
onerosi dietro l’impegno ad approvare riforme politiche e fiscali rigorose da
parte dei beneficiari. Non è un caso se Ferdinando II, re di Napoli dal 1830,
iniziò un programma radicale di modernizzazione del regno proprio in
concomitanza con uno di questi prestiti. E non è un caso che, dopo il 1848, il
regno cominciò a sfaldarsi, anche per via del disimpegno dei Rothschild stessi
dalle finanze partenopee. Tornando all’avventura garibaldina, poco prima
dell’inizio della spedizione, il titolo del debito pubblico borbonico raggiunse
il suo massimo: 120,06 ducati nel 1857. Si tratta di una fase che potremmo
considerare come una sorta di bolla speculativa. Prima dell’inizio della
spedizione dei Mille, l’Europa guardava al Regno delle Due Sicilie come a una
monarchia in crisi irreversibile. Si trattava soltanto di capire di che morte il
regno dovesse morire, un po’ come capitato con la fine del governo Berlusconi.
Il grafico in alto (visibile qui) mostra l’andamento della serie delle
quotazioni giornaliere del debito pubblico borbonico durante il 1860. La retta
verticale segna l’inizio della spedizione. Come è possibile evincere, le
quotazioni del debito crollano con l’avanzare dei garibaldini. La spedizione di
Garibaldi è un’impresa decisamente non lineare, che procede per salti discreti.
Indubbiamente, da un punto di vista numerico, lo scontro appariva impari: un
migliaio di volontari, male armati e peggio equipaggiati, contro le 100mila
unità di cui contava, almeno sulla carta, l’esercito regolare di Francesco II.
Seguire la spedizione attraverso le contrattazioni sul mercato ci consente di
fare luce, in un modo assai originale, sull’evento... Dallo sbarco avvenuto a
Marsala l11 maggio alla battaglia di Calatafimi, quattro giorni dopo (il primo
grosso smacco per l’armata borbonica) il titolo perse 4,4 punti percentuali.
Dopo Calatafimi, i Mille puntarono verso Palermo, dove, a protezione della
città, stava il grosso del contingente borbonico sull’isola (25 mila unità). In
pratica, Garibaldi conquistò la città senza combattere, sfruttando insieme la
sua abilità tattica e la disorganizzazione delle truppe regie, guidate da
Ferdinando Lanza. Al 19 giugno, data di caduta della città, il titolo aveva
perso 10 punti percentuali, fermo a 103 ducati. Luglio fu sostanzialmente un
mese di stasi: i garibaldini si organizzarono in Sicilia mentre, allo stesso
tempo, pianificavano lo sbarco in continente; i borbonici, a Napoli, preparavano
invece la controffensiva. Questa incertezza si concretizzò, non casualmente, in
un periodo di immobilismo delle contrattazioni, con il titolo che reagisce, sì,
alla battaglia di Milazzo (19 luglio) perdendo altri 5,5 punti percentuali (96
ducati), ma rimane, poi, sostanzialmente stabile, un po’ come lo spread italiano
oggi, fermo da giorni sulla soglia dei 500 punti. Dallo sbarco in Calabria e
fino alla caduta di Napoli e del Regno, con la battaglia del Volturno che si
conclude il 1° ottobre 1860, e l'incontro tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II a
Teano il 26 ottobre, il valore del titolo scese a 87 ducati, con una perdita di
altri 9,2 punti percentuali. Il crollo si arrestò nel momento in cui i Savoia
proclamarono ufficialmente che, con l'istituzione del Gran Libro del Debito
Pubblico, avrebbero onorato il pagamento del debito anche degli Stati
pre-unitari annessi, da vero e proprio last resort lender. Il titolo borbonico,
da quel momento, andò assestandosi sui valori della rendita sabauda. La
scaltrezza di Cavour e della casa regnante di Torino, dapprima informalmente
ostili all'avventura garibaldina e, successivamente, pronti a sfruttare
l'opportunità politica offerta dal successo della spedizione, si riflesse nei
corsi del debito, che fotografano come in un elettrocardiogramma le pulsazioni
della finanza dell'epoca, pronta a sintonizzarsi sui ritmi di un cuore Savoia. A
nulla valsero le promesse di riforma costituzionale di Francesco II, dopo il 25
giugno 1860. A nulla servì la controinformazione del regno, ben evidenziata
dal Giornale Ufficiale del Regno delle Due Sicilie, che parlava di brillanti
successi dell'esercito regio contro una masnada di filibustieri, proprio mentre
i buoni del tesoro, inesorabili, cadevano sotto gli occhi della casa regnante in
crisi. Uno degli aspetti più interessanti di questa straordinaria vicenda è
appunto l'informazione, che aumentò l'incertezza attorno all'evento e, con essa,
le fibrillazioni del mercato internazionale. I bookies dell'epoca avrebbero
avuto le loro difficoltà a scommettere sugli eventi. Era chiara, da un lato, la
decadenza del regno borbonico; meno chiara, la via d'uscita: un trionfo
elettorale della coalizione Garibaldi-Mazzini o un governo tecnico Cavour, per
rassicurare i mercati? Col senno di poi, è un po come se Garibaldi avesse detto
obbedisco! non solo al re Vittorio Emanuele, ma anche ai Rothschild.
LUCIANO CANOVA. Docente e ricercatore alla Scuola
Enrico Mattei, dove insegna i corsi di Economia Sperimentale e di Comunicazione
Scientifica al Master MEDEA (Management dell’Economia dell’Ambiente e
dell’Energia). Ha studiato Economia a Milano, laureandosi al DES in Bocconi nel
2002. Ha conseguito un master in Development Economics alla University of Sussex
e il dottorato in Economia all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Per due
anni, è stato post-doc alla Paris School of Economics. iProf di Economia della
felicità su Oilproject.org, collabora con diverse testate di divulgazione
scientifica.
Lettera da Crispi a Garibaldi
- Caprera. Torino, 3 febbraio 1863.
Mio Generale!
Giunto da Palermo, dove stetti poco men che un
mese, credo mio dovere dirvi qualche cosa della povera isola che voi chiamaste a
libertà e che i vostri successori ricacciarono in una servitù peggiore di prima.
Dal nuovo regime quella popolazione nulla ha
ottenuto di che potesse esser lieta. Nissuna giustizia, nissuna sicurezza
personale, l'ipocrisia della libertà sotto un governo, il quale non ha
d'italiano che appena il nome. Ho visitate le carceri e le ho trovate piene
zeppe d'individui i quali ignorano il motivo per il quale sono prigionieri. Che
dirvi del loro trattamento? Dormono sul pavimento, senza lume la notte, sudici,
nutriti pessimamente, privi d'ogni conforto morale, senza una voce che li
consigli e li educhi onde fosser rilevati dalla colpa.
La popolazione in massa detesta il governo
d'Italia, che al paragone trova più tristo del Borbonico. Grande fortuna che non
siamo travolti in quell'odio noi, che fummo causa prima del mutato regime! Essa
ritien voi martire, noi tutti vittime della tirannide la quale viene da Torino e
quindi ci fa grazia della involontaria colpa. Se i consiglieri della Corona non
mutano regime, la Sicilia andrà incontro ad una catastrofe.
E' difficile misurarne le conseguenze, ma esse
potrebbero essere fatali alla patria nostra. L'opera nostra dovrebbe mirare ad
evitare cotesta catastrofe, affinchè non si sfasci il nucleo delle provincie
unite che al presente formano il regno di Italia. Con le forze di questo regno e
coi mezzi ch'esso ci offre, noi potremmo compiere la redenzione della penisola e
occupar Roma. Sciolto cotesto nucleo, è rimandata ad un lontano avvenire la
costituzione d'Italia. Della vostra salute,
alla quale tutti c'interessiamo, ho buone notizie, che spero sempre migliori. Di
Palermo tutti vi salutano come vi amano.
Abbiatevi i complimenti di mia moglie e voi continuatemi il vostro affetto e
credetemi. Vostro ora
e sempre. F. Crispi.
La verità è
rivoluzionaria. Gli oltraggi subiti dalle popolazioni meridionali sono
incommensurabili. Non credo di aver fatto del male. Nonostante ciò, non rifarei
oggi la via dell'Italia meridionale, temendo di essere preso a sassate,
essendosi colà cagionato solo squallore e suscitato solo odio. Giuseppe
Garibaldi (da una lettera scritta ad Adelaide Cairoli, 1868)
Cronologia
moderna delle azioni massoniche e mafiose.
27 marzo 1848 -
Nasce la Repubblica Siciliana. La Sicilia ritorna ad essere indipendente,
Ruggero Settimo è capo del governo, ritorna a sventolare l'antica bandiera
siciliana. Gli inglesi hanno numerosi interessi nell'Isola e consigliano al
Piemonte di annettersi la Sicilia. I Savoia preparano una spedizione da affidare
a Garibaldi. Cavour si oppone perchè considera quest'ultimo un avventuriero
senza scrupoli (ricordano impietositi i biografi che Garibaldi ladro di cavalli,
nell' America del sud, venne arrestato e gli venne tagliato l'orecchio destro.
Sarà, suo malgrado, capellone a vita per nascondere la mutilazione) [Secondo
altre fonti l’orecchio gli sarebbe stato staccato con un morso da una ragazza
che aveva cercato di violentare all’epoca della sua carriera di pirata,
stupratore, assassino in America Latina, NdT]. Il nome di Garibaldi, viene
abbinato altresì al traffico di schiavi dall'Africa all'America. Rifornito di
denaro inglese da i Savoia, Garibaldi parte per la Sicilia.
11 maggio 1860 -
Con la protezione delle navi inglesi Intrepid e H.M.S. Argus, Garibaldi sbarca a
Marsala. Scrive il memorialista garibaldino Giuseppe Bandi: I mille vengono
accolti dai marsalesi come cani in chiesa! La prima azione mafiosa è contro la
cassa comunale di Marsala. Il tesoriere dei mille, Ippolito Nievo lamenta che si
trovarono pochi spiccioli di rame. I siciliani allora erano meno fessi! E'
interessante la nota di Garibaldi sull'arruolamento: "Francesco Crispi arruola
chiunque: ladri, assassini, e criminali di ogni sorta".
15 maggio 1860 -
Battaglia di Calatafimi. Passata alla storia come una grande battaglia, fu
invece una modesta scaramuccia, si contarono 127 morti e 111 furono messi fuori
combattimento. I Borbone con minor perdite disertano il campo. Con un esercito
di 25.000 uomini e notevole artiglieria, i Borbone inviano contro Garibaldi
soltanto 2.500 uomini. E' degno di nota che il generale borbonico Landi, fu
comprato dagli inglesi con titoli di credito falsi e che l'esercito borbonico
ebbe l'ordine di non combattere. Le vittorie di Garibaldi sono tutte una
montatura.
27 maggio 1860 -
Garibaldi entra a Palermo da vincitore!....Ateo, massone, mangiapreti, celebra
con fasto la festa di santa Rosalia.
30 maggio 1860 -
Garibaldi dà carta bianca alle bande garibaldine; i villaggi sono saccheggiati
ed incendiati; i garibaldini uccidevano anche per un grappolo d'uva. Nino Bixio
uccide un contadino reo di aver preso le scarpe ad un cadavere. Per incutere
timore, le bande garibaldine, torturano e fucilano gli eroici siciliani.
31 maggio 1860 -
Il popolo catanese scaccia per sempre i Borbone. In quell'occasione brillò, per
un atto di impavido coraggio, la siciliana Giuseppina Bolognani di Barcellona
Pozzo di Gotto (ME). Issò sopra un carro un cannone strappato ai borbonici e
attese la carica avversaria; al momento opportuno, l'avversario a due passi,
diede fuoco alle polveri; il nemico, decimato, si diede alla fuga disordinata.
Si guadagnò il soprannome Peppa 'a cannunera (Peppa la cannoniera) e la medaglia
di bronzo al valor militare.
2 giugno 1860 -
Con un decreto, Garibaldi assegna le terre demaniali ai contadini; molti
abboccano alla promessa. Intanto nell'Isola divampava impetuosa la rivoluzione
che vedeva ancora una volta il Popolo Siciliano vittorioso. Fu lo stesso popolo
che unito e compatto costrinse i borbonici alla ritirata verso Milazzo.
17 luglio 1860 -
Battaglia di Milazzo. Il governo piemontese invia il Generale Medici con 21.000
uomini bene armati a bordo di 34 navi. La montatura garibaldina ha fine. I
contadini siciliani si ribellano, vogliono la terra promessagli. Garibaldi,
rivelandosi servo degli inglesi e degli agrari, invia loro Nino Bixio.
10 agosto 1860 -
Da un bordello di Corleone, Nino Bixio ordina il massacro di stampo mafioso di
Bronte. Vengono fucilati l'avvocato Nicolò Lombardo e tre contadini, tra i quali
un minorato! L'Italia mostra il suo vero volto.
21 ottobre 1860
- Plebiscito di annessione della Sicilia al Piemonte. I voti si depositano in
due urne: una per il "Sì" e l'altra per il "No". Intimorendo, come abitudine
mafiosa, ruffiani, sbirri e garibaldini controllano come si vota. Su una
popolazione di 2.400.000 abitanti, votarono solo 432.720 cittadini (il 18%). Si
ebbero 432.053 "Sì" e 667 "No". Giuseppe Mazzini e Massimo D'Azeglio furono
disgustati dalla modalità del plebiscito. Lo stesso ministro Eliot, ambasciatore
inglese a Napoli, dovette scrivere testualmente nel rapporto al suo Governo che:
"Moltissimi vogliono l'autonomia, nessuno l'annessione; ma i pochi che votano
sono costretti a votare per questa". E un altro ministro inglese, Lord John
Russel, mandò un dispaccio a Londra, cosí concepito: "I voti del suffragio in
questi regni non hanno il minimo valore".
1861 - L'Italia
impone enormi tasse e l'obbligo del servizio militare, ma per chi ha soldi e
paga, niente soldato. Intanto i militari italiani, da mafiosi, compiono atrocità
e massacri in tutta l'Isola. Il sarto Antonio Cappello, sordomuto, viene
torturato a morte perchè ritenuto un simulatore, il suo aguzzino, il colonnello
medico Restelli, riceverà la croce dei "S.S. Maurizio e Lazzaro". Napoleone III
scrive a Vittorio Emanuele: "I Borbone non commisero in cento anni, gli orrori e
gli errori che hanno commesso gli agenti di Sua Maestà in un anno”.
1863 - Primi
moti rivoluzionari antitaliani di pura marca indipendentista. Il governo
piemontese instaura il primo stato d'assedio. Viene inviato Bolis per massacrare
i patrioti siciliani. Si prepara un'altra azione mafiosa contro i Siciliani.
8 maggio 1863 -
Lord Henry Lennox denuncia alla camera dei Lords le infamie italiane e ricorda
che non Garibaldi ma l'Inghilterra ha fatto l'unità d'Italia.
15 agosto 1863 -
Secondo stato d'assedio. Si instaura il terrore. I Siciliani si rifiutano di
indossare la divisa italiana; fu una vera caccia all'uomo, le famiglie dei
renitenti furono torturate, fucilate e molti furono bruciati vivi. Guidava
l'operazione criminale e mafiosa il piemontese Generale Giuseppe Govone. (Nella
pacifica cittadina di Alba, in piazza Savona, nell'aprile 2004 è stato
inaugurato un monumento equestre a questo assassino. Ignoriamo per quali
meriti.)
1866 - In
Sicilia muoiono 52.990 persone a causa del colera. Ancora oggi, per tradizione
orale, c'è la certezza che a spargervi il colera nell'Isola siano state persone
legate al Governo italiano. Intanto tra tumulti, persecuzioni, stati d'assedio,
terrore, colera ecc. la Sicilia veniva continuamente depredata e avvilita; il
Governo italiano vendette perfino i beni demaniali ed ecclesiastici siciliani
per un valore di 250 milioni di lire. Furono, nel frattempo, svuotate le casse
della regione. Il settentrione diventava sempre più ricco, la Sicilia sempre più
povera.
1868 - Giuseppe
Garibaldi scrive ad Adelaide Cairoli:"Non rifarei la via del Sud, temendo di
essere preso a sassate!". Nessuna delle promesse che aveva fatto al Sud (come
quella del suo decreto emesso in Sicilia il 2 giugno 1860, che assegnava le
terre comunali ai contadini combattenti), era stata mantenuta.
1871 - Il
Governo, con un patto scellerato, fortifica la mafia con l'effettiva connivenza
della polizia. Il coraggioso magistrato Diego Tajani dimostrò e smascherò questa
alleanza tra mafia e polizia di stato e spiccò un mandato di cattura contro il
questore di Palermo Giuseppe Albanese e mise sotto inchiesta il prefetto, l'ex
garibaldino Gen. Medici. Ma il Governo italiano, con fare mafioso si schiera
contro il magistrato costringendolo a dimettersi.
1892 - Si
formano i "Fasci dei Lavoratori Siciliani". L'organizzazione era pacifica ed
aveva gli ideali del popolo, risolvere i problemi siciliani. Chiedeva,
l'organizzazione dei Fasci la partizione delle terre demaniali o incolte, la
diminuzione dei tassi di consumo regionale ecc.
4 gennaio 1894 -
La risposta mafiosa dello stato italiano non si fa attendere: STATO D'ASSEDIO.
Francesco Crispi, (definito da me traditore dei siciliani a perenne vergogna dei
riberesi) presidente del Consiglio, manda in Sicilia 40.000 soldati al comando
del criminale Generale Morra di Lavriano, per distruggere l'avanzata impetuosa
dei Fasci contadini. All'eroe della resistenza catanese Giuseppe De Felice
vengono inflitti 18 anni di carcere; fu poi amnistiato nel 1896, ricevendo
accoglienze trionfali nell'Isola.
Note di "Sciacca
Borbonica": Sono molti i paesi del mondo che dedicano vie, piazze e strade a
lestofanti e assassini. Ma pochi di questi paesi hanno fatto di un pirata
macellaio addirittura il proprio eroe nazionale. Il 27 luglio 1995 il
giornale spagnolo "El Pais", giustamente indignato per l’apologia di Garibaldi
fatta dall’allora presidente Scalfaro (quello che si prendeva 100 milioni al
mese in nero dal SISDE, senza che nessuno muovesse un dito) nel corso di una
visita in Spagna, così gli rispose a pag. 6: “Il presidente d'Italia è stato
nostro illustre visitante...... Disgraziatamente, in un momento della sua
visita, il presidente italiano si è riferito alla presenza di Garibaldi nel Rio
della Plata, in un momento molto speciale della storia delle nazioni di questa
parte del mondo. E, senza animo di riaprire vecchie polemiche e aspre
discussioni, diciamo al dott. Scalfaro che il suo compatriota [Garibaldi] non ha
lottato per la libertà di queste nazioni come egli afferma. Piuttosto il
contrario". Il 13 settembre 1860, mentre l'unificazione italiana era in pieno
svolgimento, il giornale torinese Piemonte riportava il seguente articolo.
(1): «Le imprese di Garibaldi nelle Due Sicilie parvero sin da allora così
strane che i suoi ammiratori ebbero a chiamarle prodigiose. Un pugno di giovani
guidati da un audacissimo generale sconfigge eserciti, piglia d'assalto le città
in poche settimane, si fa padrone di un reame di nove milioni di abitanti. E ciò
senza navigli e senz'armi... Altro che Veni, Vedi, Vici! Non c'è Cesare che
tenga al cospetto di Garibaldi. I miracoli però non li ha fatti lui ma li fecero
nell'ordine: 1°)-L'oro con il quale gli inglesi comprarono quasi tutti i
generali borbonici e col quale assoldarono 20.000 mercenari ungheresi e slavi e
pagarono il soldo ad altri 20.000 tra carabinieri e bersaglieri, opportunamente
congedati dall'esercito sardo-piemontese e mandati come "turisti" nel Sud, altro
che i 1000 scalcinati eroi...... 2°)-il generale Nunziante ed altri tra
ufficiali dell'esercito e della marina che, con infinito disonore, disertarono
la loro bandiera per correre sotto quella del nemico eccovi servito un piccolo
elenco di traditori al soldo degli anglo-piemontesi, oltre al
Nunziante: Generale Landi, Generale Cataldo, Generale Lanza, Generale Ghio,
Comandante Acton, Comandante Cossovich,ed altri ancora; 3°)-i miracoli li ha
fatti il Conte di Siracusa con la sua onorevolissima lettera al nipote Francesco
II° (lettera pubblicata in un post a parte); 4°)-li ha fatti la Guardia
Nazionale che, secondo il solito, voltò le armi contro il re che gliele avea
date poche ore prima; 5°)-)li ha fatti il Gabinetto di Liborio Romano il quale,
dopo aver genuflesso fino al giorno di ieri appié del trono di Francesco II, si
prostra ai piedi di Garibaldi; 6°)- La quasi totalità della nobiltà siciliana.
Beh, Con questi miracoli ancor io sarei capace di far la conquista, non dico
della Sicilia e del Reame di Napoli, ma dell'universo mondo. Dunque non state a
contare le prodezze di Sua Maestà Garibaldi I. Egli non è che il comodino della
rivoluzione. Le società segrete (la massoneria) che hanno le loro reti in tutto
il paese delle Due Sicilie, hanno di lunga mano preparato ogni cosa per la
rivoluzione. E quando fu tutto apparecchiato si chiamò Garibaldi ad eseguire i
piani [...]. Se non era Garibaldi sarebbe stato Mazzini, Kossuth, Orsini o Lucio
della Venaria: faceva lo stesso. Appiccare il fuoco ad una mina anche un bimbo
può farlo. Di fatto vedete che dappertutto dove giunge Garibaldi la rivoluzione
è organizzata issofatto, i proclami sono belli e fatti, anzi stampati. In questo
modo credo che Garibaldi può tranquillamente fare il giro del mondo a piantare
le bandiere tricolori del Piemonte. Dopo Napoli Roma, dopo Roma Venezia, dopo
Venezia la Dalmazia, dopo la Dalmazia l'Austria, caduta l'Austria il mondo è di
Garibaldi, cioé del Piemonte! Oh che cuccagna! Torino capitale dell'Europa, anzi
dell'orbe terracqueo. Ed i torinesi padroni del mondo!». Dai Savoia agli
Agnelli, da una famiglia di vampiri ad un altra.....per il Sud sempre lo stesso
destino.......dar loro anche l'ultima goccia di sangue. Comunque la Giustizia
Divina arriva sempre........i savoia son finiti nella merda e nel ludibrio, gli
Agnelli nella tomba e nella droga che certamente sarà il mezzo con quale ci
libereremo di questa gente maledetta.
Gli eurobond che fecero l'Unità d'Italia
quando il Regno di Napoli era come la Germania, scrive
Giuseppe
Chiellino il 30 giugno 2012 su “Il Sole 24 Ore”. Il vertice europeo di
fine giugno ha cancellato gli eurobond dall'agenda. Almeno per ora. Angela
Merkel è stata drastica: «Mai finchè sarò viva» aveva detto in pubblico qualche
giorno prima. Chissà se la cancelliera tedesca aveva avuto il tempo di leggere
lo studio di Stéphanie Collet, storica della finanza della Université Libre de
Bruxelles che è andata a spulciare negli archivi delle Borse di Parigi e Anversa
per studiare l'unico precedente assimilabile agli Eurobond: l'unificazione del
debito sovrano dei sette stati che 150 anni orsono, su iniziativa del Piemonte e
sotto tutela di Francia e Inghilterra, costituirono il Regno d'Italia. Nella
storia dello stato moderno è l'esperienza storicamente più vicina al
faticosissimo tentativo di dare maggiore consistenza politica all'Unione
europea, anche attraverso l'integrazione delle politiche economiche e fiscali,
compresi debiti sovrani dei 17 paesi dell'euro. Un precedente prezioso, secondo
la Collet, per cercare di capire – mutatis mutandis - come potrebbero
comportarsi i mercati finanziari di fronte all'unificazione del debito pubblico
dei paesi della zona euro. «Come l'Italia di allora, l'Europa oggi è fatta da
stati eterogenei, con economie di dimensioni e condizioni diverse, che parlano
lingue diverse e hanno sistemi di imposizione fiscale separati» ricorda la
studiosa. Grazie al fatto che anche dopo l'unificazione i titoli del Regno
d'Italia conservarono fino al 1876 l'indicazione della loro origine (per
esempio, ad Anversa le emissioni del Regno delle Due Sicilie erano indicate come
"Italy-Neapolitean") la Collet è riuscita a ricostruire le serie storiche dei
prezzi settimanali tra il 1847 e il 1873. Un lavoro certosino di raccolta
manuale dei dati dagli archivi e dai database originali per capire come si sono
mosse le quotazioni, prima e dopo l'unità, politica ed economica. 25 emissioni
suddivise in quattro gruppi: Regno di Piemonte e Sardegna, Lombardo-Veneto, Due
Sicilie e Stato Pontificio. La prima cosa che balza agli occhi è lo spread
(anche allora!) tra i rendimenti dei diversi gruppi di bond prima e dopo
l'Unità. Quelli del Regno delle Due Sicilie (che erano un quarto del totale)
prima del 1861 pagavano i tassi più bassi: 4,3%, 140 punti base in meno delle
emissioni papali e di quelle piemontesi (che rappresentavano rispettivamente il
29% e il 44% del debito unitario dopo la conversione) e 160 in meno rispetto a
quelle Lombardo-Venete (che però erano solo il 2%). Insomma, a voler utilizzare
le categorie di oggi, il Regno di Napoli economicamente era per l'Italia quello
che oggi la Germania è per l'Eurozona. «Come il Regno di Napoli prima
dell'integrazione del debito sovrano, la Germania di oggi è l'economia più forte
dell'eurozona e beneficia del costo del debito più basso in assoluto» scrive
Collet. Considerazioni, queste, che faranno storcere il naso a molti, ma
sicuramente non di parte. Del resto, come ricorda Collet, Napoli era di gran
lunga la città più importante del neonato Regno d'Italia. E le regioni del Sud
avevano una discreta struttura industriale, un'agricoltura fiorente sia pure
basata sul latifondismo, e importanti porti commerciali. Subito dopo il 1861,
però, lo scettiscismo dei mercati nel processo unitario italiano impose un "risk
premium" comune a tutti i bond degli stati preunitari, anche a quelli che fino a
quel momento avevano goduto di maggiore fiducia e dunque di rendimenti più
bassi. Proprio quello che oggi la Germania teme possa avvenire con gli eurobond:
l'anno successivo, infatti, i rendimenti dei titoli convertiti in "Regno
d'Italia" si allinearono ben al di sopra dei tassi precedenti, al 6,9%. Per gli
"Italy – Neapolitean" 260 punti base in più che diventarono 460 nel 1870, per
poi cominciare a ripiegare dopo il 1871, quando cioè l'annessione di Venezia e
di Roma e il trasferimento della capitale nella città del papato convinsero gli
investitori, e non solo, che l'Unità era ormai irreversibile. L"Italia" non era
più una mera "espressione geografica", come l'aveva definita Metternich nel
1847, ma dopo tre guerre d'indipendenza e più di vent'anni di manovre
diplomatiche era diventata uno stato unitario. «L'integrazione dei debiti
sovrani era stato uno strumento per portare avanti l'integrazione politica, come
sarebbe oggi per l'Europa» afferma Collet, ma nota anche che «un aumento del
premio di rischio aggraverebbe la crisi del debito che sta vivendo l'Europa
piuttosto che risolverla. Significherebbe che, se fossero introdotti gli
eurobond, la Germania perderebbe il suo rating elevato». Questo portava Collet a
definire, già nei mesi scorsi, «remote» le speranze di vedere nel breve termine
un mercato integrato dei titoli di debito dell'eurozona. Nel lungo termine,
invece, i risultati della ricerca sul caso italiano dimostrano che «nel tempo i
rendimenti dei titoli diminuirono». Alla luce di questo, oggi la domanda è:
quanto tempo ci vorrà perché anche l'Europa sia considerata come un blocco unico
e in grado di dotarsi di un vero e proprio piano di salvataggio per l'euro? Per
l'Italia ci volle all'incirca un decennio. Considerato che quella italiana fu
un'annessione anche militare e quella europea è un'integrazione consensuale, e
che i mercati dei capitali si muovono a ritmi diversi rispetto alla seconda metà
dell'800, anche Collet concorda che un aumento del costo del debito nel breve
termine sarebbe un prezzo che potremmo permetterci di pagare se avessimo la
certezza di avere, tra qualche anno, un'Europa più unita. Ma questa certezza
nessuna ricerca, per quanto accurata, potrà mai darla. Serve, forse, la capacità
di andare oltre il breve periodo, di guardare un po' più lontano rispetto alla
prossima scadenza elettorale, superando la "veduta corta" che per Tommaso Padoa
Schioppa è stata «la radice» della crisi.
Si può anche non leggere questi libri, frutto di
anni di ricerca, ma nell’ignoranza imperante che impedisce l’evoluzione non
potrà dire che la colpa è degli altri e che gli altri son tutti uguali. Ad oggi,
per esempio, sappiamo che lo studio di due ricercatori svela: i magistrati di
sinistra indagano di più gli avversari politici; i magistrati di destra
insabbiano di più le accuse contro i loro amici e colleghi. E poi. Parla l’ex
capo dei Casalesi. La camorra e la mafia non finirà mai, finchè ci saranno
politici, magistrati e forze dell’ordine mafiosi. "Noi avevamo la nostra idea.
Dovevamo formare, per la fine del millennio, i nostri giovani come degli
infiltrati dentro lo Stato: quindi dovevano diventare magistrati, poliziotti,
carabinieri e perché no, anche ministri e presidenti del Consiglio. Per avere i
nostri referenti nelle istituzioni". Inutile lamentarci dei "Caccamo" alla
Cassazione. Carmine Schiavone ha detto: Roma nostra! "Ondata di ricorsi dopo il
«trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici, Napoli capitale
dei promossi. L'area coperta dalla Corte d'appello ha «prodotto» un terzo degli
aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori". O la statistica è birichina
assai o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale concorso di accesso alla
magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici ammessi agli orali vengono
infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli, che rappresenta solo un
trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della popolazione italiana. Un
trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza: erano della stessa area,
più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della commissione e 5 su 8 dei docenti
universitari. Cioè oltre un terzo degli esaminatori. Lo strumento per
addentrarsi nei gangli del potere sono gli esami di Stato ed i concorsi pubblici
truccati.
LADRI ED ASSASSINI. MAFIOSI E MASSONI.
Giovanni Falcone: «La mafia non è affatto
invincibile; è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà
anche una fine. Piuttosto, bisogna rendersi conto che è un fenomeno
terribilmente serio e molto grave; e che si può vincere non pretendendo
l'eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze
migliori delle istituzioni...La mafia è un fenomeno umano e come tutti i
fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine.
Spero solo che la fine della mafia non coincida con la fine dell'uomo. Se
vogliamo combattere efficacemente la mafia, non dobbiamo trasformarla in un
mostro né pensare che sia una piovra o un cancro. Dobbiamo riconoscere che ci
rassomiglia. A questa città vorrei dire: gli uomini passano, le idee restano.
Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di
altri uomini...L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper
convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il
coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio ma incoscienza...Ci troviamo di
fronte a menti raffinatissime che tentano di orientare certe azioni della mafia.
Esistono forse punti di collegamento tra i vertici di Cosa nostra e
centri occulti di potere che hanno altri interessi. Ho l'impressione che sia
questo lo scenario più attendibile se si vogliono capire davvero le ragioni che
hanno spinto qualcuno ad...Se poni una questione di sostanza, senza dare
troppa importanza alla forma, ti fottono nella sostanza e nella forma...Credo
che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. Contano
le azioni non le parole. Se dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti
bravi e irreprensibili...Si muore generalmente perché si è soli o perché si è
entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle
necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno...Chiunque è in grado di
esprimere qualcosa deve esprimerlo al meglio. Questo è tutto quello che si può
dire, non si può chiedere perché. Non si può chiedere ad un alpinista perché lo
fa. Lo fa e basta. A scuola avevo un professore di filosofia che voleva sapere
se, secondo noi, si era felici quando si è ricchi o quando si soddisfano
gli ideali....Tre magistrati vorrebbero
oggi diventare procuratore della Repubblica. Uno è intelligentissimo,
il secondo gode dell’appoggio dei partiti di governo, il terzo è un cretino, ma
proprio lui otterrà il posto. Questa è la mafia...Temo che la magistratura torni
alla vecchia routine: i mafiosi che fanno il loro mestiere da un lato,
i magistrati che fanno più o meno bene il loro dall'altro, e alla resa dei
conti, palpabile, l'inefficienza dello Stato...Se un pentito rivela che
un candidato è stato aiutato dalla mafia per interessamento di un alto esponente
del suo partito, che invece risulterebbe un suo avversario, la rivelazione batte
la logica, e si va avanti lo stesso... La certezza è che così non si fa un passo
avanti nella dura lotta alla mafia...Perché una società vada bene, si muova
nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del
bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per
avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il
suo dovere...L'impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata è
emotivo, episodico, fluttuante. Motivato solo dall'impressione suscitata da un
dato crimine o dall'effetto che una particolare iniziativa governativa può
suscitare sull'opinione pubblica...Si muore generalmente perché si è soli o
perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si
dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la
mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a
proteggere...Come evitare di parlare di Stato quando si parla di mafia?...Io
dico che bisogna stare attenti a non confondere la politica con
la giustizia penale. In questo modo, l'Italia, pretesa culla del diritto,
rischia di diventarne la tomba...Il P.M. non deve avere nessun tipo di parentela
con il giudice e non deve essere, come invece oggi è, una specie di paragiudice.
Chi, come me, richiede che (giudice e P.M.) siano, invece, due figure
strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato
come nemico dell'indipendenza del Magistrato, un nostalgico della...La
magistratura ha sempre rivendicato la propria indipendenza, lasciandosi
in realtà troppo spesso irretire surrettiziamente
dalle lusinghe del potere politico. Sotto la maschera di un'autonomia formale,
il potere ci ha fatto dimenticare la mancanza di un'autonomia reale. Abbiamo
sostenuto con passione la tesi del pubblico ministero indipendente...Per lungo
tempo si sono confuse la mafia e la mentalità mafiosa, la mafia
come organizzazione illegale e la mafia come semplice modo di essere.
Quale errore! Si può benissimo avere una mentalità mafiosa senza essere
un criminale..Nei momenti di malinconia mi lascio andare a pensare al destino
degli uomini d’onore: perché mai degli uomini come gli altri, alcuni dotati di
autentiche qualità intellettuali, sono costretti a inventarsi un’attività
criminale per sopravvivere con dignità?... La mescolanza tra società sana
e società mafiosa a Palermo è sotto gli occhi di tutti e l'infiltrazione di Cosa
Nostra costituisce la realtà di ogni giorno...Ci si dimentica che
il successo delle mafie è dovuto al loro essere dei modelli vincenti per la
gente. E che lo Stato non ce la farà fin quando non sarà diventato esso stesso
un «modello vincente»...Entrare a far parte della mafia equivale a convertirsi a
una religione. Non si cessa mai di essere preti. Né mafiosi...La mafia si
caratterizza per la sua rapidità nell'adeguare valori arcaici alle esigenze del
presente, per la sua abilità nel confondersi con la società civile, per
l'uso dell'intimidazione e della violenza, per il numero e la
statura criminale dei suoi adepti, per la sua capacità ad essere sempre diversa
e sempre uguale a se stessa...“Il dialogo Stato/mafia, con gli alti e bassi tra
i due ordinamenti, dimostra chiaramente che Cosa Nostra non è un anti-Stato, ma
piuttosto una organizzazione parallela...»
Paolo Borsellino: «La lotta alla mafia dev’essere
innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del
fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale,
dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità...Se
la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia
svanirà come un incubo...Non ho mai chiesto di occuparmi di mafia. Ci sono
entrato per caso. E poi ci sono rimasto per un problema morale. La gente mi
moriva attorno...Non sono né un eroe né un Kamikaze, ma una persona come tante
altre. Temo la fine perché la vedo come una cosa misteriosa, non so quello che
succederà nell'aldilà. Ma l'importante è che sia il coraggio a prendere il
sopravvento... Se non fosse per il dolore di lasciare la mia famiglia, potrei
anche morire sereno...È bello morire per ciò in cui si crede; chi ha paura muore
ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola...La paura è umana, ma
combattetela con il coraggio...Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad
amarla. Perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace per
poterlo cambiare...Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione,
sui giornali. Però parlatene...A fine mese, quando ricevo lo stipendio, faccio
l'esame di coscienza e mi chiedo se me lo sono guadagnato...Guardi,
io ricordo ciò che mi disse Ninnì Cassarà allorché ci stavamo
recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del
luglio del 1985, credo. Mi disse: "Convinciamoci che siamo dei cadaveri che
camminano"... È normale che esista la paura, in ogni uomo, l'importante è che
sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura,
altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti...L’impegno contro
la mafia, non può concedersi pausa alcuna, il rischio è quello di ritrovarsi
subito al punto di partenza...I pentiti sono merce delicata, delicatissima, sono
loro che scelgono il giudice a cui confessare, non viceversa, sono degli
sconfitti che abbandonano un padrone per servirne un altro, ma vogliono che
sia affidabile».
Le parole. Le sue, con quella cadenza ellittica
della lingua siciliana, davanti a un gruppo di studenti dall’accento vicentino.
«Volevo sapere, giudice, se si sente protetto dallo Stato e ha fiducia nello
Stato stesso», chiede un ragazzo. «No, io non mi sento protetto dallo Stato»,
risponde Paolo Borsellino. È il 26 gennaio del 1989, il video è in Rete grazie
all’Archivio Antimafia.
La ricostruzione dei giornalisti del Fatto,
Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza, mette i brividi: Borsellino è stato ucciso
perché stava indagando, formalmente, sulla trattativa Stato-Mafia, scrive
"L'Infiltrato" il 19 luglio 2016. La conferma arriva dal ritrovamento di un
fascicolo assegnato a Borsellino in data 8 luglio 1992 (11 giorni prima di
essere ucciso…) in cui viene fuori l’ufficialità dell’indagine e i nomi delle
persone coinvolte. Nomi pesanti. Nomi di capimafia. Nomi di politici. Nomi di
esponenti dei servizi segreti. In piena stagione stragista, a metà giugno del
‘92, un anonimo di otto pagine scatenò fibrillazione e panico nei palazzi del
potere politico-giudiziario: sosteneva che l’ex ministro dc Calogero Mannino
aveva incontrato Totò Riina in una sacrestia di San Giuseppe Jato (Palermo). Una
sorta di prologo della trattativa. Ricordiamo che Mannino è stato assolto per
“non aver commesso il fatto”. Su quell’anonimo, si scopre dai documenti prodotti
dal pm Nino Di Matteo nell’aula del processo Mori, stava indagando formalmente
Paolo Borsellino. Con un’indagine che il generale del Ros Antonio Subranni
chiese ufficialmente di archiviare perché non meritava “l’attivazione della
giustizia”. Il documento dell’assegnazione del fascicolo a Borsellino e a
Vittorio Aliquò, datato 8 luglio 1992, insieme alle altre note inviate tra
luglio e ottobre di quell’anno, non è stato acquisito al fascicolo processuale
perché il presidente del Tribunale Mario Fontana non vi ha riconosciuto una
“valenza decisiva” ai fini della sentenza sulla mancata cattura di Provenzano
nel ‘95, quando si è deciso di assolvere Mori e Obinu, anche in appello nel
2016. Ma le note sono state trasmesse alla Procura nissena impegnata nella
ricostruzione dello scenario che fa da sfondo al movente della strage di via
D’Amelio. In aula a Caltanissetta, infatti, Carmelo Canale ha raccontato che il
25 giugno 1992, Borsellino, “incuriosito dall’anonimo” volle incontrare il
capitano del Ros Beppe De Donno, in un colloquio riservato alla caserma Carini,
proprio per conoscere quel carabiniere che voci ricorrenti tra i suoi colleghi
indicavano come il “Corvo due”, ovvero l’autore della missiva di otto pagine.
Quale fu il reale contenuto di quell’incontro? Per il pm, gli ufficiali del Ros,
raccontando che con Borsellino quel giorno discussero solo della pista
mafia-appalti, hanno sempre mentito: una bugia per negare l’esistenza della
trattativa, come ha ribadito Di Matteo in aula, nell’ultima replica. Tre giorni
dopo, il 28 giugno, a Liliana Ferraro che gli parla dell’iniziativa avviata dal
Ros con don Vito, Borsellino fa capire di sapere già tutto e dice: “Ci penso
io”. Il primo luglio ‘92, a Palermo il procuratore Pietro Giammanco firma una
delega al dirigente dello Sco di Roma e al comandante del Ros dei Carabinieri
per l’individuazione dell’anonimo. Il 2 luglio, Subranni gli risponde con un
biglietto informale: “Caro Piero, ho piacere di darti copia del comunicato
dell’Ansa sull’anonimo. La valutazione collima con quella espressa da altri
organi qualificati. Buon lavoro, affettuosi saluti”. Nel lancio Ansa, le
“soffiate” del Corvo sono definite dai vertici investigativi “illazioni ed
insinuazioni che possono solo favorire lo sviluppo di stagioni velenose e
disgreganti”. Come ha spiegato in aula Di Matteo, “il comandante del Ros, il
giorno stesso in cui avrebbe dovuto cominciare ad indagare, dice al procuratore
della Repubblica: guardate che stanno infangando Mannino”. Perché Subranni tiene
a far sapere subito a Giammanco che l’indagine sul Corvo 2 va stoppata? Venerdì
10 luglio ‘92 Borsellino è a Roma e incontra proprio Subranni, che il giorno
dopo lo accompagna in elicottero a Salerno. Borsellino (lo riferisce il collega
Diego Cavaliero) quel giorno ha l’aria “assente”. Decisivo, per i pm, è proprio
quell’incontro con Subranni, indicato come l’interlocutore diretto di Mannino. È
a Subranni che, dopo l’uccisione di Salvo Lima, l’ex ministro Dc terrorizzato
chiede aiuto per aprire un “contatto” con i boss. È allo stesso Subranni che
Borsellino chiede conto e ragione di quella trattativa avviata con i capi
mafiosi? No, secondo Basilio Milio, il difensore di Mori, che in aula ha
rilanciato: “Quell’incontro romano con Subranni è la prova che Borsellino
certamente non aveva alcun sospetto sul Ros”. Il 17 luglio, però, Borsellino
dice alla moglie Agnese che “Subranni è punciuto”. Poche ore dopo, in via
D’Amelio, viene messo a tacere per sempre. Nell’autunno successivo, il 3
ottobre, il comandante del Ros torna a scrivere all’aggiunto Aliquò, rimasto
solo ad indagare sull’anonimo: “Mi permetto di proporre – lo dico
responsabilmente – che la signoria vostra archivi immediatamente il tutto ai
sensi della normativa vigente”.
Trattativa, ecco i documenti sul presunto
patto fra lo Stato e Cosa nostra. La lettera a
Scalfaro scritta nel 1993 dai familiari dei boss detenuti al 41bis. L'appunto in
cui il direttore del Dap Nicolò Amato suggerisce l'alleggerimento del carcere
duro. E l'elenco completo dei mafiosi che ne beneficiarono. Ilfattoquotidiano.it
pubblica le carte al centro dell'inchiesta di Palermo sui presunti accordi
segreti per fare cessare la stagione delle stragi, scrive Marco Lillo il 26
giugno 2012 su "Il Fatto Quotidiano". Questa è la storia di
una trattativa iniziata con una lettera dei familiari dei boss in cui si parla
di mutande e biancheria per far calare le braghe allo Stato. Una trattativa che
la pubblicistica in voga vorrebbe sia stata chiusa dall’allora ministro Giovanni
Conso con il rilascio di 334 mafiosi, usciti dal regime dell’isolamento nel
novembre del 1993 e che invece potrebbe essere ancora aperta, come dimostra la
storia di una strage mancata durante una partita di calcio: Roma-Udinese del 23
gennaio 1994. Oggi pubblichiamo i documenti che dovrebbero aprire e chiudere le
danze della partita a scacchi tra istituzioni e corleonesi, cioè la lettera dei
familiari dei detenuti nelle supercarceri spedita nel febbraio 1993 e l’elenco
dei graziati di Conso del novembre 1993 più altri documenti disponibili sul sito
internet di ilfattoquotidiano.it (guarda in fondo all’articolo) che scandiscono
i momenti cruciali di quel periodo in cui la storia della mafia e quella della
Repubblica si sono intrecciate inscindibilmente. Il punto di rottura degli
equilibri decennali tra Stato e mafia è il 31 gennaio del 1992, quando
la Cassazione infligge migliaia di anni di carcere ai boss mafiosi imputati
al maxi-processo. Il 12 marzo Cosa Nostra uccide Salvo Lima. Il 23 maggio salta
in aria la staffetta della scorta di Giovanni Falcone e l’onda d’urto travolge
anche l’auto blindata che ospita il giudice e la sua compagna. I boss fanno
circolare un elenco di vittime possibili, tra queste spiccano gli ex
ministri Salvo Andò e Calogero Mannino. I Carabinieri del Ros, guidati dal
generale Angelo Subranni, avviano i contatti con il Consigliori dei
corleonesi, Vito Ciancimino. Paolo Borsellino, secondo le testimonianze più
recenti in qualche modo è informato. Di certo, dicono tutti i suoi colleghi e
amici, si sarebbe opposto con tutta la sua forza a qualsiasi forma di cedimento
alla mafia. Secondo i giudici di Caltanissetta, Borsellino sapeva che lo Stato
stava scendendo a patti con Cosa Nostra e anche per questa ragione, in quanto si
sarebbe opposto, è stato ucciso il 19 luglio del 1992 a via D’Amelio. Cosa
Nostra però non si ferma e porta il suo attacco nel “continente”. Il 14 maggio
del 1993 c’è l’attentato a Maurizio Costanzo a Roma. Il 27 maggio le stragi
di Firenze e Milano e il 28 luglio l’attentato contro le chiese a Roma.
Prima dell’avvio di questa seconda ondata di bombe
però era arrivato un segnale che solo recentemente è stato valorizzato grazie al
libro di Sebastiano Ardita, magistrato di grande esperienza, oggi procuratore
aggiunto a Messina e per molti anni al Dipartimento amministrazione
penitenziaria, il Dap. Nel libro Ricatto allo Stato, Ardita racconta che nel
febbraio 1993 arriva una strana lettera al presidente della Repubblica Oscar
Luigi Scalfaro: “Siamo un gruppo di familiari di detenuti che sdegnati e
amareggiati da tante disavventure” è l’incipit (leggi il documento integrale). I
familiari chiedono al presidente: “Quante volte in una settimana Lei cambia la
biancheria intima? Quante volte cambia le lenzuola? Lo sa quanta biancheria in
un mese noi possiamo portare al nostro congiunto? Soli cinque kg”. Poi si
lamentano dei secondini di Pianosa, definiti “sciacalli” e chiedono di “togliere
gli squadristi del dittatore Amato”, Nicolò Amato, direttore del Dap allora
(leggi l’appunto di Amato sul 41 bis). A impressionare sono gli indirizzi a cui
la lettera al presidente, che non si trova negli archivi del Quirinale secondo
quello che dice al telefono mentre è intercettato, il consigliere del Capo di
Stato, Loris D’Ambrosio, è spedita: il Papa, il Vescovo di Firenze e, tra gli
altri, Maurizio Costanzo, oltre a Vittorio Sgarbi e ad altre istituzioni.
L’elenco impressiona perché i destinatari sembrano altrettanti messaggi in
codice decrittati poi dalle bombe contro Costanzo prima, a Firenze poi e infine
davanti al Vicariato di Roma. Lo Stato cede: già nel giugno del 1992 il nuovo
capo del Dap Adalberto Capriotti (Amato è sostituito come chiedevano
implicitamente i familiari) chiede al capo di gabinetto del ministro della
Giustizia di non prorogare i decreti per il 41 bis a centinaia di detenuti per i
quali il trattamento di isolamento era in scadenza. A novembre del 1993, con una
scelta della quale si è assunto la responsabilità davanti ai magistrati,
l’allora ministro Giovanni Conso lascia decadere il 41 bis per ben 334
detenuti (leggi l’elenco completo). Tra questi boss del calibro di Vito
Vitale di Partinico e Giuseppe Farinella che poi insieme ad altri 50 detenuti
torneranno negli anni successivi al regime che gli spettava. Queste carte
mostrano un segmento importante della sequenza, ma da sole non bastano a
spiegare quello che è successo nel braccio di ferro tra mafia e Stato. Non è un
caso se nella contestazione del reato di minacce a corpo dello Stato contro il
senatore del Pdl Marcello Dell’Utri (stessa accusa contestata anche per Calogero
Mannino, all’ex capo del Ros dei Carabinieri Antonio Subranni, al suo vice
dell’epoca Mario Mori e all’allora capitano Giuseppe De Donno) non sia definito
dalla Procura di Palermo il momento in cui sarebbe terminata la cosiddetta
trattativa, che sarebbe meglio definire minaccia allo Stato. Che la partita a
scacchi sia rimasta aperta anche dopo la resa di Conso nel novembre 1993, lo
dimostra proprio un’altra partita, stavolta di calcio, ignorata dai giornali di
destra e dai politici del Pdl che vorrebbero attribuire la responsabilità del
cedimento scellerato dello Stato (che pure per la Procura di Palermo ci fu) solo
e soltanto all’ex ministro Conso, governo Ciampi, quindi uomo del
centrosinistra. La partita che fa saltare questo schema è Roma-Udinese del 23
gennaio 1994. Quel giorno, come ha raccontato Gaspare Spatuzza al processo
Dell’Utri, dovevano saltare in aria un centinaio di carabinieri. Per fortuna il
telecomando non funzionò, ma quel tentativo di strage dimostra che la mafia non
era affatto soddisfatta dei 334 detenuti liberati dal 41 bis. La trattativa non
si chiude a novembre del 1993 e forse non si è chiusa ancora oggi. Da Il Fatto
Quotidiano del 26 giugno 2012.
Borsellino, ecco perché ci vergogniamo.
Ventiquattro anni dopo la strage il processo sta
facendo emergere molti punti oscuri che riguardano investigatori e uomini delle
istituzioni che non avrebbero fatto bene il proprio dovere e molti di loro,
chiamati a testimoniare, hanno ripetuto ai giudici di non ricordare, scrive
Lirio Abbate il 18 luglio 2016 su “L’Espresso”. Siamo arrivati a 24 anni dalla
strage di via D'Amelio alla celebrazione del quarto processo per esecutori e
depistatori, dopo aver avuto quello per i mandanti ed organizzatori di questo
attentato avvenuto il 19 luglio 1992, in cui sono stati uccisi il procuratore
aggiunto di Palermo, Paolo Borsellino e gli agenti di polizia Emanuela Loi,
Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli. Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. La
verità però ancora non emerge su molti aspetti di questa strage. Non emergono i
motivi dei depistaggi, i motivi che hanno spinto piccoli pregiudicati a
diventare falsi collaboratori di giustizia, perché ci sarebbero stati
"suggerimenti" investigativi che hanno spostato l'asse delle indagini lontano da
quelle reali. Sono interrogativi a cui si deve dare ancora una risposta, ma che
hanno portato nei giorni scorsi Lucia Borsellino, figlia del magistrato ucciso,
a sostenere davanti alla Commissione antimafia presieduta da Rosi Bindi che
"quello che sta emergendo in questa fase processuale (è in corso a Caltanissetta
il quarto procedimento sulla strage, ndr) ci si deve interrogare sul fatto se
veramente ci si possa fidare in toto delle istituzioni". Parole pesanti, che
sembrano essere scivolate nel silenzio mediatico e politico. Il processo sta
facendo emergere molti punti oscuri che riguardano investigatori e uomini delle
istituzioni che non avrebbero fatto bene il proprio dovere e molti di loro,
chiamati a testimoniare, hanno ripetuto ai giudici di non ricordare. "Il
semplice sospetto che uomini dello Stato abbiamo potuto tradire un altro uomo
dello Stato e lo dico da figlia, mi fa vergognare", ha detto Lucia Borsellino ai
commissari antimafia, ai quali ha precisato: «Nel caso della strage che ha tolto
la vita a mio padre e agli uomini della scorta non è stato fatto ciò che era
giusto si facesse, se siamo arrivati a questo punto vuol dire che qualcosa non è
andata. Ci sono vicende che gridano vendetta anche se il termine non mi piace».
Per poi concludere: «Mi auguro questa fase processuale tenti di fare chiarezza
sull’accaduto, pensare ci si possa affidare ancora a ricordi di un figlio o una
figlia che lottavano per ottenere un diploma di laurea è un po’ crudele, anche
perché papà non riferiva a due giovani quello che stava vivendo. Non sapevo
determinati fatti, è una dolenza che vivo anche da figlia e una difficoltà
all’elaborazione del lutto». Oggi le indagini della procura di Caltanissetta
hanno svelato che a premere il pulsante che ha fatto esplodere l'auto carica di
esplosivo è stato Giuseppe Graviano, ma non si conosce il motivo che ha portato
ad accelerare la strage. Si è scoperto che nei 57 giorni che separano gli
attentati di Capaci e via d'Amelio uomini delle istituzioni hanno parlato con i
mafiosi, ma non si sa a cosa abbia portato questo "dialogo". Si è scoperto che
le indagini dopo l'attentato del 19 luglio 1992 sono state depistate, ma non è
stato individuato il movente. Nemmeno quello che ha portato tre pregiudicati a
raccontare bugie ai giudici, ad autoaccusarsi della strage e rischiare il
carcere a vita, a diventare falsi collaboratori di giustizia. I magistrati,
grazie alla collaborazione di Gaspare Spatuzza (senza le cui dichiarazioni,
riscontrate in tutti i punti, non sarebbe stato possibile avviare la nuova
inchiesta dopo le sentenze definitive sulla strage) e Fabio Tranchina, un
fedelissimo di Graviano, sono riusciti a trovare alcune tessere del mosaico che
dal '92 avevano impedito di ricostruire la trama dell'attentato. Un attentato
che a 24 anni di distanza ci continua a far star male, come dice Lucia
Borsellino, "per il semplice sospetto che uomini dello Stato abbiamo potuto
tradire un altro uomo dello Stato" e questo ci fa vergognare.
Un giorno chiesi a Borsellino, un altro che
conosceva la lingua siciliana, scrive Giorgio Bocca il 22 maggio 2002 su “La
Repubblica”: "Che rapporto c'è tra politica e mafia?". Mi rispose: "Sono due
poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio: o si fanno la guerra o
si mettono d'accordo. Il terreno su cui possono accordarsi è la spartizione del
denaro pubblico, il profitto illegale sui pubblici lavori". La frase detta da
Paolo Borsellino “Mafia e Stato sono due poteri su uno stesso territorio, o si
combattono o si mettono d’accordo.” Racchiude un’amara verità e riassume bene la
storia del nostro Paese. Storicamente si può dire che di trattative Stato-mafia
ce ne sono state varie. Sono iniziate dal 1861, con la nascita della Stato. Le
indagini a ritroso della Procura di Palermo sono arrivate fino ai torbidi
intrecci degli alleati con il bandito Salvatore Giuliano, che dopo la
liberazione nazi-fascista è stato anche utilizzato dalle
correnti filo-americane contro il “pericolo comunista”. La prima strage
stato-mafia fu a Portella della Ginestra e rientrava in questi piani.
SCADUTO IL SEGRETO DI STATO SU PORTELLA E
SULLA MORTE DI GIULIANO. Scrive Pino Sciumé il 5
luglio 2016 su “Siciliaonpress”. Mattina del 5 luglio 1950. A Castelvetrano, in
provincia di Trapani, in un cortile ubicato nella via Mannone, un corpo senza
vita, riverso bocconi e circondato da carabinieri, magistrati, giornalisti,
abitanti del posto, fu mostrato all’opinione pubblica come un trofeo di guerra,
la vittoria dello Stato contro il ricercato più pericoloso che per sette anni lo
aveva tenuto in pugno. Quel corpo era del “bandito” Salvatore Giuliano. Autori
della brillante operazione furono il Colonnello Ugo Luca e il Capitano Antonio
Perenze, quest’ultimo dichiaratosi autore materiale dell’eliminazione fisica
dell’imprendibile “re di Montelepre”. L’operazione militare, ordinata
direttamente dall’allora ministro degli Interni Mario Scelba, siciliano di
Caltagirone e inventore del famoso corpo di polizia denominato “La Celere”,
sembrò mettere a tacere per sempre la questione del banditismo siciliano che,
secondo le fonti governative, aveva provocato centinaia di morti nei sette anni
precedenti, culminati con la strage di Portella delle Ginestre in cui la banda
Giuliano provocò la morte di undici contadini e il ferimento di altre trenta
persone. Poco prima della morte di Giuliano era cominciato a Viterbo il processo
per la strage di Portella, definita da Scelba, opera di criminali comuni che
nulla avevano a che fare con i politici, gli agrari e la mafia. La Corte non si
preoccupò pertanto di ricercare eventuali mandanti, ma di accertare la
responsabilità personale degli esecutori comminando loro la giusta condanna. Due
anni dopo, dodici componenti della c.d. banda Giuliano furono condannati alla
pena dell’ergastolo, dodici e non undici, quanti erano effettivamente presenti
sul monte Pizzuta assieme a Giuliano. Ma uno in più, uno in meno… Le cronache di
quei tempi riferiscono che nessun siciliano credeva alla colpevolezza di
Giuliano perché quello di Portella era il suo popolo, la gente per cui aveva
lottato contro uno Stato da lui considerato nemico e da cui voleva che la
Sicilia si distaccasse. Umberto Santino, giornalista e attento osservatore, come
lo fu il coraggioso Tommaso Besozzi (autore dell’articolo: “Di sicuro c’è solo
che è morto” scritto all’indomani del 5 luglio 1950) così scrive in uno dei suoi
pezzi “La verità giudiziaria sulla strage si è limitata agli esecutori
individuati nei banditi della banda Giuliano. Nell’ottobre del 1951 Giuseppe
Montalbano, ex sottosegretario, deputato regionale e dirigente comunista,
presentava al Procuratore generale di Palermo una denuncia contro i monarchici
Gianfranco Alliata, Tommaso Leone Marchesano e Giacomo Cusumano Geloso come
mandanti della strage e contro l’ispettore Messana come correo. Il Procuratore e
la sezione istruttoria del Tribunale di Palermo decidevano l’archiviazione.
Successivamente i nomi dei mandanti circoleranno solo sulla stampa e nelle
audizioni della Commissione parlamentare antimafia che comincia i suoi lavori
nel 1963”. Ancora Umberto Santino, nei suoi articoli che fanno parte
dell’Archivio del compianto Professor Giuseppe Casarrubea, scrive: “Nel novembre
del 1969 il figlio dell’appena defunto deputato Antonio Ramirez si presenta
nello studio di Giuseppe Montalbano per recapitargli una lettera riservata del
padre, datata 9 dicembre 1951. Nella lettera si dice che l’esponente monarchico
Leone Marchesano aveva dato mandato a Giuliano di sparare a Portella, ma solo a
scopo intimidatorio, che erano costantemente in contatto con Giuliano i
monarchici Alliata e Cusumano Geloso, che quanto aveva detto, nel corso degli
interrogatori, il bandito Pisciotta su di loro e su Bernardo Mattarella era
vero, che Giuliano aveva avuto l’assicurazione che sarebbe stato amnistiato”. E
ancora: “Montalbano presenta il documento alla Commissione antimafia nel marzo
del 1970, la Commissione raccoglierà altre testimonianze e nel febbraio del 1972
approverà all’unanimità una relazione sui rapporti tra mafia e banditismo,
accompagnata da 25 allegati, ma verranno secretati parecchi documenti raccolti
durante il suo lavoro. La relazione a proposito della strage scriveva: “Le
ragioni per le quali Giuliano ordinò la strage di Portella della Ginestra
rimarranno a lungo, forse per sempre, avvolte nel mistero”. La Commissione
Parlamentare Antimafia istituì nel 1971 una sotto commissione sui fatti Portella
presieduta da Marzio Berardinetti che tra l’altro affermò: “Il lavoro, cui il
comitato di indagine sui rapporti fra mafia e banditismo si è sobbarcato in così
difficili condizioni, avrebbe approdato a ben altri risultati di certezza e di
giudizio se tutte le autorità, che assolsero allora a quelli che ritennero
essere i propri compiti, avessero fornito documentate informazioni e
giustificazioni del proprio comportamento nonché un responsabile contributo
all’approfondimento delle cause che resero così lungo e travagliato il fenomeno
del banditismo”. Per tali motivi, nell’intento di non andare oltre in
interrogatori che potevano portare a verità scomode fu apposto il Segreto di
Stato fino al 2016, fino a questo 5 luglio 2016, 66° anniversario della
messinscena della morte di Salvatore Giuliano. Abbiamo sentito il nipote
Giuseppe Sciortino Giuliano, figlio di Mariannina e sorella di Salvatore. “Noi
della famiglia siamo sicuri dell’estraneità di mio zio sui fatti di Portella.
Quella fu una Strage di Stato addossata ad arte a Giuliano. Le Autorizzo a
scrivere che noi conosciamo la verità fin dal 1965. Ora se lo Stato vuole aprire
quegli archivi che ben venga, anche se non credo ci possa essere ormai qualcosa
che non conosciamo. Ma dalla fine del prossimo settembre sarà in distribuzione
in tutta Italia prima e successivamente negli Stati Uniti, un Docufilm di circa
tre ore in formato DVD che farà conoscere al mondo intero la verità su mio zio
Salvatore Giuliano, eroe siciliano, colonnello dell’Evis, punto fermo
dell’ottenimento del mai attuato Statuto Siciliano, anche se lui ha sempre
lottato per l’Indipendenza della Sicilia”. Una pagina dell’Unità del 7 luglio
1950 mostra la cronaca della morte di Salvatore Giuliano. Potrà essere risolto
nel 2016, allorché cadrà il segreto di stato sulle carte conservate negli
archivi dei ministeri dell’interno e della difesa, il giallo sulla morte del
bandito Giuliano, uno dei tanti misteri della storia italiana sui quali
recentemente la magistratura è tornata ad indagare. Ne è convinto Giuseppe
Sciortino Giuliano, nipote di Salatore Giuliano, che ha appena pubblicato un
libro (“Vita d’inferno. Cause ed affetti”) che si chiude con una ricostruzione
secondo la quale il cadavere mostrato all’epoca alla stampa non sarebbe stato
quello del celebre bandito, bensì di un sosia.
Montelepre: una “Vita D’inferno”.
Ricordato Salvatore Giuliano, nel 60° anniversario della morte, con una
pubblicazione del nipote Pino Sciortino Giuliano. La vicenda di Salvatore
Giuliano ci riporta ad anni particolarmente “inquieti”, complessi, della storia
della Sicilia e, nonostante gli innumerevoli fiumi d’inchiostro versati, su quei
fatti permangono ancora molte zone d’ombra. Sono gli anni dello sbarco degli
Alleati, del separatismo, della ribellione civile frettolosamente etichettata
come bieco “banditismo”. Un groviglio di rapporti nebulosi – tra americani e
mafia, tra patiti politici e mafia, tra Giuliano e politici senza scrupoli –,
pose le basi della nascente Repubblica Italiana. Allora tutti si incontrarono,
dialogarono e si accordarono: aristocratici, politici, intellettuali, operai,
contadini, servizi segreti internazionali, forze di polizia e banditi. Il “caso”
Giuliano servì a ognuno fino a quando considerarono conveniente l’accordo, poi…
la mattina fatidica del 5 Luglio del 1950, in un cortile di Castelvetrano, il
“presunto” corpo di Turiddu venne trovato crivellato di colpi, in seguito, ad un
falso conflitto a fuoco sostenuto dagli agenti del Cfrb, e nell’arco di appena
un decennio tanti possibili testimoni uscirono di scena con morti alquanto
misteriose. In pochi si salvarono affrontando il carcere duro e solo pochissimi
resistettero e tornarono a casa a fine pena. Seguì l’inevitabile volontario
silenzio degli esigui superstiti. A 60 anni dalla morte del leggendario
colonnello dell’Evis, il nipote di Salvatore Giuliano, Giuseppe Sciortino
Giuliano, figlio della sorella del bandito, Mariannina, ha presentato lo scorso
5 luglio (data ufficiale della morte di Turiddu), ad un folto pubblico
proveniente da tutta la Sicilia ed anche dall’estero, l’ultimo suo libro “Vita
d’Inferno - Cause ed effetti”. Un’opera che racconta la vita degli abitanti di
Montelepre, paese natale di Giuliano, dal 1943 al 1950, periodo di forti
tensioni politiche e civili, caratterizzato da arresti ingiustificati, false
accuse e vessazioni da parte dello Stato nei confronti della popolazione
contadina dell’area monteleprina, posta in continuo stato d’assedio ed
ingiustamente colpevolizzata. «Un pregevole recupero della verità storica,
troppo spesso mistificata dalla storiografia ufficiale (figlia faziosa dei
poteri imperanti) – ha evidenziato il relatore, prof. Salvatore Musumeci,
giornalista ed esperto di storia della Sicilia, tra l’altro presidente nazionale
del Mis –, che malgrado tutto si è mantenuta, pur rimanendo per parecchio tempo
in uno stato di oblio. Su Salvatore Giuliano molto è stato scritto con lo scopo
di intorpidire le acque. Oggi più che mai, mentre si celebrano i falsi miti dei
150 di Stato unitario, Montelepre, e non tanto la sola figura di Turiddu, ha
bisogno di conoscere e di riappropriarsi della verità storica, perché per quegli
eventi è stata colpevolizzata un’intera cittadina che nulla aveva a che fare con
gli accadimenti che travolsero Giuliano. Ai monteleprini è successo ciò che
accadde ai meridionali all’indomani della forzata annessione piemontese e per
spiegarlo cito un pensiero di Pino Aprile (dal suo recente Terroni): “È accaduto
che i (monteleprini) abbiano fatto propri i pregiudizi di cui erano oggetto. E
che, per un processo d’inversione della colpa, la vittima si sia addossata
quella del carnefice. Succede quando il dolore della colpa che ci si attribuisce
è più tollerabile del male subìto. Così, la resistenza all’oppressore, agli
stupri, alla perdita dei beni, della vita, dell’identità, del proprio paese, è
divenuta vergogna”». Fatti analoghi sono stati vissuti da Ciccu Peppi, il
protagonista del libro “Vita d’Inferno - Cause ed effetti”, e da tre quarti
della popolazione monteleprina continuamente vessata dal famigerato “don
Pasquale”, il brigadiere Nicola Sganga, e dallo “Sceriffo”, il maresciallo
Giovanni Lo Bianco (ambedue appartenenti alla Benemerita). Sciortino, inoltre,
descrive le ipotesi più attendibili sull’uccisione di Giuliano e una
ricostruzione delle circostanze in cui morì Gaspare Pisciotta, braccio destro
del bandito, avvelenato in cella il 9 febbraio 1954. Parla anche della strage di
Portella della Ginestra e di come la banda Giuliano sarebbe stata oculatamente
coinvolta al fine di giustificare il massacro. In appendice, il volume contiene
una poesia scritta da un componente della Banda Giuliano, Giuseppe Cucinella che
ha ispirato l’opera di Giuseppe Sciortino Giuliano. «La poesia – ha sottolineato
l’autore –, è stata in qualche modo ispiratrice della stesura del libro. Devo
molta riconoscenza alla figlia di Giuseppe Cucinella (la signora Giusi
Cucinella, ndr), che me l’ha messa a disposizione ed io ho voluto farle il
regalo di inserirla all’interno del libro. Proprio, perché dalla lettura di
questa poesia si vede il patriottismo di quest’uomo, che era comune anche a
tutti gli altri, e ciò per dimostrare che gli uomini di mio zio non erano
volgari delinquenti ma gente che aveva un ideale e combatteva per questo ideale.
All’interno della mia famiglia mi sono dovuto caricare di una responsabilità
enorme, perché dovevo in qualche modo rimuovere la macchia nera di Portella
delle Ginestre che aveva colpevolizzato un’intera comunità. Per cui io stesso
sono diventato ricercatore della verità e man mano che gli uomini di mio zio
uscivano dal carcere li avvicinavo, chiedevo, li intervistavo perché volevo
capire, io per primo, quello che veramente era successo in quegli anni. Questo
mi ha permesso di avere una cognizione di causa sull’argomento e sulla vita in
generale di mio zio e di tutto il periodo storico e, quindi, ho potuto scrivere
diversi volumi (Mio fratello Salvatore Giuliano, scritto assieme alla madre
Mariannina, e Ai Siciliani non fatelo sapere, ndr)». Allo storico monteleprino,
prof. Pippo Mazzola, abbiamo chiesto: quali nuove verità apprenderemo nel 2016
quando verranno desecretati i faldoni del fondo Giuliano? «Sicuramente nessuna –
sorride ironico il Mazzola –. Sappiamo da fonti attendibilissime che nel corso
degli anni, via via, sono spariti tutti i documenti compromettenti, tra cui il
fascicolo 29 C contenente il memoriale di Gaspare Pisciotta e i suoi quattordici
quaderni. Pare che siano scomparsi durante il governo D’Alema. Oggi non possiamo
provarlo, ma chi vivrà vedrà». Prima di lasciare Montelepre ci fermiamo per
qualche attimo al Cimitero. Incontriamo una comitiva ed una graziosa ragazza ci
chiede: «Excuse me, here is the tomb of Salvatore Giuliano?».
Rispondiamo: «Yes, in the chapel on the left
most». Ci ringrazia e l’ascoltiamo spiegare: «Giuliano was a hero who fought for
the Sicily against the abuses of the Italian State. For the Sicily’s
independence. Too bad that Sicilians like him there are not more!».
Lasciamo ai lettori il piacere della traduzione. Giuseppe
Musumeci. Pubblicato su “Gazzettino”, settimanale regionale, Anno XXX, n. 25,
Giarre sabato 10 luglio 2010
Ernesto "Che" Guevara: la verità rossa e
la verità vera, scrive “Cumasch”. La storia dovrebbe
essere oggettiva, ma in realtà alcuni aspetti vengono da sempre distorti e
adattati alle convinzioni ideologiche di chi li tratta. In un paese che si
definisce antifascista (ma non evidentemente anticomunista...) certi aspetti
"scomodi" del Comunismo sono da sempre ignorati. La Storia ne è piena: i
massacri delle Foibe, i massacri dei 20.000 soldati italiani nei Gulag Sovietici
su ordine di Togliatti, ecc...La storia di Ernesto Guevara rappresenta forse il
più grande falso storico mai verificatosi. Tutti conoscono la storia "ufficiale"
del Che. Chi non ha mai sentito parlare del "poeta rivoluzionario?" Del "medico
idealista"? Ma chi conosce le reali gesta di questo "eroe"? Da tempo immemore il
volto leonino di Ernesto “Che” Guevara compare su magliette e gadgets, in
ossequio all’anticonsumismo rivoluzionario. La fortuna di quest’eroe della
revoluçion comunista è dovuto a due coincidenze: 1) – “Gli eroi son sempre
giovani e belli” (La locomotiva – F. Guccini); come ironizzò un dirigente del
PCI nel ’69, se fosse morto a sessant’anni e fosse stato bruttarello di certo
non avrebbe conquistato le benestanti masse occidentali di quei figli di papà
“marxisti immaginari”. 2) – l’ignoranza degli estimatori di ieri e di oggi. Il
“Che”, infatti, viene associato a tutto quanto fa spettacolo nel grande circo
della sinistra: dal pacifismo antiamericano alle canzoni troglodite di Jovanotti
«sogno un’unica chiesa che va da Che Guevara a Madre Teresa». Meglio allora fare
un po’ di chiarezza sulla realtà del personaggio: Ernesto Guevara De la Serna
detto il “Che” nasce nel 1928 da una buona famiglia di Buenos Aires. Agli inizi
degli anni 50 si laurea in medicina e intanto con la sua motocicletta gira in
lungo e in largo l’America Latina. In Guatemala viene in contatto con il
dittatore Jacobo Arbenz, un approfittatore filosovietico che mantiene la
popolazione in condizioni di fame e miseria, ma che gira in Cadillac e abita in
palazzotti coloniali. A causa dei forti interessi economici degli Usa in
Guatemala, viene inviato un contingente mercenario comandato da Castillo Armas a
rovesciare il dittatore. Il “Che”, anziché sacrificarsi a difesa del “compagno”,
scappa e si rifugia nell’ambasciata argentina; di qui ripara in Messico dove, in
una notte del 1955, incontra un giovane avvocato cubano in esilio che si prepara
a rientrare a Cuba: Fidel Castro. Subito entrano in sintonia condividendo gli
ideali, il culto dei “guerriglieri” e la volontà di espropriare il dittatore
Batista del territorio cubano. Sbarcato clandestinamente a Cuba con Fidel, nel
1956 si autonomina comandante di una colonna di “barbudos” e si fa subito notare
per la sua crudeltà e determinazione. Un ragazzo non ancora ventenne della sua
unità combattente ruba un pezzo di pane ad un compagno. Senza processo, Guevara
lo fa legare ad un palo e fucilare. Castro sfrutta al massimo i nuovi mezzi di
comunicazione e, pur a capo di pochi e male armati miliziani, viene innalzato
agli onori dei Tg e costruisce la sua fama. Dopo due anni di scaramucce per le
foreste cubane, nel ’58 l’unità del “Che” riporta la prima vittoria su Batista.
A Santa Clara un treno carico d’armi viene intercettato e cinquanta soldati
vengono fatti prigionieri. In seguito a ciò Battista fugge e lascia l’Avana
sguarnita e senza ordini. Castro fa la sua entrata trionfale nella capitale
accolto dalla popolazione festante. Una volta rovesciato il governo di Batista,
il Che vorrebbe imporre da subito una rivoluzione comunista, ma finisce con lo
scontrarsi con alcuni suoi compagni d'armi autenticamente democratici. Guevara
viene nominato “procuratore” della prigione della Cabana ed è lui a decidere le
domande di grazia. Sotto il suo controllo, l’ufficio in cui esercita diventa
teatro di torture e omicidi tra i più efferati. Secondo alcune stime, sarebbero
stati uccise oltre 20.000 persone, per lo più ex compagni d’armi che si
rifiutavano di obbedire e di piegare il capo ad una dittatura peggiore della
precedente. Nel 1960 il “pacifista” GUEVARA, istituisce un campo di
concentramento ("campo di lavoro") sulla penisola di Guanaha, dove trovano la
morte oltre 50.000 persone colpevoli di dissentire dal castrismo. Ma non sarà il
solo lager, altri ne sorgono in rapida successione: a Santiago di Las Vegas
viene istituito il campo Arca Iris, nel sud est dell’isola sorge il campo Nueva
Vida, nella zona di Palos si istituisce il Campo Capitolo, un campo speciale per
i bambini sotto i 10 anni. I dissidenti vengono arrestati insieme a tutta la
famiglia. La maggior parte degli internati viene lasciata con indosso le sole
mutande in celle luride, in attesa di tortura e probabile fucilazione. Guevara
viene quindi nominato Ministro dell’Industria e presidente del Banco Nacional,
la Banca centrale di Cuba. Mentre si riempie la bocca di belle parole, Guevara
sceglie di abitare in una grande e lussuosa casa colonica in un quartiere
residenziale dell’Avana. E' facile chiedere al popolo di fare sacrifici quando
lui per primo non li fa: pratica sport borghesissimi, ma la vita comoda e l’ozio
ammorbidiscono il guerrigliero, che mette su qualche chilo e passa il tempo tra
parties e gare di tiro a volo, non disdegnando la caccia grossa e la pesca
d’altura. Per capire quali "buoni" sentimenti animassero questo simbolo con cui
fregiare magliette e bandiere basta citare il suo testamento, nel quale elogia
«l’odio che rende l’uomo una efficace, violenta, selettiva e fredda macchina per
uccidere». Sono queste le parole di un idealista? Di un amico del popolo? Se si,
quale popolo? Solo quello che era d'accordo con lui? Guevara si dimostra una
sciagura come ministro e come economista e, sostituito da Castro, viene da
questi “giubilato” come ambasciatore della rivoluzione. Nella nuova veste di
vessillifero del comunismo terzomondista lancia il motto «Creare due, tre, mille
Vietnam!». Nel 1963 è in Algeria dove aiuta un suo amico ed allievo, lo
sterminatore Desirè Kabila (attuale dittatore del Congo) a compiere massacri di
civili inermi! Il suo continuo desiderio di diffusione della lotta armata e un
tranello di Castro lo portano nel 1967 in Bolivia, dove si allea col Partito
comunista boliviano ma non riceve alcun appoggio da parte della popolazione
locale. Isolato e braccato, Ernesto De La Serna viene catturato dai miliziani
locali e giustiziato il 9 ottobre 1967. Il suo corpo esposto diviene un’icona
qui da noi e le crude immagini dell’obitorio vengono paragonate alla
“deposizione di Cristo”. Fra il sacro e il profano la celebre foto del “Che” ha
accompagnato un paio di generazioni che hanno appeso il suo poster a fianco di
quello di Marylin Monroe. Poiché la madre degli imbecilli è sempre incinta,
ancora oggi sventola la bandiera con la sua effige e i ragazzini indossano la
maglietta nel corso di manifestazioni “contro la guerra”. Come si fa a prendere
come esempio una persona così? Possibile che ci siano migliaia di persone
(probabilmente inconsapevoli della verità) che sfoggiano magliette con il suo
volto? In quelle bandiere e magliette c'è una sola cosa corretta: il colore.
Rosso, come il sangue che per colpa sua è stato sparso. In un film di qualche
anno fa Sfida a White Buffalo, il bianco chiede al pellerossa: «Vuoi sapere la
verità rossa oppure la verità vera?». Lasciamo a Gianni Minà la verità rossa,
noi preferiamo conoscere la verità vera.
PARLIAMO DI MASSONERIA, MAFIA ED ANTIMAFIA.
Il caso Cucchi e i segreti
della massoneria.
Del collegio di esperti che dovrà fare la nuova perizia sul corpo
di Stefano fa parte un professore ex massone. "In sonno" dal 1983. Sulla vicenda
è stata aperta un'indagine, ora archiviata. Ma la procura ha acquisito i
documenti ufficiali della Loggia di Bari. Dal giuramento alla costituzione
massonica. Materiale inedito e segreto che apre le porte del Grande oriente,
scrive Giovanni Tizian il 12 aprile 2016 su "L'Espresso". «Certificato di
apprendista numero 33547. Loggia Saggezza Trionfante 984 Bari. Grande Oriente
d'Italia. Con fraterni saluti». Il documento del 1980 attesta l'affiliazione di
Francesco Introna, ordinario di Medicina Legale dell'Università di Bari. Perito
in importanti processi, come il caso Claps, consulente di parte per Raffaele
Sollecito. E nominato nel collegio dei periti per l'incidente probatorio
nell'inchiesta bis sulla morte di Stefano Cucchi che vede indagati cinque
carabinieri. E proprio in quest'ultima sede, durante la prima udienza,
l'avvocato Fabio Anselmo della famiglia Cucchi ha sollevato la questione
dell'incompatibilità di Introna vista la sua presunta fede massonica e la
passata candidatura nel 2009 nelle fila del Pdl alle comunali di Bari. Fazione
politica che su Stefano Cucchi ha dimostrato, con dichiarazioni e prese di
posizione, una profonda ostilità. L'affiliazione massonica del perito è finita
così in una denuncia presentata in procura dalla famiglia del geometra romano.
Dopo un'approfondita verifica di atti e documenti, l'indagine è stata chiusa e
per Introna è stata richiesta l'archiviazione: «L'accusa non potrebbe essere
sostenuta in giudizio per evidente carenza dell'elemento soggettivo del delitto
ipotizzato». In pratica, Introna, ha sì dichiarato il falso davanti al giudice,
affermando di non essere nemmeno più “in sonno”, ma l'ha fatto senza dolo.
Perché convinto di quella sua affermazione. Introna è stato un libero muratore
ufficialmente fino al 1983. Poi, come emerge dai documenti acquisiti dai
magistrati, risulta “assonnato”. Non c'è dunque motivo per dubitare della buona
fede del professore. Potrà così continuare a fare parte del pool che dovrà
svolgere una nuova perizia sul corpo di Stefano Cucchi, morto nell'ottobre 2009
dopo l'arresto per possesso di droga. Messa da parte la vicenda specifica, il
materiale inviato dal Grande Oriente ai pm del caso Cucchi apre le porte di un
mondo misterioso e segreto. Tessere di iscrizione, codici scritti, la
costituzione massonica, elenchi, simboli esoterici e timbri ufficiali di maestri
venerabili. Tutto materiale che “l'Espresso” ha potuto consultare. «Mi laureai
nel 1979, e quell'anno all'interno dell'istituto di Medicina Legale di Bari
conobbi due colleghi, i quali erano iscritti alla Loggia Saggezza Trionfante.
Uno di questi si chiamava Roberto Gagliano Candela (medico luminare ndr).
Sentendoli parlare della Loggia ritenni l'argomento interessante e, presentato,
da questi due colleghi mi iscrissi alla medesima nel 1980». Francesco Introna
ripercorre davanti ai magistrati romani i giorni del reclutamento massonico.
«Aggiungo che la mia convinzione di essere stato espulso dalla massoneria
risultava confermata dal fatto che un paio di anni fa ricevetti l'onorificenze
di Commendatore per meriti professionali e in questo caso la mia persona fu
oggetto di accertamenti da parte dei carabinieri su incarico della prefettura.
Perciò ritengo che se io fossi stato in “sonno” questa circostanza sarebbe
venuta fuori. Invece i carabinieri non mi chiesero nulla». Sul significato
dell'essere “assonnato” gli inquirenti chiedono spiegazioni al gran maestro del
Goi, Stefano Bisi. Convocato a piazzala Clodio negli uffici della procura
risponde dettagliatamente alle domande. «La collocazione in “sonno” viene
comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno. I fratelli attivi
partecipano alle riunioni e pagano una quota, il fratello in “sonno” e quello
depennato hanno comunque l'obbligo di lealtà nei confronti degli altri fratelli,
così come risulta dall'articolo 9 della Costituzione del Grande oriente
d'Italia». Poi, Bisi, riferisce delle quote d'iscrizione: «L'importo dovuto è
predeterminato, non si tratta comunque di importi considerevoli, vari da 400 a
500 euro l'anno, a seconda della singola loggia. «Io Francesco Introna
liberamente, spontaneamente, con piano e profondo convincimento dell'animo, con
assoluta e irremovibile volontà, alla presenza del Grande Architetto
dell'Universo, sul mio onore e in piena coscienza solennemente giuro: di non
palesare i segreti dell'iniziazione muratoria, di aver sacri l'onore e la vita
di tutti; di soccorrere, confortare e difendere i miei fratelli; di non
professare principi che osteggiano quelli propugnati dalla Libera Muratoria». Il
giuramento è impresso su una pergamena con la firma del venerabile maestro. E
risale al 1980. L'atto ufficiale è successivo alla votazione, con scrutinio
delle schede su cui ogni fratello vota il “gradimento” del nuovo adepto. A
seguire il testamento, altro passaggio fondamentale per entrare a far parte
della loggia. Si tratta di una seconda pergamena in cui l'iniziato risponde alle
domande sulle regole di comportamento generale che i fratelli devono tenere:
«Quali sono i doveri dell'uomo verso se stesso? Migliorarsi in continuazione;
Quali sono i doveri verso la Patria? Amarla. Rispettarla; Quali sono i doveri
verso l'umanità? Porsi al suo servizio per essere utile». Di Dio e la religione;
Del magistrato civile supremo e subordinato; Delle Logge; Dei maestri,
sorveglianti, compagni e apprendisti; Della condotta dell'Arte nel lavoro; Del
Comportamento. Questi sono i titoli generali della Costituzione della libera
muratoria del Goi. Al punto 3 del capitolo sul Comportamento è spiegato
l'atteggiamento da tenere nel caso in cui due “fratelli” si incontrano non in
una loggia e senza estranei: «Vi dovete salutare l'un l'altro in modo cortese,
chiamandovi fratello l'un l'altro, liberamente fornendovi scambievoli istruzioni
che possano essere utili, senza essere visti o uditi e senza prevalere l'uno
sull'altro o venendo meno al rispetto dovuto a ogni fratello». Al punto
successivo, invece, le istruzioni sul come comportarsi in presenza di non
massoni: «Sarete cauti nelle vostre parole e nel vostro portamento affinché
l'estraneo più accorto non possa scoprire o trovare quando non è conveniente che
apprenda; e talvolta dovrete sviare un discorso e manipolarlo prudentemente per
l'onore della rispettabile Fratellanza». Ma cosa fare davanti a uno straniero?
«Lo esaminerete cautamente, conducendovi secondo un metodo di prudenza, affinché
non siate ingannati da un ignorante falso pretendente, che dovrete respingere
con disprezzo e derisione». Se lo straniero è degno di affiliazione, invece,
cambia tutto: «Dovete allora rispettarlo e se egli ha bisogno dovete aiutarlo se
potete oppure indirizzarlo dove possa venire aiutato: dovete occuparlo per
qualche giornata di lavoro oppure raccomandarlo perché venga occupato. Ma non
siete obbligato a fare oltre la vostra possibilità». Può anche succedere però un
litigio tra fratelli o tra affiliati e “stranieri”. Che fare? Anche per questo
il regolamento è chiaro: «Non consentite agli altri di diffamare qualsiasi
onesto fratello...E se qualcuno vi ingiuria dovete rivolgervi alla vostra o alla
sua loggia e dopo appellarvi alla Gran Loggia annuale, come è stato l'antico
lodevole costume dei nostri antenati in ogni nazione. Non dovete intraprendere
un processo legale a meno che il caso non possa venire risolto in altro modo e
pazientemente affidatevi all'onesto e amichevole consiglio del Maestro e dei
Compagni, allorché essi vogliono evitare che voi compariate in giudizio contro
estranei...Amen così sia». Insomma, le questioni è meglio risolverle in Loggia.
Tra fratelli. I liberi muratori una volta giurato sono sottoposti alla giustizia
massonica dell'Ordine: «E vi restano soggetti anche se non più attivi». È
l'articolo 56 del titolo X, “Della Giustizia massonica”, della costituzione del
Goi. I fratelli possono sbagliare, come tutti gli esseri umani. Perciò il
regolamento prevede delle “colpe massoniche” e pene collegate. «Costituiscono
colpa massonica: ogni azione contraria alla lealtà, all'onore o alla dignità
della persona umana». I provvedimenti sono tre: Espulsione, censura solenne e
censura semplice. A giudicare i cattivi massoni sono gli organi interni: il
tribunale della loggia; tribunale dei Colleggi dei maestri venerabili; la corte
centrale del Grande oriente. Fidarsi l'uno dell'altro. Per chi è dentro una
loggia, questo è un presupposto imprescindibile. La fiducia deriva dalla
modalità “sicura” di affiliazione. Il neofita è sempre presentato da almeno tre
fratelli anziani. Ognuno dei quali deve mettere per iscritto, su un modulo, le
motivazioni della scelta. Tendendo però presente le regole del buon massone:
«Moralità, costumi e reputazione; probità costante nel corso della vita;
esattezza nel disimpegno dei doveri del proprio stato; fermezza di carattere nei
principi professati; cultura, impegno, attitudini a penetrare e assimilare la
dottrina massonica». Inoltre, chi presenta il nuovo arrivato deve specificare se
questo appartiene «ad associazioni di carattere ricreativo, filantropico,
benefico, religioso, politico, culturale o di altra natura; se ha avuto
eventuali cariche in enti e altre notizie eventuali sulla persona». La
radiografia del pretendente è approfondita. Ma spesso, come ha insegnato la
storia passata e recente, non è stata sufficiente a rintracciare “l'intruso”,
con interessi che poco hanno a che fare con la il rispetto dell'umanità.
Papà Boschi e l'ombra della
massoneria.
Da
vicepresidente di Etruria per scegliere il suo dg incontrò Carboni, coinvolto
nel caso P3. Ma ha sostenuto di non avere deleghe operative, scrive Massimo
Malpica, Domenica 17/01/2016, su "Il Giornale". Non bastasse il caos prodotto
dal crac di Banca Etruria e dal successivo decreto salva banche del governo che
ha lasciato in mutande i risparmiatori, ora saltano fuori anche le «consulenze»
a Bpel in odore di grembiulini e servizi richieste e ottenute - da papà Boschi
per individuare il nuovo dg dell'istituto da nominare al posto di Luca Bronchi.
L'ex vicedirettore di Banca Etruria e papà del ministro per le riforme Maria
Elena, a metà 2014, chiese dunque una mano nientemeno che a Flavio Carboni, uomo
di affari (spesso chiacchierati), indagato per la presunta loggia P3 e il cui
nome è emerso in tutti i gialli del Bel Paese degli ultimi lustri. L'altro
consulente non ortodosso era un caro amico comune, che risponde al nome di
Valeriano Mureddu. Vicino di casa della famiglia Renzi a Rignano e figlio di un
pastore sardo emigrato in Toscana a fine anni '60, anche Mureddu che sostiene
tra l'altro di aver lavorato per la nostra intelligence - ha qualche magagna con
la giustizia, sia per una sospetta maxievasione fiscale (con tanto di
dossieraggio a carico di vari personaggi ritrovati nella sede aretina della sua
società che si occupa di materie plastiche) risalente all'inizio del 2014, che
per violazione della legge Anselmi. A Repubblica, Mureddu nega di essere
Massone, mentre intervistato dalla Nazione ammette di aver «lavorato» per conto
delle nostre barbe finte. Nel 2010, peraltro, di Mureddu si parlò già per un
abbocco con il suocero di Fini, Sergio Tulliani, relativo agli affari nel
fotovoltaico (tra l'altro proprio il settore al centro di uno dei filoni delle
indagini sulla presunta P3). Quando nell'estate del 2014 Boschi senior si affida
a questo curioso duo, incontrando Mureddu nell'ufficio romano a disposizione di
Carboni, il nome che salta fuori è quello di Matteo Arpe. A suggerirlo a Carboni
sarebbe stato l'ex leghista Gianmario Ferramonti. Ma la consulenza al gusto di
massoneria (per la verità non certo una novità per Bpel, sempre divisa tra
cattolici e grembiulini) non porterà frutti, visto che ad agosto dello scorso
anno la poltrona di dg andò a Daniele Cabiati, rimasto in carica fino allo
scorso giugno.Zero risultati, appunto, ma nuovi scenari imbarazzanti per il
governo a margine del patatrac di Banca Etruria. Boschi senior, più che un
vicepresidente senza deleghe e senza potere, appare come uno dei capi effettivi
della banca, proprio come indicato dalle relazioni di Bankitalia che parlavano
di un «direttivo» ristretto che di fatto comandava dentro Bpel. Tanto che,
stando ai racconti di Carboni e dello stesso Mureddu, il papà della Boschi s'era
messo a lavorare informalmente all'individuazione di un ruolo chiave per
l'istituto di credito che stava affondando. Incaricando dopo una cena proprio
Mureddu, che sarà anche figlio di un pastore e dunque coerente con il quadretto
bucolico tracciato dalla figlia nella appassionata autodifesa di famiglia in
occasione del voto di sfiducia ma che è anche vicino di Tiziano Renzi,
amicissimo di Carboni e legato, secondo quanto Carboni ha raccontato a Libero,
anche dell'ex presidente di Bpel Lorenzo Rosi. Sempre Carboni, precisando che a
darsi da fare sarebbe stato soprattutto Mureddu, aggiunge anche che oltre alla
nomina del direttore generale ci sarebbe anche stata una richiesta per
individuare «qualche stato estero che intervenisse a favore di questo gruppo».Si
delinea insomma un nuovo fronte temporalesco per il governo, in particolare per
la Boschi, che appena qualche mese fa al capogruppo M5S Gianluca Castaldi che
evocava «indicibili accordi massonici» dietro alla riforma costituzionale, urlò:
«Massone lo dici a tua sorella». Beccandosi una bacchettata del Gran Maestro del
Grande Oriente d'Italia, Stefano Bisi: «Frase sgradevole, mi sorprende che sia
stata proprio lei a pronunciarla». Ma oltre ai guai per l'esecutivo, sembrano
confermati anche gli scenari ancora in parte oscuri celati dietro ai freddi
numeri (fallimentari) che raccontano la storia di Banca Etruria. Da sempre, come
detto, divisa tra l'anima cattolica e quella massonica che per anni, durante la
gestione di Elio Faralli, aveva imperversato nel governo della ex mutua
dell'oro, prima di lasciare le redini al gruppo dirigente espressione della ex
democrazia cristiana. Ma, a quanto pare, le cointeressenze non si sono mai
spezzate.
La strana loggia top secret
dell'amico dei papà illustri.
Il massone
Mureddu è legato ai padri di Renzi e della Boschi. E la sua società occulta è
nel mirino dei pm di Perugia da 2 anni, scrive Luca Fazzo, Lunedì 18/01/2016, su
"Il Giornale". Ci sono logge e logge: quelle che al primo inciampo in una
inchiesta finiscono in prima pagina sui giornali, e altre la cui esistenza viene
invece tenuta rispettosamente lontano dai riflettori, anche dopo il loro
ingresso in un fascicolo processuale. A restare a lungo sotto traccia è stata,
per esempio, la associazione segreta che ruota intorno all'imprenditore aretino
Valeriano Mureddu, buon amico sia del padre di Matteo Renzi, presidente del
Consiglio, che di quello di Maria Elena Boschi, ministro delle Riforme.Degli
intrecci tra Mureddu e i due illustri papà si parla finalmente da qualche
giorno, e negli ambienti governativi l'imbarazzo è pari solo al silenzio. Ma ora
si scopre che da quasi due anni, da marzo 2014, la procura di Perugia ha in mano
tutte le carte relative alla società occulta guidata da Mureddu, avendole
trovate nel corso di una perquisizione presso la sua azienda a Civitella Val di
Chiana, una dittarella di nome Geovision specializzata nel commercio di
sacchetti e altri articoli in plastica. Ma la modestia dei suoi affari ufficiali
non impedisce a Mureddu di allacciare amicizie importanti. Con Tiziano Renzi è
praticamente compaesano, avendo vissuto a lungo a Rignano sull'Arno, mentre con
Pierluigi Boschi ha stretto amicizia quando il padre di Maria Elena invece che
di banche si occupava di vini e cantine sociali. E nei due anni trascorsi dalla
scoperta delle carte segrete, gli amiconi di Mureddu hanno continuato a fare
carriera. Compresi Tiziano Renzi, Pierluigi Boschi, e soprattutto i loro
brillanti figlioli. Eppure nella carte dell'inchiesta della procura umbra
compaiono nomi che sono presenze fisse delle indagini che periodicamente, dagli
anni '80 in poi, portano alla ribalta l'esistenza di consorterie segrete. Nei
contatti di Mureddu c'è per esempio quel Gianmario Ferramonti, politico di
insuccesso in area leghista, che esattamente 20 anni fa fu indicato in una
indagine della procura di Aosta (battezzata Phoney Money, e finita in nulla)
come uomo-cerniera di affari leciti e illeciti che coinvolgevano mezzo
firmamento politico dall'Italia all'America; e tra i contatti c'è anche quel
Flavio Carboni che era già nelle liste P2, che fu condannato per il crac del
Banco Ambrosiano, e che a 84 anni continua a mantenere buoni rapporti con
l'Italia che conta: compreso uno dei grandi alleati di Renzi, l'ex coordinatore
di Forza Italia Denis Verdini, imputato insieme a lui nel processo P3. Cosa
facciano tutti insieme Mureddu, Ferramonti, Carboni e i loro amici, quale sia il
core business della nuova loggia scoperta dalla procura di Perugia, è tema un
po' fumoso: Mareddu si proclama massone e si vanta di avere lavorato per i
servizi segreti, non si capisce per quali e in che veste. «Ho relazioni in giro
per il mondo - dice di sé - mi vengono proposti degli affari e io a mia volta li
propongo a chi penso che possa portarli a termine». Un faccendiere, insomma.
Affari non sempre fortunati e cristallini, visto che anche la procura di Arezzo
ha messo il 46enne sardo nel mirino per evasione fiscale. E tra gli affari di
Mureddu, quello che ora lo ha portato alla ribalta è quello combinato per conto
di Pierluigi Boschi, all'epoca in cui il padre della ministra cercava un
direttore generale da piazzare nella Banca dell'Etruria. Come e perché babbo
Boschi si sia ridotto a cercare la consulenza di uno come Mureddu è allo stato
inspiegabile, e ancora di più lo è la circostanza che si sia fatto convincere a
partecipare a un summit nell'ufficio romano di Carboni. E ad accogliere l'idea
suggerita dalla coppia Mureddu-Carboni, quella del banchiere Fabio Arpe, portata
all'esame del cda, ma bloccata poi dall'ufficio di vigilanza della Banca
d'Italia.
L'imprenditore Starace a Libero: "Vi
spiego come Flavio Carboni lavorava per papà Boschi",
scrive di Giacomo Amadori su “Libero Quotidiano del 20 gennaio 2016. Da ragazzo
spaccava ossa giocando a rugby nelle Fiamme oro della Polizia di Stato, oggi le
aggiusta nei centri di riabilitazione di cui è proprietario. La voce è gioviale:
«Premetto: non sono massone. Io non c’entro nulla». Inizia così la conversazione
con il quarantaduenne romano Riccardo Starace, l’uomo che avrebbe dovuto trovare
un direttore generale e un fondo arabo per salvare la Banca dell’Etruria.
Lei conosce Valeriano Mureddu, il «grembiulino»
indagato a Perugia per associazione segreta e amico di Flavio Carboni?
«Non l’ho mai visto. Carboni invece lo avevo
conosciuto, due settimane prima degli incontri dell’estate del 2014 di cui voi
di Libero state scrivendo in questi giorni, al Piccolo mondo antico, un
ristorante vicino al suo ufficio romano di via Ludovisi. Il proprietario del
locale mi presentò questo signore anziano... era con la figliola».
Lei sapeva chi fosse Carboni?
«All’inizio no, ammetto la mia ignoranza (ride
ndr). Il mio amico mi disse: “Guarda Riccardo è una persona con una grande
esperienza, ti può essere utile conoscerlo”. Ho detto: “Va bene”. È cominciata
così questa storia».
Perché è rimasto in contatto con Carboni?
«Chiacchierando gli dissi che avevo rapporti con
un fondo impegnato nel settore della sanità, l’Enterprises di Sheikh Bin Ahmed
Al Hamed. Allora mi parlò subito di un suo progetto, il grafene, un materiale
rivoluzionario che dovrebbe servire a pulire e rendere potabile l’acqua,
risolvendo il problema della sete in Africa, e mi disse di andare a trovarlo in
ufficio. Il suo fu in pratica un monologo. Però prima di andare controllai su
Internet chi fosse e vidi che era una persona di un certo peso per la storia
dell’Italia, nel bene e nel male».
Ha una condanna di tipo definitivo per il crac
del Banco Ambrosiano ed è imputato per la P3...
«Ecco... appunto. Si trattava di cose abbastanza
delicate e visto che io ho lavorato sette anni nella Polizia di Stato, ci andai
cauto. In ufficio mi coinvolse subito riparlandomi di questa storia del grafene
e chiedendomi informazioni sul fondo di Abu Dhabi. Poi mi disse che c’era una
banca in difficoltà finanziaria e io gli risposi: “M’informo con gli arabi”».
Non doveva andarci cauto?
«La verità è che io non ho avuto nemmeno il
coraggio di parlare di questa cosa a Sheik Alamed, ma con Carboni non potevo
essere scortese. Con me fu subito gentilissimo, avvolgente, non avevo motivo per
essere scortese con lui. L’avevo visto dieci minuti al tavolo e improvvisamente
mi chiedeva di salvare una banca. Le sembrerò un ballista, ma è andata così».
Però lei non parlò solo del fondo con Carboni,
ma anche del nuovo direttore generale...
«A un certo punto, in quella chiacchierata di
mezz’ora, Carboni mi accennò a una nomina da fare per la banca. Quindi mi chiese
il numero di telefono e io a una persona tanto gentile come potevo negarlo?
Pensavo che avrei saputo difendermi dalla sue avances... Invece iniziò a
bombardarmi di telefonate, anche la domenica: mi chiedeva di questo fondo e poi
di ritornare nel suo ufficio. Mia moglie in quel periodo non mi telefonava così
tante volte. Poi un giorno ci siamo rivisti, casualmente, in via Ludovisi,
subito dopo pranzo. Mi acchiappò sul marciapiede e mi disse: “Come stai
carissimo, sali un attimo con me, ti devo parlare della posizione della banca”.
E io salii con lui...».
In ufficio c’era anche lo scienziato russo, il
presunto coinquilino di Carboni?
«Non ho mai incontrato russi in quello studio.
Quando entrammo mi disse: ho delle persone che mi attendono, vieni che te le
presento. Io ero nell’imbarazzo più totale».
Chi c’era insieme a Carboni in ufficio?
«Tutti quelli che ha raccontato nell’articolo,
così facciamo prima».
L’ex presidente Lorenzo Rosi, il suo vice Pier
Luigi Boschi e l’imprenditore Mauro Cervini?
«Sì c’erano loro tre».
E Gianmario Ferramonti, l’imprenditore amico di
Licio Gelli?
«Non in quell’occasione, forse in altre...»
Dove erano Boschi e Rosi?
«Erano seduti amabilmente in una grande sala
riunioni e Carboni mi ha presentato come un amico imprenditore con ottimi
contatti con un fondo arabo».
I due banchieri che persone le sembrarono?
«Timidi e taciturni. Ricordo che erano vestiti
elegantemente, con l’abito. Sembravano stupiti, quasi imbarazzati per la mia
età. Probabilmente non si immaginavano un “salvatore” così giovane. Quando
Boschi mi ha detto il suo cognome, visto che la figlia era appena stata nominata
ministro, ho fatto due più due e ho intuito chi fosse».
Che cosa vi siete detti?
«Ci siamo solo salutati. Anche in quell’occasione
ci fu quasi un monologo di Carboni».
Perché hanno chiesto a lei il nome del
direttore generale?
«Non ne ho idea, ma la cosa mi lasciò incredulo.
Era come se mi dicessero: tu ci trovi il fondo che porta i soldi e noi facciamo
un favore a un tuo amico».
Lei propose il vicedirettore generale della
Popolare del Frusinate Gaetano Sannolo...
«L’ho conosciuto quando era direttore della
filiale della Cassa di risparmio di Firenze di cui ero cliente. Con me è sempre
stato carino e corretto. Io feci il suo nome così, in modo quasi goliardico,
anche se pensavo che fosse una persona giovane e dinamica. Inizialmente non
avevo dato peso a quella richiesta».
Neanche quando le presentarono Pier Luigi
Boschi?
«In quel caso rimasi veramente stupito. Dentro di
me pensai: “Andiamo bene”, perché non aveva senso tutto quello che stava
accadendo. Capisco che le possa sembrare assurdo, ma andò così».
Che spiegazione si è dato?
«Forse venni presentato a Rosi e Boschi come una
persona più importante di quella che in realtà fossi. A Carboni, invece, devo
essere entrato in simpatia e per questo fatto del fondo mi si era pure un po’
attaccato, questo sì».
Quanto durò l’incontro con Boschi e Rosi?
«Pochi minuti, meno di una decina. Poi andai via».
Avete discusso anche del direttore generale?
«Sulla questione venne fatto un accenno, ma non ne
parlammo approfonditamente in quell’occasione».
E quando lo avete fatto?
«In un terzo incontro, in cui presentai il mio
amico Gaetano al dottor Carboni. Sorridendo gli dissi: “Dai andiamo a sentire”.
Ma successivamente Sannolo fu chiamato davvero a fare il colloquio ad Arezzo.
Non ci potevamo credere. In quei giorni ci sentivamo in continuazione per
scherzare. Gli suggerii di chiedere un super stipendio, pensavamo che il mondo
si fosse capovolto. Il suo nome è uscito pure sul Sole24ore».
Quella mi risulta sia stata una fuga di notizie
orchestrata all’interno della banca per bruciare il nome del suo amico...
«Lo immaginavo. In ogni caso Carboni
improvvisamente cambiò atteggiamento».
Forse perché lei gli aveva detto che il fondo
non era disponibile...
«Infatti. Da quel momento iniziò a diradare le
chiamate, quindi ha proprio smesso. Non lo vedo e non lo sento più dalla fine di
quell’estate».
Non la stupì che Rosi e Boschi si fossero messi
nelle mani di Carboni?
«Molto. Mi sembrò una situazione surreale».
Quando capì che il padre della ministra era lì
a farsi consigliare il direttore generale della sua banca da lei che cosa pensò?
«“Non è possibile”. Non ci volevo credere, era
inverosimile...».
Ha conosciuto Ferramonti l’uomo che consigliò
il nome dell’altro candidato alla direzione generale, il banchiere Fabio Arpe?
«Sì, nel 2014, a Roma, mentre ero impegnato nel
lancio di un neonato movimento politico. Si presentò lui, mostrandosi
interessato a quella mia iniziativa. L’ho rivisto qualche volta nella Capitale.
In una di quelle occasioni incontrammo casualmente Carboni nel solito
ristorante. Sembrava che i due non si vedessero da tempo e si scambiarono il
numero di telefono davanti a me. Parlarono anche di questa cosa della banca».
In pratica la Popolare dell’Etruria era una
delle ossessioni di Carboni?
«Con me ha discusso solo di quella e del grafene».
E per salvarla si è affidato a due che aveva
incontrato al ristorante?
«Lei ride, ma all’epoca ho riso di più io. Certo
non vorrei apparire come una persona incapace di intendere e di volere, ma è
andata proprio così». Di Giacomo Amadori.
Il terreno di papà Boschi
in odore di 'ndrangheta.
Il manager nel 2010 venne
indagato per estorsione e riciclaggio per l'acquisto di una fattoria: il pm
Rossi archiviò tutto ma adesso rischia un'azione disciplinare. La strana
compravendita e quei 250mila euro in nero, scrive Anna Maria Greco, Venerdì
22/01/2016, su "Il Giornale". Il procuratore di Arezzo Roberto Rossi ha fatto di
tutto per non farsi salvare dal Csm. La prima bugia su Pier Luigi Boschi e Banca
Etruria gli è stata perdonata, ma la seconda fa riaprire il suo caso, che
sembrava avviato all'archiviazione. E non rischia solo il trasferimento
d'ufficio, ma anche un'azione disciplinare. Il procuratore generale della
Cassazione ha infatti chiesto gli atti al Csm, evidentemente per una
preistruttoria disciplinare. Rossi, infatti, potrebbe aver violato l'obbligo di
astensione dall'inchiesta su Banca Etruria ed essere accusato di dichiarazioni
infedeli al Csm. Ma i suoi guai potrebbero non fermarsi qui. Perché sembra che
da Arezzo stia uscendo nuovo fango dalle vecchie inchieste sul padre del
ministro Maria Elena e il pm ha fatto archiviare, forse con troppa facilità.
Prima di diventare procuratore e di diventare consulente di Palazzo Chigi. A
cambiare le carte in tavola sono le notizie di Panorama sul fatto che il
titolare dell'inchiesta su Banca Etruria quando era sostituto procuratore ha
indagato Boschi nel 2010 per turbativa d'asta e riciclaggio, poi per estorsione
nel 2013. A febbraio il papà viene iscritto nel registro degli indagati e Maria
Elena diventava ministro, a luglio Rossi inizia la consulenza con il governo, a
novembre archivia tutto. Eppure al Csm Rossi, sotto esame per la possibile
incompatibilità tra il suo ruolo di inquirente del padre del ministro e la
consulenza con Palazzo Chigi, disse di non conoscere nessuno della famiglia.
Ieri il pm è corso ai ripari inviando una lettera a palazzo De' Marescialli,
spiegando: «L'ho indagato, ma non lo conoscevo». Troppo tardi. La prima
commissione aveva creduto alle sue giustificazioni quando aveva negato che papà
Boschi facesse parte del consiglio «informale» della banca che rifiutò l'opa
della Banca Popolare di Vicenza senza informare il Cda, mentre Bankitalia
sosteneva il contrario. Una confusione tra la prima gestione Forsasari e la
seconda Rosi, aveva assicurato. Ma stavolta, la fiducia ottenuta al Csm evapora.
E tra i consiglieri c'è molta irritazione per la sua seconda e più pesante
bugia. Ha taciuto di aver già indagato Boschi, un personaggio molto noto ad
Arezzo anche al di là del ruolo politico della figlia. «Abbiamo preso tutti atto
con rammarico di un ennesimo equivoco in cui sembra essere caduto il
procuratore», ironizza il laico di Fi Pier Antonio Zanettin. È lui, che aveva
voluto l'apertura della pratica su Rossi a chiedere ora una nuova istruttoria.
La delibera assolutoria, che aspettava solo l'ok del plenum, viene sospesa. «A
tutela della trasparenza e della credibilità dell'operato della magistratura la
prima Commissione ha deciso all'unanimità un ulteriore approfondimento sulla
vicenda Rossi, alla luce di circostanze che emergerebbero da articoli di
stampa», spiegano i togati di Area Piergiorgio Morosini (relatore) e Antonello
Ardituro. Gli atti sono già stati inviati al Pg della Cassazione per gli
accertamenti disciplinari, mentre per verificare l'incompatibilità il Csm ha
chiesto informazioni al procuratore generale di Firenze. La relazione potrebbe
arrivare per la riunione di lunedì. E si potrebbe anche convocare di nuovo
Rossi. Dovrà spiegare come mai ha dimenticato che 6 anni fa ha indagato Boschi
(con altre 8 persone) per irregolarità nell'acquisto della grande tenuta
Fattoria di Dorna per 7,5 milioni (era valutata almeno 9), da parte della coop
Valdarno superiore che presiedeva, poi diventata una società di cui Pier Luigi
aveva il 90 per cento e il resto era del crotonese Francesco Saporito, in odore
di 'ndrangheta. E anche di aver indagato una seconda volta nel 2013 Boschi,
perché un certo Apolloni che acquistò un podere della tenuta lo accusò di
essersi fatto pagare in nero 250mila euro su 460 mila.
Pier Luigi Boschi, già
indagato (e prosciolto) sei anni fa.
Le archiviazioni per le accuse di turbativa d'asta e estorsione, furono del pm
che oggi indaga su Banca Etruria: lo scrive "Panorama" il 20 gennaio 2016. La
posizione di Pier Luigi Boschi, ex vicepresidente di Banca Etruria, è al vaglio
della Procura di Arezzo insieme a quella di altri membri del disciolto consiglio
d’amministrazione. Non sarebbe comunque la prima volta che il padre del ministro
delle Riforme, Maria Elena Boschi, si trova indagato. Nel numero in edicola da
domani, giovedì 21 gennaio, il settimanale Panorama ricostruisce nei
dettagli una vicenda giudiziaria risalente a sei anni fa, nella quale Boschi
padre fu indagato ad Arezzo per i reati di turbativa d’asta ed estorsione, e
venne per due volte prosciolto su richiesta del magistrato Roberto Rossi, oggi
divenuto procuratore della città toscana, nonché lo stesso magistrato che oggi
indaga sul dissesto di Banca Etruria e che è stato consulente del governo Renzi.
La vicenda, che fino al 2014 coinvolse Pier Luigi Boschi e altri otto indagati,
riguardava la compravendita, nel 2007, di una grande tenuta agricola posseduta
dall’Università di Firenze. Malgrado il proscioglimento, restano senza risposta
due domande, relative a 250 mila euro in contanti che un successivo acquirente
di parte della tenuta affermò di avere personalmente consegnato a Boschi. Da una
parte non si sa dove siano effettivamente finiti quei soldi, ma non si sa
nemmeno perché la Procura di Arezzo non abbia mai indagato per calunnia chi
affermava fossero stati versati.
Boschi: si riapre
l'istruttoria sul pm Roberto Rossi, dopo l'inchiesta di Panorama.
Il Csm vuole chiarire la posizione del magistrato che, come riportato dal nostro
giornale, archiviò le accuse nei confronti del padre del ministro, scrive
"Panorama" il 21 gennaio 2016. Giornata nera per il procuratore di Arezzo
Roberto Rossi, titolare delle inchieste su Banca Etruria. Il comportamento del
pm è finito al vaglio del Procuratore generale della Cassazione Pasquale
Ciccolo, titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati. E la
Prima Commissione del Csm ha riaperto l'istruttoria sul suo conto. A mettere nei
guai il procuratore, le indagini svolte negli anni passati su Pierluigi Boschi,
padre del ministro per le Riforme Maria Elena ed ex vice presidente di Banca
Etruria. Procedimenti conclusi con due richieste di archiviazione ma di cui
il pm non aveva fatto cenno nelle sue audizioni davanti ai consiglieri del Csm,
ai quali aveva invece assicurato di non conoscere "nessuno della famiglia
Boschi". Poi è arrivato il servizio di copertina del nostro giornale, in edicola
da oggi, in cui si racconta delle indagini di Rossi su Pierluigi Boschi per
turbativa d'asta e estorsione, andate avanti dal 2007 sino al 2014 e che
sarebbero state legate alla compravendita di una grande tenuta agricola
dell'Università di Firenze. Venuto a conoscenza del nostro servizio, Rossi ha
pensato di giocare d'anticipo inviando una lettera al Csm in cui ha scritto di
essersi occupato in passato di procedimenti riguardanti Pierluigi Boschi, padre
del ministro per le Riforme Maria Elena ed ex vice presidente di Banca Etruria,
ma ha confermato di non aver mai avuto occasione di incontrarlo. Nella sua
lettera Rossi parlerebbe di più procedimenti, sui quali ora la Commissione (che
solo due giorni fa aveva deciso di archiviare il fascicolo che lo riguarda)
intende fare approfondimenti, accogliendo all'unanimità la richiesta del laico
di Forza Italia Pierantonio Zanettin: verificare quali vicende hanno riguardato
e che esito hanno avuto. Il primo passo sarà a richiesta di informazioni e della
documentazione relativa al Procuratore generale di Firenze, l'organo di vertice
del distretto. "Ascoltare di nuovo il procuratore Rossi? Per ora no: lo abbiamo
sentito due volte e abbiamo ricevuto da lui tre comunicazioni scritte". Lo dice
il presidente della Prima Commissione del Csm Renato Balduzzi, che spiega come
la lettera fatta recapitare a Palazzo dei Marescialli, in cui Rossi parla di
precedenti procedimenti penali riguardanti Pierluigi Boschi dei quali aveva
avuto occasione di occuparsi sia il "fatto nuovo", che ha spinto oggi la
Commissione a "sospendere la delibera di archiviazione e a procedere ad
ulteriori approfondimenti istruttori". "Dobbiamo conoscere quali sono queste
vicende e quale esito hanno avuto" dice Balduzzi, precisando che nella lettera
il procuratore fornisce anche chiarimenti sul "disallineamento" tra quanto sta
emergendo e le sue dichiarazioni nell'audizione di dicembre davanti al Csm.
L'ottica dell'intervento della Commissione non cambia: "garantire la massima
serenità alla procura di Arezzo". "Non solo Banca Etruria e massoneria deviata.
Ora su papà Boschi arrivano anche le ombre, carte della DDA alla mano di aver
fatto affari con uomini legati alla 'ndrangheta. A questo punto il ministro
Maria Elena Boschi deve rassegnare le dimissioni, perché una pesantissima e
insopportabile ombra politica aleggia sulla sua famiglia ed anche su tutte le
false riforme che hanno distrutto la Costituzione repubblicana. Del resto la
deforma Boschi non sarebbe mai passate senza gli accordi ed i voti del
plurinquisito Denis Verdini". Lo scrive in una nota il capogruppo M5S Senato
Mario Giarrusso, "dopo la pubblicazione delle notizie che nel 2007 Pierluigi
Boschi portò a termine un grosso affare immobiliare insieme a un socio
calabrese, Francesco Saporito, che secondo la DDA di Firenze era legato alla
'ndrangheta crotonese". Il senatore pentastellato fa riferimento ad un'inchiesta
pubblicata dal settimanale Panorama. "Di questo argomento se ne dovrà far
carico anche la Commissione d'inchiesta parlamentare antimafia", conclude il
capogruppo M5S.
Solita sinistra a senso
unico...La denuncia di Rosy Bindi: "C'è una mafia che usa l'antimafia".
Il j'accuse della presidente della Commissione d’inchiesta nell'intervista
esclusiva rilasciata a l'Espresso. Troppi interessi sfruttano la lotta ai clan.
Che spesso diventa una facciata per la conquista di potere, scrive Marco
Damilano il 28 gennaio 2016 su "L'Espresso". Inchieste, scandali, scontri
intestini. Magistrati che accusano le icone antimafia di «monopolio» dei beni
confiscati. Il presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante, garante
della legalità dell’associazione degli imprenditori a livello nazionale,
indagato e perquisito e il presidente del Senato Piero Grasso che parla di
«antimafia infangata». È la stagione del malcontento per il movimento
anti-mafia, a trent’anni esatti dall’apertura del primo maxi processo a Palermo,
voluto da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Con il sospetto che siano gli
stessi campioni dell’anti-mafia a infangare se stessi. A Palazzo San Macuto,
sede della commissione parlamentare che indaga sui legami tra la criminalità e
la politica, la presidente Rosy Bindi non è sorpresa, come spiega a Marco
Damilano nell'intervista sull'Espresso in edicola da venerdì 29 gennaio 2016.
«Quando un anno fa annunciai a Caltanissetta che avremmo avviato un’inchiesta ci
furono molte ironie (l’antimafia che indaga sull’antimafia!) da parte di quei
commentatori interessati semplicemente a indebolire il movimento. E invece il
nostro obiettivo è riaffermare il valore dell’impegno di associazioni,
cittadini, istituzioni e imprenditori che per venti anni ha dato un contributo
fondamentale alla lotta contro la criminalità mafiosa. C’è chi vuole
delegittimare queste presenze preziose. I soliti negazionisti e chi non ammette
che la forza della mafia continua a essere fuori dalla mafia. Nel silenzio,
nelle complicità, nelle sue relazioni sociali. Vogliamo rilegittimare
l’antimafia. Ma possiamo farlo soltanto smascherando alcune ambiguità che
obiettivamente esistono». Quali ambiguità? Fino a qualche mese fa si pensava
all’antimafia come a un movimento monolitico. E incontaminato. «Ci muoviamo su
più fronti. C’è una mafia che usa l’antimafia per prosperare, l’aspetto più
grave e pericoloso. Una mafia, ad esempio, che utilizza la comunicazione per
infangare chi lotta contro la mafia. Anche Roberto Saviano ne è stato vittima.
C’è poi un’antimafia che dietro l’obiettivo manifesto di combattere i mafiosi
nasconde la cura di altri interessi. È quanto sembra emergere in Sicilia, un
caso che va approfondito. Al di là dei risvolti penali, lì c’è un movimento
antimafia che si è trasformato in un movimento di potere. Cerca di determinare
la formazione delle maggioranze in regione, di influenzare le scelte politiche
ed economiche. C’è, infine, un’antimafia che diventa un mestiere. Una
professione, ma non come intendeva dire Leonardo Sciascia».
C’è del marcio in
antimafia. Ma sul “caso Libera” la Bindi fa la gnorri,
scrive Francesca De Ambra venerdì 15 gennaio 2016 su “Il Secolo d’Italia”. C’è
del marcio in antimafia. Ma l’unica che riesce a non vederlo è proprio
l’on. Rosy Bindi. Non che la presidente dell’omonima commissione manchi
d’iniziativa, tutt’altro. Se lo ricorda bene Enzo De Luca che a 24 ore dal voto
che lo avrebbe eletto governatore della Campania si ritrovò in una lista di
“impresentabili” redatta in fretta e furia proprio dall’organismo da lei
guidato. O il deputato forzista Carlo Sarro, invitato dalla
Pasionaria a dimettersi dall’Antimafia dopo aver ricevuto una richiesta di
arresti ai domiciliari poi demolita da un micidiale uno due
Riesame-Cassazione. Dove invece la Bindi segna il passo è sulla sempre più
inquietante vicenda della gestione dei beni sottratti alle mafie, deflagrata a
fine estate con l’inchiesta della procura di Caltanissetta sul giudice Silvana
Saguto. Prima della Procura nissena era stato però l’ex-direttore dell’Agenzia
nazionale per i beni confiscati, il prefetto Giuseppe Caruso, a denunciare, i
presunti conflitti d’interesse dell’avvocato Gaetano Cappellano Seminara,
l’amministratore giudiziario cui la Saguto aveva affidato la gestione di tutti i
beni confiscati ricevendone – secondo la tesi dei pm – consulenze per il proprio
marito. Nessuno, però, ringraziò Caruso. Neppure la Bindi, che anzi
gli rinfacciò di aver innescato un «effetto delegitttimazione» attraverso
«un’accusa generalizzata al sistema» e «a magistrati che rischiano la vita».
Quando scoppia la bomba dell’inchiesta di Caltanissetta, Caruso si toglie la
soddisfazione dell’“avevo detto io” e intervistato
da Liberoquotidiano.it rilascia una replica al curaro: «Ora qualcuno dovrebbe
confessare come stanno effettivamente le cose e più di qualcuno dovrebbe
dimettersi…». Ogni riferimento, ancorché implicito, è puramente voluto. La
lezione, tuttavia, non è servita. Tanto è vero che la Bindi rischia ora di
ripetere lo stesso errore di superficialità commesso con Caruso. Solo che questa
volta a dare l’allarme non è un prefetto ma Catello Maresca, il pm in forze
alla Dda di Napoli che ha fatto arrestare boss del calibro di Michele Zagaria
e Antonio Iovine, cioè proprio uno di quei «magistrati che rischiano la vita».
Intervistato da Panorama, Maresca ha contestato il sistema che regola la
gestione dei beni sottratti ai boss esprimendo più di una riserva su Libera
di don Luigi Ciotti. Che ha annunciato querele. E la Bindi? Prima ha rivendicato
il progetto di riforma della normativa sulla gestione dei patrimoni mafiosi
per poi defilarsi rispetto ai rilievi mossi dal pm: «Se Maresca – ha detto –
continua a spiegare e magari si incontra con Libera si fa una cosa buona».
Davvero? E la commissione Antimafia che ci sta a fare? Non ha forse il dovere di
capire e approfondire? O dobbiamo forse pensare che le pesanti critiche mosse da
Maresca a don Ciotti siano dovute a vecchie ruggini personale, pronte però a
svanire davanti al buon vino che sempre riconcilia i veri amici? Non scherziamo:
la faccenda è fin troppo seria per consentire alla presidente Bindi di voltarsi
dall’altra parte.
Don Ciotti e Libera
osannato da tutta l'Antimafia di Facciata.
Bindi: "Don Ciotti non
resterà solo. Pieno sostegno dall'Antimafia",
scrive il 31 Agosto 2014 "Live Sicilia". La solidarietà della presidente della
commissione parlamentare Antimafia al sacerdote fondatore di Libera. D'Alia:
"Minacce da non sottovalutare". Vendola: "Cosa nostra vada all'inferno". Grasso:
"Tutti al fianco di don Ciotti". Gelmini: "Non sarà mai solo". "Don Ciotti non è
solo e non resterà solo nella battaglia contro i poteri mafiosi". Lo dichiara il
presidente della commissione parlamentare Antimafia, Rosy Bindi commentando le
intercettazioni riportate dal quotidiano 'La Repubblica', in cui Totò Riina
accosta la figura di don Luigi Ciotti a quella di don Puglisi e dice:" Ciotti,
Ciotti, putissimu pure ammazzarlo". "E' malvagio e cattivo - aggiunge il padrino
al boss Lorusso suo compagno di passeggiate nell'ora d'aria - ha fatto strada
questo disgraziato". "A don Luigi la mia affettuosa vicinanza e il pieno
sostegno della Commissione parlamentare Antimafia - dice Bindi - Le minacce di
Riina intercettate nel carcere di Opera lo scorso anno vanno prese sul serio,
soprattutto per l'inquietante accostamento al martirio di don Pino Puglisi". "A
don Ciotti - aggiunge - va assicurata tutta la protezione e il sostegno
necessari, molti mesi sono passati da quando i magistrati hanno esaminato le
intercettazioni e si deve capire che tipo di messaggio vuole inviare il capo di
Cosa Nostra mentre inveisce contro un sacerdote così esposto sul fronte della
lotta alla mafia". "So che le raccapriccianti parole di Riina - dice ancora
Bindi - non faranno arretrare il suo appassionato servizio cristiano per la
giustizia e la promozione della dignità umana e da oggi saremo al suo fianco con
più determinazione". "L'impegno che insieme a tanti con Libera don Ciotti da
anni profonde per promuovere la cultura della legalità, la memoria delle vittime
innocenti e lo sviluppo solidale nelle terre confiscate alle mafie - prosegue -
sono ormai punto di riferimento della coscienza civile del paese". Ed è proprio
il lavoro di Libera che scatena l'odio di Riina, preoccupato per i tanti
sequestri di beni alla mafia che poi vengono gestiti dalle cooperative di
Libera. "La scomunica di Papa Francesco - aggiunge Rosy Bindi - ha tracciato una
linea invalicabile tra la Chiesa e le mafie che dà a tutti, credenti e non
credenti, più forza e coraggio nel combattere la cultura dell'omertà e della
sopraffazione. Ma non possiamo abbassare la guardia, c'è una mafia silente che
moltiplica affari e profitti e penetra in ogni settore della vita del paese
approfittando della crisi economica. E c'è - conclude - una mafia violenta che
continua a tenere sotto scacco con l'intimidazione e la paura buona parte del
Mezzogiorno, dove pesano povertà e disoccupazione ma dove sono anche più vitali
e preziose le esperienze di libertà e resistenza create da Libera per strappare
il territorio al controllo della criminalità organizzata".
"Un abbraccio affettuoso e di
vera solidarietà a Don Luigi Ciotti, ogni giorno in prima linea nella lotta alla
mafia. Le minacce di Riina nei suoi confronti non possono essere in alcun modo
sottovalutate. Il suo impegno quotidiano, non ultimo quello per i testimoni di
giustizia che ho avuto modo di apprezzare da vicino nella mia attività di
ministro, merita sostegno e protezione". Lo afferma il deputato e Presidente
dell'Udc Gianpiero D'Alia.
"Un forte abbraccio don Luigi!
All'inferno la mafia! L'impegno di Don Luigi ci dice che per la lotta alla mafia
non servono proclami o moralismi. Bensì ogni giorno, con un umile coraggio,
serve condurre la battaglia per affermare i diritti dei più deboli e affermare
la legalità con fatti concreti, che anche la politica deve compiere". Così Nichi
Vendola, presidente di Sinistra Ecologia Libertà, su Twitter esprime la propria
solidarietà al fondatore di Libera coop dopo le minacce di Riina.
Il presidente del Senato,
Pietro Grasso, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un messaggio di
solidarietà a don Luigi Ciotti in riferimento alle minacce di Riina emerse dagli
organi di informazione. "Caro Luigi - si legge nel testo - sono più di venti
anni che sfidi la mafia con coraggio e passione. Le minacce di Riina emerse oggi
sono l'ennesimo attacco ad una storia di impegno e di memoria che coinvolge ogni
anno migliaia di cittadini e che ha contribuito a rendere il nostro Paese più
libero e più giusto. Ti conosco da anni e so che non ti sei lasciato intimorire
nemmeno per un attimo: continuerai sulla strada della lotta alla criminalità, e
tutti noi - conclude Grasso - saremo al tuo fianco. Un abbraccio, Piero".
"Le minacce di Totò Riina
all'amico Don Ciotti, preoccupano certo, ma non sorprendono. Un uomo come Luigi,
che da anni promuove la cultura della legalità e combatte contro le mafie
attraverso azioni concrete, non può che essere un nemico per un boss di Cosa
Nostra. Una persona da temere, per aver dimostrato, insieme con Libera, che i
beni della criminalità possono essere riutilizzati a scopi sociali". Lo scrive
sul suo profilo Fb Laura Boldrini, Presidente della Camera.
"Le parole di Riina sono
inquietanti e ci dicono che non bisogna mai abbassare la guardia soprattutto nei
confronti di chi si trova in prima linea nella lotta alle mafie, come il
magistrato Nino Di Matteo e don Luigi Ciotti ai quali esprimo il mio pieno
sostegno". Lo dice il senatore del Pd Giuseppe Lumia, componente della
Commissione parlamentare antimafia, commentando le intercettazioni delle
conversazione in carcere tra il boss di Cosa nostra ed il boss pugliese Alberto
Lorusso. "A Riina - aggiunge - lo Stato deve dare una risposta chiara e netta
con l'approvazione in tempi rapidi di un pacchetto di norme che consentano alla
lotta alle mafie di far fare un salto di qualità. Alcune di queste, ad esempio
il rafforzamento delle misure di prevenzione, l'autoriciclaggio ed il falso in
bilancio, sono già contenute nella riforma della giustizia, ma ce ne sono tante
altre da adottare. Ecco perchè - conclude Lumia - torno a chiedere una sessione
dedicata in Parlamento".
"Don Ciotti non sarà mai solo:
fra lui e Riina l'Italia civile ha scelto da che parte stare. Sempre contro la
mafia!". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, vicecapogruppo vicario di
Forza Italia alla Camera.
La capriola della Bindi su
don Ciotti prova che Libera è anche una lobby,
scrive Venerdì 15 Gennaio 2016 Giuseppe Sottile su Il Foglio. I beni dei mafiosi
sono diventati un Tesoro Maledetto. E la bufera della polemica ha investito in
pieno anche la creatura di don Ciotti. Ma la politica, prodiga di riverenza, ha
preferito squadernare solidarietà incondizionata. Che cosa racconterà questo
sanguigno prete torinese ai bambinetti di mezz’Italia che, sotto la sua ala
benefica e protettiva, andranno a rendere omaggio anche quest’anno alla memoria
di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino? Con quali preghiere, o con quali
giaculatorie, don Luigi Ciotti, uomo di fede e di misericordia, tenterà di
allontanare i sospetti che ormai da qualche tempo scuotono e avviliscono il
meraviglioso mondo di Libera, l’associazione che, come i bambini forse non
sanno, è anche la più potente e denarosa lobby antimafia? E come potrà questo
buon sacerdote spiegare, a tutti quei ragazzi, così innocenti e già così
innamorati della legalità, che Libera dopo un inizio come sempre difficile è poi
diventata troppo grande e si è trovata spesso a giocare col fuoco sugli stessi
terreni, sugli stessi feudi, sugli stessi patrimoni sui quali per anni padrini e
picciotti avevano sparso sangue e nefandezze? Parliamoci chiaro. Sull’impegno di
don Ciotti contro ogni mafia e contro ogni boss nessuno potrà mai sollevare
alcun dubbio: come Papa Francesco, il fondatore di Libera conosce la strada e i
problemi degli umili; con il suo Gruppo Abele ha fatto il volontariato duro e sa
come si aiuta un infelice nel disperato labirinto della droga. Sa anche come si
combattono le violenze, come si contrasta una intimidazione, come si restituisce
dignità civile a un giovane senza lavoro e tragicamente affascinato dalla vie
traverse. Ed è per questo che, dopo le stragi degli anni Novanta, è nata Libera:
per sollevare Palermo dallo scoramento, per ridare fiducia a una terra segnata
dal martirio e dalle lacrime. Un progetto ambizioso. Che certamente trovava
sostegno e conforto in un altro torinese: in quel Gian Carlo Caselli che, di
fronte alle mattanze di Capaci e via D’Amelio, aveva chiesto con coraggio al
Consiglio superiore della magistratura di trasferirsi nel capoluogo siciliano e
di insediarsi come procuratore in un Palazzo di giustizia sventrato prima dalle
faide tra gli uffici e poi dalle bombe di Totò Riina, detto ‘u Curtu. Sono stati
certamente anni eroici e straordinari quelli di Palermo. E Libera, la cui
missione principale (il core business, stavo per dire) è quella di creare
cooperative di lavoro sui beni confiscati alla mafia, non ha mai incontrato
ostacoli. Anzi: non c’è stata istituzione che non abbia preso a cuore la causa;
non c’è stato potere che non abbia guardato con riverenza ai buoni propositi di
don Ciotti e non c’è stato partito politico, soprattutto a sinistra, che non
abbia mostrato orgoglio nell’accettare candidature ispirate direttamente
dall’associazione. Troppa grazia, sant’Antonio, si sarebbe detto una volta. Ma
la troppa grazia non sempre è foriera di prosperità. Spesso, troppo spesso,
dietro un eccesso di grazia c’è anche un’abbondanza di grasso. E Libera davanti
a quella montagna di soldi, oltre trenta miliardi di euro, sequestrati dallo
stato alle mafie, non ha saputo atteggiarsi con il necessario distacco né con la
necessaria misura: era una semplice associazione antimafia ed è diventata una
holding; era fatta da poveri e ora presenta bilanci milionari; era animata da un
gruppo di volontari e si ritrova governata da tanti manager e, purtroppo, anche
con qualche spregiudicato affarista tra i piedi. Poteva mai succedere che a
margine di tanta ricchezza, piovuta come manna dal cielo, non nascessero invidie
e risentimenti, gelosie e prese di distanza, storture e due o tre storiacce poco
chiare? Sarà doloroso ammetterlo ma i beni dei mafiosi, sia quelli sequestrati
in via provvisoria sia quelli confiscati dopo una sentenza definitiva, sono
diventati una sorta di Tesoro Maledetto. Una tomba faraonica dentro la quale
viene ogni giorno seppellita – cinicamente, inesorabilmente – la credibilità
dell’antimafia: non solo di quella che avrebbe dovuto riaccendere una speranza
politica ed è finita invece in una insopportabile impostura; ma soprattutto di
quella che, dall’interno dei tribunali, avrebbe dovuto garantire rigore e
legalità e ha consentito invece a un gruppo di magistrati infedeli di intramare
i beni sequestrati con i propri interessi privati: certo l’inchiesta aperta
questa estate dalla procura di Caltanissetta è in pieno svolgimento e le
responsabilità personali sono ancora tutte da definire, ma le intercettazioni,
come sempre ottime e abbondanti, ci dicono con desolante chiarezza come si
amministravano fino all’altro ieri le misure di prevenzione a Palermo; con quali
disinvolture e con quali coperture i figli e i fraternissimi amici dei più alti
papaveri del Palazzo di giustizia affondavano le mani nei patrimoni, ricchi e
scellerati, che la dottoressa Silvana Saguto, presidente della sezione, aveva
strappato, con mano decisa e irrefrenabile, alla potestà di Cosa Nostra. La
maledizione, e non poteva essere diversamente, ha finito per colpire anche
Libera, cioè la macchina più grande ed efficiente aggrappata alla grande
mammella dei beni confiscati: 1.500 tra associazioni e gruppi collegati, 1.400
ettari di terreno sui quali coltivare ogni ben di dio, 126 dipendenti e un
fatturato che supera i sei milioni. Con una aggravante: che le accuse,
chiamiamole così, non vengono tanto, come sarebbe persino scontato, dal
maleodorante universo mafioso; arrivano piuttosto dai compagni di strada, da
personaggi che rivendicano, al pari di don Ciotti, il diritto di parlare a nome
dell’antimafia: come Franco La Torre, figlio del segretario del Pci ucciso a
Palermo nel 1982, che non ha sopportato il silenzio di Libera sullo scandalo
della Saguto e delle altre cricche nascoste dentro le misure di prevenzione; o
come Catello Maresca, pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia
di Napoli e nemico numero uno del clan dei casalesi, il quale, intervistato dal
settimanale Panorama, ha lanciato parole roventi: ha detto che “Libera gestisce
i beni attraverso cooperative non sempre affidabili” e ha aggiunto, senza
indulgenze di casta, che forse è venuta l’ora di smascherare “gli estremisti
dell’antimafia”, cioè quegli strani personaggi accucciati nelle associazioni
nate per combattere la mafia ma che “hanno acquisito l’attrezzatura mentale
dell’organizzazione e tendono a farsi mafiose esse stesse”. Queste associazioni,
spiega Maresca, “sfruttano beni che non sono di loro proprietà, utilizzano
risorse e denaro di tutti”; e Libera, in particolare, gestisce i patrimoni “in
regime di monopolio e in maniera anticoncorrenziale”. Inevitabile e inevitata,
ovviamente, la risposta di don Ciotti: “Menzogne: Noi questo signore lo
denunciamo domani mattina. Ci possono essere degli errori, si può criticare, ma
non può essere calpestata la verità”. Più sorprendente, se non addirittura
imbarazzante invece l’atteggiamento con cui la Commissione parlamentare
antimafia, presieduta da Rosy Bindi, si è posta di fronte alla polemica aperta
da Maresca, un magistrato antimafia unanimemente apprezzato sia per il suo
equilibrio che per il suo coraggio. Il pm napoletano, nel suo lungo colloquio
con Panorama, ha sollevato questioni non secondarie: a suo avviso Libera, dopo
avere scalato i vertici della montagna incantata, non ha lasciato e non lascia
spazio a nessun altro; e se c’è un concorrente da stroncare lo fa senza
problemi: tanto, lavorando su un bene non suo, non ha gli stessi costi del
rivale. Non solo: è mai possibile che questo immenso patrimonio, continuiamo a
parlare di oltre trenta miliardi di euro, non possa essere sfruttato in termini
strettamente imprenditoriali per dare la possibilità allo Stato di sviluppare le
aziende e ricavarci pure un ulteriore valore aggiunto? Di fronte a interrogativi
così pesanti, ma anche così pertinenti, la commissione parlamentare avrebbe
dovuto a dir poco avviare un dibattito, magari ascoltando oltre a don Ciotti,
sentito a lungo mercoledì proprio mentre le agenzie di stampa diffondevano
l’anteprima di Panorama, pure il magistrato napoletano. Quantomeno per
verificare l’eventuale necessità di una modifica alle intricatissime leggi che
regolano la materia. Invece no: Rosy Bindi ha preferito definire “offensive” le
affermazioni di Maresca e l’ha chiusa lì. Don Ciotti certamente non avrà tutte
le colpe che Maresca, più o meno volontariamente gli attribuisce. Ma la
solidarietà assoluta e incondizionata squadernata l’altro ieri a San Macuto
dalla presidente Bindi, e dai parlamentari che man mano si sono a lei accodati,
è la prova provata che Libera è anche e soprattutto una lobby.
Beni confiscati,
associazioni, coop. Libera, impero che muove 6 milioni,
scrive Lunedì 16 Marzo 2015 Claudio Reale su "Live Sicilia". L'associazione
raduna 1.500 sigle, ma il suo cuore economico è "Libera Terra", che fattura 5,8
milioni con i prodotti dei terreni sottratti ai boss e li reinveste per
promuovere la legalità e assumere lavoratori svantaggiati. E mentre si prepara
il ventesimo compleanno, don Ciotti apre alla collaborazione con il movimento di
Maurizio Landini. Vent'anni da compiere fra pochi giorni. E circa 1.500 sigle
radunate sotto il cartello dell'“associazione delle associazioni”, con un
modello che in fondo richiama la tradizione storica dell'Arci. “Libera” è
formalmente un'organizzazione non governativa che si occupa di lotta alle mafie,
di promozione della legalità e di uso sociale dei beni confiscati alle mafie:
sotto la sua bandiera, però, si muovono attività diversificate nello scopo e
nello spazio, coprendo quasi per intero il Paese e con ramificazioni
internazionali. Un mondo il cui cuore economico è “Libera Terra”, che gestisce
1.400 ettari di terreni confiscati alla mafia, dà lavoro a 126 persone e muove
un fatturato che nel 2013 ha sfiorato i sei milioni di euro. Un impero sotto il
segno della legalità. Che fa la parte del leone nell'assegnazione per utilità
sociale dei beni confiscati e che non si sottrae allo scontro fra antimafie, in
qualche caso – come ha fatto all'inizio del mese don Luigi Ciotti – facendo
aleggiare l'imminenza di inchieste: "Mi pare di cogliere – ha detto il 6 marzo
il presidente dell'associazione – che fra pochi giorni avremo altre belle
sorprese, che sono in arrivo, che ci fanno soffrire. Perché riguardano
personaggi che hanno sempre riempito la bocca di antimafia”. Uno scontro fra
paladini della legalità, in quel campo minato e denso d'insidie popolato dalle
sigle che concorrono all'assegnazione dei terreni sottratti ai boss.
Un mondo che, nel tempo, ha
visto in diverse occasioni l'antimafia farsi politica. E se Libera non è stata
esente da questo fenomeno - Rita Borsellino, fino alla candidatura alla guida
della Regione e poi all'Europarlamento, dell'associazione è stata ispiratrice,
fondatrice e vicepresidente – a tenere la barra dritta lontano dalle
identificazioni con i partiti ci ha sempre pensato don Ciotti. Almeno fino a
qualche giorno fa: sabato, infatti, sulle colonne de “Il Fatto Quotidiano”, il
carismatico sacerdote veneto ha aperto a una collaborazione con il nascente
movimento di Maurizio Landini. Certo, don Ciotti assicura nella stessa
intervista disponibilità al dialogo con tutto l'arco costituzionale ed esclude
un coinvolgimento diretto di Libera. Ma le parole di “stima e amicizia” espresse
a favore del leader Fiom, osserva chi sa cogliere le sfumature degli interventi
del sacerdote antimafia, sono un assoluto inedito nei vent'anni di storia
dell'associazione. Ne è passato di tempo, da quel 25 marzo 1995. A fondare il
primo nucleo di Libera furono appunto don Ciotti, allora “solo” numero uno del
Gruppo Abele, e Rita Borsellino. Da allora l'associazione si è notevolmente
diversificata: al filone principale, riconosciuto dal ministero del Welfare come
associazione di promozione sociale, si sono via via aggiunti “Libera
Formazione”, che raduna le scuole e ne coordina quasi cinquemila, “Libera
Internazionale”, che si occupa di contrasto al narcotraffico, “Libera
informazione”, che si concentra sulla comunicazione, “Libera Sport”, che
organizza iniziative dilettantistiche, “Libera ufficio legale”, che assiste le
vittime di mafia, e appunto “Libera Terra”, che raduna le cooperative impegnate
sui campi confiscati ed è l'unico troncone a commercializzare prodotti. In
Sicilia le cooperative sono sei. Dell'elenco fanno parte la “Placido Rizzotto” e
la “Pio La Torre” di San Giuseppe Jato, la “Lavoro e non solo” di Corleone, la
“Rosario Livatino” di Naro, la castelvetranese “Rita Atria” e la “Beppe Montana”
di Lentini, alle quali si aggiungono le calabresi “Terre Joniche” e “Valle del
Marro”, la brindisina “Terre di Puglia” e la campana “Le terre di don Peppe
Diana”: ciascuna è destinataria di almeno un bene sottratto alla mafia e produce
su quei terreni vino, pasta e altri generi alimentari commercializzati appunto
sotto il marchio unico “Libera Terra”. Fuori dal mondo agroalimentare, poi, c'è
la new-entry “Calcestruzzi Ericina”, confiscata a Vincenzo Virga e attiva però –
col nuovo nome “Calcestruzzi Ericina Libera” – nella produzione di materiali da
costruzione. A questa rete di cooperative si aggiunge la distribuzione
diretta. Un network fatto di quindici punti vendita, anch'essi ospitati per lo
più in immobili confiscati a Cosa nostra, sparpagliati in tutta Italia: a
Bolzano, Castelfranco Veneto, Torino, Reggio Emilia, Bologna, Genova, Firenze,
Pisa, Siena, Roma, Castel Volturno, Napoli, Mesagne, Reggio Calabria e nel cuore
di Palermo, nella centralissima piazza Politeama, dove la bottega ha sede in un
negozio confiscato a Gianni Ienna. Non solo: nel pianeta “Libera Terra” trovano
posto anche una cantina (la “Centopassi”), due agriturismi (“Portella della
Ginestra” e “Terre di Corleone”), un caseificio (“Le Terre” di Castel Volturno),
un consorzio di cooperative (“Libera Terra Mediterraneo”, che dà lavoro a nove
dipendenti e cinque collaboratori) e un'associazione di supporto (“Cooperare con
Libera Terra”, onlus con 74 cooperative socie). Ne viene fuori un universo che
nel 2013 ha dato uno stipendio a 126 lavoratori, 38 dei quali svantaggiati, ai
quali si sono aggiunti 1.214 volontari. Tutto per produrre circa 70 prodotti –
venduti nelle botteghe Libera Terra, ma anche nei punti vendita Coop, Conad e
Auchan – che spaziano dalla pasta all'olio, dal vino alla zuppa di ceci in
busta: ne è venuto fuori, nel 2013, un fatturato di 5.832.297 euro, proveniente
per più di un quinto dalla commercializzazione all'estero. Numeri che fanno
delle cooperative il cuore pulsante dell'economia targata Libera: basti pensare
che l'intero bilancio dell'associazione-madre muove 2,4 milioni di euro, meno
della metà del flusso di denaro che passa dai campi confiscati. Denaro che però
non finisce nelle tasche dei 94 soci: se una royalty – nel 2013 di 157 mila euro
– viene girata a “Libera”, il resto viene utilizzato per attività sociali come
la promozione della legalità, il recupero di beni sottratti ai boss e i campi
estivi. Già, perché nei terreni confiscati il clou si raggiunge d'estate. Nei
mesi caldi, infatti, le cooperative siciliane (ma anche quelle pugliesi)
accolgono giovani da tutta Italia per attività di volontariato sui beni
sottratti ai capimafia. Il momento centrale della vita dell'associazione, però,
si raggiungerà fra pochi giorni: il 21 marzo, infatti, “Libera” organizza dal
1996 una “Giornata della memoria e dell'impegno” durante la quale vengono
ricordate le vittime di mafia. Quest'anno l'appuntamento è a Bologna, con una
kermesse iniziata venerdì e destinata a concludersi il 22. A ridosso dei
vent'anni dell'associazione. E in un momento di grandi conflitti per le
antimafie.
"Fatti di inaudita gravità".
Beni confiscati, una ferita aperta, scrive Sabato 30 Gennaio 2016 Riccardo Lo
Verso su "Live Sicilia". Anno giudiziario. Nel giorno in cui i magistrati
presentano i risultati di un anno di lavoro, a Palermo e Caltanissetta tiene
banco l'inchiesta sulle Misure di prevenzione. Nel capoluogo siciliano il
ministro Andrea Orlando dice: "La mafia non è vinta". È il caso Saguto a tenere
banco nel giorno dell'inaugurazione dell'anno giudizio a Palermo e
Caltanissetta. Palermo è la città dove lavorava l'ex presidente della sezione
Misure di prevenzione del Tribunale finita sotto inchiesta. A Caltanissetta,
invece, lavorano i pubblici ministeri che con la loro indagine hanno fatto
esplodere la bomba giudiziaria della gestione dei beni sequestrati alla mafia. A
Palermo, davanti al ministro della Giustizia Andrea Orlando. Ha fatto al sua
relazione il presidente della Corte d'appello, Gioacchino Natoli. "Se le
criticità emerse dai controlli seguiti alle vicende legate all'inchiesta sulla
sezione misure di prevenzione dovessero essere confermate - ha detto Natoli -
occorrerebbe riflettere sulla sorveglianza esercitata dalla dirigenza locale e
dal consiglio giudiziario". Il magistrato ha recitato il mea culpa a nome
dell'intera categoria, spiegando che "la prevenzione di certi episodi parte dai
controlli a cominciare dalla valutazione della professionalità" e ammettendo che
nella gestione della sezione c'erano "criticità e inefficienze nella durata dei
procedimenti, nell'organizzazione e nella distribuzione degli incarichi". E il
ministro è stato altrettanto duro: "E' necessario perseguire le condotte che
hanno offuscato il lavoro di tanti valenti magistrati. Quello dell'aggressione
ai beni mafiosi è uno dei terreni che ha dato maggiori risultati nel contrasto a
Cosa Nostra". Il ministro, anche richiamando la recente normativa sui tetti ai
compensi degli amministratori giudiziari, ha auspicato "una riduzione dei
margini di discrezionalità in cui si sono sviluppati fenomeni allarmanti". Poi,
un passaggio dedicato alla lotta a Cosa nostra: "La mafia è stata colpita, ma
non è battuta, né si tratta di un'emergenza superata anche se altre se ne
profilano all'orizzonte". Nel frattempo, a Caltanissetta, interveniva il
vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini: "I magistrati della Procura di
Caltanissetta, con un'indagine coraggiosa e difficile che è tuttora in corso,
hanno consentito che emergessero fatti di inaudita gravità nella gestione delle
misure di prevenzione antimafia a Palermo, permettendo che la prima Commissione
e la sezione disciplinare del Csm potessero sollecitamente esercitare le
funzioni di ripristino del prestigio e dell'autorevolezza di quell'ufficio".
Ecco perché Legnini ha detto di avere “scelto di essere presente a
Caltanissetta, per testimoniare la mia gratitudine è quella di tutto il Csm
verso i magistrati che prestano servizio in questo distretto”. Sulla stessa
lunghezza d'onda le parole del procuratore generale di Caltanissetta, Sergio
Lari: "Gli scandali che hanno visto coinvolti i magistrati, pur trattandosi di
episodi isolati, non possono essere sottovalutati e dimostrano come la massima
attenzione debba essere posta alla deontologia ed alla questione morale nella
magistratura, essendo inammissibili, soprattutto in un'epoca così degradata in
altri ambiti istituzionali, cadute etiche da parte di chi deve svolgere l'alto
compito del controllo di legalità".
L’antimafia di facciata ai
pm non piace più.
Apertura dell'anno giudiziario a Palermo. Il procuratore Lo Voi: persegue affari
e carriera, scrive Luca Rocca il 31 gennaio 2016 su “Il Tempo”. Che un giorno
anche la procura di Palermo potesse destarsi e puntare il dito contro
l’«antimafia di facciata», accusata di perseguire solo «affari e carriera», ci
credevano in pochi. Forse nessuno. E invece è accaduto ieri in occasione
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, quando il procuratore capo Francesco
Lo Voi si è scagliato proprio contro chi, nascondendosi dietro l’intoccabilità
di chi quella categoria l’ha usata come una corazza, ha pensato di poter
coltivare i propri interessi con la certezza di non essere sfiorato nemmeno dal
sospetto. D’altronde, dopo i casi di Silvana Saguto, ex presidente della sezione
Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo per la gestione dei beni
confiscati indagata per corruzione, abuso d'ufficio e riciclaggio; quello di
Roberto Helg, ex presidente della Camera di Commercio di Palermo arrestato per
estorsione dopo anni di proclami contro il pizzo; o ancora di Antonello
Montante, delegato nazionale per la legalità di Confindustria Sicilia indagato
per concorso esterno in associazione mafiosa; oppure Rosy Canale, condannata a
quattro anni di carcere per truffa e malversazione dopo aver vestito i panni
della paladina anti ’ndrangheta col «Movimento donne di San Luca»; dopo questi
«colpi al cuore» al professionismo dell’antimafia, dicevamo, dalla procura che
più di ogni altra ha incarnato la lotta alla mafia, «slittando», da un certo
momento in poi, verso mete fantasiose e poco concrete, una parola di condanna
non poteva più mancare. E così ieri Lo Voi (la cui nomina a capo della procura
palermitana è stata resa definitiva, pochi giorni fa, dal Consiglio di Stato,
che si è espresso sui ricorsi di Guido Lo Forte e Sergio Lari, procuratori
rispettivamente a Messina e Caltanissetta) non ha taciuto, non ha voluto tacere:
«Forse c'è stata – ha affermato il procuratore capo di Palermo - una certa
rincorsa all'attribuzione del carattere di antimafia, all'auto-attribuzione o
alla reciproca attribuzione di patenti di antimafiosità, a persone, gruppi e
fenomeni che con l'antimafia nulla avevano e hanno a che vedere». Lo Voi non ci
ha girato intorno, e pur senza citare, ovviamente, casi specifici, ha preso di
petto la deriva di quell’antimafia che, dopo la sconfitta della mafia stragista,
come sostiene da tempo lo storico Salvatore Lupo, ha perso la sua ragione
d’essere: «La rincorsa è servita anche a tentare di crearsi aree di
intoccabilità – ha scandito il procuratore -, o magari a riscuotere consensi, a
guadagnare posizioni, anche a fare affari ed a bollare come inaccettabili
eventuali dissensi e opinioni diverse». Parole inequivocabili. Proprio come
quelle pronunciate subito dopo e che chiamano in causa le stesse toghe: «E,
spiace registrarlo, a questa rincorsa non si è sottratta quasi nessuna categoria
sociale e, pur con tutte le cautele del caso derivanti dal rispetto per alcune
indagini ancora in corso, forse neanche qualche magistrato». Dato a Cesare quel
che è di Cesare, il procuratore capo non poteva, infine, non concedere qualche
distinguo: «Antimafia è e significa rispettare le leggi e fare il proprio
dovere. Gran parte del resto è sovrastruttura, che è servita a costituire
categorie di presunti intoccabili, così rischiando di vanificare l'opera talora
pionieristica e sicuramente coraggiosa di chi l'antimafia l'ha fatta veramente.
Dire che tutta l'antimafia è inquinata è, ancora una volta, fuori dalla realtà
ed è falso».
Lo Voi e l'antimafia di
facciata: "È servita per affari e carriere",
scrive Sabato 30 Gennaio 2016 "Live Sicilia". Intervento del procuratore
all'inaugurazione dell'anno giudiziario di Palermo: "A questa rincorsa non si è
sottratta quasi nessuna categoria sociale". Poi, una frecciata agli imprenditori
che "pretendono" la restituzione dei beni che sono stati sequestrati per mafia.
(Nella foto il procuratore Francesco Lo Voi". "C'è stata forse una certa
rincorsa all'attribuzione del carattere di antimafia, all'autoattribuzione o
alla reciproca attribuzione di patenti di antimafiosità a persone, gruppi e
fenomeni che con l'antimafia nulla avevano e hanno a che vedere. L'antimafia di
facciata, che serve a scalare posizioni sociali e fare carriera, finisce "sotto
attacco" del procuratore di Palermo Francesco Lo Voi nel corso
dell'inaugurazione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Ed ancora: "La
rincorsa è servita anche a tentare di crearsi aree di intoccabilità, o magari a
riscuotere consensi, a guadagnare posizioni, anche a fare affari; ed a bollare
come inaccettabili eventuali dissensi o opinioni diverse. E, spiace registrarlo,
a questa rincorsa non si è sottratta quasi nessuna categoria sociale e, pur con
tutte le cautele del caso derivanti dal rispetto per alcune indagini ancora in
corso, forse neanche qualche magistrato". Eppure, secondo Lo Voi, basterebbe
poco: "Antimafia è e significa rispettare le leggi e fare il proprio dovere;
gran parte del resto è sovrastruttura, che è servita a costituire categorie di
presunti intoccabili, così rischiando di vanificare l'opera talora pionieristica
e sicuramente coraggiosa di chi l'antimafia l'ha fatta veramente". Poi ha
lanciato un monito: "Da un lato dobbiamo essere estremamente vigili, tutti, per
evitare che vi siano non soltanto infiltrazioni e sostenendo e supportando
coloro che fanno, anziché quelli che dicono di fare. Dall'altro lato, dobbiamo
evitare il danno peggiore, che è quello della generalizzazione. Dire che tutta
l'antimafia è inquinata è, ancora una volta, fuori dalla realtà ed è
falso". "Mettere nel nulla i risultati ottenuti sarebbe assurdo. Pretendere,
solo per fare un esempio, la restituzione dei beni sequestrati o confiscati ai
mafiosi, addirittura costituendo associazioni ad hoc sarebbe ancora più
assurdo", ha concluso riferendosi all'associazione costituita dopo il caso
Saguto da imprenditori indiziati di contiguità mafiose ai quali erano stati
sequestrati i patrimoni.
Mea culpa di politica e
magistratura,
scrive Sabato 30 Gennaio 2016 di Riccardo Lo Verso su "Live Sicilia". La
gestione dei beni confiscati alla mafia tiene banco nel giorno
dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. A Palermo come a Caltanissetta
autorevoli voci confermano che lo scandalo andava e poteva essere evitato, ma
sono mancati i controlli. Dell'antimafia di mestiere, tutta chiacchiere e
distintivo, restano le macerie. Persino la magistratura siciliana ammette i
propri errori. E lo fa scegliendo il giorno della parata delle toghe. Per una
volta non c'è solo retorica nei discorsi dell'inaugurazione dell'anno
giudiziario. È il caso Saguto ad imporlo, senza se e senza ma, sia a Palermo, la
città dello scandalo che ha travolto la sezione Misure di prevenzione del
Tribunale, che a Caltanissetta, dove lavorano i pm che lo scandalo hanno fatto
esplodere con le indagini. Sarà l'inchiesta e l'eventuale processo a stabilire
se l'ex presidente Silvana Saguto e gli altri componenti del vecchio collegio
che sequestrava i beni ai mafiosi e li assegnava agli amministratori giudiziari
abbiano davvero commesso i reati che i finanzieri ipotizzano. Reati pesanti che
includono la concussioni, la corruzione e il riciclaggio. Dalle indagini è,
però, già emerso uno spaccato di favori e clientele che fa a pugni con
l'imparzialità che ci si attende da chi indossa una toga. È Giovanni Legnini,
vice presidente del Csm, l'organo di autogoverno della magistratura, oggi a
Caltanissetta, a parlare di “fatti di inaudita gravità”. La magistratura ammette
gli errori. È lecito chiedersi, però, cosa abbia fatto per evitarli. A Palermo
il presidente della corte d'appello Gioacchino Natoli ha spiegato “che se le
criticità emerse dai controlli seguiti alle vicende legate all'inchiesta sulla
sezione misure di prevenzione di Palermo dovessero essere confermate,
occorrerebbe riflettere sulla sorveglianza esercitata dalla dirigenza locale e
dal consiglio giudiziario". Insomma, secondo Natoli, chi doveva controllare non
lo avrebbe fatto. A livello locale, così come anche nei palazzi romani. Sempre
Legnini si è complimentato con "i magistrati della Procura di Caltanissetta” che
grazie alla loro indagine "coraggiosa e difficile hanno consentito che
emergessero fatti di inaudita gravità nella gestione delle misure di prevenzione
antimafia a Palermo, permettendo che il Csm potesse sollecitamente esercitare le
funzioni di ripristino del prestigio e dell'autorevolezza di quell'ufficio".
Ripristinare, appunto, qualcosa che è venuta meno e non prevenire che ciò
accadesse. E la politica? Anch'essa ammette, per bocca del ministro della
Giustizia Andrea Orlando, oggi a Palermo, “la timidezza della politica negli
anni passati sulla magistratura. Avere lasciato spazi di discrezionalità ampia,
per esempio, non regolando attraverso norme i compensi e le modalità di
affidamento degli incarichi agli amministratori giudiziari o in altre procedure
che prevedano incarichi con ampio margine di discrezionalità, ha consentito che
si creassero zone d'ombra. La stagione nuova che si è aperta - conclude il
ministro - ci consente di ragionare, grazie anche al rinnovato dialogo con la
magistratura, su questi temi allo scopo di tutelare il prestigio della
giurisdizione". E così la politica e la magistratura, per bocca dei suoi stessi
autorevoli rappresentanti, hanno finito per contribuire a rendere vuota di
significato la parola antimafia. L'intervento più duro della giornata è arrivato
dal procuratore di Palermo Francesco Lo Voi che fotografia le macerie
dell'antimafia: "C'è stata forse una certa rincorsa all'attribuzione del
carattere di antimafia, all'autoattribuzione o alla reciproca attribuzione di
patenti di antimafiosità a persone, gruppi e fenomeni che con l'antimafia nulla
avevano e hanno a che vedere. Rincorsa che è servita anche a tentare di crearsi
aree di intoccabilità o magari a riscuotere consensi. Spiace registrarlo a
questa rincorsa non si è sottratta quasi nessuna categoria sociale e, pur con
tutte le cautele del caso derivanti dal rispetto per indagini ancora in corso,
forse neanche qualche magistrato".
L’Antimafia? Una, nessuna,
centomila,
scrive Salvo itale il 24 gennaio 2016 su Telejato. C’È QUALCOSA CHE NON FUNZIONA NEL MONDO DELL’ANTIMAFIA, DI SICURO
NON FUNZIONA IL FATTO CHE CI SIA IN MEZZO IL DENARO. La vera antimafia,
come sosteniamo da anni, tirandoci addosso le ire di tutte le associazioni
antimafia, dovrebbe essere gratuita, in nome degli alti ideali cui fa
riferimento e in nome di tutti coloro che sono morti per mano della mafia senza
avere lucrato una sola lira. Recentemente lo stesso concetto è stato “scoperto”
e ripetuto dal garante anticorruzione Raffaele Cantone e da un altro magistrato
in prima linea contro la ‘ndrangheta, Nicola Gratteri. Un altro magistrato
napoletano, Maresca, ha scatenato le ire di tutta la commissione Antimafia, a
partire dalla sua presidente Rosy Bindi, e naturalmente anche di Don Ciotti, per
aver affermato che anche in Libera “C’è del marcio”, ovvero che la più
prestigiosa associazione antimafia dovrebbe stare un po’ più attenta nella
scelta di coloro cui viene affidata la gestione di alcuni affari e di alcuni
terreni confiscati alla mafia. La notizia di oggi è che il presidente di
Confindustria Sicilia Antonello Montante, bandiera dell’antiracket e strenuo
sostenitore del fatto che bisogna denunciare gli estortori, è stato sottoposto a
perquisizioni domiciliari disposte dalla procura di Caltanissetta ed è sotto
inchiesta, a seguito delle dichiarazioni di alcuni pentiti, con l’accusa di
concorso esterno in associazione mafiosa. L’indagine era partita da un articolo
di Riccardo Orioles,
scritto qualche anno fa, su “I Siciliani giovani” nel quale si denunciava che
Montante era stato testimone di nozze del boss di Serradifalco. Montante, difeso
a spada tratta dalla Procura Nazionale Antimafia e da tutti i suoi colleghi
industriali, cammina sotto scorta, essendo ritenuto un soggetto esposto a
ritorsioni mafiose per la sua costante attività in favore della legalità. Per
anni è stato l’anello di collegamento con prefetti, questori, esponenti del
governo, magistrati, industriali, tutti d’accordo ad esaltare le sue scelte
antimafia e il suo coraggio. Addirittura era stato scelto da Alfano come
componente dell’Agenzia Nazionale dei beni confiscati e quindi avrebbe potuto
facilmente disporne l’assegnazione agli industriali suoi amici: per fortuna,
dopo le polemiche sorte, non ha accettato. Ma Montante ha una serie di
precedenti che dimostrano il fallimento dell’Antimafia di facciata, spesso
scelta per non avere grane, per non essere sottoposto a indagini o, qualche
volta, per coprire certi affari poco puliti. Il caso Helg, anche lui bandiera
dell’antimafia, colto con le mani nel sacco, non è diverso da tutta una serie di
altri casi che puntano alla spartizione di fondi governativi o europei al mondo
delle associazioni antimafia, privilegiando quelle più vicine politicamente a
certi uomini di potere. Nell’albo prefettizio, sono iscritte, solo per l’Italia
meridionale oltre cento associazioni antiracket. Ma già nel marzo del 2012 le
associazioni “La Lega per la Legalità” ed “S.O.S. Impresa” avevano inviato una
lettera al ministro Cancellieri, denunciando la “mercificazione” dell’attività
contro il pizzo, l’esistenza di una “casta dell’antiracket” e, addirittura,
alcuni casi di nomine ‘politiche’ ai vertici di associazioni antimafia diventate
a parere dei firmatari della missiva, mera merce di scambio, in una logica di
premi e promesse elettorali. Allora i fondi del Pon erano stati destinati
soltanto a: “Comitato Addio Pizzo” (1.469.977 euro); Associazione Antiracket
Salento (1.862.103 euro) e F.A.I. (Federazione delle Associazioni Antiracket e
Antiusura), che pur raggruppando una cinquantina di associazioni ottenne
finanziamenti per 7 milioni di euro in qualità di soggetto giuridicamente
autonomo. Altri 3.101.124 euro erano finiti a Confindustria Caserta e
Confindustria Caltanissetta, quella di Montante. Allora si trattava di 13
milioni e 433 mila euro stanziati da Bruxelles che facevano parte del
Pon-Sicurezza, al fine di contrastare gli ostacoli allo sviluppo del
Mezzogiorno. Quei soldi furono distribuiti, con la benedizione dell’allora
ministro Cancellieri e dall’allora sottosegretario all’Interno Alfredo
Mantovano, del commissario antiracket Giosuè Marino, poi assessore in Sicilia
della giunta dell’ex Governatore Lombardo indagato per mafia e del presidente
dell’autorità di gestione del Pon-Sicurezza e al contempo vicecapo della polizia
Nicola Izzo, il prefetto dallo scandalo sugli appalti pilotati dal Viminale.
È cambiato qualcosa in questi anni? Niente: un mare di denaro pubblico
finisce per finanziare progetti di “educazione alla legalità” preparati dalle
associazioni antimafia e antiracket che vanno per la maggiore, ma i risultati
sono pochi, contraddittori e senza risvolti. Per non parlare dell’antimafia da
tribunale, della quale abbiamo detto tante cose, quelle legate alla gestione di Silvana
Saguto e dei suoi collaboratori, con una caterva di persone che hanno
succhiato a questa mammella senza ritegno, cioè magistrati, amministratori
giudiziari curatori fallimentari, avvocati, affaristi, cancellieri,
collaboratori a vario titolo, consulenti ecc. Per tornare alla Confindustria,
dalle varie situazioni giudiziarie è uscito indenne Catanzaro, altro antimafioso
che gestisce la discarica di Siculiana, scippata al comune, assieme al fratello,
vicepresidente, sempre di Confindustria Sicilia. Si potrebbe dire ancora tanto,
ma facciamo solo un cenno ai politici che dell’antimafia hanno fatto una loro
bandiera, che sono presenti a tutte le manifestazioni e agli anniversari, che
hanno costruito le loro fortune grazie a questa bandiera, ammainata quasi
sempre, ma pronta a sventolare nelle grandi occasioni.
Qualcuno direbbe che siamo nella terra di Sciascia, quella dei professionisti
dell’antimafia, qualche altro direbbe che siamo in quella del Gattopardo, in cui
si fa vedere l’illusione del cambiamento per non cambiare, o nella terra di
Pirandello, dove il caciocavallo ha quattro facce, o meglio ne ha una, nessuna,
centomila.
Cantone: "C'è chi usa
l'antimafia, smascheriamolo".
Il presidente
dell'Anticorruzione interviene nella polemica sui beni confiscati alle mafie. E
su Libera dice: "Ha fatto tanto ma è diventata un brand", scrive il 25 gennaio
2016 Maurizio Tortorella su "Panorama". “C’è chi usa l’antimafia e va
smascherato”. Questo dice Raffaele Cantone, oggi presidente dell’Autorità
anticorruzione e dal 1999 al 2007 magistrato attivo a Napoli nella lotta alla
camorra. In questa intervista, Cantone parla della opaca gestione dei beni
confiscati e della durissima denuncia che sulla materia ha lanciato attraverso Panorama Catello
Maresca, proprio il pm che di Cantone è stato il successore alla Procura di
Napoli.
Dottor Cantone, il pm
Maresca attacca “gli estremisti dell’antimafia, le false cooperative con il
bollino, le multinazionali del bene sequestrato”. Le sue accuse sono molto
gravi. Lei è d’accordo con lui?
«Ho
letto l'intervista di Catello Maresca, cui mi legano rapporti di affetto e
amicizia, e anche le precisazioni dopo che è scoppiata la polemica con Libera.
Condivido gran parte dell’analisi svolta da Catello e ritengo sia stato giusto e
opportuno richiamare l’attenzione su cosa sta accadendo in generale nel mondo
dell’Antimafia sociale e nella gestione dei beni confiscati».
Che cosa sta accadendo,
secondo lei, in quel mondo?
«Si
stanno verificando troppi episodi che appannano l’immagine dell’antimafia
sociale e troppe volte emergono opacità e scarsa trasparenza sia
nell’affidamento che nella gestione di beni confiscati. Questi ultimi, invece,
di rappresentare una risorsa per il Paese, spesso finiscono per essere un altro
costo; vengono in molti casi affidati a terzi gratuitamente e a questi
affidamenti si accompagnano spesso anche sovvenzioni e contributi a carico di
enti pubblici. Cosa che può essere anche giusta e condivisibile in astratto ma
che richiede un controllo reale in concreto su come i beni e le risorse vengano
gestite per evitare abusi e malversazioni. Non sono, però, d’accordo nell’aver
individuato quale paradigma di queste distorsioni Libera; e il mio giudizio in
questo senso non è influenzato dai rapporti personali con Luigi Ciotti né dal
fatto che come Autorità anticorruzione abbiamo avviato una collaborazione con
Libera, che rivendichiamo come un risultato importante».
Su Libera, Maresca ha
dichiarato a Panorama:
«Libera gestisce i beni sequestrati alle mafie in regime di monopolio e in
maniera anticoncorrenziale. Sono contrario alla sua gestione: la ritengo
pericolosa». Ha torto o ha ragione?
«Sono
sicuro che in questa parte il ragionamento di Catello sia stato equivocato; non
mi risulta che Libera abbia il monopolio dei beni confiscati e che li gestisca
in modo anticoncorrenziale; conosco alcune esperienze di gestione di beni da
parte di cooperative che si ispirano a Libera (per esempio, le terre di don
Peppe Diana) e li ritengo esempi positivi; beni utilizzati in una logica
produttiva e che stanno anche dando lavoro a ragazzi dimostrando quale deve
essere la reale vocazione dell’utilizzo dei beni confiscati. Condivido, invece,
l’idea di fondo di Catello; è necessario che le norme prevedano che anche
l’affidamento dei beni confiscati debba seguire procedure competitive e
trasparenti, non diverse da quelle che riguardano altri beni pubblici.
Ovviamente tenendo conto delle peculiarità dei beni che si affidano».
Ma lei, che alla Direzione
distrettuale antimafia di Napoli occupava proprio la stanza che oggi è di
Maresca, che cosa pensa di Libera?
«Libera
è un’associazione che ha fatto battaglie fondamentali in questo paese; le va
riconosciuto il merito di aver compreso quanto fosse utile per la lotta alla
mafia l’impegno dei cittadini; e sta provando a fare la stessa cosa anche sul
fronte della corruzione, cosa di cui gli siamo grati. Certo Libera è
un’associazione che è cresciuta tantissimo ed è diventata sempre più nota e
visibile; è diventato anche un “brand” di cui in qualche caso qualche
speculatore potrebbe volersi appropriare per ragioni non necessariamente nobili.
Credo che questo possa essersi in qualche caso anche verificato. E’ però il
rischio di un’associazione che cresce ed è un rischio che ha ben presente anche
Luigi Ciotti che in più occasioni non ne ha fatto nemmeno mistero in pubblico».
Don Ciotti ha annunciato
querela contro Maresca. Viene un po’ in mente la polemica di Leonardo Sciascia
del gennaio 1987 sui «professionisti dell’antimafia»: è possibile criticare
l’antimafia?
«Spero
che Ciotti possa rivedere la sua posizione. Sono certo che, se parlasse con
Maresca, i punti di contatto sarebbero maggiori delle distanze. E lavorerò
perchè questo accada. Credo che la reazione a caldo di Ciotti però si
giustifichi anche perché in questo momento ci sono attacchi a Libera (che non
sono quelli di Catello, sia chiaro!) che giustamente lo preoccupano. Ciò detto,
l’antimafia può ben essere criticata se è necessario e parole anche dure, come
quelle dette anni fa da Sciascia, non possono essere semplificativamente
respinte come provenienti da “nemici”. Sciascia con quella sua frase dimostrò di
essere in grado di guardare molto lontano e di aver capito i rischi della
professionalizzazione di un impegno civile, anche se aveva sbagliato nettamente
l’obiettivo immediato; quelle critiche si riferivano a Paolo Borsellino ed erano
nei suoi confronti ingiuste ed ingenerose».
Maresca dice anche che «è
necessario smascherare gli estremisti dell’antimafia». La frase è forte: ha
ragione?
«Si,
anche se io preferisco dire che bisogna smascherare chi l’antimafia la usa e la
utilizza per fini che nulla hanno a che vedere con le ragioni di contrasto alla
mafia. E negli ultimi tempi di soggetti del genere ne abbiamo visto non pochi!»
Lo scorso settembre il
«caso Saguto» ha fatto emergere a Palermo lo scandalo della cattiva gestione dei
beni confiscati. Il procedimento è in ancora corso. Ma lei che opinione s’è
fatto?
«Il
caso Saguto attende le verifiche giudiziarie, come è giusto che sia; lo spaccato
che emerge può essere valutato a prescindere dagli aspetti penali ed è
decisamente inquietante. Ho sempre pensato che i giudici debbano tenersi lontano
dalle gestioni economiche soprattutto quando passano per incarichi lucrosi e
discrezionali a terzi professionisti, con cui si rischia di creare rapporti
personali oltre che professionali. Da presidente dell’Anac ho chiesto
formalmente al Governo di fissare le tariffe per gli amministratori (a cui sono
legati gli emolumenti per gli amministratori dei beni da noi commissariati)
proprio perchè certe discrezionalità in questo settore possono aprire la strada
ad abusi.»
Certi Uffici misure di
prevenzione dei Tribunali sono forse diventati "enclave" con troppo potere?
«Può
forse essere accaduto in qualche caso, ma le generalizzazioni rischiano di far
dimenticare quanto sia stato importante il ruolo di quelle sezioni del tribunale
nella lotta alla mafia. La natura temporanea di questi incarichi, prevista
opportunamente da regole interne introdotte dal CSM, è un antidoto utile a
favore degli stessi magistrati per evitare eccessive personalizzazioni. Ed
aggiungo, io non sono affatto favorevole alla norma, in discussione in
parlamento, secondo cui le sezioni in questione devono obbligatoriamente
occuparsi solo di prevenzione».
Già nel marzo 2012 l’ex
direttore dell’Agenzia beni confiscati Giuseppe Caruso diceva che "i beni
confiscati sono serviti, in via quasi esclusiva, ad assicurare gli stipendi e
gli emolumenti agli amministratori giudiziari, perché allo Stato è arrivato poco
o niente". Possibile che per altri tre anni sia prevalso l’immobilismo?
«L’affermazione
di Caruso ha un che di vero, ma è comunque esagerata. È vero che ad oggi lo
Stato non è riuscito ancora a cogliere l’occasione di utilizzare in modo più
proficuo i beni confiscati e che è indispensabile un cambio di passo. Non va,
però, dimenticato quanto siano state importanti le confische per indebolire le
mafie. Non vorrei che qualcuno pensasse di utilizzare queste criticità per
indebolire la lotta alla mafia, che ha invece assoluta necessità di utilizzare
le misure di prevenzione patrimoniale».
Più di recente, nel 2014,
Caruso aveva denunciato l’esistenza di amministratori giudiziari "intoccabili",
di "professionisti che hanno ritenuto di disporre dei beni confiscati per
costruire i loro vitalizi" e criticato apertamente l’operato del Tribunale di
Palermo. Era stato criticato ferocemente da sinistra: Rosy Bindi disse che aveva
"delegittimato i magistrati e l’antimafia". Eppure Caruso aveva ragione: allora,
perché è stato isolato?
«Con
il senno di poi non si può dire altro che avesse ragione. Non conoscendo, però,
con precisione le sue dichiarazioni non so se avesse fornito indicazioni precise
che, ovviamente sarebbe stato compito della commissione antimafia approfondire,
o avesse fatto affermazioni generiche che potevano essere considerate
effettivamente delegittimanti. Del resto Caruso, era un prefetto ed un pubblico
ufficiale e se aveva conoscenza di fatti illeciti non doveva limitarsi a
segnalarli all’Antimafia, ma denunciarli alla Procura competente!»
Anche l’Associazione
nazionale magistrati nel 2014 aveva criticato il prefetto: "I magistrati della
sezione misure di prevenzione e i loro collaboratori" si leggeva in un
comunicato "operano in difficili condizioni, conseguendo risultati di assoluto
rilievo (…). Chiunque ricopre incarichi istituzionali (cioè
Caruso,
ndr), ha il dovere di denunciare eventuali illeciti alla competente autorità
giudiziaria e dovrebbe astenersi dal rilasciare dichiarazioni pubbliche non
supportate da elementi di riscontro". Un comunicato che oggi grida vendetta,
vero?
«Spesso
scatta una sorta di riflesso condizionato, di difesa della magistratura e dei
magistrati “a prescindere”. Ma io non voglio altre polemiche con l’Anm. Credo
che l’Anm possa e debba svolgere un ruolo importante anche per tenere alta la
questione morale in magistratura. Ho fatto parte alcuni anni fa del collegio dei
probiviri dell’Anm ed ho verificato quanto fosse difficile applicare le regole
deontologiche. Disponemmo un’espulsione di un magistrato dall’associazione ed
avviammo altri procedimenti analoghi e per capire anche come stilare il
provvedimento di espulsione cercammo precedenti che non trovammo. Fummo
sicuramente noi poco diligenti nel non reperirli».
Una domanda da 30 miliardi
di euro (tanto si dice sia il valore dei patrimoni sequestrati): che cosa
dovrebbe fare lo Stato per gestire al meglio i beni confiscati alle mafie?
«Lo
Stato deve capire quale sia la destinazione migliore e farlo anche grazie ad
esperti indipendenti. In qualche caso ho avuto l’impressione che certe attività,
che funzionavano chiaramente solo perchè gestite da mafiosi, siano state tenute
in vita senza una logica e abbiano finito per creare solo inutili perdite.
Bisogna preferire le destinazioni economiche dei beni, incentivando l’utilizzo
in funzione produttiva piuttosto che destinazioni poco utili.
Per esempio?
«Quante
ludoteche e centri per anziani abbiamo in passato aperto in beni confiscati? È
per questo che credo che iniziative come quelle citate prima, dell’utilizzo di
terreni da parte di cooperative di giovani siano assolutamente da favorire. È un
segnale importante che deve dare lo Stato, di essere capace di utilizzare i beni
per produrre ricchezza, non lasciandoli deperire. Quando nel mio paese vedo un
immobile oggi confiscato, nel quale prima operava una scuola, e oggi è
completamente vandalizzato, mi chiedo se questa non sia l’immagine peggiore che
riesce a dare l’istituzione pubblica».
Non sarebbe meglio vendere
tutto quel che è possibile vendere, come suggerisce Maresca?
«La
vendita deve essere ammessa, ma considerata comunque eccezionale e riguardare
beni che non possono essere destinati in alcun modo. Il primo impegno deve
essere quello di utilizzarli per fini di utilità sociale o per avviare attività
economiche a favore di giovani e soggetti svantaggiati».
Come si evita il rischio
che poi, a ricomprare, siano gli stessi mafiosi o loro teste di legno?
«Il
rischio è reale; ma se si fanno controlli veri, attraverso la Guardia di
finanza, su chi li compra e si stabilisce, per esempio, un vincolo di non
alienazione per alcuni anni, questo rischio si riduce. Eppoi questo rischio non
può giustificare il lasciar andare in malora qualche bene. Meglio è, come
provocatoriamente più volte ha detto Nicola Gratteri, abbatterli e destinare per
esempio i terreni a parchi pubblici!»
Certo, è più facile
alienare beni mobili e immobili confiscati. Lo è meno nel caso delle aziende:
qui quale soluzione prospetta?
«È
molto più difficile gestire un’impresa appartenuta ad un mafioso, che come ho
accennato sopra, spesso si è imposta nel mercato e ha utilizzato il know-how
mafioso per ottenere risultati economici. Perciò va fatta una valutazione
immediata e preliminare per capire se un'impresa è in grado di funzionare. Se no
è meglio chiuderla ed eventualmente vendere i beni che di essa fanno parte. Se
l’impresa è sana o comunque riportabile nella legalità, lo Stato può pensare di
creare condizioni favorevoli (per esempio esenzioni fiscali e crediti di
imposta) per consentirle di operare secondo le regole».
Perché tante aziende
mafiose confiscate falliscono (creando tra l’altro un malessere sociale di cui
poi le mafie inevitabilmente si approfittano)?
«Perché
gli imprenditori mafiosi utilizzano regole diverse nello svolgimento
dell’attività; utilizzano i canali mafiosi per imporre i loro prodotti; non
hanno bisogno di farsi dare soldi in prestito dalle banche; non devono andare in
tribunale per riscuotere i crediti; né rivolgersi a sindacati per i problemi con
i lavoratori. Sono imprese "drogate" e quando viene meno il doping criminale non
reggono il mercato! Il loro fallimento crea sicuramente malessere sociale ma
bisogna stare attenti a salvarle a tutti i costi e fare un’attenta prognosi come
dicevo prima. Spesso in esse lavorano persone direttamente collegati alle cosche
e si rischia, salvandole a spese pubbliche, di foraggiare indirettamente i clan».
Nel luglio 2015, due mesi
prima dell’emersione dello scandalo Saguto, lei aveva chiesto al governo
d’intervenire sulle elevatissime retribuzioni degli amministratori giudiziari.
Aveva intravisto qualche criticità?
«Ho
fatto il pubblico ministero antimafia per otto anni e pur non essendomi occupato
di misure di prevenzione, mi era chiaro come un sistema con regole non chiare
rischiava di aprire il varco ad abusi. In qualche caso mi era capitato di vedere
liquidazioni che mi erano sembrate eccessive. Ammetto, però, che sono sobbalzato
quando ho sentito di alcune liquidazioni di onorari fatti ad amministratori
giudiziari».
Le leggi e la prassi
permettono effettivamente agli amministratori giudiziari dei beni confiscati di
raggiungere retribuzioni elevatissime: è un errore da cancellare, oppure con un
calo dei compensi nessuno accetterebbe?
«Il
rischio c’è: le tariffe introdotte dal provvedimento del governo sicuramente
renderanno meno appetibili le amministrazioni e probabilmente allontaneranno
alcuni professionisti di valore dal settore. C’è pero una certa elasticità che
consente di adeguarle e forse sarà l’occasione per dare spazio a giovani
professionisti che non sempre hanno avuto l’occasione di operare in tale ambito».
Non sarebbe più corretto
ordinare il sequestro di un bene soltanto quando si è dimostrata, almeno nel
primo grado di giudizio, la sua provenienza mafiosa?
«No.
Il sequestro resta un provvedimento necessario per togliere subito i beni ai
mafiosi. Bisogna invece fare in modo che duri il meno possibile e che sia
sostituito da provvedimenti definitivi di confisca».
Non sarebbe bene, anche,
svincolare le competenze sui decreti di sequestro e di nomina degli
amministratori dalle mani di un solo magistrato, per attribuirla a tutti i
magistrati di un pool antimafia?
«Già
è competenza collegiale del tribunale, quantomeno nei casi di confische di
prevenzione. Il sistema prevede controlli sufficienti anche da parte dei vertici
degli uffici. Basta che tutti gli attori siano realmente attenti e scrupolosi
rispetto ai loro compiti. Non sempre può dirsi dopo “non me ne ero accorto” o
“non avevo capito”.»
Il nuovo Codice antimafia,
varato dalla Camera e in attesa di approvazione al Senato, è la soluzione?
«Va
nella giusta direzione per molti aspetti. Vuole migliorare la capacità di lavoro
dell’Agenzia, un’entità utile che ad oggi ha dovuto fare sforzi enormi, per
difficoltà oggettive. Prevede regole più chiare sulla destinazione dei beni. Ci
sono delle criticità in quella normativa, come ad esempio l’estensione
automatica delle regole della prevenzione ai fatti corruttivi che rischia di
creare più problemi di quanti ne risolve. Complessivamente comunque un
provvedimento positivo, ma probabilmente saranno opportuni interventi
modificativi da parte del Senato».
È una soluzione il divieto
giacobino di affidare beni confiscati a un «commensale abituale» del giudice che
decide?
«Come
magistrato lo sento gravemente offensivo; non avrei mai pensato, anche senza
questa regola, di affidare un incarico ad un mio commensale abituale. Certe
vicende, però, giustificano persino regole che dovrebbero rientrare nella
deontologia minima. Quelle vicende, però, sono l’eccezione, per fortuna, perché
di queste regole la maggior parte dei magistrati non ha certo bisogno!»
Torniamo a Catello Maresca:
non crede che ora rischi parecchio (e non sto parlando, ovviamente, della
querela di Don Ciotti…)?
«Lo
escludo. I rischi che ha corso e corre Catello sono legati al suo eccezionale
impegno giudiziario e ai risultati ottenuti, quale la cattura del più importante
boss dei casalesi. E su quell’aspetto non è stato lasciato solo. Nè lo sarà,
assolutamente».
I guai dei paladini antimafia. Rosy
Canale condannata a quattro anni.
Quattro anni di galera. È la condanna inflitta all’ex paladina
antimafia Rosy Canale, la donna che subito dopo la feroce strage di Duisburg del
15 agosto 2007, quando le cosche rivali Nirta-Strangio..., scrive L.R. il 23
gennaio 2016 su “Il Tempo”. Quattro anni di galera. È la condanna inflitta
all’ex paladina antimafia Rosy Canale, la donna che subito dopo la feroce strage
di Duisburg del 15 agosto 2007, quando le cosche rivali Nirta-Strangio e
Pelle-Vottari regolarono i conti in Germania con uno scontro a fuoco che provocò
sei morti, fondò, nel piccolo centro aspromontano scenario della faida, il
«Movimento donne di San Luca». Un barlume di luce, in apparenza, una speranza,
ci si illudeva, che si chiude, tristemente, con la condanna a 4 anni per truffa
e malversazione, a fronte dei 7 chiesti dal pm della Direzione distrettuale
antimafia di Reggio Calabria, Francesco Tedesco. Dunque, per il Tribunale di
Locri che l’ha processata, Rosy Canale, per anni considerata un’icona della
lotta alle cosche, ha davvero utilizzato finanziamenti pubblici destinati
all’attività del «suo» Movimento per scopi personali. La storia, che getta altre
ombre sul mondo dell’antimafia di professione, scosso negli ultimi mesi da
micidiali colpi d’immagine, inizia il 12 dicembre del 2013, giorno in cui la Dda
reggina, coordinata dal procuratore Federico Cafiero de Raho, fa scattare le
manette ai polsi di alcuni ex amministratori comunali, imprenditori e boss. La
donna simbolo dell’antimafia, alla quale non viene contestata l’aggravante
mafiosa, finisce ai domiciliari. L’inchiesta, non a caso denominata «Inganno»,
appare subito solida. Alla Canale i magistrati contestano di aver utilizzato
160mila euro per comprare vestiti delle più note marche e una minicar alla
figlia, arredamento per la casa e oggetti di lusso. Quando il Tribunale del
Riesame revoca l’arresto, la Canale va in tv a parlare di «grande montatura». La
sentenza di ieri toglie, per ora, ogni dubbio. Eppure lei, la donna simbolo di
San Luca, nei panni della paladina antimafia ci si era calata alla perfezione:
vergando libri per raccontare la sua ribellione alla ’ndrangheta, ricevendo il
premio «Paolo Borsellino» (poi ritirato). Persino il Los Angeles Times dedicò un
reportage alle donne di San Luca. La pessima figura dell’«antimafia di
professione», stavolta, ha varcato pure i confini nazionali.
Rosy Canale, 4 anni per truffa alla paladina della
lotta alla ’Ndrangheta. La fondatrice delle «Donne di San Luca» accusata d’aver
utilizzato 160 mila euro di fondi pubblici per comprare vestiti e beni di lusso:
«Me ne fotto, non sono soldi miei», scrive
Carlo Macrì il 22
gennaio 2016. Era considerata un'icona dell'Antimafia Rosy Canale,
l'imprenditrice reggina condannata venerdì dal tribunale di Locri a quattro anni
di carcere, più l'obbligo di risarcire gli Enti che ha truffato attraverso la
sua Fondazione «Donne di San Luca». È proprio attraverso questo movimento che la
Canale, 42 anni, riuscì a ritagliarsi un ruolo nell'Antimafia, «parlando» alle
donne del centro preaspromontano all'indomani della strage
di Duisburg (sei morti) dell'agosto 2007. La procura distrettuale di
Reggio Calabria l'aveva arrestata a dicembre del 2013 con l'accusa di truffa
aggravata e peculato per distrazione. La donna, infatti si era
impossessata dei fondi pubblici comunitari e italiani erogati per finanziare la
sua fondazione antimafia. Centosessanta mila euro che anziché foraggiare il
laboratorio dei saponi artigianali a San Luca, sarebbero finiti nelle tasche
dell'imprenditrice che li avrebbe utilizzati per l'acquisto di abiti firmati e
un'auto per la figlia, vestiti per il padre e beni di lusso. E quando la madre
ha cercato di fermarla - come hanno ascoltato le microspie dei carabinieri -
Rosy replicava: «Me ne fotto, non sono soldi miei». Un passato da imprenditrice
alle spalle, attività abbandonata dopo aver subito la violenza delle cosche
reggine e un futuro da attrice. La sua storia, infatti, è diventata Malaluna,
un'opera teatrale con la regia di Guglielmo Ferro e le musiche di Franco
Battiato. Nel 2013, proprio per il suo impegno antimafia, aveva ricevuto
il premio Borsellino. Quel giorno disse: «Vorrei che Papa Francesco venisse fra
gli ultimi e i dimenticati di San Luca». Quando Rosy Canale arrivò a San Luca
era una sconosciuta. Ascoltando in chiesa il perdono di Teresa Strangio che
nella strage di Duisburg perse il figlio e il fratello, l'imprenditrice capì che
le donne di San Luca alla fine erano propense a rinnegare ogni violenza e a
ripartire. La Prefettura le affidò un bene confiscato alla famiglia Pelle per
dare inizio alle sue attività culturali. Ricami, cucina tipica, ogni donna a San
Luca sembrava muoversi verso una nuova vita. Tutto svanì. Perchè con «Inganno»
l'operazione dei carabinieri che aprì le porte del carcere alla Canale,
sfumarono le idee e la rinascita di un popolo per far posto all'arricchimento di
una donna considerata sino a quel momento una paladina dell'Antimafia.
Condannata a 4
anni Rosy Canale, fondatrice di "Donne di San Luca".
L'ormai ex simbolo dell'antimafia calabrese
riconosciuta colpevole di aver utilizzato a scopi privati gran parte dei fondi
pubblici destinati al suo movimento, scrive Alessia Candito il 22 gennaio 2016
su “La Repubblica”. Rosy Canale Era
divenuta un nome e un volto noto dell'antimafia per le sue campagne in favore
delle donne di San Luca, ma con i soldi di enti e fondazioni si viziava con
vestiti e borse di marca, mobili per la propria casa, viaggi e persino
un'automobile. Per questo motivo, i giudici del Tribunale di Locri hanno
condannato a quattro anni di carcere l'ormai ex stellina dell'antimafia Rosy
Canale, smascherata dall'inchiesta della procura di Reggio Calabria che ha
svelato come la donna tenesse per sé gran parte dei fondi destinati al
"Movimento delle donne di San Luca". Ex titolare di una discoteca, dopo anni
trascorsi tra gli Stati Uniti e Roma Rosy Canale torna in Calabria all'indomani
della strage di Duisburg, l'uccisione di sei persone
vicine al clan Pelle-Vottari di San Luca, che nel 2007 svela alla Germania il
volto della violenza mafiosa. Anche in Italia, l'episodio impone la 'ndrangheta
al centro dell'attenzione nazionale. E Canale fiuta il business. Accreditandosi
come imprenditrice "con la schiena dritta", vittima di un pestaggio per aver
sbarrato il passo agli spacciatori quando gestiva un noto locale reggino, la
donna si precipita a San Luca dove fonda un movimento che - almeno ufficialmente
- avrebbe dovuto dare speranza e lavoro alle donne del piccolo centro nei pressi
di Reggio Calabria storicamente soffocato dalla 'ndrangheta. In realtà, puntava
solo ad arraffare quattrini. Grazie a una strategia mediatica abilmente
pianificata, condita da
diverse denunce di minacce fasulle, ma strombazzate - scrivono i magistrati -
"con l'unico scopo di cavalcare l'allarme sociale in modo da acquisire
credibilità sia in campo politico che nel contesto dei rapporti con soggetti
istituzionali", Canale si accredita in fretta. Ministero della Gioventù,
Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, Prefettura di Reggio Calabria
e Fondazione "Enel Cuore" le inviano finanziamenti per centinaia di migliaia di
euro. Al centro di San Luca, ottiene anche un immobile confiscato che sarebbe
dovuto diventare una ludoteca per le sue "donne di San Luca", ma dopo
l'inaugurazione non entrerà mai in funzione. Canale sforna un libro, gira
l'Italia con il suo spettacolo teatrale e spende senza freni. A chi, come la
madre, le raccomanda prudenza e moderazione - raccontano le intercettazioni - la
donna risponde, arrogante: "Me ne fotto". Ma forse, alla luce della sentenza
delle Tribunale di Locri, avrebbe fatto meglio a dare ascolto a quei consigli.
La verità di Rosy Canale: "Non ho preso
soldi, ma ora sono una persona finita,
scrive Claudio Cordova su “Il Dispaccio”
del 23 giugno 2014. "Io sono una persona finita
perché è stata intaccata la mia credibilità a 360 gradi su quello che io,
Dottore, ho lavorato per anni ed ho creduto con tutta me stessa". E, ancora: "Ho
una sola amarezza, che ho stimato tante – col cuore, persone che lavorano qua
dentro e persona che lavorano qua dentro si sono permessi di dire delle cose che
non erano vere, non avevano prove documentali screditandomi a livello nazionale
e internazionale". Due interrogatori. Uno al cospetto del Gip Domenico Santoro,
l'altro, alcuni mesi dopo, davanti al pm Francesco Tedesco. Interrogatori lunghi
e intensi che non hanno permesso, tuttavia, a Rosy Canale, ex eroina antimafia e
promotrice del Movimento Donne di San Luca, di evitare l'udienza preliminare
davanti al Gup Davide Lauro nell'ambito dell'indagine "Inganno" che, oltre a
svelare le ingerenze delle cosche nella vita pubblica del borgo aspromontano
della Locride, coinvolgerà anche la stessa Canale che, a detta della Procura,
avrebbe utilizzato una parte dei finanziamenti concessi da varie Istituzioni al
Movimento per proprie spese personali. A Rosy Canale, gli inquirenti arriveranno
grazie ai numerosi contatti che la donna avrà con gli amministratori locali di
San Luca, fino al momento dello scioglimento del Comune. Il Movimento "Donne di
San Luca" otterrà - per la propria attività di sostegno alle donne vittime della
'ndrangheta – anche un bene confiscato: un immobile sottratto alla potente cosca
Pelle "Gambazza" di San Luca, destinato a ludoteca, inaugurata nel 2009, ma mai
entrata in funzione. Rosy Canale avrebbe ricevuto finanziamenti da un arco
vastissimo di Istituzioni. Ministero della Gioventù, Presidenza del Consiglio
Regionale della Calabria, Prefettura di Reggio Calabria e Fondazione "Enel
Cuore". E il lungo interrogatorio dal Gip Domenico Santoro, nei giorni
successivi all'ordinanza cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della
donna si sofferma sui vari finanziamenti ricevuti. A cominciare da quello del
Consiglio Regionale, in quel periodo presieduto da Giuseppe Bova:
GIUDICE -. Mi dica di come nasce il finanziamento
di 5.000 euro da parte della Presidenza del Consiglio Regionale.
INDAGATA CANALE -. Con una telefonata, Dottore,
perché era periodo pre-elettorale e c'era gente che regalava soldi, se gliela
devo proprio dire tutta in maniera sfacciata.
GIUDICE -. Ma con chi l'ha fatta questa
telefonata?
INDAGATA CANALE -. Con Strangio, il segretario
di...
GIUDICE -. Con l'Avvocato Giuseppe Strangio.
INDAGATA CANALE -. Esatto.
E però ci sono anche i soldi ricevuti dal
Ministero della Gioventù, in quel periodo retto da Giorgia Meloni, "Giorgietta",
come la chiama Rosy Canale in alcune intercettazioni. Un finanziamento che
sarebbe nato da una telefonata del Capo Dipartimento del Ministero della
Gioventù, Andrea Fantoma, interessato, a detta della Canale, alle attività delle
Donne di San Luca:
INDAGATA CANALE -. E tra l'altro il Dottore
Fantoma mi disse, proprio per chiarezza, che qualunque cosa succedeva e avevo
bisogno di qualunque riferimento, l'uomo sul territorio che li rappresentava era
Franco... aiutatemi... Franco... il Consigliere Regionale arrestato con l'accusa
di avere collusioni...
GIUDICE -. Morelli?
INDAGATA CANALE -. Franco Morelli, esatto. Tra
l'altro, Dottore, nel mio cellulare ci sono due o tre messaggi inviati al Dottor
Morelli, dove io dico per conto del Dottor Fantoma mi ha detto di contattarla
per dire se ci sono delle iniziative a livello regionale che ci possano aiutare
in qualche modo, questa persona non mi rispondeva né telefonicamente alle
chiamate e né ai messaggi, e poi un giorno mi scrisse: "Guardi, se vuole ci
incontriamo" e lo può verificare agli atti, sennò le produco io il cellulare mio
e lo può evidenziare, "Se vuole ci vediamo, tanto io non sono... non mi piace
avere contatti telefonici" e poi voglio dire è questo.
Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il Gip
Santoro contesta all'indagata una serie di conversazioni anche piuttosto
imbarazzanti, dalle quali, secondo le indagini condotte dai pm Nicola Gratteri e
Francesco Tedesco, emergerebbe l'uso disinvolto per fini personali di soldi
destinati al Movimento Donne di San Luca: "Io ho un modo molto goliardico nel
parlare a volte, spiritoso, che viene frainteso, è facilmente fraintendibile" si
difende Rosy Canale. L'ex pasionaria antimafia, però, nega con forza di essersi
appropriata di somme destinate per la lotta alla 'ndrangheta su un territorio
difficile, come quello di San Luca: "Si può fare una visura patrimoniale e
vedere che cos'ho, si può fare una visura di qualunque tipo, si possono prendere
sotto sequestro i miei vestiti, Dottore, e vedere se ci sono cose più costose di
30 euro, vestiti come scarpe, non ho macchine intestate, cioè se io avessi preso
questi soldi, che non ho preso Dottore, ci dovrebbe essere, come dire, un cambio
di tenore che io non ho mai avuto, Dottore una traccia qualunque. Quando mi
viene scritto qua, le ripeto, che io ho pagato una settimana bianca per mia
figlia...". A proposito di antimafia e di lotta alla 'ndrangheta, nei propri
racconti, spesso a ruota libera, Rosy Canale non disdegna qualche stoccata ad
altri movimenti legalitari, quelli sì, a suo dire, fatti di parole e poco altro:
"Io non sono stata una di quelle che scende in campo, Dottore, con i fiorellini,
che va sottobraccio con i Procuratori per avere i finanziamenti di altro genere
e fare le manifestazioni e poi intelligentemente e meno, come dire, sprovvedute
di me, mettono le pezze d'appoggio e poi si fanno i fatti loro, io sono stata
una di quelle che è scesa in campo a sporcarsi le mani a San Luca, e queste cose
se si sarebbero realizzate, e magari il Signore si fossero realizzate, avrebbero
cambiato il volto di quel paese, perché questi soldi... se io mettevo in campo
una cosa del genere con il Ministero, che doveva fare questa cosa, perché il
fatto di cavalcare la legalità molta gente la cavalca, ma la cavalca in altri
sensi, Dottore, io sono andata a San Luca, ho vissuto con quella gente, io mi
sono battuta lì. L'unica cosa è che Rosy Canale non ha fatto la favoletta, è
andata lì sul territorio e oggi è qui a parlare con Lei per questo motivo,
invece di fare le passerelle come altri". Lei avrebbe lavorato, lei si sarebbe
battuta. E il Movimento sarebbe stato una cosa seria. Rosy Canale lo ribadisce
anche lo scorso 30 aprile, quasi cinque mesi dopo l'emissione dell'ordinanza
nell'ambito dell'operazione "Inganno": Viene scritto viene detto che il
movimento delle donne è stato creato e fondato per creare con raggiri e artifizi
diciamo per sottrarre dei soldi pubblici o comunque ecco allora, io brevemente
sicuramente perché capisco che il tempo è prezioso per tutti però desidero che
lei mi ascolti allora, io ho fondato questo movimento sono arrivata a San Luca
poco dopo della strage di Duisburg per un desiderio mio personale. Già da subito
avevo scritto una lettera via mail mi ero messo in contatto su facebook con il
sindaco di allora che era Giuseppe Mammoliti scrivendo il mio cordiglio più
profondo per tutto quello che era successo da calabrese, da persona che ama
profondamente questa terra, lui mi rispose, da quel momento io ho iniziato a
pensare a qualcosa che poteva che io nel mio pi piccolissimo potevo creare e
fare per quella comunità". In quell'occasione, però, Rosy Canale ammetterà: "Io
ho fatto un sacco di ingenuità". Con riferimento all'interrogatorio di garanzia,
invece, più volte, il Gip Santoro contesta all'indagata le proprie
intercettazioni, spesso dai contenuti autoaccusatori. Tutte frasi che Rosy
Canale bolla come delle semplici chiacchiere, magari sconvenienti e
superficiali, ma solo chiacchiere con le proprie amiche o con i propri
familiari: "Le do questo aspetto, allora io e mio padre siamo molto... a volte
parliamo di queste dinamiche qua, di alcuni aspetti della parte storica di
quella che è una costruzione proprio... ricostruzione storica della 'ndrangheta,
perché ci sono tutti degli aspetti anche, come dire, culturali, sociologici". Al
Gip Santoro, però, le chiacchiere interessano poco. Interessano molto di più i
fatti contestati alla donna, che, sempre secondo la Procura, avrebbe utilizzato
decine di migliaia di euro per varie utilità personali: dall'acquisto due
autovetture – una Smart e una Fiat 500 – a quello di vestiti e mobili, nonché la
possibilità di effettuare viaggi di natura privata. "Me ne fotto". Così Rosy
Canale rispondeva alla madre, che le raccomandava di spendere con attenzione i
soldi che le arrivavano da Istituzioni varie: dalla Presidenza del Consiglio
Regionale, alla Prefettura, passando per l'associazione "Enel Cuore". A detta
dei giudici, i soldi destinati al Movimento "Donne di San Luca" "sono stati
biecamente piegati ai propri interessi personali dalla presidente di quel
movimento". Nell'ottobre 2009, in particolare, sarebbe arrivato un grosso
finanziamento e proprio in quel momento, Rosy avrebbe sua figlia e "le chiede di
che colore vuole le Hogan perché sono arrivati i soldi". La ragazza chiede
"quanto si tiene lei e Rosy risponde che poi vedrà". Ma Rosy Canale si difende
di fronte alle varie intercettazioni. Anche quella in cui ammetterebbe di aver
tenuto per sé 3000 euro tra i fondi destinati alla ludoteca:
INDAGATA CANALE -. Aspetti, Dottore, non voglio
mettere in difficoltà nessuno, però c'è una cosa, io questi 3.000 euro sono
stata autorizzata dalla Prefettura a prenderli, loro mi dissero "Riserva per te,
per il lavoro che stai facendo, 3.000 euro".
GIUDICE -. C'è una carta scritta?
INDAGATA CANALE -. No, non c'è niente di scritto.
GIUDICE -. Chi gliel'ha detto? Lei capisce che nel
momento... o si avvale della facoltà di non rispondere o me lo dice, si sta
difendendo, mi sta dando una prova d'alibi, tra virgolette.
INDAGATA CANALE -. Lo so, Dottore, però... il
Dottore Priolo me lo disse.
GIUDICE -. Va bene.
INDAGATA CANALE -. Che era il mio angelo custode,
mi disse... mi disse: "Guarda Rosy, tu stai facendo un lavoro grandissimo e
credo che sia giusto che tu abbia qualcosa, prenditi 3.000 euro, non di più,
però questi 3.000 euro prenditeli perché sono giusti".
Gianluca Calì ha acquistato
all'asta un'abitazione di pregio un tempo di proprietà dei boss di Bagheria,
Michelangelo Aiello e Michele Greco. Prima gli sono arrivate le minacce di
sedicenti “eredi”, quindi non ne ha più potuto usufruire, perché finita in un
vortice di sequestri disposti da alcuni ufficiali della Forestale poi finiti nel
mirino della procura, scrive Giuseppe Pipitone il 28 giugno 2013 su “Il Fatto
Quotidiano”. Ha acquistato all’asta una villa un tempo di proprietà dei boss
mafiosi. Prima gli sono arrivate le minacce di sedicenti “eredi”, quindi non ha
più potuto usufruire dell’abitazione, perché finita in un vortice
di sequestri disposti da alcuni ufficiali della Forestale poi finiti sotto
inchiesta. Da quando Gianluca Calì ha deciso di tornare a lavorare nella sua
Sicilia i guai sono spuntati ad ogni angolo. Come funghi. Siamo ad Altavilla
Milicia, zona costiera tra Bagheria, Casteldaccia e Palermo. È qui che Calì
torna nel 2009 per aprire una succursale della sua concessionaria d’automobili
milanese: la Calicar. Ma al pronti via, qualcosa comincia subito ad andare
storto: a Calì arriva immediatamente una richiesta di pizzo dalla cosca mafiosa
locale. “Richiesta che non mi sono mai sognato di assecondare, li ho denunciati”
sottolinea lui da siciliano orgoglioso. Il 3 aprile del 2011 alcune automobili
della sua concessionaria di Casteldaccia vanno a fuoco. La storia di Gianluca
Calì, l’imprenditore antiracket, finisce sui giornali. “Mi è stato vicino
soprattutto il centro Pio La Torre” dice lui. Intanto le indagini degli
inquirenti portano in carcere 21 affiliati al clan di Bagheria: tra questi anche
i suoi estorsori. Storia finita? Neanche per idea. Perché nel frattempo Calì ha
avviato le pratiche per acquistare all’asta una villa vicino Casteldaccia: due
piani da 160 metri quadrati l’uno. “L’idea era quella di trasformarla in una
struttura ricettiva, che potesse creare un minimo di ricchezza per la nostra
terra, dare lavoro e incrementare l’indotto turistico della zona”, spiega.
Quella villa però non è una casa qualsiasi: apparteneva allo storico padrino di
Bagheria Michelangelo Aiello e al suo sodale Michele Greco, il Papa di Cosa
Nostra. Non è mai stata confiscata perché era ipotecata ed è quindi passata
nelle disponibilità di un istituto di credito che lo mette all’asta. “Poco prima
di presentare la mia offerta, ricevo la visita di alcuni personaggi”, racconta
Calì. Si presentano come “eredi dei precedenti proprietari” e chiedono
all’imprenditore di “lasciar perdere quella casa”. “Risposi di ripetere le loro
parole davanti ad un giudice, dopo di ché mi aggiudicai la casa”, spiega Calì. E
per un po’ sembra passare tutto liscio. La quiete però dura poco. Perché l’8
febbraio scorso la villa che fu dei boss viene sequestrata da due
ispettori della Forestale. “Stato grezzo e in corso d’opera”, scrivono nel
verbale di sequestro, come se la costruzione fosse stata costruita di sana
pianta in maniera abusiva. Così non è, perché quella villa esiste dal 1965, e
Calì sta solo attuando dei lavori di ristrutturazione. Fa opposizione al
sequestro e il 4 marzo ritorna in possesso dell’immobile. I “solerti” ispettori
della Forestale però non demordono. E il 15 marzo sequestrano di nuovo la villa
con le stesse motivazioni. Solo un duplice intoppo burocratico? Un errore?
Possibile. Il verbale di sequestro porta due firme: sono gli ispettori della
Forestale di Bagheria Luigi Matranga e Giovanni Coffaro. Che a fine marzo
finiscono coinvolti in un’inchiesta della procura di Palermo: alcuni dipendenti
della Forestale di Bagheria ricattavano gli abitanti della zona minacciando il
sequestro di immobili. In cambio chiedevano somme di denaro. “Una vicenda –
scrive il gip Angela Gerardi – in cui emerge lo scarso se non inesistente senso
del dovere e indegno esercizio del potere che interessa alcuni componenti
dell’ufficio del corpo forestale (tra questi viene citato proprio Giovanni
Coffaro) e l’irresponsabile comportamento da parte di altri (come il comandante
Luigi Matranga)”. In carcere finiscono in quattro. Coffaro, uno dei due che
sequestra la villa di Calì, è tra gli indagati anche se il gip ha respinto
l’arresto. Nelle carte dell’inchiesta si ipotizza invece che Matranga, l’altro
estensore del verbale di sequestro, fosse a conoscenza del “lavoro
sporco” portato avanti dai suoi sottoposti. “Matranga non ha mai presentato una
denuncia né ha mai segnalato i comportamenti dei suoi subordinati” scrive sempre
il gip. A Calì però non è mai arrivata una richiesta formale di “messa a posto”
per dissequestrare la villa. “Finora ho speso migliaia di euro per far valere
un mio diritto contro un verbale che non sta né in cielo né in terra. Eppure
questi si accontentavano di 500 euro”. Dalle maglie dell’inchiesta sui forestali
però emerge anche altro: l’ombra della mafia di Bagheria. Un elemento in più se
si pensa che i lavori di ristrutturazione della villa che fu di Greco sono
affidati dall’imprenditore palermitano a suo fratello, l’ingegner Alessandro
Calì. Che i tentacoli della piovra li ha visti da vicino qualche tempo fa,
quando da presidente dell’ordine degli ingegneri ha radiato dall’albo Michele
Aiello, il ricchissimo prestanome di Bernardo Provenzano. Aiello è un uomo
potente e fortunato: condannato a 15 anni di carcere è riuscito a trascorrerne
uno ai domiciliari, proprio nella sua Bagheria, perché affetto da favismo. Solo
una coincidenza? Può darsi. Nel frattempo la villa che fu dei boss rimane
sequestrata in attesa che la Cassazione si esprima nel settembre prossimo. “Io
volevo soltanto provare a rilanciare la nostra terra. Ma per un imprenditore
onesto, imbattersi non solo nella mafia, ma anche in infedeli servitori dello
Stato non è un bel segnale”. E in Sicilia, isola che vive soprattutto di
segnali, è ancora peggio.
Vatti a fidare dell'antimafia. Il
ministro Orlando: "Lo scandalo dell’antimafia è un gravissimo colpo alla
credibilità delle istituzioni". In un intervento su Panorama in edicola dall'8
ottobre, il Guardasigilli commenta lo scandalo dell’Ufficio misure di
prevenzione antimafia di Palermo, scrive "Panorama" il
7 ottobre 2015. "Quanto sin qui è emerso a Palermo, nonostante siano ancora in
corso i doverosi accertamenti, rischia di rappresentare un
colpo gravissimo alla credibilità delle
istituzioni su un terreno delicato come quello del contrasto alle mafie". Così
si esprime Andrea Orlando,
ministro della Giustizia, in un testo affidato al settimanale Panorama, che lo
pubblica nel numero in edicola da giovedì 8 ottobre. Panorama aveva interpellato
il Guardasigilli sullo scandalo dell’Ufficio misure di prevenzione antimafia di
Palermo: da metà settembre quel Tribunale
è scosso da un’inchiesta per corruzione che
ha coinvolto finora cinque magistrati e ipotizza gravissimi abusi
sull’attribuzione degli incarichi ai custodi giudiziari, con parcelle
milionarie. Orlando aggiunge: "Il solo dubbio che nella gestione dei beni
sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali possano essersi celati e
sviluppati fenomeni di malaffare deve
provocare la più vigorosa delle reazioni".
l pm antimafia Maresca: "Libera ha il
monopolio della gestione dei beni sequestrati". Sul numero di Panorama in
edicola dal 14 gennaio, il giudizio durissimo del magistrato sull'associazione,
scrive "Panorama" il 13 gennaio 2016. "Libera è stata un’importante associazione
antimafia. Ma oggi mi sembra un partito che si è auto-attribuito un ruolo
diverso. Gestisce i beni sequestrati alle mafie in regime di monopolio e in
maniera anticoncorrenziale. Personalmente sono contrario alla sua gestione: la
ritengo pericolosa". Così si esprime Catello
Maresca, 43 anni e da 11 magistrato
della Direzione nazionale antimafia di Napoli, impegnato in prima linea
nella lotta ai clan della camorra, in un’intervista che Panorama
pubblica nel numero in edicola da domani, giovedì 14 gennaio. "Oggi"
aggiunge Maresca "per combattere la mafia è necessario smascherare gli
“estremisti dell’antimafia”, i monopolisti di valori, le false cooperative con
il bollino, le multinazionali del bene sequestrato. Registro e osservo che
associazioni nate per combattere la mafia hanno acquisito l’attrezzatura mentale
dell’organizzazione criminale e tendono a farsi mafiose loro stesse". Il
magistrato insiste: "Purtroppo queste associazioni hanno esasperato il sistema.
Sfruttano beni che non sono di loro proprietà, utilizzano risorse e denaro di
tutti. Vedo insomma l’estremismo dei settaristi e non di un’associazione ogni
qual volta sento dire che 'si deve fare sempre così'". E
conclude affidando a Panorama questo
duro giudizio: "Libera gestisce i beni attraverso cooperative non sempre
affidabili. Io ritengo che questa antimafia sia incompatibile con lo spirito
dell’antimafia iniziale".
Il Pm Maresca critica Libera su Panorama
e Don Ciotti si infuria. "Gestisce i beni sequestrati alle mafie in modo
anticoncorrenziale". Lo denuncio, risponde il fondatore. A lui la solidarietà di
Rosy Bindi e Claudio Fava, scrive "Panorama" il 13
gennaio 2016. Giornata convulsa attorno a Libera dopo l'anticipazione di
un'intervista al pm antimafia
Catello Maresca che Panorama pubblica
sul numero in edicola il 14 gennaio. In essa Maresca dice che "Libera è stata
un’importante associazione antimafia. Ma oggi mi sembra un
partito che si è auto-attribuito un ruolo diverso. Gestisce i beni
sequestrati alle mafie in regime
di monopolio e in maniera anticoncorrenziale. Personalmente sono
contrario alla sua gestione: la ritengo pericolosa". Parole forti. Don
Ciotti non ci sta. Lo denunciamo, dice don Ciotti.
"Noi questo signore lo denunciamo domani mattina, abbiamo deciso di farlo. Uno
tace una volta, due volte, tre volte, ma poi si pensa che siamo nel torto. Il
fango fa il gioco dei mafiosi", ha tuonato don Ciotti, davanti alla
Commissione parlamentare antimafia. Oggi infatti era il giorno dell'Audizione
del fondatore di Libera da parte dell'organismo presieduto da Rosy Bindi. Le
parole di Maresca risuonano anche più forti in questi giorni nei quali è alta
l'attenzione sul mondo dell'antimafia che ha scosso il tribunale di Palermo con
il "caso Saguto". "Le dichiarazioni di questo magistrato sono sconcertanti,
chiedo che ci sia verità e
giustizia in questo Paese", aggiunge don Ciotti. Che poi ricorda che
"per la gestione dei beni confiscati Libera
non riceve contributi pubblici, le associazioni ricevono in gestione i
beni, Libera non riceve alcun bene. Libera promuove, agisce soprattutto sulla
formazione. Sono pochissimi i beni assegnati a Libera, che gestisce solo 6
strutture, di cui una a Roma e una a Catania, su 1600 associazioni che la
compongono. È in atto una semplificazione per demolire il percorso di
Libera con la menzogna". Il fondatore di Libera ammette tuttavia che "il
tema dell'infiltrazione è reale: le nostre rogne sono iniziate con i 17
processi in cui siamo parte civile, lì ci sono situazioni complesse. Altri
problemi vengono dalle cooperative: abbiamo scoperto che alcune situazioni erano
mutate, siamo dovuti intervenire. Qualche tentativo di infiltrazione c'è ed è
trasversale a molte realtà italiane. Abbiamo allontanato il consorzio Libero
Mediterraneo e realtà che non avevano più i requisiti e queste gettano il
fango". "Le trappole dell'antimafia
sono davanti ai nostri occhi, mai come oggi. Si deve eliminare anche questa
parola Antimafia, che è un fatto di coscienza", conclude Ciotti, che respinge
anche le accuse di non aver tenuto gli occhi aperti su Roma: "ricordo che nel
2011, alla riapertura del Caffè de Paris, sequestrato a clan calabresi, Libera
lanciò l'allarme sulle infiltrazioni mafiose nell'economia della Capitale e
prima dello scoppiare dell'inchiesta su Mafia Capitale, a Corviale, denunciammo
ancora questa presenza". Solidarietà a don Ciotti e a Libera è arrivata da Rosy
Bindi che ha giudicato le parole del magistrato "gratuite e infondate", dal
vicepresidente della Commissione Claudio Fava (Si), che ha parlato di
"affermazioni calunniose e ingenerose", dal capogruppo del Pd Franco Mirabelli,
che ha sottolineato tuttavia come "serva oggi un ripensamento dell'antimafia" e
del Pd Davide Mattiello, che ha espresso "sconcerto per le parole del pm, salvo
smentite e chiarimenti". Maresca, 43 anni e da
11 magistrato della Direzione nazionale antimafia di Napoli, è
impegnato in prima linea nella lotta ai clan della camorra. Nell'intervista a
Panorama aggiunge che "oggi per combattere la mafia è necessario smascherare gli
'estremisti dell’antimafia', i monopolisti di valori, le false cooperative con
il bollino, le multinazionali del bene sequestrato. Registro e osservo che
associazioni nate per combattere la mafia hanno acquisito l’attrezzatura mentale
dell’organizzazione criminale e tendono a farsi mafiose loro stesse". Il
magistrato insiste: "Purtroppo queste
associazioni hanno esasperato il sistema. Sfruttano beni che non sono
di loro proprietà, utilizzano risorse e denaro di tutti. Vedo insomma
l’estremismo dei settaristi e
non di un’associazione ogni qual volta sento dire che 'si deve fare sempre
così'". E conclude affidando a Panorama questo duro giudizio: "Libera gestisce i
beni attraverso cooperative non sempre affidabili. Io ritengo che questa
antimafia sia incompatibile con lo spirito dell’antimafia iniziale".
A volte l'antimafia sembra
mafia. È Il pensiero di Catello Maresca, magistrato antimafia a Napoli che ha
accusato Libera: "Sono contrario a come gestisce i beni sequestrati alle mafie",
scrive il 18
gennaio 2016 Carmelo Caruso su "Panorama". In quest'intervista, pubblicata sul
numero di Panorama in edicola dal 14 gennaio, il magistrato Catello Maresca
punta il dito contro un certo tipo di antimafia e contro Libera, l'associazione
fondata da Don Ciotti che gestisce i beni sequestrati alle mafie "in regime di
monopolio e in maniera anticoncorrenziale". Le sue dichiarazioni hanno suscitato
lo sdegno di Don Ciotti che ha risposto alle accuse. Ecco l'integrale
dell'intervista.
Dice che i bunker lo
tormentino.
"Da magistrato ho passato 10
anni a studiare quello di Michele Zagaria".
Il padrino di “Gomorra”?
"Non solo un padrino. La sua
biografia criminale è l’autobiografia di un popolo e di un territorio". Le piace
studiare il sottosuolo? "Mi piace perché tutta la mafia è un mondo capovolto. I
mafiosi abitano sottoterra, parlano con il sottotesto, utilizzano un soprannome.
La mafia si nasconde e si maschera nell’opposto".
È l’antimafia l’ultimo
travestimento della mafia?
"È stata ed è la più
eccezionale via di fuga che la mafia ha escogitato per celarsi".
È più pericolosa la mafia
di sotto o l’antimafia di sopra?
"Oggi per combattere la mafia
è necessario smascherare gli “estremisti dell’antimafia”, i monopolisti di
valori, le false cooperative con il bollino, le multinazionali del bene
sequestrato. Registro e osservo che associazioni nate per combattere la mafia
hanno acquisito l’attrezzatura mentale dell’organizzazione criminale e tendono a
farsi mafiose loro stesse".
Parla di “Libera”,
l’associazione fondata da Don Ciotti?
"Libera è stata un’importante
associazione antimafia. Ma oggi mi sembra un partito che si è autoattribuito un
ruolo diverso. Gestisce i beni sequestrati alle mafie in regime di monopolio e
in maniera anticoncorrenziale. Personalmente sono contrario alla sua gestione e
la ritengo pericolosa".
A Napoli, Catello
Maresca, magistrato della direzione nazionale antimafia, ha ereditato la stanza
dell’uomo più invocato e affaccendato d’Italia quel Raffaele Cantone oggi
presidente dell’Anac.
"E non ho ereditato solo la
stanza ma anche i fascicoli, i quadri e la sua assistente".
Come si chiama?
"Rosaria. Un esempio di
pazienza e laboriosità".
Maresca assomiglia alle sue
indagini che sono lente ma solide e non improvvise ma deboli. Con metodo che lui
chiama scientifico ha catturato i gangster di Casal di Principe, i “Tony
Montana” che canta il neomelodico Nello Liberti: "O
capoclan è n’omm serio, che è cattivo nun è o ver".
Dove ha iniziato?
"A Torre Annunziata. Mi occupavo di crimini finanziari".
Figlio di magistrati?
"Maestri elementari entrambi,
vengo dalla provincia e mi piace ritornarci".
Maresca ha quarantatre anni e
da undici è magistrato della direzione antimafia di Napoli, "una città che muore
di doppiezza". Come i dati che immagazzina e assembla, Maresca si lascia
crescere una barba fiamminga e dura che non taglia, "per un principio d’economia
temporale" dice, ma anche per trattenere le idee e le parole che infatti sulla
barba si fermano e non scivolano.
Chi è stato il suo maestro?
"Franco Roberti, un magistrato
eccellente e oggi procuratore nazionale antimafia".
È ancora credibile
l’antimafia dopo lo scandalo di Palermo dove a essere indagato dalla procura di
Caltanissetta per induzione, corruzione, abuso d’ufficio è l’ex presidente della
sezione misure di prevenzione, il giudice Silvana Saguto?
"L’antimafia è stato un
fenomeno volontaristico. Credo a quella delle origini ma non credo a quella che
si ostenta e che si è fatta impresa".
Per Giapeto editore,
Maresca ha pubblicato “Male Capitale”, un libro che grazie alle foto di Nicola
Baldieri non è solo un documento antropologico, i “tristi tropici” della camorra
e delle sue tane, ma anche un campionario di non luoghi, il catalogo dei beni
confiscati e inceneriti dalla cattiva procedura. Maresca stila un piccolo elenco
campano: l’ex convento dei Cappellini Avella, l’hotel Zagarella, la villa di
Walter Schiavone, la Calcestruzzi Po.li, l’azienda agricola La Malsana, gli
autocompattatori della Eco Quattro.
"E poi ci sarebbe l’azienda
Bufalina, un gioiello che venduto sarebbe stato non solo un simbolo di vittoria
da parte dello Stato, ma anche un pezzo d’identità restituito alla Campania".
Le imprese sequestrate ai
mafiosi si devono vendere?
"Vendere, vendere, vendere. Mi
chiedo che fini sociali possa avere un capannone industriale. Oggi il tabù
dell’antimafia è la parola vendita. Una volta sequestrati i beni, bisogna
individuare quelli riutilizzabili per fini sociali. Dove possibile si possono
costruire caserme ad esempio. Ma tutto il resto è da alienare".
Anche Maresca conosce i numeri
del fallimento che hanno accompagnato la gestione dei beni sequestrati: 11 mila
immobili, 2000 imprese, 90 per cento è il parametro delle aziende estinte.
"Il ciclo di vita è sempre lo
stesso. Prima li divorano gli amministratori giudiziari poi le carcasse vengono
divise dai tribunali fallimentari".
Non sono i magistrati a
decidere la loro sorte?
"E io infatti rispondo che i
magistrati non possiedono quella expertise necessaria per svolgere questo
compito. Non è un caso che la gestione concreta sia poi appaltata alle
associazioni".
Da “cosa nostra” a “cosa
loro”?
"Purtroppo queste associazioni
hanno esasperato il sistema. Sfruttano beni che non sono di loro proprietà,
utilizzano risorse e denaro di tutti. Vedo insomma l’estremismo dei settaristi e
non di un’associazione ogni qual volta sento “che si deve fare sempre così”.
Don Ciotti ha scomunicato e
cacciato il figlio di Pio La Torre, Franco, per lesa maestà proprio per le
stesse critiche.
"Sarò malpensante ma i
malpensanti sono a volte ottimisti che non hanno fretta. Libera ha monopolizzato
la gestione dei beni sequestrati alle mafie".
E però, Libera dice di non
avere mai gestito beni...
"Libera li gestisce attraverso
cooperative che non sempre sono affidabili. Io ritengo che questa antimafia sia
incompatibile con lo spirito dell’antimafia iniziale".
Maresca smonta anche il
pregiudizio della mafia come destino, la convinzione che il suo influsso si
riproduca e ritorni come la maschera sith di Dart Vader in Star Wars.
"Sinceramente trovo risibile
la ragione per cui Libera si oppone alla vendita. Si dice: “I beni ritornano ai
mafiosi”. Io rispondo che sono contento due volte perché lo Stato li
sequestrerebbe due volte e ci guadagnerebbe il doppio. La verità è che uno Stato
può, anzi, deve riuscire a controllare la vendita di un bene sequestrato. Da
uomo delle istituzioni non posso pensare che lo Stato non sia nelle condizioni
di farlo. È un’idea d’impotenza".
Il nuovo codice antimafia
non le piace?
"Ripeto, rimane ancora tabù la
parola vendita e farraginosa la gestione. Eppure un esempio virtuoso ce lo
abbiamo già. È l’Anac guidata da Cantone".
Non crede che Cantone non
sia più un magistrato ma un oracolo?
"Essere bravi non è una colpa
diverso è quando i mediocri salgano sulle spalle dei bravi appesantendoli.
Perchè non fare dell’Agenzia dei Beni confiscati una sorta di Anac?"
È il suo emendamento al
nuovo codice?
"Non basterebbe solo questa
modifica. Quanti beni vengono sottratti ma tenuti in bilico tra la confisca e la
restituzione? Inoltre esistono termini precisi per quanto riguarda il sequestro
preventivo, ma non per quello penale che si può trascinare per anni".
Maresca si muove sotto scorta
sin da prima che con la semantica vigliacca, il macellaio Cesare Setola lo abbia
avvisato "che tutti tengono famiglia". Il capo della camorra, Michele Zagaria,
guardando la fronte alta e le guance ferme di Maresca ha detto: "Stimo il dottor
Maresca. Perché voi fate un mestiere, io me ne sono scelto un altro".
Anche questo riconoscimento
nasconde l’avvertimento ambiguo?
"È possibile. Di certo da
magistrato ho rispettato gli avversari. Non credo nella faccia feroce del pm.
Sarò ancora eretico, ma per sconfiggere le mafie e la corruzione penso che non
serva inasprire le pene e neppure aumentare il termine della prescrizione.
Bisogna smontare questo sistema infetto di valori, la corruzione come patrimonio
trasmissivo". Ma la corruzione non è anche il vizio dello strapotere dell’uomo
di legge, dei giudici? "Accade. Bisogna attendere e illuminare le ombre".
Il caso Saguto a Palermo,
il caso Scognamiglio a Napoli …c’è il sottosuolo anche nella magistratura?
"Di certo viene fuori un mondo
opaco. Eppure voglio ricordare che tutti i casi di corruttela che hanno
riguardato giudici sono stati svelati da altri giudici. La magistratura possiede
ancora gli anticorpi". Quando si ammala la magistratura? "Quando un magistrato
perde l’equilibrio e sopravvaluta la sua funzione. Quando invece di farsi rapire
dall’enigma della giustizia un giudice è chiamato ad amministrare patrimoni da
milioni di euro. Quando la giustizia diventa l’angoscia del bunker e smette
d’essere luce a mezzogiorno".
Cantone: "Per i beni
confiscati alle mafie servono trasparenza e concorrenza".
Il presidente
dell'Anticorruzione, su "Panorama", spiega perché Libera "è diventata un brand
di cui qualche speculatore potrebbe volersi appropriare", scrive "Panorama" il
20 gennaio 2016. "C’è chi usa l’antimafia, e va smascherato". Si esprime
così Raffaele Cantone, oggi presidente dell’Autorità anticorruzione e dal 1999
al 2007 magistrato anticamorra attivo a Napoli, in una lunga intervista che il
settimanale Panorama pubblica nel numero in edicola da domani, giovedì 21
gennaio. Cantone parla dell’opaca gestione dei beni confiscati e della durissima
denuncia che sulla materia aveva lanciato attraverso Panorama Catello
Maresca, il magistrato che di Cantone è stato diretto successore nella Procura
di Napoli, suscitando la sdegnata reazione (e un annuncio di querela) da parte
di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. Proprio su Libera, Cantone dice a Panorama: "È
un’associazione che ha fatto battaglie fondamentali in questo Paese. Le va
riconosciuto il merito di aver compreso quanto fosse utile per la lotta alla
mafia l’impegno dei cittadini, e sta provando a fare la stessa cosa anche sul
fronte della corruzione, cosa di cui le siamo grati. Certo, Libera è cresciuta
tantissimo ed è diventata sempre più nota e visibile; è diventata anche un
'brand' di cui in qualche caso qualche speculatore potrebbe volersi appropriare
per ragioni non necessariamente nobili. Credo che questo possa essersi in
qualche caso anche verificato". Quanto al "caso Saguto", con l’inchiesta che a
Palermo ha scoperchiato un sistema apparentemente deviato nella gestione dei
beni sottratti alla mafia, Cantone dichiara a Panorama: "Il caso Saguto
attende le verifiche giudiziarie, ma lo spaccato che emerge può essere valutato
a prescindere dagli aspetti penali ed è decisamente inquietante. Ho sempre
pensato che i giudici debbano tenersi lontano dalle gestioni economiche,
soprattutto quando passano incarichi lucrosi e discrezionali a professionisti
con cui si rischia di creare rapporti personali oltre che professionali".
Nessun monopolio, per
allargare il fronte di chi combatte i clan. E bisogna consentire di vendere i
beni sequestrati. Dopo l’inchiesta sui giudici di Palermo e le polemiche interne
a Libera, interviene Giuseppe Di Lello, il magistrato del pool di Falcone e
Borsellino,
scrive il 21 gennaio 2016 “L'Espresso”.
Le polemiche nell'antimafia dell'ultimo anno, le inchieste giudiziarie che hanno
coinvolto magistrati che si occupavano a Palermo del sequestro dei beni ai
mafiosi, e lo scontro interno a Libera, sono i punti che affronta Peppino Di
Lello, ex magistrato dello storico pool antimafia di Caponnetto, Falcone e
Borsellino, in un intervento scritto per l'Espresso che sarà pubblicato nel
numero in edicola da venerdì 22 gennaio 2016. Di Lello affronta il problema dei
beni sequestrati e ne propone la vendita: «Qualche rimedio sarebbe utile,
rimanendo sul terreno della concretezza. Molti immobili inutilizzati o
inutilizzabili, e che comunque rimangono sotto amministrazione giudiziaria
procurando solo oneri per lo Stato, andrebbero alienati. Si obietta che
tornerebbero ai mafiosi, ma si dimentica che per riacquistarli questi dovrebbero
pagarli e quelle somme potrebbero essere utilizzate dalle amministrazioni locali
per gestire altri beni destinati ad usi sociali. In più, il bene riacquistato,
dato l’affinamento dei mezzi di indagini patrimoniali, potrebbe essere di nuovo
sequestrato e confiscato». L'ex magistrato antimafia che ha lavorato con Falcone
e Borsellino, facendo riferimento all'inchiesta che ha coinvolto il presidente
del tribunale misure di prevenzione, Silvana Saguto, scrive: «Il “caso Palermo”
ha fatto emergere il problema degli incarichi agli amministratori giudiziari,
assegnati quasi dappertutto con una inconcepibile discrezionalità: trasparenza e
obiettività possono essere realizzate solo con una legge ad hoc. Ancor più
difficile sarà applicare questi principi di buona amministrazione
nell’assegnazione dei beni confiscati». Di Lello poi punta sulle associazioni
antimafia: «Nella giungla delle tante sigle si sono inserite persino
associazioni e cooperative costituite da soggetti mafiosi e quindi sono
necessarie serie riflessioni. Il “disagio” di Franco La Torre (figlio di Pio, il
segretario regionale del Pci ucciso dalla mafia a Palermo nel 1982 ndr)
ed altri sul ruolo di Libera, per esempio, non va demonizzato ma analizzato e
verificato. Libera ha avuto ed ha grandi meriti nel campo dell’antimafia ma
bisogna capire che il pericolo di monopoli o oligopoli nelle assegnazioni va
contrastato, non “contro” qualcuno, ma proprio per far crescere ed allargare il
fronte antimafia».
Soffiate, call Center e
anonimi: viaggio nel covo di Cantone,
scrive Antonello
Caporale. Il ministero dell’Onestà dista un alito dalla Fontana di Trevi
e solo cento passi da Palazzo Chigi. Il padrone di casa è Raffaele Cantone,
personalità il cui potere avanza come le quotazioni dell’oro in tempi di crisi.
Ogni giorno un po’ di più. Cantone infatti non è un magistrato ma un metallo
prezioso, insieme diga anticorruzione e tutor del corso collettivo sulla
moralità pubblica. Scrutatore delle coscienze sporche, selezionatore delle
pratiche migliori, dei buoni propositi e delle buone persone. Tutti lo vogliono,
lo cercano e, se del caso, lo annunciano. Non è solo Matteo Renzi a utilizzarlo
un po’ come le casalinghe fanno con Mister Muscle, il detersivo che
spurga in cinque minuti. Expo, Giubileo, Mafia Capitale, l’arbitrato per gestire
il rimborso dei clienti truffati dalle banche fallite. A una grana di rilevante
entità nazionale segue la convocazione di Cantone che perciò a volte sembra,
immaginiamo persino contro la propria volontà, il dodicesimo giocatore della
squadra di governo in campo. Col tempo, e dal momento che deviare verso di lui
produce profitti, un po’ tutti aspirano a una carezza cantoniana. È esploso il
caso Quarto? Ecco Cantone. E Beppe Sala, il mister Expo candidato alla carica di
sindaco di Milano, ha già annunciato che con Cantone sicuramente farà un patto,
stringerà ancor di più l’amicizia fattiva e gli chiederà un occhio supervigile
sui costumi meneghini, sottintendendo che lui può permetterselo ma gli altri
candidati? Al palazzo di questo speciale ministero che è l’Autorità nazionale
anticorruzione si accede dominati dalle decorazioni liberty della galleria
Sciarra, ricca di partiture architettoniche, dipinta da Giuseppe Cellini.
Palazzo sontuoso e imperiale come l’inquilino che lo ospita (la sua scrivania è
un Luigi XVI niente male). Qui giungono le perorazioni dell’Italia onesta, le
denunce, a volte le illusioni o le delazioni di un popolo che il nostro sente
“iconoclasta, votato spesso al nichilismo. Sa quanti anonimi arrivano?”. Dottor
Cantone, è l’Italia del rancore che bussa alla porta? “Credo proprio di sì. Ma
la nostra dev’essere una casa di vetro, si accomodi pure”. Cinque piani di
trasparenza, al quinto eccoci alla sala delle riunioni. “Sono stato nominato il
24 aprile 2014 e devo dire che la macchina ha iniziato a funzionare presto e
bene”. L’organico prevede 350 tra funzionari e impiegati, un numero prossimo a
essere raggiunto. Sono 302 gli effettivi, naturalmente divisi in sezioni. “La
nostra missione è prevenire la corruzione, anticipare le mosse, contestare e,
soprattutto, suggerire buone pratiche. Il nostro più grande potere è la moral
suasion, la forza di questa Autorità è la sua reputazione. L’autorevolezza
conta di più di ogni norma e devo dire che i frutti che si stanno avendo non
sono modesti”. Giuristi di impresa, architetti, esperti di appalti, finanzieri.
“Nel primo anno abbiamo “lavorato” 120.828 atti, una enormità. Rappresenta la
somma delle denunce, degli esposti, delle deduzioni e controdeduzioni, è il
risultato di un lavoro meticoloso, puntiglioso. Nell’anno 2015 il numero è
lievitato a 151.988. Chi denuncia? “Purtroppo molti sono anonimi, noi
approfondiamo laddove avvertiamo segnalazioni circostanziate di fatti
evidentemente rilevanti. Facciamo una cernita e teniamo conto. Devo dirle però
che la gran parte degli anonimi esala un sentimento purtroppo comune di noi
italiani: in premessa la fanfara di grandi ruberie poi stringi stringi e arrivi
alla miseria del furto dell’energia elettrica”. Chiunque scriva, email o
lettere, sappia che c’è un ufficio protocollo occupato da una decina di
impiegati. Stanze larghe e comode come altrove non è. La capo ufficio: “Leggiamo
e smistiamo per competenza. Ci dividiamo in turni”. Si smista alle sezioni e da
lì si avanza. Se viene ritenuta utile e documentata la segnalazione parte il
servizio ispettivo. “Controlliamo l’appalto e teniamo un lumino acceso anche in
corso d’opera”, dice Angela Di Gioia, segretario generale. Il baco della
corruzione ha un concepimento seriale e uno sviluppo tipico. Tardano i lavori,
s’interrompono spesso, si chiede l’aggiornamento prezzi, si autorizza la
variante. O ancora: si affida l’appalto producendo un progetto esecutivo finto
cosicché i lavori avanzino a vista e possano deviare. Al primo piano di palazzo
Sciarra fa ingresso il malcostume italico che poi viene distribuito per piano.
Più sale e più acuta è la rimostranza, grave il danno alle casse pubbliche. Ai
trecento militi dell’onestà si aggiungono cinquanta lavoratori di uno speciale
call center che gestisce via telefono le procedure corrette. Telefonano dalle
amministrazioni centrali e locali. Telefonano i funzionari e telefonano le
imprese. Un grande via vai di parole a leggere i dati sul numero dei contatti.
Nel 2014 risultano 432 mila telefonate, nel 2015 già lievitate a 682 mila.
Cantone riceve un compenso di 180mila euro l’anno, i quattro consiglieri (un
magistrato e tre professori universitari) 150mila. Il presidente ha fatto il
conto, visti i tempi, pure degli scontrini. Le differenze con Renzi si notano.
Il premier, quand’era presidente della Provincia di Firenze, riuscì nell’impresa
di far fuori quasi un milione di euro. Cantone mangia e beve di meno e non ha
avuto finora bisogno del letto a cinque stelle. Nel 2014 per vitto e alloggio ha
speso 1.065 euro. Da: Il Fatto Quotidiano, 15 gennaio 2016.
Mafiosi si nasce o si diventa? Quei
minori tolti a mamma mafia. Sono 30 i minori
sottratti per decisione dei tribunali alle famiglie della ’ndrangheta e affidati
a coppie o comunità. Per i boss l’affronto peggiore. Perché così si spezza la
trasmissione della cultura criminale, scrive Giovanni Tizian su "L'Espresso"
del 13 gennaio 2016. «Dite al Dottore che i figli non si toccano». Per un boss
la famiglia conta più dei soldi e del potere. Perché figli, nipoti e mogli,
garantiscono la continuità dell’impero. Per questo il capo dei capi di Reggio
Calabria, Giuseppe De Stefano, ha reagito in malo modo quando il pm Giuseppe
Lombardo ha chiesto al tribunale d e i minorenni di far decadere la patria
potestà sui piccoli eredi. Un colpo durissimo per il padrino dello Stretto che
ha sempre reagito a processi, sequestri di beni e latitanze, con un sorriso
beffardo. L’affronto, senza precedenti, aveva aperto una crepa profonda in quel
monolite criminale che da 40 anni dominava l’intera città. Educare la prole a un
avvenire da mafioso può avere conseguenze pesanti: l’allontanamento dei minori
dal nucleo familiare. È questo il nuovo fronte della lotta alla ’ndrangheta.
Nell’ultimo anno si sono moltiplicati i provvedimenti di questo tipo e sempre
più casi sono finiti sotto la lente degli inquirenti. Il tribunale dei minorenni
di Reggio Calabria è l’unico ad avere intrapreso la strada dell’allontanamento
dai genitori mafiosi. Finora sono 30 i minori sottratti alle cosche e affidati a
famiglie o comunità del Nord. Dalle informazioni di cui è venuto a conoscenza
“l’Espresso”, il numero è destinato a crescere. I figli dei boss sottratti per
legge alle famiglie, in questo modo non saranno più costretti a impugnare
pistole, ad avere “confidenza” con la droga e così potranno giocare e studiare
come tutti i ragazzi.
Il più piccolo ha 12 anni, ma
la maggior parte è nel pieno dell’adolescenza. «È una misura che non si applica
mai in maniera leggera», spiega il procuratore capo di Reggio Calabria, Federico
Cafiero De Raho, che aggiunge: «Chi la critica sostiene che è una intromissione
intollerabile nell’ambito familiare. Però dobbiamo capire una cosa: il clan
mafioso impartisce ai suoi rampolli regole opposte a quelle naturali». Così, per
esempio, se per la giovane B. il codice della ’ndrina prevedeva una vita di
segregazione e silenzio, l’intervento dei giudici le ha permesso di realizzare
il suo sogno: disegnare abiti. Da qualche mese la ragazza, figlia di un boss
della provincia reggina, vive fuori regione, in una località sconosciuta, dove è
finalmente libera di seguire la sua passione. Il procuratore, poi, ragiona su un
fatto acclarato: «Ci troviamo di fronte a sedicenni che si comportano già da
capi. Hanno entrambi i genitori in galera o latitanti. Lasciamo che le figure
adulte continuino ad addestrarli al crimine? Più tardi si interviene più
difficile è il cambiamento». Il legame di sangue in questa organizzazione non ha
eguali nel mondo della criminalità. E in effetti ad ascoltare le intercettazioni
registrate negli ambienti di casa ’ndrangheta, l’impressione è che il destino di
molti bambini sia segnato per sempre.
«Spara!». Il padre ordina, il figlio esegue. Ha
solo 7 anni, ma deve già impugnare la pistola d’ordinanza. L’arte della ’ndrina
si apprende tra le mura domestiche. In un’altra casa, le cimici hanno catturato
in diretta una lezione di mafia: il patriarca spiegava all’erede al trono, ormai
sulla soglia della maggiore età, il significato dei diversi gradi della
gerarchia criminale. Ma ci sono anche ragazzini che, ai piedi dell’Aspromonte,
saltano la teoria per apprendere direttamente sul campo. Come a San Luca, cuore
delle tradizioni dell’onorata società, dove durante l’ultima faida i più giovani
sono stati istruiti su come proteggere le abitazioni delle famiglie da
incursioni nemiche durante le faide. Nel
processo Fehida, che ha visto alla sbarra i carnefici della
strage di Duisburg del Ferragosto 2007, c’erano anche alcuni minorenni accusati
di associazione mafiosa e concorso esterno.
Crescono così i figli d’onore, fanciulli di ’ndrangheta,
costretti a immergersi nelle profondità più estreme dell’oceano criminale da cui
spesso non riemergono più. E se ci riescono, lo fanno da cadaveri o ricompaiono,
da adulti, nelle celle del 41 bis. Intere dinastie sono state falcidiate nelle
guerre: in soli quindici anni, per esempio, la ’ndrina Dragone della provincia
di Crotone ha perso il capo e i suoi due figli maschi. Secondo gli ultimi dati
del ministero, aggiornati a ottobre 2015, in Calabria sono sei i minorenni
accusati di associazione mafiosa. Addestrati da padri-padrini per i quali
uccidere, morire o andare in galera, sono tappe di una carriera obbligata. La
stessa che hanno scelto per i loro pargoli ancora in fasce. La «smuzzunata» è il
battesimo da ’ndranghetista dei bimbi appena nati. È un diritto e un privilegio
che spetta solo ai figli dei boss. Un marchio che trova legittimità in un codice
parallelo, ancestrale e non scritto. Che trasforma la famiglia naturale in
’ndrina, nucleo fondante della mafia calabrese. «Quando la moglie di uno
’ndranghetista di grado elevato mette al mondo un figlio maschio, quest’ultimo
viene battezzato nelle fasce con la “smuzzunata” e, per il rispetto goduto dal
genitore, entra a far parte dell’associazione sin dai primi giorni di vita.
Percorrerà così tutta la gerarchia mafiosa».
Giuseppe Scriva, è il
pentito che a metà
anni ’80 ha sviscerato i segreti della più potente tra le mafie moderne. E sono
proprio queste regole, tra mistero e leggenda, che hanno garantito ai clan
calabresi continuità generazionale. Le nuove leve, i figli e nipoti degli
anziani padrini, hanno lanciato la ’ndrangheta nel mercato della modernità,
mantenendo intatto, però, il dna arcaico. Sono giovani che investono milioni di
euro a Roma come a Toronto, ma legati indissolubilmente alle antiche regole
della “famiglia”. Negli ultimi vent’anni il tribunale dei minorenni di Reggio ha
celebrato cento processi per reati di mafia. Gli imputati erano rampolli non
ancora diciottenni delle cosche più blasonate. Giovanissimi ma con un curriculum
da malavitosi esperti. Le condanne non hanno, però, frenato la loro ascesa
criminale. Così a distanza di tempo c’è chi è rinchiuso al carcere duro, chi,
invece, è stato ucciso e chi ha conquistato il vertice. Negli stessi vent’anni
l’ufficio, ora diretto dal presidente Roberto Di Bella, ha giudicato anche una
cinquantina di casi di omicidio. «Il dato impressionante è che abbiamo di fronte
una generazione che potevamo salvare e che invece abbiamo abbandonato», ragiona
Di Bella, che dal suo insediamento ha dato vita a un protocollo unico in Italia.
È convinto che il documento firmato con procura dei minori, antimafia e servizi
sociali può davvero salvare molte vite dalla morte e dal carcere. «Ci troviamo
davanti ai figli e ai fratelli di persone processate negli anni ’90. Questo ci
fa pensare che la ’ndrangheta si eredita», racconta nel suo piccolo
ufficio-trincea. L’anno della svolta è il 2012: «Da allora stiamo intervenendo
con provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale e il conseguente
allontanamento dei figli minori dal nucleo familiare. L’obiettivo è interrompere
la trasmissione culturale».
Una misura estrema. Che ha sollevato molte critiche, anche da parte della chiesa.
È convinto che sia la strada giusta don Pino De Masi, vicario della diocesi di
Oppido-Palmi e referente di Libera nel territorio caldissimo della piana di
Gioia Tauro. «Dobbiamo mettere questi ragazzi nelle condizioni di scegliere
un’alternativa che non sia l’interesse della cosca», è netto De Masi. «Nella mia
parrocchia vengono anche i rampolli, qualcuno timidamente mi dice che il cognome
che porta gli pesa. Sta a noi aiutarli a fare il passo successivo», spiega il
parroco. Il fronte degli scettici, invece, ha azzardato persino un paragone:
«Dalla confisca dei beni a quella dei figli». L’intervento del tribunale però
non è indiscriminato. Il “salvataggio” scatta solo quando gli inquirenti entrano
in possesso di notizie sull’educazione mafiosa impartita ai figli. Informazioni
che i pm girano al tribunale e alla procura dei minorenni. Solo
a quel punto si mette in moto il meccanismo che
potrebbe portare all’allontanamento. Lezioni di mafia, minori incaricati di
custodire armi e droga, ragazzini obbligati a dimostrare quanto valgono con
azioni di fuoco, sono tutti segnali che allertano gli uffici giudiziari. Non
sono escluse dall’indottrinamento neppure le giovani donne. Abituate a ubbidire
agli ordini fin da piccole: subiscono tutto questo, si trincerano dietro il
silenzio e spesso sono costrette ad accettare matrimoni che uniscono due
potentati criminali. I primi giorni dopo l’allontanamento sono i più difficili. Chi
conosce i casi racconta di incubi che angosciano le notti dei bambini. Sono
pensieri di morte, con simboli ben precisi: bare, sangue, violenza. I brutali
insegnamenti riaffiorano nella nuova vita distante dai papà-boss. Il tribunale
si occupa anche dei minori colpevoli di un reato e messi alla prova come
alternativa al carcere. Vengono affidati a comunità ma restano in Calabria.
Continuano così a frequentare l’ambiente di provenienza. La maggior parte
respira cultura mafiosa da quando è nato. Una mentalità che distorce il rapporto
con le istituzioni: «Ricordo un ragazzo, ospite di una comunità, con i tatuaggi
di un carabiniere sotto la pianta del piede, così da calpestare la divisa a ogni
passo, e il giuramento della ’ndrangheta sul cuore», racconta un operatore
sociale. A volte per ribellarsi all’omertà è sufficiente percepire la presenza
dello Stato. Come spiegare altrimenti il gesto di quel gruppo di mamme che ha
chiesto aiuto al presidente Di Bella. Chiedono di essere portate via insieme ai
figli. Lontano dai mariti. È una piccola rivoluzione in corso. L’avanguardia è
fatta da una decina di madri che hanno deciso di chiedere aiuto al tribunale e
di collaborare. «È un fenomeno del tutto nuovo. Queste signore hanno esperienze
terribili alle spalle, quindi vuol dire che i nostri provvedimenti stimolano a
reagire. E c’è anche un lieto fine perché molti dei casi trattati, inviati al
nord, non vogliono più tornare nei paesi d’origine», aggiunge il presidente. Non
sempre però il finale è dei migliori. I figli
di Maria Concetta Cacciola -
la pentita che la famiglia ha spinto al suicidio per aver scelto di andare via
da Rosarno per collaborare con la giustizia - sono tornati nel paese degli zii.
Nel frattempo il padre che teneva segregata in casa Maria Concetta è tornato in
libertà. Gli educatori che lavorano con i due adolescenti sono amareggiati,
perché in quel contesto l’esempio esplosivo di ribellione della loro mamma è
stato depotenziato. «Il figlio maschio è come se avesse rimosso la vicenda, è
intriso purtroppo di quella mentalità che sua madre ha messo sotto accusa»,
racconta una fonte. Un’occasione di riscatto persa. Al civico 404 del corso
principale di Reggio Calabria c’è un piccolo ufficio che segue la gran parte dei
casi di allontanamento. Attualmente i ragazzi affidati a questa squadra sono
dieci. Provengono tutti da cosche affermate nel panorama criminale.
«Interveniamo immediatamente dopo la decisione del tribunale», spiega la
dirigente Giuseppa Maria Garreffa, che specifica: «Alla base di ogni
allontanamento c’è sempre un procedimento nei confronti dei genitori». In queste
stanze si lavora ininterrottamente. «Siamo sovraccarichi», sospira Garreffa, «ma
resistiamo». Finché questi giovani seguono il percorso studiato dal team del
ministero tutto sembra andare per il meglio. Poi, quando compiono 18 anni, sono
liberi di tornare nel paese in cui sono nati. E una volta rientrati il cognome
pesa ancora come un tempo. «Il contesto in cui tornano è spesso decisivo.
Vengono accolti, “rieducati”, indottrinati. Non dimenticherò mai quando un
ragazzo ci disse: “grazie per quello che fate, ma io devo... non posso
scegliere”. Ecco, il dovere di seguire le orme dei padri è la vera condanna di
questa terra». Come in “Onora il padre” di Gay Talese, il passaggio di consegne
tra padre e figlio è un automatismo che imprigiona i più giovani. Il figlio del
boss, per i compaesani, è sempre il figlio del boss. E va riverito. Un
meccanismo che molto spesso vanifica i risultati ottenuti lontano dell’ambiente
familiare. È un investigatore a raccontarci una scena che ricorda il Padrino di
Francis Ford Coppola: «In un paesone arroccato nell’Aspromonte, al termine del
funerale dell’anziano del clan si è formata la fila per salutare con grande
rispetto il capomafia e il suo bambino, prossimo erede, che per l’occasione
aveva fatto ritorno a casa dalla struttura dei servizi sociali». Il passaggio è
devastante: da un luogo e una scuola in cui amici e compagni li considerano
semplici coetanei con cui giocare o fare i compiti, a una realtà in cui
l’etichetta di provenienza esercita ancora fascino sugli altri. «Se i servizi
sociali sono inadeguati, se non c’è lavoro, se manca il diritto alla mobilità,
come possiamo pensare di lottare contro una multinazionale del crimine che offre
denaro e successo immediato ai giovani?», conclude Garreffa. «Gli sforzi devono
concentrarsi sul concedere, una volta finito il percorso di allontanamento,
delle opportunità legali a questi giovani. Altrimenti si torna al punto di
partenza», ragiona Di Bella. Una soluzione la propone il pm Lombardo, il primo
ad aver intrapreso, nel 2008, la strada del distacco forzato: «Prima di arrivare
alla misura estrema della revoca, si potrebbe immaginare un modello misto,
flessibile. Con percorsi di sostegno ai genitori che, però, devono dimostrarsi
volonterosi e pronti a tagliare con il passato». S. ha un cognome ingombrante.
Nella Locride molti tremano solo a sentirlo pronunciare. Il suo sguardo però non
è arrogante. Sorride spesso, preferisce parlare in dialetto, anche se con
l’italiano se la cava abbastanza bene. Ha compiuto 18 anni da poco, e invece di
dedicarsi allo studio e al divertimento, ragiona già da manager navigato: «Ormai
in questa terra non si può più investire denaro», sussurra. Fa il cassiere
nell’hotel di famiglia, dissequestrato da poco. Guadagna 1.600 euro al mese. Non
male per un ragazzo così giovane, in una provincia, Reggio Calabria, ultima per
qualità della vita secondo la classifica del “Sole 24 Ore”, che comprende tra
gli indicatori il tenore di vita e l’occupazione. Incontriamo S. in una saletta
del centro don Milani, un punto di riferimento per gli adolescenti di Gioiosa
Marina e Gioiosa Ionica. Comuni attaccati, con due sindaci e due giunte
differenti. Nella piazza di Gioiosa Ionica c’è un murale dedicato a Rocco Gatto:
il mugnaio comunista ucciso dalla ’ndrine del paese per non essersi piegato alle
loro richieste. È il simbolo dimenticato della Locride anti ’ndrangheta. Il suo
omicidio doveva servire da monito per tutto il neonato movimento antimafia.
All’inizio di dicembre, invece, il nuovo e giovane sindaco, Salvatore Fuda, è
stato minacciato con alcuni colpi di pistola sparati sulla fiancata dell’auto.
La violenza è il ponte che lega il passato e il presente di questi luoghi. S. è
cresciuto a Gioiosa. Si presenta all’appuntamento ben vestito, il suo
abbigliamento è tutto firmato. L’orologio costoso di metallo nero al polso
destro, il bracciale d’argento in quello sinistro. S. sogna di trasferirsi in
Canada, dagli zii. Per il momento si divide tra la cassa dell’albergo e il
commercio di olio in società con il fratello. È finito al don Milani per tre
bravate, l’ultima è guida senza patente: «Guidavo una moto 125, che sarà mai?»,
sorride. Il tribunale gli ha concesso la messa alla prova, che prevede un
percorso di volontariato. Il responsabile del centro è Francesco Riggitano e
tutto il tempo che ha disposizione lo dedica ai ragazzi di questi paesi della
Locride. «Ci sono famiglie mafiose storiche, importanti, nelle quali la
trasmissione mafiosa è evidente. La nostra esperienza ci dice però una cosa: si
incide più facilmente sulla manovalanza, su quei ragazzi le cui famiglie non
sono criminali da generazioni. Diverse mamme di questi soldatini si sono rivolte
a noi per toglierli dalla strada». Il centro è frequentato da tanti ragazzi. Una
risorsa straordinaria in questo deserto della Locride. D’altronde crescere qui,
o a Rosarno, o tra i boschi dell’Aspromonte, oppure nel quartiere Archi di
Reggio Calabria, è una lotta quotidiana. Non ci sono cinema, teatri,
polisportive. Sale giochi e strade abbandonate diventano gli unici spazi di
aggregazione. Al Don Milani c’è anche una squadra di calcio, la Seles (acronimo
di Scuola Etica e Libera di Educazione allo Sport), diventata un punto di
riferimento per bambini e adolescenti. Gli allenamenti hanno strappato i giovani
dalla strada. Simbolicamente è come aver dato un calcio alla ’ndrangheta. Per
Riggitano e i suoi collaboratori non è tutto facile, anzi. «Su 42 comuni della
Locride, solo il 30 per cento di questi ha assistenti sociali di ruolo»,
denuncia Francesco. Troppo pochi per svuotare le madrasse dei clan, che
trasformano ragazzini senza possibilità in picciotti d’onore.
Non crescerai mafioso: i minori tolti
alla mafia. Sparano, maneggiano la droga, interpretano il ruolo di piccoli boss.
Per questo i giudici dei minorenni hanno deciso di allontanarli dalle famiglie
di 'ndrangheta. Togliendoli ai padri-padrini per offrirgli un'alternativa alla
vita scelta per loro dagli adulti, scrive Giovanni
Tizian su "L'Espresso" del 14 gennaio 2016. C'è un
nuovo fronte nella lotta alla 'ndrangheta aperto dai magistrati di Reggio
Calabria. Qui, infatti, il tribunale dei minorenni è l’unico in Italia ad avere
intrapreso la strada dell’allontanamento
dai genitori mafiosi.
Finora sono 30 i minori sottratti alle cosche e affidati a famiglie o comunità
del Nord. Un numero destinato a crescere. I figli dei boss sottratti per legge
alle famiglie in questo modo non saranno più costretti a impugnare pistole o ad
avere “confidenza” con la droga e così potranno giocare e studiare come tutti i
ragazzi. Il più piccolo ha 12 anni, ma la maggior parte è nel pieno
dell’adolescenza. «È una misura che non si applica mai in maniera leggera»,
spiega a “l'Espresso” il procuratore capo di Reggio Calabria, Federico Cafiero
De Raho, che aggiunge: «Chi la critica sostiene che è una intromissione
intollerabile nell’ambito familiare. Però dobbiamo capire una cosa: il clan
mafioso impartisce ai suoi rampolli regole opposte a quelle naturali». Così, per
esempio, se per la giovane B. il codice della ’ndrina prevedeva una vita di
segregazione e silenzio, l’intervento dei giudici le ha permesso di realizzare
il suo sogno: disegnare abiti. Da qualche mese la ragazza, figlia di un boss
della provincia reggina, vive fuori regione, in una località sconosciuta, dove è
finalmente libera di seguire la sua passione. Il procuratore, poi, ragiona su un
fatto acclarato: «Ci troviamo di fronte a sedicenni che si comportano già da
capi. Hanno entrambi i genitori in galera o latitanti. Lasciamo che le figure
adulte continuino ad addestrarli al crimine? Più tardi si interviene più
difficile è il cambiamento». E in effetti ad ascoltare le intercettazioni
registrate negli ambienti di casa ’ndrangheta, l’impressione è che il destino di
molti bambini sia segnato per sempre. Bambini che a sette anni sono costretti a
sparare, ragazzi più grandi che assistono a lezioni di mafia impartite dai
papà-boss oppure adolescenti trasformati in vedette durante le faide. Crescono
così i figli d’onore. Senza una vera alternativa e senza possibilità di
scegliere. Addestrati da padri-padrini per i quali uccidere, morire o andare in
galera sono tappe di una carriera obbligata. La stessa che hanno scelto per i
loro pargoli ancora in fasce. D'altronde la 'ndrangheta è fondata sulla
famiglia: i legami di sangue hanno un valore enorme in questa organizzazione,
più che in qualsiasi altra mafia. Tanto che esiste un rito, la «smuzzunata», per
i bimbi appena nati. È Il battesimo da 'ndranghetista, un diritto che spetta
solo ai figli dei capi. «Ci troviamo davanti ai figli e ai fratelli di persone
processate negli anni Novanta. Questo ci fa pensare che la ’ndrangheta si
eredita», racconta Roberto Di Bella, il presidente del tribunale dei minorenni
di Reggio Calabria, che ha creduto fortemente in questo protocollo. «Dal 2012
stiamo intervenendo con provvedimenti di decadenza della responsabilità
genitoriale e il conseguente allontanamento dei figli minori dal nucleo
familiare. L’obiettivo è interrompere la trasmissione culturale». L’intervento
del tribunale però non è indiscriminato. Il “salvataggio” scatta solo quando gli
inquirenti entrano in possesso di notizie sull’educazione mafiosa impartita ai
figli. Informazioni che i pm girano al tribunale e alla procura dei minorenni.
Solo a quel punto si mette in moto il meccanismo che potrebbe portare
all’allontanamento. Lezioni di mafia, minori incaricati di custodire armi e
droga, ragazzini obbligati a dimostrare quanto valgono con azioni di fuoco, sono
tutti segnali che allertano gli uffici giudiziari. Non sono escluse
dall’indottrinamento neppure le giovani donne. Abituate a ubbidire agli ordini
fin da piccole: subiscono tutto questo, si trincerano dietro il silenzio e
spesso sono costrette ad accettare matrimoni che uniscono due potentati
criminali. Gli interventi dei giudici stanno dando i primi risultati. Hanno
stimolato la reazione di diverse donne. Che hanno deciso così di chiedere
aiuto e di collaborare. La ribellione, quindi, è possibile. E questo gruppo di
mamme lo dimostra: una decina di mogli di alcuni importanti padrini che hanno
bussato alle porte del tribunale per collaborare. Lo fanno, dicono, per salvare
i figli.
Pro e contro l'allontanamento forzato. Quattro
opinioni (e quattro libri) prendono posizione sul distacco dei bambini dalle
famiglie mafiose, scrive Angiola Codacci-Pisanelli su "L'Espresso" del 13
gennaio 2016. «Se suo figlio nasceva dove sono nato
io, adesso era lui nella gabbia; e se io nascevo dove è nato suo figlio, magari
ora facevo l’avvocato, ed ero pure bravo». Sembrano parole inventate per
giustificare i giudici calabresi che tolgono i figli a chi è condannato per
mafia per dare a quei ragazzi un futuro lontano dalla delinquenza. Invece sono
parole vere, dette da un giovane mafioso che per i suoi crimini sconterà 26
anni, continuerà a sognare di costruirsi una vita migliore e alla fine,
sconfitto da una burocrazia ancora più impietosa dell’ergastolo “ostativo”,
uscirà come il Miché di Fabrizio De André: «Adesso che lui s’è impiccato la
porta gli devono aprir...». Siamo a Torino alla fine degli anni Ottanta, ai
margini di un maxi processo alla mafia catanese. Salvatore, uno dei più
pericolosi tra i 242 imputati che assistono alle udienze chiusi in gabbie
d’acciaio, chiede un colloquio al
Presidente della Corte d’Assise, Elvio Fassone.
Le sue parole, con quella nostalgia per un destino diverso da quello
assegnatogli dalla «lotteria della vita», segnano un punto di svolta nel
rapporto tra quel pluriomicida e il giudice che firmerà la sua condanna. Ne
nasce un rapporto epistolare durato 26 anni, un libro composto e struggente
(“Fine pena: ora”, Sellerio) e l’impegno personale di Fassone per mitigare una
pena che «è una vera barbarie: una sentenza della corte europea del 2013 ci
obbligherebbe a riesaminare caso per caso dopo 25 anni di carcere». Nel libro il
rapporto malato tra infanzia e mafia torna tre volte. Nel bambino che Salvatore
era e che non aveva altra strada che la delinquenza. Nei figli che non ha potuto
avere dalla “ragazza perbene” che non ha fatto in tempo a sposare e che dopo
anni d’attesa ha rinunciato ad aspettarlo. E nell’ansia per i nipotini, «quattro
discoli» che con il padre anche lui in carcere e la madre che «si arrabatta come
può» ormai «non rispettano nessuno». Salvatore si tormenta: «Dovrei esserci io
insieme a loro, gli direi di studiare e di imparare a fare un lavoro altrimenti
finiscono dove sono finito io». Eppure Fassone non è favorevole all’idea di
togliere i figli ai mafiosi, un provvedimento che, se andasse avanti una
proposta presentata nel 2014 dal deputato renziano Ernesto Carbone, potrebbe
diventare legge. «Sono sempre riluttante davanti agli interventi coercitivi,
anche se fatti con la certezza di “fare del bene” a un innocente», spiega
Fassone. «Mi rendo conto però che quando un nucleo è radicato in ambito mafioso
può essere una scelta accettabile. Purché però non si perdano i contatti con la
madre. Pensiamo a questi bambini: con il padre in carcere, la madre diventa
ancora più importante...». A preoccupare l’ex giudice torinese quindi non è
tanto la possibilità che la perdita dei figli diventi una pena accessoria ancora
più esasperante per dei condannati già difficilissimi da recuperare, quanto
l’effetto sui bambini. Che oltretutto quando arriva la decisione dei giudici
sono spesso già adolescenti. Non è troppo tardi? No, spiega Massimo
Ammaniti, specialista di psicologia
dell’età evolutiva. Nel suo “La famiglia adolescente» (Laterza), lo studioso
mette a fuoco gli anni in cui «si conclude per i figli la fase del
rispecchiamento e comincia - o dovrebbe cominciare - un processo diverso, la
mentalizzazione». È questo il momento giusto, spiega a “l’Espresso”, «per
cercare di costruire un senso civico che nasce da un’educazione a far proprie le
regole e a capire il punto di vista dell’altro. Un’educazione all’empatia e alla
mentalizzazione, la capacità di “leggere nella mente dell’altro” che entra in
crisi fra i dodici e i quattordici anni, quando i ragazzi iniziano a prendere le
distanze dal modello dei genitori». Ma il distacco forzato dai genitori è
giustificato? «Sì, perché chi cresce in una famiglia mafiosa è vittima di una
forma di abuso psicologico. Non è molto diverso da quello che succede ai bambini
soldato della Sierra Leone. Toglierli alla famiglia è un modo per proteggerli da
un meccanismo di affiliazione tanto più potente perché fa uso anche
dell’affetto. E dal pericoloso senso di onnipotenza che ne deriva: appartenere a
una famiglia mafiosa crea un’identificazione col gruppo che porta a un disturbo
dell’identità, perché ci si sente parte di un sé grandioso». E comunque parliamo
di affido temporaneo, «ben diverso dalla pulizia etnica o politica, dai bambini
tolti ai nomadi in Svizzera o ai desaparecidos in Argentina». Questi distinguo
non bastano a chi considera i provvedimenti «una vera barbarie, oltretutto con
risultati minimi».
È categorica Silvana
La Spina, scrittrice catanese che
nell’ultimo libro, “L’uomo che veniva da Messina” (Giunti) si è allontanata
dall’attualità, ma che all’atteggiamento dei bambini di fronte alla malavita ha
dedicato anni fa “La mafia spiegata ai miei figli (e anche ai figli degli
altri)” (Bompiani). «Lo Stato non può pensare di salvare un solo bambino
lasciando intatta la cultura malata di interi territori. Deve entrare nelle
famiglie: medici, psicologi, assistenti sociali devono trovare gli “anelli
deboli” che possono spezzare la catena, lavorare con le donne che sempre più
spesso si oppongono silenziosamente». Allontanare un singolo bambino dal
“contagio” «può creare una forma di rancore controproducente», nota la
scrittrice. Che aggiunge: «Se è vero che la ‘ndrangheta ha ancora comportamenti
tribali, lo Stato non può limitarsi a togliere un bambino dalla tribù. Deve
aiutare la tribù intera».
«I giudici calabresi hanno ragione», ribatte Melita Cavallo. «Ne
sono convinta fin dagli anni Novanta: l’ho scritto chiaramente nel mio libro
“Ragazzi senza”. Se si fosse intervenuti allora non vivremmo lo stato di cose di
oggi». Alla vigilia dell’uscita di “Si fa presto a dire famiglia” (Laterza),
ritratto delle “nuove” famiglie italiane attraverso quindici storie vere, l’ex
presidente del tribunale per i minorenni di Roma da poco in pensione ha ben
presente la situazione delle famiglie mafiose: «Non si può mai procedere per
categorie. Il Tribunale decide sui casi singoli: non concorderei mai con un
allontanamento “di massa” dei bambini da ambienti mafiosi, ‘ndranghetisti o
camorristi. E comunque si nomina un tutore che fa da tramite tra la famiglia e
il bambino nella sua nuova situazione: si evita così che nel piccolo si crei una
ferita che non sarebbe facile risanare nel tempo». Ma c’è un altro modo di
sottrarre questi piccoli alla “lotteria della vita” che li porta alla
delinquenza. «Lo Stato deve intervenire pesantemente: non con esercito e polizia
ma con la scuola. Una scuola che prende bambini e ragazzi dalle 8 alle 16, 30,
in un territorio ricco di ludoteche, palestre e luoghi di incontro per suonare,
disegnare, leggere, creare insomma un gruppo alternativo al modello familiare.
Questo tipo di politica non paga subito, i suoi effetti si registreranno dopo
anni, ma salverà migliaia di ragazzi». E non più solo i bambini del singolo
camorrista che a vent’anni da quando lei aveva deciso l’allontanamento dei figli
le scrisse dal carcere ringraziandola «perché i ragazzi si erano salvati».
Figli dei boss Luperti
Riina e Company mafiosi per sempre.
Brindisi e mafia, Luperti querela «Emiliano mi ha dato del mafioso».
Controffensiva dell’ex assessore di Consales: «In Commissione antimafia
Emiliano ha portato città indietro di vent’anni e ha fatto passare me per quello
che non sono», scrive "Il Corriere del Mezzogiorno" il 22 febbraio 2016. «Posso
accettare qualsiasi critica sul mio operato politico, ma nessuno dica che sono
un mafioso. Mafioso no, proprio non posso accettarlo. Per me, per la mia
famiglia». L’ex assessore all’Urbanistica del Comune di Brindisi, Pasquale
Luperti, con questa motivazione annuncia che querelerà il presidente della
Regione Michele Emiliano. Dal governatore, infatti, si sarebbe sentito offeso
per i riferimenti, fatti anche in sede di Commissione antimafia, al padre
Salvatore e allo zio Antonio, il primo già condannato per associazione mafiosa.
I due furono uccisi alla fine degli anni novanta nell’ambito di una guerra di
mafia in seno alla Scu scoppiata per la gestione del traffico di sigarette di
contrabbando. Emiliano nel dicembre aveva chiesto le dimissioni di Luperti dalla
giunta guidata da Mimmo Consales (Pd), arrestato per corruzione lo scorso 6
febbraio. «Con il suo racconto - spiega Luperti - Emiliano ha portato Brindisi
indietro di vent'anni, facendo passare me per quello che non sono e cioè una
persona collegata con la Sacra corona unita che ha potuto creare infiltrazioni
nella pubblica amministrazione. Mio padre è morto 20 anni fa, e se io sono
diverso lo devo anche a lui. Ci ho messo tantissimo per farmi conoscere e
apprezzare. Accetto tutte le critiche ma non l'appellativo (mai detto in maniera
esplicita da Emiliano, ndr) di mafioso. Quel mondo mi ha distrutto una parte di
vita».
"Il giorno della civetta" e
i figli dei boss,
scrive di Valter Vecellio. "Lasci stare mia figlia", ruggisce il capo mafia. Il
capitano dei carabinieri che gli sta di fronte, ed è venuto ad arrestarlo, gli
chiede conto delle ingenti somme di denaro depositate in tre diverse banche, il
suo apparente non far nulla, l'irrisoria denuncia dei redditi, nonostante il
reddito reale sia elevato; e osserva che anche a nome della figlia risultano,
altri, cospicui depositi, lei che studia in un costoso collegio svizzero...Poi,
dopo lo scatto, il boss riprende il controllo dei nervi: "Mia figlia è come me",
sibila, ma più a rassicurarsi, che a smentire il capitano; e magari, chissà, col
tarlo, il dubbio, il sospetto che forse quell’uomo in divisa così diverso da lui
per esperienze, cultura, nascita e accento, possa aver ragione e compreso quello
che lui non ha capito e non vuole capire quando, poco prima gli aveva detto:
"Immagino lei se la ritroverà davanti molto cambiate: ingentilita, pietosa verso
tutto ciò che lei disprezza, rispettosa verso tutto ciò che lei non
rispetta...". E’ una scena de "Il giorno della civetta" di Leonardo Sciascia,
più del romanzo che del film. Nel film la ragazza si vede, compare, è devota nel
porgere i calzini al padre, svegliato di soprassalto, e anche complice: il boss
infatti le affida qualcosa che deve far “sparire”. Nel romanzo è invece una
presenza evocata, non compare mai. Il romanzo - è bene ricordarlo - Sciascia lo
scrisse più di cinquant'anni fa. Il capitano Bellodi e don Mariano Arena sono di
fronte uno a l'altro, il mafioso poi descrive quelle che a suo giudizio sono le
cinque categorie in cui si divide l'umanità; Bellodi individua nella legge, nel
rispetto del diritto, le "armi" per sconfiggere la mafia. E’ un brano che
autorizza una cauta speranza: quella che attraverso lo studio, la cultura, i
figli e i nipoti di mafiosi riescano a levarsi di dosso la mafiosità dai loro
padri e zii e nonni vissuti come "naturale", una pelle; e diventino appunto
pietosi, rispettosi. Anni dopo, non a caso, richiesto su quello che i ragazzi
potevano fare contro la mafia, Sciascia lapidario risponde: “Magari una marcia
in meno, e un libro in più”. Quasi naturalmente ho pensato a quel brano de “Il
giorno della civetta”, nell'apprendere che la diciassettenne figlia del boss
latitante Matteo Messina Denaro (si dice erede di Totò Riina), avrebbe convinto
la madre a lasciare la casa dove le due donne hanno sempre vissuto, e per andare
altrove. Un po' frettolosamente si è scritto che la ragazza - e con lei la madre
- si sono "ribellate": "la ragazza vuole vivere lontano dai familiari del papà.
Una scelta rivoluzionaria perché suona come sfida ai codici di Cosa nostra''.
Ribellione è una forzatura. La ragazza, che ha un suo profilo su facebook, il
giorno del compleanno del padre, gli fa gli auguri, sotto forma di un cuoricino
rosso, e scrive frasi di delicata malinconia: "Quanto vorrei l'affetto di una
persona e, purtroppo, questa persona non è presente al mio fianco e non sarà mai
presente per colpa del destino...". Già perchè la ragazza, a differenza di altri
figli di boss (quelli di Totò Riina, o di Bernardo Provenzano, o Nitto
Santapaola, per esempio) non avrebbe mai visto il padre in vita sua. Sa chi è,
quello che ha fatto e fa, ma non lo ha mai visto. Con la madre ha vissuto per
quasi vent'anni nella casa della madre di Messina Denaro, e con le sorelle di
lui; ma ora aspira a vivere una vita normale di una normale diciassettenne. Ha
un fidanzatino, vorrebbe fare quelle cose che fanno tutte le sue coetanee, fuori
dalla "gabbia" della mafiosità della famiglia del padre. La sua non è una
ribellione, piuttosto la richiesta di una liberazione. Qualcosa deve aver
toccato il cuore spietato del boss, o "semplicemente" ha fatto i suoi conti, si
è reso conto che era meglio allentare di qualche anello la catena. Perché una
cosa è indubitabile: se le due donne possono andare a vivere altrove significa
che il boss si è convinto che la cosa si può fare. C’è da augurarsi ora, che la
ragazza, staccandosi da quell'ambiente e vivendo normalmente la sua giovinezza,
come la figlia di don Mariano Arena, e nonostante l’ambiente in cui è vissuta,
il retaggio, i condizionamenti patiti e subiti, ne acquisti in “gentilezza”,
“pietosa” verso tutto ciò che il padre disprezza, “rispettosa” verso tutto ciò
che i mafiosi non rispettano. Merito della cultura, della “lettura di qualche
libro in più”? Altri figli di boss, come quelli di Bernardo Provenzano, hanno
studiato e si sono laureati in Germania, e con la mafia non hanno nulla a che
fare. Si sono liberati, o vogliono cercare di liberarsi, della “pelle” mafiosa.
Altri, al contrario, proprio grazie a lauree e specializzazioni in prestigiose
università, hanno ulteriormente affinato le tecniche criminali e ampliato gli
“imperi” dei padri e dei nonni. Ad ogni modo, resta l’intuizione di Sciascia,
che merita di essere approfondita e studiata. Se dicessi che già cinquant’anni
fa aveva capito tutto, lui per primo inarcherebbe il sopracciglio, con un gesto
di muto rimprovero. Tutto no, ma tanto, e l'essenziale, probabilmente sì.
Chi condanna i figli dei
Boss, scrive
Alessandro Ziniti su "La Repubblica". Il figlio di Totò Riina chiede il rilascio
della certificazione antimafia. Indiscutibilmente è una notizia e, come tale, i
giornali, "Repubblica" in testa, la pubblicano con il dovuto rilievo. Due
settimane dopo, a Corleone, l'azienda agricola dei figli del boss e la
lavanderia della moglie e dei figli di Bernardo Provenzano sono costrette a
chiudere i battenti. Il prefetto e la Camera di commercio non hanno dato le
necessarie autorizzazioni e le due attività, di per sé assolutamente legali,
devono immediatamente cessare. Certo, è un'altra notizia che fa scalpore e che
fa discutere. Ma, con altrettanta certezza, avrebbe fatto più clamore se agli
eredi dei due capi assoluti di Cosa nostra fosse stata rilasciata la
certificazione antimafia. Vi immaginate, lo Stato che rilascia la patente di
antimafiosità ai figli di Riina e Provenzano? Impossibile. Eccole, allora, a
secondo della prospettiva da cui la si guarda, le tante facce dell'ultima
vicenda che ha riportato Corleone agli onori della cronaca. Lo Stato, con i
provvedimenti dei giorni scorsi, ha - nei fatti - detto ai giovani figli dei
capi di Cosa nostra che a loro non è consentita alcuna attività "lecita".
Intendiamoci: l'azienda di macchine agricole e la lavanderia non sono state
chiuse perché condotte irregolarmente ma perché i legami dei titolari con la
criminalità organizzata "appaiono inequivocabili". E dunque, in assenza dei
requisiti personali, non sono nelle condizioni di ottenere le certificazioni che
le leggi dello Stato richiedono ad un qualunque cittadino. I figli dei boss sono
dunque condannati a non potere avere un futuro da "qualunque cittadino"? I
provvedimenti di questi giorni dicono di sì, ma davanti all'umano dubbio morale
o alla semplicistica "solidarietà" che i giovani rampolli di Cosa nostra possono
raccogliere, vale forse la pena di riflettere sul fatto che a decretare questa
terribile condanna non è solo lo Stato (almeno quello che non intende abbassarsi
ad alcuna "trattativa") ma, primi di tutti, i loro padri. Quei padri che, in
cella o latitanti da una vita, non sono riusciti a costruire per i loro figli un
futuro migliore. Certo, non deve essere stata facile la decisione del prefetto
di Palermo prima, del sindaco di Corleone poi, e poi ancora del presidente della
Camera di commercio: la ragion di Stato ha prevalso, e non avrebbe potuto essere
diversamente, su quella del "recupero" di questi ragazzi alla società
civile. Dice il sindaco di Corleone Pippo Cipriani, ogni giorno a contatto con i
giovani Riina e Provenzano: "Nessuna persecuzione, per carità. Io sono stato il
primo a tendere loro una mano quando sono tornati a Corleone. Certo, pretendere
che questi ragazzi rinneghino i padri forse è troppo, ma da loro non è mai
arrivato neanche un segnale, il più piccolo, della volontà di intraprendere una
strada diversa. L'apertura di quelle attività era il loro modo di riaffermare il
controllo sul territorio, un controllo che, in uno Stato civile, spetta alle
istituzioni". Poche decine di giorni prima e poche centinaia di metri più in là,
Giuseppe Riina, accettando per la prima volta di parlare davanti alle telecamere
della Rai, mostrava orgoglioso la sua azienda e spiegava: "Noi vogliamo lavorare
nella legalità, non vogliamo vivere tutta la vita con questo fardello sulle
spalle, se lo Stato non vuole che lo facciamo ce lo dica chiaramente". E la
risposta, inequivocabile, è arrivata poco dopo. Lo Stato non consente. Ma c'è
ancora un'altra faccia della vicenda: perché questi provvedimenti arrivano solo
ora se le attività, soprattutto quella dei Provenzano, era aperta da ben quattro
anni senza che nessuno avesse mai mosso un dito? E ancora perché si è mossa solo
l'autorità amministrativa e non anche quella giudiziaria? Riconosciuti
"nullatenenti", i due boss corleonesi non hanno mai "potuto" risarcire, così
come sancito da decine di sentenze, le vittime delle loro attività criminali. Le
misure di prevenzione hanno colpito in tutti questi anni i loro presunti o
accertati prestanome. Ma se quelle due piccole attività sono state messe su con
i proventi di quelle famiglie mafiose alle quali - dicono i provvedimenti - i
ragazzi sarebbero inequivocabilmente legati perché non sono state sequestrate?
Tanti perché, ognuno dei quali avrà sicuramente una valida risposta. Forse le
spalle di un prefetto, di un sindaco, di un presidente di Camera di commercio
sono troppo esili per reggere da sole il peso del futuro di questi ragazzi o
forse la vicenda di Corleone è lo specchio fedele dell'impasse dell'antimafia.
La figlia di Riina: vi
sembro donna di mafia?
L’ultimogenita di Salvatore e Ninetta Bagarella si racconta. La sua infanzia in
clandestinità, nelle campagne palermitane, e l’arrivo a Corleone dopo la cattura
del padre, il 15 gennaio 1993. L’impatto con la società e oggi il desiderio di
esprimersi attraverso l’arte, scrive Siana Vanella il 4 febbraio 2014 su
"Panorama". L'appuntamento è alle 12, all’entrata del paese. Ogni chilometro
rappresenta metri di riflessioni e punti interrogativi. Come sarà dal vivo Lucia
Riina? In fondo la sua persona ha sempre vissuto mediaticamente all’ombra del
padre Salvatore, di mamma Antonietta e dei fratelli Salvo, Maria Concetta e
Gianni. Il cartello «Corleone» indica che non è più tempo di pensare.
«Benvenuti nella mia città, vista l’ora che ne dite di fare un salto in
pescheria? Qui si trova dell’ottimo pesce». Così esordisce la più piccola di
casa Riina in jeans e t-shirt nera. Da lì a poco, eccoci nella cucina decorata
con maioliche blu e bianche e due chili di polipi da preparare. Mentre in
pentola il pesce cuoce insieme con il pomodoro fresco fatto da mamma Ninetta,
Lucia chiarisce la provenienza dei suoi occhi azzurri. «Il colore è tipico dei
Riina» spiega con in mano un mestolo di legno «quelli di mio padre sono
cangianti tra il marrone e il verde, anche se il taglio appartiene alla famiglia
Bagarella. Da piccola ero molto magra e mamma a colazione mi dava le vitamine
alla ciliegia. Ormai, da quando vivo in campagna, sono le uova della mia
fattoria a darmi energia». E in realtà, ad animare le giornate di Lucia e del
marito Vincenzo, alle prese con il lavoro a singhiozzo, ci pensano cani, gatti,
oche e galline. Sul suo sito si legge: «Sin da quando ero bambina ho avuto la
passione per il disegno, ricordo che mamma e papà cercavano di procurarmi
sempre album e matite ovunque eravamo. Io ero piccola e non capivo, però mi
entusiasmava l’idea che a ogni nuova residenza c’erano ad attendermi matite e
album nuovi».
Che ricordo ha della sua
infanzia?
«Ho
un ricordo di gioia e serenità. Si respirava amore puro in casa, sembrava di
vivere dentro a una fiaba: mamma mi accudiva, papà mi adorava e mia sorella
Mari per farmi addormentare mi raccontava le favole accarezzandomi i capelli.
Mio fratello Gianni mi metteva sulle sue gambe chiamandomi “pesciolino”, Salvo
(col quale la differenza di età è di appena tre anni, ndr) era il compagno di
giochi. Avevamo un cane e un gatto, per questo adoro gli animali».
Si respirava profumo di
arte?
«Mamma
ha conseguito il diploma magistrale, quindi ci parlava spesso di storia
dell’arte e di letteratura, papà era un appassionato di libri, e trascorreva le
sue serate a leggere volumi sulla storia della Sicilia. Credo di avere,
comunque, ereditato l’amore per la pittura dallo zio Leoluca (Bagarella, ndr),
il fratello di mia madre. In casa custodisco gelosamente alcuni suoi dipinti,
regali delle zie per il mio matrimonio: sapevano che anche dal carcere lo zio
avrebbe apprezzato il gesto. Da piccola si dilettava a disegnare pesci e
farfalle, adesso questi soggetti sono diventati i protagonisti delle sue tavole.
Rappresentano un po’ il mio carattere. Il pesce con la sua serenità e i suoi
colori cangianti, la farfalla con la sua libertà e delicatezza. Da bambina li
disegnavo per esprimere i miei stati d’animo, adesso per rievocare il mio
passato e comunicare il fatto di essere innamorata. Se dovessi rappresentare la
mia esistenza attraverso i colori utilizzerei il rosa e il celeste, ma anche il
giallo, il rosso e l’arancio perché mi ritengo una persona ottimista. La vita
va affrontata con coraggio e anche quando si presentano situazioni difficili
bisogna sempre andare avanti».
C’è qualcosa che le manca
per completare il quadro della sua serenità?
«La
mia è stata sicuramente una vita articolata e piena di difficoltà. È
traumatico per una bambina di 12 anni vedersi strappare, dall’oggi al domani, la
persona che più adora senza conoscerne i motivi e senza potergli dare nemmeno
un ultimo bacio. I mesi dopo l’arresto di papà sono stati durissimi: l’arrivo a
Corleone cercando di ambientarsi in una nuova realtà, frequentare la scuola
(eravamo infatti abituati alla mamma che tutti i giorni ci riuniva a un tavolo
impartendoci lezioni personalizzate), l’impatto con la società. A questo
aggiungete le visite in carcere. Non riesco ancora a dimenticare la prima, dopo
il periodo di isolamento di papà a Rebibbia: fu atroce, anzi peggio.
Inizialmente credo che la struttura non fosse organizzata ad accogliere papà, e
nemmeno noi, durante i colloqui. Ricordo che fecero entrare me, i miei fratelli
e la mamma in una stanza piena di sedie e con un paravento dotato di fori. Mio
padre era a pochi centimetri da noi, l’avrei potuto abbracciare in un istante,
ma le guardie erano tutte attorno a lui e ci imploravano di non alzarci. Abbiamo
passato tutto il tempo a piangere. Certe atrocità ai bambini non si fanno. Per
chi non mi conosce e si basa solo sulle polemiche sollevate dai media negli
anni, Lucia Riina non è quella bambina che si è risvegliata violentemente da
una fiaba e non è nemmeno la donna che oggi fa fatica, come tutti i giovani, a
trovare un’occupazione complice la crisi economica e un cognome forse un po’
ingombrante. Per me l’arte diventa un modo per rappresentare il mio mondo e far
conoscere agli altri realmente chi sono».
Nel suo sito afferma di non
aver potuto frequentare il liceo artistico di Palermo «perché a quell’età e in
quella situazione non potevo andare a studiare così lontano da casa». C’è un
artista da cui ha tratto spunti creativi?
«L’ispirazione
nasce dalla vita di tutti i giorni, dal luogo in cui vivo e dal fatto che sto
bene con mio marito. Negli ultimi mesi sto studiando le correnti
dell’astrattismo basate sugli stati d’animo espressi attraverso i colori, le
pennellate e le forme indefinite. Inoltre, sono attratta da Jackson Pollock e
dalla tecnica del dripping: mi piacerebbe reinterpretarla personalizzandola».
Oltre alla pittura avrebbe
voluto coltivare altre passioni?
«Sicuramente
la danza. Da piccola guardavo tutti i film del genere, mi mettevo davanti allo
specchio e ballavo o improvvisavo coreografie davanti ai miei genitori. Ancora
oggi rimango incantata dalla danza classica e se un giorno dovessi avere una
bimba mi piacerebbe vederla in tutù e calzamaglia».
Che cosa pensa di avere
ereditato dai suoi genitori?
«Da
papà, sicuramente, la gioia di vivere e l’ottimismo. Il fatto di andare sempre
avanti senza arrendersi. Con lui c’è sempre stato un feeling speciale, complice
anche il fatto di essere la più piccola in famiglia. Nelle lettere che mi
spedisce mi chiama ancora «Lucietta di papà» nonostante i miei 33 anni suonati.
Anche dal carcere, in questi anni, ha cercato spesso di ammorbidire mamma per le
classiche richieste che una figlia adolescente fa ai propri genitori. Mi
riferisco all’orario di rientro il sabato sera o al permesso per andare al mare.
Quando conobbi Vincenzo, mio fratello Salvo inizialmente era un po’ geloso così
ne parlai durante un colloquio a papà, che rispose: «Se la mia Lucietta è
contenta, fatele fare le sue scelte». Da mamma credo di aver ereditato l’amore
per gli affetti e per la conoscenza che mi ha spronato sempre a interagire con
nuove persone».
In questi anni sua madre ha
avuto un ruolo importante in famiglia. È stata moglie, madre e dal 1993 ha
dovuto pure sopperire all’assenza fisica di suo padre. Adesso i ruoli si sono un
po’ invertiti: è un po’ Lucia a dover sostenere Antonietta?
«Crescendo,
un figlio diventa un punto di forza per un genitore. Ci sono momenti in cui fare
i conti con la mancanza di papà per mia madre diventa difficile. Il loro è
stato un amore da romanzo: lei ha lasciato tutto per dedicarsi anima e corpo a
noi figli e al grande amore della sua vita. Tutte le volte che è giù perchè
pensa a papà o a Gianni che è in carcere le dico: «Mamma, stai tranquilla, io
sarò sempre accanto a te». È il minimo che puoi fare per chi ti dà la vita.
Lei aveva deciso di devolvere
a Save the children il 5 per cento del ricavato della vendita dei suoi dipinti,
ma la sua scelta ha causato polemiche. Da anni seguivo le iniziative di questa
associazione, così visitando la loro pagina ufficiale su internet venni a
conoscenza del fatto che chiunque, munito di sito, poteva inserire il banner di
Save the children per contribuire alle iniziative a favore dell’infanzia. Così,
venduti i primi quadri, ho inviato una parte del compenso con un bollettino
postale, cui seguì una lettera di ringraziamento intestata a me da parte
dell’associazione con tanto di tessera di socio e una esortazione a continuare a
contribuire. Io ero felicissima di poter aiutare bambini sfortunati e tutto mi
sarei aspettata tranne che, da lì a poco, Save the children potesse reagire in
quel modo. Ci sono rimasta malissimo, ho tolto il banner spiegando sul sito come
sono andate le cose perché voglio essere trasparente con chi mi segue. Il mio
è un lavoro onesto e da sempre il mondo dell’arte è legato alla beneficenza.
Adesso sono alla ricerca di una nuova associazione da sostenere, perché mi
sento realizzata quando faccio del bene».
RIINA FAMILY LIFE.
Mi chiamo Salvatore Riina, sono nato a Corleone e sono il figlio secondo genito
di Totò Riina e di Ninetta Bagarella. Dopo essermi consultato con la mia
famiglia, soprattutto con i miei genitori, ho deciso di scrivere questa
biografia per raccontare la storia della mia famiglia e dei rapporti tra noi
fratelli e sorelle e mio padre Totò e mia madre. Figli, tutti, nati e cresciuti
latitanti, dovendo seguire gli “spostamenti” forzati dei miei genitori. Ne parlo
con l’affetto di un figlio, anche se mio padre si chiama Totò Riina. Voglio
raccontare dall’interno la vita della famiglia più “conosciuta” al mondo, ma
solo di nome. Io voglio invece raccontare i fatti. Davvero tante saranno le
sorprese.
«La mia vita con Salvatore
Riina, mio padre». Il racconto di Giuseppe Salvatore, il figlio del boss.
Il figlio racconta: «Assieme nelle nottate alla tv per l’America’s Cup, non cenò
mai fuori. Me lo ricordo zitto il giorno di Capaci. Le vittime? Preferisco il
silenzio. Di mafia non parlo, e se lei mi domanda che cosa ne penso, io non
rispondo», scrive Giovanni Bianconi il 4 aprile 2016 su “Il Corriere della
Sera”. «Tra febbraio e marzo del 1992 passammo notti intere insonni davanti al
televisore a seguire il Moro di Venezia gareggiare nell’America’s Cup. Papà
preparava la postazione del divano solo per noi due, con un vassoio di biscotti
preparato per l’occasione e due sedie piazzate a mo’ di poggiapiedi... Io non
avevo ancora compiuto 15 anni e lui, Totò Riina, era il mio eroe». Che, in
quegli stessi giorni, pianificava e ordinava l’omicidio di Salvo Lima, il
politico democristiano assassinato per non aver saputo «aggiustare» il
maxiprocesso alla mafia. Poco dopo venne il 23 maggio: «La tv era accesa su
Rai1, e il telegiornale in edizione straordinaria già andava avanti da un’ora.
Non facemmo domande, ma ci limitammo a guardare nello schermo. Il viso di
Giovanni Falcone veniva riproposto ogni minuto, alternato alle immagini
rivoltanti di un’autostrada aperta in due... Un cratere fumante, pieno di
rottami e di poliziotti indaffarati nelle ricerche... Pure mio padre Totò era a
casa. Stava seduto nella sua poltrona davanti al televisore. Anche lui in
silenzio. Non diceva una parola, ma non era agitato o particolarmente
incuriosito da quelle immagini. Sul volto qualche ruga, appena accigliato,
ascoltava pensando ad altro». Era stato lui a decidere quella strage, per
eliminare il magistrato che aveva portato alla sbarra Cosa nostra fino a
infliggere l’ergastolo a Riina e compari. E poi il 19 luglio, mentre la famiglia
era in vacanza al mare: «Fu uno di quei giorni in cui mio padre preferì rimanere
a casa ad aspettarci, sempre circondato dai suoi giornali che leggeva lentamente
ma con attenzione. Negli ultimi mesi era diventato più attento nelle uscite in
pubblico, anche se dentro casa era sempre il solito uomo sorridente e disposto
al gioco». Al ritorno dalla spiaggia ancora la tv accesa, ancora immagini di
morte, fuoco e fiamme: «Il magistrato Paolo Borsellino appariva in un riquadro a
fianco, ripreso in una foto di poche settimane prima... Lucia, dodicenne, era la
più colpita da quelle immagini. Si avvicinò a mio padre silenzioso. “Papà,
dobbiamo ripartire?”. “Perché vuoi partire?” domandò lui, finalmente rompendo la
tensione con la quale fissava il televisore. “Non lo so. Dobbiamo tornare a
Palermo?”. “Voi pensate a godervi le vacanze. Restiamo al mare ancora per un
po’”. Lucia scoppiò in una ingenua risata e lo abbracciò... E così restammo lì
fino alla fine di agosto». Anche l’eccidio di via D’Amelio era stato deciso da
suo padre, Totò Riina. Ma questo particolare il figlio Giuseppe Salvatore detto
Salvo, lo omette. Così come non parla di Lima, di Falcone e di tutte le altre
vittime del capomafia corleonese che ha governato Cosa nostra a suon di omicidi.
«Io non sono il magistrato di mio padre — dice sfilandosi gli occhiali da sole
al tavolino di un bar di Padova, dove vive e lavora in libertà vigilata»,
divieto di lasciare la provincia e di uscire dalle 22 alle 6 —; non è competenza
mia dire se è stato il capo della mafia oppure no. Lo stabiliscono le sentenze,
io ho voluto parlare d’altro: la vita di una famiglia che è stata felice fino al
giorno del suo arresto, raccontata come nessuno l’ha mai vista e conosciuta». È
nato così il libro Riina-Family Life scritto da Salvo Riina che a maggio compirà
39 anni, mafioso anche lui per la condanna a 8 anni e 10 mesi di pena
interamente scontata, papà e fratello maggiore all’ergastolo (e al «41 bis»):
«Giovanni lo può incontrare in prigione, seppure con le limitazioni del “carcere
duro”, io no». E nel libro lamenta: «È dal gennaio del 1993 (quando Riina fu
catturato, ndr). Che non faccio una carezza a mio padre, e così le mie sorelle e
mia madre». Facile replicare che nemmeno i familiari dei morti di mafia possono
più accarezzare i loro cari, e chiedere un pensiero per loro: le vittime. Salvo
Riina risponde quasi di getto: «Non ne voglio parlare, perché qualunque cosa
dicessi sarebbe strumentalizzata». Dipende, forse. Ma lui insiste: «Meglio il
silenzio, nel rispetto del loro dolore e della loro sofferenza. Anche in questo
caso la meglio parola è quella che non si dice». Un motto che rievoca l’omertà
mafiosa, che però Riina jr contesta: «Non è omertà, è che io ho scritto il libro
non per dare conto delle condanne subite da mio padre, anche perché sarebbe
inutile. A me interessava far capire che esiste ed è esistita una famiglia che
non aveva niente a che fare coi processi e quello che succedeva fuori, e che
nessuno conosce anche se tutti pensano di poterla giudicare». Ne viene fuori
un’immagine di papà premuroso e amorevole che contrasta con la realtà
giudiziaria e storica del boss protagonista delle più cruente trame criminali.
«Non è quello che ho conosciuto io — ribatte convinto suo figlio —. Io sono
orgoglioso di Totò Riina come uomo, non come capo della mafia. Io di mafia non
parlo, se lei mi chiede che cosa ne penso non le rispondo. Io rispetto mio padre
perché non mi ha fatto mai mancare niente, principalmente l’amore. Il resto
l’hanno scritto i giudici, e io non me ne occupo». Quello che scrive Salvo Riina
diventa così un racconto asciutto ma ricco di dettagli sulla vita fra le mura
domestiche di una famiglia di latitante: Totò Riina e, di conseguenza, la moglie
e i figli nati mentre lui era ricercato; continui cambi di case, ma sempre tra
Palermo e dintorni; i bambini regolarmente registrati all’anagrafe ma
impossibilitati ad andare a scuola, con la mamma che insegnava loro a leggere e
scrivere; giochi e divertimenti garantiti ma niente amici in casa né visite a
casa di amici; il papà che esce la mattina per andare a lavorare — «il geometra
Bellomo», si faceva chiamare — e puntuale a cena si mette a tavola con la
famiglia: «Mai saltata una sera», garantisce Salvo; l’attrazione per i motorini
e le belle ragazze, i primi amori. Infanzia e adolescenza felici, assicura il
figlio del boss, trascorse senza fare domande: né sull’improbabile lavoro di un
«terza elementare», né sulla necessità di non avere contatti con l’esterno o sul
continuo girovagare, che col passare del tempo diventa consapevolezza di una
vita in fuga. «A mio padre non ho mai chiesto perché dovessimo nasconderci, e
nemmeno se era vero ciò che cominciai a sentire in tv o in giro, quando ho
scoperto che ci chiamavano Riina, e non Bellomo». Strano, perché? «Per rispetto
e pudore». Nei confronti di chi? «Di mio padre e mia madre: siamo cresciuti
abituati a non chiedere». Si potrebbe chiamare cultura mafiosa. «Io invece lo
chiamo rispetto, un’educazione a valori magari arcaici e tradizionali, che però
a me piacciono; valori forti e sani». Con l’arresto di Riina sr, il 15 gennaio
1993, cambiò tutto: l’arrivo a Corleone, l’esistenza non più clandestina ma
sotto i riflettori del mondo e il microscopio di investigatori e giudici, che
poi hanno arrestato e condannato i due figli maschi, Giovanni e lo stesso Salvo.
Che adesso narra quel che vuole (anche il carcere e la pena scontata, evitando
di entrare nel merito dei reati, fino al matrimonio della sorella accompagnata
all’altare in sostituzione del papà, e altro ancora) ma tace su tanti
particolari: dall’ultimo «covo» in cui abitò con suo padre ai commenti del
capomafia intercettati in carcere, quando confessò la «fine del tonno» riservata
a Falcone e altri delitti: «Non mi interessa soddisfare le curiosità altrui. Io
difendo la dignità di un uomo e della sua famiglia. E la sua coerenza, quando ha
rifiutato di collaborare con i magistrati. “Non ci si pente di fronte agli
uomini, solo davanti a Dio”, mi ripeteva». Il risultato lo giudicheranno i
lettori. L’editore, Mario Tricarico, chiarisce il senso di un’operazione che
ritiene legittima e interessante: «È come se in casa del “Mostro” che ha
governato l’impresa criminale forse più importante del mondo ci fosse stata una
telecamera nascosta che ne registrava i momenti di normalità, e adesso chi vuole
può vedere quel film». Scene di un interno mafioso che lasciano molte zone
d’ombra, ma rivelano un punto di vista: il figlio del boss che non vuole parlare
del boss bensì di un padre e di una madre «ai quali devo l’inizio della mia vita
e l’uomo che sono», come ha scritto nel libro. Senza nessun imbarazzo? «No,
nessun imbarazzo», risponde Salvo Riina rinforcando gli occhiali da sole.
"Licenziata per il cognome
che porto". Parla la nipote di Totò Riina.
Maria Concetta Riina, nipote
del boss, è stata definita "presenza inquietante" dal prefetto di Trapani. "Non
posso scontare le colpe di mio zio", scrive Carmelo Caruso il 20 luglio 2015 su
"Panorama". «Chi le dice che non ci sia mai stata tra i tanti che hanno reso
omaggio in silenzio e anonimamente…». Una Riina non può andare il 18 luglio in
via d’Amelio a commemorare Paolo Borsellino? «Non so più se per me esista un
luogo da dove non essere cacciata, inseguita e marchiata». Cambiare il cognome?
«Pensa che basterebbe?». Forse no, ma la aiuterebbe. «E però, se lo facessi
sarei una cattiva figlia. A quale figlia si può chiedere di dimenticare il
padre?» Più semplicemente si libererebbe di suo zio Totò Riina, di Corleone,
della genetica, e chissà perfino di quell’interdittiva del prefetto di Trapani,
Leopoldo Falco, che ha definito la sua presenza in azienda “inquietante”. «Ho 39
anni e mio zio l’ho conosciuto solo quando lo hanno catturato. In tutta la mia
vita l’ho visto solo due volte». E mentre parla Maria Concetta Riina si fa più
piccola della sua statura, che è quella dei Riina, prova a sgonfiare il viso
pasciuto, a rallentare gli occhi svelti e azzurri che vigilano su una fronte
rotonda d’adipe mediterranea, tutta carne e salute che invece di appesantire
alleggerisce, scioglie il carattere e lo pacifica. Dunque non è sguardo di mafia
ma solo quello eccitato della siciliana che fuma dalle narici, quel modo tutto
loro che hanno le donne nell’isola quando mettono le mani sui fianchi e
implorano i santi e Dio per farsi vendicare dai torti, «sono nelle mani del
Creatore». Crede? «Si, sono cattolica. Sono normale, italiana come tutte. Se
vuole saperlo non vado a messa ogni domenica. È una colpa anche questa?». Suo
padre Gaetano è stato arrestato nel 2011, così come i suoi cugini, e sono sempre
accuse per mafia. «Conosco mio padre e sono sicura che non abbia commesso nessun
reato. Oggi posso solo attendere che esca dal carcere. È un uomo di 82 anni con
un tumore alla prostata, un rene malandato, una scheggia conficcata nella gamba.
Accetto la sua reclusione in galera, se a stabilirlo è la giustizia, ma non
posso essere condannata per la mia famiglia, perseguitata come un’appestata». Il
padre Gaetano a Maria Concetta non ha trasmesso solo il cognome ma pure il nome
della nonna, così come ha fatto Totò con la sua prima figlia, la matriarca dei
Riina che fino a 90 anni si trascinava in tribunale e taceva, come taceva
Ninetta Bagarella che di fronte al suo Salvatore si eclissava, dimenticava i
suoi studi magistrali e tornava moglie, «perché questo vuol dire che deve essere
il mio destino» rispondeva ai giudici la maestra Ninetta: «Ho studiato pure io.
Diplomata in ragioneria. Per due anni ho frequentato la facoltà di
giurisprudenza poi ho lasciato». Voleva fare l’avvocato per difendere suo zio?
«Lo ripeto. Per me è stato un estraneo fino al suo arresto. Ero curiosa quanto
voi di vedere la sua faccia». In Sicilia non bisognerebbe “latitare” dalla
famiglia? «Mi sono allontanata e ho provato a costruirne una. Ma evidentemente
non basta se un prefetto definisce la mia presenza “inquietante” costringendo il
mio datore di lavoro a licenziarmi, a lasciarmi senza uno stipendio dopo dieci
anni di attività». Suo zio dopo la Sicilia ha dannato anche lei. «Non posso
essere dannata per ciò che ha fatto e se lo ha fatto». Vede? È prigioniera del
cognome. «Io non credo che abbia potuto commettere da solo tutto quello per cui
è condannato e che fosse solo lui il padreterno». Ha chiamato sua figlia con il
nome della nonna? «No». L’abbigliamento di Maria Concetta Riina non è il nero
castigo della letteratura di mafia, rosari e spine alle donne e lupara e velluto
ai mariti, ma bensì il colore di questa estate torrida a Mazara del Vallo dove
ha casa: t-shirt bianca da madre indaffarata, jeans da spesa e mercato, elastico
ai capelli fulvi per afferrare meglio i venti. Di Maria Concetta Riina non
esistono fotografie, che rifiuta, a differenza di sua cugina e dell’altra figlia
di Totò, Lucia che si è mostrata e raccontata proprio a Panorama. «Non me lo
chieda. Altro che fotografia. Vorrei scomparire e se non avessi perso il lavoro
non sarei qui a parlare». Andare? «Io voglio restare. Sono incensurata, non ho
neppure una multa per divieto di sosta. E poi anche andare via dalla Sicilia non
basterebbe. Dopo il cognome è il viso che dovrei mutare. Più degli avvocati
avrei bisogno di un chirurgo estetico che mi cambi i tratti, mi faccia perdere
peso. A volte credo che anche il corpo mi imprigioni a una storia che non mi
appartiene». Nello studio dell’avvocato Giuseppe La Barbera, un uomo dal corpo
solido come una montagna, ad accompagnare la Riina c’è il marito, «ci siamo
sposati nel 2011 e oggi abbiamo una figlia di due anni. E ho più pietà per lui
che per me. Gli ho portato come dote un bollo, ha dovuto sopportare le battute
degli amici». E infatti l’unico che si aggira sperduto in questo fondaco di
legali e in questa giurisprudenza di concorso esterno per associazione di nome,
è proprio quest’uomo di trentanove anni, magro come quegli esseri che
consumandosi si asciugano nel peso ma addensano pensieri, si chiudono nel
mutismo che in Sicilia è dolore acerbo, un frutto che non cade dall’albero. «Da
due anni non lavora, ha il terrore ogni volta che spedisce un curriculum. Rimane
in silenzio. Quale marito sarebbe felice di vedere sua moglie segnata come
un’indegna». Non sapeva di sposare una Riina? «Ha sposato me e non certo mio zio
o mio padre. Lui per primo mi ha imposto come precondizione di rimanere a
distanza dalla mia famiglia. L’unica colpa è che si è innamorato di me». Con una
disposizione del prefetto di Trapani che ha definito «inquietante» la sua
presenza in azienda senza contestare reati ma solo prevedendo possibili
infiltrazioni mafiose, Maria Concetta Riina è stata licenziata da segretaria
nella concessionaria di automobili dove lavorava da dieci anni, licenziamento
per giusta causa e che La Barbera insieme alla sua collega Michela Mazzola
vogliono adesso impugnare: «Ricorreremo al giudice del lavoro, chiederemo il
reintegro e un’indennità risarcitoria» spiega l’avvocato nel suo studio di
Villabate, pochi chilometri da Palermo, l’unico comune d’Italia che ha avuto sia
lo scioglimento per mafia che il commissario chiamato a governarlo indagato a
sua volta per mafia. E certo anche La Barbera sa che è possibile rincorrere il
diritto ma che è impossibile chiedere di cambiare i connotati ai clienti.
«Comprendo pure il mio datore di lavoro. Lo hanno costretto a licenziarmi. Era
addolorato ma non aveva scelta. Mi chiedo solo perché» dice Maria Concetta che
anche quando è seduta si sente un’imputata. Non crede che l’abbia assunta per
riverenza come scrive il prefetto? «Mi ha assunta dopo avermi conosciuta in
spiaggia sotto l’ombrellone. Un’amicizia che è nata e che poi si è tradotta in
un lavoro da segretaria, lontana da qualsiasi contatto con il pubblico. Se
avesse provato riverenza nei miei confronti non avrebbe osato licenziarmi per
un’interdittiva. Fin quando mi è stato possibile ho lavorato come farebbe la
signora Rossi da mattina a sera. Io e mio marito siamo una delle tante famiglie
normali di questo paese. 1100 euro di stipendio, un mutuo, la bambina lasciata
alla nonna. E se non mi avessero licenziata sarei rimasta quella persona anonima
che ho sempre cercato di essere in paese. Solo oggi agli occhi di tutti sono
tornata a essere una Riina. Non esco più di casa per paura dell’ottusità della
gente». La ignoravano o la temevano? «Mi presento a tutti come Maria Concetta,
ormai sono abituata a omettere il mio cognome e non perché me ne vergogni, ma
perché so benissimo che tutti penserebbero a mio zio e smetterebbero di vedermi
come donna e madre. Oggi, dopo questa interdittiva, non sono più una donna ma
un’entità». La Barbera, che mafiosi ne ha difeso, finora mai si era imbattuto
nell’accusa di mafia per biologia che si dice pronto a smontare nei tribunali ma
che prima ancora vorrebbe abbattere più come pregiudizio che come capo: «È
evidente che qui siano gravemente compromessi i principi costituzionalmente
garantiti del diritto al lavoro. Siamo di fronte ad un inorridimento delle norme
giuridiche. La mia cliente cerca solo una giusta e anonima quotidianità». E
anche Michela Mazzola insieme a Claudia Gasperi, due giovani avvocate
determinate e specializzate in diritto del lavoro, e che adesso difendono la
Riina, dicono che più delle norme di mafia qui andrebbero rilette quelle sullo
statuto dei lavoratori: «Si tratta di un vero e proprio atto persecutorio a una
lavoratrice», dice la Gasperi. Volete fare “guerra” allo Stato? «Agiremo contro
il prefetto e il ministro degli Interni - aggiunge La Barbera a volte sfiduciato
e disincantato anche lui - non ho mai visto tanta ipocrisia. Va bene il diritto,
ma qui siamo alla barbarie dei nomi come destino». In Sicilia, lo ripetiamo,
adesso è l’anagrafe che andrebbe bonificata. Ecco, forse dopo i migranti è
arrivato il momento di assegnare lo status di rifugiato anche ai figli senza
colpa, ai nipoti senza macchia come Maria Concetta Riina, concedere l’asilo dal
cognome. «Ditemi cosa debbo intanto fare per vivere. Nessun azienda può
assumermi. Neppure per togliere la spazzatura da un ristorante mi assumerebbero.
Me lo cerchi lo Stato un posto di lavoro dove il mio nome non possa avere
influenze o destare referenze. Me lo dica lo Stato». Lasciamo Palermo pensando
che davvero tutto ci inquieta tranne questa donna.
Intervista di Dina
Lauricella ad Angelo Provenzano figlio di Bernardo Provenzano.
Il figlio del Boss Provenzano parla per la 1a volta a Servizio Pubblico il
15.3.2012. Il vero giornalismo racconta i fatti, non promuove opinioni
ideologiche culturalmente conformate. Ciononostante l’intervista ha suscitato
l’indignazione dei mafiosi antimafiosi. Perché in Italia secondo i cittadini
“onesti”, che ogni giorno salgono agli onori della cronaca, i mafiosi son sempre
gli altri.
Il figlio di Bernardo
Provenzano star per turisti. E quei rapporti difficili nella famiglia del boss.
Angelo
Provenzano è diventato, per fare soldi, un'attrazione per gli americani che
arrivano in Sicilia e vogliono immergersi nelle atmosfere del Padrino. E una
vecchia intercettazione di una discussione col fratello spiega cosa significa
avere il boss dei boss come padre, scrive Lirio Abbate il 30 marzo 2015 su
"L'Espresso". L'attrazione per i turisti americani che pagano un viaggio di
andata e ritorno per la Sicilia, anzi per Corleone, è diventato Angelo
Provenzano, 39 anni, figlio del vecchio capomafia Bernardo Provenzano. Gli
Yankees sono ancora legati alle immagini del film il Padrino. Immagini che
raccontavano di don Corleone e del clan siciliano. Oggi un tour operator sfrutta
quel mito grazie anche al fatto che il punto finale della visita guidata a
Palermo è proprio Corleone, dove i turisti incontrano personalmente la star,
Angelo Provenzano, ingaggiato dalla società americana. E lui racconta a modo suo
la mafia, la sua vita e la latitanza del padre. Scelte personali che hanno il
solo scopo di fare soldi. A sei mesi dall'arresto di Bernardo Provenzano i
poliziotti avevano registrato un'interessante conversazione fra i figli del boss
Angelo e suo fratello Paolo. È il 28 settembre 2005 e gli agenti ascoltano i due
fratelli, mentre chiacchierano in una cabina della motonave La Suprema, il
ferryboat che da Palermo li porta a Genova. Paolo sta trasferendo tutte le sue
cose in Germania dove in quel momento si trasferiva per un periodo di
insegnamento, ed ha chiesto al fratello di guidare con lui un’auto piena zeppa
di bagagli. È una conversazione importante che alla luce del risvolto
“turistico” di Angelo Provenzano è utile ricordare per analizzare la vita dei
due ragazzi e della loro madre. Per comprendere che rapporto avevano con il
padre, durante la latitanza. Questa intercettazione l'avevamo riportata per la
prima volta nel libro “I Complici” scritto con Peter Gomez, in un capitolo che
raccontava proprio di “due fratelli in barca”. Il rumore della sala macchine è
un cupo ronzio confuso, i due figli del boss stanno cenando. Sul tavolino
pieghevole di formica c’è il cibo che Saveria, loro madre, ha preparato a casa.
I ragazzi lo guardano e pensano che nelle ultime settimane le incomprensioni in
famiglia sono aumentate. Le tensioni sono ormai evidenti: a zio Simone, il
fratello di Binu che li ha allevati in Germania, è stato persino vietato di
entrare in casa quando Saveria è sola. Ha fatto troppe domande che non doveva,
anche sull’operazione alla prostata di suo fratello Bernardo, si è lasciato
sfuggire molte parole di troppo. Ma il capo dei capi lo ha scoperto, si è
adirato e ha disposto l’ostracismo nei suoi confronti. «Lo zio Simone non si
lamenta. Dice soltanto che ci sono delle cose mal riportate oppure che quello
[Binu] è uscito folle. Altra soluzione non ne ha», spiega Paolo. «E le cose che
sono mal riportate [secondo lui] da dove vengono? [Intende dire] che gliele
andiamo a riportare male noi altri? Giusto». «O la mamma, Angelo». Dunque zio
Binu, in quelle prime settimane di autunno, è ancora lì, vicinissimo a Corleone,
tanto vicino che i suoi parenti lo vanno a trovare, discutono con lui, parlano
di un’abitazione che deve essere lasciata in eredità a qualcuno, riaprono
vecchie ferite, solo nascoste, ma mai del tutto rimarginate. Il suo arrivo, dopo
quattordici anni di lontananza, in un nucleo familiare che ormai era riuscito a
trovare da solo i propri equilibri, sta minando dalle fondamenta ogni certezza.
E oltretutto Paolo, che ha solo ventitré anni e che di fatto non frequenta più
il padre da quando ne aveva nove, si è dovuto confrontare con un genitore che è
per lui un estraneo. Dice al fratello: «Tra l’altro, ci sono sempre state cose
che a me hanno dato fastidio: perché quando lui [nel 1992] ha detto di partire
[cioè di tornare a Corleone], siamo dovuti partire a prescindere da tutti nostri
cazzi di problemi e nessuno se ne è mai fatto un baffo? [E anche] questa volta
[quando] io sono arrivato [dal mio nuovo lavoro in Germania, era] il primo
sabato [libero], va bene? E siamo dovuti andare là, siamo andati a finire là
[nel suo nascondiglio]. L’interesse suo non so quale sia. Io non vedo interesse
in un colloquio, in un dialogo con lui: almeno personalmente con me non c’è mai
stata una cosa del genere. [...] Quando mi dovevo laureare [nel marzo del 2005]
e dovevo fare l’ultimo esame, non gliene è fottuto a nessuno se io potevo avere
i miei problemi e invece dovevo andare a fare la bella statuina da lui. Perché
poi io vado a fare [solo quello] da lui. Tu [Angelo] bene o male, sei sempre
stato più coinvolto, ma io da lui ho sempre fatto la bella statuina, fin da
piccolo». Il doloroso sfogo sul difficile rapporto con un padre latitante (nel
vero senso della parola) va avanti per cinque minuti buoni. La cabina della
motonave si riempie di risentimenti, di recriminazioni, di frasi che forse Paolo
vorrebbe non aver mai pronunciato. Poi il fratello maggiore lo interrompe:
«Paolo, vuoi sapere come la penso? Lui nel posto dove si trova ci si è davvero
trovato per caso». «E io dovrei essere contento di una cosa del genere? Io devo
essere contento che le cose succedano per caso? Io devo essere contento che ora
si sta ricostituendo questa sorta di unione [familiare]… per caso! Anzi no, io
lo chiamo caso e lui la chiama invece volontà di Dio [...] e poi neanche te lo
ammettono che è per caso, Angelo». «No, assolutamente perché…». «[Pensa di aver
fatto per noi] tutte cose, lui. [Papà continua a ripetere:] “ora ti racconto di
quando [io e gli zii] eravamo piccoli”. [Dice] che suo padre gli dava le
bastonate e che lui a nove anni se ne andava a vendere i [parola
incomprensibile], e invece noialtri [abbiamo avuto tutto]. [Ma] quando ti [fa]
la domanda: “Ti è mai mancato niente?” [Si può] mai aspettare una risposta
positiva? [Perché la fa,] perché cerca sicurezza? [...] Mi dispiace [dirlo], mi
dispiace». Angelo non lo contraddice, ma invita a riflettere. In famiglia, come
in ogni famiglia, tutti hanno le loro colpe, le loro responsabilità. Ce l’ha
Saveria, loro madre, «che ha subito tutte le decisioni, che non ha mai avuto il
coraggio di dire: “questa cosa mi piace, questa cosa non mi piace, facciamola
così, facciamola colì”». E ce le hanno anche loro, perché in casa Provenzano
«hanno subito tutti». «Se poi ci sono anche delle responsabilità personali
questo è un discorso. [Lo possiamo] addossare al destino, alla volontà di Dio...
[Ma] i dati di fatto sono che noi abbiamo subìto tutta una serie di situazioni e
le continuiamo a subire. Non ci si può né ribellare né provare ad aggiustare la
croce per portarla con comodo. [Io] non l’ho mai detto a nessuno, [...] ma
quanti si sono resi conto che la situazione, che abbiamo vissuto noi, è
addirittura peggiore di avere un padre morto?». Quante domande, quanti
interrogativi senza risposta. «[Stiamo vivendo] cose assurde, Angelo. O assurdo
sono io. Boh, mi piacerebbe tanto saperlo certe volte. Mi piacerebbe veramente
cominciare a capire la vita come va… e se continua così». «Quando ci sveglieremo
e lo avremo capito avremo settanta anni ciascuno, Paolo, e sarà troppo tardi».
“Fiero di mio padre”: il
figlio di Bernardo Provenzano parla a Servizio Pubblico.
L'intervista esclusiva al
primogenito del boss di Cosa Nostra in onda nella puntata di stasera del
programma di Santoro. "Falcone e Borsellino? Due vittime immolate sull'altare
della patria, due vittime della violenza", scrive David Perluigi il 15 marzo
2012 su "Il Fatto Quotidiano". “La verità processuale dice che mio padre è stato
il capo di Cosa Nostra. Certo, a pensare che oggi, a distanza di 20 anni dalle
stragi, sui giornali si sta parlando di revisione, dobbiamo riscrivere qualche
verità a questo punto”. Le parole sono cadenzate, intervallate da sospiri,
pronunciate per la prima volta davanti a una telecamera da Angelo Provenzano,
figlio di Bernardo, 36 anni il primogenito del capomafia corleonese.
Bell’aspetto, ben vestito, buona dialettica, lavora nel settore vinicolo. Sicuro
di sé, si definisce “fiero del padre”. E’ il ritratto che se ne ricava
dall’intervista video esclusiva rilasciata all’inviata di Servizio
Pubblico, Dina Lauricella, che andrà in onda stasera alle 21. Mesi di tentativi,
attraverso la mediazione di uno degli avvocati dei Provenzano, Rosalba Di
Gregorio: un primo contatto un anno fa, un “no che lasciava comunque delle
aperture” racconta al Fatto la giornalista palermitana “poi nuovi, pazienti
tentativi, fino a un mese fa quando il legale di famiglia, mi dice: 'Chiami lei
signorina direttamente il signor Angelo questa volta'”. Studi da geometra,
incensurato, come anche il fratello più piccolo di tre anni, Francesco Paolo,
“unico, e io per lui, compagno di giochi per 16 lunghi anni, gli anni anche
della mia latitanza. Ho vissuto in un reality show, essere figlio di una persona
latitante per 43 anni, vuol dire essere messo sotto controllo e ne sono stato
consapevole. Solo dopo la fine della mia ‘latitanza’ è cominciata la mia
rinascita, il contatto con la gente, prima conoscevo solo pochi volti”. Gli
viene chiesto cosa ne pensa dei collaboratori di giustizia e alle loro
ricostruzioni sul periodo stragista. Provenzano accenna un sorriso: “Sì, è
un’anomalia tutta italiana questa dei collaboratori di giustizia. Ma stiamo
parlando di uomini e si possono dare anche delle indicazioni sbagliate. In ogni
cosa in cui c’è l’uomo c’è la possibilità dello sbaglio”. “Sulle stragi, sopra
l’impronta della mafia, si accavalla l’ombra dello Stato”, interviene la
giornalista. “In questi anni – risponde – mi sono cimentato nello studio delle
cose, mi sono imbattuto nella strage di Portella della Ginestra, dopo 50 anni
scopriamo, forse, che non è stata opera di un bandito, Salvatore Giuliano, ma di
un pezzo dell’esercito italiano. Mi sembra che sia un copione che venga recitato
la seconda volta e non è su queste cose che si può fondare una fiducia
incondizionata, quando qualcosa parte dall’interno dello Stato – continua – si
rischia di perdere la fiducia”. “Chi sono per lei Falcone e Borsellino?” chiede
Lauricella. “Per me sono due vittime immolate sull’altare della patria. Sono due
vittime della violenza”. Fa attenzione a non usare mai il termine “mafia” Angelo
Provenzano; anche quando gli viene chiesto “la mafia le fa schifo?”, lui
risponde: “Tutti i tipi di violenza mi danno fastidio”. Sul punto in
cui Riina sostiene che sia stato Bernardo Provenzano a venderlo allo Stato,
Angelo è netto: “Se riesce a ottenere il permesso dal Dap (il dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria), vada a rivolgere la domanda direttamente a
mio padre”. Sulla possibilità che un giorno il padrino possa collaborare con la
giustizia, replica: “Nello stato attuale trovo che sia difficile immaginarlo che
collabori con lo Stato, sarebbe una dimensione totalmente nuova”. “Ma cosa
chiede oggi lei in concreto, nei fatti?”. “Quello che io chiedo è che si faccia
una perizia per capire se mio padre è capace di intendere e volere, se a
livello neurologico possa essere curato. Vorrei dignità. Ma deve stabilirlo lo
Stato. Noi siamo consapevoli che sarà difficile che venga scarcerato, chiediamo
però che venga curato. Mio padre – prosegue – vive un decadimento neurologico
tale da non poter ricevere cure chemioterapiche per il suo tumore alla prostata.
Perché ci deve essere questa discriminante? Perché si chiama Provenzano? Perché
è un membro di Cosa Nostra?”. “L’incapacità di intendere e volere potrebbe
mettere a rischio il proseguimento di processi fondamentali?”, conclude la
giornalista. “Che qualcuno si prenda allora la responsabilità di istituire la
pena di morte anche ad personam”.
La giornata nazionale della
memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.
A proposito delle vittime
della mafia e la solita liturgia antimafia che nasconde il malaffare.
In virtù degli scandali gli
Italiani dalla memoria corta periodicamente scoprono che sui bisogni della gente
e dietro ad ogni piaga sociale (mafia, povertà ed immigrazione, randagismo,
ecc.) ci sono sempre associazioni e cooperative di volontariato che vi lucrano.
Un sistema politico sostenuto da una certa stampa e foraggiato dallo Stato.
Stato citato dalle grida sediziose dei ragazzotti che gridano alle
manifestazioni organizzate dal solito sistema mafioso antimafioso. Cortei che
servono solo a marinare la scuola ma in cui si grida: “Fuori la mafia dallo
Stato”. Poveri sciocchi, se sapessero la verità, capirebbero che nessuno
rimarrebbe dentro a quello Stato, compresi, per primi, coloro che sono a capo di
quei cortei inneggianti.
La scusa delle piaghe sociali
non è che serve ad una certa sinistra per espropriare la proprietà dei ricchi o
percepire finanziamenti dallo Stato al fine di ridistribuire la ricchezza, senza
che si vada a lavorare?
Le aziende messe ko dallo
Stato in nome dell'antimafia.
In fumo 72mila posti di lavoro. Non è mai stato creato un albo degli
amministratori giudiziari e neppure una tabella dei compensi. E i furbetti fanno
affari e disastri, scrive Luca Fazzo, Lunedì 05/01/2015, su "Il Giornale".
Serrande abbassate sul Café de Paris, nel cuore di via Veneto, a Roma. Trentadue
operai al posto di 2.500 alla Colocoop di Milano. Un buco di due milioni e mezzo
alla Calf di Catania, che prima macinava utili. Cos'hanno in comune un bar nella
Capitale, una cooperativa di lavori stradali, una società di servizi portuali in
Sicilia? Sono passate nel tritacarne della legge antimafia, quella che prevede
misure draconiane per colpire gli interessi economici della criminalità. Legge
sacrosanta nei princìpi. Ma che si risolve in una Caporetto quando, dopo che
aziende grandi e piccole sono finite nel mirino della giustizia, accusate a
ragione o a torto di essere la longa manus delle cosche, a prenderle in mano è
lo Stato. Dovrebbe essere lo Stato a incarnare l'economia buona che prende il
posto di quella cattiva, mandando avanti secondo legalità ciò che prima viveva
nell'orbita del crimine. Risultato: un disastro. L'ultimo rapporto di Srm,
l'osservatorio sull'economia meridionale di Intesa San Paolo, parla di
settantaduemila posti di lavoro (diecimila più dell'intera Fiat!) persi nel
passaggio delle imprese dalle mani del crimine a quelle dello Stato. Di oltre
millesettecento aziende sequestrate, ne sono ancora vive trentotto. Trentotto. E
va bene che la catastrofe può avere più di una spiegazione nobile: l'azienda
mafiosa sta a galla più facilmente, perché non rispetta le regole, paga in nero,
intimidisce i concorrenti, soggioga i clienti. Tutte armi che lo Stato non ha.
Ma gli addetti ai lavori sanno bene che dietro alla catastrofe dei beni c'è
anche un colossale problema di inefficienza dello Stato, che si è assunto un
dovere che non è in grado di compiere. A partire dai livelli più alti. Il Codice
antimafia varato nel 2011 prevedeva che venisse creato un albo nazionale degli
amministratori giudiziari, i professionisti incaricati di gestire le aziende
confiscate: sono passati più di tre anni, e l'albo ancora non c'è. A febbraio
dello scorso anno, il governo ha promesso il varo di una tabella nazionale dei
compensi da pagare agli amministratori: non si è vista neppure questa, col
risultato che ogni tribunale si regola a modo suo, e a mandare avanti (e più
spesso ad affossare) le aziende sono commercialisti pagati a volte cifre
spropositate. Anche sui criteri di scelta ci sarebbe da discutere:
nell'inchiesta su Mafia Capitale compare il nome di Luigi Lausi, uno dei
professionisti cui il tribunale romano ha affidato una lunga serie di aziende
confiscate, di cui Salvatore Buzzi dice «Lausi è mio». E a volte, come nel caso
della Piredil di Milano, si scopre che gli amministratori inviati dal tribunale
continuavano a trescare con i vecchi proprietari. Ci sono tre modi in cui lo
Stato interviene per colpire gli interessi economici del crimine. Il primo, il
più semplice, è l'interdittiva antimafia spiccata dalle prefetture, che non
decapita le aziende ma si limita a bloccare i loro appalti pubblici: spesso è
più che sufficiente per affossarle. Sacrosanto quando dietro ci sono davvero i
clan; meno quando, come nel caso della Colocoop, nel frattempo i manager
sospettati di essere collegati ai clan sono stati assolti. Poi c'è il sequestro
disposto dai pm durante le inchieste. Infine, ed è lo strumento più usato, il
provvedimento delle cosiddette «misure di prevenzione», che può scattare a
prescindere dall'esistenza di un'inchiesta penale, sulla base di un semplice
sospetto, o anche se il processo penale è finito in nulla. Il provvedimento ha
una durata massima di diciotto mesi, quanto basta per disintegrare qualunque
azienda, ed è inappellabile. Il caso più eclatante da questo punto di vista è
probabilmente quello di Italgas, l'azienda di distribuzione gas di Snam, tremila
addetti, messa sotto amministrazione giudiziaria dal tribunale di Palermo il 9
luglio 2014 sulla base di remoti contatti di un manager locale con una ditta in
odore di mafia. Il manager non è mai stato neanche indagato, la ditta è stata
assolta con formula piena, ma Italgas rimane commissariata. Per giovedì prossimo
era fissata un'udienza, ma a fine dicembre i pm hanno chiesto e ottenuto il
rinnovo del commissariamento per altri sei mesi; nel frattempo, secondo alcuni
calcoli, gli amministratori nominati dal tribunale hanno già presentato parcelle
per diversi milioni di euro. Nel corso dell'audizione davanti alla commissione
Antimafia, il deputato di Scelta civica Andrea Vecchio ha motivato così il
trattamento riservato all'azienda: «Mi sono arrivate chiacchiere da bar secondo
le quali, in passato, la quasi totalità delle imprese che hanno messo i tubi per
la Snam, da nord a sud, erano mafiose». Così, tra inchieste serie e chiacchiere
da bar, l'elenco delle aziende inghiottite e distrutte in nome dell'antimafia
cresce giorno per giorno. Fare i conti di questo disastroso business è quasi
impossibile. Secondo le stime più caute, il valore totale dei beni confiscati è
intorno ai dieci miliardi di euro, ma la commissione Antimafia parla di un
totale superiore ai trenta miliardi. Una parte di questo colossale patrimonio è
costituito da beni immobili, che hanno il pregio di essere poco deperibili, e di
poter essere dati in affido a associazioni antimafia come Libera di don Ciotti,
o usate - è uno degli ultimi casi - per alloggiare i carabinieri della compagnia
di Partinico. Ma la fetta più grossa è quella delle attività imprenditoriali, ed
è qui che lo Stato-manager fa i danni peggiori. Dal momento della confisca di
primo grado, i beni vengono presi in mano dall'Agenzia nazionale per i beni
confiscati, guidata da un prefetto. In teoria, dovrebbe esserci anche un
consiglio direttivo, ma è vacante da tempo, compresi i due «qualificati esperti
in materia di gestioni aziendali e patrimoniali», che dovrebbero cercare di
evitare la dissipazione dei beni sequestrati. Così, nel frattempo, la
distruzione va avanti. Gli amministratori giudiziari vengono pagati
profumatamente, qualunque siano i danni che producono. «La verità - dice un
addetto ai lavori - è che oggi fare l'amministratore dei beni confiscati è un
business ambito. Si fanno un sacco di amicizie, non si rischia niente, si
guadagna bene».
Antimafia, la profezia di Sciascia.
È evidente che il malaffare siciliano ha adottato il
codice di camuffarsi dietro le insegne dell’antimafia. Non si tratta di accuse
generiche, si possono fare nomi e cognomi, scrive Paolo Mieli il 6 aprile 2016
su "Il Corriere della Sera". Adesso dovremmo tutti riconoscere che il pericolo
era stato ben intravisto trent’anni fa da Leonardo Sciascia per quanto è ormai
evidente che il malaffare siciliano ha adottato il codice di camuffarsi dietro
le insegne dell’antimafia. E, se il presidente di Confindustria in uscita,
Giorgio Squinzi, volesse fare un gesto di cortesia nei confronti del suo
successore, Vincenzo Boccia, utilizzerebbe gli ultimi giorni del suo mandato per
convincere il suo proconsole in Sicilia Antonello Montante — grande sostenitore
della lotta a Cosa Nostra ma da oltre un anno indagato per concorso esterno in
associazione mafiosa — a farsi da parte. E, nel contempo, ad abbandonare
l’ingombrante incarico di delegato «per la legalità» di tutti gli industriali
italiani. Non sono del tutto chiare le vere ragioni che hanno indotto Squinzi
fin qui (ancora domenica sera, intervistato da Milena Gabanelli) a non esortare
Montante ad affrontare la sua vicenda giudiziaria senza coinvolgere
l’organizzazione che rappresenta. Ma sarebbe nobile da parte sua lasciare al
presidente che verrà dopo di lui una Confindustria simile a quella di dieci anni
fa quando Ivan Lo Bello, proprio in Sicilia, avviò una campagna di pulizia che
ebbe un’eco di approvazione in tutto il Paese. Eviteremmo così grandi imbarazzi
come quello in cui si sarebbe potuto trovare domattina il capo dello Stato,
Sergio Mattarella, il quale, in visita ufficiale a Noto per rendere onore allo
straordinario restauro della Cattedrale, dovrà affidarsi a un rigidissimo
protocollo che — salutati il governatore della Regione Rosario Crocetta e il
sindaco Corrado Bonfanti — gli eviti di stringere le mani di qualche
rappresentante della politica o dell’imprenditoria siciliana. Personaggi «a
rischio» anche (e forse soprattutto) nel caso si presentino avvolti nelle
bandiere della lotta ai padrini. Cosa sta succedendo in Sicilia? I campioni
dell’antimafia «non servono più», lo ha detto persino Leoluca Orlando: «Chi si
ostina a voler rimanere tale, spesso si rivela poi un impresentabile o un
corrotto». Stiamo parlando di un fenomeno gustosamente descritto da Nando Dalla
Chiesa: «A un convegno si presenta il tale magistrato che fu “impegnato nella
trincea di Palermo ai tempi di Giovanni Falcone”. Seguono applausi… che
cos’abbia fatto non si sa, magari complottava contro Falcone. Il tal’altro è
invece un freelance minacciato dalla mafia e dunque censurato (magari ha solo
fatto un dvd o un libro fallimentare): subito invitato nelle scuole, anche a
pagamento. Un nullasapiente gioca a spararla più grossa di tutti, delirando di
trame e di complotti? È l’unico che ha il coraggio di dire le cose come stanno,
meno male che c’è lui. E poi il commerciante che pretende di essere in pericolo
di vita e se la prende con gli “antimafiosi da tastiera” che non solidarizzano
abbastanza, salvo scoprire che paga un delinquente per sparargli contro il
chiosco». Giancarlo Caselli, a proposito della legge per la gestione dei beni
confiscati ai mafiosi, ha constatato che «è venuta delineandosi anche
un’antimafia degli affari e delle partite Iva, un mestiere, un sistema di
relazioni opache». Raffaele Cantone si dice preoccupato per alcuni «fatti
oggettivi»: il «coinvolgimento in indagini giudiziarie di soggetti considerati
icone dell’antimafia»; le «vicende che hanno sfiorato magistrati di primissimo
livello per i quali si credeva che il contrasto alle mafie fosse un valore»; la
«questione dei beni confiscati e il fatto che sia stata messa in discussione
persino Libera», l’associazione di don Luigi Ciotti. Tutti coloro che si
occupano di mafia da vicino sanno che le cose da tempo stanno proprio così: Rosy
Bindi ha messo questo tema all’ordine del giorno della Commissione da lei
presieduta; lo storico Salvatore Lupo (assieme a Giovanni Fiandaca) ne ha
cominciato a scrivere con coraggio. E già si pubblicano libri che denunciano
questi camuffamenti: «Contro l’Antimafia» di Giacomo Di Girolamo; «Antimafia
Spa» di Giovanni Tizian e Nello Trocchia; «Le trappole dell’Antimafia» di Enrico
del Mercato ed Emanuele Lauria. Lo studioso Rocco Sciarrone (in «Alleanze
nell’ombra») dimostra, dati alla mano, che tutte ma proprio tutte le imprese
della connection mafiosa in provincia di Palermo si erano «travestite» con una
pronta adesione ad associazioni antiracket. Accuse generiche? No. Si possono
fare nomi e cognomi. Vincenzo Artale titolare di un’azienda di calcestruzzo che
da dieci anni era salito alla ribalta come grande accusatore di mafiosi e, un
anno fa, era stato eletto in un ruolo dirigente dell’associazione antiracket del
suo paese, è stato arrestato in provincia di Trapani per tentata estorsione
«aggravata dal favoreggiamento alla mafia» (quella di Mazara del Vallo). I
costruttori Virga di Marineo, a dispetto del loro sostegno alle associazioni
nemiche di coppola e lupara e dei riconoscimenti ottenuti da associazioni del
calibro di «Addio pizzo», di «Libero futuro» e financo dal Fai, sono stati
accusati di essersi arricchiti con il sostegno del mandamento di Corleone. Mimmo
Costanzo anche lui grande paladino antimafioso, è stato arrestato nell’inchiesta
sulla corruzione Anas ed è al centro di indagini per i suoi rapporti con la
cosca catanese. Idem Concetto Bosco Lo Giudice finito, con lo stesso genere di
imputazioni, ai domiciliari. E se non è mafia, sono comunque storie di natura
consimile. Carmelo Misseri imprenditore di Florida in provincia di Siracusa
(«ribellarsi è giusto», ripeteva in pubblico) pagava tangenti alla Dama Nera
dell’Anas, Antonella Accroglianò. E, a proposito di Siracusa, c’è l’imbarazzante
caso di una Confindustria locale guidata dapprima da Francesco Siracusano
(dimissionato per affari sospetti), poi commissariata con Ivo Blandina (rinviato
a giudizio per un’allegra gestione di fondi con i quali aveva acquistato uno
yacht) e infine con Gianluca Gemelli ( il «marito» di Federica Guidi travolto,
assieme alla compagna ministra, dalla vicenda Total). Il presidente della Camera
di Commercio di Palermo Roberto Helg anche lui proclamatosi grande combattente
contro «la piaga delle estorsioni», è stato condannato a quattro anni e otto
mesi dopo che era stato filmato mentre intascava una tangente di centomila euro
da un poveretto che voleva aprire una pasticceria all’aeroporto del capoluogo
siciliano. E tramite il «caso Helg» si scopre una parentela tra le vicende
siciliane di Confindustria e quelle di Unioncamere, altra associazione in cui si
notano sintomi di diffusione dell’infestazione qui descritta. Per non farsi
mancare nulla, Montante è anche presidente Unioncamere Sicilia e della Camera di
Commercio di Caltanissetta. Se Squinzi volesse favorire il debutto del suo
successore, potrebbe trovare l’occasione (che so?) di pronunciare a freddo un
«elogio di Sciascia». Montante capirebbe l’antifona e ne trarrebbe le
conseguenze. Forse.
Giuseppe Costanza ha deciso
di parlare perché a suo parere troppi lo fanno a sproposito.
C' è un uomo che più di altri
avrebbe titolo a dire qualcosa sull'apparizione di Riina junior in Rai e sulla
lotta alla mafia in generale. È Giuseppe Costanza, l'autista di Giovanni Falcone
negli ultimi otto anni di vita del magistrato, dal 1984 fino al 23 maggio 1992.
Costanza era a Capaci, scrive Alessandro Milan per “Libero Quotidiano” il 18
aprile 2016. Di più, Costanza era a bordo della macchina guidata da Falcone e
saltata in aria sul tritolo azionato da Giovanni Brusca. Eppure in pochi lo
sanno. Perché per quei paradossi tutti italiani, e siciliani in particolare, da
quel giorno Costanza è stato emarginato. Non è invitato alle commemorazioni,
pochi lo ricordano tra le vittime. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, di essere
suo ospite a cena in Sicilia e ho ricavato la sensazione di trovarmi di fronte a
qualcuno che è stato più del semplice autista di Giovanni Falcone: forse un
confidente, un custode di ricordi e, chissà, uno scrigno di segreti. Che però
Costanza dispensa col contagocce: «Perché un conto è ciò che penso, un altro è
ciò che posso provare». Un particolare mi colpisce del suo rapporto con Falcone:
«Il dottore - Costanza lo chiama così - aveva diritto a essere accompagnato in
macchina, oltre che da me, dal capo scorta. Ma pretendeva che ci fossi solo io».
Perché non si fidava di
nessun altro?
«Quale altro motivo ci
sarebbe?».
Cominciamo da Riina a
"Porta a Porta"?
«Mi sono rifiutato di vederlo.
Solo a sapere che questo soggetto era stato invitato da Bruno Vespa mi ha dato
il voltastomaco. Vespa qualche anno fa ha invitato pure me, mi ha messo nel
pubblico e non mi ha rivolto una sola domanda. Ora parla con il figlio di colui
che ha cercato di uccidermi. I vertici della Rai dormono?».
Cosa proponi?
«Lo Stato dovrebbe requisire i
beni che provengono dalla vendita del libro di Riina. Questo si arricchisce
sulla mia pelle».
Lo ha proposto la
presidente Rai Monica Maggioni.
«Meno male. Ma tanto non
succederà nulla. D'altronde sono passati 24 anni da Capaci senza passi avanti».
Su che fronte?
«Hanno arrestato la
manovalanza di quella strage. Ma i mandanti? Io un'idea ce l'ho».
Avanti.
«Presumo che l'attentato sia
dovuto al nuovo incarico che Falcone stava per ottenere, quello di Procuratore
nazionale antimafia».
Ne sei convinto?
«Una settimana prima di Capaci
il dottore mi disse: "È fatta. Sarò il procuratore nazionale antimafia"».
Questa è una notizia.
«Ma non se ne parla».
Vai avanti.
«Se lui avesse avuto
quell'incarico ci sarebbe stata una rivoluzione. Sempre Falcone mi disse che
all' Antimafia avrebbe avuto il potere, in caso di conflitti tra Procure, di
avocare a sé i fascicoli. Chiediti quali poteri ha avuto il Procuratore
antimafia in questi anni. E pensa quali sarebbero stati se invece fosse stato
Falcone».
Chi non lo voleva
all'Antimafia?
«Forse politici o faccendieri.
Gente collusa. Ma queste piste non le sento nominare».
Torniamo ai mandanti.
«L'attentato a Palermo è un
depistaggio, per dire che è stata la mafia palermitana. Sì, la manovalanza è
quella. Ma gli ordini da dove venivano? Ti racconto un altro particolare. Io
personalmente, su richiesta di Falcone, gli avevo preparato una Fiat Uno da
portare a Roma. E lui nella capitale si muoveva liberamente, senza scorta. Se
volevano colpirlo potevano farlo lì, senza tutta la sceneggiata di Capaci.
Ricorda l'Addaura».
21 giugno 1989, il fallito
attentato all'Addaura. Viene trovato dell'esplosivo vicino alla villa affittata
da Falcone.
«Io c'ero».
All'Addaura?
«Sì, ero lì quando è
intervenuto l'artificiere, un carabiniere. Eravamo io e lui. Lui ha fatto
brillare il lucchetto della cassetta contenente l'esplosivo con una destrezza
eccezionale. Poi ha dichiarato in tribunale che il timer è andato distrutto. Ha
mentito. Io ho testimoniato la verità a Caltanissetta e lui è stato condannato».
Invece come è andata?
«L'esplosivo era intatto. Lo
avrà consegnato a qualcuno, non chiedermi a chi. Evidentemente lo ha fatto
dietro chissà quali pressioni».
Falcone aveva sospetti dopo
l'Addaura?
«Parlò di menti
raffinatissime. Io posso avere idee, ma non mi va di fare nomi senza prove.
Attenzione, io non generalizzo quando parlo dello Stato. Ma ci sono uomini che
si annidano nello Stato e fanno i mafiosi, quelli bisogna individuarli».
23 maggio 1992: eri a
Capaci.
«Ma questo agli italiani,
incredibilmente, non viene detto. Quella mattina Falcone mi chiamò a casa, alle
7, comunicandomi l'orario di arrivo. Io allertai la scorta. Solo io e la scorta
in teoria sapevamo del suo arrivo».
Cosa ricordi?
«Falcone, sceso dall'aereo, mi
chiese di guidare, era davanti con la moglie mentre io ero dietro. All'altezza
di Capaci gli dissi che una volta arrivati mi doveva lasciare le chiavi della
macchina. Lui istintivamente le sfilò dal cruscotto, facendoci rallentare. Lo
richiamai: "Dottore, che fa, così ci andiamo ad ammazzare". Lui rispose: "Scusi,
scusi" e reinserì le chiavi. In quel momento, l'esplosione. Non ricordo altro».
Perché la gente non sa che
eri su quella macchina?
«Mi hanno emarginato».
Chi?
«Le istituzioni. Ti sembra
giusto che la Fondazione Falcone non mi abbia considerato per tanti anni?».
La Fondazione Falcone
significa Maria Falcone, la sorella di Giovanni.
«Io non la conoscevo».
In che senso?
«Negli ultimi otto anni di
vita di Giovanni Falcone sono stato la sua ombra. Ebbene, non ho mai
accompagnato il dottore una sola volta a casa della sorella. Andavamo spesso a
casa della moglie, a trovare il fratello di Francesca, Alfredo. Ma mai dalla
sorella».
Poi?
«Lei è spuntata dopo Capaci.
Ha creato la Fondazione Falcone e fin dal primo anno, alle commemorazioni, non
mi ha invitato».
Ma come, tu che eri l'unico
sopravvissuto, non eri alle celebrazioni del 23 maggio 1993?
«Non avevo l'invito, mi sono
presentato lo stesso. Mi hanno allontanato».
È incredibile.
«Per anni non hanno nemmeno
fatto il mio nome. Poi due anni fa ricevo una telefonata. "Buongiorno, sono
Maria Falcone". Mi ha chiesto di incontrarla e mi ha detto: "Io pensavo che
ognuno di noi avesse preso la propria strada". Ma vedi un po' che razza di
risposta».
E le hai chiesto perché non
eri mai stato invitato prima?
«Come no. E lei: "Era un
periodo un po' così. È il passato". Ventitre anni e non mi ha mai cercato. Poi
quando ho iniziato a denunciare il tutto pubblicamente mi invita, guarda caso.
Comunque, due anni fa vado alle celebrazioni, arrivo nell'aula bunker e scopro
che manca solo la sedia con il mio nome. Mi rimediano una seggiola posticcia. Mi
aspettavo che Maria Falcone dicesse anche solo: "È presente con noi Giuseppe
Costanza". Niente, ancora una volta: come se non esistessi».
L' emarginazione c'è sempre
stata?
«Un anno dopo la strage di
Capaci sono rientrato in servizio alla Procura di Palermo ma non sapevano che
cavolo farsene di un sopravvissuto. Così mi hanno retrocesso a commesso, poi
dopo le mie proteste mi hanno ridato il quarto livello, ma ero nullafacente».
Per l'ennesima volta:
perché?
«Ho avuto la sfortuna di
sopravvivere».
Come sfortuna?
«Credimi, era meglio morire.
Avrei fatto parte delle vittime che vengono giustamente ricordate ma che
purtroppo non possono parlare. Io invece posso farlo e sono scomodo. Diciamola
tutta, questi presunti "amici di Falcone" dove cavolo erano allora? Ma chi li
conosce? Io so chi erano i suoi amici».
Chi erano?
«Lo staff del pool antimafia.
Per il resto attorno a lui c'era una marea di colleghi invidiosi. Attorno a lui
era tutto un sibilìo».
Tu vai nelle scuole e parli
ai ragazzi: cosa racconti di Falcone?
«Che era un motore trainante.
Ti racconto un episodio: lui viveva in ufficio, più che altro, e quando il
personale aveva finito il turno girava con il carrellino per prelevare i
fascicoli e studiarli. Questo era Falcone».
È vero che amava scherzare?
«A volte raccontava
barzellette, scendeva al nostro livello, come dico io. Però sapeva anche
mantenere le distanze».
Tu hai servito lo Stato o
Giovanni Falcone?
«Bella domanda. Io mi sentivo
di servire lo Stato, che però si è dimenticato di me. E allora io mi dimentico
dello Stato. L'ho fatto per quell' uomo, dico oggi. Perché lo meritava. È una
persona alla quale è stato giusto dare tutto, perché lui ha dato tutto. Non a
me, alla collettività».
Il presidente Mattarella
non ti dà speranza?
«Io spero che il presidente
della Repubblica mi conceda di incontrarlo. Quando i miei nipoti mi dicono:
"Nonno, stanno parlando della strage di Capaci, ma perché non ti nominano?", per
me è una mortificazione. Io chiederei al presidente della Repubblica: "Cosa devo
rispondere ai miei nipoti?"».
Questo silenzio attorno a
te è un atteggiamento molto siciliano?
«Ritengo di sì. Fuori dalla
Sicilia la mentalità è diversa. Devo dire anche una cosa sul presidente del
Senato, Piero Grasso».
Prego.
«Di recente, a Ballarò,
presentando un magistrato, un certo Sabella, come colui che ha emanato il
mandato di cattura per Totò Riina, mi indicava come "l'autista di Falcone".
Ma come si permette questo
tizio? Io sono Giuseppe Costanza, medaglia d'oro al valor civile con un
contributo di sangue versato per lo Stato e questo mi emargina così? "L'autista"
mi ha chiamato. Cosa gli costava nominarmi?».
Costanza, credi nell'
Antimafia?
«Non più. Inizialmente dopo le
stragi c'è stata una reazione popolare sincera, vera. Poi sono subentrati troppi
interessi economici, è tutto un parlare e basta. Noi sopravvissuti siamo pochi:
penso a me, a Giovanni Paparcuri, autista scampato all' attentato a Rocco
Chinnici, penso ad Antonino Vullo, unico superstite della scorta di Paolo
Borsellino. Nessuno parla di noi».
Il 23 maggio che fai?
«Mi chiudo in casa e non
voglio saperne niente. Vedo personaggi che non c'entrano nulla e parlano, mentre
io che ero a Capaci non vengo nemmeno considerato. Questa è la vergogna
dell'Italia».
“Meno attacchi in cambio di
soldi”: indagato a Palermo paladino della tv antimafia.
Pino Maniaci, direttore di
Telejato. Il direttore di Telejato Pino Maniaci è sospettato di aver estorto
favori e compensi a due sindaci. Le conversazioni intercettate, scrive Francesco
Viviano il 22 aprile 2016 “La Repubblica”. Chiedeva, e avrebbe ottenuto,
"contributi" e posti di lavoro in cambio di una linea morbida della sua
televisione nei confronti di alcuni sindaci del Palermitano. Pino Maniaci,
giornalista e direttore di Telejato di Partinico (Palermo), tv di frontiera
antimafia, è sotto inchiesta, come racconta "Repubblica" oggi in edicola. La
procura di Palermo ipotizza il reato di estorsione. Un'accusa gravissima per un
personaggio che, da anni, dalla sua tv conduce battaglie contro mafia e
malaffare. L'ultima, quella contro la gestione dei beni confiscati in cui sono
coinvolti l'ex presidente delle misure di prevenzione del Tribunale di Palermo
Silvana Saguto (sospesa dalle funzioni e dallo stipendio dal Csm), altri tre
magistrati e l'amministratore giudiziario, Gaetano Cappellano Seminara, tutti
indagati per vari reati e costretti alle dimissioni. "La vendetta della Procura
è arrivata. Non mi è arrivato alcun avviso di garanzia e sono certo che tutto
ciò non porterà ad alcun rinvio a giudizio. Ma intanto mi hanno infangato",
replica il direttore di Telejato a "Palermo Today". Maniaci è stato più volte
ascoltato e intercettato dai carabinieri nell'ambito di altre indagini: avrebbe
ottenuto favori in cambio di una "linea morbida" della sua emittente nei
confronti dei due amministratori comunali, i sindaci di Partinico e Borgetto.
Dalle conversazioni intercettate sarebbero emersi altri elementi a carico di
Maniaci che avrebbe ottenuto dal sindaco di Partinico e da quello di Borgetto,
Gioacchino De Luca, finanziamenti sotto forma di pubblicità per la sua emittente
televisiva. I due sindaci, interrogati da carabinieri e magistrati, avrebbero
fatto delle ammissioni. Gli inquirenti avrebbero espresso anche qualche dubbio
in relazione ad uno degli ultimi atti intimidatori che Pino Maniaci avrebbe
subito nel dicembre del 2014 quando due suoi cani furono avvelenati ed
impiccati. Per gli investigatori non si tratterebbe di una intimidazione
mafiosa, ma sarebbe legata ad una vicenda privata. Ad aggravare la posizione di
Maniaci, proprio le ammissioni di Salvatore Lo Biundo e Gioacchino De Luca,
rispettivamente sindaci di Partinico e Borgetto. Maniaci tuttavia si ritiene
estraneo ai fatti e così commenta: “La vendetta della Procura è arrivata. Non mi
è arrivato alcun avviso di garanzia e sono certo che tutto ciò non porterà ad
alcun rinvio a giudizio. Ma intanto mi hanno infangato”. Da parte sua Pino
Maniaci rispedisce le accuse al mittente: “La vendetta della procura è
arrivata. Non mi è arrivato alcun avviso di garanzia e sono certo che tutto ciò
non porterà ad alcun rinvio a giudizio. Ma intanto mi hanno infangato”, ha detto
il giornalista a PalermoToday. “Sapevamo di questa inchiesta, nata prima dello
scandalo Saguto e che parte da alcune intercettazioni ben precise. Una – ha
detto ancora al quotidiano – è quella fra l’ex prefetto di Palermo Silvana
Cannizzo e la stessa Saguto, che a domanda rispose: ‘Ha le ore contate’. Penso
possa entrarci anche la denuncia per stalking di Cappellano Seminara, che aveva
l’obiettivo di farmi mettere sotto controllo il telefono. Il piano era ed è
quello di bloccarmi per impedirmi di fare il mio lavoro. Chiederemo con il mio
avvocato di essere sentiti, perché siamo sicuri che quello che dicono i
magistrati sulle ammissioni è totalmente falso. Qualcuno non vuole che nostra
inchiesta su incarichi Ctu e sezione Fallimentare continui. Ma noi andiamo
avanti”.
Telejato, Maniaci: "Io indagato?
L'Antimafia mi vuole fermare". Il direttore di
Telejato Pino Maniaci risponde alle accuse in un'intervista di Lorenzo Lamperti
su Affaritaliani.it il 22 aprile 2016.
"Non ho ricevuto nessun avviso di garanzia". Pino
Maniaci, il direttore dell'emittente tv Telejato noto per le sue scomode
inchieste antimafia, commenta a caldo in un'intervista su Affaritaliani.it la
notizia riportata da Repubblica secondo la quale sarebbe indagato dalla Procura
di Palermo con l'ipotesi di reato di estorsione.
Pino Maniaci, Repubblica scrive che lei sarebbe
indagato con l'ipotesi di reato di estorsione.
«L'avvocato mi
aveva detto di aspettare e non fare dichiarazioni prima di parlare con lui ma io
non sono il tipo. Non avendo nulla da nascondere non ho nessun problema a
parlare».
Ha ricevuto l'avviso di garanzia?
«Io non ho
ricevuto nessun avviso di garanzia, non si capisce nemmeno che inchiesta è.
Vogliono tirarmi un po' di merda addosso».
Si scrive che lei avrebbe ottenuto favori in
cambio di un linea morbida della sua emittente Telejato nei confronti di due
amministratori comunali.
«Intanto siamo
nel campo delle ipotesi, ho letto testualmente. Quindi non capisco come sul
campo delle ipotesi e su delle indagini in corso ci sia questa violazione grave.
Come la possiamo definire, fuga di notizie? Non so come definirla...»
Ma che cosa risponde alle accuse?
«Entrando nel
merito di quello che ho letto personalmente siamo stati querelati come emittente
dal presidente del consiglio comunale di Borgetto perché in un servizio abbiamo
detto che sono andati in America sia il presidente sia il sindaco a incontrare
dei malavitosi. Tra le altre cose, il Comune tramite il sindaco si è costituito
parte civile nel processo quindi non capisco dove sarebbe questa linea morbida
di cui si parla».
Nessuna linea morbida neppure verso il Comune
di Partinico?
«Sul Comune di
Partinico abbiamo fatto giornalmente dei servizi sulla mala gestio che sono
ovviamente verificabili negli archivi di Telejato».
Si scrive anche che sua moglie sarebbe stata
assunta dal Comune di Partinico.
«Tutte
minchiate. Sul campo delle assunzioni, io ho tutta la famiglia disoccupata e
quindi non capisco come sia venuta fuori questa cosa. O meglio, forse lo
capisco...»
Che cosa vuole dire?
«Partiamo da
una denuncia che ho ricevuto a suo tempo per stalking da Cappellano Seminara.
Una denuncia che ha fatto sì che mi tenessero sotto controllo non per
diffamazione ma, appunto, per stalking. E poi c'è la questione dell'inchiesta
sui beni sequestrati. E' un'inchiesta che non è piaciuta a molti e probabilmente
c'era qualcuno che voleva bloccarla. Sa che cosa mi ha detto un magistrato? Mi
ha detto così: "A questo punto stai attento che non ti ammazza la mafia ma
l'antimafia"».
Pino Maniaci non potrà risiedere nelle
province di Palermo e Trapani. Le intercettazioni
svelano che non era minacciato dai boss, ma dal marito della sua amante, che gli
avrebbe bruciato l'auto e impiccato i cani. Ma lui diceva in Tv: “Sono
perseguitato per le mie inchieste”. Lo aveva chiamato pure Renzi per esprimergli
solidarietà e poco dopo Maniaci commentava: "Mi ha telefonato quello stronzo",
scrive Salvo Palazzolo il 4 maggio 2016 su “La Repubblica”. Non sono stati i
boss di Cosa nostra a bruciare l’auto di Pino Maniaci, il direttore di Telejato
diventato in questi anni un simbolo dell’antimafia. Non sono stati i boss a
impiccare i suoi due amati cani. La mafia non c’entra proprio niente in questa
storia. Le intercettazioni disposte dalla procura di Palermo svelano che le
intimidazioni a Pino Maniaci le avrebbe fatte il marito della sua amante. E lui
ne era ben consapevole. Ma ai giornali e alle Tv annunciava in pompa magna: “E’
stata la mafia a minacciarmi per le inchieste del mio tg”. Quel giorno, era il 4
dicembre dell’anno scorso, gli telefonò persino il presidente del Consiglio per
esprimere solidarietà. E qualche minuto dopo, lui si vantava al telefono, con
un’amica: “Ora tutti, tutti in fibrillazione sono, pensa che mi ha telefonato
quello stronzo di Renzi”. E’ un altro Pino Maniaci – niente affatto eroe della
legalità - quello che emerge dalle intercettazioni dei carabinieri della
Compagnia di Partinico. Il giornalista è indagato per estorsione nei confronti
dei sindaci di Partinico e Borgetto, come anticipato nei giorni scorsi da
Repubblica: avrebbe preteso soldi e favori per ammorbidire i suoi servizi
televisivi. Questa mattina, gli è stato notificato un provvedimento di divieto
di dimora nelle province di Palermo e Trapani. Il provvedimento è stato emesso
dal gip Fernando Sestito su richiesta dei sostituti procuratori Francesco Del
Bene, Amelia Luise, Annamaria Picozzi, Roberto Tartaglia e dal procuratore
aggiunto Vittorio Teresi. Un’inchiesta che si aggiunge alle altre di questi
ultimi mesi sui simboli dell’antimafia finiti nella cenere. Pino Maniaci è
accusato di aver estorto al sindaco di Partinico Salvatore Lo Biundo anche
un’assunzione per la sua amante. Un contratto di solidarietà al Comune per tre
mesi: “Alla scadenza, non poteva essere rinnovato – ha ammesso il sindaco
interrogato dai carabinieri – ma Maniaci diceva che dovevamo farla lavorare a
tutti i costi e allora io e alcuni assessori ci siamo autotassati per pagarla”.
Intanto, lui si vantava al telefono con l’amante: “Per quella cosa ho parlato,
già a posto, stai tranquilla, si fa come dico io e basta. Qua si fa come dico io
se ancora tu non l’avevi capito… decido io, non loro… loro devono fare quello
che dico io, se no se ne vanno a casa”. Per i magistrati è la prova chiarissima
delle “vessazioni” imposte dal giornalista antimafia. Maniaci era ormai in pieno
delirio di onnipotenza. All’amante diceva di volerle fare vincere un concorso
all’azienda sanitaria locale di Palermo. Grazie alle sue solite buone amicizie.
“Quello che non hai capito tu è la potenza… tu non hai capito la potenza di Pino
Maniaci. Stai tranquilla che il concorso te lo faccio vincere”. E spiegava di
essere in partenza per ritirare un premio antimafia: “A me mi hanno invitato
dall’altra parte del mondo per andare a prendere il premio internazionale del
cazzo di eroe dei nostri tempi, appena intitolato l’oscar di eroe dei nostri
temi”. Era il novembre 2014. In un’altra occasione: “Ormai tutti e dico tutti si
cacano se li sputtano in televisione”. Nei giorni scorsi, il giornalista si è
difeso sostenendo di essere vittima di un complotto, per le sue denunce sulla
gestione dei beni confiscati. Ma nel novembre 2014, l’inchiesta sulla gestione
allegra della sezione Misure di prevenzione di Palermo non era neanche nella
mente dei magistrati di Caltanissetta, che iniziarono a indagare nel mese di
maggio successivo. L'indagine su Maniaci è nata per caso, durante alcuni
accertamenti dei carabinieri sulle amministrazioni comunali. E stanotte è anche
scattato un blitz dei carabinieri del Gruppo Monreale, fra Partinico e Borgetto,
coinvolge nove presunti mafiosi. “C’è il sindaco che mi vuole parlare – diceva
ancora all’amante – per ora lo attacco perché gli ho detto che se non si mette
le corna a posto lo mando a casa, hai capito? A natale non ti ci faccio
arrivare, che te ne vai a casa e non ci scassi più la minchia”. Poi aggiungeva:
“Mi voglio fare dare 100 euro così domani te ne vai a Palermo tranquilla”.
Intercettazioni che per la procura diretta da Francesco Lo Voi non lasciano
spazio a interpretazioni. Il direttore di Telejato sussurrava ancora, a
proposito del sindaco: “Dice che in tasca non ne aveva e che stava andando a
cercare i soldi… i piccioli li deve andare a cercare a prescindere… così ne
avanzo 150 di iddu”.
Indagine su Maniaci, il giornalista:
"Abbiamo toccato poteri forti, me l'aspettavo". Il
direttore di TeleJato è un fiume in piena: "Non ho nulla da temere, dopo il caso
Saguto mi immaginavo qualcosa del genere. A proposito, a che punto è
quell'inchiesta?", scrive Francesco Viviano il 22 aprile 2016 su “La
Repubblica”. Da accusatore ad accusato dalla procura di Palermo con l’ipotesi di
reato di estorsione nei confronti dei sindaci di Partinico e di Borgetto dai
quali avrebbe ottenuto favori e contributi, cosa succede? “Abbiamo toccato
poteri forti ed ovviamente ci aspettavamo una reazione che è puntualmente
arrivata”. Pino Maniaci, direttore della emittente Telejato che copre un vasto
territorio del palermitano e del trapanese, è un fiume in piena, si difende poco
ma attacca molto come è nel suo stile preannunciando che attraverso il suo
avvocato, l’ex pm antimafia Antonino Ingroia, denuncerà i magistrati che lo
hanno indagato. Intanto su Facebook e Twitter il popolo del web si divide fra
colpevolisti e innocentisti.
“L’iniziativa della Procura – afferma Maniaci - è
un vero e proprio agguato ed una vendetta per il lavoro che abbiamo fatto e che
facciamo ancora oggi contro il malaffare e l’ illegalità anche all’ interno
della magistratura come nel caso dell’ inchiesta sulla gestione dei beni
confiscati alla mafia dove a capo di tutto c’era l’ex presidente della sezione
misure di prevenzione Silvana Saguto ed il suo clan, che è stata indagata e
punita dal Csm che l’ha sospesa dalle funzioni e dallo stipendio anche se lei
continua a prendere oltre 5000 mila euro al mese”.
La Procura che tende agguati e che si vendica?
Mi pare un po’ eccessivo o no?
“Guarda che già nel settembre scorso qualcuno
dentro la procura di Palermo mi aveva avvertito dicendomi che entro dicembre
sarei stato arrestato e che sarebbe stata proprio l’antimafia e non la mafia ad
attaccarmi cosa che è puntualmente accaduta”.
Ma ci sarebbero delle intercettazioni che,
secondo l’accusa, dimostrerebbero che avresti compiuto dei reati, ottenendo
favori dai due sindaci di Borgetto e Partinico in cambio, diciamo così, di un
occhio di riguardo nei loro confronti nei tuoi servizi giornalistici.
“Allora io dal sindaco di Borgetto contro cui ho
fatto dei servizi per alcuni suoi viaggi sospetti negli Stati Uniti (e per
questo mi ha anche querelato) dove avrebbe incontrato alcuni mafiosi, non ho
ottenuto nulla. Da sua moglie, invece si”.
Che cosa?
“Dei contratti pubblicitari per Telejato dove
pagava 250 euro al mese, cifre che fanno veramente ridere”.
Ed il posto di lavoro per una sua conoscente al
comune di Partinico?
“Io non ho fatto assumere nessuno e dico e ripeto
che nella mia famiglia, sono tutti disoccupati”.
Quindi nessuna assunzione di favore?
“Ripeto, nella mia famiglia sono tutti
disoccupati”.
Quindi nulla di illegale? Ne sei proprio certo?
“Non ho nulla da temere, queste accuse della
Procura di Palermo mi fanno ridere. Non ho ricevuto nessun avviso di garanzia né
di conclusione delle indagini e questa è stata una vendetta per le mie inchieste
sulla gestione dei beni confiscati alla mafia. Le mie intercettazioni sono nate
a “tavolino”. Ci aspettavamo una cosa del genere soprattutto dopo la denuncia
dell’avvocato Cappellano Seminara, amico della Saguto, anche lui finito
indagato, che ha dato modo e possibilità alla procura di mettere sotto controllo
il mio telefono e di intercettarmi. In Italia guai a toccare i poteri forti e
tra questi la magistratura ma io continuerò il mio lavoro ed anche per questa
indagine, attraverso il mio avvocato, Antonino Ingroia, li denuncerò, per
competenza, alla Procura di Caltanissetta”.
Con quali accuse?
“Non posso anticipare nulla per il momento, ma
starete a vedere….Proprio nei giorni scorsi su Telejato abbiamo ampliato lo
spettro della nostra inchiesta sulla gestione dei beni confiscati a quella sulla
sezione fallimentare del Tribunale di Palermo, dove ci sono interessi enormi e
dove girano gli stessi nomi e cognomi, di amici degli amici dei magistrati e
di altri amministratori giudiziari. Tutto questo dà fastidio, molto fastidio,
ecco perché tentano di fermarmi con indagini che non hanno nè capo nè coda”.
Ma sapevi di questa inchiesta nei tuoi
confronti?
“Qualcosa avevamo intuito proprio dalle
intercettazioni relative alla Saguto ed ai suoi amici che sono stati tutti
indagati dalla Procura di Caltanissetta: a proposito a che punto è questa
inchiesta?”.
CE LO ASPETTAVAMO DA TEMPO E ALLA FINE È ARRIVATO.
Scrive Salvo Vitale il 22 aprile 2016 su "Telejato". “Quello là è questione di
ore” aveva detto la signora Saguto, quando era ancora “come un dio” sull’alta
sedia di Presidente dell’Ufficio misure di prevenzione. Una battaglia Portata
avanti dalla redazione di Telejato aveva svelato un “sistema di potere” attorno
a cui ruotavano e continuano a ruotare quelli che oggi si possono considerare la
nuova classe dominante di Palermo, ovvero avvocati, magistrati, cancellieri,
curatori ed amministratori giudiziari, commercialisti, giornalisti, sindaci,
imprenditori e commercianti mafiosi che hanno fatto professione di antimafia,
affaristi, pentiti usati con il telecomando, a seconda delle cose che gli dicono
di dire. Quando è scoppiato il terremoto ed è saltato il tappo, alcuni giudici
hanno dovuto lasciare la poltrona, sono stati spostati ad altri incarichi,
alcuni amministratori giudiziari sono stati sostituiti, ma sono ancora al loro
posto, nessuno di loro si è preoccupato di fare le consegne e pertanto è stato
necessario nominare qualcuno che se ne preoccupasse. Era chiaro che, alcuni dei
responsabili di questo finimondo non potevano passarla liscia. Non sappiamo che
cosa succederà ai giudici di Caltanissetta, che stanno indagando sui loro
colleghi, probabilmente saranno “ammorbiditi” dai loro superiori, nella stessa
misura in cui Maniaci è accusato di essersi ammorbidito con due sindaci, ma
sappiamo oggi che cosa è successo a Pino Maniaci. Il suo telefono, da tempo
sotto controllo, probabilmente dopo la denuncia per stalking avanzata da
Cappellano Seminara, avrebbe fornito chissà quali elementi, in base ai quali si
poteva studiare un bel capo di accusa. Non è stata una “questione di ore”, ma,
da settembre ad adesso ci sono voluti quasi nove mesi, tanti quanti ne occorrono
per un parto. Sarebbe stato troppo sfacciato far partire l’accusa nel momento in
cui è scoppiato lo scandalo, e perciò, in base alla norma tutta nostra, secondo
cui “la vendetta è un piatto che si mangia freddo”, la procura di Palermo ha
deciso di mollare il missile adesso che le acque si sono calmate, o, come si
dice in siciliano, “a squagghiata di l’acquazzina”, quando la brina si è
sciolta. Il metodo è sempre lo stesso: chiamare un giornalista con cui la
procura è in contatto, dargli la notizia, quasi sempre anche all’insaputa
dell’indagato, fornirgli anche qualche brano sospetto di intercettazioni, da
trasmettere, non tutte insieme, ma un poco al giorno, per tenere la vicenda in
caldo, ed è fatta. [Pino era stato sentito dai magistrati della procura di
Palermo qualche mese fa e pensava di avere chiarito tutto, e invece no]. Ha
dovuto nominare due difensori, uno dei quali è Antonio Ingroia, l’altro Bartolo
Parrino. L’accusa è ridicola e non merita di essere commentata. Basta ascoltare
i telegiornali, per rendersi conto che quotidianamente i sindaci di Partinico e
di Borgetto sono “massacrati” da Pino per la loro, diciamo “presunta”,
incapacità a risolvere gli enormi problemi del loro territorio. Non parliamo poi
della triste vicenda dei cani impiccati: quella che circolava a Partinico,
allora, era la tremenda accusa che i cani fossero stati uccisi dallo stesso
Maniaci per farsi pubblicità, e un nutrito gruppo della gente di facebook si è
apprestato a condividere questa infame accusa, così come oggi mostra
soddisfazione per quello che è venuto fuori, con le loro idiote condivisioni.
Costoro non si aspettano una condanna: Pino è già stato da loro condannato e da
tempo. Fra l’altro, proprio per non farla “vastasa” si è fatta scivolare
l’ipotesi che il “canicidio” sia stata opera di qualcuno che si voleva vendicare
personalmente e non un’intimidazione mafiosa. Così si toglie, guarda un po’ dove
arriva l’intelligenza inquirente, anche, oltre che credibilità, questa
sventolata patente di giornalista antimafia che Maniaci si è guadagnata sul
campo. La notizia è arrivata dopo che Maniaci, assieme a Lirio Abbate, è stato
ritenuto uno dei giornalisti più impegnati in Italia, ma anche dopo che
“Reporter sans frontieres” ha pubblicato la graduatoria sui paesi in cui la
libertà di stampa è in pericolo: l’Italia è scivolata dal 65simo al 74esimo
posto. Fare giornalismo in Sicilia è già difficile. Le querele per diffamazione
fioccano e ormai non si contano più, ma quando si ci mette anche la magistratura
è il caso di chiedersi se non è meglio cambiar mestiere.
RETTIFICA. Si rettifica l’affermazione, nel senso
che Pino Maniaci non è stato mai sentito dalla Procura di Palermo e, sino ad
oggi, non ha ricevuto alcun avviso di garanzia. Tutto quello che è venuto fuori
è stato reso noto da un articolo su “La Repubblica”, a firma F. Viviano. In tal
senso i legali di Maniaci hanno annunciato che lunedì prossimo sarà presentata
alla Procura di Palermo una formale richiesta di accesso agli atti per sapere se
esiste un capo d’imputazione, su che cosa e su quali elementi è fondato e per
chiedere l’audizione dello stesso presunto imputato. Anche ai giudici di
Caltanissetta sarà inviata dal collegio di difesa di Maniaci, formato da Antonio
Ingroia e da Bartolo Parrino, una richiesta di accesso degli atti e alle
intercettazioni da cui si evincerebbe che, da parte di alcuni settori della
Procura di Palermo e di altre forze istituzionali ci sarebbero state manovre e
tentativi di fermare l’azione di Telejato.
Pino Maniaci aveva previsto tutto: ecco
l’intervista del 13 Novembre 2015 di Giulio Ambrosetti su "La Voce di New York".
In questa intervista, ripetiamo, siamo a Novembre dell’anno scorso, commentiamo
con lui le voci – già ricorrenti in quel periodo - di una inchiesta a suo carico
e, addirittura, di un suo arresto. Rileggiamola:
Caso Saguto con finale pirandelliano: vogliono
arrestare Pino Maniaci?
Gira voce che vogliono arrestarla…ci faccia
capire, direttore, alla fine il mafioso è lei?
Maniaci: “Che vuole che le risponda? Noi qui,
ormai, ci aspettiamo di tutto. Sì, di tutto. Abbiamo toccato interessi
incredibili. Personaggi che hanno fatto il bello e il cattivo tempo con la
gestione dei beni sequestrati alla mafia. E sequestrati anche a imprenditori che
con la mafia non c’entravano affatto. Questi signori che hanno gestito tali
beni, con molta probabilità, erano protetti anche dalla Massoneria. Certo,
alcuni di questi signori sono caduti in disgrazia. E si vogliono vendicare
contro di me. Detto questo, il sistema è ancora in piedi”.
Sembra che a Roma, addirittura in Parlamento,
alcuni deputati avrebbero chiesto notizie su di lei…
Maniaci: “La storia gliela racconto subito. La
Commissione nazionale antimafia ha convocato il procuratore della Repubblica di
Palermo, Franco Lo Voi”.
E perché l’avrebbe convocato?
Maniaci: “Per parlare dei problemi legati alla
gestione dei beni sequestrati alla mafia”.
Scusi, invece di convocare la dottoressa
Silvana Saguto, che è stata per lunghi anni protagonista della gestione, a
quanto pare non entusiasmante, di questo travagliato settore, i parlamentari
della Commissione nazionale Antimafia convocano il procuratore Lo Voi. Ma come
funziona la politica italiana?
Maniaci: “Questo non lo deve chiedere a me: lo
deve chiedere ai politici. E, segnatamente, all’ufficio di presidenza della
Commissione nazionale Antimafia”.
Si riferisce all’onorevole Rosy Bindi, quella
che difendeva la dottoressa Saguto e che, a proposito della gestione dei beni
sequestrati alla mafia, diceva: tutto a posto, tutto bene?
Maniaci: “Per l’appunto: parliamo proprio di lei,
dell’onorevole Bindi. E anche dell’onorevole Claudio Fava”.
Che ha combinato stavolta Claudio Fava?
Maniaci: “E’ stato lui, nel corso dell’audizione
del procuratore Lo Voi, a chiedere allo stesso magistrato: ‘Abbiamo sentito di
un’inchiesta a carico di Pi no Maniaci, lei procuratore che ci può dire?”.
E che gli ha detto il procuratore Lo Voi?
Maniaci: “Guardi, di questa storia, che se mi
consente è un po’ incredibile, ho notizie frammentarie. So che c’era l’Aula di
Montecitorio convocata. E che per raccontare vent’anni di antimafia, così mi
hanno riferito che avrebbe detto il procuratore Lo Voi – con riferimento anche
al mio operato – sarebbe servito almeno un quarto d’ora di pausa. A questo punto
la presidente Bindi avrebbe detto: ‘Un quarto d’ora? Anche mezz’ora, anche due
ore. Tutto il tempo che occorre”.
Però lei l’onorevole Bindi la deve capire: era
una sorta di Santa Maria Goretti del PD e voi di TeleJato l’avete sputtanata a
dovere. Per non parlare delle Iene, che se la stavano sbranando…
Maniaci: “Guardi, noi non abbiamo sputtanato
l’onorevole Bindi: ha fatto tutto lei”.
Insomma, se non abbiamo capito male vorrebbero
farla arrestare e, magari, sbaraccare TeleJato. E’ così?
Maniaci: “Non so quali siano le intenzioni. Non so
che cosa abbiano in testa di fare. Ma so che la dottoressa Saguto, l’ex Prefetto
Cannizzo, l’avvocato Cappellano Seminara e il colonnello della Guardia di
Finanza Rosolino Nasca non mi amano. Anzi. Lo sa perché tutti mi denunciano per
stolking e non per diffamazione?”.
No, ci dica.
Maniaci: “Mi denunciano per stalking per poter
fare mettere sotto controllo il mio telefono”.
E ci sono riusciti?
Maniaci: “Penso proprio di sì”.
Sanno che voi di TeleJato siete molto
informati. Magari perché, da giornalisti, parlate con tutti. Che cosa vogliono
combinare?
Maniaci: “Vedo che lei mi ha anticipato. Noi
abbiamo trattato tanti casi di mafia. E tante vicende legate alla gestione dei
beni sequestrati alla mafia. Il caso degli imprenditori Cavallotti, per esempio.
O il caso dell’Abazia di Sant’Anastasia e via continuando con tante altre
storie. Sa, equivocando si possono alzare polveroni”.
Lo sappiamo benissimo. Basti per tutti il
‘caso’ dello scioglimento del Comune di Racalmuto per mafia. Una barzelletta.
Una farsa che, però, ha consentito ai comitati di affari dell’acqua e dei
rifiuti di eliminare un sindaco scomodo. Torniamo alle stranezze. Cosa ci dice
della vicenda Cavallotti?
Maniaci: “Pagavano il ‘pizzo’. Ma sono stati
assolti. La Procura generale ha detto: restituitegli i beni”.
E glieli hanno restituiti?
Maniaci: “No.”
Sono stati assolti e non gli hanno restituito i
beni?
Maniaci: “Esattamente. E hanno fatto di più”.
Cosa?
Maniaci: “Hanno venduto alcuni beni dell’azienda
Cavallotti, che si occupava di metanizzazione, a Italgas. E poi hanno
sequestrato i beni a Italgas”.
E perché?
Maniaci: “Perché aveva rapporti con l’azienda
Cavallotti”.
Ma qui siamo oltre Pirandello. Questi
amministratori giudiziari sono ‘artisti’. Meriterebbero di andare a recitare in
un Teatro…
Maniaci: “Lei scherza. Ma lo sa quant’è costato
questo scherzetto a Italgas? Da sei a nove milioni di Euro tra amministratori
giudiziari e coadiutori”.
A proposito di affari: chi sono quelli rimasti
ancora nel giro?
Maniaci: “Cominciamo con il dottore Andrea Dara,
il commercialista e amministratore giudiziario che ha massacrato Villa Santa
Teresa di Bagheria. In questi giorni è stato ‘promosso’: ha incassato una bella
nomina ad Aci Trezza dal Prefetto Postiglione”.
E poi?
“Guardi, i casi più eclatanti restano quelli degli
avvocati Cappellano Seminara e Virga”.
Ancora loro?
Maniaci: “Vero è che hanno rinunciato agli
incarichi (in parte, almeno alcuni). Ma fino a quando non subentreranno i nuovi
amministratori giudiziari resteranno in carica. E continueranno a gestire”.
Vuole dire qualcosa al procuratore Lo Voi e sui
vent’anni di antimafia che dovrebbe illustrare a Rosy Bindi e a Claudio Fava?
Maniaci: “Prima di parlare di vent’anni di
antimafia a proposito del mio operato, il procuratore Lo Voi farebbe bene ad
occuparsi del verminaio che c’è presso la Sezione fallimentare del Tribunale di
Palermo e degli incarichi a decine di migliaia di Euro dei Ctu (Consulenti
tecnici del Tribunale). Magari arriverà prima di noi, che ce ne stiamo
cominciando ad occupare”.
La doppia vita di Pino Maniaci: dalla
lotta alla mafia alle estorsioni. Il direttore di Tele
Jato era un paladino della legalità, accusatore di magistrati per la gestione
dei beni confiscati. Ricattava i sindaci per far assumere la sua amante, scrive
Felice Cavallaro il 4 maggio 2016 su “Il Corriere della Sera”. I cani glieli
avrebbe impiccati il marito della sua amante. E per fare lavorare la stessa
signora nel Comune di Borgetto avrebbe ricattato sindaco e consiglieri. Sarebbe
questa la verità di una classica estorsione e di una storia di «femmine»
maturate fra le pieghe di un impegno antimafia che ha visto per anni nei panni
di un inflessibile paladino il direttore della piccola e combattiva emittente di
Partinico, Pino Maniaci. Lo stesso implacabile accusatore di magistrati e
amministratori finiti a Palermo sotto inchiesta per la gestione dei beni
confiscati. A cominciare dalla ex presidente della sezione misure di prevenzione
Silvana Saguto, intercettata a maggio dell’anno scorso con il prefetto: «Quando
matura la cosa di Maniaci...?». Stavolta le intercettazioni sono tutte a carico
di quest’altro simbolo dell’antimafia che cade sotto il sospetto di essersi
inventato una parte delle intimidazioni mafiose. Una parte. Non dimentichiamo lo
sfogo del boss di Partinico, Vito Vitale, soprannominato Fardazza, intercettato
qualche anno fa in carcere a Torino: «Sta televisione si sta allargando troppo».
Anche questo tassello deve aver pesato nel 2009 quando il Consiglio dell’Ordine
dei giornalisti di Sicilia iscrisse come «pubblicista» d’ufficio Maniaci,
editore e conduttore del Tg di TeleJato, nonostante i suoi precedenti penali:
furto, assegni a vuoto, truffa, omissione di atti d’ufficio. Tutto considerato
ininfluente e cancellato dal rinnovato impegno antimafia. Conteso da tutte le
scuole italiane per raccontare la sua vita, le continue presunte minacce
ricevute e la storia dei Cento passi di Peppino Impastato, modello al quale si
ispirava, Maniaci adesso non potrà nemmeno soggiornare nel suo paese accusato di
estorsione «per aver ricevuto somme di denaro e agevolazioni dai sindaci di
Partinico e Borgetto onde evitare commenti critici sull’operato delle
amministrazioni». Si tratta però di «cifre ridicole», come le ha definite lo
stesso Maniaci la scorsa settimana, intervistato in Tv dalle Iene. Di volta in
volta avrebbe «strappato» al sindaco di Borgetto e ad altri personaggi politici
locali poche centinaia di euro, «pezzi da 100 o 150 euro». Il sindaco di
Partinico Salvatore Lo Biundo e i suoi consiglieri si sarebbero addirittura
autotassati pur di pagare lo stipendio all’amante di Maniaci, dopo un corso
trimestrale non rinnovabile. E questo sempre per il timore di ricatti. Accusa
pesantissima di un’inchiesta condotta dai carabinieri di Monreale e Partinico,
sotto il diretto controllo del procuratore Francesco Lo Voi, dell’aggiunto
Vittorio Teresi e dei sostituti Francesco Del Bene, Amelia Luise, Annamaria
Picozzi e Roberto Tartaglia. Una squadra di magistrati al completo proprio per
le ovvie ripercussioni che la notizia può determinare all’interno di un pianeta
antimafia che vede ormai cadere i suoi simboli uno dopo l’altro. Dal presidente
della Camera di commercio Roberto Helg alle inchieste tutte da definire contro
il presidente di Confindustria Antonello Montante e del vice presidente
nazionale di viale dell’Astronomia Ivan lo Bello, inciampato nella storiaccia
del porto di Augusta con il compagno della dimissionaria ministra Guidi. Nel
caso di Maniaci le voci delle scorse settimane erano state clamorosamente
smentite dallo stesso direttore parlando di una «vendetta» covata fra i
magistrati dopo le accuse alla Saguto. Le intercettazioni a suo carico sarebbero
però precedenti al cosiddetto «caso Saguto» ufficialmente esploso solo nel
maggio 2015. Ma è anche vero che Maniaci le sue battaglie (fondate) sulla
gestione dei beni confiscati le cominciò un anno prima. Quando anche il prefetto
Giuseppe Caruso denunciò gli stessi imbrogli. A prima vista sembra però che
quelle denunce e le presunte estorsioni procedano su due linee parallele. Con un
solo punto di incontro: l’amante e il marito tradito, disposto a impiccare due
cani e bruciare l’auto di Maniaci. Storia dello scorso dicembre, quando su Tele
Jato rimbalzarono le solidarietà di mezzo mondo e la telefonata di Renzi della
quale parlava, ignaro di essere intercettato, il direttore-simbolo, travolto da
un delirio di onnipotenza: «Ormai tutti e dico tutti si cacano se li sputtano in
televisione... Ora tutti, tutti in fibrillazione sono, pensa che mi ha
telefonato quello stronzo di Renzi».
TELEJATO: PESANTI OMBRE SUL PASSATO DI PINO
MANIACI. Scrive Dario Milazzo il 26 aprile 2016 su l’Urlo”. Episodi inquietanti
sembrerebbero contraddistinguere il passato di Pino Maniaci: l’imprenditore
avrebbe commesso diversi reati quando era ancora imprenditore edile. Dopo
l’indagine per estorsione spuntano altri elementi che potrebbero macchiare
l’immagine di Pino Maniaci. Pino Maniaci è l’editore di Telejato, emittente
comunitaria famosa per le inchieste e per le battaglie anti-mafia. Come sappiamo
Maniaci risulta attualmente indagato a Palermo per il reato di estorsione
(Indagato il direttore di Telejato per estorsione). Da fonti autorevoli abbiamo
appreso che l’editore di Telejato avrebbe avuto in passato diversi problemi con
la giustizia. Si tratterebbe di una sfilza di condanne, tutte passate in
giudicato, che avrebbero portato il Maniaci a scontare pene detentive (non
possiamo dire se ai domiciliari o in carcere). Ma l’imprenditore di Partinico
nel periodo “pre-Ordine” avrebbe goduto anche di indulto e di amnistia. I reati
contestati sarebbero: emissione di assegni a vuoto, furto, abuso d’ufficio,
truffa e ricettazione. Ricordiamoci inoltre che Pino Maniaci era stato
processato nel 2009 per il reato di esercizio abusivo della professione. Come ci
ha confermato l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Maniaci fu processato perché,
dopo circa 10 anni di attività giornalistica, non aveva mai presentato le
pratiche per ottenere il tesserino di giornalista commettendo così, ovvero
scrivendo senza essere iscritto all’Ordine, il reato di esercizio abusivo della
professione giornalistica. Dal processo per esercizio abusivo della professione
giornalistica Pino Maniaci venne assolto per insussistenza del fatto. Tornando
ai fatti passati, pesanti sono le accuse che sono state lanciate a Pino Maniaci
dall’ingegnere Vincenzo Bonomo, ex assessore di Partinico. In base a quanto
asserito dall’ingegnere ed insegnante di Partinico, l’editore di Telejato
avrebbe gestito in passato un laboratorio d’analisi cliniche di Montelepre
sfoggiando una falsa laurea. Da sottolineare il fatto che fra Vincenzo Bonomo e
Pino Maniaci non correrebbe buon sangue: in passato l’ingegnere ha querelato per
diffamazione ben 5 volte l’editore di Partinico. I guai giudiziari che in
passato avrebbero coinvolto l’editore non hanno nulla a che vedere con la sua
attività giornalistica e con l’indagine che lo coinvolge attualmente. Ribadiamo
inoltre che Pino Maniaci ha dato tantissimo all’antimafia e alla sua Sicilia,
proprio per questo motivo ci aspettiamo da lui una presa di posizione chiara e
forte che sia una smentita o una conferma dei fatti contestati.
Indagini su Pino Maniaci: alcuni tasselli
del mosaico, scrive Salvo Vitale il 28 aprile 2016 su
"Telejato. L’ESTORSIONE È UN REATO. IL SINDACO È UN PUBBLICO UFFICIALE. SE IL
SINDACO SUBISCE UNA ESTORSIONE O È AL CORRENTE CHE UNA ESTORSIONE SIA STATA
COMPIUTA DA QUALSIASI CITTADINO, HA IL DOVERE DI DENUNCIARE L’ESTORTORE. Quindi,
se il sindaco non denuncia rischia di diventare omissivo e compie un reato,
anzi, diversi reati, a cominciare dall’omissione di atti d’ufficio. Sono passati
due anni, almeno da quello che è trapelato fuori dalla presunta indagine su Pino
Maniaci, della quale ancora non gli è stato notificato NULLA, così come nessuna
denuncia è stata fatta dai due sindaci per il presunto tentativo di estorsione.
Ergo, o il giornalista della Repubblica si è inventato tutto, o la Procura si è
inventato tutto, oppure ha cercato in tutti i modi di costruire e imbastire un
atto d’accusa farlocco, oppure ancora abbia interpretato male alcune frasi,
oppure non è vero che i sindaci abbiano subito un’estorsione, ma rimane il fatto
che se il fatto è successo, un reato, quello di non denunciare l’estortore, è
stato commesso dai due sindaci. Perché questo reato non è stato loro contestato?
Non dovrebbero essere oggi in galera o lì vicino? Forse quel reato non c’era, ma
se non c’era tutto dovrebbe sgonfiarsi come un palloncino. SI VA DELINEANDO A
POCO A POCO IL QUADRO E I VARI TASSELLI DEL PUZZLE CHE LO COMPONGONO, CON IL
QUALE SI È CERCATO DI TAGLIARE L’ERBA AI PIEDI DI PINO MANIACI, DI ZITTIRE UNA
BOCCA DIVENTATA TROPPO FASTIDIOSA E POSSIBILMENTE DI INCHIODARLO DISTRUGGENDO
L’ALONE DI PALADINO DELL’ANTIMAFIA CHE EGLI HA CERCATO DI COSTRUIRE ATTORNO A
SÉ. L’infamia ha una sua base nell’affermazione, che abbiamo letto
sulla Repubblica, secondo la quale l’efferata morte dei due cani di Pino sarebbe
motivata da questioni personali. Niente minacce mafiose, la mafia è innocente.
Anche per tanti altri delitti, da Peppino Impastato a Mauro Rostagno, a Beppe
Alfano, a Pippo Fava, all’inizio l’affermazione è stata sempre quella: la mafia
è innocente. È la posizione tipica dei mascalzoni che vogliono distruggere
l’immagine di una persona proprio in quello che lo caratterizza positivamente.
Ma andando indietro, è il 16 febbraio 2016, si tratta di un’intervista a Pino.
Emerge dalle sue dichiarazioni che non è una novità che il suo telefono è
intercettato e che si sta mettendo assieme la trappola per incastrarlo. Una
serie di persone che lo hanno contattato telefonicamente, come risulta dai
tabulati, sono chiamate dalla Procura e sono talora invitate a confermare quanto
è stato già scritto deciso a tavolino, invitate a firmare quello che dovrebbero
dire, in modo abbastanza perentorio. “Sto venendo a prendere i soldi delle
magliette. Vedi chi ti tappiu”. Che vogliamo di più, è una chiara richiesta di
pizzo. Oppure, se vogliamo andare indietro, c’è una dichiarazione di Pino sul
presidente del consiglio comunale di Borgetto: egli sostiene che è collegata a
certi ambienti mafiosi. Il presidente reagisce denunciando Maniaci. I
consiglieri comunali chiedono che la cosa sia chiarita, il sindaco denuncia
Maniaci ritenendo che sia stato offeso il Comune, così sarà il Comune a pagare
l’avvocato, e il resto, su come andrà a finire, è tutto da scrivere, ma è chiaro
che le dichiarazioni non possono essere lette a pezzettini, e che fanno parte di
un insieme. Quell’insieme che Silvana Saguto ha cercato di mettere su, con
l’assenso e il benestare degli amici giudici di Magistratura Indipendente, tutti
suoi colleghi affettuosi, Virga, Lo Voi, Petralia, ma anche con le riserve e
l’opposizione di altri giudici, al punto da arrivare a farle affermare: “Se
quelli lì si sbrigassero non ci sarebbe bisogno di ….”. Chi sono quelli lì che
ci stanno andando con i piedi di piombo? Insomma si ha l’impressione che la
nuova linea è stata lanciata, dopo che Vespa, tanto per mettere una pezza alla
minchiata dell’intervista a Salvuccio Riina, chiama in televisione Angelino
Alfano, e questo gli dice, più o meno che, visto che la mafia sta finendo, anche
l’antimafia dovrebbe finire. Cazzate dietro cazzate con l’annuncio a cui oggi
tutti i pennivendoli di regime si sono associati: l’antimafia è morta, sono
tutti corrotti, tutti sono nella stessa barca che affonda, la Saguto, Pino
Maniaci che l’ha impallinata, Saviano, che rilascia false notizie, Salvatore
Borsellino che abbraccia Massimo Ciancimino, Helg, Montante, Lo Bello, Ciancio,
ricchi e poveri, colpevoli e innocenti, boss e vittime, don Ciotti e Libera,
Addio Pizzo, tutti nello stesso mucchio, tutti uguali, tutti a mare, dopo di
che, dopo questa grande piazza pulita di discredito e di merda, Cosa Nostra, con
i suoi colletti bianchi, con le sue toghe, con i suoi avvocaticchi, con i suoi
imprenditori, con le sue aziende liberate dalla paura di finire sotto inchiesta,
davanti a una magistratura intimidita potrà tornare a imperare, senza più
bisogno di boss nascosti: basterà metterli bene in evidenza come componenti del
sistema politico che ci regge, farli diventare onorevoli, oggi si decide a
tavolino, presidenti ecc. e tutto sarà risolto. Insomma, il sogno fatto in modo
un po’ rozzo da Totò Riina e in modo più sapiente da u zzu Binnu in Sicilia e da
Licio Gelli nel resto d’Italia, diventerà realtà.
Pino Maniaci: il fango, la stampa e
l’ignoranza, scrive Massimiliano Perna il 30 aprile
2016 su “Il Megafono”. Pino Maniaci è un delinquente, un finto paladino
dell’antimafia. È anche un pregiudicato, come qualcuno, con eccitazione, sta
urlando ai quattro venti in queste ore. Pino Maniaci è pure un estortore. Non
presunto, per carità, lo è e basta. Lo avete deciso voi. Lo ha deciso la stampa,
o almeno quella parte che non vede l’ora di beccarne un altro che possa
aggiungere crepe a un movimento sempre più instabile. Lo ha deciso una parte
dello stesso movimento antimafia, soprattutto quella che non è mai stata sul
campo e ha fatto il proprio nido sulle tastiere e dietro uno schermo,
pontificando, accusando, giudicando senza appello persone e storie, vite e
vissuti. Pino, oggi, per molti colleghi e per diversi presunti antimafiosi di
questo Paese non è più quel giornalista coraggioso, onesto e ostinato che da
anni denuncia, a suo rischio, tutto quel che non va nella provincia palermitana
e in Sicilia. Uno della cui amicizia si può andare fieri. Pino adesso,
d’improvviso, è diventato un uomo da osservare con sospetto. La campagna
denigratoria nei suoi confronti è di una violenza inaudita e non sono violenti
soltanto gli attacchi velenosi dei detrattori o il ghigno dei nemici nascosti,
ma anche i silenzi di chi dovrebbe sostenerlo e che invece preferisce non dir
nulla, non esporsi. Tutti ad accettare giudizi vergognosi, senza battere ciglio.
Sintomo non di cautela, ma di profonda ignoranza, che è uno dei problemi più
grandi anche del movimento antimafia. Un movimento troppo affollato, dove entra
chiunque e dove chiunque, solo in virtù della partecipazione a qualche evento o
presidio o della lettura di qualche libro o articolo, si sente in diritto di
esprimere qualsiasi giudizio nei confronti di chi la mafia la sfida ogni giorno
o l’ha sfidata per anni. Sul campo. Il tutto in un Paese (e in un contesto
giornalistico) che vive di antipatie, invidie, fazioni, manie, fanatismi e che
perde spesso di vista la realtà. Così, in molti hanno partecipato, più o meno
direttamente e senza condizionali, alla gara di lancio del fango su Pino Maniaci
e Telejato. E lo hanno fatto nonostante non avessero a disposizione nient’altro
che un articolo nel quale si parla di una grottesca estorsione (soldi e posti di
lavoro chiesti ai sindaci di Borgetto e Partinico in cambio di una linea morbida
di Telejato nei loro confronti) e si annunciano intercettazioni sensazionali.
Stop. Non si fa riferimento ad altro, non si racconta la storia più recente di
Pino e della sua tv, non è chiaro quale sia il contesto di queste
intercettazioni, quale sia il loro contenuto, non sappiamo nemmeno se esistano
davvero. C’è solo un articolo con una notizia frammentata e ciò basta a
scatenare l’inferno. Poco importa che a Pino non sia arrivata alcuna notizia di
indagine, non sia giunto alcun avviso di garanzia. Di sicuro, però, qualora
questa indagine fosse reale, qualcuno andrebbe punito per violazione del segreto
di ufficio e dovrebbe spiegare come mai la stampa abbia saputo prima del diretto
interessato. Ovviamente, la maggior parte finge di ignorare che Pino, in questi
ultimi due anni, ha smascherato il malaffare nella gestione dei beni confiscati
alla mafia, mettendo nei guai giudici molto potenti, come Silvana Saguto, e
avvocati altrettanto potenti. Sappiamo benissimo come vanno queste cose e come,
quando tocchi certi ambiti, la reazione (peraltro attesa) possa in qualche modo
arrivare colpendoti sempre nel tuo punto più caro. Accusano Pino, infatti,
proprio delle cose contro le quali si è sempre battuto. Provano a gettare
un’ombra su di lui e sul suo impegno e lo fanno comunicando alla stampa una
notizia che aizza i suoi detrattori. Qualcuno poi decide di andare oltre e
finisce per affondare le mani nel passato di Pino, tirando fuori storie note
come se fossero sensazionali e inedite. “Pino Maniaci ha avuto problemi con la
giustizia”, scrive un giornale online a cui non diamo nemmeno l’onore del nome
per non fargli pubblicità (visto che lo leggono in quattro), elencando tutta una
serie di presunti reati, oltre a raccogliere l’accusa non dimostrata di un
nemico dichiarato di Telejato, un ex assessore del Comune di Partinico. A tal
proposito, sempre l’ignoranza e la disinformazione fanno sì che la gente non
presti attenzione al fatto che i comuni di Borgetto e Partinico siano attaccati
quotidianamente e duramente dall’emittente Telejato. Addirittura la presidenza
del consiglio comunale di Borgetto aveva querelato la tv di Pino Maniaci per
diffamazione e lo stesso sindaco si era costituito parte civile contro
l’emittente. Non vi pare allora quantomeno contraddittoria la storia della
“linea morbida” verso i due sindaci in cambio di soldi e favori? Ma torniamo
indietro al passato “burrascoso” di Maniaci. Dove starebbe la notizia? Lo stesso
Pino (nel libro Dove Eravamo – Vent’anni dopo Capaci e via D’Amelio, Caracò
editore, 2012) aveva scritto e raccontato del suo passato e dei problemi
vissuti, della galera per un caso di omonimia, della sua richiesta di
risarcimento per ingiusta detenzione e infine del suo momento di svolta, legato
a quanto accaduto a Capaci e in via D’Amelio. Riportiamo qui alcuni passaggi che
qualche giornalista sprovveduto farebbe bene a leggere: “…I miei delatori lo
sanno bene ed ogni volta che qualcuno mi vuol attaccare, non avendo altro,
subdolamente non fa che ricordare che Pino Maniaci non è altro che un
pregiudicato della peggior specie e non un giornalista accreditato. Già perché
io non ho fatto sempre questo mestiere. Proveniente da una famiglia non proprio
agiata ma neanche mala cumminata, sin da ragazzo mi sono sempre sbracciato. […]
Ho fatto mille lavori sino a diventare anche un piccolo imprenditore edile, ed è
qui che cominciano i miei guai. Siamo negli anni ’80, lavorare nel settore edile
e nel mio territorio non è cosa facile. I soldi non bastano mai ed è così che
l’impresa che costituisco cammina sempre sul filo del rasoio. Si vive di pagherò
e di assegni postdatati e ai fornitori sta pure bene”. Pino racconta di essere
stato arrestato in una operazione antimafia, ma per errore, perché omonimo di un
affiliato (che poi si scopre essere un suo lontano parente). Sarà Giovanni
Falcone ad accorgersi dell’errore e a liberarlo. Ma mentre è in galera, fuori
per l’attività di Pino le cose peggiorano: “Con me lontano, i lavori non vanno
avanti, i creditori spariscono mentre rimangono i debiti e i fornitori che
incassano gli assegni, ovviamente scoperti. Le cose si mettono male ed oltre a
una denuncia per mafia, cominciano i miei guai per gli assegni non pagati”.
Eccolo il passato “ombroso” di Pino, quello dal quale derivano la sua forza e,
soprattutto, la sua scelta, dovuta alla rabbia provata per le stragi del ‘92, di
ritirare la richiesta risarcitoria per ingiusta detenzione e di impegnarsi
attivamente nella lotta alla mafia. Un impegno che da quel momento non si è mai
fermato, che ha portato alla bellissima realtà di Telejato, palestra ed esempio
per tanti giovani e per tanti giornalisti liberi. Un uomo onesto, sia nel
raccontare il suo passato che nel vivere il suo presente, con coraggio e senza
fare sconti a nessuno. Anche se questo atteggiamento poi, come vediamo, qualcuno
glielo fa pagare. Noi, che persone come Pino le abbiamo avute accanto, le
abbiamo conosciute da vicino, sul loro campo di battaglia, ci schieriamo dalla
sua parte e dalla parte di chi resiste e rifiuta di farsi mettere cappelli
politici o di movimento. Siamo in attesa di vedere come evolverà questa vicenda,
convinti che sia solo un tentativo, anche piuttosto banale e goffo, di
screditare chi ha osato troppo. Più avanti, quando tutto sarà chiarito, avremo
poi tutto il tempo per ricordarci di chi oggi, senza nulla in mano, dalle
tastiere e dalle pagine di certi giornali, ha già emesso illegittime sentenze e
sputato calunnie.
La calunnia è un venticello. Pino Maniaci
e le indagini presunte, scrive il 30 aprile
2016 Martina Annibaldi su "Stampa Critica”. Da circa vent’anni è il volto di
Telejato. Unico tra gli italiani, insieme a Lirio Abbate, a finire nella lista
dei 100 eroi mondiali dell’informazione stilata da Reporter Sans Frontier. Pino
Maniaci è per tanti di noi il simbolo vivente di una lotta alla mafia che è
fatta di impegno quotidiano e di coraggio. Quel coraggio di raccontare le
distorsioni e i veleni di una terra, la propria. Anni di battaglie, di
intimidazioni, di violenza, di querele a catinelle (più di duecento, ad oggi!)
nel tentativo ancora mai riuscito di tappare la bocca a lui e alla sua
redazione. Pino è sempre andato avanti ma, si sa, prima o poi dove non arriva la
crudeltà o la minaccia arriva quel leggero venticello dell’infamia a colpire chi
avrebbe dovuto tacere e non lo ha fatto. “Meno attacchi in cambio di soldi:
indagato a Palermo paladino della tv antimafia”, è il titolo dell’articolo
pubblicato da Repubblica venerdì 22 Aprile che apre il caso Maniaci. Secondo la
ricostruzione fornita dal giornalista, Pino Maniaci sarebbe indagato dalla
Procura di Palermo per estorsione ai danni del sindaco di Partinico, Salvo Lo
Biundo, e del sindaco di Borgetto, Gioacchino De Luca. In cambio di soldi, il
volto di Telejato, avrebbe promesso ai due primi cittadini un ammorbidimento dei
servizi che li riguardavano e richiesto posti di lavoro per i propri familiari.
Le indagini sarebbero state aperte dopo una serie di intercettazioni da parte
dei Carabinieri e, alla luce di quanto emerso, avrebbe persino spinto gli
inquirenti a ripensare la matrice delle intimidazioni violente subite dal
giornalista siciliano nel 2014, quando i suoi due cani vennero prima avvelenati
e poi impiccati dalla mafia. Per un istante, un solo istante di spaesamento, a
molti di noi si è gelato il sangue. Ma si è trattato di un istante e nulla più.
Perché in fin dei conti hanno ragione a Telejato quando dicono che se lo
aspettavano. Perché la mafia ha smesso di essere solo quella dei Messina Denaro
e dei Riina. La mafia ha smesso di fare patti con lo Stato. La mafia si è fatta
Stato attraverso la corruzione e l’insediamento nei poteri forti. E quei poteri
forti non vogliono essere toccati, perché se li tocchi ti fanno male, molto male
ma senza colpo ferire. Pino Maniaci a quei poteri forti ha dato fastidio, e
tanto. Lui e la sua redazione da anni si battono per portare alla luce non solo
i traffici della mafia “ufficiale” ma anche i movimenti occulti di
quell’antimafia intrisa di cultura mafiosa che solo di recente è finalmente
venuta alla luce, permettendo di mandare a casa la ormai ex Presidente delle
misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, Silvana Saguto, finita sotto
inchiesta insieme a tre magistrati e ad una serie di amministratori giudiziari
per aver messo su un sistema fatto di favori, di clientelismo e di enormi quanto
loschi guadagni sui beni confiscati alla mafia. È la stessa Saguto che,
intercettata al telefono con l’ex prefetto di Palermo, Francesca Cannizzo
(indagata a sua volta per concussione) riferendosi a Telejato parla di “ore
contate”. “Mi sembra che la storia sia chiarissima: l’avvocato Cappellano
Seminara mi ha denunciato per stalking solo per fare in modo che io venissi
intercettato: ma basta andare a vedere i servizi del mio telegiornale per capire
che i sindaci in questione vengono attaccati almeno una volta al giorno. Senza
contare che il presidente del consiglio comunale di Borgetto mi ha persino
querelato di recente”, dichiara Maniaci, assistito dagli avvocati Antonio
Ingroia e Bartolomeo Parrino. Finora nessun avviso di garanzia a carico del
giornalista siciliano (peraltro, come già sottolineato dallo stesso Ingroia,
grave violazione del segreto d’ufficio, qualora l’inchiesta esistesse realmente)
solo indiscrezioni di stampa che continuano a montare nel silenzio assoluto
della Procura di Palermo. Maniaci si dichiara pronto a chiarire ogni dettaglio,
qualora questa inchiesta passasse dell’essere presunta all’essere reale. Certo è
che, in un Paese in cui gli avvisi di garanzia, i rinvii a giudizio e persino le
condanne a carico dei politici e dei potenti passano sempre in secondo piano o
si gonfiano in polemiche mordi e fuggi, fa sorridere (o forse fa piangere) il
polverone sorretto da presunti e da condizionali. Quello che sta montando nei
confronti di Pino Maniaci ha il sapore esatto delle macchinazioni a cui la
mafia, nel senso più ampio ed onnicomprensivo del termine, ci ha abituati da
sempre. Infangare, affossare, calunniare. Delegittimare, insinuare il dubbio su
tutto, persino sulla violenza subita. Come quei tanti giornalisti morti di mafia
su cui ancora aleggia il sospetto del delitto passionale. A Maniaci i cani li
hanno ammazzati per motivi personali, questa sarebbe la nuova versione dei
fatti. E forse tanto basterebbe per far riflettere. E poi quella denuncia per
stalking, perché per stalking? Cappellano Seminara avrebbe, forse, potuto
tentare la denuncia per diffamazione ma sceglie lo stalking. Perché, si sa, non
serve che il reato sia realmente accaduto, basta qualche stralcio di
intercettazione qua e là, o forse neanche quello, per gettare un’ombra
indelebile su alcuni personaggi. Lo scandalo è montato, e forse cadrà nell’ombra
una volta raggiunto il suo apice, cadrà nell’ombra prima che arrivi la versione
ufficiale, prima che la Procura faccia chiarezza su questa indagine fantasma.
Pino Maniaci resta in attesa che questo silenzio venga dissipato. Altrettanto
sarebbe opportuno che facesse l’intera comunità, perché non si giudichi, ancora
una volta, sospinti solo da quel famoso venticello dell’infamia.
"Caso Saguto, che fine ha fatto?".
L'e-mail e la ferita aperta, scrive Riccardo Lo Verso il 28 aprile 2016 su "Live
Sicilia". Va bene il convegno. Va bene il confronto “meritorio” sul tema della
disabilità, ma l'indagine sulla Saguto che fine ha fatto? A rivolgere la domanda
al procuratore aggiunto di Caltanissetta, Lia Sava, è un magistrato di Palermo.
“Cara Lia...”, comincia così la lettera che Maria Patrizia Spina, presidente
della quinta sezione della Corte d'appello, ha girato a una mailing list di
colleghi. Una sezione, la sua, particolarmente attenta all'argomento visto che
tratta, nel secondo grado di giudizio, le decisioni che un tempo venivano prese
dal collegio presieduto da Silvana Saguto, oggi sospesa dal Csm. Un collegio
azzerato dall'inchiesta dei pm di Caltanissetta, coordinati proprio dalla Sava
che, oltre a fare l'aggiunto, oggi è anche il capo pro tempore dei pm nisseni in
attesa della nomina del nuovo procuratore. La Sava è promotrice di un convegno
in programma fra qualche giorno a Palermo. Ecco perché è a lei che la Spina
chiede se sia “opportuno” organizzare un convegno a Palermo “mentre si attendono
gli esiti sul caso Saguto”. Caso che, in un passaggio della lettera, viene
definito “sistema” e per il quale tutti “ci aspettavamo gli esiti
dell'indagine”. La Spina mette per iscritto un'esigenza diffusa tra i magistrati
palermitani. Quando scoppiò lo scandalo si disse che in gioco c'era la
credibilità dell'intero distretto giudiziario palermitano. Non restava che
aspettare che venisse fatta chiarezza nel più breve tempo possibile. Il punto è
che bisogna fare i conti con i tempi delle indagini e con quelli che servono ai
giudici per tirare le somme. Il fattaccio beni confiscati venne a galla nel
settembre 2015, quando i finanzieri del Nucleo di polizia tributaria fecero
irruzione nella stanza della Saguto, al piano terra del nuovo Palazzo di
giustizia. Si scoprì che c'erano le cimici nel suo ufficio. L'indagine era
partita qualche mese prima, quando i pm di Palermo si accorsero che c'erano
finiti dentro alcuni magistrati e trasferirono il fascicolo a Caltanissetta per
competenza. La conferma dei tempi dell'inchiesta si è avuta fra dicembre e
gennaio quando gli indagati - dalla Saguto all'avvocato Gaetano Cappellano
Seminara, dal giudice Tommaso Virga al figlio Walter, all'ex prefetto Francesca
Cannizzo - ricevettero l'avviso di proroga delle indagini. I termini scadono fra
giugno e luglio prossimi, ma se i pm non avranno finito di analizzare le
informative dei finanzieri in teoria avrebbero l'opportunità di chiedere una
nuova e ultima proroga di ulteriori sei mesi. E torniamo al tema sollevato dal
giudice Spina nella sua e-mail. I magistrati, ma non solo loro, aspettano “gli
esiti delle indagini”. Aspettano di conoscere il contenuto completo di quel
quadro che, a giudicare da quanto finora emerso, sarebbe connotato da favori,
soldi e forse anche mazzette. Tra i reati ipotizzati, infatti, c'è pure la
corruzione. Il punto è che i bene informati continuano a ripetere che quanto
finora trapelato è poca roba rispetto al materiale raccolto. Si vedrà. Intanto
l'attesa pesa. Innanzitutto ai magistrati stessi. L'e-mail del giudice sta
facendo parecchio discutere nelle stanze del Palazzo. Non sappiamo se altri
colleghi abbiano contributo al dibattito on line, oppure se abbiano scelto la
strada del silenzio. Il silenzio che ha caratterizzato la polemica sollevata,
sempre via e-mail, dal pm Antonino Di Matteo sulla presenza del professore
Giovanni Fiandaca a un evento formativo della Scuola superiore della
magistratura. Invitare il "nemico" del processo sulla Trattativa Stato-mafia a
"fare lezione" ai magistrati palermitani: è opportuno?, si è chiesto di Di
Matteo. Fiandaca ha risposto a muso duro: "Da lui censura fascista". Nessuna
risposta dai colleghi a cui il pm ha girato il messaggio di posta elettronica.
Il mare magnum del caso Saguto.
Obiettivo: "Blindare" le prove, scrive Riccardo Lo
Verso il 29 aprile 206 su "Live Sicilia”. Un numero maggiore di indagati di
quanti finora emersi, decine di amministrazioni giudiziarie setacciate,
tonnellate di carte da spulciare, un elenco sterminato di favori, o presunti
tali, e assunzioni. Ed ancora: nomine, consulenze e soprattutto passaggi di
denaro. Benvenuti nel mare magnum dell'inchiesta sui beni confiscati alla mafia.
“Che fine ha fatto il caso Saguto?”, si chiede, come ha raccontato Livesicilia,
un giudice della Corte d'appello di Palermo. Risposta complicata perché
complesse sono le indagini che la Procura della Repubblica di Caltanissetta ha
delegato ai finanzieri della Polizia tributaria di Palermo. Considerata la mole
di lavoro, a dire il vero, gli undici mesi finora trascorsi sembrano persino
pochi per potere già tirare le somme. Eppure almeno una parte delle indagini
sembra destinata ad arrivare alla conclusione prima dei caldi mesi estivi,
quando scadrà la proroga di sei mesi iniziata fra dicembre e gennaio scorsi. Di
proroga i pm nisseni, coordinati dall'aggiunto Lia Sava, potrebbero sfruttarne
un'altra, sempre di 180 giorni. Il punto è che si è partiti da un caso singolo -
la gestione della concessionaria Nuova Sport Car sequestrata ai Rappa e affidata
dal giudice Silvana Saguto al giovane avvocato Walter Virga, figlio di un altro
giudice, Tommaso - e si è scoperto un fenomeno. Un sistema, come viene definito,
dove la gestione della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo
sarebbe stata piegata ad interessi personali fino a ipotizzare reati
pesantissimi come la corruzione e l'autoriciclaggio. Il caso è esploso nella sua
drammatica evidenza una mattina di settembre con i finanzieri che piombano nella
stanza della Saguto e nella cancelleria del Tribunale. Tutti, gli indagati per
primi, a quel punto sanno di essere finiti sotto inchiesta, anche se dalle
intercettazioni sembrava che lo avessero già intuito da un po'. Nell'ufficio
dell'ex presidente, infatti, c'erano le cimici. Perché svelarne l'esistenza e
spegnere la microspia nella stanza dei bottini? Perché, evidentemente, era
giunto il momento di scoprire le carte forse per stoppare qualcosa, oppure
perché gli investigatori avevano ascoltato già ciò che serviva. Che deve essere
molto di più di quanto finora trapelato. Le intercettazioni finora conosciute ci
hanno svelato un sistema di nomine clientelari, favori, piccoli e grandi -
cassette di frutta e laurea del figlio della Saguto inclusa -, ma non è
tutto. Da approfondire, secondo i pm, è il corposo capitolo del presunto patto
corruttivo fra Saguto e l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara che avrebbe
ottenuto la gestione di grossi patrimoni in cambio di consulenze per il marito
del'ex presidente, l'ingegnere Lorenzo Caramma, pure lui sotto inchiesta.
Settecentocinquantamila euro: a tanto ammontano i compensi liquidati a Caramma
dal 2005 al 2014, in un arco temporale che è iniziato quando la Saguto era
membro del collegio delle Misure di prevenzione ed è proseguito quando dello
stesso collegio il magistrato è divenuto presidente nel 2010. C'è un dato certo
perché scolpito nei nastri delle intercettazioni. La famiglia della Saguto aveva
un tenore di vita altissimo, che ad un certo punto divenne insostenibile. Il
magistrato diceva a Elio, uno dei suoi tre figli: "Dobbiamo parlare, perché la
situazione nostra economica è arrivata al limite totale, non è possibile più...
voi non potete farmi spendere 12,13,14 mila euro al mese noi non li abbiamo
questi introiti perché siamo indebitati persi". In realtà, dall'analisi della
carta di credito del magistrato, si è scoperto che di soldi ne arrivavano a
spendere in un mese fino a 18 mila euro. Per rimediare, secondo la Procura
nissena, l'ex presidente avrebbe ottenuto soldi in contanti da Cappellano
Seminara. E qui si innesta un altro passaggio delicato. L'ipotesi, smentita dai
presunti protagonisti, è che una sera di giugno l'amministratore giudiziario
possa avere portato ventimila euro in un trolley a casa Saguto. Nelle
intercettazioni si parlava di “documenti”. Altra domanda: perché non bloccare
Cappellano con la prova regina? Possibile risposta: perché a fini investigativi
la prova, o presunta tale, poteva essere meglio cristallizzata seguendo i
successivi passaggi del denaro. "Non è emersa alcuna traccia di scambi di denaro
tra la mia assistita e gli amministratori giudiziari, e gli accertamenti bancari
lo confermano - disse l'avvocato della Saguto, Giulia Bongiorno - le accuse sono
palesemente sbagliate". In altre conversazioni fra l'ex presidente e il padre si
parla di mazzettine di denaro. Non sarebbero solo i soldi in contanti, però, che
i finanzieri hanno cercato per riscontrare le parole intercettate. Parole da cui
emergerebbe la convinzione di potere godere dell'impunità. Una sicurezza che
avrebbe spinto i protagonisti a commettere degli errori e a lasciarne traccia?
Lo scopriremo e forse non si dovrà neppure attendere molto tempo ancora. Il
lavoro degli inquirenti impegnati a "blindare" ciò che sarebbe già stato
acquisito sembra muoversi su più livelli. C'è quello più alto dove compaiono i
nomi della Saguto, di Cappellano, dei Virga e di qualche altro rappresentante
delle istituzioni come l'ex prefetto di Palermo, Francesca Cannizzo. La sola
Saguto è stata sospesa, tutti gli altri trasferiti. E poi, a cascata, ci sono i
livelli più bassi che arriverebbero fino ai “raccomandati” per un post di lavoro
o per una consulenza. L'inchiesta potrebbe procedere per step.
Amministrazioni giudiziarie e curatele
fallimentari: “U mancia mancia”, scrive il 19 aprile
2016 Salvo Vitale su Telejato. Sono state dissequestrate alcune aziende che
erano finite sotto le grinfie della dott.ssa Saguto senza sufficienti
motivazioni, ma solo perché alcuni protagonisti del cerchio magico, in
particolare i cosiddetti “quotini”, avevano pensato di sistemarsi a vita
spolpandone le risorse. Il caso del capo dei “quotini”, Cappellano Seminara è
uno dei più sconvolgenti e ancora oggi aspetta di essere esplorato in tutte le
sue “malefatte”. Man mano che i nuovi amministratori giudiziari, nominati per
effettuare le consegne scavano per cercare di capire dove sono finiti i soldi,
si configurano casi di falso in bilancio, casi di fornitori non pagati che
reclamano i loro soldi, addirittura di vasche da bagno strappate dal loro posto
e messe in vendita di nascosto o portate in altra struttura. Milioni di debiti
che sicuramente non saranno pagati da chi ha combinato questi dissesti, ma che,
come al solito graveranno sulle spalle dei proprietari cui è stato riconsegnato
il bene sotto sequestro. Sono stati cambiati alcuni amministratori giudiziari,
ma in qualche caso, come per i beni dei Virga, dove Rizzo è stato sostituito con
Privitera, tutto è rimasto come prima, anzi peggio di prima, perché Privitera
viene da Catania una volta la settimana, riceve solo chi decide lui e non vuole
prendere alcuna decisione se non con l’autorizzazione di Montalbano. Addirittura
a una ragazza ha fatto firmare una ricevuta di un acconto datole per il suo
lavoro di cento euro, cioè l’elemosina e a qualche altra lavoratrice che
reclamava un minimo di acconto e che aveva ritirato dalla scuola la figlia,
perché non poteva darle nemmeno i soldi per il panino, ha detto che ci vuole
sempre l’autorizzazione di Montalbano per avere un sussidio. Insomma, storie di
ordinaria miseria all’ombra dell’antimafia. Ma se in questo settore si aprono
spiragli, altre porte sembrano chiudersi: si presentano in redazione lavoratori
disponibili e pronti a prendere in mano aziende sotto sequestro e destinate al
fallimento, ma Montalbano li indirizza agli amministratori giudiziari, i quali
dicono che “ci pensano loro” e che non hanno bisogno di aiuto. Spiragli di
lavoro che potrebbero funzionare, ma ai quali viene chiusa ogni possibilità
prima di cominciare. Ben più serrata e impenetrabile è la situazione degli
uffici che si occupano di fallimenti e di curatele giudiziarie. Qua diversi
avvocati, nominati, non si sa se frettolosamente o in modo complice dal
tribunale, sono stati capaci di costruire le proprie ricchezze acquistando o
facendo acquistare da prestanomi i beni messi in vendita, anzi svenduti in un
particolare momento in cui all’asta si presentava solo chi era stato deciso che
doveva acquistare. Beni immobili di milioni di euro venivano e vengono
aggiudicati per pochi spiccioli e, se in qualche occasione il proprietario ha
deciso di ricomprare ciò che era suo, allora il prezzo sale. Una vera e propria
casta della piccola e media borghesia palermitana si è proposta e agisce come
classe dominante, non facendosi scrupoli anche di amministrare e gestire le
risorse di Cosa Nostra. L’arresto di alcuni professionisti fatto anche
recentemente, è un semplice indizio di quanto serpeggia in modo sotterraneo.
Quella che il grande Mario Mineo e poi Umberto Santino e altri chiamano
“borghesia mafiosa”, è in grado persino di spremere soldi a Cosa Nostra, dal
momento che i mafiosi fanno collette tra i loro amici per pagare gli avvocati
dei loro parenti in carcere. Ma le nostre sono solo parole e considerazioni
tratte da quanto sono venute dichiararci le persone danneggiate da queste
trappole. Sicuramente sotto c’è ben altro che forse non sapremo mai, c’è
un verminaio altrettanto grave di quello dei sequestri giudiziari e di cui
qualche spiraglio speriamo che si apra con il nuovo presidente della sezione
Fabio Marino.
Il Paladino, la mafia, le corna,
scrive Vincenzo Marannano il 4 maggio 2016 su “Di Palermo”. L'indagine su Pino
Maniaci, la mafia spacciata per una trita storia di amanti e di vendette e
quella verità, se di verità si tratta, che arriva sempre tardi. Troppo tardi. La
prima vittima eccellente, in questa ennesima storia nebulosa, è sicuramente la
verità. Azzoppata intanto da mesi di indiscrezioni, colpita duramente da chi ha
accreditato – con premi, patenti di legalità e attestati di stima – qualcuno che
a quanto pare non era poi così accreditabile, e trafitta infine da indagini
troppo lunghe. Perché – se confermata la ricostruzione degli investigatori – due
anni per dirci che a bruciare un’auto non era stata la mafia ma un marito geloso
forse sono un po’ troppi. E perché consentire per mesi a carovane di
associazioni e rappresentanti delle istituzioni di sfilare quasi in
pellegrinaggio verso la sede di una televisione che (sempre se le prove
supereranno l’esame del processo) invece estorceva denaro in cambio di una linea
più morbida, fa male anche e soprattutto alle credibilità delle istituzioni e
alla parte sana del movimento antimafia. La verità in Italia purtroppo viaggia
spesso a due velocità. Il tribunale dell’opinione pubblica, basato solitamente
su semplici indiscrezioni, è molto più rapido di quello della giustizia. E un
cittadino tante volte finisce per essere condannato anni prima di vedere
conclusa, in un modo o nell’altro, la sua vicenda processuale. I tempi della
giustizia sono lunghi. Le prove o gli indizi impiegano ancora troppo per
diventare informative degli investigatori prima, richieste della Procura dopo e,
infine, ordinanze dei gip. Così ci ritroviamo con reati compiuti a partire dal
2012 che, se va bene, approderanno in un’aula di tribunale dopo cinque anni. Con
tutti i limiti e i problemi che questo comporta. Sia per chi i reati li
commette, ma anche per chi deve discolparsi di qualcosa che non ha mai fatto.
C’è poi un altro aspetto che non va sottovalutato. Nell’era di internet e dei
social network – e dei pulpiti offerti a chiunque grazie a strumenti come
Twitter o Facebook – qualsiasi notizia lascia ormai una traccia quasi
indelebile, nel bene e nel male. Se un’inchiesta impiega cinque o vent’anni per
arrivare a sentenza, fino a quel momento l’unica verità, parziale, sarà quella
emersa dalle indagini o dalle indiscrezioni. A questo aggiungiamo che ogni
giorno plotoni di internauti si svegliano, leggono il tema del momento e si
improvvisano arbitri, giudici, allenatori, investigatori, opinionisti. E che,
purtroppo, le chiacchiere da bar non si disperdono più tra un bicchiere e
l’altro ma restano impresse e spesso diventano verità a uso e consumo di chi non
è in grado di selezionare e capire cosa è informazione e cosa, invece, è solo
opinione. O “curtiglio”. Questa leggerezza porta a condannare semplici indagati
o ad esaltare modelli impresentabili. E in questa continua improvvisazione si
finisce col rovinare carriere o (chissà cosa è peggio) col costruire o inventare
di sana pianta eroi, paladini o semplici “bolle” che quando si sgonfiano o
esplodono danneggiano tutto l’ambiente in cui hanno proliferato. La storia di
Pino Maniaci non fa differenza. Autoproclamatosi paladino dell’antimafia, in
questi anni è stato celebrato da un capo all’altro del Paese (e perfino
all’estero) grazie anche alla ribalta concessa da televisioni nazionali abituate
a fare informazione semplicemente mettendo un microfono davanti alla faccia
dell’intervistato. Senza scavare o chiedere conferme. Perché a molti è bastato
sentire dalla sua viva voce che la mafia aveva bruciato la sua auto per
costruire una verità che invece spettava a qualcun altro accertare. Perché in un
momento storico in cui comandano l’audience e i like su Facebook, è sicuramente
più popolare una storia di ribellione a Cosa nostra che la solita trita e
ritrita questione di corna. Perché c’è sempre qualcuno, prima degli
investigatori, pronto a dire che è stata la mafia a bruciare quella macchina o a
piazzare quella finta bomba. Perché – spesso anche nella categoria dei
giornalisti – bisogna arrivare sempre primi (per vincere cosa?), dare una
notizia in più anche se non verificata o (peggio) sostituirsi agli investigatori
nelle analisi o ai giudici nelle sentenze. A scapito di una verità che, come un
frutto rarissimo, purtroppo ha ancora tempi troppo lunghi per maturare.
Per l'avv. Antonio Ingroia “il corpo del reato è
un video che è stato montato dai Carabinieri (c’è la firma, perché c’è lo stemma
dei Carabinieri), ed è stato distribuito inserendo intercettazioni e atti
giudiziari che noi ancora non conosciamo se non attraverso quel video, perché
non fanno parte degli atti trasmessi al giudice e comunque non fanno parte
dell’ordinanza cautelare, trattandosi di fatti penalmente irrilevanti, ma
servivano soltanto a distruggere l’immagine di Pino Maniaci. Perché dentro
queste indagini ci sono rancori e vendette di amministratori locali, che hanno
avuto la grande occasione di liberarsi della voce libera di Telejato e di Pino
Maniaci. Ma c’è stata anche un’operazione che era attesa… L’operazione era
attesa, com’è noto dalle intercettazioni della Procura di Caltanissetta, sui
magistrati e gli amministratori giudiziari indagati per gravissimi reati, per i
quali, invece, al contrario di Pino Maniaci, sono a piede libero. La verità vera
è che si voleva macchiare Pino Maniaci, e si è macchiato, per due o tre piccole
presunte piccole estorsioni (parliamo di centinaia di euro) a fronte di
magistrati, avvocati, professionisti e amministratori giudiziari che sono
imputati per centinaia di milioni di euro, che sono stati sottratti allo Stato,
e sono oggi a piede libero, e altro non aspettavano in questi mesi, che
approdasse a destinazione questa indagine. E’ grave e inquietante e noi faremo
denuncia di questo, per il fatto che questi, magistrati, prefetti e avvocati
sapessero che c’era questa inchiesta che bolliva in pentola e gradivano che
arrivasse in porto. Per questo presenteremo denuncia”.
Ingroia diventa garantista per incassare
una parcella. L'ex pm è l'avvocato del direttore di
"Telejato" Maniaci, icona antimafia accusata di estorsione. Ora scopre che la
sua vecchia Procura fa "indagini mediatiche". E denuncia pure i carabinieri,
scrive Paolo Bracalini, Sabato 07/05/2016, su "Il Giornale". Da pm d'assalto a
paladino degli imputati, la rivoluzione (personale, più che civile) di Antonio
Ingroia è compiuta. Si fatica a riconoscere nell'ex pasdaran della Procura di
Palermo pronto a mettere sotto accusa anche il Quirinale, l'autore di
esternazioni tipo «questo provvedimento (della sua ex Procura, ndr) è
sproporzionato», «c'è un accanimento accusatorio», «Pino Maniaci è stato
crocifisso mediaticamente», «è grave e inquietante che i magistrati sapessero
prima dell'inchiesta», «siamo di fronte a gossip, ad un processo mediatico alla
vita privata», e poi indignarsi perché i pm avrebbero fatto «il copia incolla
delle informative dei carabinieri», infilando nell'ordinanza anche «chiacchiere
senza alcuna rilevanza penale», utili solo a «sporcare l'immagine» delle
persone. Dopo la carriera da pm finita con un duello (perso) col Csm e l'addio
alla toga, e poi la brevissima carriera da leader politico finita con il
disastro elettorale, l'incarico ricevuto da Crocetta in una partecipata
regionale siciliana andato a schifìo pure quello, Ingroia è tornato in pista
come avvocato. Ma nemmeno in questo campo mancano incidenti e scivoloni per 'U
comunista immuruteddu (il gobbetto comunista), soprannome affettuoso che gli
diede Borsellino ai tempi in cui Ingroia era il suo vice a Marsala. Tra i suoi
primi assistiti, dopo aver detto che «per coerenza con la mia storia non
difenderò né mafiosi né corrotti», l'ex pm si è scelto Augusto La Torre, già
boss della camorra di Mondragone (spiegando che «si può condurre una battaglia
antimafia anche difendendo un pentito»). E adesso è proprio lui, l'avvocato
Ingroia, a difendere il direttore di Telejato, Pino Maniaci, già simbolo
dell'informazione antimafia, accusato dai giudici di Palermo di aver usato la
sua posizione per estorcere denaro a politici. Ingroia ha un debole per i
paladini dell'antimafia, ma non sempre ci prende, anzi. Nei lunghi mesi del
processo sulla presunta «trattativa Stato-mafia», sua ultima ossessione
giudiziaria, Ingroia è arrivato a riconoscere «quasi un'icona dell'Antimafia» in
Ciancimino jr, rivelatosi poi un testimone tutt'altro che affidabile (condannato
per calunnia), dopo essere stato elevato però (anche grazie ai talk show dei
giornalisti amici di Ingroia) a fonte di verità suprema sulle malefatte della
politica collusa coi clan, quasi sempre di centrodestra. Ma adesso che il
segugio delle trame occulte e dei segreti inconfessabili della Repubblica è
passato dall'altra parte della barricata, ha sposato con lo stesso impeto il
garantismo. Nel difendere Maniaci, l'ex pm minaccia sfracelli. Accusa la Procura
di Palermo di «inseguire il gossip» e di aver costruito un'indagine sul nulla,
minaccia la Procura di Caltanissetta («Non possiamo non denunciarne
l'anomalia...), vuol portare in tribunale pure i carabinieri, «per avere
distribuito lo spot promozionale dell'accusa, un video fatto intenzionalmente
per distruggere Maniaci, inserendo la faccende dei cani e di Matteo Renzi (a cui
Maniaci dà dello str..., ndr), faccende che non avevano alcuna rilevanza penale.
La Procura ha il dovere di chiedere formalmente all'Arma chi ha predisposto
questo video e poi chi lo ha distribuito». Ma non denuncia mica solo i
carabinieri, mezza Sicilia: «Faremo anche una denuncia al sindaco di Borgetto e
del suo addetto stampa, e denunceremo per calunnia alcune delle persone che
hanno agito per motivi di rancore contro il nostro cliente». Anche qui Ingroia
intravede una trattativa nascosta: «Si voleva marchiare Pino Maniaci per due o
tre presunte piccole estorsioni», che invece per il suo legale corrispondono
alla riscossione di diritti pubblicitari. Maniaci è stato interrogato dal gip, a
cui ha esposto la sua linea: «Mi hanno buttato addosso merda perché qualcuno
vuole fermarmi». Per un complotto, non c'era migliore avvocato di Ingroia.
Sempre che abbia più fortuna come legale che non come pm o leader di partito.
Il mio amico Maniaci.
Masaniello, Pancho Villa, il contadino o il brigante che dopo
anni di ribellione viene infine scoperto dai nobili, dalla corte, scrive
Riccardo Orioles il 05/05/2016 su “I Siciliani”. “Ha visto com’è spontaneo, don
Alonzo? Mangia colle mani! Es un hombre del pueblo, poco da fare…”. “È un
campesino, si vede. Un liberal campesino. Però potrebbe anche farsi la barba
ogni giorno”. “Ed ecco a voi… Pino Maniaci! Il coraggioso giornalista di…”. “Di
Partinico”. “Ecco, di Partinico! Nel cuore della Sicilia maffiosa! Ci dica,
Maniaci, lei ha paura quando affronta la mafia?”. E Maniaci – e Pancho Villa, e
Masaniello – risponde, come tutti si aspettano, con una parola volgare. “Eh eh –
sorride il presentatùr – Pane al pane, eh? Scusate, amici telespettatori, ma
stiamo parlando con un protagonista della lotta alla maffia… Uno che non bada
certo a parlare da intellettuale…”. Altra malaparola di Masaniello (o di Pancho
Villa, o di Maniaci), altro sorriso complice del presentatore. E lo spettacolo
va avanti. Francisco Arango Arambula di San Juan del Rio in realtà era uno dei
migliori generali del Ejercito Republicano. Aveva cominciato con quattro
compagni, poi dieci, poi cinquanta. Abilissimo tattico, uno dopo l’altro aveva
sfasciato i battaglioni del dittatore, lassù nel Norte. E ora eccolo qua, nel
Palazzo Presidencial, imbarazzato e felice, lisciandosi i baffoni e cercando di
rispondere alle domande dei capi liberales con l’occhialino. (E anche Gennaro
Aniello, come sindacalista e politico, non era poi tanto male. L’unico, in tutta
Napoli, a capire che la gabella sul pesce era la chiave di tutto, che là si
doveva insistere, coprendosi con “Viva el Rey” ma senza mollare un momento).
Pino Maniaci è uno dei migliori cronisti che ho conosciuto, e ne ho conosciuti
un bel po’. “Dilettante” all’inizio, ma rapidamente cresciuto, e all’antica, in
questo mestiere. Uno che è in giro all’alba, per colline e campagne, per
prendere i particolari, non solo le grandi linee, dell’ultimo omicidio o di una
cronachetta qualunque. E buona capacità, anche, di coordinare un’inchiesta
grossa, di mettere insieme dati, di trarne conclusioni razionali (la dottoressa
Saguto ne sa qualcosa). E ora eccolo qui, insieme a los generales e ai marchesi,
coccolato e schernito (ma elegantemente): “Don Pancho!”, “Excellencia!”, “Gran
Maniaci!”. Finché un bel giorno – come Tomaso Aniello, come Francisco – è
scasato di testa. Come la nobiltà, del resto, pazientemente aspettava. È una
storia di poveri. Decine o centinaia di euri, banconote e monete, raccolte senza
osar crederci, impaurito e spavaldo. “Hai finito di stentare”, dice alla donna.
Potrà lavare i pavimenti trecento euri al mese, una ricchezza. “Hai visto? Fanno
quello che voglio! Comando io!”. È un nobile pure lui adesso, uno che può
afferrare le cose, può comandare. Così fanno i signori, i ricchi della città, i
generali, gli avvocati. E così, se dio vuole, faremo pure noialtri, d’ora in
avanti. Ce lo siamo meritato. Inizia la breve ricchezza, la povera ricchezza,
soldini di rame e di tolla (ma ai poveri pare oro sonante) del campesino
Francisco, del pescatore Masaniello. “Comando io!”. E i nobili, con pazienza,
aspettano allegramente il passo falso. “Avete visto? – si preparano a dire – Don
Montante, el senor Costanzo, il barone Lo Bello: v’incazzavate con loro, voi
communisti, ma in fondo che cos’è mai successo? Chi vede quattrini se li piglia,
e voi non siete meglio degli altri: guardate il vostro eroe, che cos’ha fatto!”.
Cosi i milioni dei ricchi si confondono colle quattro monete dei poveracci:
tutta roba rubata, tutta la stessa cosa. “Vi prego, voi velocisti, telegiornali,
giornali vari, che mai avete fatto inchieste… Che fate servizi fiume sull’eroe
antimafia decaduto, e ci godete. Noi siamo i ragazzi di Telejunior. In quelle
stanze di Telejato ci abbiamo passato giornate intere. A impappinarsi nel
registrare i servizi, a fare le rassegne stampa, a montare. In giro a fare
domande, a Borgetto, a San Giuseppe Jato, al tribunale di Palermo. I vostri
coltelli feriscono, fanno un male che nemmeno vi immaginate. Ma io devo fare
scudo. Con gli occhi gonfi, la nausea che va e viene, il naso rosso paonazzo. Io
devo fare scudo ai miei ragazzi, ai ragazzi di Telejunior. Io Michela, e Salvo e
Arianna e Danilo, e Marco, Ivano, Eleonora, Pasquale e Giulia e tutti gli
altri”. Un altro ragazzo, un militante, da Milano: “Da me su Maniaci non avrete
parole, solo dolore”. Telejato deve continuare. Come la lotta contro la gabella
a Napoli, come la tierra y liberdad dei contadini. Con Masaniello, con Pancho
Villa, dopo Pancho Villa, dopo Masaniello. Perché siamo noi questa lotta, noi
popolo, noi banda di disperati. Non un singolo capo, che prima o poi può
crollare. Voi nobili, voi giornalisti importanti, guardate solo ai capi. Ma noi
abbiamo vissuto un’altra storia, un’altra grande speranza e sofferenza. Noi
siamo qui, noi non molliamo. Caro Pino, rimettiti dall’ubriacatura, ingollati
‘sto caffè e torna com’eri prima. In culo alla nobiltà e a tutto il gran
giornalismo italiano: noi siamo viddani zappaterra, non baroneddi. Ce ne
fottiamo di comandare, non c’interessa diventare come loro, vivere è ciò che ci
piace. Ti aspetto e ti stringo la mano. (Fino a un minuto fa, altro che stretta
di mano, volevo salutarti con un calcio nel sedere. Ma abbiamo cavalcato
insieme, stracciati e miserabili ma orgogliosi. Gliene abbiamo date, ai signori.
E torneremo a dargliene. Forza, un altro caffè, tutto d’un fiato. Ti aspetto).
Collega Letizia, aspetto i suoi ordini. Lei è la mia nuova direttrice. Telejato
continua, non c’è bisogno di dirlo. Mi spiace per lorsignori, ma si va avanti.
Sono già al computer, mi dica cosa debbo fare. “Perché, la storia di Telejato, e
di tutti noi ragazzi, non si può cancellare così. Siamo tutti stretti l’uno
all’altro, e rimarremo in questo modo, qualunque sia il pensiero di ciascuno,
qualunque emozione. Qualunque cosa accada. Uniti. Insieme”.
Il ruolo dei Carabinieri e della Procura
nella vicenda di Pino Maniaci, scrive il 10 agosto
2016 Salvo Vitale su "Telejato". MAN MANO CHE IL TEMPO PASSA ED È FINITO LO
STUPORE SUSCITATO NEL MOMENTO IN CUI È VENUTA FUORI LA NOTIZIA, I MARGINI DELLA
VICENDA CHE HA INTERESSATO PINO MANIACI SI FANNO PIÙ CHIARI E, PER MOLTI VERSI,
PIÙ INQUIETANTI. Tutto è iniziato nel 2013, quando “per caso”, nell’ambito di
una serie di intercettazioni disposte per indagare eventuali collusioni tra i
mafiosi e i politici di Borgetto, viene registrata una sospetta telefonata di
Maniaci al Sindaco di Borgetto. Va detto che Maniaci si era occupato, attraverso
la sua emittente, di strane commistioni che vedevano un consigliere comunale che
aveva preoccupanti parentele mafiosi o, addirittura, rapporti di comparaggio con
un esponente delle forze dell’ordine. Non si sa le intercettazioni abbiano preso
il via, grazie alle denunce di Maniaci o se siano state decise da altri canali
d’indagine. La telefonata di Maniaci consentiva l’apertura di un capitolo su di
lui, dal momento che vi si raffiguravano le caratteristiche dell’estorsione.
Maniaci avrebbe chiesto dei soldi al sindaco di Borgetto in cambio di un
ammorbidimento della linea del suo telegiornale nei suoi confronti. Da allora
non un respiro, non una parola è sfuggita all’orecchio vigile degli inquisitori,
che hanno accumulato oltre 4 mila pagine di intercettazioni per cercare prove e
provini che potessero costituire elementi d’accusa nei suoi confronti. Ben più
di quanto non ne siano state raccolte sui nove mafiosi di Borgetto, che avevano
rimesso in funzione una gigantesca macchina di estorsioni e taglieggiamenti tra
Borgetto e Partinico. Contemporaneamente Telejato ha, in quel periodo, aperto
una serie d’inchieste sull’operato della sezione “misure di prevenzione” del
tribunale di Palermo, in particolare sull’accoppiata Saguto-Cappellano Seminara
e ha messo in onda una serie di interviste e di servizi di operatori economici e
commerciali ai quali era stato sequestrato tutto, senza che penalmente ci fosse
nessuna condanna e nessun capo d’imputazione. Una delle caratteristiche emerse
dall’inchiesta è che al tribunale di Palermo tutti sapevano, ma nessuno era
intervenuto né tantomeno aveva il coraggio di intervenire sulle distorsioni
della giustizia che venivano consumate all’interno della citata sezione. Una
convocazione, di Maniaci, da parte del tribunale di Caltanissetta, giudice
Gozzo, si era conclusa con un’audizione di tre ore e con l’impegno di una nuova
convocazione, cui non era seguito più nulla. Il controllo dei telefoni di
Telejato consentiva agli intercettatori di ricostruire la rete di informazioni e
le persone che venivano a raccontare le loro storie: i carabinieri sapevano
benissimo delle visite dei Niceta, dei Giacalone, dei Virga, degli Impastato,
degli operai della 6Digi di Grigoli, dei lavoratori dell’Hotel Ponte, di quelli
dell’ex immobiliare Strasburgo, di Rizzacasa, di Lena, di Di Giovanni, di Ienna
ecc. Dall’altro lato la Saguto sapeva benissimo che Telejato era sotto controllo
e che in qualsiasi momento la procura avrebbe potuto intervenire per bloccarne
le iniziative. “Quello lì è questione di ore…” diceva il prefetto Cannizzo
alla Saguto, la quale poi si lamentava con la stessa per il ritardo della
procura: “Se quelli lì si spicciassero…”, mentre scherzava con Cappellano
sul “dover chiedere il permesso” a Telejato per prendere la decisione di un
sequestro. Una corsa contro il tempo che è finita con l’apertura dell’indagine
da Caltanissetta sulla Saguto e sui provvedimenti di sospensione o di
trasferimento, del prefetto, dei giudici Licata e Chiaramonte e di Tommaso Virga
e sul rinnovo dei magistrati di tutta la sezione. È sembrato poco opportuno, in
quel momento, ai magistrati, coinvolgere Maniaci, perché la cosa avrebbe potuto
avere il sapore di una ritorsione, così l’indagine è stata raffreddata e la
miccia è stata accesa circa sette mesi dopo, come si dice in siciliano “’a
squagghiata di l’acquazzina”, cioè quando si è sciolta la brina. CERCHIAMO DI
RICOSTRUIRE, CON L’ABBUONO DELL’IMMAGINAZIONE, LA STRATEGIA DELLA PROCURA. Primo
obiettivo, distruggere l’immagine del giornalista antimafia, e quindi
nullificare il suo lavoro, per ribadire che l’antimafia, le indagini, le denunce
non appartengono all’operato di un giornalista che si è allargato troppo, ma
solo agli investigatori, alle istituzioni o agli organismi riconosciuti come
soggetti istituzionalmente interlocutori. Non pare importante in ciò l’esistenza
di reati penali o la presunzione d’innocenza: basta mettere insieme alcuni
elementi di presunta colpevolezza e il lavoro di Telejato avrebbe dovuto
crollare come un castello di carta. Mettere Maniaci assieme ai nove mafiosi di
Borgetto, di cui egli stesso aveva denunciato da anni le malefatte è stato un
colpo da maestri, perché si è creato di tutta l’erba un fascio e perché così si
è dimostrato che tra le estorsioni dei mafiosi, per richiesta di protezione e le
richieste di denaro di Maniaci non c’era nessuna differenza. Le prime
garantivano protezione, da se stessi, quella di Maniaci garantiva un trattamento
morbido dell’informazione sulla persona estorta. In tutto questo c’è un elemento
che non quadra, che non ha il dovuto riscontro, ovvero che quel “trattamento
morbido” non esiste, che non c’è alcuna trasmissione benevola nei confronti dei
due sindaci di Borgetto e Partinico e che, nell’arrivare a questa affrettata
conclusione, come ha detto uno dei giudici, Vittorio Teresi, “ci siamo fidati
dei carabinieri”. Altra trovata: non essendoci ancora processo, bisognava pure
studiare qualcosa per dimostrare all’opinione pubblica che un provvedimento era
stato adottato, perché sotto c’era qualcosa di penalmente rilevante, e allora si
è pensato di adottare la misura cautelare del divieto di dimora nelle province
di Palermo e Trapani. Perché? Quale reato avrebbe potuto reiterare Maniaci, al
punto da disporne l’allontanamento dalla sua televisione? Pare di capire che
l’obiettivo non tanto occultato, è stato quello di togliere alla televisione il
suo principale protagonista e provocarne la chiusura. Caduto l’elemento
d’accusa, dal momento che i pochi euro “estorti” ai due sindaci riguardavano, da
una parte il pagamento d’una pubblicità, dall’altra una sorta di contributo
assistenziale “per comprare il latte” o qualche vestitino a una bambina malata,
figlia di una donna sposata con un “malacarne” e additata a tutta Italia come la
sua “amante”, si è disposta la revoca della misura, costata a Maniaci una
ventina di giorni d’esilio, e si è trovato un altro escamotage per tornare a
riproporne l’allontanamento: c’era un passaggio, nelle intercettazioni, tra l’ex
sindaco di Borgetto Davì e il già citato Polizzi in cui si parla della
commissione, da parte di Maniaci, di un blocco di magliette che non sarebbero
mai state pagate, così come non erano stati pagati tre mesi d’affitto per
ospitare alcuni ragazzi di Telejunior. Polizzi ha negato tutto, ma è stato
indagato per le discordanze tra l’intercettazione e la sua dichiarazione, mentre
Davì, che aveva concesso a Maniaci l’uso provvisorio di uno stabile affittato
come sede della Protezione civile, non è stato mai sentito. A questo punto il
ricorso è finito in Cassazione, la quale, ad ottobre, dovrà pronunciarsi se
reiterare l’allontanamento di Maniaci, dopo che egli è rientrato da parecchio
tempo in sede e non ha reiterato alcun reato. Sono vicende che sfiorano il
comico e l’incredibile, ma che svelano quanta acredine e quanta determinata
voglia di “fottere” Maniaci, di colpirlo e di mettere a tacere la sua emittente,
ci sia dietro. Il montaggio del video e la contestuale distribuzione delle
registrazioni delle intercettazioni sembra uno dei capolavori usati per avere lo
strumento principe nella demolizione dell’immagine di Maniaci. C’è tutto: il
sindaco di Borgetto che gli conta i soldi in bella mostra, la sparata offensiva
nei confronti della telefonata di Renzi, il disprezzo per una targa-premio che
gli era stata conferita, gli apprezzamenti della presunta amante sulla capacità,
anzi sulla “potenza” di Maniaci nel tenere in scacco gli amministratori di
Partinico, il disprezzo per tutte le istituzioni, dai politici, alle forze
dell’ordine, a magistrati, definite corrotte ed espressione del malaffare e
infine l’accusa più infamante, quella di avere utilizzato l’uccisione dei due
cani, di cui egli conosceva l’esecutore, non come un atto di gelosia di un
marito cornuto, ma come un attentato mafioso nei confronti della sua attività
giornalistica… Per quest’ultimo caso viene abilmente occultata la denuncia,
presentata da Maniaci, con l’indicazione della persona da lui sospettata e non
si fa alcun accenno al fatto che, non essendo stata questa persona indagata,
interrogata o ritenuta responsabile, avrebbero potuto essere proprio i mafiosi
borgettani con i quali egli è stato messo insieme nell’operazione Kelevra, ad
aver compiuto il barbaro gesto. Una volta confezionata la polpetta avvelenata ci
sono, ci siamo cascati tutti, senza renderci conto che dietro tutto non c’erano
reati, ma elementi d’accusa deboli, ma erano evidenti altri elementi che
riguardavano il senso della morale, nei confronti di una persona atteggiatasi a
fustigatore dei costumi e a giudice delle immoralità altrui. Persino i più noti
antimafiosi, come Lirio Abbate, che ha chiesto a “Reporters sans Frontieres” di
cancellare il nome di Maniaci dall’elenco dei giornalisti a rischio, o Claudio
Fava, che, sbagliando premio, ha dichiarato Maniaci indegno di potere ricevere
il premio Mario Francese hanno condiviso quanto propinato dai magistrati. Un
passaggio che occorre inserire nel quadro di questa indagine è la nomina a
Palermo del Procuratore Lo Voi, inframezzata dai ricorsi dei colleghi Lari e Lo
Forte e dalle supplenze del procuratore Facente Funzione Leonardo Agueci,
indicato da Maniaci e da qualche altro giornalista, come cugino della titolare
della distilleria di Antonina Bertolino, a Partinico, uno dei suoi principali
bersagli. Lo Voi, la cui nomina è stata definita come una “nomina politica”,
ovvero voluta direttamente da Renzi e da Alfano, si è insediato a Palermo nel
2015. Fa parte della corrente di Magistratura Indipendente, la stessa di quella
della Saguto e di Tommaso Virga. Egli ha affermato subito che l’indagine sulla
Saguto è partita su segnalazione del tribunale di Palermo, da Caltanissetta si
affrettano a dire, subito, che Maniaci non c’entra niente, certamente è lui ad
affidare il caso “Maniaci”, più nove, a quattro magistrati, Teresi, Del Bene,
Picozzi, Tartaglia e Luise, che si occupano di vicende di mafia e che con una
dedizione più degna di altra causa, hanno usato i giornalisti che ruotano
attorno alla procura come amplificatori di una strategia che sembra avere
qualche tinta diffamatoria. La materia prima su cui muoversi è data da quanto è
in mano alla caserma dei carabinieri di Partinico, la quale, per un verso non
invia più le informazioni sulla propria attività a Telejato, per l’altro
assicura ancora la tutela. La pubblicazione di pruriginose intercettazioni con
la ragazza definita amante offre Maniaci in pasto alle possibili ritorsioni e
all’eventuale rischio della vita, da parte di un soggetto che potrebbe ancora
voler vendicare il proprio onore ferito. Una preoccupante sentenza di morte che
avrebbe potuto essere evitata se chi ha diffuso intercettazioni che non avevano
nulla di penalmente rilevabile, ma che riguardavano la vita privata, le avesse
cancellate o omesse. È di questo che Maniaci accusa la Procura e i Carabinieri,
in una sua denuncia. Altre cose sono in itinere, ma sembra profilarsi
all’orizzonte una ben più preoccupante situazione, quella di una sorta di gioco
di fioretto tra l’ex magistrato Antonio Ingroia, difensore di Maniaci, che
conosce bene tutti i modi di muoversi e d’agire dei suoi ex colleghi, e quella
di costoro, che forse ci tengono a dimostrare che sono più bravi di lui e che,
in un modo o nell’altro troveranno come condannare Maniaci, almeno in primo
appello, mentre continua all’infinito la strategia della graticola, quella su
cui venne bruciato San Lorenzo, di cui oggi ricorre l’anniversario: cuocere a
fuoco lento l’imputato, sino a demolirne progressivamente qualsiasi capacità di
difesa. Cosa che potrebbe andare bene quando l’imputato è colpevole. Si può
concludere che la motivazione strisciante di tutto quello che è successo sarà
stata presa un po’ più in alto, da parte di qualcuno che ha ritenuto essere
arrivato il tempo di chiudere un’emittente anomala che non sa stare in linea con
il modo di agire delle altre emittenti. E cioè siamo sempre lì, nel conformismo
dell’informazione, che ha relegato l’Italia agli ultimi posti per la libertà di
stampa.
Sul rapporto tra i Carabinieri e Telejato,
scrive il 6 agosto 2016 Salvo Vitale su Telejato. COM’ERA E COS’È CAMBIATO DOPO
L’OPERAZIONE KELEVRA. Il video diffuso in tutta Italia su Pino Maniaci e i testi
delle intercettazioni ripropongono il problema del ruolo che hanno avuto i
carabinieri dietro tutta questa vicenda e lascia diversi interrogativi sulle
motivazioni che stanno dietro le loro azioni. Va premesso che Telejato ha sempre
avuto con i carabinieri uno stretto rapporto di collaborazione, che ne ha da
sempre trasmesso i comunicati, anche quando questi riguardavano trascurabili
vicende, tipo il sequestro di un grammo di marjuana e di 20 euro considerati
come proventi della sua vendita. Ai carabinieri sono state dirottate alcune
lettere anonime, ben dettagliate su nomi e affari loschi, ricevute a Telejato.
Con i carabinieri, e in particolare con una figura “leggendaria”, come il
capitano Cucchini, sono state portate avanti alcune attività che poi hanno
condotto al sequestro dell’impianto della distilleria Bertolino, chiusa per
quattro anni o all’arresto dei Fardazza e alla lotta per la demolizione delle
stalle. Va detto che Cucchini aveva spostato l’allora Nucleo Operativo, che
ancor oggi è composto dalle stesse persone e che scherzando abbiamo
ribattezzato Nucleo aperitivo, a espletare servizi d’ufficio e si era servito di
personale più giovane. Il principio da lui seguito era che dopo trent’anni, poco
più poco meno, chi lavora in una caserma diventa sì un esperto del territorio e
dei suoi problemi, ma può talmente affezionarsi al suo ruolo sino a mettere casa
e famiglia e ad avviare contatti, richieste di lavoro per i propri familiari e
conoscenze che potrebbero finire con il gettare un cono d’ombra sulla
trasparenza dell’operato dal personale di cui parliamo. Non saremo noi a parlare
di queste cose, in quanto, se ne hanno voglia, spetta a chi fa le indagini
indagare, magari anche al proprio interno. Ottimo anche il rapporto con i
carabinieri ai quali è stato affidato l’incarico di far la tutela a Maniaci. Il
2013 è un anno in cui cominciano le intercettazioni che riguardano Maniaci, ma è
anche l’anno in cui vengono spediti alla caserma di Partinico il capitano De
Chirico e il tenente Alimonda, i quali fra poco, ultimati i loro tre anni,
saranno promossi e trasferiti. Di qualcuno di essi Telejato ha detto che a
Partinico non ci volevano ragazzini di 22 anni usciti dal corso da poco, ma
gente con le palle quadrate. Apriti cielo!!! A qualche altro che gli chiedeva
come mai la gente si rivolge a Telejato e non ai carabinieri, Maniaci ha detto
che la gente ritiene Telejato un’istituzione più seria di altre istituzioni.
Anche qua apriti cielo. E tuttavia anche questo sembra troppo poco per motivare
alcune azioni, come quella della diffusione del “gossip” ovvero di tutta una
serie di telefonate personali tra Maniaci e la sua presunta amante, che non
hanno alcuna rilevanza penale, ma tali da ingenerare nel di lei marito la
volontà di arrivare all’eliminazione fisica della persona che aveva offeso il
suo onore. E che tale sospetto sia, sino ad oggi, motivato, lo si può ricavare
dalla fedina penale dell’interessato, che risulta, agli atti, essere
tossicodipendente (è schedato al SERT come cocainomane), alcolizzato,
spacciatore, individuo violento con sei denunce fatte dalla moglie per
maltrattamenti vari, al punto che questa ha scelto la separazione. Ultimamente è
stato beccato con otto grammi di cocaina e un coltello a serramanico ma rimesso
a piede libero. Quindi è evidente, dopo la diffusione delle telefonate
morbosamente registrate dai carabinieri di Partinico, che l’esposizione di
Maniaci, ne comporta il rischio dell’eliminazione fisica. Inutile chiedersi se i
carabinieri si sono posti il problema e come mai la loro “presa di distanze” è
arrivata al punto che non vengono più fornite notizie e informazioni
all’emittente Telejato, mentre, per contro, viene ancora effettuata la tutela.
C’è qualcosa che non funziona.
Salvo Vitale è stato un compagno di lotte di
Peppino Impastato, con il quale ha condiviso un percorso politico e di impegno
sociale che ha portato entrambi ad opporsi a Cosa Nostra, nella Cinisi governata
da Tano Badalamenti, il boss legato alla Cupola guidata negli anni Settanta da
Stefano Bontate.
I 100 EROI DELL’INFORMAZIONE SONO 99 –
GIUSTIZIALISMO TRIONFERÀ. REPORTER SENZA FRONTIERE CONDANNA PINO MANIACI ALLA
DAMNATIO MEMORIAE. Quanti sono i 100 eroi mondiali
dell’informazione? Sembra una domanda simile a quella sul colore del cavallo
bianco di Napoleone, ma è meno scontata di quanto appaia. Perché i “100
Information heroes” selezionati da Reporters sans frontières, la nota ong che si
occupa di libertà di stampa, in realtà sono 99. Ne manca uno, tra l’altro uno
dei due italiani originariamente presenti nella lista, il giornalista siciliano
Pino Maniaci (l’altro è Lirio Abbate, che invece mantiene lo status di eroe).
Maniaci era entrato nel club dei 100 giornalisti che nel mondo si erano distinti
per aver svolto il loro lavoro in contesti pericolosi e per aver affermato il
principio della libertà di stampa anche a rischio della propria incolumità.
Reporter senza frontiere (Rsf) descriveva Giuseppe ‘Pino’ Maniaci come il
coraggioso direttore di “una piccola stazione televisiva antimafia”, Telejato,
che si occupa di “omicidi e racket, che sono una parte della vita quotidiana in
Sicilia”. “È stato citato in giudizio centinaia di volte e ripetutamente
minacciato e una volta è stato picchiato dal figlio di un boss mafioso”. Ora
però sul sito Rsf la foto di Maniaci non c’è più, al suo posto c’è uno spazio
vuoto, la sua scheda è stata eliminata: i 100 eroi sono diventati 99 e la ong
che si batte per la libertà di stampa non spiega da nessuna parte perché. Cos’è
successo? A maggio su tutti i giornali è scoppiato il “caso Maniaci”: il
giornalista impegnato da anni nella lotta alla mafia e all’illegalità è indagato
dalla procura di Palermo con l’accusa di estorsione, avrebbe ricevuto da alcuni
sindaci poche centinaia di euro e favori in cambio di soldi. Pochi spiccioli, ma
comunque un comportamento deprecabile. Dalle intercettazioni sono emersi altri
aspetti poco piacevoli, come ad esempio la possibilità che alcune intimidazioni
che avrebbe subìto – e per cui aveva ricevuto la solidarietà anche del premier
Matteo Renzi – in realtà non sarebbero minacce mafiose ma vendette personali del
marito della sua amante. Maniaci ne era consapevole, ma ha cavalcato l’ipotesi
dell’intimidazione per aumentare il proprio prestigio di giornalista antimafia.
In ogni caso questi aspetti più personali, per quanto censurabili, non vengono
contestati dalla procura e rispetto alle accuse di estorsione il giornalista si
difende dicendo che il passaggio di denaro si riferisce all’acquisto di spazi
pubblicitari. L’indagine va avanti e, come si suol dire, la giustizia farà il
suo corso. Rsf invece ha già emesso una sentenza di condanna, senza però
pubblicare la sentenza. Perché Maniaci è stato rimosso dal sito? Ne è stato
informato? Rsf ha pubblicato un comunicato ufficiale sulla vicenda? “Ci è
capitato di apprendere che l’onestà di Giuseppe Maniaci è stata seriamente messa
in discussione e che lo scorso maggio è stato incriminato”, ha risposto alla
richiesta di spiegazioni del Foglio il chief editor di Rsf Gilles Wullus. “Fino
a quando l’indagine non sarà fnita, abbiamo scelto di ritirarlo dalla nostra
lista di ‘Eroi dell’informazione’”. La scelta sarebbe anche legittima, ma
restano aperte alcune questioni gravi sul modo di operare della ong che stila
classifiche sulla libertà d’informazione del mondo. La prima è un dettaglio, che
però indica il livello di approfondimento che Rsf ha dedicato alla vicenda:
Maniaci non è “incriminato”, ha solo ricevuto un avviso di garanzia e i pm non
hanno ancora chiesto il rinvio a giudizio. L’altra è la totale assenza di
trasparenza: mai Rsf ha comunicato che la posizione di Maniaci è sospesa e per
quali motivi, né ha chiesto spiegazioni al giornalista, sia per avere gli
elementi per una valutazione giusta sia per garantire il diritto di difesa. Rsf
ha semplicemente sbanchettato Maniaci, come si faceva in Unione Sovietica con le
foto dei compagni caduti in disgrazia dopo le purghe, come fanno ancora oggi
tutti quei regimi autoritari e totalitari nemici della libertà di stampa. Al
posto della sospensione e di un giudizio pubblico e trasparente, Rsf ha scelto
la damnatio memoriae, la cancellazione di ogni traccia del sospetto, come se
Maniaci non fosse mai stato uno dei 100 “Eroi dell’informazione”. Che Rsf e i
suoi premi non sono una cosa seria l’aveva intuito lo stesso Maniaci che, mentre
in pubblico era impettito per il premio simbolo del giornalismo impegnato, in
un’intercettazione diceva: “M’hanno invitato dall’altra parte del mondo per
andare a prendere il premio internazionale del cazzo di eroe dei nostri tempi”.
Non più dell’informazione, ma eroe della sincerità. Il Foglio Quotidiano – anno
XXI numero 179 – pag. 2 – 30/07/2016 Autore: Luciano Capone
Il dito e la Luna. A proposito di Pino
Maniaci di Telejato. L’opinione del dr. Antonio
Giangrande. Scrittore, sociologo storico, blogger, youtuber, presidente
dell’Associazione Contro Tutte le Mafie. Chi parla di Mafia e antimafia dice a
sproposito la sua e non so cosa ne capisca del tema. Chi mi conosce sa che sono
disponibile a dar lezione! Nel caso di Pino Maniaci ci troviamo a bella a posta
a sputtanare qualcuno con notizie segretate con tanto di video e senza sentire
la sua versione, così come io ho fatto. A prescindere dal caso specifico, Pino
Maniaci da vero giornalista ha indicato sempre la luna e ora si sta a guardare
questo cazzo di dito. Vi siete chiesti perché tutto è successo nel momento in
cui è stata attaccata “Libera” ed i magistrati e tutta la carovana antimafia con
i suoi carovanieri? In quel momento i paladini mediatici e scribacchini
dell’antimafiosità ed i magistrati delatori (non è sempre un reato?) si son dati
da fare a distruggere un mito, prima di una sentenza. I codardi, poi, che prima
osannavano Pino, oggi lo rinnegano come Gesù Cristo. Comunque io sto con chi ha
le palle, quindi con Pino Maniaci. Mi dispiace del fatto che a Palermo si vede
la Mafia anche dove non c’è, giusto per sputtanare un popolo e fottersi i beni
delle aziende sane. E di questo tutti tacciono. Se a Palermo si stanno
dissequestrando i beni sequestrati dagli “Antimafiosi” è grazie a Pino. Pino
colpevole, forse, anche perché in Italia nessuno può dirsi immacolato, ma
guardiamo la luna e non sto cazzo di dito.
Parla l’avvocato dei boss: «Ecco i
misteri di via D’Amelio che non conoscete». La guerra
intestina tra Riina e Provenzano, il depistaggio di Vincenzo Scarantino, le
lacune delle inchieste. E la domanda più inquietante: fu davvero una 126 ad
esplodere in via D’Amelio? Il racconto dell’avvocato Rosalba Di Gregorio a
Manuel Montero su “Fronte del Blog” il 30 agosto 2014. Dal suo ufficio i boss
sono passati in massa. Il primo fu Giovanni Bontate, fratello di Stefano, alias
il Principe di Villagrazia e gran capo di Cosa Nostra prima che i Corleonesi lo
ammazzassero dando vita alla seconda guerra di mafia. Poi ci furono i Vernengo e
Francesco Marino Mannoia. E ancora Vittorio Mangano, lo stalliere di Arcore,
Michele Greco detto il Papa della mafia. E ora Bernardo Provenzano, Binnu u
tratturi. Dallo speciale osservatorio che si è costruita, l’avvocato Rosalba Di
Gregorio ha potuto raccontare così l’ “altra faccia” delle stragi. E lo ha fatto
con Dina Lauricella nel libro non a caso intitolato “Dalla parte
sbagliata” (Castelvecchi), un volume che rappresenta un pugno nello stomaco per
chi (quasi tutti, in verità) ritiene il 41bis un regime di detenzione degno di
una società civile: ne narra gli orrori da Guantanamo, le inutili crudeltà, le
indescrivibili pressioni fisiche e psicologiche. Fatte anche su chi, come
abbiamo scoperto di recente, ci è finito dentro per quasi vent’anni da
innocente: i sette malcapitati trascinati al 41bis dal falso pentito di via
D’Amelio, Vincenzo Scarantino. Ma il libro fa molto di più: mette a nudo le
pecche dei pentiti, chi tra loro confessa a rate lunghissime, chi di volta in
volta aggiunge, sottrae e corregge le versioni senza mai pagarne il conto. Col
rischio che raccontino storie molto lontane dalla realtà. Ma è proprio sulla
vicenda di Scarantino che il legale può illuminarci, dato che, alcuni di quei
malcapitati innocenti, li difendeva lei.
Lei dice che si vedeva subito che le
dichiarazioni di Scarantino erano una farsa.
«L’unico riscontro che esisteva alle sue parole
era la 126 esplosiva che uccise Paolo Borsellino e la sua scorta. Tutto il resto
erano cose surreali. Spiegò che la decisione di uccidere il magistrato era
avvenuta in casa di un uomo, tale Giuseppe Calascibetta, intorno al 25 giugno
1992, a cui parteciparono capi di Cosa Nostra di qualsiasi grado, cosa già di
per sé impossibile. Ma incredibile è il fatto che fu creduto quando disse di
averlo sentito perché lui, che doveva aspettare fuori, ad un certo punto, avendo
sete, entrò a prendere in frigorifero una bottiglia d’acqua. Anziché fermarsi o
cacciarlo o qualsiasi altra iniziativa, proprio allora tutti avrebbero parlato
dell’attentato da fare in via D’Amelio. Ci sarebbe da ridere se non fosse una
tragedia. E il guaio è che è il meno».
Cioè?
«Scarantino raccontò le modalità con cui era stato
affiliato, una specie di rimpatriata tra amici, finita al ristorante. Non era
incredibile solo la narrazione, ma proprio lui, che aveva rapporti con una
transessuale, cosa che un uomo d’onore non avrebbe fatto mai. Non riuscivo a
credere che i magistrati lo ritenessero attendibile. E infatti non lo era. Ma
quando raccontò delle torture subite per farlo confessare nessuno gli diede
retta, anzi…»
Lei scrive che voi avvocati foste accusati dai
giudici di cambiare le carte in tavola, per usare un eufemismo…
«Fosse solo questo. I pm Anna Palma e Nino Di
Matteo ci denunciarono due volte per il caso Scarantino. La prima volta quando
scoprimmo l’esistenza di tre confronti che altri pentiti avevano avuto con lui,
confronti a lungo negati dai pm. Quando ne chiedemmo l’acquisizione da un altro
procedimento, dissero che non servivano. Noi li denunciammo per falso, loro per
calunnia. Tutto archiviato. La seconda volta accadde, quando Scarantino ritrattò
la sua confessione in aula: due legali furono accusati di essere le menti
occulte a disposizione di Cosa Nostra che lo avevano convinto a cambiare idea.
Un’altra fesseria, archiviata per buona sorte. Oggi sappiamo che Scarantino
davvero era un poveraccio, uno che di mafia non sapeva nulla, neurolabile
riformato dal servizio di leva, le cui confessioni erano studiate a tavolino e
per arrivare alle quali subì un trattamento orrendo nel carcere di Pianosa».
Cosa sappiamo della strage di via D’Amelio?
«Praticamente dopo tre processi non sappiamo
granchè. Non si sa quando avvenne, se avvenne, una riunione deliberativa per
deciderne la morte. Non sappiamo il movente. Non sappiamo da dove fu azionato il
telecomando esplosivo. Non sappiamo quanti parteciparono, perché ognuno
conosceva un segmento delle azioni. Non sappiamo neppure come faceva Cosa Nostra
a sapere dell’arrivo di Borsellino proprio quella domenica. Le nuove indagini
stanno cercando di far luce, ma sono penalizzate di ventidue anni. E da vari
elementi che agli atti non si trovano».
E quelli che hanno partecipato?
«Dicono tutti di aver preso ordini da Salvatore
Biondino, di solito definito l’autista di Riina, in realtà il reggente del
mandamento di S.Lorenzo, il cui capomandamento Giuseppe Giacomo Gambino, era
stato arrestato».
La 126 esplosiva. Nel libro lei esprime dubbi
sul fatto che sia stata davvero quella l’arma usata in via D’Amelio.
«Guardi, sulla copertina del libro c’è una foto un
po’ ridotta rispetto a quella che ho qui nel mio ufficio, scattata dal palazzo
di fronte a quello della sorella del giudice Borsellino. È stata fatta la
mattina del 20 luglio 1992. La strada è deserta. Eppure dopo le 13,30 venne
recuperato lì, di fianco alla Croma che c’è sulla foto senza nulla intorno, il
motore della 126, una cosa da 80 kg, non roba piccola, mi spiego? Ho chiesto di
acquisire tutti i filmati e le foto del 19 luglio, il blocco motore non appare
da nessuna parte. Nessuno lo vede questo motore, 80 kg che regge in tre
processi. Noi sappiamo però quattro cose. La prima è che un pentito, Giovan
Battista Ferrante, disse che loro l’esplosivo l’avevano piazzato in un fusto
ricoperto da 200 litri di calce e non nella 126. La seconda è che il consulente
di parte Ugolini chiese in aula come mai non fosse stato repertato un grosso
frammento “stampato” sul cratere dell’esplosione. La terza è che la scientifica
di Palermo riempì 60 sacchi della pattumiera con tutto ciò che era stato trovato
a terra, ma senza mettere a verbale reperto per reperto inviandole a Roma, a
disposizione solo dell’Fbi. La quarta la raccontò Scarantino in aula al momento
di ritrattare la confessione. Disse che, quando era sotto protezione, godeva
della compagnia sostanziale e inspiegabile dei poliziotti del gruppo d’indagine
Falcone-Borsellino. E ricordò che uno di loro gli aveva spiegato come in realtà
la 126 fosse stata fatta esplodere in una discarica e i pezzi poi portati lì per
incolpare gli imputati. Naturalmente fu giudicata “ridicola” la sua
affermazione. Però…».
Però?
«Ci sarebbe una quinta cosa, un’agenzia Ansa
scomparsa».
Prego?
«Un’ora dopo la strage uscì un’agenzia nella quale
si diceva che grazie ad una felice intuizione investigativa si era scoperto che
la causa dell’esplosione era stata un’autobomba 126. Un’ora dopo! Ne feci copia,
una per me e una da depositare. La mattina successiva entrai in ufficio ed
entrambe erano sparite. L’agenzia sull’archivio Ansa oggi non c’è. D’altra parte
c’era confusione. Il pm di turno fu avvisato della strage alle 18,40, quando
sulla scena del crimine era entrato l’universo mondo. Solo un quarto d’ora dopo
l’area fu recintata. Nel frattempo, mentre in via D’Amelio si addensavano
centinaia e centinaia di persone, la polizia aveva capito che l’autobomba era
una 126. Non me lo spiegherò mai».
Lei non crede dunque alla ricostruzione di
Spatuzza?
«Certo, ma Spatuzza racconta solo del furto della
126. Ciò che accadde una volta consegnata l’auto non può saperlo e infatti non
lo dice, perché fu fatto allontanare da Palermo».
Non ritiene valido neppure il teorema Buscetta
sull’unitarietà e l’aspetto verticistico di Cosa Nostra.
«Con queste ultime sentenze su via D’Amelio
sappiamo che il mandamento della Guadagna, quello di Pietro Aglieri, con le
stragi del ’92 e ‘93 non c’entrava nulla. E non poteva che essere così, perché
ad Aglieri Riina aveva chiesto di ammazzare uno dei parenti di Totuccio
Contorno, condannato a morte dai Corleonesi. Ma Aglieri, quando aveva visto la
vittima con il bimbo in braccio si era rifiutato di ucciderlo. Lo riferì a
Provenzano e lui fu d’accordo. Ma Aglieri non entrò più nelle grazie di Riina.
Fu Borsellino a dire che Riina e Provenzano erano due pugili che si guardavano
in cagnesco. Si trattava di un gruppo non più unitario nelle idee e nel metodo.
Io l’ho constatato in diverse sentenze, con assoluzioni del gruppo di Provenzano
rispetto a fatti in cui quelli di Riina erano stati condannati. Con Riina
c’erano Brusca, Graviano e Spatuzza, non Provenzano. D’altra parte il pentito
Giuffrè disse che già nel 1989 Riina gli aveva chiesto a che ora Binnu uscisse
di casa. Evidentemente perché lo voleva ammazzare».
L’agenda rossa di Borsellino che fine può aver
fatto?
«Guardi, intanto Arnaldo La Barbera, il capo della
mobile di Palermo e poi del gruppo Falcone-Borsellino, qualche giorno dopo la
strage disse che l’ “agenda telefonica” di Borsellino molto probabilmente era
andata distrutta nell’esplosione e che non era stata ritrovata. Un’agenda che il
sostituto procuratore Ignazio De Francisci diceva essere importantissima. Poi
sappiamo che l’agenda marrone era stata ritrovata e, dalla testimonianza del pm
dell’epoca Fausto Cardella al Borsellino quater sappiamo che anche l’ “agenda
telefonica” è stata infine trovata. Ed era nella borsa di Borsellino apparsa,
non si sa come, proprio nell’ufficio di La Barbera. Ecco, intanto sappiamo
questo, che La Barbera fosse o meno il collaboratore dei servizi segreti col
nome di Rutilius. Ma se per via D’Amelio i misteri sono ancora moltissimi, non è
che per la strage di Capaci noi si sappia poi moltissimo».
Cioè?
«Neppure lì sappiamo molto sulla riunione
deliberativa per ammazzarlo. Nel senso che una sentenza di Catania che riuniva
stralci delle stragi di Capaci e di via D’Amelio colloca la riunione tra il
novembre e il dicembre del 1991, basandosi sulle dichiarazioni del pentito Nino
Giuffrè. Giuffrè raccontò che nell’occasione si erano ritrovati tutti i capi. E
Riina, avendo avuto notizie che il maxiprocesso non sarebbe stato cassato, disse
che era arrivata l’ora della resa dei conti. E che era venuto il tempo di
ammazzare Lima, Falcone e Borsellino. A marzo, aveva dunque mandato a Roma
Gaspare Spatuzza e altri per pedinare Falcone e poi ammazzarlo per vendetta.
Senonchè, alla fine, il gruppo era stato chiamato indietro da Biondino perché
bisognava fare la strage di Capaci. Come si passa dalla vendetta con un colpo di
pistola alla strage di Capaci? Chi, quando, dove, come e perché lo ha deciso?
Non si sa».
Riina: mi fece arrestare Provenzano.
Avrebbe confidato queste parole al poliziotto Bonafede nel 2013. E sul bacio di
Andreotti: «Lei mi vede a baciare quell’uomo? Però sono sempre stato
andreottiano», scrive “Il Corriere del Mezzogiorno” il 30 giugno 2016. La
cattura, la presunta trattativa e il leggendario bacio ad Andreotti. Al processo
Stato-Mafia piombano, e sono sempre macigni, le parole di Totò Riina. Utili per
una serie di riscontri. In particolare, vengono riportate le confidenze che
Riina avrebbe fatto al poliziotto Michele Bonafede nel carcere milanese di
Opera. «A me mi hanno fatto arrestare Bernardo Provenzano e Ciancimino e non
come dicono i carabinieri» avrebbe detto l’ex Capo dei capi all’agente il 21
maggio 2013. L’episodio, ricordato oggi dal poliziotto durante il processo
Stato-mafia, confermerebbe quanto detto dal figlio di Ciancimino, Massimo, che
per primo ha parlato del ruolo del padre e del capomafia di Corleone nella
cattura di Riina. Al boss i carabinieri sarebbero arrivati grazie
all’indicazione del covo segnata da Provenzano nelle mappe catastali fattegli
avere dal Ros attraverso Vito Ciancimino. L’udienza si sta svolgendo nell’aula
bunker del carcere Ucciardone di Palermo. «Ma è vera la storia del bacio ad
Andreotti?» gli chiese poi l’agente. «Appuntato, lei mi vede a baciare
Andreotti? - rispose il boss - Le posso solo dire che era un galantuomo e che io
sono stato dell’area andreottiana da sempre». Su un’altra frase del boss,
raccolta da Bonafede e da un altro agente, Francesco Milano, il 31 maggio 2013
mentre si recavano nell’aula per le videoconferenze del carcere («Io non ho
cercato nessuno, erano loro che cercavano me»), in aula sono emerse due versioni
discordanti. Bonafede ricorda che il boss avrebbe aggiunto «per trattare»,
mentre Milano ha riferito che il capomafia disse in siciliano stretto: «Il non
cercai a nuddu (nessuno,ndr), furono iddi (loro, ndr) a cercare a mia (a
me, ndr)». Senza aggiungere altro, né spiegare il contesto. «Io sono stato 25
anni latitante in campagna - avrebbe riferito a Bonafede, come scritto
dall’agente nella relazione di servizio - senza che nessuno mi cercasse, come è
che sono responsabile di tutte queste cose? Nella strage di Capaci mi hanno
condannato con la motivazione che essendo il capo di Cosa Nostra non potevo non
sapere. Lei mi ci vede a confezionare la bomba di Falcone?». Poi il padrino
avrebbe aggiunto: «Brusca non ha fatto tutto da solo. Lì c’era la mano dei
servizi segreti. La stessa cosa vale anche per l’agenda del giudice Paolo
Borsellino. Perché non vanno da quello che aveva in mano la borsa e non si fanno
dire a chi ha consegnato l’agenda? In via D’Amelio c’entrano i servizi che si
trovano a Castello Utveggio e che dopo cinque minuti dall’attentato sono
scomparsi, ma subito si sono andati a prendere la borsa».
Bernardo Provenzano. Il padrino. L’ultimo
atto. Una lenta agonia di Stato Così si è spento Zu Binnu.
Ormai non riusciva più a nutrirsi e pesava solo 45 chili, scrive
Lu. Ro. su “Il Tempo” il 14 luglio 2016. Disteso sul letto, come morto, nel
reparto di medicina protetta dell’ospedale San Paolo nel carcere milanese di
Opera. I capelli lunghi e addosso il camice del nosocomio. Peso: 45 chili.
Incapace di muoversi, di interloquire, di capire cosa accadeva intorno a lui. E
anche di nutrirsi. A farlo ci pensava un sondino naso-gastrico, che andava non
più dal naso allo stomaco, ormai non funzionante, ma direttamente all’intestino.
In queste condizioni il boss dei boss Bernardo Provenzano ha abbandonato questo
mondo. È così che lo Stato italiano, dopo anni di dinieghi e inspiegabili prese
di posizione, alibi più o meno adattabili alle drammatiche circostanze e
spiegazioni inammissibili, ha voluto far morire Zu Binnu. Senza pietà. Senza
compassione. Senza umanità. Non sono bastate le battaglie del suo avvocato,
Rosalba Di Gregorio, a restituire un minimo di dignità umana a chi, certo, non
ne ha avuta; non è stato...
Lo stato confusionale di Provenzano.
Quando il boss perse la lucidità, scrive Riccardo Lo
Verso il 13 Luglio 2016 su “Live Sicilia”. Pensieri sconclusionati, frasi
incomplete, una sorta di balbettio scritto che lo porta a ripetere più volte una
parola, uno stato confusionale che si manifestava nel non sapere dove e perché
fosse detenuto. Le lettere che Bernardo Provenzano scriveva ai suoi familiari
sarebbero state la prova che il padrino corleonese negli ultimi tempi era
gravemente malato. “Delle due l'una: o siamo di fronte a un grande simulatore
oppure a un uomo gravemente malato e dissociato dalla realtà”, diceva i legale
di Provenzano, Rosalba Di Gregorio, che ha condotto una inutile battaglia per
ottenere un regime carcerario meno afflittivo. Erano i giorni in cui gli esami
diagnostici avevano evidenziato delle lacune cerebrali dovute a un'ischemia. Una
patologia che si aggiungeva al tumore alla prostata confermato dalle perizie. A
fare suonare il primo campanello d'allarme sulle condizioni di salute di
Provenzano era stata una lettera del 5 marzo 2001. Al di là dei limiti
grammaticali di una persona non scolarizzata, i ragionamenti erano lineari. Il
boss spiegava alla moglie di essere stato sottoposto ad alcune visite mediche.
In alcuni passaggi, però, si leggevano parole ripetute senza una logica: “Amore
mio carissimo. E figli Angelo e Paolo con gioia ho ricevuto la vostra lettera...
amore mio carissimo non ricopio a tutto quello che mi chiedi spero spero spero
con il tempo di spiegarti... amore mio mi dice se sò cosa anno scritto nel
diario diario non l'ho letto ma tu mi che ho avuto una eschemia, non so cosa
sia...” L'11 maggio Provenzano riprendeva carta e penna. Il destinatario era
ancora la moglie: “Oggi mercoledì 11 maggio. Amore mio ho ricevuto la tua
lettera. Amore mio grazie delle notizie che al ritorno che avete avuto un buon
viaggio. Amore mio mi dici che ero troppo sofferente e ne se addoloratissima.
Che cosa mi hanno fatto, se c'erano i dottori che mi hanno visitato, se mi hanno
cambiato le medicine Non lo so Amore mio vuoi sapere che sto Amore mio sento
stanco...”. A un certo punto il ragionamento si interrompeva e riprendeva con
una datazione diversa: “02-05-2001 tuo marito che ti pensa Amore mio e figli
Angelo e paolo carissimi smetto con la penna non con il cuore... - chi scrive
perde lucidità - che smetto con la presente e ne ricevo un'altra ricevuta ieri
giovedì di paolo, che con il volere di Dio iniziare quella che ho ricevuto dopo
da paolo e scritto te amore mio. Ora con piacere a rispondere in quella lunga
tua - e lascia il periodo tronco - Con quello che mi succede nel rispondere con
affetto segue i seguito...”. Il 23 maggio Provenzano sceglieva un telegramma per
comunicare con il fratello Salvatore. "Mio caro fratello e Figlio come state
padre e figli si unanomia si incoraggia essendo due. Io vi chedo scusa, e cioè
mi prometto di scrivervi e sorte no veglio chiare vi sforzano a emesso senza
scrivere e il mio pensiero s sforza e si vede la mia vecchiaia e aspetta oggi
aspetta domani ho ensato di scriverti ora smetto con la penna non con il cuore
augurandovi un mondo di bene per tutti vi benedica il signore che vi protegge vi
benedica il signore vi protegge”. Il 9 giugno 2001 Provenzano sembrava
smarrito: “Ma io sono qui da solo non so dove sono sono. Oggi c'è la
videconferenza non ci vado per scrivere e voi potete parlare con l'avvocato
dicci la nostra posizione ed chiedere per ottenere colloqui tra noi i mia moglie
e i mie figli Angelo paolo e mamma con lo sta bene con l'avvocato perché io sono
forse più malato di quello che vi dico”. Poi, fornisce il suo indirizzo ai
parenti come se mai prima d'ora non avesse ricevuto le loro lettere: “Ripeto se
potete parlati parlare con l'avvocato della mia posizione vi do il mio
indirizzo: Sono in via Burla numero n.53.L3:100 Parma. Con questo mi potete
scrivere mi potete venire attrovare ce possiamo parlare di presenza oppure uno
scritto dopo che avete parlato con l'avvocato così cerchiamo la serenità che ci
manca a tutti...”. Sempre a giugno Provenzano scriveva di nuovo. Forse era una
risposta alla moglie e ai figli che gli chiedevano cosa volesse portato al
prossimo colloquio. Il capomafia, invece, di rappresentare le sue esigenze, si
limitava a ricopiare il contenuto della lettera che ha ricevuto: “Avevo tue
amore mio mi dici che stai in pensiero la mia salute ma io ho pensieri per la
mia salute se ho capito bene e studiare e comprendere nella mia miseria...
Figlio mio mi addolora tanto con la desolazione e triste Figlio Angelo mi dici
scrivi tutto quello che capita e che succede Ho chiesto ho chiesto il foglio per
edere per il foglio per vedere per vedere cosa ti posso portare per il prossimo
colloquio qui scrivimi quello che posso portare Amore mio chiudi la lettera
augurandoti sempre di stare meglio”.
Provenzano è uscito dal carcere,
scrive Simona Musco il 13 luglio 2016 su "Il Dubbio". Il boss alla fine è morto.
Era in coma da anni ma restava al 41 bis. È già guerra sui funerali. «Qui non lo
vogliamo». Bernardo Provenzano era già morto. Lo era già due giorni fa quando,
ormai in coma, il giudice di sorveglianza di Milano 2 aveva respinto l’ennesima
istanza presentata dall’avvocato Rosalba Di Gregorio affinché il boss di Cosa
Nostra venisse scarcerato. Ma i suoi trascorsi criminali e il valore simbolico
del suo percorso all’interno della mafia, per il giudice, lo avrebbero esposto
ad «eventuali “rappresaglie” connesse al suo percorso criminale, ai moltissimi
omicidi volontari dei quali è stato riconosciuto colpevole, al sodalizio
malavitoso» del quale era a capo. Provenzano è così rimasto al 41 bis, senza che
moglie e figli potessero salutarlo. Il figlio Angelo, lunedì scorso, aveva fatto
richiesta di un permesso straordinario, che gli era stato negato. Ed è arrivato
proprio ieri, dopo la morte del padre. «I veri detenuti al 41 bis sono i parenti
– denuncia ora la Di Gregorio -, il regime di restrizione è stato applicato ai
figli e alla moglie impedendogli di poterlo vedere». Le condizioni di Provenzano
si sono aggravate venerdì, quando a causa di un’infezione polmonare è entrato in
coma irreversibile. Ma il carcere duro, ha dichiarato Roberto Piscitello,
direttore generale dei detenuti e del trattamento del ministero della giustizia,
«in nulla ha aggravato lo stato di salute di Provenzano: anzi nei due ospedali
in cui è stato ha ricevuto cure puntuali ed efficaci». Negli ultimi anni,
l’avvocato Di Gregorio ha presentato tre istanze di revoca del carcere duro e
tre di sospensione dell’esecuzione della pena. Alle prime avevano dato parere
favorevole le Procure di Palermo, Firenze e Caltanissetta, ma si sono incagliate
poi nel parere della Direzione nazionale antimafia. Diverse perizie, nel corso
del tempo, hanno confermato la gravità delle sue condizioni: non era più
ricettivo, incapace, dunque, di comandare e inviare messaggi. Il 12 maggio del
2012 le videocamere del carcere di Parma lo avevano immortalato nella sua cella
intento a infilarsi un sacchetto in testa. Non un tentativo di suicidio, secondo
i suoi legali, bensì i segni che non ci stava più con la testa. A dicembre dello
stesso anno cadde riportando un ematoma al cervello. Entrato in coma e operato,
non si è più ripreso. Il gip lo ha anche dichiarato incapace di prendere parte
in maniera cosciente al processo sulla trattativa Stato-mafia. Le patologie di
cui soffriva sono state definite dai «plurime e gravi di tipo invalidante». Non
parlava più, faticava a muoversi. Ma la giustizia italiana non ha ceduto di un
millimetro. Così, nel 2013, la famiglia si era rivolta alla Corte europea dei
diritto dell’uomo, denunciando l’incompatibilità del suo stato di salute col
regime del 41 bis. A gennaio 2015, il Tribunale di sorveglianza di Roma
confermava l’esigenza di trattenerlo lì per questioni di sicurezza pubblica,
«sussistendo il pericolo di continuità di relazioni criminali» con Cosa Nostra.
A settembre, invece, la Cassazione giustificava il carcere duro proprio con la
necessità di assicurargli cure adeguate. Il figlio Angelo, nominato curatore
speciale del padre, tempo fa aveva anche rilasciato un’intervista shock: «anche
un pluriergastolano ha diritto di essere trattato come un essere umano – aveva
detto a Repubblica -. Se poi l’esistenza di mio padre dà fastidio, qualcuno
abbia il coraggio di chiedere la pena di morte, anche ad personam». Ma era già
morto, ribadisce la Di Gregorio, che ha appreso della morte del boss mentre era
in aula a Caltanissetta per il Borsellino quater, tramite un sms inviatole
proprio da Angelo. Lo era dal momento «in cui è caduto ed è stato operato al
cervello. Era un vegetale. Le sue condizioni di salute si erano aggravate da
circa 4 anni. Non aveva più reazioni di nessun genere». Intanto il pg di
Palermo, Nico Gozzo, è intervenuto a muso duro: lo Stato, polemizza sul suo
profilo Facebook, avrebbe potuto far sentire «la differenza tra uno stato di
diritto» e «le belve di Cosa Nostra, che le regole le fanno solo a loro uso e
consumo, calpestando sempre la vita umana. Ed invece si è voluto continuare ad
applicare il 41 bis ad un uomo già morto cerebralmente, da tempo. Con ciò
facendo nascere l’idea, in alcuni, che la giustizia possa essere confusa con la
vendetta. O che il diritto non è uguale per tutti. E ciò, per me, è
inaccettabile». Il senatore Pd Giuseppe Lumia, componente della commissione
antimafia, ha invece chiesto di evitare «sontuosi funerali» nella sua città,
Corleone, per evitare di trasformare il boss in un mito. Ma il sindaco Lea
Savona ha messo le mani avanti: «Oggi si celebra il nostro 25 aprile. Mi opporrò
alla possibilità che si celebrino qui i funerali».
Era morto ma loro non lo sapevano,
scrive Tiziana Maiolo il 13 luglio 2016 su "Il Dubbio". Hanno voluto vederlo
morto in ceppi, quel corpo ormai da tempo senz’anima e senza vita, e così è
stato. Non era certo Bernardo Provenzano quell’essere ridotto a vita vegetativa
il cui cuore si è fermato ieri mattina in una cella dell’ospedale San Paolo,
quartiere Barona di Milano. Pure quel corpo, che non ragionava e non parlava,
non si muoveva e non si nutriva, che quotidianamente veniva ripulito,
riposizionato nel letto e nutrito con il sondino naso-gastrico. Quel corpo
“viveva” nel regime carcerario dell’articolo 41-bis, quello applicato ai mafiosi
più pericolosi. Che sia stato un capomafia tra i più pericolosi, Bernardo
Provenzano, quello vero, arrestato dieci anni fa dopo quasi mezzo secolo di
latitanza, non c’è dubbio. Insieme al suo socio Totò Riina è stato protagonista
della più sanguinosa stagione delle stragi culminata nel 1992 con le uccisioni
dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ma erano altri tempi e altri
personaggi. E paradossalmente chi oggi piangerà (oltre ai familiari) la
scomparsa di “quel” Provenzano, saranno gli orfani, magistrati e qualche
giornalista, di quella bislacca teoria della “trattativa Stato-mafia” che ormai
langue sconfitta dal punto di vista processuale. Erano proprio questi orfani del
complotto a cercar di tenere in vita quel corpo in cui vita non albergava più da
tempo, nella vana speranza di poterlo trascinare, prima o poi (ma ormai la sua
posizione era stata sensatamente stralciata dal processo) a rivelare segreti
inconfessabili e quasi certamente inesistenti. Invano nei mesi scorsi la
famiglia aveva cercato di far liberare “il corpo” dai ceppi dell’art. 41bis per
poterlo trasferire in un reparto di lungodegenza dell’ospedale. Si era trovata
davanti un muro, composto di magistrati di un po’ tutte le città italiane che
avevano processato Provenzano e dalla stessa cassazione, cui si era aggiunto, un
po’ sorprendentemente, lo stesso ministro guardasigilli Orlando, che si era
spinto a interpretazioni sociologiche: “Seppur ristretto dal 2006 Provenzano è
tuttora costantemente destinatario di varie missive dal contenuto ermetico. Cui
spesso sono allegate immagini religiose e preghiere, che ben possono celare
messaggi con la consorteria mafiosa”. Era il 24 marzo scorso. Pochi giorni dopo,
incuriositi e increduli, siamo andati all’ospedale San Paolo di Milano, dove “il
corpo” era custodito in un reparto speciale, sorvegliato all’interno da tre
agenti di polizia penitenziaria e all’esterno da 28 poliziotti che si
alternavano intorno al perimetro dell’ospedale. Avevamo incontrato il primario
del reparto, il professor Rodolfo Casati, colui che meglio conosceva le gravi
patologie cui era affetto quel detenuto così speciale. “Provenzano – ci aveva
detto – non è in grado di mettere insieme soggetto predicato e complemento,
borbotta qualche suono senza senso”. Che cosa ha esattamente? “Ha avuto ripetute
lesioni cerebrali, è stato operato per due episodi di emorragia, inoltre è
affetto dal morbo di Parkinson”. Ma dice qualche parola comprensibile? “A volte
pronuncia mmmm, che sembra quasi mamma”. Queste cose il professor Casati le ha
scritte in decine di relazioni, spedite nei vari tribunali d’Italia, in
cassazione, al ministro. Erano considerazioni tecniche, da medico. Ma forse
politicamente scorrette. Quindi inascoltate. Tanto che si è preferito custodire
“il corpo” dandogli il rango di pericoloso capomafia al 41bis piuttosto che
compiere un normale gesto di umanità e ammettere di aver perso per strada un
altro protagonista della vagheggiata “trattativa Stato-mafia”.
«Quando hanno aperto la cella...», scrive Piero
Sansonetti il 14 luglio 2016 su "Il Dubbio". Ve la ricordate quella canzone
struggente di Fabrizio de André? «Quando hanno aperto la cella / era già tardi
perché / con una corda sul collo / freddo pendeva Michè…». Altri tempi,
naturalmente. Non esisteva ancora il “justicially correct” e qualcuno dedicava
le canzoni anche ai delinquenti. De André lo faceva spesso. Era un tipaccio De
André. Figuratevi che perdonò persino i suoi rapitori e si rifiutò di accusarli
in tribunale. Comunque Miché era un delinquente simpatico. Aveva ucciso per
amore di Maria. Provenzano no: è stato un assassino matricolato, feroce, ha
devastato la Sicilia, ha seminato morte per 45 anni. Il problema è che l’
“umanità - il senso dell’umanità, che è uno dei pilastri, forse il più grande
pilastro della civiltà e della modernità, e che è un sentimento, l’unico,
espressamente previsto dalla nostra Costituzione - non si applica solo alle
persone perbene, o a quelli che ci stanno simpatiche, ma a tutti. La forza della
civiltà è lì: nell’umanità e nella cancellazione della categoria della vendetta.
Quando la vendetta diventa il carburante (o addirittura lo scopo) della
giustizia, la civiltà scivola via e scompare. Provenzano da molti anni era in
stato semi-comatoso e poi comatoso. Applicare a lui le misure del 41 bis
(concepite, ufficialmente, per ragioni di sicurezza e non di punizione) è stata
una scelta illogica, illegale e crudele. La crudeltà è crudeltà e basta: che la
si applichi ad Abele o a Caino, non cambia. Nei giorni scorsi il sottosegretario
alla giustizia, Gennaro Migliore, è stato crocifisso (dal “Fatto Quotidiano”)
perché aveva ricordato il senso del 41 bis e aveva spiegato che secondo lui deve
essere corretto, mitigato, in modo che resti una misura di sicurezza e non di
vendetta. Non si è alzata una voce a difesa di Migliore, né dal mondo politico
né da quello del giornalismo e dell’intellettualità. Qualche giorno dopo il
“Fatto” è tornato sull’argomento per farcii sapere che aveva avuto notizia di un
barattolo di miele entrato proditoriamente in una cella di 41 bis, e per
esprimere sdegno verso questa “mollezza”! E’ normale che esista una parte della
società (e anche dell’intellettualità e della classe dirigente) che tra
modernità e giustizialismo sceglie il giustizialismo. Non è normale che non
esista una parte delle classi dirigenti che si oppone al giustizialismo,
apertamente, senza nascondersi. Oggi, se volete rivolgervi a una autorità morale
(e politica) che contrasta la ferocia e chiede civiltà, avete una sola
possibilità: chiedere udienza al papa.
Ingroia: «Fu cerniera tra Stato e Cosa
nostra. Ma il suo 41bis era un accanimento», scrive
Giulia Merlo il 13 luglio 2016 su "Il Dubbio". L’ho incontrato in carcere e mi è
sembrato quasi impaurito e poco sicuro di sé, a differenza dell’immagine di lui
che si dava. Era però già vecchio, debole e fragile. L’ex procuratore di Palermo
Antonio Ingroia e Bernardo Provenzano. Uno è il pm che gettò le basi per
l’inchiesta sulla trattativa Stato-Mafia, l’altro il capo di Cosa Nostra e
presunto ingranaggio della trattativa. I due si sono incontrati nel carcere dove
Provenzano ha passato in regime di 41bis gli ultimi dieci anni, e Ingroia lo ha
definito «un uomo dell’altro Stato», riconoscendo però che il carcere duro nei
suoi confronti è stato un «accanimento superfluo».
Cosa intende con la definizione di «uomo
dell’altro Stato»?
«Lo Stato non è
un blocco monolitico. Ha una faccia pulita, che è quella di tutti gli uomini e
le donne che sono caduti per difenderlo, come i giudici Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino. Esiste però anche una faccia cupa, fatta dei visi dei molti che
hanno “trescato”, conducendo trattative di cui la mafia è stata parte. Non mi
riferisco solo a quella tra Stato e mafia, ce ne sono state molte altre. Penso
ad esempio allo sbarco degli Alleati nella Seconda Guerra Mondiale, in cui la
mafia è stata un soggetto attivo».
E con questo Provenzano cosa c’entra?
«Lui è stato
uno degli uomini-cerniera di questa trattativa. Provenzano ha passato la vita a
difendere e proteggere gli interessi della mafia ma anche quelli di questo altro
Stato. E lo ha fatto fino alla morte, non rivelando nessuno dei segreti su cui
molte inchieste hanno provato a far luce».
Quando lo ha conosciuto, Provenzano era già
sottoposto al regime del 41bis, che non gli è stato revocato nemmeno negli
ultimi anni di vita, quando era malato. Ha condiviso questa scelta?
«Oggi tutti,
con il senno di poi, diranno che la misura fosse irragionevole. Io lo dissi in
tempi non sospetti e mi sono già preso molte critiche da parte dei paladini
dell’antimafia. Anch’io mi considero un militante dell’antimafia, eppure credo
che il regime di carcere duro sia stato eccessivo e sconsigliabile, anche per
chi viene considerato il peggiore tra i boss mafiosi. Io ho conosciuto
Provenzano quando era già vecchio e malato e penso che il 41bis sia stato un
accanimento superfluo nei suoi confronti».
Che impressione le ha fatto quando lo ha
incontrato?
«Ricordo di
aver pensato che era un uomo diverso dal “zu’ Binnu u Tratturi” di cui si
raccontavano i feroci assassinii. L’ho incontrato in carcere e mi è sembrato
quasi impaurito e poco sicuro di sé, a differenza dell’immagine di lui che si
dava. Era però già vecchio, debole e fragile. Durante l’interrogatorio, mi è
anche sembrato di leggere in lui un conflitto interno, un’indecisione profonda».
Indecisione su che cosa?
«Mi sembrava
indeciso sull’ipotesi di voltare pagina, aprendo un dialogo con l’altro Stato,
quello pulito di cui dicevo prima, oppure rimanere coerente con se stesso e
rimanere in silenzio. Alla fine è rimasto fedele, oppure è stato indotto in
qualche modo a rimanere fedele alla mafia e ha portando con sé i segreti di Cosa
Nostra e quelli del doppio Stato».
“Zu Binnu” si arrese per 2 milioni di
euro, scrive Rocco Vazzana il 13 luglio 2016 su "Il
Dubbio". L’intermediario all’Antimafia mise subito in chiaro le cose: per
consegnarsi, il boss voleva una buona uscita e un mese di “silenzio” dal momento
dell’arresto. A Roma, via Giulia, sede della Direzione nazionale antimafia. Un
uomo varca il portone della Superprocura accompagnato dalla Guardia di Finanza.
È il novembre del 2003 e vuole parlare con Pier Luigi Vigna, il capo della Dna.
Si chiama Vittorio Crescentini, è un faccendiere, e dice di avere notizie
importanti da riferire. Ma non si presenta davanti ai magistrati in veste di
informatore, come pure era capitato in altre occasioni, questa volta dice di
essere un mediatore, un messaggero per conto di Bernardo Provenzano. Ma l’uomo
pone subito una condizione: non dirà neanche una parola in presenza di
magistrati siciliani. Vigna accetta di ascoltarlo e chiede ai sostituti Vincenzo
Macrì e Alberto Cisterna, entrambi calabresi, di assistere al colloquio
investigativo. Provenzano è latitante da più di 40 anni, e adesso, vecchio e
stanco, vorrebbe aprire «un tavolo di accomodamento» per trattare la resa.
Perché un capo, anche se non più operativo, non si arrende incondizionatamente.
E l’intermediario arrivato in Via Giulia mette subito in chiaro le cose: per
consegnarsi, il boss pretende una buona uscita da due milioni di euro e un mese
di riserbo dal momento dell’arresto. Un periodo di tempo utile a fornire
elementi investigativi agli inquirenti lontano dal clamore mediatico. Gli
inquirenti lo ascoltano con attenzione, sono convinti che Crescentini non sia un
millantatore, perché se qualcuno si presenta in Dna dicendo di avere notizie su
Provenzano non può essere un impostore, è la convinzione dei magistrati. Il
faccendiere, poi, fornisce anche qualche elemento sulla latitanza del ricercato
numero uno: sarebbe nascosto nel Lazio, in un luogo non meglio definito. Per
Pier Luigi Vigna la cattura di Provenzano sarebbe la ciliegina sulla torta di
una carriere già brillante. Nel 2003 il capo dell’Antimafia è a un passo dalla
pensione e non vorrebbe lasciarsi sfuggire l’occasione di chiudere col botto. Ma
prima deve superare l’ostacolo più grosso: la richiesta di denaro. La palla deve
passare ad altre autorità, bisogna informare subito il ministero dell’Interno
della faccenda. «Mi pare di ricordare che Vigna disse che avrebbe informato il
ministero dell’Interno e per correttezza anche il procuratore della Repubblica
di Palermo (che all’epoca era Piero Grasso, l’attuale presidente del Senato,
ndr) », racconterà quasi dieci anni dopo Vincenzo Macrì, uno dei magistrati
presenti agli incontri con il mediatore. «Non era compito del nostro ufficio
stabilire tempi e modi di un eventuale accordo. Non so con chi parlò Vigna. So
che allora il capo del Sismi era Niccolò Pollari. E che i Servizi segreti
diedero la loro disponibilità in linea di massima a reperire il denaro». La
trattativa, dunque, si complica. Il faccendiere dice che si rifarà vivo ma
passano altri otto mesi senza ricevere più notizie del boss. Vittorio
Crescentini ritorna in Via Giulia nel luglio del 2004, pochi giorni prima del
71esimo compleanno di Pier Luigi Vigna, che festeggerà il primo agosto. Il
secondo colloquio investigativo si conclude come il primo. È ancora un incontro
interlocutorio, il messaggero non fa altro che confermare le richieste già
avanzate prima, ma aggiunge un elemento: incontrare il boss è diventato più
complicato anche per lui. Scopriremo solo dopo che in quel periodo il latitante
corleonese non godeva di ottima salute, tanto da essere sottoposto a un
intervento chirurgico in un ospedale di Marsiglia, come documentato nel 2005
dalla procura di Palermo. Ma 71 anni, per Vigna, non sono solo candeline da
spegnere su una torna, significano anche un’altra ricorrenza più amara: la
pensione. E nonostante una legge ad hoc (in realtà concepita per impedire a Gian
Carlo Caselli di andare alle guida della Dna) conceda a Procuratore nazionale un
anno di proroga, fino al primo agosto del 2005, Vigna non riuscirà a portare a
termine l’arresto. L’ultimo colloquio investigativo accertato con Vittorio
Crescentini, infatti, risale al novembre del 2005. Alla Direzione nazionale
antimafia c’è un nuovo capo: Piero Grasso, appena arrivato da Palermo. Spetta a
lui gestire l’ultimo contatto con l’uomo che dice di essere stato delegato da
Provenzano. Il nuovo procuratore chiede a Macrì e Cisterna, i due pm che avevano
già seguito il caso, di partecipare all’incontro. Ma Grasso, a differenza del
suo predecessore, non si fida molto del faccendiere, è convinto che sia un
«millantatore». E chiede all’intermediario di fornire una prova biologica del
boss latitante, come racconterà anni dopo il magistrato siciliano nel corso di
un’audizione al Csm: «Quando ero procuratore a Palermo, avevamo fatto
un’indagine sulla presenza di Provenzano a Marsiglia», spiega Grasso. «Eravamo
riusciti a ottenere un frammento di un reperto medico sanitario». In altre
parole, i magistrati avevano in mano il dna del boss corleonese. «Quindi essendo
in possesso di quel reperto, a colui che diceva di essere in contatto con il
latitante Provenzano, dissi di farci avere qualcosa - un fazzoletto, un
bicchiere, un qualcosa... Insomma, non potendo catturare tutto il latitante ne
avevamo catturato un pezzetto. Per quanto ne so questo è l’ultimo incontro con
l’intermediario». Il boss, ancora tutto intero, sarà catturato pochi mesi dopo,
nel marzo del 2006, dal procuratore di Palermo Giuseppe Pignatone e dal capo
della Squadra mobile Renato Cortese.
Il questore del blitz: «Così ho catturato
Bernardo Provenzano», scrive Vincenzo R. Spagnolo il
13 luglio 2016 su "Avvenire”. Con la morte, oggi, di Bernardo Provenzano, esce
di scena uno dei capi mafia più temuti e sanguinari. Quando venne arrestato,
l'11 aprile 2006, Due giorni dopo, il 13 aprile su Avvenire comparve questa
intervista al vicequestore aggiunto di Polizia, Renato Cortese. «Quando ho
incrociato il suo sguardo sorpreso, sono stato certo. Per anni ho avuto il suo
volto davanti negli identikit. Ha provato a chiudere la porta a vetri, ma io e
il resto della squadra l'abbiamo sfondata. Allora ha abbassato le braccia,
sussurrando: non sapete l'errore che state commettendo». È l'epilogo della
caccia, raccontato dall'uomo che dal 1998 l'aveva condotta in silenzio, ombra
fra le ombre, sulle tracce del capo di Cosa nostra. Il «cacciatore» è il
vicequestore aggiunto di Polizia, Renato Cortese, a capo della squadra di 30
poliziotti del Servizio centrale operativo e della Mobile palermitana,
incaricati di stanare Provenzano. Hanno passato 8 anni sulle orme del fantasma
di "Binnu u tratturi", pedinando familiari, affiliati e postini. Mancandolo per
un soffio più volte, come nel 2001 nelle campagne di Mezzojuso («Sapevamo che
nel casale c'era un malato di prostata: pensavamo a lui e invece trovammo
Benedetto Spera»), fino a martedì, quando lo spettro si è materializzato e gli
«acchiappafantasmi» della Polizia gli hanno messo le manette. Cortese ha la
barba scura e i capelli ricci come i suoi avi della Calabria magnogreca, ha 42
anni (lo "zu Binnu" era già uccel di bosco un anno prima che nascesse), ma di
boss ne ha scovati altri: da Brusca a Spatola, da Vitale ad Aglieri, la cui
cattura gli valse una promozione per meriti straordinari. Ora forse gliene
toccherà un'altra: «Non so - sorride -. Piuttosto, ci ha fatto piacere la
valanga di attestati di stima che sta giungendo in questura a Palermo. Non
eravamo abituati. In una e-mail c'era scritto: magnifici sbirri! Già. E ci ha
colpito l'accoglienza riservata dalla folla a Provenzano: fischi e epiteti che
mostrano che il sentimento della gente comune sta cambiando, che la mafia è
vista come il Male e non come un potere a cui appoggiarsi. La rinascita dovrà
fare i conti con l'altra Sicilia, quella dell'omertà: Provenzano lo avete
trovato a Corleone, a pochi chilometri da casa».
Dov'era stato in questi 43 anni?
«A parte il viaggio per le cure a Marsiglia, quasi
sempre in Sicilia. Per i boss, è regola fondamentale mantenere il contatto col
territorio. Spostarsi dalla propria terra è un segno di debolezza che un capo
come Provenzano non poteva mostrare».
Per il procuratore Piero Grasso, le indagini
hanno rivelato una vasta rete di coperture, a livello mafioso, imprenditoriale,
politico...
«È stata una lunga investigazione, con molti
filoni, che speriamo conducano presto ad altri risultati».
Quando siete stati certi che in quel casolare
c'era lui?
«Da mercoledì 5 aprile avevamo messo gli occhi su
quella masseria. La catena di "postini" sorvegliati ci aveva portato lì. Ma
poteva anche essere disabitata: nessuno usciva fuori. Abbiamo sorvegliato a
distanza con microtelecamere, aspettando gli eventi. Una settimana dopo, il
blitz».
Perché solo allora?
«Perché martedì 11, prima delle 9, qualcuno ha
messo fuori un sacchetto bianco: una conferma che il casale era abitato. E
alle 10 è arrivato un uomo a noi noto, con un pacco per l'inquilino misterioso.
Allora ho fatto scendere un furgone con 20 uomini. E siamo entrati dentro».
Dopo, qual è stato il suo primo pensiero?
«Ho pensato che era andata bene, che potevamo
mandare in archivio 8 anni di lavoro duro, notte e giorno, senza riposi né
ferie. Ho pensato ai miei uomini, ai sacrifici imposti a noi stessi e alle
famiglie per arrivare al risultato. E poi ho pensato anche ad altri: a
poliziotti di altissimo valore che lavorarono alla Mobile di Palermo: uomini
come Boris Giuliano, Beppe Montana, Ninni Cassarà e altri ancora. La mafia li ha
uccisi, è vero, ma ignora che la loro eredità si respira ogni giorno nei nostri
uffici. Ecco, questa vittoria dello Stato non è solo nostra. Appartiene anche a
loro».
La pm che lo fece catturare “Dopo
l’arresto ci minacciò”. Il magistrato Sabella: sono
tanti i segreti che non ha svelato, scrive Guido Ruotolo il 14/07/2016 su "La
Stampa".
Marzia Sabella, lei è stata uno dei pm della
Procura di Palermo - insieme all’allora aggiunto Giuseppe Pignatone e al pm
Michele Prestipino - a coordinare le indagini del pool di poliziotti guidati da
Renato Cortese, per la cattura di Bernardo Provenzano, ’u tratturi. Chi era
Provenzano?
«Come direbbe Wikipedia, “Provenzano era un
criminale italiano”. Aggiungo che era un criminale latitante da 43 anni, cioè
uno smacco alle leggi dello Stato che ogni giorno ci sforziamo di applicare».
Quando erano latitanti, i due Corleonesi
eccellenti, Totò Riina passava per il macellaio e zu’ Binnu Provenzano per
l’intellettuale, il mediatore, l’ambasciatore. I pentiti ma anche le indagini ci
hanno consegnato in realtà i ritratti di due veri mafiosi con personalità
diverse. Corresponsabili delle carneficine e mattanze.
«Ecco, era una questione di personalità diverse.
Ma probabilmente anche una questione strategica: un tempo, per rendere proficui
gli interrogatori ci si serviva di due figure, lo “sbirro” buono e quello
cattivo. Per il resto, come riferito da tanti collaboratori, “erano la stessa
cosa”».
Ambedue le catture, Provenzano e Riina, sono state
accompagnate da un alone di mistero. Addirittura si sono fatti processi con
ufficiali dell’Arma dei carabinieri sul banco degli imputati, per la mancata
cattura di Provenzano.
«Non abbiamo ancora una ricostruzione giudiziaria
definitiva. Aspettiamo di conoscerla. Per le indagini più recenti che hanno
portato alla sua cattura invece non vi sono misteri ma fasi investigative
tracciabili minuto per minuto. Mi piace sottolinearlo perché ogni tanto ci si
diverte a dare letture alternative».
Ha mai avuto sentore che Provenzano avesse avuto
contatti, rapporti con pezzi dello Stato?
«La storia di quegli anni va ancora scritta o
forse va riscritta. Ma quel “sentore”, che certo ho avuto, per il magistrato è
solo uno spunto investigativo. Poi ci vogliono le prove. E chi le prove vuole
cercarle e chi le vuole far trovare».
Con la morte di Provenzano si è chiusa una
stagione? Insomma cosa è diventata oggi Cosa nostra?
«La stagione di Provenzano non si è chiusa con la
sua morte, ma con il suo arresto: la fine della sua latitanza ha azzerato il
“vantaggio” rispetto a Totò Riina che era e rimane, almeno formalmente, il capo
della commissione. Ma Cosa nostra resta Cosa nostra, con i suoi alti e bassi,
con le perdite e i guadagni, con il mutamento di uomini e di strategie, con la
sua capacità di adattarsi alle stagioni e soprattutto con il suo talento
speculativo d’avanguardia. Bisogna chiedersi piuttosto se negli ultimi anni
abbiamo saputo leggere questo cambiamento, peraltro fisiologico, o se abbiamo
scambiato l’integrazione sociale della mafia, che è la sua più pericolosa
peculiarità, con la sconfitta della mafia».
Nel libro che ha scritto con la giornalista Serena
Uccello («Nostro Onore») lei racconta il dietro le quinte del lavoro di pm a
Palermo. «Solo dopo averlo visto con i miei occhi - scrive - mi sono convinta
che l’avevamo preso veramente (Provenzano, ndr)». Il suo lavoro come quello
degli investigatori spesso è anche tanta fatica e sudore. Ne è valsa la pena?
«Mi scordo sempre di fare bilanci tra la fatica
personale e il risultato delle indagini. Un lavoro si porta avanti comunque,
anche quando il traguardo non è la cattura di un noto latitante che porta il tuo
nome sui giornali. Semmai il confronto va fatto tra l’impegno dello Stato, anche
in termini di costi, e la cattura. Ed è certo che, in tal caso, ne è valsa la
pena nonostante Provenzano, quell’11 aprile, ci avesse detto che non sapevamo
quello che stavamo facendo, forse alludendo a conseguenze negative per il Paese
dalla prossima riorganizzazione di Cosa nostra».
L’ex procuratore Piero Grasso dice che Provenzano
porta con sé tanti misteri. D’accordo? Quali quelli che avrebbe voluto
conoscere?
«Certo che sono d’accordo. Sono d’accordo anche
con il “tanti” perché, appunto, sono molteplici, ma non sono tutti quelli che ci
servirebbero e che oltrepassano la storia di Provenzano. Non saprei scegliere
tra i misteri che avrei voluto conoscere. Se ce li avesse elencati uno per uno
oggi saremmo a buon punto».
Così i picciotti di Corleone diventarono
boss, scrive Paolo Delgado il 13 luglio 2016 su "Il
Dubbio". Bernardo Provenzano è morto ieri in regime di carcere duro, ai sensi
dell’art. 41bis, quello che nel mondo viene considerato senza mezzi termini
tortura. Era entrato in carcere nel 2006, dopo 43 anni di latitanza. Da un anno
sopravviveva in stato vegetativo. Con tutta la sua ferocia e i suoi crimini, non
avergli permesso di morire in un carcere normale copre di vergogna lo Stato
italiano. Tra i contadini di Corleone diventati imperatori di Cosa nostra,
Bernardo Provenzano è il più enigmatico. Era uomo di mano e di pistola,
soprannominato Binnu u tratturi perché «tratturava tutto e dove passava lui non
cresceva più l’erba», come da descrizione di Antonino Calderone, fratello del
capomafia di Catania Pippo, uno dei tanti fatti ammazzare dai corleonesi. Però
era anche "il ragioniere", perché il suo governo di Cosa nostra è stato mite a
paragone della ferrea dittatura esercitata dai compaesani Totò u Curtu Riina e
Leloluca "Luchino" Bagarella. Di Riina Binnu è stato sempre il compare più
fidato, eppure proprio su di lui ha sempre aleggiato il sospetto di aver dato
una mano a chiudere la carriera criminale dell’onnipotente zu’ Totò. Non per
sete di potere ma per mettere fine alla guerra senza prigionieri che il capo dei
capi aveva dichiarato allo Stato e dalla quale Cosa nostra rischiava di uscire
distrutta. Per caso o per calcolo, è un fatto che quella guerra Provenzano
scelse di non combatterla, recuperando l’uso antico della mafia siciliana:
scivolare sott’acqua e rendersi invisibile quando la tempesta infuria. Biografie
identiche quelle di Provenzano, Riina e dei fratelli Bagarella. Tutti di
Corleone, poverissimi, figli di famiglie contadine nella miseria del dopoguerra
siciliano, viddani cresciuti con la puzza della fame addosso. Amici sin
dall’infanzia, complici sin dai primi crimini. Erano l’ultimo gradino di Cosa
nostra, un altro universo rispetto all’aristocrazia mafiosa dei Bontade di
Palermo, "principi di Villagrazia", o del corleonese don Michele Navarra, tanto
potente da essere soprannominato "u patri nostru", grande elettore dei notabili
Dc dell’epoca incluso Bernardo Mattarella, padre dell’attuale capo dello Stato.
I futuri corleonesi erano manovalanza. Picciotti reclutati e combinati mafiosi
da Luciano Leggio, campiere e braccio destro di Navarra, per occuparsi dei
lavori sporchi e sanguinosi. Non avevano amicizie potenti tra i politici. Nella
rete di alleanze famigliari e territoriali che costella e sostanzia la mappa di
Cosa nostra neppure comparivano. Le sole risorse di cui disponessero erano la
ferocia e la determinazione, figlie entrambe della fame. Se c’è un giorno che
segna il passaggio dalla mafia tradizionale alla moderna Cosa nostra è il 2
agosto 1958, quando un autocarro bloccò in una strada di campagna la 1100 sulla
quale viaggiavano u patri nostru con un giovane collega e i viddani di Leggio
trucidano il potente boss con 92 colpi. Senza chiedere il permesso a nessun
padrino. Incuranti dell’alto lignaggio mafioso della vittima e delle liturgie di
Cosa nostra. Contando solo sulla forza e sulla potenza implicita nel fatto
compiuto. L’uccisione di Navarra registra un modus operandi che i contadini di
Corleone adopereranno più volte nei decenni seguenti: disprezzo per le regole
mafiose, rapidità e spietatezza nel colpire, ferocia nello sterminare i nemici.
La leggenda vuole che all’uccisione del dottore sia seguita una strage con
almeno un centinaio di cadaveri. Le vittime della purga furono in realtà molte
di meno, ma il metodo era davvero quello: niente prigionieri. Nel 1963
Provenzano fu denunciato per l’omicidio di uno degli ultimi fedeli di Navarra.
Scelse di darsi latitante e tale sarebbe rimasto per i successivi 43 anni.
Ancora più di Riina, Binnu era uomo d’armi, considerato più per le doti
guerresche che per quelle diplomatiche o strategiche. Quando nel 1969 la
"commissione" decise di eliminare il boss che aveva innescato la prima guerra di
mafia negli anni ‘60, Michele Cavataio, nascostosi a Milano, ogni capo indicò
uno o più killer. Leggio spedì Provenzano e Calogero Bagarella, fratello
maggiore di Leoluca e Ninetta, fidanzata e poi moglie di Riina. Arrivarono in
via Lazio, dove si rifugiava la vittima, travestiti da poliziotti. Cavataio
mangiò la foglia. Era un osso durissimo: pur colpito ferì a morte Bagarella, se
la pistola non si fosse inceppata avrebbe eliminato anche Provenzano. Anche il
mitra di Binnu si inceppò subito dopo. Provenzano non si fermò per questo.
Strappò di mano a Cavataio la pistola, lo abbattè colpendolo col calcio della
stessa. Il soprannome u tratturi se lo guadagnò lì. I corleonesi si erano
ritagliati il loro posto nelle gerarchie di Cosa nostra, ma pur sempre di bassa
forza si trattava. Quando nei ‘70, grazie all’eroina, i soldi iniziarono a
diluviare sulle famiglie siciliane, i viddani dovettero accontentarsi delle
briciole. A chi gli proponeva di eliminare Riina, diventato capo dei coleonesi
dopo l’arresto di Leggio, Stefano Bontade, capo della famiglia di Santa Maria
del Gesù, la più potente di Palermo, rispondeva con noncuranza: «Ma no, lascialo
correre, tanto sempre da qui deve passare: è viddanu». Bontade, detto "il
Falco", era il figlio di don Paolino Bontà, uno che prendeva pubblicamente a
schiaffoni i politici poco solerti nell’obbedire. Aveva amicizie potentissime,
un esercito ai suoi ordini, alleati quasi altrettanto potenti come Totuccio
Inzerillo, cugino dei Gambino di New York. Riina e Provenzano lo fecero
ammazzare la notte del 23 aprile 1981 inaugurando per la prima volta l’uso del
Kalashnikov nell’isola. Bissarono meno di un mese dopo, adoperando la stessa
arma per eliminare Inzerillo nonostante la protezione dei Gambino. La cosiddetta
"seconda guerra di mafia", che cominciò con quelle raffiche di mitra, fu in
realtà una mattanza a senso unico, il massacro di chiunque fosse considerato un
nemico dai corleonesi. I grandi pentiti come Buscetta hanno sempre sostenuto che
Cosa nostra è morta allora. Non hanno tutti i torti. La mafia siciliana, a modo
suo, era sempre stata una democrazia. Nessuno aveva mai preteso di essere "capo
dei capi". Il rigido rispetto delle regole era una favola, ma l’idea che persino
i mafiosi dovessero adeguarsi a un codice c’era. Riina e Provenzano non
conoscevano altro codice che il loro potere, la loro fu una dittatura tra le più
spietate. Con lo Stato Totò u Curtu adoperò gli stessi mezzi che gli avevano
assicurato l’impero su Cosa nostra. Ammazzò magistrati e poliziotti, provocò
stragi, seminò terrore. Conosceva solo la forza, e con la forza tentò di
costringere lo Stato a trattare. Uscito di scena lui, con l’arresto nel gennaio
1993, il cognato Bagarella decise di seguire la stessa strada. Provenzano no, e
anche per questo riuscì a restare libero per 13 anni dopo la cattura di Riina,
dominando con i suoi "pizzini", discretamente, senza spargere troppo sangue. Con
gli anni, il sanguinario viddano morto ieri era diventato, a modo suo, un
mafioso della vecchia scuola.
Massacri e pizzini, muore Provenzano il
padrino dei misteri. Latitante per 43 anni, guidò i
corleonesi e trattò con la politica, scrive Francesco La Licata il 13/07/2016 su
"La Stampa". Con Bernardo Provenzano scompare l’ultimo padrino «Old style»: il
capo, cioè, che preferisce comandare più con la persuasione che col pugno di
ferro. Non che non fosse in grado di fare male a chi «deviava», anzi. Solo che
lui amava accreditarsi come persona ragionevole. E allora potrebbe trovare una
spiegazione la sfilza di nomignoli, anche contraddittori, che il boss si è
meritato durante la sua lunga carriera. Il nome che gli rimarrà per sempre è
Binnu, diminutivo di Bernardo usato nel Corleonese. Gli amici, i familiari lo
hanno sempre chiamato così. Per i sudditi era obbligatorio il don e perciò «don
Binnu». Da giovane aveva un temperamento forte e, dunque, non era famoso per le
doti di saggezza che gli verranno riconosciute nella maturità. No, lui era
famoso come «Binnu ‘u tratturi», per la straordinaria determinazione con cui
spianava gli avversari. Nel 1958 aveva 25 anni e, ricordano alcuni pentiti,
«sparava come un Dio». Allora, appena tornato dal servizio militare con una
lettera di esenzione per inadeguatezza fisica, preferì imbracciare le armi per
combattere la guerra privata contro l’esercito del vecchio Michele Navarra,
medico, segretario politico della dc e capomafia. Il suo comandante era Luciano
Liggio, l’amico del cuore Totò Riina. Il sangue scorreva tra i vicoli di
Corleone, Binnu compì veri «atti di valore» e durante un’azione pericolosa
rimase ferito alla testa. In ospedale disse che non capiva: «Stavo camminando e
ho sentito qualcosa che mi ha colpito al capo». Finì sotto processo con tutti
gli altri, Riina compreso, ma al dibattimento di Bari arrivò il «liberi
tutti». Ci furono altri morti, ma Binnu si era fatto ancora più furbo e quando
lo cercarono era già uccel di bosco. Primavera 1963: ebbe inizio in quella data
la lunga latitanza di Provenzano, conclusa a Montagna dei cavalli (Corleone,
naturalmente) l’11 aprile del 2006, 43 anni dopo. Clandestinità dorata,
attenzione. Perché Binnu si è sempre mosso a suo piacimento: andava a Cinisi,
regno di don Tano Badalamenti, perché lì «filava» con Saveria, l’amore della sua
vita e la madre dei suoi due figli, Angelo e Francesco. In clandestinità si sono
sposati, Binnu e Saveria: rito religioso celebrato da preti compiacenti,
matrimonio non registrato, situazione regolarizzata dopo la sua cattura. Una
volta preso, gli venne chiesto se fosse coniugato e lui rispose: «Col cuore sì,
per la legge no. Ma presto regolarizzerò questa situazione». E così fu: la
«messa a posto» avvenne in carcere. Binnu è un maestro della clandestinità: ha
abitato a Palermo, a Bagheria, a Corleone; ha girato la Sicilia in lungo e
largo, è riuscito a farsi operare alla prostata in una clinica specializzata di
Marsiglia, ottenendo persino il rimborso delle spese mediche dalla Asl. Ha
viaggiato in barca, dentro un’auto nascosta all’interno di un furgone e nessuno
lo ha mai scoperto. Teneva riunioni della cupola nei casolari di campagna e
selezionava attentamente gli amici che chiedevano udienza. Con la maturità è
cambiato il carattere. L’ultima volta che viene visto in azione come «’u
tratturi» era il dicembre del 1969, anno della strage di viale Lazio. Lui, Totò
Riina e un gruppo di «corleonesi» massacrano l’odiato Michele Cavataio e i suoi
amici: quattro morti, ma muore anche Calogero Bagarella, fratello di Leoluca,
luogotenente e cognato di Totò Riina. Quella volta Provenzano finisce Cavataio
colpendolo alla testa col calcio della pistola che gli si era inceppata e poi
tenta di dargli fuoco. Eccesso di ferocia? Anche di calcolo, visto che si sapeva
che Cavataio teneva una lista scritta delle famiglie di Cosa nostra e i relativi
adepti. Ecco, quel biglietto andava distrutto. Un lungo periodo di anonimato,
poi si saprà agevolato, in qualche modo, dai carabinieri, precede la comparsa
dell’«altro» Binnu: l’uomo riflessivo, il principe della mediazione, l’esecutore
della «volontà di Dio». Il freddo calcolatore, l’uomo d’affari e, quindi, «’u
ragiuniere», affidabile anche per certe istituzioni tolleranti. Il dispensatore
di appalti e affari che - al chiuso degli uffici della Icre di Bagheria,
un’impresa di proprietà del boss Nardo Greco - pianificava la spartizione dei
lavori pubblici ottenuti tramite le sue amicizie politiche. Già, la politica. A
differenza di Riina (che non vantava grandi amici), Provenzano un buon
protettore, e addirittura complice, lo aveva. Era Vito
Ciancimino, democristiano, sindaco e assessore al Comune di Palermo. Erano amici
d’infanzia, i due. Racconterà poi Massimo Ciancimino, figlio del sindaco
mafioso, che Binnu aveva una vera e propria adorazione per Vito. Si erano
conosciuti da piccoli, a Corleone, quando Provenzano (terzo di sette figli)
pativa la fame e Vito non gli negava biscotti e una tazza di latte. Da grandi
erano rimasti amici: Binnu gli dava del lei e lo chiamava «ingegnere» anche se
era soltanto geometra, l’altro gli dava del tu, imponeva la via politica e
garantiva l’arricchimento dell’intera consorteria mafiosa attraverso i soldi
pubblici. Ma quando Binnu e Vito «correvano» insieme, già una rete di complicità
girava intorno a loro. Racconterà Massimo che il padre finì per diventare una
specie di anello di congiunzione fra rappresentanti delle Istituzioni (che
ambivano di stare a contatto con mafiosi e affaristi) e il vertice di Cosa
nostra. Siamo nel periodo delle stragi e della svolta terroristica imposta da
Totò Riina. Binnu non l’ha mai condivisa perché convinto, saggiamente, che «non
si può fare la guerra allo Stato». Ma poteva esprimere soltanto pareri, visto
che il momento delle decisioni spettava al capo, a Totò Riina. Raccontava il
pentito Nino Giuffrè che «Provenzano a Riina spesso discutevano e non erano
d’accordo, ma non si alzavano dal tavolo se non avevano raggiunto un
accomodo». Chissà, forse alla vigilia delle stragi di Falcone e Borsellino, nel
1992, Binnu era riuscito ad ottenere dal capo la possibilità di tirar fuori i
familiari. Sarà per questo che donna Saveria, nella primavera di quell’anno,
improvvisamente torna a Corleone, riapre la casa degli avi ed esce ufficialmente
dalla clandestinità, insieme coi figli che, così, assumono una vera forma.
Finiscono di essere dei fantasmi per entrare nell’anagrafe del comune di
Corleone, seppure offrendo pochi scampoli di verità sulla loro trascorsa
latitanza. È il momento più difficile di Cosa nostra. Riina deve affrontare il
suo popolo e convincerlo che non tutto è perduto con quella maledetta sentenza
del maxiprocesso voluto da Falcone e Borsellino. Promette che sarà posto rimedio
a quella batosta e che i «traditori politici» avranno quello che si meritano.
Scatta la rappresaglia: la mafia uccide Ignazio Salvo, il deputato dc Salvo
Lima, uccide Giovanni Falcone in quel modo eclatante e, soltanto 57 giorni dopo,
mette in scena il bis con l’attentato a Paolo Borsellino. Questo, a sentire i
collaboratori di giustizia e le risultanze di importanti indagini, è quanto
imposto dalla «linea Riina», con la prudente astensione di Provenzano. Anzi, con
l’opposizione sotterranea di Binnu. Così raccontano primattori e comparse
dell’indagine che è già sfociata nel processo sulla «trattativa
Stato-mafia». Una sceneggiatura che consegna addirittura l’immagine di un Binnu
collaboratore dei carabinieri (e quindi risparmiato e tenuto libero), nel
tentativo di garantire una pax mafiosa e fermare la follia stragista di Totò
Riina, che avrebbe portato anche all’eliminazione fisica di alcuni politici
considerati «traditori» rispetto alle promesse fatte e non mantenute. Ma questo
è un capitolo ancora aperto e foriero di grandi attriti politico-istituzionali.
Ha già provocato feroci discussioni e divisioni un dibattimento che annovera tra
gli imputati mafiosi del calibro di Provenzano e Riina, politici come Mannino,
poi assolto, Dell’Utri e gli alti ufficiali dei carabinieri Mori e Subranni.
Tutti accusati di aver condotto una vera e propria trattativa sulla base anche
di richieste ufficiali della mafia, ufficializzate nel cosiddetto «papello»,
cioè un elenco di benefici (tra l’altro l’alleggerimento del carcere duro,
l’abolizione dell’ergastolo, della legge sui pentiti e sul sequestro dei beni ai
mafiosi) consegnato allo Stato italiano (attraverso i carabinieri) da Vito
Ciancimino, con la «benedizione» di don Binnu. Tutto ciò, ovviamente, ha
appannato il prestigio di Provenzano. I suoi amici (in particolare il boss
Matteo Messina Denaro) gli hanno addirittura rimproverato poca cautela nella
gestione della comunicazione attraverso i suoi famigerati «pizzini». E non si
può negare che qualche problema l’ha creato la scoperta dei duecento e più
bigliettini trovati nel suo covo di Montagna dei cavalli. Ma quando è stato
preso, don Binnu, era già votato alla «pensione». Non era più «u tratturi» e
neppure «u ragiunieri»: forse si ritrovava ancora nei panni del vecchio
mediatore, nell’intento di poterla sfangare e tramontare senza l’onta e il
marchio del collaboratore. I pizzini, infatti, ci lasciano l’immagine che gli è
più congeniale. L’eterno «moderato» che proprio se deve ordinare l’esecuzione di
qualcuno lo fa congiungendo le mani sul petto e sussurrando: «Sia fatta la
volontà di Dio».
Attilio Bolzoni: “Ci serve un pentito di
Stato, un Presidente della Repubblica, un uomo dei servizi segreti o un
Generale”. Intervista di Francesca Scoleri del 23
luglio 2016 su “T&M”.
Dott. Bolzoni, i suoi colleghi Nuzzi e
Fittipaldi sono stati recentemente assolti da una accusa che il mondo del
giornalismo non dovrebbe assolutamente conoscere: reperire informazioni. Lei ben
conosce questo drammatico paradosso, ma a differenza dei suoi colleghi appena
citati, ha dovuto affrontare il carcere per aver pubblicato le rivelazioni di un
pentito. Chi non conosce la storia potrebbe pensare sia accaduta sotto il
fascismo e invece eravamo quasi negli anni 90. Cosa ricorda oggi di quei giorni?
«La mia storia
racconta una Palermo molto particolare. Il mio arresto e quello di Saverio
Lodato – lavoravamo insieme in quel periodo – rappresenta solo uno specchio di
quel momento. Noi siamo stati il capro espiatorio perchè l’obiettivo non eravamo
noi. Era un segnale. Noi siamo stati arrestati innanzitutto, con un reato
infamante per un giornalista: concorso con pubblico ufficiale - rimasto ignoto –
in peculato. Una parola che fa venire in mente un reato economico, un
giornalista che ha dimestichezza col denaro…In realtà, avevamo pubblicato la
cantata di un collaboratore di giustizia, un capomafia, Nino Calderone, che
parlava dei rapporti fra mafia e politica e quindi, la cosa fece infuriare
molto. Il Procuratore che fece l’ordine di cattura quel 16 marzo 1988, non ha
mai arrestato un solo ladro di galline a Palermo. Solo due giornalisti. Noi,
lavoravamo da tanti anni su quel fronte perchè, nei primi anni 80, dopo la
guerra di mafia – la città mattatoio, è nato un nuovo giornalismo a Palermo,
molto più libero, quindi quello fu un avvertimento in puro stile mafioso da
parte di quel magistrato. Siamo nell’88, appena pochi anni prima, nessuno
parlava di mafia, nessuno scriveva di mafia ma adesso se ne parla troppo e a
sproposito. Nel giro di 30 anni, si è passato dal silenzio assoluto, a un rumore
fondamentalmente silenzioso. Che cos’è la mafia? Per me la mafia non è più
quella dei corleonesi di Totò Riina, quella è stata una parentesi violentissima
durata 25 anni. La mafia si traveste, cambia pelle e quando fa questo processo,
noi non la riconosciamo mai. La cercavamo nei campi ed era già nei cantieri, la
cercavamo nei cantieri ed era già a fare la droga, la cercavamo nella droga e
faceva finanza. Oggi la mafia è molto più pettinata, profumata, politicamente
corretta e sta nei convegni insieme a noi e il limite più grosso di una certa
antimafia, è l’incapacità di riconoscerla».
Da oltre 30 anni, racconta la Sicilia e la
mafia che per nostra sciagura, ha percorso la via preannunciata da Sciascia
quando diceva “Forse tutta l’Italia va diventando Sicilia…” Un sistema
consolidato composto da criminali, colletti bianchi e imprenditoria, è questa la
mafia che ha conquistato la nazione?
«Dopo le
stragi, ho lavorato 10 anni sui corleonesi ma nei 10 anni successivi sono
rimasto disorientato, non capivo più cos’era la mafia. Perché? I corleonesi,
sono una piccola parentesi nella storia della mafia, 25 anni di violenza, ma
prima dei delitti eccellenti degli anni 80, erano passati circa 80 anni
dall’ultimo delitto eccellente, era il 1893 quando ci fu l’uccisione del
marchese Notarbartolo, il simbolo di Palermo, del Banco di Sicilia. Quindi, la
mafia si nasconde e se non la cerchi non la trovi. Invece i corleonesi, hanno
rappresentato solo il braccio armato di altre forze, preliminare di un sistema
politico mafioso in Sicilia. I delitti eccellenti non li hanno voluti solo i
corleonesi, anche se materialmente, li hanno commessi. Se pensiamo al delitto La
Torre, Mattarella, Dalla Chiesa, Falcone, Borsellino, non possiamo pensare che
siano solo questi 70 caproni di Corleone. Gente che veniva dal niente ed è
tornata nel niente. La mafia oggi occupa posti chiave del potere in Sicilia e in
Italia ed è una mafia che non sempre riconosciamo subito. La mafia proletaria,
la mafia popolare è stata quasi decimata, ma l’aristocrazia mafiosa va avanti e
c’è ancora molto da scoprire su come alcuni personaggi abbiano salvato il
sistema criminale italiano».
Lei ha visitato il covo di Bernardo Provenzano
dopo la sua cattura, disse che era “un covo miserabile pieno di Crocifissi,
rosari e santini”. Attraverso il processo trattativa Stato-mafia e il processo
sulla mancata cattura di Provenzano, scopriamo a distanza di oltre 20 anni, che
Provenzano è sfuggito alla cattura in più occasioni. Le ultime sentenze su Mori
e Obinu, ci consegnano un’irrilevanza penale della mancata cattura, lei che idea
si è fatto?
«Prima della
mancata cattura di Provenzano, c’è stata la mancata perquisizione del covo di
Riina. Dietro ogni cattura eccellente, c’è sempre un mistero. Riina è stato
latitante dal 1969 al 1993. Provenzano, è stato latitante dal 1963 al 2006. Non
avevano lo status di latitanti, avevano lo status di capi di Stato riconosciuti
perché chi è latitante per tutto questo tempo, è di fatto, un latitante libero.
Solo quando hanno cominciato a cercarli li hanno presi. Tutta la vicenda della
trattativa, non solo processuale ma anche storica, è strettamente legata ai
misteri del covo di Riina e alla mancata cattura di Provenzano. Mi fanno
sorridere quelli che dicono la trattativa non c’è. Da quando esiste lo Stato
italiano, c’è un pezzo di apparati che tratta con le classi criminali italiane e
questo è un dato storico. Che poi, il dottor Di Matteo, riesca a dimostrarlo
nel suo processo è un altro discorso che riguarda il corso della giustizia. Ma
il fatto che lo Stato italiano, ripeto, non la mafia ma lo Stato abbia chiesto
accordi e abbia trattato con la mafia, è dal 1861, accade da quando esiste
l’Italia. Gli ufficiali dei carabinieri sono stati assolti sia per quel che
riguarda la mancata perquisizione del covo di Riina, sia per la mancata cattura
di Provenzano e questo è il risultato giudiziario. Ma da quel processo sono
emerse verità che erano state nascoste. Il magistrato ha dei confini precisi che
sono determinati dalla legge, dai codici, dalle regole e fuori da quel confine
non può andare, ma un osservatore, uno storico, un giornalista, un esperto, può
avventurarsi in altre ipotesi. Io, da cittadino italiano, non mi accontento
delle sentenze su Capaci e Via D’Amelio, verità che mi hanno offerto dei
magistrati anche bravissimi perché sono arrivati fin là, ma io non mi accontento
perché sono convinto che a fare quelle stragi non sia stata solo Cosa nostra il
che non significa che abbiano fatto male le indagini. In alcuni casi sicuramente
ci sono stati depistaggi però dobbiamo capire che la verità storica non coincide
mai con la verità giudiziaria. Nel 1984 arriva Buscetta e per la prima volta si
rompe il muro di omertà di Cosa nostra, sono passati 32 anni ma il muro
dell’omertà di Stato non si è rotto. Oggi ci serve un pentito di Stato: un
Presidente della Repubblica, un Generale dei carabinieri un capo dei servizi
segreti…un pentito di Stato potrebbe offrirci frammenti di verità che ad oggi
non sono ancora affiorati».
Con il libro “La giustizia è cosa nostra”, lei
e il compianto Giuseppe D’Avanzo, avete cercato di dimostrare come le manine del
potere soccorrono abitualmente la mafia. Sono le stesse manine che intralciano
il lavoro di ottimi investigatori – mi viene in mente l’attuale capo scorta di
Nino Di Matteo, Saverio Masi, che accumula note di merito eccellenti fino a
quando non individua il covo di Provenzano. Da quel momento in poi, viene
trattato alla stregua di un delinquente. Come si fa la guerra alla mafia in
queste condizioni?
«La mafia non
sarebbe mafia se non avesse dei complici dentro gli apparati. Il libro è di 30
anni fa e racconta di processi aggiustati e il simbolo di questi processi
aggiustati è quello che riguarda l’uccisione del Capitano Basile. E’ il processo
più tormentato della storia giudiziaria per quanto riguarda la mafia. Hanno
provato a condizionarlo e ad aggiustarlo da dentro il palazzo di giustizia in
tutti i modi ma non ci sono riusciti. Prima dell’era Falcone, i processi a
Palermo si trattavano nei corridoi, nei villini a mare…non si discutevano nelle
aule di giustizia. I mafiosi stavano in carcere pochi mesi o pochi anni, ma
sapevano che dovevano uscire. Dopo l’arrivo di Falcone e Borsellino, avviene una
rivoluzione e si ristabiliscono le regole. Si è scoperto che un pezzo di
magistratura era complice. All’epoca però, era molto più evidente la complicità
del potere, oggi è molto più subdola e meno riconoscibile. Un’antimafia legata
al potere ad esempio, non è una vera antimafia. Si parla dell’isolamento di Di
Matteo, non posso dimenticare, un paio d’anni fa, il vecchio CSM è andato a
Palermo e il vice presidente non ha stretto la mano a Di Matteo. E’ stato un
bruttissimo segnale. Di Matteo non è un buon magistrato perché indaga sulla
trattativa o non è un buon magistrato in assoluto? Il vice presidente che
dichiara – il protocollo mi impedisce di incontrare Di Matteo – indica un
atteggiamento ambiguo».
La negazione della trattativa Stato-mafia ha
raccolto molti consensi, almeno quanto oggi la giustificazione della stessa.
Maria Falcone, ad esempio, ha dichiarato “Se trattativa c’è stata, non credo che
si sono voluti salvare i potenti, ma che si sia cercato di proteggere la
sicurezza italiana”. Eppure c’è una sentenza che ne prova l’esistenza. La
trattativa c’è stata. Ma l’oggetto dell’accordo qual é stato secondo lei? Lunghe
latitanze e mancata perquisizione del covo di Riina per cominciare?
«Ci sono verità
indicibili. Gli Stati, non solo l’Italia, hanno sempre trattato con le classi
pericolose. Non sono corpi fuori dalla società. La trattativa c’è stata prima,
durante e dopo le stragi che poi questa abbia rilevanza penale o meno non è
fondamentale. Il negazionismo va molto di moda, ad esempio – Roma mafia capitale
– è altrettanto evidente che ci sono organizzazioni mafiose radicate da decenni
a Roma ma la maggior parte degli osservatori e della popolazione ne nega
l’esistenza. Io ho seguito molto il processo di mafia capitale, sono andato in
aula a Rebibbia e c’erano degli imputati, un famosissimo commercialista e un
famosissimo consigliere comunale del PD, che si chiedevano – ma noi che ci
facciamo qui? – non si rendevano nemmeno conto del perché fossero li. Non
bluffano. E’ tanto fradicio il tessuto sociale e politico della Capitale che non
si rendevano conto delle ragioni per le quali erano lì insieme al nero
Carminati, un signore, che per 18 anni è rimasto libero e in un Paese civile, un
personaggio come Carminati non può rimanere libero ma anche lì, siamo nelle zone
di confine dove non sai mai chi è guardia e chi è ladro. Roma come Palermo. Gli
stessi contesti».
La parola antimafia, crea molti imbarazzi
ultimamente. Ma è necessaria questa etichetta per dimostrarsi ostili all’azione
mafiosa?
«L’antimafia
c’è sempre stata anche quando non si chiamava antimafia. L’antimafia moderna
nasce subito dopo il delitto Dalla Chiesa e si è allargata estesa e diffusa dopo
le stragi del 92. Io credo che abbia avuto una funzione veramente importante
l’antimafia sociale in Italia fino a qualche anno fa ma poi, c’è stata una
degenerazione dello spirito originario. Bisogna fare una distinzione tra la
mafia che si traveste da antimafia, tra dei sistemi imprenditoriali mafiosi che
occupano potere e l’antimafia che è degenerata. E’ vero che ci sono dei cerchi
che mettono in relazioni queste tre realtà, però bisogna distinguerle. C’è
l’antimafia dei finanziamenti pubblici da centinaia di migliaia di euro e
l’antimafia dei funzionari delle grandi associazioni che provengono da un
sottobosco politico. Bisognerebbe fare un esperimento: togliere per u paio
d’anni un bel po di finanziamenti alle associazioni antimafia e assisteremmo ad
un fuggi fuggi generale. In alcuni casi, c’è la complicità del ministero degli
Interni che concede finanziamenti esorbitanti per dei progetti che, vien da
chiedersi, saranno andati a buon fine con tutti i milioni stanziati? Ho
conosciuto un signore di Avviso Pubblico, che gira l’Italia battendo cassa alle
amministrazioni per organizzare convegni con partecipanti zero. Sono personaggi
improbabili che si improvvisano esperti di mafia, che parlano di legalità e che
vanno in giro per l’Italia a proporre pittoreschi kit per la legalità. Ma
intorno alla maggior parte di queste realtà c’è solo un obiettivo, rastrellare
denaro pubblico. Bisogna chiudere i cordoni della borsa. Poi c’è un’antimafia
sociale che è ostile ad ogni dialogo, alcune realtà sembrano sette, appena uno
le critica viene accusato di essere mafioso. Io non ne posso più di questi
predicatori della legalità, imbonitori e saltimbanchi. Hanno messo su un circo.
E a proposito dei predicatori della legalità, è molto grande la distanza tra
quello che urlano nelle piazze e quello che in realtà fanno. Un altro tema
interessante è quello delle costituzioni di parti civile: quando un’associazione
accompagna un commerciante, un imprenditore che denuncia la mafia lungo tutto il
percorso – lo porta dalla polizia, dal magistrato, lo convince a collaborare – è
giustissimo che si costituisca parte civile perché ha partecipato al percorso
che porta al processo. Ma questo baraccone delle parti civili che c’è oggi in
Italia è scandaloso. Mi viene in mente un’associazione a Marsala che si chiama
Paolo Borsellino, è formata da un solo avvocato che non fa nulla tutto l’anno,
ma ha pensato bene di costituirsi parte civile al processo Aemilia e per questo
ha ricevuto un risarcimento. C’è poi il caso di un comune sciolto per mafia –
come quello di Brescello – che ha perfino ricevuto un indennizzo dopo la
costituzione di parte civile al processo Aemilia. A questo punto credo che
bisogna ridimensionare i finanziamenti alle associazioni antimafia perché sono
emerse troppo vergogne».
Un sentito grazie a Sabrina D’Elpidio e Annalisa
Insardà per aver contribuito alla realizzazione di questa intervista.
La giustizia è Cosa Nostra.
Edito da Mondadori, 1995, di Attilio Bolzoni, Giuseppe D'Avanzo. E' un libro che
si legge tutto d'un fiato. Racconta di giudici e di boss, di avvocati e di
politici, di processi di mafia pilotati e di inchieste insabbiate, di Palazzi di
Giustizia condizionati dal volere degli uomini d'onore. E ripercorre alcuni
scabrosi episodi che, a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, sono diventati
clamorosi "casi giudiziari". E' scritto a quattro mani da Attilio Bolzoni e
Giuseppe D'Avanzo, due tra i più bravi cronisti italiani di storie di mafia.
Lo stato nascosto. Le trattative che
portarono alla pax mafiosa. Libro di Antonio M.
Moccia, Rosalia Monica Capodici. Questo è un libro diverso, particolare, una
riflessione, che gronda in ogni sua pagina della passione civile degli autori,
sugli aspetti più delicati dell'intero sistema criminale mafioso. Quelli che
hanno condizionato, e continuano a condizionare, la nostra democrazia ed un
quadro politico istituzionale sempre più esposto alla erosione del cancro
mafioso. Si parla, e lo si fa con cognizione di causa e grande onestà
intellettuale, dei nodi essenziali del sistema di potere mafioso: il rapporto
con la politica, i tanti compromessi, la mediazione, i sotterranei "dialoghi
pericolosi" tra lo Stato e la mafia, l'isolamento e la delegittimazione di tanti
uomini delle istituzioni che, sull'altare della convenienza o dell'opportunità
politica, sono stati traditi dallo Stato prima di essere uccisi dal tritolo o
dal piombo dei mafiosi.
Recensione Libro: Lo stato nascosto. Per il
politico, stringere il patto con l’organizzazione mafiosa significa insomma
effettuare una precisa scelta di campo. Significa impegnare, da subito, i propri
futuri comportamenti, anche sul piano istituzionale, in una logica di servizio a
beneficio degli interessi dell’organizzazione. Di cosa parla Lo stato nascosto
di Rosalia Monica Capodici e Antonio Michele Moccia. Ci sono argomenti come
quello trattato nel libro Lo stato nascosto – le trattative che portarono alla
pax mafiosa di Rosalia Monica Capodici e Antonio Michele Moccia che non solo
devono essere discussi ma anche approfonditi per ricordare che bisogna lottare
contro i poteri violenti e che per quanti anni siano passati dalle stragi
di Falcone e Borsellino non è cambiato poi molto. Da questo libro degno di
attenzione – già solo per la sfida lanciata dai due scrittori di portare alla
luce fatti ai più celati che riguardano la gestione dello Stato da parte della
mafia, – Capodici e Moccia sono riusciti a dare una visione globale del potere
nascosto utilizzando i fatti e non le teorie. Nel libro Lo stato nascosto,
infatti, si utilizzano le sentenze, i risultati dei processi, ma non quelli
conosciuti ai più, al contrario si porta alla luce tutto ciò che i giornalisti
hanno trascurato, non sappiamo ovviamente se la distrazione da parte della
stampa è stata voluta o meno. Quel che conta adesso è sapere. Tutto ciò che
viene raccontato in questo libro ci riguarda da vicino, fa parte della nostra
quotidianità senza che in alcuni casi ce ne rendiamo conto ed è per questo che è
fondamentale aprire gli occhi sulla verità e scoprire chi gestisce la maggior
parte della nostra ricchezza, delle nostre stanze di potere, dei traffici e di
parte della società. La presenza della mafia si è diffusa a qualsiasi livello e
settore: che si tratti di istituzioni o quartieri non c’è distinzione, perché le
organizzazioni criminali sono ormai ovunque. Le conseguenze che portano questo
sistema criminale possiamo prevederlo e osservarlo continuamente, basta guardare
il telegiornale, ma la mafia condiziona la democrazia anche quando non ce ne
rendiamo conto, è questo che tendono a sottolineare con il loro libro Capodici e
Moccia. Ciò che viene portato sotto i riflettori, e quindi alla portata di tutti
i lettori, è il rapporto che intercorre tra Stato e mafia, i compromessi a cui
vanno incontro chi gestisce la politica, ma nel libro Lo stato nascosto c’è
anche spazio per gli eroi che hanno combattuto e purtroppo sono caduti per
tradimento o isolamento sotto il nemico. Lo stato nascosto di Rosalia Monica
Capodici e Antonio Michele Moccia, pubblicato dalla casa editrice Salvatore
Insenga Editore va letto e discusso senza ombra di dubbio. Vorrei concludere
citando una frase di Paolo Borsellino che potete leggere nella prefazione di
Nino Di Matteo: “Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui
giornali. Però parlatene.”
La vera ‘ndrangheta e quei
«quattro storti» che ci credono ancora,
scrive Felice Manti il 19 luglio 2016 su “Il Giornale”. È stata una settimana
horribilis per la ’ndrangheta. Altri 100 arresti tra la provincia di Cosenza e
la Liguria, con le famiglie «in trasferta» che facevano affari sulle opere
pubbliche grazie a una coop con interessi in settori diversissimi come movimento
terra, import-export di prodotti alimentari, sale giochi e piattaforme di
scommesse online, lavorazione dei marmi, autotrasporti e rifiuti speciali,
produzione e commercializzazione di lampade a led. Due parlamentari come Antonio
Caridi di Gal e Pino Galati di Ala considerati al servizio delle famiglie di
’ndrangheta anche a causa di un paio di intercettazioni telefoniche che non
lasciano spazio a troppi dubbi. Funzionari delle Agenzie delle Entrate che
trescavano con la ’ndrangheta. Il boss del pesce Franco Muto che con il suo clan
controllava «ogni respiro» tra Cetraro e Scalea (in provincia di Cosenza) da 30
anni, e prima ancora una Spectre politico-affaristico-massonica guidata dall’ex
deputato Psdi Paolo Romeo, già noto alle forze dell’ordine sin dall’operazione
Olimpia – che sta alla ’ndrangheta come il cosiddetto maxiprocesso di Falcone e
Borsellino sta alla mafia – come referente della mafia calabrese che avrebbe
deciso a tavolino tutte le elezioni degli ultimi 15 anni (a volte puntando però
su qualche candidato sbagliato ma tant’è) coinvolto anche nelle recentissime
inchieste Fata Morgana e Reghion sul condizionamento della criminalità al Comune
di Reggio, sciolto per contiguità con la ‘ndrangheta. È la prova dell’esistenza
dei cosiddetti Invisibili cui dà la caccia il pm Giuseppe Lombardo, una sorta
di ’ndrangheta superiore che comanda sulla fazione criminale ma di cui la
stragrande maggioranza degli affiliati non conosce l’esistenza, come
dimostrerebbe l’inchiesta Mammasantissima, e che avrebbe agevolato la
latitanza di personaggi che fanno comodo alle cosche (vedi l’inchiesta
Breakfast), da Amedeo Matacena al capo della mafia Matteo Messina Denaro, con in
mezzo un peso decisivo nell’inchiesta Mafia Capitale. Allora c’è qualcosa che
non torna. Facciamo un salto di sei anni. Alla fine del 2010, nel
libro Madundrina scritto con Antonio Monteleone, scrivevamo: «Forze occulte,
servizi deviati, poteri forti e massoneria. Come si combatte un nemico
invisibile? Ma, soprattutto, come si dimostra la sua esistenza? Gli inquirenti
devono dare una risposta anche a questo quesito». E già allora riportavamo una
frase captata durante una delle oltre 500mila intercettazioni, contenuta nelle
52 inchieste passate al setaccio dagli inquirenti, in cui a parlare era un
sindacalista, e qui riprendo da Madundrina «che viene descritto dai magistrati
come “anello di congiunzione tra esponenti di spicco della locale criminalità
organizzata e appartenenti al settore politico-amministrativo della fascia
jonico-reggina” e promotore di “una sorta di cupola” (…) perché parte del
contesto criminale (…) definito degli “invisibili”. Si chiama Sebastiano
Altomonte. Intercettato al telefono con la moglie, a margine di una
conversazione su alcuni dissidi locali parla anche della ’ndrangheta invisibile.
“Effettivamente gli invisibili siamo cinque (…), lo sanno solo nel provinciale
(…)”. Chi sono questi cinque? Che cosa vogliono? Per chi lavorano? Come fanno a
sapere tutto? E quanto vale, nell’economia della ’ndrangheta, un’operazione
mostruosa come quella congiunta di Milano e Reggio Calabria (parlavamo di
Crimine e Infinito, nda), se i boss sapevano tutto (grazie alle rivelazioni
di Giovanni Zumbo, legato ai servizi segreti, nda)? Chi comanda veramente?». Chi
legge questo blog sa cosa penso delle operazioni di ’ndrangheta del 2010 che
hanno ispirato il libro, recentemente definite dalla Cassazione come «sentenze
storiche» perché definiscono per la prima volta l’unitarietà della ’ndrangheta.
Delle due l’una. Perché o ha ragione il procuratore antimafia Ilda Boccassini
quando dice che con Infinito si è smantellata la ’ndrangheta in Calabria, quella
comandata dal boss scissionista Carmelo Novella, ammazzato come un cane (ma il
mandante è ancora oscuro…) perché voleva sganciarsi dalla Calabria, quella del
summit al centro Falcone e Borsellino di Paderno Dugnano, quella zeppa di gente
senza precedenti penali e senza reati fine oggi in carcere con l’accusa di
associazione mafiosa che non hanno neanche mai sparato un colpo di pistola per
sbaglio. E che la ‘ndrangheta calabrese fosse comandata da Domenico Oppedisano,
che prima di diventare famoso come capo della ’ndrangheta vendeva piantine
vicino allo svincolo di Rosarno, talmente pericoloso che di recente è uscito dal
regime di carcere duro, il famigerato 41bis. Un esperto in affiliazioni, vero,
uno che mangiava pane e ’ndrangheta certamente, ma non un capo. E d’altronde
anche il procuratore antimafia Nicola Gratteri lo sostiene con forza.
D’altronde, dell’esistenza della maxi inchiesta erano al corrente molti boss,
come è emerso dalle intercettazioni. Oppure la ’ndrangheta che conta quella
vera, è altro. È difficile pensare che i boss arrestati fossero veramente a capo
della ’ndrangheta milanese mentre facevano il bello e il cattivo tempo altri
boss del calibro di Paolo Martino, killer dormiente imparentato con il
potentissimo clan dei De Stefano e considerato il vero tesoriere della
’ndrangheta a Milano (solo per fare un esempio). Oggi sappiamo con certezza che
una Spectre aveva in mano i destini della politica e trescava facendo affari con
parlamentari e coop, anche alle spalle dei picciotti. E se avesse ragione il
boss della ’ndrangheta Pantaleone Mancuso, che intercettato dice testuale: «(Ci
sono) quattro storti che ancora credono alla ‘ndrangheta… hanno fatto la
massoneria… il mondo cambia…»? E se la Boccassini avesse arrestato proprio quei
quattro storti, gente che non ha mai tenuto una pistola in mano?
Crocetta e i gran maestri
della massoneria convocati in commissione nazionale antimafia.
Il prossimo 2 agosto a Palazzo San Macuto a Roma verrà sentito il presidente
della Regione, scrive Rino Giacalone il 30/07/2016 su “La Stampa”. La
commissione nazionale antimafia all’indomani delle audizioni in Sicilia, ha
convocato il presidente della Regione Crocetta e i gran maestri degli ordini
massonici per approfondire i temi emersi nel corso della missione a Palermo e
Trapani, dove tanto si è parlato di indagini giudiziarie che riguardano i
contatti diventati stretti tra mafia e massoneria. Un fronte che non serve solo,
hanno detto in audizione i magistrati di Trapani e Palermo, a coprire la
latitanza del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ma rappresenta la nuova
stagione criminale di Cosa nostra che se non spara più, grazie al sostegno della
massoneria, «ha migliori capacità di inquinare i settori della vita politica,
sociale ed economica del territorio» ha tra l’altro affermato la presidente
della commissione Rosy Bindi. Il prossimo 2 agosto a Palazzo San Macuto a Roma
verrà sentito il presidente della Regione Rosario Crocetta. Certamente tra le
domande che attendono il governatore siciliano quelle relative a Patrizia
Monterosso segretario generale di Palazzo d’Orleans, sede della presidenza della
Regione Sicilia. Il nome della Monterosso nel corso del processo a Catania
contro l’ex governatore Raffaele Lombardo, è stato fatto dal pentito agrigentino
Giuseppe Tuzzolino. Tuzzolino ha affermato che la Monterosso farebbe parte di
una loggia massonica di Castelvetrano, dove avrebbe fatto da garante ad una
serie di affari sugli impianti eolici. La Monterosso ha già smentito la
circostanza: «Non appartengo alla massoneria, le uniche volte in cui mi sono
imbattuta in cose che riguardano questo tipo di associazione sono state delle
mail ricevute all’indirizzo istituzionale della segreteria generale, nel luglio
2015 ho ricevuto due messaggi da una loggia di Catania, c’era una lista di 17
nomi, forse si trattava di iscritti, ma io ho subito denunciato alla Polizia
Postale di Catania, a novembre 2014 nella casella di posta è arrivata una email
del Grande Oriente d’Italia, direttamente da Palazzo Giustiniani. Anche in
questo caso ho denunciato». In commissione nazionale antimafia però la
circostanza ha suscitato attenzione. Critico è stato il leghista “siciliano”
Angelo Attaguile: «Come siciliano - ha detto - sono preoccupato, i politici
passano i burocrati restano, da siciliano mi preoccupo che al Governo regionale
ci siano funzionari e burocrati che non dovrebbero stare al loro posto».
Mantenendo poi fede a quanto annunciato in Commissione nazionale antimafia sono
stati convocati gran maestri degli ordini massonici, il prossimo 3 agosto verrà
sentito in gran maestro del Grande Oriente Stefano Bisi. La presidente Bindi ha
spiegato a Trapani il perché di queste convocazioni, «intendiamo sapere se siano
a conoscenza di logge segrete nel trapanese, della cui esistenza abbiamo appreso
dai magistrati e soprattutto come intendano comportarsi».
Il caso Trapani: una
saldatura tra mafia e massoneria.
La visita della Commissione in
Sicilia. Bindi: “Sui beni confiscati abbiamo dato troppa voce in capitolo
all’agenzia regionale”, scrive Rino Giacalone il 21/07/2016 su “La Stampa”. La
commissione nazionale antimafia è pronta ad aprire un caso Trapani e
denuncia: «la latitanza di Matteo Messina Denaro è coperta da intrecci tra mafia
e massoneria altolocata». Massoneria che oggi starebbe cavalcando un forte
attacco contro la magistratura trapanese: «certe indagini stanno dando
fastidio». Forti i toni usati dalla presidente Rosy Bindi, ma anche dal suo vice
Claudio Fava, dai commissari Davide Mattiello (Pd), dai 5 Stelle Mario Giarrusso
e Francesco Dell’Uva e dal leghista siciliano Angelo Attaguille. «Abbiamo
sconfitto la mafia contro la quale combatterono Falcone e Borsellino, oggi -
dice la presidente Bindi - abbiamo innanzi una mafia che è mutata, una mafia che
uccide di meno ma incide di più nella vita sociale, politica ed economica del
Paese». Se volete venire a conoscere cos’è la nuova mafia, che c’entra tanto
con le stragi del 1992, bisogna venire in provincia di Trapani. E la commissione
antimafia su questo ha raccolto tanto ascoltando magistrati, giudici,
investigatori. Claudio Fava: «Esiste una nuova cupola fatta di mafia e
massoneria ed è strano che esista un concentrato di logge segrete a
Castelvetrano, la terra del boss latitante Matteo Messina Denaro e del suo
sistema di potere». «In questa provincia - dice il deputato Davide Mattiello -
bisogna ricercare quell’accordo forte denunciato ieri a Palermo dal procuratore
generale Scarpinato sull’esistenza di un fronte “masso-mafia” che a Messina
Denaro ha garantito coperture altolocate per la sua ventennale latitanza». I
magistrati trapanesi ascoltati, a cominciare dal procuratore Viola, hanno
confermato indagini aperte sul fronte della massoneria ma hanno consegnato
precisi elementi dei contrasti che la magistratura trapanese subisce. «Ci siamo
trovati a fare un viaggio nel tempo - racconta il senatore Mario Giarrusso -
abbiamo sentito parlare nel 2016 magistrati con le stesse parole che altri
giudici usavano a Trapani negli anni ’80, quando si scopriva la loggia segreta
Iside 2. Abbiamo sentito i magistrati inquirenti che si sono detti non al sicuro
nelle proprie stanze, che non lasciano documenti in ufficio». «C’è una Procura
sotto tiro - dice il vice presidente Fava - sotto le reazioni illecite di chi
con fastidio giudica il lavoro della Procura, attenzioni che arrivano da parte
di ambienti inquietanti». La presidente Bindi ha annunciato che verranno
convocati i vertici degli ordini massonici, i Gran Maestri saranno convocati in
commissione: «Chiederemo loro se sanno di logge segrete e se sanno perché non
hanno denunciato, se invece non sanno chiederemo che agiscano per espellere
questi corpi fornendo collaborazione all’autorità giudiziaria». Tanti i temi
toccati, con l’annuncio, dopo avere ascoltato in giudici della Corte di Assise,
Pellino e Corso, che verrà aperto un approfondito esame sui depistaggi emersi
durante il processo per il delitto di Mauro Rostagno. Affrontato anche il tema
della gestione dei beni confiscati, partendo dall’assedio che oggi continua a
subire la Calcestruzzi Ericina, l’impresa confiscata al boss di Trapani Vincenzo
Virga. C’è un progetto che prevede di mettere in rete la Calcestruzzi Ericina e
tutte le imprese del settore che producono calcestruzzo, oggi sequestrate e
confiscate. Ma il progetto registra forti ritardi nell’attuazione e i ritardi
stanno tutti dentro l’agenzia nazionale dei beni confiscati. La commissione ha
puntato attenzione sulla sede regionale dell’agenzia e la Bindi ha
chiosato: «Credo che sia stata lasciata all’agenzia regionale troppa voce in
capitolo». Infine è stato affrontato il caso Castelvetrano, dove il Consiglio
dopo un tira e molla si è sciolto per non far restare consigliere quel Lillo
Giambalvo intercettato a esaltare la figura del latitante Matteo Messina Denaro.
A Castelvetrano la commissione ha registrato attraverso le audizioni un maxi
concentrato di logge, troppe per il territorio che protegge la latitanza di
Matteo Messina Denaro. La commissione ha sentito il sindaco di Castelvetrano
Felice Errante e l’ex capogruppo del Pd Pasquale Calamia. «Ci saremmo aspettati
una presa di distanza del sindaco di Castelvetrano che non c’è stata» ha detto
la presidente Bindi e il vice presidente Fava continua: «Se Castelvetrano fosse
in Baviera non ci porremmo il problema di una Giunta dove siedono tre assessori
appartenenti alla massoneria, ma si tratta della città di Messina Denaro». E sul
boss, latitante dal 93, la presidente Bindi aggiunge: «Aspettiamo anche noi la
buona notizia della cattura».
"Nel Trapanese una nuova
cupola fatta di mafia e massoneria",
scrive Rino Giacalone il su "Live Sicilia" il 20 luglio 2016. "Abbiamo sconfitto
la mafia contro la quale combatterono Falcone e Borsellino, oggi abbiamo innanzi
una mafia che è mutata, una mafia che uccide di meno ma incide di più nella vita
sociale, politica ed economica del Paese". Sono le parole della presidente della
commissione parlamentare antimafia, on. Rosy Bindi, espresse a conclusione della
tre giorni siciliana, una missione durante la quale numerose sono state le
audizioni ma c'è stata anche la significativa presenza alle manifestazioni a
ricordo dei 24 anni dalla strage di via d'Amelio. "Abbiamo ritardi anche
politici da scontare - ha detto ancora l'on. Bindi -. Falcone e Borsellino non
sono stati mai ascoltati da una commissione antimafia, a 24 anni dalla strage di
via d'Amelio abbiamo ascoltato Lucia Borsellino, figlia del procuratore aggiunto
paolo ucciso con la sua scorta il 19 luglio del 1992, a lei abbiamo promesso il
nostro impegno, ma dobbiamo anche dire che si tratta di restituire non solo a
lei e alla famiglia Borsellino, e ancora alla famiglia Falcone, alle famiglie
dei poliziotti uccisi, dobbiamo restituire al paese segmenti di verità che
appartengono al Paese". Commissione antimafia che ha raccolto tanto sulla mafia
in provincia di Trapani, ascoltando magistrati, giudici, investigatori. "Esiste
una nuova cupola fatta di mafia e massoneria, anomalo che un concentrato di
logge segrete esiste a Castelvetrano, la terra - ha detto il vice presidente
della commissione antimafia Claudio Fava - dove il boss latitante Matteo Messina
Denaro ha costruito il proprio sistema di potere". "Lavoreremo per capire meglio
- ha aggiunto il deputato Pd Davide Mattiello - ma abbiamo la forte impressione
che qui bisogna cercare quell'accordo forte denunciato ieri a Palermo dal
procuratore generale Scarpinato sull'esistenza di un fronte “masso-mafia” che a
Messina Denaro ha garantito altolocate coperture per la sua ventennale e
perdurante latitanza". "Ci siamo trovati a fare un viaggio nel tempo - ha detto
il senatore Mario Giarrusso di 5 Stelle -, non è possibile sentire parlare nel
2016 magistrati con le stesse parole di altri magistrati, quando a Trapani negli
anni '80 si scopriva la famosa loggia segreta Iside 2". E un quadro pesante a
proposito degli uffici giudiziari trapanesi emerge al termine delle audizioni
fatte a Trapani dalla commissione parlamentare antimafia. Situazione che ha
spinto la presidente Rosy Bindi a ipotizzare la possibilità che a parte la
relazione finale prevista a fine legislatura su tutte le missioni svolte nel
corso del mandato parlamentare, su Trapani potrebbe esserci una specifica
relazione. Sullo scenario già descritto delle connessioni tra mafia e
massoneria, si è sviluppata una attenzione che poteri occulti dedicano proprio
alla Procura di Trapani, "nel 2016 - ha detto il senatore 5 Stelle Giarrusso -
sentiamo magistrati inquirenti che non dicono non sentirsi al sicuro nelle
proprie stanze, che non lasciano documenti in ufficio, un clima assurdo che
rimanda ad altri tempi ed altre vicende". Sulle parole di Giarrusso si sono
ritrovati altri commissari come Fava, vice presidente della Commissione
antimafia: "Siamo preoccupati del clima pesante che riscontriamo nei confronti
degli uffici giudiziari, abbiamo l'esatta percezione che c'è una Procura sotto
tiro, con intrusioni e pedinamenti, sono le reazioni illecite di chi con
fastidio giudica il lavoro della Procura, attenzioni che arrivano da parte di
ambienti inquietanti, la Commissione avrà scrupolo e attenzione". Su questi temi
sono stati sentiti dalla commissione antimafia in prefettura a Trapani il
procuratore della Repubblica Marcello Viola ed i pm Marco Verzera e Andrea
Tarondo, e le dichiarazioni rese dai magistrati sono state secretate. In
particolare la commissione antimafia ha ascoltato i giudici della Corte di
Assise che hanno processato e condannato due boss mafiosi all'ergastolo,
Vincenzo Virga e Vito Mazzara, per il delitto del sociologo e giornalista Mauro
Rostagno, risalente al 1988. "Abbiamo apposta voluto ascoltare i giudici Angelo
Pellino e Samuele Corso, presidente e giudice a latere della Corte - ha detto il
presidente Bindi - perché interessati al processo e interessati a conoscere la
fase dei depistaggi". "Non escludo - ha aggiunto il vice presidente Claudio Fava
- che per questo delitto si faccia ciò che è stato fatto per altri analoghi
delitti". Chiaro il riferimento alla costituzione di una commissione che come è
stato fatto per il delitto di Peppino Impastato, si occupi anche del delitto
Rostagno.
Un'analisi organica dei
rapporti fra massoneria deviata e cosche mafiose è contenuta nella relazione
della Commissione parlamentare antimafia presieduta da Luciano Violante,
scriveva già a suo tempo Salvo Palazzolo. "Il terreno fondamentale sul quale si
costituiscono e si rafforzano i rapporti di Cosa nostra con esponenti dei
pubblici poteri e delle professioni private è rappresentato dalle logge
massoniche. Il vincolo della solidarietà massonica serve a stabilire rapporti
organici e continuativi". Questo il punto di partenza dell'analisi proposta.
"L'ingresso nelle logge di esponenti di Cosa nostra, anche di alto livello, non
è un fatto episodico ed occasionale ma corrisponde ad una scelta strategica -
spiega la Commissione antimafia - Il giuramento di fedeltà a Cosa nostra resta
l'impegno centrale al quale gli uomini d'onore sono prioritariamente tenuti. Ma
le affiliazioni massoniche offrono all'organizzazione mafiosa uno strumento
formidabile per estendere il proprio potere, per ottenere favori e privilegi in
ogni campo; sia per conclusione di grandi affari sia per "l'aggiustamento" dei
processi, come hanno rivelato numerosi collaboratori di giustizia. Tanto più che
gli uomini d'onore nascondono l'identità dei "fratelli" massonici ma questi
ultimi possono anche non conoscere la qualità di mafioso del nuovo entrato"
(punto 57 della citata Relazione). Rapporti fra Cosa nostra e massoneria sono
comunque emersi anche nell'ambito dei lavori di altre due Commissioni
parlamentari d'inchiesta: quella sul caso Sindona e quella sulla loggia
massonica P2, che già avevano approfondito la vicenda del finto rapimento del
finanziere e della sua permanenza in Sicilia dal 10 agosto al 10 ottobre 1979.
Agli atti, le indagini della magistratura milanese e di quella palermitana, che
avevano svelato i collegamenti di Sindona con esponenti mafiosi e con
appartenenti alla massoneria. Il finanziere era stato aiutato da Giacomo Vitale,
cognato di Stefano Bontade, capomafia della famiglia palermitana di Santa Maria
di Gesù e da Joseph Miceli Crimi: entrambi aderenti ad una comunione di Piazza
del Gesù, "Camea" (Centro attività massoniche esoteriche accettate). Nel gennaio
1986 la magistratura palermitana dispone una perquisizione e un sequestro presso
la sede palermitana del Centro sociologico italiano, in via Roma 391. Vengono
sequestrati gli elenchi degli iscritti alle logge siciliane della Gran Loggia
d'Italia di Piazza del Gesù. Fra gli iscritti figurano i nomi dei mafiosi
Salvatore Greco e Giacomo Vitale. Nel mese di gennaio dello stesso anno, la
magistratura trapanese dispone il sequestro di molti documenti presso la sede
del locale Centro studi Scontrino. Il centro, presieduto da Giovanni Grimaudo,
era anche la sede di sei logge massoniche: Iside, Iside 2, Osiride, Ciullo
d'Alcamo, Cafiero, Hiram. L'esistenza di un'altra loggia segreta trova poi una
prima conferma nell'agenda sequestrata a Grimaudo, dove era contenuto un elenco
di nominativi annotati sotto la dicitura "loggia C". Tra questi, quello di
Natale L'Ala, capomafia di Campobello di Mazara. Nella loggia Ciullo d'Alcamo
risultano essere affiliati: Pietro Fundarò, che operava in stretti rapporti con
il boss Natale Rimi; Giovanni Pioggia, della famiglia mafiosa di Alcamo; Mariano
Asaro. Nel processo, vari testimoni hanno concordato nel sostenere
l'appartenenza alla massoneria di Mariano Agate, capomafia di Mazara del
Vallo. Alle sei logge trapanesi e alla loggia "C" erano affiliati imprenditori,
banchieri, commercialisti, amministratori pubblici, pubblici dipendenti, uomini
politici (la Commissione antimafia, nella citata relazione, ricorda come
l'onorevole democristiano Canino, nell'estate del '98 arrestato per collusioni
con Cosa nostra, abbia ammesso l'appartenenza a quella loggia, pur non figurando
il suo nome negli elenchi sequestrati). Già nel processo di Trapani e poi
successivamente in quello celebrato nel '95 a Palermo contro Giuseppe Mandalari
(accusato di essere il commercialista del capo della mafia, Totò Riina) sono
emersi contatti fra le consorterie mafiose e massoniche di Palermo e Trapani.
Mandalari, "Gran maestro dell'Ordine e Gran sovrano del rito scozzese antico e
accettato" avrebbe concesso il riconocimento "ufficiale" alle logge trapanesi
che facevano capo a Grimaudo. Le indagini sui rapporti mafia-massoneria
continuano. Seppur fra tante difficoltà. L'unica condanna al riguardo, ottenuta
dai pm palermitani Maurizio De Lucia e Nino Napoli, riguarda proprio Pino
Mandalari, il commercialista di Riina attivo gran maestro. Solo nel febbraio del
2002, è stata sancita in una sentenza la pesante influenza dei "fratelli" delle
logge sui giudici popolari di un processo di mafia: la Corte d'assise stava
seguendo il caso dell'avvocato palermitano Gaetano Zarcone, accusato di avere
introdotto in carcere la fiala di veleno che doveva uccidere il padrino della
vecchia mafia Gerlando Alberti. Non è stata facile la ricostruzione del pm
Salvatore De Luca e del gip Mirella Agliastro, che poi ha emesso sette condanne:
non c'erano mai minacce esplicite, solo garbati consigli a un "atteggiamento
umanitario". Questo il volto delle intimidazioni tante volte denunciate. Il caso
più inquietante di cui si sono occupate le indagini è quello di una misteriosa
fratellanza, la Loggia dei Trecento, anche detta Loggia dei Normanni. Il pentito
Angelo Siino ha fugato ogni dubbio: il divieto per gli aderenti a Cosa nostra di
fare parte della massoneria restò sempre sulla carta. "Le regole erano un po'
elastiche - spiega - come la regola che non si devono avere relazioni
extraconiugali". Erano soprattutto i boss della vecchia mafia, Stefano Bontade e
Salvatore Inzerillo, ad avere intuito l'utilità di aderire alle logge. Rosario
Spatola seppe da Federico e Saro Caro che Bontade "stava cercando di
modernizzare Cosa nostra. Vedeva più in là, vedeva la potenza della massoneria,
e magari riteneva di potere usare Cosa nostra in subordine, come una sorta di
manovalanza". Per questo aveva creato una sua loggia. Era appunto la Loggia dei
Trecento. Anche Siino riferisce di "averne sentito parlare: si diceva che ne
facevano parte parecchi personaggi quali i cugini Salvo, Totò Greco "il
senatore" e uomini delle istituzioni. La loggia non era ufficiale e non aderiva
a nessuna delle due confessioni, né a quella di Piazza del Gesù né a quella di
Palazzo Giustiniani". Correvano a Palermo i ruggenti anni Settanta. Il pentito
Spatola conferma il ruolo di Bontade come gran maestro della Loggia dei
Trecento. E spiega: "Ne facevano parte soggetti appartenenti alle categorie più
disparate, e per questo era molto potente. E troppa potenza si era creata anche
attorno a Stefano Bontade, per questo andava eliminato lui ma anche la
loggia". Il 23 aprile 1981, Bontade fu ucciso dai corleonesi di Totò Riina e
Bernardo Provenzano. Ha svelato Spatola che fu proprio Provenzano, attuale capo
dell'organizzazione mafiosa, a prendere l'iniziativa di sciogliere la Loggia dei
Trecento. Particolare davvero inedito e curioso. Quale autorità aveva mai don
Bernardo per intervenire d'autorità su una fratellanza tanto riservata? Forse
era massone anche lui? Forse, già allora, aveva ben presenti rapporti e
complicità eccellenti che da lì a poco avrebbero fatto a gara per riposizionarsi
e ingraziarsi i nuovi potenti?
LE RIVELAZIONI DEI
COLLABORATORI DI GIUSTIZIA
Tommaso Buscetta. Nel 1984
parla per la prima volta del rapporto fra mafia e massoneria nel contesto del
tentativo golpista di Junio Valerio Borghese del dicembre 1970. Il collegamento
tra Cosa nostra e gli ambienti che avevano progettato il colpo era stato
stabilito attraverso il fratello massone di Carlo Morana, uomo d'onore. La
contropartita offerta a Cosa nostra consisteva nella revisione di alcuni
processi.
Leonardo Messina. Sostiene che
il vertice di Cosa nostra sia affiliato alla massoneria: Totò Riina, Michele
Greco, Francesco Madonia, Stefano Bontade, Mariano Agate, Angelo Siino (oggi
collaboratore di giustizia pure lui). Ritiene che spetti alla Commissione
provinciale di Cosa nostra decidere l'ingresso in massoneria di un certo numero
di rappresentanti per ciascuna famiglia.
Gaspare Mutolo. Conferma che
alcuni uomini d'onore possono essere stati autorizzati ad entrare in massoneria
per "avere strade aperte ad un certo livello" e per ottenere informazioni
preziose ma esclude che la massoneria possa essere informata delle vicende
interne di Cosa nostra. Gli risulta che iscritti alla massoneria sono stati
utilizzati per "aggiustare" processi attraverso contatti con giudici massoni.
Le conclusioni della
Commissione antimafia presieduta da Luciano Violante. "Il complesso delle
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia appare essere concordante su tre
punti:
- intorno agli anni 1977-1979
la massoneria chiese alla commissione di Cosa nostra di consentire
l'affiliazione di rappresentanti delle varie famiglie mafiose; non tutti i
membri della commissione accolsero positivamente l'offerta; malgrado ciò alcuni
di loro ed altri uomini d'onore di spicco decisero per motivi di convenienza di
optare per la doppia appartenenza, ferma restando la indiscussa fedeltà ed
esclusiva dipendenza da Cosa nostra;
- nell'ambito di alcuni
episodi che hanno segnato la strategia della tensione nel nostro paese, vale a
dire i tentativi eversivi del 1970 e del 1974, esponenti della massoneria
chiesero la collaborazione della mafia;
- all'interno di Cosa nostra
era diffuso il convincimento che l'adesione alla massoneria potesse risultare
utile per stabilire contatti con persone appartenenti ai più svariati ambienti
che potevano favorire gli uomini d'onore". Salvo Palazzolo
LE TERRE DEI FUOCHI.
“L’Italia è una terra dei fuochi”. Lo rivela l’Istituto Superiore della Sanità.
Ma l’informazione balbetta,
scrive Marco Mastrandrea su "Articolo 21" il 13 gennaio 2016. «’O vogl’ squartat
viv’», «‘o giurnalist’ je a spacc a cap’», «ve ne dovete andare». Sono solo
alcune delle parole dei camorristi che hanno minacciato e aggredito fisicamente
diversi giornalisti che hanno solo svolto il proprio mestiere nella Terra dei
Fuochi. Nello Trocchia, Marilena Natale, Sandro Ruotolo, per fare qualche nome.
Ed è proprio Ruotolo che attualmente vive sotto scorta dopo le minacce di
Michele Zagaria, numero uno del clan dei Casalesi, a scrivere dal proprio
profilo facebook: con la pubblicazione dell’11 gennaio a cura dell’Istituto
Superiore di Sanità emerge «il più grande atto di accusa contro lo Stato, lo si
aspettava da 20 anni, ora è arrivato: l’Italia è una terra dei fuochi». Il
rapporto dell’ISS giudica «in eccesso rispetto alla media regionale» il tasso di
mortalità, ricoveri e tumori nell’area. L’allarme drammatico riguarda anche i
bambini: «si osservano eccessi di bambini ricoverati nel primo anno di vita per
tutti i tumori e eccessi di tumori del sistema nervoso centrale, questi ultimi
anche nella fascia 0-14 anni». Dopo tante difficoltà e tante battaglie condotte
da giornalisti, studiosi, comitati e società civile finalmente una notizia che
determina la gravità in cui versa un’area dove è presente un’importante fetta
della popolazione campana. Ma se alcuni si sono sacrificati per raccontare una
terra in difficoltà e soggiogata alla camorra, i quotidiani del 12 gennaio non
sembrano ritenere i dati del rapporto ISS un caso grave, al punto tale da
compiere una scelta editoriale di rilievo. Per “Il Mattino”, storico quotidiano
partenopeo, la notizia va collocata nella sezione locale e solamente dopo il
dibattito attorno alle comunali 2016 e la “festa dall’avvocato al barista” in
doppia pagina sul Napoli, infatti, la squadra di calcio ha vinto il cosiddetto
“campionato d’inverno”. E pensare che gli ultimi giorni del 2015 “Il Mattino”
aveva rivelato con un’inchiesta di Gigi Di Fiore in parte le cifre contenute nel
rapporto dell’ISS. Per il “Corriere della Sera” la notizia va posta nella
sezione cronache a pagina 22 e dedica un minibox nella parte inferiore della
prima pagina; la vicenda non viene menzionata affatto dalla prossima quarantenne
“La Repubblica”. “Il Tempo” si arrischia con il titolo ad effetto: “La Terra dei
Fuochi rom: 2000 roghi”, un’inchiesta in cui dall’area campana si fa un balzo
nella Capitale con tanto di mappa corredata. Il lavoro del quotidiano si
concentra su “la Terra dei Fuochi de’ noantri” con il dito puntato nei confronti
della situazione “esplosiva nei campi rom”: appena citata la vicenda campana che
funge da allaccio per l’inchiesta romana. D’altra parte, le parole di Sandro
Ruotolo spingono ad approfondire il lavoro giornalistico e l’impegno di tutti
attorno alla vicenda come necessità da cogliere in quanto sfida quotidiana non
solo per chi abita queste terre: «Sono incazzato nero e tutto questo non lo
accetterò più. Non sono Howard Beale del Quinto potere. E non sono uno
scienziato. Ma un giornalista che ha raccontato la terra dei fuochi. Accusato di
aver “esagerato”, di essere un catastrofista. Il rapporto dell’istituto
superiore della sanità è una pessima notizia per tutti, perché purtroppo
certifica quello che tutti sapevano e che in tanti hanno finta di non sapere. La
terra dei fuochi è diventata la terra dei morti per avvelenamento. Noi che siamo
vivi non lo possiamo sopportare più».
Il poliziotto comunista che
ha scoperto la terra dei fuochi.
Roberto Mancini è l'investigatore che per primo si è messo sulle tracce dei
veleni sversati in terra di Gomorra. "Io morto per dovere" è il libro in uscita
la prossima settimana che racconta la sua storia: dal collettivo comunista alle
informative in cui descriveva il sistema camorra- massoneria- politica che ha
ucciso un'intera regione. Fino alla sua morte, stroncato da un tumore contratto
durante i sopralluoghi sui terreni colmi di veleni, scrive Giovanni Tizian il 5
febbraio 2016 su “L’Espresso”. Dalla barricate degli anni '70 alla trincea della
terra dei fuochi. Sempre in prima linea. Sempre a sinistra e per la giustizia
sociale. Nel collettivo studentesco del liceo Augusto di Roma all'alba degli
anni di piombo, e poi poliziotto col Manifesto sotto braccio. Con o senza
divisa, Roberto Mancini non ha mai abdicato ai suoi ideali. A 17 anni lottando
con i “compagni” per una società più giusta, a 20, con il tesserino da sbirro,
indagando sui crimini più squallidi. Il poliziotto Mancini non è un eroe. Negli
ultimi anni della sua vita ha tentato in tutti i modi di sfuggire a questa
etichetta. Lui sapeva bene che gli eroi servono a pulire la coscienza di chi non
si sporca le mani. È comodo indicare l'eroe e poi starsene sul divano a guardare
le imprese dei tanti paladini che salveranno questo mondo. Mancini è stato il
primo poliziotto a investigare sui rifiuti tossici. Le sue indagini hanno
anticipato di quasi due decenni la scoperta del disastro ambientale in alcune
zone della Campania, la cosiddetta Terra dei fuochi. Quando era nella
Criminalpol, a metà degli anni Novanta, Mancini ha smascherato la connivenza tra
imprenditoria e camorra; tra politica, massoneria e bassa manovalanza criminale.
Il risultato della sua inchiesta è scritto nero su bianco in un’informativa che,
per qualche sconosciuto motivo, è rimasta chiusa in un cassetto per più di dieci
anni. Mancini ha completato quel documento ormai storico senza mai curarsi dei
rischi che correva. «Voglio credere che allora non fossero ancora maturi i tempi
e l’opinione pubblica non fosse pronta» ha detto il poliziotto poco prima di
morire commentando il fatto che le sue indagini fino a quel momento fossero
state ignorate. I suoi sopralluoghi sui terreni inquinati e l'aria avvelenata
respirata durante l'inchiesta sono stati la causa della malattia che lo ha
ucciso lentamente. La storia di Roberto adesso è un libro dal titolo "Io, morto
per dovere" in uscita il 12 febbraio. Scritto dai giornalistiLuca Ferrari e
Nello Trocchia, edito da Chiarelettere, con la prefazione di Beppe Fiorello e la
postfazione della moglie Monika Dobrowolska Mancini. La vita del poliziotto che
scoprì la terra dei fuochi sarà anche un fiction (in onda il 15 e il 16 febbraio
su Rai Uno), e sarà proprio Fiorello a interpretare Mancini. Il libro è un
racconto intimo della gioventù di Roberto. Gli scontri coi fascisti e le
sassaiole negli anni caldi delle rivolte, il sogno della rivoluzione, la
vicinanza a Democrazia proletaria, la ferma condanna della lotta armata. E
infine, quando il sogno di un mondo migliore era ormai stato distrutto dal
piombo dei terroristi rossi e neri e dal compromesso storico, la scelta di
entrare in polizia, «perché bisogna provare a cambiare il sistema dall'interno»,
tenendo sempre ben distinte la parola legalità dal concetto di giustizia
sociale, che non sempre coincide con la prima. Frammenti di vita, speranze e
illusioni, che gli autori riportano fedelmente facendo parlare i testimoni di
quel periodo e gli amici più cari di Mancini. La prima parte del libro è un
flusso di emozioni. La passione politica e l'impegno che pagina dopo pagina si
trasformano in delusione per come evolve la società, stretta tra violenza e
ingiustizia sociale. Ma “Io morto per dovere” è soprattutto un focus sul lavoro
del poliziotto comunista. Le sue inchieste, le sue informative, i suoi rapporti
inediti inviati alla procura antimafia di Napoli. Nomi, cognomi, affaristi dei
rifiuti, massoni, politici complici che negli anni sono stati promossi a
incarichi di prestigio. Un buco nero della democrazia dove regna il malaffare.
Tutto questo, Roberto, l'aveva scritto prima di tutti gli altri detective.
L'aveva intuito e indagato. L'informativa più importante di tutte è quella dei
primi anni '90. Lì, tra quelle pagine intestate Criminalpol, c'era già tutto il
sistema svelato dalle inchieste del 2000. Gomorra, Mancini, l'aveva conosciuta e
raccontata due decenni fa. Ma nessuno lo ascoltò. Fino a quando un magistrato di
Napoli non ha alzato il telefono e lo ha chiamato nel suo piccolo ufficio del
commissariato di San Lorenzo. La richiesta del pm è semplice: gli chiede di
sbobinare tutte quelle telefonate della sua vecchissima informativa perché gli
servono nel processo contro Cipriano Chianese, l'inventore dell'ecomafia, il
broker dei veleni, ora sotto accusa per disastro ambientale. Finalmente,
l'impegno di Mancini viene riconosciuto. Chianese ha lavorato indisturbato fino
ai primi anni del Duemila. Nelle discariche gestite da Chianese sono finite le
schifezze d'Italia. Rifiuti industriali delle aziende del Nord. E rifiuti
“legali” con l'autorizzazione dello Stato. Eppure, quel Chianese è lo stesso che
Mancini descriveva, già nel '90, come un pezzo grosso del business illegale
della “monnezza”. Quando era un avvocato, di Forza Italia, candidato al
Parlamento. A metà tra massoneria, camorra e politica. Una cerniera tra tre
mondi, i cui interessi stavano avvelenando una terra bellissima e fertilissima.
Se solo quel documento eccezionale fosse stato considerato nella sua importanza
probabilmente quei territori non sarebbero stati uccisi. Ormai è tardi per
impedirlo. L'omicidio ambientale è compiuto. Roberto Mancini è morto di tumore.
I complici insospettabili del clan dei rifiuti hanno fatto carriera. Ma non
tutto è finito, non tutto è perso. C'è ancora una speranza per Roberto. È
nell'opera di verità che sta cercando di compiere il pool antimafia della
procura di Napoli. Il magistrato Alessandro Milita rappresenta l'accusa contro
Chianese. In quel processo i rapporti firmati Mancini stanno giocando un ruolo
decisivo. Dà fastidio alla camorra anche da morto. E in fondo, il compagno
Roberto è contento così.
La fondina a destra e «il
Manifesto» sotto braccio.
Pubblichiamo un capitolo tratto dal libro 'Io, morto per dovere'
di Luca Ferrari e Nello Trocchia, sulla storia del poliziotto Roberto Mancini.
La storia è diventata anche una fiction, interpretata da Giuseppe Fiorello, in
onda su Raiuno il 15 e il 16 febbraio, scrive il 5 febbraio 2016 “L’Espresso”.
In libreria dal 12 febbraio per Chiarelettere il libro "Io morto per dovere, la
vera storia di Roberto Mancini, il poliziotto che ha scoperto la Terra dei
fuochi" di Luca Ferrari, Nello Trocchia con Monika Dobrowolska Mancini. La
storia è diventata anche una fiction per la televisione, interpretata da
Giuseppe Fiorello, che sarà trasmessa su Raiuno il 15 e il 16 febbraio. Quando
Roberto parte per Trieste per seguire un corso di sei mesi, mamma Giovanna alla
stazione Termini lo stringe in un forte abbraccio. Non una lacrima di fronte a
lui, ma a casa afferra i panni del ragazzo, li annusa, se li passa sul viso e
scoppia in un pianto dirotto. «Robe’, sei nato per farmi soffrire» ripeterà per
giorni nella sua solitudine. Un nuovo cambiamento radicale, l’arruolamento in
polizia dopo gli anni del liceo vissuti con la paura costante guardando in tv
gli scontri di piazza e pregando perché il figlio «ribelle», come lo chiamava
una delle sue docenti, tornasse a casa sano e salvo. E pensare che poco dopo
sarebbe arrivata anche l’assunzione da parte delle Ferrovie dello Stato, ma
Roberto ha fatto ormai la sua scelta definitiva: sarà uno sbirro in prima linea
e non un capotreno. In quel periodo Mancini tiene un fitto carteggio con Gianni
Angelici e la corrispondenza con l’amico scolpisce il suo stato d’animo. «Il mio
allontanamento altro non è stato che il “frutto dei tempi”, non trovarsi più a
proprio agio nell’ambiente nel quale sono cresciuto, in cui ho passato i momenti
più belli e divertenti nonché i più tristi. Ho condiviso con tutti voi i miei
pensieri, i miei stati d’animo di persona triste, ma a un certo momento mi sono
reso conto che quelle cose erano ormai superate, storicamente determinate, e che
era inutile continuare a vivere situazioni ormai passate, che era futile
impegnarsi per ricercare episodi e momenti che, a loro tempo, avevano suscitato
emozioni originalissime, ma che ora risultano assiduamente patetiche e
nostalgiche.» E ancora: «La tristezza sale sempre più, il senso di nullità
pervade tutto il mio essere». Roberto rimugina i pensieri mentre li scrive, quel
cambiamento in atto lo sta mettendo senz’altro a dura prova: «Sono privo di
qualunque certezza. Mi aiuterebbe molto in questo momento, e anche in altri,
averti vicino per cercare di capirci fino al limite del possibile. [...] Erro
misero e solo». Al giuramento la famiglia arriva al completo. La madre lo
ritrova, fiero, dopo pochi mesi, nella sua divisa di ordinanza. C’è anche lo zio
Betto, quello che era stato pestato dai neri, che si guarda intorno attonito e
che mai avrebbe immaginato di trovarsi in quel luogo ad applaudire, orgoglioso,
il nipote comunista e guardia. Di lì a poco Roberto sarebbe diventato il più
giovane viceispettore di polizia d’Italia. Tornerà presto a Roma, al ministero
dell’Interno. Come al solito testardo, capace. Sarà lui stesso, sul letto
d’ospedale, poco prima di morire, a enfatizzare lo spirito che l’ha sempre
contraddistinto, scrivendo: «L’essere quel che sono mi ha penalizzato. La
professionalità dovrebbe essere l’unico elemento di giudizio, dovrebbe essere
sempre presente nella valutazione delle capacità di un investigatore. E invece
no! È obbligatorio obbedire agli ordini superiori al di là di ogni logica, al di
là di ogni buon senso e così la carriera è assicurata». E ancora: «Per fare
carriera devi essere quel che non sei. Devi uniformarti al comportamento della
massa. Non devi discutere le decisioni dei superiori. Soprattutto non devi
dimostrare che ne sai di più di chi deve decidere!». Sono queste le regole per
avere successo in polizia, ma Roberto non si piega e qualcuno nell’ambiente non
gli perdona il suo odio per la neutralità. «Il manifesto» sotto braccio procura
la reazione di alcuni colleghi: «Ci siamo messi il nemico in casa» è la frase
che serpeggia nei corridoi, e Roberto finisce a mettere in ordine le auto di
servizio nella rimessa. All’Ucigos – l’Ufficio centrale per le investigazioni
generali e per le operazioni speciali – dura poco: quello strazio, quell’ordine
rarefatto, quella disciplina finta, quell’imposizione, quella boria, quel
retaggio fascista non fanno per lui. Roberto parte di nuovo, inizia il suo giro
per l’Italia, passerà diversi anni tra la Toscana e l’Umbria. Ogni città amori e
sogni, divisa e conflitti. Tornerà a Roma alla Criminalpol per iniziare a
occuparsi di crimine organizzato, siamo a metà degli anni Ottanta.
Quell’esperienza lo porterà a indagare poco dopo sull’organigramma
imprenditoriale, affaristico e politico che ha saccheggiato risorse pubbliche e
devastato territori.
Tra roghi e indifferenza la
Terra dei Fuochi continua a bruciare,
scrive Marco Cesario il 3 Agosto 2015 su “L’Inkiesta”. Napoli. Il viaggio nella
Terra dei Fuochi comincia quasi sempre qui, lungo una tetra strada che serpeggia
tra caseggiati, pescheti e campi coltivati che s'estendono a perdita d'occhio.
L’asse mediano è una strada a scorrimento veloce che collega Napoli e i comuni
dell'hinterland partenopeo ai paesi del casertano. Basta percorrerne pochi
chilometri per essere investiti dal lezzo acre e pungente dei roghi che spuntano
qua e là nel territorio appestando l’aria di chi ci vive. Le rare piazzole di
sosta che costeggiano la strada sono trasformate in improvvisate discariche a
cielo aperto. Giuseppe Ruggiero, dirigente campano di Legambiente, fu il primo
nel 2003 a coniare il termine “Terra dei Fuochi” in riferimento ai roghi di
pneumatici e di materiali tossici che tempestavano la zona. Oggi come allora
niente è cambiato e l’aria continua ad essere irrespirabile. Ogni giorno decine
di segnalazioni vengono raccolte sulla pagina Facebook “La Terra dei Fuochi”
mentre i riflettori su queste terre si sono quasi spenti, salvo riaccendersi
improvvisamente quanto si torna a parlare di tumori che colpiscono gli abitanti
della zona. Percorrendo questa strada, viene improvvisamente in mente quanto
nota Alessandro Iacuelli nel suo libro-inchiesta “Le vie infinite dei rifiuti”.
C'è stata una vera e propria mutazione del registro dello smaltimento dei
rifiuti tossici. La tecnica di smaltimento con grossi camion e ruspe all’interno
di cave abusive o laghi artificiali, dopo le decine di inchieste della
magistratura, le dichiarazioni dei pentiti e i successivi scavi, è stata oramai
accantonata e rimpiazzata da una nuova tecnica, più leggera ma ugualmente nociva
perché costante. Il “piccolo smaltimento”. Piccoli furgoni o motocarri con fusti
che vengono lasciati in un posto e poi bruciati con una tecnica rudimentale ma
molto efficace: una base di pneumatici fuori uso sui quali vengono deposti i
rifiuti tossici ricoperti di benzina. Spesso ad appiccare questi roghi sono
poveri diavoli che non sono altro che l’ultima catena del processo. I roghi
sprigionano alte colonne di fumo nero e altamente tossico. Ecco cosa rende
l’aria qui completamente irrespirabile. I fusti vengono bruciati con una tecnica
rudimentale ma molto efficace: una base di pneumatici fuori uso sui quali
vengono deposti i rifiuti tossici ricoperti di benzina. A Frattamaggiore, Luigi
Costanzo è medico di famiglia ISDE Napoli, e fa parte di una rete di medici che
lavora per la creazione di un registro tumori del territorio. «Io sono medico di
famiglia – spiega a L’Inkiesta Costanzo - e ho circa 1600 assistiti. Il medico
di famiglia è quello che tocca con mano le realtà del territorio e conosce da
vicino le patologie che ne colpiscono gli abitanti. Con altri colleghi abbiano
cercato di raccogliere dei dati che noi come medici di famiglia abbiano nei
nostri database. In questi database è già presente un piccolo registro tumori.
Se incrociamo i dati di tutti i medici di famiglia del territorio possiamo, a
tempo zero e a costo zero, effettuare una fotografia del territorio. Un progetto
del genere è stato fatto a Casoria e si chiama EPI.CA (EPIdemiologia
CAncro ndr). Sia i pediatri sia i medici di famiglia hanno estrapolato dei dati
ed hanno dimostrato che c’è un aumento d’incidenza di tumori nel territorio dove
questi medici di famiglia esercitano la propria professione. Io, per quanto
riguarda la mia esperienza, ho assistito ad un aumento di patologie tumorali che
colpiscono soprattutto giovani. Nello specifico per quanto riguarda il tumore
alla mammella, su 1600 pazienti, ho cinque donne che sono al di sotto dell’età
dello screening della mammella, che è i 45 anni, affette da patologie tumorali.
Oltre a questo però, possiamo anche agire ad un secondo livello, ovvero quello
della geo-localizzazione. Conoscendo dove abitano i pazienti possiamo anche
geo-localizzare la malattia ovvero sapere se in una determinata area c’è una
concentrazione maggiore di patologie rispetto ad un’altra. È un’operazione
importante perché in quelle aree in cui ci sono picchi di malattia possiamo
stabilire se è stato commesso anche qualche delitto ambientale e lasciare in
seguito gli scienziati e gli epidemiologi studiare i nostri dati grezzi e
stabilire il nesso e l’impatto sulla salute umana. In attesa del famoso registro
tumori dunque possiamo già fornire delle prime risposte a quelli che sono i
problemi che attanagliano il nostro territorio». Luigi Costanza è un medico di
famiglia: «Per quanto riguarda la mia esperienza, ho assistito ad un aumento di
patologie tumorali che colpiscono soprattutto giovani». Era il lontano 1991
quando un certo Mario Tamburino, camionista italo-argentino, correva in ospedale
a Pozzuoli per un improvviso bruciore agli occhi che gl’impediva anche di
vedere. Di li a poco sarebbe diventato completamente cieco. Quel bruciore era
provocato da gocce di una sostanza corrosiva fuoriuscita dai fusti tossici (ben
571) che lui stesso aveva caricato a Cuneo, in Piemonte, presso un’azienda
specializzata nello smaltimento di rifiuti pericolosi, e aveva scaricato in una
fossa nelle campagne di Sant’Anastasia, a Nord di Napoli. Dall’inchiesta che ne
scaturì nacque la parola “ecomafia” e si palesò un business di miliardi tra
l’imprenditoria del Nord Italia e la classe politica campana. Due anni prima,
nell’albergo ristorante ‘La Lanterna’ di Villaricca, un conciliabolo di
politici, camorristi, mafiosi, esponenti della Loggia Massonica P2 e servizi
deviati stringevano un patto diabolico per sotterrare nella Campania Felix
milioni di tonnellate di rifiuti tossici. Ma gli scavi sarebbero iniziati molto
tempo dopo grazie anche ad un metodo innovativo. A raccontare i passi salienti
che hanno portato ai primi scavi è Sergio Costa, generale e comandante Regionale
in Campania del Corpo Forestale dello Stato. «È accaduto circa quattro anni fa –
dice a L’Inkiesta - quando io sono stato nominato Comandante provinciale di
Napoli del Corpo Forestale dello Stato. Essendo considerato un esperto di
investigazioni antimafia ambientali, ho iniziato, con quella nomina, a studiare
fascicoli, a raccogliere dati e a elaborare un metodo investigativo innovativo:
ho messo in relazione tutte le ortofotogrammetrie, le foto aeree degli ultimi
vent’anni, le banche dati italiane, le ho raffrontate con ogni singola zona
della superficie della Campania, soprattutto le zone di Napoli e Caserta, ed ho
avuto l’idea di incrociarle con lo studio dei campi magnetici della crosta
terrestre. Mettendo insieme foto in cui è palese che ci sono stati determinati
movimenti e dati che dicono che non c’è un campo magnetico normale ma c’è
qualcosa di anomalo ho tratto certe conclusioni. In più c’è stata l’attività di
polizia info-investigativa (testimoni, denunce, prove sul territorio). Mettendo
insieme tutti questi elementi e grazie anche alla creazione di un’équipe di
esperti siamo riusciti a convincere il giudice ad effettuare il sequestro ed il
successivo scavo. Col tempo abbiamo individuato le discariche di Caivano, Casal
di Principe, Castel Volturno, Villa Literno, fino a quest’ultima recentissima di
Calvi Risorta che potrebbe essere forse la più grande d’Europa (è grande circa
25 ettari). Finora abbiamo disseppellito circa 5 milioni di metri cubi di
rifiuti tossici ma questo potrebbe essere solo il 25% del totale. Il resto è
ancora da disseppellire». E i roghi quotidiani? «I roghi - spiega il generale
Costa - dal punto di vista criminale, hanno la stessa matrice delle discariche
abusive. Si tratta di rifiuti che attività in nero in regime di evasione fiscale
ed evasione contributiva smaltiscono, seppelliscono o accatastano e bruciano. Si
tratta di aziende che producono in nero e dunque smaltiscono in nero. Se non si
aggrediscono queste aziende non si possono ottenere risultati di nota».
Come se non bastassero le
tonnellate di rifiuti tossici seppelliti in queste terre oggi il ‘biocidio’
continua dunque sotto forma di roghi, che proliferano a tutte le ore del giorno
e della notte, come ricorda l'attivista Vincenzo Petrella dei Volontari
Antiroghi di Acerra. «Noi siamo un gruppo di volontari che nasce dalla necessità
di dare un freno a tutti questi roghi appiccati a tutte le ore del giorno –
spiega Vincenzo – e soprattutto la sera e a notte inoltrata. Giriamo la sera
dalle 23 in poi facendo il giro di tutta la periferia a caccia di roghi
appiccati, soprattutto in quelle campagne isolate dove potrebbero bruciare per
tutta la notte e nessuno se ne accorgerebbe. Noi segnaliamo subito i roghi alle
autorità e aspettiamo l'arrivo dei vigili del fuoco. Ma teniamo sott'occhio
anche gli sversamenti». Enzo Tosti è un attivista che conosce molto bene le zone
e fa parte del Coordinamento Comitati Fuochi. Davanti alla chiesa di Caivano,
dove padre Maurizio Patriciello, simbolo della battaglia per la rinascita di un
territorio inquinato dai rifiuti versati, s’appresta ad accompagnare un gruppo
di missionari nella zona della discarica Resit di Giugliano, spiega: «Quando
Legambiente parlò per la prima volta di Terra dei Fuochi parlava di un’area
molto circoscritta, ovvero del cosiddetto triangolo della morte tra Nola e
Marigliano. Oggi dobbiamo renderci conto che l’area non è soltanto circoscritta
a quel triangolo ma è molto più vasta. Partiva da quelle zone per arrivare
all’agro aversano e fino al litorale domizio, ovvero un’area che interessa
milioni di abitanti. La zona è stata declassata da SIN (sito d’interesse
nazionale) a SIR (sito d’interesse regionale) ma non perché la situazione sia
migliorata ma perché lo stato se n’è voluto semplicemente lavare le mani. La
Campania è soltanto la punta di un iceberg che evidenzia un sistema produttivo
italiano ed internazionale non sostenibile e che non tiene conto né della vita
umana né dell’ambiente. Il rogo poi non ha una matrice diversa da quella del
seppellimento dei rifiuti tossici ed è strumentale ad un indotto industriale che
lavora localmente al nero. Parliamo dell’industria tessile e calzaturiera locale
collegata con le grandi griffe nazionali ed internazionali. A che punto siamo
oggi? Tutto quello che ha sbandierato il governo non è servito a nulla perché i
roghi continuano. La Terra dei Fuochi continua a bruciare». «A che punto siamo
oggi? Tutto quello che ha sbandierato il governo non è servito a nulla perché i
roghi proseguono. La Terra dei Fuochi continua a bruciare». Enzo Tosti, padre
Maurizio Patriciello ed un gruppo di missionari si recano dunque in prossimità
della discarica Resit. Qui la camorra ha sversato tonnellate di rifiuti
pericolosi. Il 23 luglio scorso un incendio è divampato all’interno della
discarica. Dietro le transenne ancora s’intravede un cumulo fumante. «È una
sorta di autocombustione interna - nota padre Maurizio Patriciello - Chissà cosa
ci hanno seppellito, qui è proprio un inferno e lo stato ci ha completamente
abbandonati. Ricordo quando scoppiò il problema dei rifiuti in Campania. Ne
hanno approfittato per mettere a tacere il problema più grosso e grave, ovvero
quello delle discariche di rifiuti tossici». Enzo Tosti spiega che quando sei
sotto vento e quell’aria ti entra nei polmoni stai male. «Io ho avuto conati di
vomito e sono stato male tutto un pomeriggio dopo aver respirato quell’aria». È
necessario allontanarsi dalle transenne, troppo pericoloso restare li. Dopo
qualche minuto, proprio a fianco alla discarica, un contadino passa in auto. Si
ferma a parlare con il parroco. «Don Maurizio - dice - qui potete aiutarci solo
voi». Fa riferimento non solo alla discarica fumante che intossica l’aria ma
anche a quei prodotti che non sono inquinati ma che nessuno compra più. Oramai
oltre i danni ambientali ci sono anche quelli collaterali. Anche se i prodotti
ortofrutticoli sono controllati e sani è difficile piazzarli sul mercato. Il
vento spinge le esalazioni lontano eppure l’odore acre è insostenibile. Per
evitare spiacevoli conseguenze, il gruppo si muove poche centinaia di metri più
in là per un’altra visita sorprendente. Attaccato ad un'altra discarica e a
poche centinaia di metri da un sito dove rifiuti pericolosi continuano a
bruciare, sorge un campo rom dove risiedono settanta famiglie (circa trecento
persone) di cui duecento bambini. I bambini giocano tra i rifiuti di una
discarica a cielo aperto e respirano a pieni polmoni le esalazioni della
discarica che pure quando il vento soffia in una certa direzione giungono fino a
qui. Difficile non chiedersi come si possa lasciare vivere dei bambini in mezzo
a discariche e esalazioni tossiche. È quasi come lasciarli in mezzo alle bombe.
I missionari abituati a luoghi poveri d'Africa e del Sudamerica forse non si
aspettavano di vedere tanta miseria e abbandono in un paese “civilizzato” come
l'Italia. Uno dei responsabili del campo racconta che è lo Stato ad averli messi
li dopo successivi sgomberi da altri campi. «Ci hanno messo qui per far morire i
nostri bambini di tumore» protestano. Dopo un po’ il gruppo di missionari viene
circondato da un gruppo di bambine. Sono incuriosite dai nuovi arrivati. Alcune
sono bellissime, dagli occhi verdi ed i capelli arruffati. Altre camminano con i
piedi scalzi nella melma sorridendo. Sguardi speranzosi ed innocenti il cui
futuro è più cupo che mai. Il pensiero va subito ad Anna Magri, che qui, nella
Terra dei Fuochi ci ha perso un figlio, il piccolo Riccardo, di soli ventidue
mesi. Coi suoi grandi occhi verdi che si velano di tristezza nel ripercorrere le
tappe di quella tragedia, Anna racconta la diagnosi, le cure e poi il terribile
epilogo. Da allora, una ricerca continua delle cause e poi l’amara scoperta,
quella Terra dei Fuochi e quelle discariche di rifiuti tossici disseminate
ovunque. Dal dramma però nasce anche l’esigenza di federarsi con altre mamme,
altri cittadini, attivisti per proteggere altre vite innocenti, per scoprire la
verità, per aiutare questa terra martoriata a risorgere. Ultime tappa del
viaggio a Villaricca. Maura Messina è nata qui ed ha solo ventisei anni quando
le diagnosticano un tumore. Ha un’energia contagiosa e gli occhi che sprizzano
una gioia quasi incontenibile. «Da quando sono guarita ogni giorno per me è
Capodanno» dice sorridendo. Basta guardarla negli occhi per crederle. Ma la sua
è stata una battaglia dura, che continua tutt’oggi. Maura racconta le cure, la
paura, la difficoltà di mantenere le amicizie, il sostegno della famiglia e del
ragazzo che l’hanno aiutata ad affrontare questa dura tappa della sua esistenza.
Cosi, decisa a combattere contro il suo personale e terribile nemico, s'imbarca
nella prova più dura e dolorosa della sua vita usando anche i mezzi della
letteratura e del disegno per sopravvivere. Ne nasce così un diario che, con
delicatezza, sensibilità e un tocco d'ironia, racconta per parole e per immagini
la storia di una viaggiatrice in un altro mondo, quello difficile e oscuro della
chemioterapia, da cui deriva il titolo del suo libro “Storia di una kemionauta”
(Homo Scrivens). Non so se è la battaglia contro la malattia ad averla forgiata,
la catarsi della letteratura oppure è proprio la sua natura gioiosa ma
sentendola ridere di gusto tra le mura serene della sua casa è come se la Terra
dei Fuochi tutta intera ridesse. Dei suoi mali, delle sue paure, della sua
insospettabile forza.
Il Sud avvelenato dalla
“monnezza di stato”: un nuovo libro sulla terra dei fuochi.
Antonio Giordano, oncologo e docente alla Temple University di Philadelphia, e
il giornalista Paolo Chiariello firmano un libro che ripercorre la storia dello
scempio che ha portato alla terra dei fuochi tra le provincie di Napoli e
Caserta, tra stato colluso, politica inerte, scienza negazionista e stampa
omertosa, scrive Nunzia Marciano il 22 gennaio 2015 su “La Voce di New York".
Monnezza di stato: è già nel titolo, esplicativo, diretto, duro, drammatico e
paradossale che ben si comprende il lavoro dovizioso che diventa denuncia di
Antonio Giordano, oncologo e direttore dello Sbarro Institute for Cancer
Research and Molecular Medicine della Temple University di Philadelphia (oltre
che columnist di recente acquisizione de La VOCE di New York), che, a quattro
mani con il giornalista Paolo Chiariello, ripercorre lo scempio che ha portato
alla terra dei fuochi, al disastro tra le provincie di Napoli e Caserta. Le
Terre dei Fuochi nell’Italia dei veleni, questo il sottotitolo del libro con
prefazione a cura di Franco Roberti, procuratore nazionale Antimafia edito dalla
Minerva Edizioni. Le “terre”, perché non c’è solo la Campania, la morte non c’è
solo tra Acerra, Giugliano e Casal di Principe. Il libro va oltre. Scoperchia i
legami fittissimi tra la Camorra senza scrupoli, la politica inerte, lo stato
connivente, la scienza negazionista e la stampa silente. La strada per uscirne
c’è, “la strategia”, ci dice Giordano, “è nelle bonifiche di quei territori e
soprattutto nella prevenzione per la popolazione (3,5 milioni di abitanti, nda)
che vive quelle zone. Cittadini che sono suscettibili a sviluppare patologie in
maniera più elevata rispetto ad altre zone”. Tra gli aspetti clamorosi poi, c’è
l’atteggiamento della scienza “omertoso”, come lo definisce Giordano, su
qualcosa che si sapeva da 40 anni. E neppure la necessità di non creare
allarmismo può giustificare un atteggiamento del genere, poiché, continua
l’oncologo, “l’allarmismo vale se si dicono cose non vere”.
Antonio Giordano: prima la
conoscenza, poi la protesta. Quante sono le terre dei fuochi? L'Italia è tutta
avvelenata?
«Nel
libro analizziamo la realtà campana che, grazie all’attività della magistratura,
della stampa, ma anche dei cittadini che si sono riuniti, spontaneamente, in
associazioni, hanno portato alla ribalta un problema che affligge quel
territorio così come altre zone d’Italia e, più in generale, del mondo.
Pensiamo, ad esempio, all’Africa diventata la discarica dei Paesi più
industrializzati, ma anche all’America. È evidente che il business dei rifiuti
tossici è globale e che non conosce confini, tuttavia diversi sono i rimedi. In
Texas, per esempio, sono state effettuate opere di bonifica che hanno
drasticamente ridotto il problema e l’impatto sulla salute dei cittadini. In
Italia troppo poco è stato fatto».
Nel suo libro ha
evidenziato i legami strettissimi tra camorra, politica, imprenditoria e,
persino scienza. Legami strettissimi, dicevamo. Come combatterli se anche la
scienza diventa connivente quando nega l’evidenza?
«Il
problema, come diceva, investe differenti categorie sociali. Questo è il motivo
per cui non mi stanco di profondere il mio impegno all’interno delle scuole e
delle università. La nostra generazione e quella precedente hanno fallito. La
speranza del mondo sono i giovani di oggi».
Nel libro si parla di
camorra e di mafia, ma anche di terrorismo. Qual è la differenza tra questi due
tipi di criminalità?
«Sinteticamente
possiamo dire che il terrorismo ha combattuto e combatte lo Stato dall’esterno
mentre la camorra, così come la mafia, ha le sue estensioni e ramificazioni
negli organi dello Stato attraverso referenti insospettabili e di spicco».
Il suo libro è molto
divulgativo. Crede che basti scrivere per diffondere l'informazione? Crede nelle
manifestazioni di piazza, nei cortei, nelle associazioni? È quella la strada da
imboccare, quella della protesta?
«Credo
che la protesta fine a se stessa debba essere definita sterile. La conoscenza
dei problemi, invece, e la conseguente protesta, possono accendere i riflettori
sulla questione ambientale e sconfiggere l’immobilismo in cui ci hanno costretti
a vivere per oltre quarant’anni. Oggi i cittadini vogliono sapere, sono
desiderosi di informarsi e di contare nelle decisioni che riguardano se stessi e
le loro famiglie. Un esempio recente è quello dei cittadini di Ercolano che si
sono stretti intorno al loro parroco, Don Marco Ricci, per raccogliere le firme
e denunciare l’aumento delle patologie tumorali in una zona dove insiste una
discarica di rifiuti tossici. Ecco l’opinione pubblica ha finalmente coscienza
del problema e si unisce per denunciare. Dove i politici non provvedono,
tradendo il mandato che gli hanno conferito gli elettori, si trovano di fronte
alle proteste. È finito il tempo in cui ci si affidava alla classe politico
dirigenziale. Oggi la gente ha capito che deve muoversi in prima persona».
L'America è oramai la sua
seconda patria. Ma ci sono anche lì "terre dei fuochi" o è un fenomeno made in
Italy?
«È
innegabile che anche l’America viva il problema dell’inquinamento. La differenza
rispetto all’Italia consiste nella certezza della pena. I colpevoli, una volta
assicurati alla giustizia, pagano anche attraverso importanti risarcimenti ai
danneggiati e alle loro famiglie. Inoltre, la classe politica americana così
come quella amministrativa è più sensibile ed educata alla tutela del
territorio. Forse perché beneficia, da sempre, di un maggiore e più costante
ricambio generazionale».
Nel 1992, ha individuato e
clonato il gene oncosoppressore RB2/p130, che ha una funzione di primaria
importanza nel ciclo cellulare dal momento che controlla la corretta
replicazione del DNA e, quindi, previene l'insorgenza del cancro. Lei, ad oggi,
dirige lo Sbarro Istitute di Philadelphia: quali passi avanti sono stati fatti
dalla sua scoperta? Ci sarà davvero un giorno la cura per il cancro? E, infine,
crede che se ci fosse una cura "alternativa" questa potrebbe essere ostacolata
dalle multinazionali farmaceutiche che non avrebbero interesse a diffonderla?
«I
passi fatti dagli scienza dagli anni Novanta ad oggi sono immensi e sono sicuro
che nel prossimo futuro ci saranno delle cure sempre più specifiche e tagliate
su misura rispetto al male del paziente. Del resto questo già sta accadendo.
Relativamente alle multinazionali posso dire che il condizionamento della
ricerca da parte loro si concretizza maggiormente in quei Paesi in cui la
ricerca è poco finanziata dal Governo, come ad esempio avviene in Italia. In
America, invece, questo fenomeno è fortemente ridotto. Le grandi scoperte
avvengono all’interno delle Università da sempre sostenute dal Governo Federale
Americano. Mi auguro, quindi, maggiori investimenti nel settore della ricerca
scientifica in Italia. Nessuno è immune, nessuno è innocente, nessuno che può
tirarsene fuori. Tra gli attori del disastro sinonimo di morte che ha infangato
anche l’immagine di ciò che ancora c’è di buono, c’è anche la stampa. E senza
nascondersi dietro ad un dito, lo sottolinea il giornalista Chiariello: “Il
ciclo dei rifiuti – spiega – era in mano ad aziende proprietarie di importanti
testate nazionali ed è per questo che i messaggi in passato non sono stati
divulgati, anche perché allora senza i social network, non c’era interesse a che
le informazioni passassero. Oggi c’è un bel pezzo di società che ha capito che
bisogna liberarsi da un'informazione non corretta”».
Una criminalità
onnipresente, uno Stato inerme, una politica collusa, un'imprenditoria malsana,
una scienza negazionista. E un'informazione che tace. Questi gli attori dello
scempio, come descriveresti le responsabilità di ciascuno?
Qualunque discorso serio
intorno ai veleni che respiriamo, alle acque avvelenate, alle terre che hanno
ingoiato rifiuti d’ogni genere, non può prescindere da una premessa: non esiste
solo una terra dei fuochi in Campania. È un dramma che colpisce anche altre
regioni dove però si finge che il problema non esista. L’Italia è un Paese che
deve sciogliere un nodo serio: ogni anno il giro d’affari in euro del traffico
di rifiuti speciali, ossia della sola produzione industriale, si aggira sui
sette miliardi di euro. Quel che inquieta è la discrasia nei dati tra rifiuti
industriali prodotti e quelli smaltiti. In pratica sappiamo che produciamo un
tot di tonnellate di rifiuti industriali, ma poi di fatto legalmente abbiamo
dati secondo cui vengono smaltite decine di migliaia di tonnellate in meno. Che
fine fanno questi rifiuti industriali che mancano all’appello? Dove vanno a
finire? Chi li smaltisce? Dove vengono smaltiti? Molte tonnellate le stiamo
trovando sotto terra tra Napoli e Caserta. Noi lo sappiamo. Sappiamo che questi
rifiuti sono stati affidati a cifre irrisorie da imprenditori del Nord ai
camorristi del clan dei Casalesi che hanno fatto fortune incredibili interrando
tutto in Campania e in altre regioni del Sud. Se ne parla poco inspiegabilmente
ma Lazio, Molise, Puglia hanno subito lo stesso affronto, le stesse ferite. E
ora veniamo al resto della domanda. Tutto questo è potuto succedere perché Stato
e Antistato spesso sono andati a braccetto. Negli anni passati si è realizzato
tra Napoli e Caserta un patto scellerato tra Stato, Camorra e imprenditoria
deviata, sulla pelle dei cittadini».
L’informazione è stata
silente, ha taciuto?
«I
fatti dicono che un giornalista è stato ucciso (Giancarlo Siani) perché voleva
fare luce sui rapporti Stato-camorra. I fatti dicono che uno scrittore, Roberto
Saviano, vive scortato, da fantasma, ed è costretto a stare fuori dai confini
nazionali perché vogliono ucciderlo in quanto colpevole di aver acceso un faro
permanente sui loschi traffici del clan dei Casalesi, quelli che hanno
accumulato miliardi di euro con i rifiuti interrati sotto i nostri piedi. I
fatti dicono che senza questi giornalisti e senza la gente che è scesa in
piazza, si è ribellata, il dramma della terra dei fuochi non avrebbe mai avuto
l’attenzione che meritava. Quanto alla scienza negazionista o positivista, non
amo partecipare ai dibattiti sul nulla. La scienza si fa nei laboratori e negli
istituiti specializzati, dove nasce una sana competizione. Quando la scienza
esce da questi ambiti, diventa marketing e spesso fa anche cattiva comunicazione
non è più scienza ma qualcos’altro. Non ne posso più di politici che parlano di
scienze, scienziati che fanno politica, giornalisti che dicono messa e preti che
fanno i reporter».
Vittime delle terre dei
fuochi sono i cittadini. Quanta consapevolezza credi ci sia oggi rispetto al
passato?
«Credo
che l’attenzione e la consapevolezza della gente sia massima in questo momento.
Troppi morti per tumori, troppa disattenzione dello Stato hanno costretto la
gente a documentarsi, a confrontarsi anche con esperti per capire che cos’è
successo, che cosa sta succedendo nella loro terra, perché tanti di loro muoiono
di tumori, che cosa c’è di vero nella questione delle falde acquifere
avvelenate, dei camorristi che hanno interrato i veleni».
Molti studi sulla terra dei
fuochi, che in realtà sono "le" terre dei fuochi, partono dall'America: credi
che all'estero ci sia una diversa libertà di ricerca e di conoscenza e,
soprattutto, di espressione?
«In
Italia libertà e indipendenza della ricerca scientifica, così come la libertà
d’espressione e d’informazione sono aspetti della nostra quotidianità da
incentivare, migliorare. C’è sempre troppa politica dietro scienza e
informazione. Se siamo arrivati tardi a stimolare una sensibilità seria rispetto
ai temi dell’ambiente forse la responsabilità è stata anche di una informazione
un po’ superficiale e di una scienza che non sempre ha brillato per indipendenza
dal potere politico. Sapere che il Governo federale americano trova risorse per
finanziare una ricerca sulla salubrità dell’ambiente e delle acque in un pezzo
d’Italia (la zona tra Napoli e Caserta) dove ci sono suoi concittadini che
lavorano (militari e civili delle basi USA) fa piacere, fa rabbrividire che
l’Italia non usi la stessa attenzione per i suoi cittadini sul suo territorio».
Molto spesso la stampa tace
perché (come sottolineavi) è condizionata da chi ne detiene la proprietà. Questo
significa che in Italia non esiste un'informazione libera? Come può un cittadino
fidarsi degli organi di informazione?
«La
libertà d’informazione quando è condizionata non la si può più definire libertà,
proprio perché ha un limite nel momento in cui può essere condizionata. Dire che
dietro certi gruppi editoriali importanti ci sono gruppi economici o anche
politici è la rappresentazione di una verità fattuale che rende il nostro Paese
una sorta di unicum nella comunità internazionale occidentale. In fondo quando
parliamo di confitto di interessi, concentrazioni editoriali, a questo ci
riferiamo. Poi però devo aggiungere che anche in questi gruppi editoriali, è il
giornalista che può e anzi deve ritagliarsi il massimo della libertà. È qui, in
questi contesti, che un giornalista italiano riesce a stabilire se è un cane da
guardia delle istituzioni piuttosto che un cane da salotto o da riporto dei
potenti di turno».
Monnezza di Stato descrive
meccanismi e collusioni. Quali sono le difficoltà che incontra chi vuole
raccontarli?
«L’Italia
è un grande Paese, una grande democrazia e qualunque difficoltà incontri sul tuo
cammino per raccontare una tragedia come quella della terra dei fuochi, dei
veleni interrati, del futuro dei nostri figli avvelenato da camorristi e
imprenditori senza scrupoli può essere superata grazie alla grande capacità che
abbiamo di raccontare la realtà. Non esiste alcun impedimento se non la tua
intelligenza nel cogliere il dramma, la tua capacità nel trovare le fonti giuste
per raccontarlo e soprattutto il modo per illuminare pagine buie della nostra
storia recente. Nella questione terra dei fuochi lo Stato ha avuto gravi
comportamenti omissivi e commissivi. Lo Stato è andato a braccetto con i mafiosi
in alcuni frangenti. Lo Stato ha agevolato l’esportazione verso la Campania di
rifiuti industriali smaltiti illegalmente. Lo Stato ha ora l’obbligo di
bonificare e controllare che le risorse usate non finiscano nuovamente nelle
mani dei camorristi che hanno sporcato».
Carpiano, la terra dei
fuochi in versione lombarda.
Veleni oltre i limiti di
legge: contaminati ettari di terreni tra il Pavese e il Milanese, scrive
Patrizia Tossi il 16 settembre 2015 su “Il Giorno”. Dodici ettari di terreni
contaminati dai veleni, un’area agricola coltivata tra il Sud Milano e il Pavese
piena zeppa di metalli pesanti, diossina e sostanze potenzialmente pericolose
per i geni umani. Secondo il dossier dell’Agenzia di ricerca europea di Ispra, i
livelli di diossina presenti nel suolo sarebbero 25 volte superiori ai limiti di
legge a causa di presunti «sversamenti pirata». Tutti sapevano da anni: il primo
dossier europeo risale al 2007 e poi ce n’è stato un altro nel 2011, ma finora
una fitta coltre di silenzio ha avvolto quel «quadrilatero nero» tra Carpiano,
Landriano, Pairana e Bascapè. «L’ennesima terra dei fuochi lombarda», denuncia
la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Iolanda Nanni, prima firmataria
di un’interrogazione al Pirellone: «Ho iniziato a scavare tra le carte a seguito
di una segnalazione dei cittadini – spiega Nanni, da tempo in prima linea per
denunciare i problemi ambientali del territorio lombardo – ed è emersa una
situazione inquietante. Le due ricerche Ispra attestano la contaminazione oltre
i limiti di legge dei terreni da metalli pesanti, Pcb, furani, composti
geno-tossici (vale a dire in grado di alterare il Dna, scatenando nel
medio-lungo periodo l’insorgenza di tumori), che avrebbero inquinato i suoli con
ricadute tossiche e nocive sulla catena agro-alimentare. Le istituzioni sapevano
da anni, ma nessuno è mai intervenuto». Il dossier dell’Agenzia europea per
l’ambiente non lascia spazio a dubbi e parla di un’area, per la maggior parte,
«direttamente e soprattutto indirettamente pericolosa per la salute degli
animali e dell’uomo». Ma non solo. «Ispra ipotizza uno ‘spargimento pirata’ di
rifiuti tossici sui terreni – continua Nanni – e nello studio 2011 denuncia uno
“stato di compromissione del suolo e della stessa vita degli organismi vegetali
e animali che sono presenti nel suolo” della zona. È un’emergenza sanitaria
gravissima, la Regione non può più tacere. Alla nostra interrogazione devono
seguire risposte concrete». La cosa assurda è che quei terreni sono coltivati
con prodotti destinati alla vendita, senza che nessun ente abbia mai imposto la
sospensione dell’attività agricola, almeno a livello precauzionale. «Mi domando
come sia possibile che le istituzioni competenti non abbiano immediatamente
denunciato la situazione alla Procura competente – conclude Iolanda Nanni –
affinché si verificassero le responsabilità penali, allertando
contemporaneamente la Procura Antimafia di Milano. E come sia possibile che, dal
2007 a oggi, le istituzioni non abbiano vietato la coltivazione dei terreni
contaminati, al contempo ingiungendo in modo perentorio all’azienda proprietaria
dei terreni l’immediata e tempestiva bonifica dei terreni stessi, nonché il
sequestro di qualsiasi prodotto agro-alimentare frutto dei terreni contaminati
già presente sul mercato». E il sindaco di Carpiano? Nessuna denuncia, nessuna
ordinanza per vietare la coltivazione dei terreni, nessun allerta per i
cittadini. «E' vero che il caso è noto da tempo –risponde il primo
cittadino Paolo Branca – ma la competenza sulla materia ambientale è del
Pirellone. La Regione ha aperto un tavolo tecnico per approfondire la vicenda e
noi, come Comune, abbiamo partecipato. È stata chiesta all’Arpa
un’attualizzazione dei dati con nuove analisi sull’eventuale presenza di
sostante inquinanti sui terreni, ma non ha ancora risposto». E prosegue: «Non mi
risulta che esista un esposto in Procura. Come Comune non possiamo fare nulla.
Il nostro è un territorio molto vasto, quei terreni si trovano lontano dal
centro abitato e riguardano più da vicino gli abitanti di Landriano. Non ci sono
odori, il caso è talmente datato che la componente volatile di eventuali
sostanze inquinanti è già evaporata anni fa. Penso che sia più probabile che ci
siano più metalli pesanti e sostanze tossico nocive nel terreno». E la falda?
«Difficile valutare se sia stata contaminata la falda, bisognerebbe fare
un’indagine accurata. L’agricoltore è attento a non coltivare una determinata
area, ma 12 ettari sono tanti, non si tratta di un fazzoletto di terra, non
posso dire se i veri perimetri sono gli stessi di quelli indicati
dall’agricoltore».
Rifiuti, è qui la terra dei
fuochi. Cinque volte più della Campania.
La denuncia di fondatore di
Marino Ruzzanenti, ambientalista fondatore di «Cittadini per il
riciclaggio»: «La provincia di Brescia smaltisce 57 milioni di metri cubi di
rifiuti tossici, quella di Caserta, nella Gomorra di Saviano, 10 milioni»,
scrive Bruna Bianchi il 5 giugno 2015 su “Il Giorno”.
Terra dei Fuochi del Nordè
un’espressione che fa inorridire.
«E allora
chiamiamola l’immondezzaio d’Italia». Marino Ruzzenenti ha l’età della memoria
storica, quella di chi ha accumulato la lunga esperienza di cittadino di
Brescia e la forza morale di un ambientalista convinto. Non è fanatico, non fa
barricate: mette in fila i fatti e i dati. «La provincia di Brescia smaltisce 57
milioni di metri cubi di rifiuti tossici, quella di Caserta, nella Gomorra di
Saviano, 10 milioni».
La verità fa male se si
mettono in fila altri dati: l’incanto delle colline moreniche dei laghi, quelle
dolci e succose di Franciacorta, le bellezze della Brescia antica attorniate
da cave piene di amianto, pcb, metalli ferrosi. Ogni tanto qualcosa si incendia,
i fumi neri escono dai comignoli degli impianti di trattamento e poi tutto tace
e il lavoro dei camion e dello smaltimento prosegue, un tempo selvaggio, ora
approvato a suon di piani e delibere.
«La situazione del Bresciano è
del tutto eccezionale. Noi tumuliamo in discarica circa il 70 per cento dei
rifiuti speciali della Lombardia. Questo territorio è diventato di rifiuti per
vocazione»
Torniamo indietro nel
tempo.
«Fino agli anni ’80 non c’era
una legge sullo smaltimento dei rifiuti speciali e le cave di terra e sabbia
erano buche perfette. Le aziende pagavano il proprietario e buttavano tutto lì».
Che tipo di scorie?
«Il 50 per cento dei rottami
dell’industria siderurgica ha trovato posto in tutta la provincia di Brescia».
Altro?
«Non ci manca proprio niente!
Abbiamo anche quattro discariche di scorie radioattive. Per una sola, a
Lumezzane, è stato costruito un bunker».
E sottoterra c’è quello che
ancora non è stato trovato...
«Decine e decine di cave
chiuse nascondono rifiuti fantasma ricoperti da terra e erba. Sappiamo che
esistono ma non sappiamo dove siano».
Signor Ruzzenenti, lei,
insieme a Legambiente e altre associazioni ha fatto un lavoro certosino di
denuncia.
«C’è un’indagine in corso alla
procura di Brescia sui rifiuti tossici provenienti dall’estero. Come si dice?
Rifiuto chiama rifiuto. Ormai qui è stata fatta una scelta produttiva, come le
armi. Ad esempio, lo smaltimento dell’amianto a Montichiari in teoria è legale,
ma quando un camion si è rovesciato è stato scoperto che non era trattato come
avrebbe dovuto essere prima di finire in discarica. I controlli sono
praticamente impossibili. Con l’autocertificazione si possono trasformare
rifiuti pericolosi in non pericolosi».
È un bell’affare, no?
«Lo stanno facendo a spese
nostre. Compreso Manlio Cerroni, il re della monnezza di Roma».
I bresciani cosa dicono?
«Cominciano a ribellarsi,
osteggiano le nuove discariche. Hanno già dato tanto».
C’è anche l’inceneritore
più potente d’Europa.
«Anche quello. In una città
già avvelenata dalla Caffaro...»
Pure la Valcamonica ha
scoperto la sua gatta da pelare...
«Il sindaco di Berzo Demo si è
ritrovato in casa migliaia di metri cubi di scarti di alluminio provenienti
dall’Australia».
Cosa chiede ai politici?
«Basta discariche e almeno una
mappatura per sapere dove sono nascosti altri veleni. Non è tutto inquinato, sia
chiaro: dobbiamo solo individuare il marcio per evitare che si estenda».
"Terra dei fuochi" alle
porte di Torino, scoperta una discarica con 450 tonnellate di veleni.
I finanzieri
torinesi nella discarica abusiva a ridosso dell'abitato. Blitz della Guardia di
finanza a San Gillio, alle porte del capoluogo: denunciato il titolare di
un'immobiliare proprietaria dell'area dove erano stoccati rifiuti industriali
pericolosi di ogni tipo compresi 120 quintali di amianto. I complimenti del
ministro Galletti: "Liberiamo l'Italia dagli inquinatori", scrive il 28 agosto
2015 “La Repubblica". C'erano 450 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi in
un capannone industriale abbandonato a San Gillio, nel Torinese, alle porte del
capoluogo e a ridosso del centro abitato. A scoprire la "terra dei fuochi"
piemontese sono stati i militari del Comando provinciale della Guardia di
Finanza di Torino. I finanzieri hanno notato sul piazzale, visibile anche
dall'esterno, "cumuli disomogenei" di rifiuti in evidente stato di abbandono.
Dopo aver individuato il proprietario e l'utilizzatore dell'area, che si estende
per circa cinquemila metri quadrati, i "baschi verdi" sono entrati per le
verifiche sui materiali eseguite insieme all'Arpa Piemonte. E' stata confermata
la grave pericolosità dei materiali, riconducibili in parte all'attività di
officina meccanica ed elettromeccanica e di stampaggio di materiali a freddo,
svolta negli anni scorsi da una ditta di San Gillio dichiarata fallita nel
maggio 2006, e in parte ad una società immobiliare attuale proprietaria del
sito. Al termine delle attività di rilevazione, spiega la Finanza, sono stati
sequestrati rifiuti speciali e pericolosi per circa 450 tonnellate, delle quali
430 provenienti da lavori di demolizione, 12 da fibra d'amianto e la restante
parte, per oltre 6 tonnellate, di prodotti chimici da decontaminare. Il
percolato dei materiali rinvenuti dai finanzieri, in parte, avrebbe potuto
finire negli scarichi per il recupero dell'acqua piovana. Al momento
l'amministratore unico dell'immobiliare proprietaria del sito è stato denunciato
per deposito incontrollato di rifiuti; è anche stato segnalato al Comune per le
violazioni in materia di edilizia e urbanistica, per avere effettuato lavori di
demolizione in assenza di autorizzazione. Proseguono gli accertamenti per la
messa in sicurezza del sito e per verificare eventuale contaminazione
ambientale. "Liberare l'Italia dagli inquinatori": ribadendo questo obiettivo il
ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, si è complimentato con la Guardia di
finanza. "Le mie congratulazioni - ha detto - per l'importante operazione che ha
permesso il sequestro di 450 tonnellate di rifiuti pericolosi nel Torinese.
Contro chi avvelena il nostro territorio abbiamo scelto di condurre una
battaglia senza quartiere, affiancando al tenace lavoro di magistrati e forze
dell'ordine l'introduzione degli ecoreati nel Codice penale: una vera svolta per
restituire la certezza ai cittadini di vivere in zone sicure sotto il profilo
ambientale e liberare l'Italia dagli inquinatori".
Duemila incendi l’anno,
ecco la terra dei fuochi de’ noantri,
scrive Grazia Maria Coletti il 12 gennaio 2016 su “Il Tempo”. Situazione
esplosiva nei campi rom. I romani stremati dal fumo si ribellano. E in Campania
l’Istituto di Sanità accerta aumento di tumori in 55 comuni La mappa dei roghi.
Se ogni porta di casa deve essere una Porta Santa, tuteliamo anche le porte
sante delle case dei romani, soffocate dal fumo dei rom. È questo il messaggio
che arriva dagli esposti piovuti sui tavoli del prefetto di Roma, Franco
Gabrielli e del commissario Francesco Paolo Tronca, impegnati nei giorni del
Giubileo e dell’allarme terrorismo. Duemila roghi tossici in un anno e un solo
arresto (due rom fermati dai carabinieri a Castel Romano a settembre), è questa
la caporetto delle pene esemplari del decreto "terra dei fuochi" che non hanno
fermato la terra dei fuochi "de’noantri". E i romani esasperati, chiedono un
piano di salvataggio dai "terroristi-rom", «gli unici al momento - dicono - ad
attentare alla vita di adulti, vecchi e bambini». Hanno ragione di temere? I
risultati drammatici della ricerca dell’Iss sui 55 comuni della "Terra dei
fuochi" campana ci dicono che in quella zona «si muore di più che in altre zone
d’Italia», ci si ammala «più di cancro», anche tra i «bambini» nella fascia
«0-14», e si «registrano più ricoveri». L’Europa ha condannato Roma più volte.
172mila390 i metri quadri di terreno, l’equivalente di 40 campi da calcio,
sequestrati come discariche abusive dallo Spe della polizia locale del
vicecomandante del Corpo Antonio Di Maggio. Interpellanze del parlamentare
europeo Giovanni La Via e della Angelilli. Ma a Roma nessuno ha ancora
monitorato l’aria prodotta dai quasi 2mila roghi, contati da Il Tempo con
l’aiuto dei cittadini di ogni quadrante, perché una mappa ufficiale ancora non
c’è. Considerando una media di 3-4 roghi a settimana, tutti i giorni d’estate, e
giorno e notte, accesi anche più volte al dì, nei campi legali e tollerati - che
ci costano 24 milioni di euro l’anno - si arriva a quasi mille. Altrettanti
nella miriade di accampamenti abusivi, nella riserva delle Valle dell’Aniene,
sotto i cavalcavia, sgomberati e ripopolati, con fonderie illegali in ogni
quartiere: da Magliana a Tor Sapienza, da Ponte di Nona, a Ciampino, dal Nuovo
Salario a Ciampino, da La Rustica fino alla provincia romana, specialmente a
est. Come racconta la mappa pubblicata qui a fianco. E quando tira il vento non
si salvano nemmeno i Parioli, come aveva già denunciato su queste pagine anche
il comico Enrico Montesano. Mentre il web fa il pieno di post sulla pagina
facebook "richiesta la chiusura del campo di via di Salone", dove i vigili del
fuoco di La Rustica vengono presi sempre a sassate, che porterà alla
manifestazione popolare in primavera per chiedere la chiusura anche di via
Salviati, La Barbuta, vicino all’aeroporto di Ciampino, Castel Romano sulla
Pontina, la Monachina, sull’Aurelia, Lombroso a Torrevecchia. Ma gli
inceneritori a tutti gli effetti di rifiuti tossici speciali, da cui si
sprigiona diossina, sono presenti anche in centinaia di microaccampamenti nelle
radure del Pratone delle valli, nelle valli di Quartaccio, segnalazioni nel
quartiere Quintiliani, Pietralata, via dei Durantini. Il comitato di quartiere
Tor Sapienza è stato il primo a contare i roghi: «155 roghi in 15 mesi da via
Salviati», con il presidente Roberto Torre che nei giorni scorsi lanciava
l’anatema contro l’immobilismo. «152 roghi tossici in un anno da via di Salone»
dice Franco Pirina, del Caop Ponte di Nona - qui i roghi, ultimamente, durante
la notte e solo al mattino la gente si rende conto dell’aria irrespirabile». Il
conto sale vertiginosamente con il campo di via Candoni, alla Magliana, e
Candoni bis, fucina che arde, notte e giorno, e avvelena l’aria dei quartieri
Marconi, Magliana, Casetta Mattei, Muratella, agli autisti della rimessa Atac
servono gli antinebbia. Il capogruppo di Forza Italia in XI Municipio, Marco
Palma, ha chiesto «l’esercito» al posto dei vigili urbani. «Già messi "ko" da
schiere di minorenni». Aperte le «indagini» a un anno dall’esposto in Procura
presentato dal consigliere regionale Fabrizio Santori.
Brucia la città, ma nessuno
spegne i roghi,
scrive Maria Lombardi il 4 febbraio 2016 su “Il Messaggero". Il fumo s'alza
sulla via Olimpica, poco prima dello svincolo per Tor di Quinto, e disegna un
arcobaleno nero. Dalla nuvola bassa e puzzolente sbucano comitive di rom,
scavalcano il guardrail e attraversano la strada anche se non ci sono strisce
pedonali, lasciandosi alle spalle il villaggio di lamiere che perennemente arde.
C'è una Roma che brucia senza sosta, ignorata, ci sono intere zone della città
condannate ai roghi, un inferno velenoso, peggio di qualsiasi altro inferno. C'è
un'altra terra dei fuochi a dieci chilometri dal Quirinale e si va allargando.
Quartieri soffocati dalle nubi pesanti delle baraccopoli. Magari ci fossero solo
le polveri sottili, qui si respira aria ancora più malata e non si sa di che.
Anneriranno in fretta le lenzuola bianche che i cittadini hanno appeso alle
finestre, verranno presto corrose dai vapori di diossina. «Basta roghi
criminali», c'è scritto. Decine e decine di striscioni nei palazzi di Conca
d'Oro, Tiburtina, San Basilio, Casal Bertone, La Rustica, Tor Sapienza, Ponte di
Nona. Chi abita in queste zone si sente perduto, il fumo dei rifiuti bruciati
nei campi per prendere il rame può uccidere. Gli appelli finora non sono
serviti, adesso è il momento della protesta corale, l'urlo esibito ai balconi.
Roghi criminali, appunto, perché di crimini si tratta. Il reato esiste dal
dicembre 2013 «combustione illecita di rifiuti», prevede il carcere dai 2 ai 5
anni, stessa pena per chi trasporta gli scarti con l'intenzione di dargli fuoco.
Eppure gli incendi di Roma nessuno riesce a spegnerli.
Terra dei Fuochi, il
sequel. Terni, Rieti e Viterbo nuova frontiera per rom e colletti bianchi,
scrive “Libero Quotidiano” il 5 febbraio 2016. Terra dei Fuochi, il sequel. Come
al cinema, il cancro criminale che affligge la Campania ha un seguito... a Roma
e non solo. A raccontarlo è il giudice Mauro Santoloci, gip di Terni, membro
della Commissione ministeriale per la revisione del Testo Unico ambientale e
autore, con Valentina Vattani, di una collana di pubblicazioni sul tema delle
eco mafie, intervenuto a Corretta informazione sui temi ambientali. Fonti
ufficiali e fonti ufficiose, corso di aggiornamento promosso dall'Ordine dei
Giornalisti dell'Umbria. "Sorvolando Roma di notte – ha spiegato Santoloci – non
è difficile individuare un corollario di fuochi, in particolare nei pressi della
tangenziale. Sono i roghi appiccati nei campi rom, destinati a smaltire rifiuti.
Un meccanismo pericoloso, per la salute e per l'ambiente, nonché nocivo per le
attività legali di smaltimento". Secondo le informazioni in possesso del
magistrato "i rom si appoggiano ad una flotta di furgoni, guidati talvolta
da schiavi bianchi, vale a dire persone disagiate, ad esempio immigrati, che per
pochi euro ti smontano un pannello di amianto senza rispettare alcuna regola di
sicurezza, lo caricano su un camion, lo portano alla discarica abusiva. Una giro
per orchestrato, grazie anche alla conoscenza delle lacune (buchi neri, li
chiama il gip, ndr) della nostra giustizia. Ad esempio, un vigile urbano mi ha
raccontato che, in due mesi, ha fermato lo stesso mezzo trentasette volte, senza
riuscire però a sequestrarlo". Il sequestro non è possibile, perché? La risposta
è nell'ex art. 240 co. 1 c.p., che elenca i requisiti di confiscabilità di un
autoveicolo usato per un illecito e la cui applicazione potrebbe sollevare
incertezze sul nesso di asservimento/strumentalità che deve legare la cosa al
reato. Interpretazioni normative a parte, ciò che lascia basiti è la
ramificazione di questa piccola criminalità: seppure non classificabile come eco
mafia, infatti, la rete rom è estesa è guarda già oltre la Campania e la zona di
Roma. Ad esempio, Rieti, Viterbo, Terni sono "candidate" ad diventare una nuova
Terra dei Fuochi. Santoloci: "In seguito ad azioni di repressione delle forze
dell'ordine, è plausibile che l'attenzione dei criminali si sposti altrove, in
città poco distanti dalla Capitale come questa (Terni, ndr) o come il reatino e
il viterbese. Dopo aver appurato, chiaramente, che le aree interessate siano più
'tranquille', gli illeciti potrebbero trovare nuovi siti". I campi nomadi nei
quali si "accendono" i fuochi sono un problema, vero, ma ostacolo non inferiore
è quello dei colletti bianchi, vale a dire professionisti ed imprenditori
insospettabili che alimentano il giro di affari che ruota intorno allo
smaltimento abusivo. Il gip: "Alla Guardia Costiera chiedo di controllare non
solo la bolla di carico, ma anche di aprire i container: i documenti sono in
regola, però a bordo della nave hai tonnellate di materiale che poi viene
trasformato e che torna, in Italia, sotto forma di prodotto per il mercato".
Ecco cosa significa "colletto bianco": far apparire corretto ciò che non lo è.
Come uscirne? Fra le soluzioni, il giudice propone anche una "formazione
continua" sul tema dei rifiuti per le forze dell'ordine, sia per capire le
modalità di gestione del traffico illegale, sia per rendersi conto che la
domanda "è di mia competenza"? di fronte ad un potenziale illecito non è
assolutamente da porsi. Nessun riferimento, invece, alla questione inceneritori
che, proprio in queste settimane, ha ri-assistito a polemiche e manifestazioni
di protesta dei comitati ambientalisti. In particolare, nelle ultime ore, il
Comitato No Inceneritori di Terni ha aspramente criticato il voto favorevole
all'articolo 35 dello Sblocca Italia, che permette la creazione di una rete di
smaltimento a livello nazionale. Secondo il Comitato, infatti, ciò andrebbe a
scapito di Terni i cui due impianti si troverebbero così a bruciare consistenti
quantitativi di immondizia. Una circostanza che nulla ha a che vedere con la
lotta al malaffare, ma che tuttavia lascia perplesse le organizzazioni
cittadine, preoccupate per le eventuali conseguenze a livello ambientale e
sanitario.
Terra dei Fuochi in Toscana,
scrive Vanessa Roghi, storica, l'11 luglio 2015 su “Internazionale". Hai mai
visto Bormida? Ha l’acqua color del sangue raggrumato, perché porta via i
rifiuti delle fabbriche di Cengio e sulle rive non cresce più un filo d’erba.
Un’acqua più porca e avvelenata, che ti mette freddo nel midollo, specie a
vederla di notte sotto la luna. Quando Beppe Fenoglio scrive Un giorno di fuoco,
negli anni della sua giovinezza, l’acqua del fiume Bormida è già rossa, porca e
avvelenata, ma la parola ambientalismo, in Italia, non esiste o è patrimonio di
illuminate minoranze. Non si pronuncia mai, tuttavia, in presenza di un’altra
parola: lavoro. Semmai fabbrica, ma lavoro no. Perché, come nella morra cinese,
lavoro spazza via ambiente; che, come la carta, avvolge il sasso, la fabbrica.
Ma è sempre meno forte della forbice, il lavoro appunto. Quando Beppe Fenoglio
descrive il fiume Bormida, l’Acna di Cengio la conoscono solo i suoi abitanti e
gli operai che ogni giorno timbrano il cartellino e producono coloranti e gas
tossici, da più di mezzo secolo. Quando nel 1963 esce Un giorno di fuoco, Beppe
Fenoglio è morto di cancro, ed è passato solo un anno dalla sentenza che ha
costretto i contadini della val Bormida a risarcire l’Acna, ora di proprietà
della Montecatini, per le spese di un processo durato 24 anni nel quale gli
abitanti della valle hanno osato far notare che in effetti va bene l’acqua
rossa, ma il fatto che nei campi non cresca un filo d’erba non va bene, o no? La
Montecatini è cresciuta negli anni del fascismo, ha allargato la sua attività in
vaste aree del Piemonte, della Liguria, della Toscana, dell’Emilia Romagna:
risorse da sfruttare, acqua, manodopera a basso costo e sono nate alcune delle
industrie più importanti della chimica italiana. “Montecatini”, scrive Alberto
Prunetti Amianto “non è quella famosa delle terme e di Miss Italia, ma la
Montecatini aspra delle Colline metallifere della Val di Cecina, in alta
Maremma. La Montecatini che diventerà Edison, poi Montedison, poi si smembrerà
in altre società, svenderà alcuni stabilimenti (…)”. La Montecatini, dalla quale
sgorgheranno fiumi e fiumi di storie, storie di minerali e di fabbriche, storie
di lavoro, scrive ancora Prunetti, “che hanno avvelenato e rovinato i polmoni
con la silicosi, per poi impestare di fanghi rossi il mare di fronte
all’arcipelago toscano e alla Corsica, smaltire ceneri di pirite nelle miniere
scavate decenni prima e intossicare di metalli pesanti i fiumi e il mare”.
Risorse naturali, acqua, manodopera a basso costo: vengono scavate nuove
miniere, ampliate quelle esistenti: rame, zolfo, piriti, fino al grande
incidente, quello del 1954, quando a Ribolla, vicino Grosseto, esplode il pozzo
Camorra e muoiono 43 minatori. La storia è nota. Luciano Bianciardi e Carlo
Cassola sulla tragedia pubblicano I minatori della Maremma. Poi arriva la prima
grande crisi industriale dopo gli anni del boom, la crisi che porta l’Eni a
rilevare la Montecatini, è il 1966, nasce la Montedison, l’Italia è in fase di
“congiuntura”, ma l’industria chimica continua a crescere, a creare centinaia di
posti di lavoro. La parola ambientalismo è sempre poco usata, poco la usa anche
Antonio Cederna, pure tra i pochi in Italia a porre all’attenzione della
politica il problema della tutela dell’ambiente insieme a quello della qualità
della vita dei cittadini. Proprio nel 1966 pubblica su L’Espresso un’inchiesta
sulla distruzione delle coste italiane, la sua attenzione è rivolta
principalmente alla speculazione edilizia, nessuno ancora si pone il problema di
come ben più grave sia la questione dell’inquinamento. Eppure gli abitanti della
val Bormida continuano le loro battaglie, denunciano l’Acna, ancora non
esiste l’orrenda espressione nimby (non nel mio giardino) e nessuno si permette
di trattarli come dei terroristi, come succederà anni dopo ai loro omologhi
della val Susa; ma in quei primi anni settanta lavoro vince su fabbrica che
vince su ambiente. Questo fino al 1976 quando esplode a Seveso un reattore
chimico destinato alla produzione di triclorofenolo, parola incomprensibile, ma
tutti, dai quarant’anni in su ne ricordano un’altra: diossina. Ascoltatelo Marco
Gisotti che racconta quel 10 luglio e la diossina sprigionata nell’aria che
ricopre tutta la Brianza. Bisogna ricordarsele queste tappe, partire da lontano,
allargare lo sguardo nel lungo periodo se vogliamo ricucire le tappe che da
Seveso e diossina, e Acna e Cengio, portano a un altro luogo della memoria del
movimento ambientalista italiano, ovvero l’incidente della Farmoplant che oggi
possiamo ricordare attraverso un libro, La terra bianca, chi l’ha scritto si
chiama Giulio Milani, la storia che racconta è questa. 17 luglio 1988. Il
serbatoio Rogor della Farmoplant esplode. Tutti ricordano la nube nera che si
solleva dalla fabbrica e spinge le persone a fuggire dalla città avvelenata.
Quasi un anno prima, il 25 ottobre del 1987 il 75 per cento degli aventi diritto
aveva votato per il referendum che chiedeva la chiusura immediata della
fabbrica. È il primo referendum consultivo d’Europa per chiedere la chiusura di
una fabbrica. L’eco ormai attutita di Seveso è appena stata risvegliata dal
boato di Cernobyl. Risponde sì il 71,69 per cento, la fabbrica deve essere
chiusa, perché dall’anno della sua apertura, il 1976, ci sono stati quaranta
incidenti, il più grave, un incendio nel 1980 al magazzino esterno del Mancozeb
– un pesticida cancerogeno tutt’ora impiegato in viticoltura. Segue la revoca
immediata delle licenze per la produzione di Rogor e di Cidial, i due
insetticidi considerati più pericolosi. Il 2 novembre 1987, scrive Milani, “la
gerenza della Farmoplant licenzia in tronco tutti i dipendenti, perché afferma
che senza la produzione di queste due richiestissime sostanze non ci sono le
condizioni per proseguire l’attività”. Ma la Farmoplant vince il ricorso e tutti
i lavoratori sono di nuovo assunti. Lo stabilimento riprende la produzione.
“Naturalmente il Comune di Massa, Lega ambiente e i Verdi fanno ricorso al
Consiglio di Stato contro la sospensione del Tar, e a marzo del 1988 il
Consiglio di Stato sospende la sospensione”. Seguono mesi di commissioni,
ricorsi e controricorsi. Il ministro dell’ambiente è Giorgio Ruffolo, la persona
giusta al posto sbagliato, come titolerà il mensile di Legambiente, per la sua
inerzia nell’affrontare il disastro che gli si riversa addosso. E arriva
l’estate del 1988: gli ambientalisti propongono di impiegare gli operai,
“durante la riconversione dell’impianto, nella bonifica dei 65 ettari di terreno
contaminato dal complesso industriale, ma il progetto non viene neppure preso in
considerazione dalla Montedison”. Nessuno si pronuncia, né il sindaco, né il
ministero, né il consiglio dell’azienda. “In questa attesa il 17 luglio esplode
proprio il serbatoio dei formulati liquidi che conteneva Rogor e cicloesanone”.
L’annuncio del tg diffonde il panico nelle regioni confinanti malgrado il tono
pacato al telegiornale di Luigi Frajese. Muoiono i pesci, muoiono le anguille,
il divieto di balneazione appare sulle spiagge di Massa. Ma cresce la
consapevolezza che senza determinate condizioni di sicurezza lavorare uccide,
non stanca, come scrive nel suo libro un altro figlio di queste terre, Marco
Rovelli. Un disastro ambientale che riguarda però anche un altro fondamentale
settore produttivo, e questa è l’altra grande storia che Milani ricostruisce: “È
stata Tangentopoli a indicare in che misura anche per il versante ligure-apuano
e apuo-versiliese l’infiltrazione mafiosa – insieme all’arrivo della chimica di
Raul Gardini – abbia accompagnato la nascita di un’economia di rapina a
esclusivo appannaggio delle multinazionali del carbonato di calcio, fondata sul
riciclaggio di proventi al nero e il commercio di rifiuti pericolosi”. Salvatore
Calleri è il presidente della fondazione Caponnetto e, racconta Milani, ha
denunciato come la Toscana, con trentacinque diverse organizzazioni criminali
censite, non sembrasse rendersi conto di rappresentare una potenziale terra di
conquista delle mafie. La chiama, Calleri, auto-omertà. Un silenzio indotto
dalla paura di andare a incidere negativamente sulla rappresentazione pubblica
della Toscana, marchio nel mondo, di buongoverno unito ad assenza di
inquinamento del territorio, ma la “terra dei fuochi”, dice uno dei testimoni
del libro di Milani “è anche qui, da noi e da ben prima”. Decidere quale sia la
vocazione di un’area non è cosa semplice: polo chimico o cave di marmo, o
addirittura turismo, o altro? “La Farmoplant”, scrive Milani, “chiude nel 1988.
La Dalmine nel 1990, è l’ultima grande industria ad andarsene dalla zona. Gli
operai della Dalmine sono l’aristocrazia. Ma dalla sera alla mattina perdono il
lavoro in 1.500”. A quel punto la vocazione sembra essere una e una solo, quella
del marmo: “Adesso i sindaci si stracciano le vesti per i lavoratori del
lapideo”, dice a Milani un operaio in pensione, “ma in tutta la provincia è un
miracolo se contano ancora duemila occupati con l’indotto e sono disposti a
perdere la ricchezza delle montagne e dell’acqua, a sborsare cifre colossali per
il continuo ripristino del dissesto prodotto dall’escavazione, dai trasporti su
camion e dalla strozzatura della rete fluviale, a mettere a repentaglio la vita
delle persone sotto le alluvioni e le frane pur di salvarli: chiediamoci come
mai”. Qualche anno fa Roberto Barocci ha pubblicato un prezioso libretto, ormai
esaurito, per Stampa alternativa, si intitolava ArsENIco. Come avvelenare la
Maremma fino alla catastrofe ambientale. In questo si faceva la stessa, identica
domanda: perché le istituzioni avevano accettato l’inquinamento delle zone
minerarie della bassa Toscana, il colpevole ritardo delle bonifiche ambientali,
ritardo che aveva finito per avvelenare terreni e corsi d’acqua, e corpi, dalle
Colline Metallifere giù fino alla costa? Si domandava l’autore
nell’introduzione: “Chi governa nel nostro paese? Nella Regione Toscana? Dove
vengono prese le decisioni importanti che riguardano le risorse strategiche,
dalla salute alle risorse idriche, al lavoro, alla qualità dell’ambiente…? Chi
sono i mercificatori che si piegano a interessi di pochi e riescono ad imporre
queste scelte anche agli onesti? Come può avvenire tutto ciò?”. “Avevamo bisogno
di lavorare e le cose che dicevano sulla pericolosità delle produzioni ci
parevano esagerate. Le istituzioni, i partiti, i sindacati, i tecnici: per tutti
l’insediamento era sicuro, anzi, una vera benedizione per la zona industriale e
per il nostro avvenire. I quadri dell’azienda abitavano nei dintorni della
fabbrica, ma anche i politici abitavano non lontano. Se il pericolo c’era, c’era
per tutti. Come si poteva pensare di essere ingannati fino a questo punto?”.
Alla fine, comunque, questo rimane l’interrogativo più lacerante lasciato aperto
dall’inchiesta di Milani, non le mafie, non le morti, non la fine del lavoro, ma
questo: se il pericolo c’era, c’era per tutti, perché inquinare, avvelenare,
uccidere? Mi raccontava qualche anno fa Sandro Veronesi una scritta che aveva
visto una volta su muro: “Chi inquina l’acqua beve pure lui”. Ci ho pensato
tutto il tempo a questa scritta mentre leggevo il libro di Milani, così come ho
pensato alle acque rosse del fiume Bormida, all’arsenico della Maremma. Chi
inquina la terra ci vive pure lui. Deve essere dunque solo una questione
d’amore, senza altre spiegazioni, come suggerisce nella sua recensione a
Milani, Annalisa Andreoni, parafrasando Brecht: “Sventurata la terra che non è
amata dai suoi”.
“L'incredibile e strana persecuzione di
due Magistrati pugliesi: Matteo Di Giorgio e Giuseppe De Benedictis,
scrive ancora Michele Imperio su "Ok Notizie Virgilio" il 9 luglio 2011. Nove
mesi fa avevamo postato la notizia dell’arresto quasi contemporaneo di due
magistrati pugliesi Giuseppe De Benedictis e Matteo Di Giorgio, entrambi
classificabili come Magistrati dell’area di centro destra, tendenza beninteso
manifestata al di fuori dell'esercizio delle funzioni nell'ambito delle quali i
due magistrati erano assolutamente irreprensibili. Giuseppe De Benedictis aveva
addirittura concesso l’arresto dell’on.le Raffaele Fitto (PDL). E dato il
clamore di certa stampa avevamo lanciato l’allarme che poteva trattarsi di un
odioso piano dei giudici di Magistratura Democratica, i quali stavano
cominciando ad avviare una sorta di pulizia etnica oltre che di uomini politici
anche di Magistrati di altra estrazione politica, utilizzando anche contro
costoro (i colleghi Magistrati) lo strumento della incriminazione penale e della
carcerazione preventiva. In questa perversa ottica si collocavano – secondo noi
- le due quasi contemporanee carcerazioni dei magistrati pugliesi Matteo Di
Giorgio e Giuseppe De Benedictis arrestati a distanza di soli quattordici giorni
l’uno dall’altro, un evento che non si era mai verificato in tutta la storia
della Puglia. Anzi in passato il Magistrato veniva rispettato in quanto tale. I
panni sporchi, se c'erano, si lavavano - come si dice - in famiglia, onde non
generare disdoro per le Istituzioni. Ora invece anche i Magistrati,
classificabili come vicini ad ambienti politici di centro-destra, possono essere
destinatari di questa iniziativa plateale e clamorosa che è l'incriminazione
penale e il mandato di cattura che - lo ricordo - non è "pane e fichi" ma è una
misura particolarmente umiliante e estremamente invasiva che bisogna adottare -
stando alla legge - solo in presenza di situazioni di particolare gravità. Il
dott. Matteo Di Giorgio già Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto, insignito per meriti acquisiti sul campo dell’incarico di
delegato della Procura distrettuale antimafia di Lecce presso il Tribunale di
Taranto, è stato all'improvviso arrestato l’11 novembre 2010 con una serie di
accuse per fatti vetusti, risalenti alcuni addirittura al 2001, alcuni dei quali
già prima facie di scarsissima o nulla rilevanza penale (per esempio far
mantenere aperto un bar dalla Amministrazione Comunale di Castellaneta anche se
non era in regola con le licenze). Lo stesso mandato di cattura parlava di
concussione ma escludeva in modo assoluto che il Dott. Matteo Di Giorgio avesse
mai preteso denaro per se o per altri soggetti per queste operazioni
ipotizzandosi a suo carico soltanto la volontà di perseguire "mire e utilità
politiche". Infatti con riferimento alle elezioni amministrative del 2008 (e
questa è la sua vera colpa) egli aveva tentato, senza riuscirci, di candidarsi
presidente della Provincia di Taranto senza coordinarsi con la Massoneria e con
le alte sfere della magistratura associata che, evidentemente, nei Tribunali di
Potenza e Taranto godono di spazi particolari. Vedi per esempio caso
Cannizzaro-Genovesi-Restivo-Claps. Ora anche i profani sanno che perchè si
configuri invece il reato di concussione occorre che l’attività estorsiva del
pubblico ufficiale sia finalizzata a conseguire denaro o altra utilità
(ovviamente simile al denaro). Ed è molto discutibile allo stato attuale della
giurisprudenza che tra queste "altre utilità" rientrino le “utilità politiche”
perché allora bisognerebbe incriminare del reato di concussione almeno il 90%
della classe politica di destra di centro e di sinistra. Il mandato di cattura a
carico del dott. Matteo Di Giorgio già per questi motivi appariva quindi anche
al profano un mandato di cattura esagerato dato che il Magistrato può disporre -
per legge - la cattura di un individuo solo se è certo che il fatto determinerà
una condanna a una pena detentiva che superi il limite della sospensione
condizionale della pena (anni due di reclusione). Peraltro il Procuratore Capo
della Repubblica di Potenza Giovanni Colangelo, insediatosi però a Potenza
quando già l'indagine era stata avviata, quel mandato di cattura non lo ha
voluto firmare. Evidentemente non era d'accordo. Peraltro "voci" riferiscono che
a Potenza non ci vuole stare più. Vorrebbe trasferirsi a Napoli. Torno ora a
parlare di questa vicenda perché proprio qualche giorno fa la Corte di
Cassazione ha annullato ben due dei quattro capi di accusa mossi al dott. Matteo
Di Giorgio e precisamente:
1. aver indotto la prima vittima tal Giuseppe Di
Fonzo a non denunciare il suo presunto strozzino, parente del Magistrato,
promettendogli il suo interessamento per l'iter di accesso al fondo antiusura;
2. aver indotto la seconda vittima tal Giovanni
Coccioli a ritrattare le accuse a lui stesso mosse dal Coccioli nell'ambito di
un'annosa diatriba con un senatore del posto Rocco Loreto, facendogli ottenere
in cambio la gestione di un bar abusivo allo stadio di Castellaneta.
Il primo capo di accusa è stato annullato senza
rinvio (cioè cancellato completamente) l'altro è stato annullato con rinvio al
Tribunale del riesame di Potenza per nuovo esame. Ora è raro che la Cassazione
annulli i capi di accusa di un mandato di cattura senza rinvio. Se lo fa è
perchè evidentemente si tratta proprio di una castroneria, nella specie
confermata (ahimè;) dal Tribunale del riesame di Potenza.
Annullati questi due capi di accusa rimangono a
carico del Magistrato Matteo Di Giorgio altre due imputazione:
1. aver esercitato presunte pressioni sul
proprietario di un villaggio turistico "Città del Catalano" per far revocare il
servizio di vigilanza a tal Vito Pentassuglia (esponente, secondo l'accusa,
dello schieramento politico avversario al suo quello di Sinistra) e poi aver
fatto altre pressioni sempre sul titolare di quel villaggio turistico per farsi
concedere due mesi di vacanza "quasi" gratuiti in due appartamenti del residence
medesimo;
2. aver costretto alle dimissioni un consigliere
comunale di Sinistra tal Domenico Trovisi dietro la minaccia di far arrestare
due suoi familiari.
Ora la Cassazione - come tutti sanno - non entra
nel merito delle vicende processuali perchè si limita a valutare solo i profili
di legittimità (ossia il rispetto della legge sostanziale e processuale da parte
del Magistrato che ha emesso il provvedimento). Però appare strano che un
Magistrato si esponga fino a quel punto solo per farsi "quasi" pagare (e perchè
non per intero?) una vacanza in un villaggio turistico della sua stessa città.
Questo può capitare a un impiegato di quart'ordine che non ha il denaro
sufficiente per pagarsi la vacanza ma non a un Magistrato il quale è lautamente
retribuito. Inoltre "voci" apparse anche sulla stampa (settimanale locale
"Wemag";) riferiscono che gli episodi relativi alle dimissioni del consigliere
comunale di Sinistra Domenico Trovisi non si sono svolte affatto come è stato
raccontato nel mandato di cattura, ma si sono verificati con queste modalità: in
quel periodo il Magistrato concittadino Matteo Di Giorgio si trovava ad
esaminare per ragioni del suo ufficio alcune intercettazioni telefoniche dalle
quali emergeva che due giovani familiari di Domenico Trovisi, persona molto in
vista in città in quanto titolare di oleifici, discoteche ed altre importanti
attività economiche, fossero responsabili di un grave reato. Per pietà e per
senso di concittadinanza il giovane familiare non è stato arrestato dal
Magistrato Matteo Di Giorgio e il Trovisi ha pensato bene - per decenza - di
dimettersi spontaneamente da consigliere comunale. Però...... "voci"..... Mi
chiedo: ma si può trattare un Magistrato come una pezza da piede per fatti di
questo genere? Peraltro - come ho detto - tutti i capi di imputazione annullati
o non annullati dalla Cassazione si riferiscono a vicende vecchie, datate nel
tempo (intorno al 2001 circa) che ormai affondavano nelle polveri degli archivi
della Procura della Repubblica di Potenza tanto era stato il tempo trascorso
dalla loro archiviazione disposte queste archiviazioni da un valoroso Magistrato
che allora era in forza alla Procura della Repubblica di Potenza, che si
chiamava John Woodcock. Solo il trasferimento di questo Magistrato dalla Procura
di Potenza a quella di Napoli ha consentito che quelle denunce fossero riprese e
valorizzate. Per verificare queste denunce poi è stata messa in moto la macchina
giudiziaria come per le grandi occasioni, riguardanti fatti gravissimi di
criminalità organizzata, sono stati addirittura impiegati anche ex Carabinieri
allontanati dall’Arma per ragioni disciplinari o penali e per ben due anni
(pensate!) tutte le stanze del Tribunale di Taranto sono state disseminate di
cimici per le intercettazioni ambientali!!!!!!!!!!! Al punto che personalmente
una volta mi è capitato di essere invitato da un Magistrato a interloquire con
lui nel bar del Tribunale anziché nel suo ufficio, proprio per la presenza –
risaputa - di queste invasive cimici. Inoltre è successo pure che molti
Magistrati del Tribunale di Taranto e - praticamente quelli più valorosi -
infastiditi da tante pressioni, hanno chiesto e ottenuto il trasferimento presso
altre sedi. E’ il caso per esempio della dott.sa P.N., del dott. G.D., del dott.
G.C. e di altri. Anzi addirittura il dott. G.C., benchè giovanissimo, ricopriva
nel Tribunale di Taranto, sua provincia di residenza, il prestigioso ruolo di
presidente del collegio penale. Ebbene egli ha preferito chiedere il
trasferimento presso un altro Tribunale e autoretrocedersi a Pretore di piccoli
paesi pur di sfuggire al clima giacobino e velenoso che, per via di queste
intrusioni, si è creato nell'ambiente giudiziario tarantino. Mi chiedo: ma data
l’inezia delle accuse e la mole delle forze messe in campo non sarà per caso che
l'inchiesta contro il Magistrato Matteo Di Giorgio sia stata solo un pretesto e
che invece da Potenza e forse da più in là qualcuno voleva inquisire tutti i
Magistrati del Tribunale di Taranto per tentare una sorte di pulizia etnica a
sfondo politico? Capisco che questa è un'ipotesi suggestiva ma l'arresto
altrettanto plateale e contemporaneo del dott. Giuseppe De Benedictis di Bari a
soli quattordici giorni di distanza e anche questo - come vedremo - carico di
simbologia, è opera - formalmente - di un'altra Procura esterna, la Procura
della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. In quel periodo si vociferava di
intrusioni del dott. Matteo Di Giorgio nella vicenda dei parchi eolici,
un'inchiesta che partiva da Roma e precisamente dal P.M. dott. Giancarlo
Capaldo, fratello di quel Pellegrino Capaldo, grande amico di Nicola Mancino, il
noto e diabolico stratega del 1992. Questa inchiesta sui parchi eolici doveva
fare strage di uomini politici e di Magistrati dell'area meridionale e poi
invece si è rivelata un flop, un'autentica bolla di sapone. Ma ci ha fatto
capire che la testa del drago di questa e di altre inchieste non sta a Taranto.
E - forse - nemmeno a Potenza. Sta a Roma. Ed è - guarda caso! - la stessa testa
pensante che ha gestito lo scandaloso processo a carico di Raniero Busco per la
morte avvenuta venti anni fa di Simonetta Cesaroni (la compiuterista
asseritamente assassinata negli Uffici di copertura del Sisde dal fidanzato
impazzito Raniero Busco). .......Bha.......a pensar male - dicono - si fa
peccato. Però qualche volta si coglie il giusto!............”
Altrettanto non
si può dire della Procura di Taranto che ha visto un suo magistrato Matteo
Di Giorgio arrestato a
seguito di un’inchiesta coordinata dal pm di Potenza, Laura
Triassi,
e condannato in 1° grado dal Tribunale
di Potenza a
15 anni per concussione e corruzione in atti giudiziari. Ma non è tutto. Come
pena accessoria è stata disposta anche l’interdizione perpetua del magistrato
dai pubblici uffici, motivo per cui è stato attualmente sospeso dalle funzioni
dal Consiglio
Superiore della Magistratura.
Sentenza processo al pm Di Giorgio, i
fatti che riguardano il procuratore aggiunto Argentino,
scrive “Il Corriere del Giorno" il 28 ottobre 2015. La
sentenza “integrale” del processo che ha condannato il pm Matteo Di Giorgio e
per cui il Tribunale di Potenza ordinò ai sensi dell’art. 207 c.p.p. la
trasmissione degli atti alla Procura per procedere nei confronti di Argentino e
Petrucci (ex procuratore capo) per il reato di falsa testimonianza. Dalle
motivazioni della sentenza del processo di primo grado a carico dell’ex pm
Matteo Di Giorgio escono con le ossa rotte insieme al principale imputato
(condannato a 15 anni di reclusione) anche le istituzioni tarantine, i massimi
esponenti del passato e attuali della Procura di Taranto, nella fattispecie l’ex
procuratore capo Aldo Petrucci e l’attuale procuratore aggiunto Pietro
Argentino, rappresentanti delle Forze dell’ordine, agenti della Digos, il
vicequestore vicario in servizio fino a qualche anno fa, Michelangelo Giusti, un
sostituto commissario della sezione di pg della Polizia di Stato della
Procura e numerosi Carabinieri in servizio nelle caserme di Castellaneta
e Ginosa. I due magistrati, poliziotti e militari dell’Arma dei Carabinieri,
sono fra i 21 testimoni esaminati in dibattimento per i quali, con l’accusa di
falsa testimonianza, il collegio del Tribunale di Potenza ha disposto la
trasmissione degli atti alla Procura lucana. Nessuno è colpevole fino al terzo
grado di giudizio, principio sacrosanto sancito dalla Costituzione, ma quello
delineato nelle 665 pagine delle motivazioni è uno scenario inquietante. Dal
processo basato su intercettazioni e numerose testimonianze emerge quello che
viene battezzato “sistema Di Giorgio”, descritto come “una struttura a
piani sovrapposti, le cui fondamenta erano costituite dall’esercizio o dallo
sviamento delle sue funzioni giudiziarie o della sua qualità”. Un sistema,
stando alla sentenza, che faceva leva sulla “connivenza di altri funzionari
pubblici che operavano nella stessa struttura o diversamente abusando, a proprio
profitto, delle ‘maglie larghe’ di una organizzazione dell’ufficio che prevedeva
pochi controlli e lasciava ampi margini di discrezionalità nella assegnazione e
nella gestione dei procedimenti”. (vedi Allegato 1 – pag. 15) I fatti
che riguardano il procuratore aggiunto Argentino sono emersi dalle testimonianze
di due carabinieri. Il maresciallo Leonardo D’Artizio, all’epoca dei fatti in
servizio alla compagnia di Castellaneta, ha riferito di un incontro tenuto di
pomeriggio in Procura a Taranto con Argentino, sostituto procuratore, da lui e
dal capitano Gabriele Stifanelli, comandante della compagnia (attualmente
tenente colonnello). Argomento: presunti illeciti al comune di Castellaneta e
pressioni di Di Giorgio sul consigliere comunale Domenico Trovisi per far cadere
l’Amministrazione guidata dal sindaco e senatore Rocco Loreto. Tali circostanze
gli erano state riferite da un assessore comunale, Pontassuglia, il quale, però,
non aveva voluto mettere nero su bianco. Le sue dichiarazioni, comunque, erano
state registrate dal maresciallo.
D’Artizio ha raccontato che Stifanelli prese
appuntamento con Argentino ma, quando spiegarono il motivo della loro presenza
in Procura, il magistrato li condusse dal procuratore capo Aldo Petrucci.
Quest’ultimo disse loro che non si poteva iniziare un’indagine così delicata con
quegli elementi. La vicenda finì lì, “perché non c’è mai stata la possibilità
di iniziare un’indagine”. Sarebbe stata insabbiata sul nascere, stando alle
dichiarazioni rese non solo da D’Artizio. Il racconto trova conferma in quanto
riferito dal comandante Stifanelli. Quest’ultimo, l’anno successivo, il 2004, in
un altro contesto, l’indagine sul suicidio di un carabiniere in servizio a
Castellaneta, riferì al pm Vincenzo Petrocelli dell’incontro avvenuto nel 2003 e
di una relazione acquisita dallo stesso Argentino. “Era fine estate, ricordo.
E poi non se ne fece niente”. Sono state le parole dell’ufficiale dell’Arma,
uno dei migliori in fatto di produttività e di contrasto al crimine in provincia
di Taranto da diversi anni a questa parte. Una deposizione definita “genuina”
dal collegio in quanto il teste è estraneo al contesto del processo Di
Giorgio e, al tempo stesso, “in stridente contrasto” con quelle
di Argentino e Petrucci i quali, malgrado l’avvertimento del presidente del
collegio su possibili responsabilità penali che potevano emergere dalle loro
dichiarazioni, hanno negato di aver ricevuto il capitano Stifanelli e di aver
acquisito la relazione. “Può ipotizzarsi un comune interesse a coprire,
forse, la loro responsabilità, per avere omesso di formalizzare e inoltrare la
denuncia di D’Artizio e Stifanelli. Verosimilmente perché essa coinvolgeva
pesantemente il loro collega e amico Di Giorgio”. Altrimenti, sono sempre le
motivazioni della sentenza, non si spiega la ragione per la quale, dopo tre
anni, nel 2006, dopo aver appreso delle dichiarazioni rese da
Stifanelli, Petrucci ha chiesto una relazione ad Argentino che l’ha fornita. “I
dottori Petrucci e Argentino, a parere del collegio, hanno così tentato di
creare una copertura reciproca, formalizzando a
“futura memoria” le rispettive posizioni in un atto scritto che non riportava
però fedelmente i fatti accaduti”. Un
rimedio peggiore del male, stando alle conclusioni dei giudici. Durante la
testimonianza, Argentino ha dichiarato di aver incontrato due marescialli dei
quali non ricordava il nome ma non il capitano Stifanelli e ha sostenuto che non
gli fu fatto il nome della fonte, non gli fu riferito del possibile
coinvolgimento di Di Giorgio e non gli fu consegnata alcuna relazione. Anche sul
contenuto dell’incontro la sua deposizione stride con quella dei testi ritenuti
attendibili, D’Artizio e Stifanelli, è scritto nella sentenza, “non è
credibile”. La relazione di servizio dei Carabinieri,
si legge nella sentenza, avrebbe dovuto essere trasmessa a Potenza dal
procuratore Petrucci ma ciò non avvenne mai. Anzi, il
capitano Stifanelli rischiò di essere perseguito sotto il profilo disciplinare
per una nota di censura inviata dalla Procura al comando provinciale. Riuscì ad
evitare provvedimenti soltanto perché non più in servizio in Puglia. Quei fatti
sono datati e le presunte responsabilità dei magistrati non sono più
perseguibili per via della prescrizione. Quella stessa prescrizione prevista dal
Codice, ed osteggiata dalla Magistratura. Nel frattempo, il processo a carico
di Di Giorgio ed altri imputati è approdato in appello.
PARLIAMO DELLA CALABRIA.
…DI REGGIO CALABRIA. Operazione
Mammasantissima: 'ndrangheta, massoneria e politica nel mirino.
Ecco i segreti dell'indagine antimafia che scuote i salotti buoni di Reggio
Calabria. E mette a nudo i rapporti tra criminalità e Stato, scrive Gianfranco
Turano il 21 settembre 2016 su “L’Espresso”. La tempesta sta per arrivare. C’è
chi conta i giorni: fine settembre, ottobre al massimo. C’è chi per la paura dà
i numeri: centodieci candidati al carcere. Un’enormità per una città come Reggio
Calabria. Significa uno ogni mille abitanti circa. Se poi non saranno
centodieci, saranno pochi in meno e farà poca differenza. Zona altamente
sismica, Reggio. Quasi mezzo secolo di edilizia politica arditissima, realizzata
con i materiali in teoria antagonistici di ’ndrangheta, massoneria e Stato,
rischia di crollare sui grandi architetti che l’hanno ideata. È un oggetto con
molti nomi che si può chiamare Santa o Cosa Unita ma fino a poco tempo fa è
stato Cosa Ignota. L’elenco dei vip è già piuttosto robusto. Mammasantissima e
le altre inchieste della direzione distrettuale antimafia reggina hanno già
inguaiato parlamentari, ministri, politici: l’ex deputato Amedeo Matacena,
latitante da quasi tre anni, il senatore Antonio Caridi, che nel 2010 andava in
visita a casa del boss Giuseppe Pelle ed è stato arrestato il 4 agosto
scorso, l’ex ministro Claudio Scajola a processo ma ancora invitato vip alla
festa della polizia dello scorso 26 maggio, Giuseppe Scopelliti, ex sindaco di
Reggio ed ex governatore calabrese. Fondatore del Ncd con il ministro
dell’Interno Angelino Alfano, Scopelliti è stato condannato in primo grado a sei
anni per le malversazioni delle finanze municipali. È ancora sotto scorta in
quanto minacciato dalla ’ndrangheta (dal 2004) e dalle Brigate Rosse (dal 2012).
Nelle carte figurano anche Angela Napoli, già membro della commissione
antimafia, l’ex ragioniere generale dello Stato Andrea Monorchio che, secondo il
braccio destro di Scopelliti arrestato, Alberto Sarra, era il suo consigliere
insieme al sottosegretario alla giustizia Giuseppe Valentino. E poi ci sono gli
amici dei bei tempi della destra, Gianni Alemanno e Maurizio Gasparri. La Reggio
bene, la Reggio che conta non solo a Reggio è investita da un’onda che, per
alcuni, è tardiva e per altri meglio tardiva che sospesa in eterno. Si teme che
gli effetti collaterali colpiscano anche chi non è colluso, ma semplice vittima
dell’attitudine reggina al “me la vedo io”, quando qualcuno offre qualcosa,
senza chiedere nulla in cambio o non subito. Giuseppe De Stefano, “Crimine” del
clan di Archi oggi al 41 bis, l’ha battezzata brillantemente “la banca dei
favori”. È un istituto di credito che ha prosperato oltre ogni speranza, in
simbiosi con le strutture istituzionali, trasformandosi in apparato statale fin
dagli anni in cui la Cosa Nostra di Totò Riina dichiarava guerra alla
Repubblica. Il procuratore Federico Cafiero de Raho e il suo sostituto Giuseppe
Lombardo hanno impresso una svolta. Adelante con juicio, per dirla con il
Manzoni. Per dirla con Totò, chi sa dove vogliono arrivare. «La procura mette in
ginocchio la città», risponde Massimo Canale, ex Comunisti Italiani e poi
candidato sindaco per il Pd sconfitto nel 2010 dal centrodestra di Demetrio
Arena, lo scopellitiano che guiderà Reggio allo scioglimento per infiltrazioni
mafiose. Oggi Canale è tornato al suo mestiere di avvocato e difende Marcello
Cammera, uno dei funzionari più influenti e chiacchierati del Comune di Reggio,
alla guida del settore lavori pubblici. Si dichiara garantista a oltranza ma si
chiede dov’era lo Stato quando Caridi, consigliere comunale con la prima giunta
del sindaco Scopelliti, veniva eletto in Senato a rappresentare, secondo
l’accusa che lo ha portato dietro le sbarre, un’organizzazione criminale che non
si può più chiamare ’ndrangheta e forse neppure criminale vista la presenza di
magistrati, imprenditori, avvocati patrocinanti in Cassazione e commercialisti
con studio in centro a Milano. Un’organizzazione che controlla sistemi operativi
di rilievo internazionale come il porto di Gioia Tauro, dove sono attivi Cia,
Mossad e MI6, e ha accesso ai più evoluti strumenti finanziari del globo, dalle
grandi banche svizzere a fondi come il malesiano 1MDB, una vasca da miliardi
messa sotto sequestro negli Stati Uniti. Il fondo asiatico è uno dei fronti di
indagine in fase di sviluppo, come quello che riguarda il banchiere Robert K.
Sursock, numero uno di Gazprombank a Beirut. Un investigatore che da anni lavora
sul cono d’ombra della città dello Stretto dice: «Qualcuno si è chiesto come mai
il Credito Svizzero, che sponsorizza solo le nazionali elvetiche di calcio e il
tennista Roger Federer, doveva comparire per due anni sulle magliette della
Reggina in serie A tra l’altro con soldi mandati attraverso la branch di Hong
Kong?». Quasi fra le righe di Mammasantissima torna un nome di grande peso a
Lugano, quello di Vittorio Peer, ex proprietario dell’isola di Budelli,
amministratore della Ciga e mediatore di opere d’arte, citato dai pentiti Nino
Fiume (clan De Stefano) e dal colletto bianco massone Michele Amandini, oggi
collaboratore di giustizia dopo che, scrivono i magistrati, «aveva svolto, per
conto della ’ndrangheta, il compito di riciclare, attraverso canali finanziari
svizzeri, i proventi dei sequestri di persona a scopo di estorsione». Giuliano
Di Bernardo, ex Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia (Goi), la maggiore
obbedienza massonica italiana, sta spiegando la sua uscita dal Goi proprio con
l’infiltrazione della ’ndrangheta nelle logge (28 su 32 secondo l’allora vice
del Goi). Di Bernardo ha anche detto di avere messo al corrente della situazione
il capo supremo della massoneria inglese, il principe Edward duca di Kent, che
per questo motivo non ha voluto riconoscere il Goi. La nuova interpretazione del
rapporto fra ’ndrangheta e massoneria è che sia stata proprio la seconda a
infiltrare la prima dopo una sorta di “reverse merger” operato dalla componente
gelliana fin dai primi anni Settanta. Con la nascita della Santa, la ’ndrangheta
è rimasta una cosa per “quattro storti”, i quattro stupidi di cui parla
Pantaleone “Luni” Mancuso del clan di Limbadi. Sono i manovali del crimine che i
capi sacrificano in nome delle relazioni diplomatiche con il potere ufficiale.
«Non ho mai conosciuto un grande boss che non fosse il confidente di polizia,
carabinieri, finanza o servizi», dice Enzo Macrì, procuratore capo ad Ancona, ex
numero due della Dna e uno dei magistrati di Olimpia, il primo processo su
’ndrangheta e politica. «Soprattutto gli apparati di intelligence controllano
Reggio fin dagli anni Settanta». “Mammasantissima” ha due assi nella manica. Uno
sono le dichiarazioni di Alberto Sarra, ex consigliere regionale, amico
d’infanzia e di basket dell’ex sindaco e governatore Giuseppe Scopelliti. I
verbali di Sarra sono definiti “dirompenti” da chi sta seguendo l’inchiesta. Ma
c’è un secondo personaggio capace di portare l’indagine a livelli altissimi. È
Cosimo Virgiglio, curiosa figura di imprenditore implicato in un processo
(“Maestro”) con potenzialità enormi poi rimpicciolito a un traffico di merci
contraffatte sbarcate al porto di Gioia Tauro. Lì erano emerse le relazioni di
Virgiglio con il clan Molè, da una parte, e con un contesto eterogeneo
rappresentato dal piduista Giorgio Hugo Balestrieri, autore di un memoriale su
’ndrangheta e politica finora rimasto lettera morta, e da esponenti del clan
Casamonica. Attivo nell’immobiliare e proprietario della stazione dei
carabinieri di Rosarno, Virgiglio sta descrivendo riti e affari di
un’organizzazione che non può essere definita semplicemente criminale perché
include gli uomini dello Stato e diventa essa stessa apparato dello Stato.
Nell’ordinanza Mammasantissima i verbali di Virgiglio sono in larga parte
coperti da omissis perché vengono integrati in corso d’opera con i riscontri
sull’enorme deposito di documenti e fotografie trovato a Villa Vecchia,
l’albergo di Monte Porzio Catone al quale erano interessati gli uomini del clan
Molè. L’ordinanza Mammasantissima non è solo, come la definisce il sindaco
Giuseppe Falcomatà, «la madre di tutte le inchieste». Raccoglie il lavoro fatto
in vent’anni, dai processi Olimpia e Meta a Crimine-Infinito. Chi ha interesse a
smontare la madre di tutte le inchieste ripete una cantilena già sentita:
possibile che Paolo Romeo, o il senatore Antonio Caridi o uno qualunque degli
altri imputati in arrivo, siano il capo dei capi? Ma è un falso problema. Si
chiami Santa o Cosa Nuova o Stato, il potere nato nel cono d’ombra di una città
del sud di 200 mila abitanti e cresciuto fino a essere l’interlocutore delle
potenze statali internazionali, oltre che potenza economica globale in sé, è
un’oligarchia. L’oligarchia, per definizione, non ammette monarchi. Un
magistrato che ha vissuto la lotta alla ’ndrangheta fin dagli anni Novanta si
mostra più critico e avverte che bisogna stare attenti a distinguere,
all’interno del reale, tra fossili e esseri viventi. Ma da questo punto di
osservazione, uno dei “Mammasantissima” arrestati dovrebbe essere un fossile.
Invece è piuttosto un mediatore politico dotato di eccezionale longevità. Paolo
Romeo, 69 anni, inizia la carriera quasi mezzo secolo fa, quando da militante di
Avanguardia nazionale porta le bombe a mano dentro l’università di Roma durante
gli scontri studenteschi del 1968. Nello stesso anno, il fratello Vincenzo
uccide per futili motivi - una lite per un ballo alla Festa della Madonna della
Consolazione patrona di Reggio - il camerata Benedetto Dominici, a sua volta
fratello di Carmine che diventerà uno dei principali collaboratori di giustizia
sulle vicende al confine fra ’ndrangheta ed eversione neofascista. Iscritto al
Fuan, l’organizzazione giovanile del Msi, e fermato per partecipazione a
manifestazione sediziosa durante i Moti per Reggio capoluogo del 1970-1971,
Romeo prende presto la strada giusta al bivio dei rivoluzionari neri. Con la
sveltezza ideologica prescritta dal trasversalismo santista, diventa deputato
del partito socialdemocratico. Non dimentica di aiutare i camerati in
difficoltà, come i fuggitivi Stefano Delle Chiaie e Franco Freda, ma mette a
disposizione la sua influenza anche verso i compagni con i quali si è preso a
sprangate. Per usare la terminologia bolscevica, diventa il commissario politico
del clan De Stefano mentre il collega avvocato Giorgio De Stefano, anch’egli
patrocinante in Cassazione, determina le strategie affaristico-militari della
famiglia del quartiere Archi. «Per loro la condanna come concorrenti esterni in
associazione mafiosa è stata meglio di un’assoluzione», ha detto il pm Lombardo.
Il terzo dei concorrenti esterni è Amedeo Matacena junior, figlio di uno dei
finanziatori dei Moti per Reggio capoluogo del 1970, vera data di nozze fra
massoneria, servizi segreti e quella che allora era nota come mafia calabrese,
perché non aveva nemmeno un nome proprio. Dopo cinquant’anni dai suoi esordi,
Paolo Romeo parlava con tutti, dava ordini a tutti. A dispetto delle sue
condanne, suggeriva al presidente di Confindustria Reggio, Andrea Cuzzocrea,
editore del “Garantista”, l’assunzione della giornalista Teresa Munari, ritenuta
utile in quanto amica del componente dell’Antimafia Angela Napoli. Pochi giorni
prima di essere di nuovo arrestato, Romeo era nelle sale del Comune, a
partecipare a incontri sulla città metropolitana come membro dell’associazione
Forum Reggio Nord 2020, creando imbarazzi a un sindaco eletto contro il blocco
di potere santista. Del resto, Romeo considerava la città metropolitana una sua
creatura. Lo ha rivendicato lui stesso davanti al tribunale del Riesame: se non
era per lui, Reggio non entrava nella shortlist. Alla faccia, si può aggiungere,
di città più grandi e più ricche, come Brescia o Verona. In fondo, è la vecchia
storia della mafia che dà lavoro. Il rischio è che i sequestri giudiziari e la
chiusura di lidi, negozi, bar, siano il colpo di grazia a un’economia fragile.
Falcomatà la cui candidatura è stata imposta a un Pd a rischio di infiltrazioni
dal reggino più potente del momento, il sottosegretario ai servizi segreti Marco
Minniti, sta formulando un piano sul modello Expo per consentire alle imprese
impegnate in lavori pubblici urgenti ma colpite da interdittive antimafia di
completare le commesse sotto controllo. «Non deve passare il messaggio che con
la ’ndrangheta si lavora e con lo Stato no», dice il sindaco che invita la città
a reagire nei suoi corpi intermedi, senza affidarsi alle sole inchieste di
polizia. Lui non lo può dire ma il marcio è lì, nelle associazioni gestite dai
professionisti dell’antimafia e della mafia, fra gli imprenditori, negli ordini
professionali che mantengono nell’albo gli avvocati Romeo e De Stefano, che
propongono come probi viri legali coinvolti in inchieste di ’ndrangheta, che
conservano l’iscrizione al dottore commercialista Pasquale “Lino” Guaglianone,
ex tesoriere dei Nar di Giusva Fioravanti e Francesca Mambro. Ma la reazione
c’è. C’è sempre stata, a smentire la leggenda razzista sull’incapacità genetica
dei calabresi a ribellarsi. Continua a esserci. Dopo il cuoco Filippo
Cogliandro, il commerciante di prodotti sanitari Tiberio Bentivoglio, il
costruttore Gaetano Saffioti, il gestore di agriturismo Cristofaro Tedioso,
emigrato di ritorno dal Canada, c’è un fioraio che si chiama Vincenzo Romeo,
nessuna parentela con Paolo. Il fioraio aveva un chiosco al centro commerciale
Perla dello Stretto a Villa San Giovanni. Per non avere firmato l’accordo con il
consorzio il cui dominus era l’avvocato Paolo Romeo, nella notte del 3 giugno
2015 il chiosco è stato bruciato. Un servizio sul network la C ha trasmesso le
telefonate dopo il rogo fra il commerciante e il suo finanziatore di Unicredit.
«Senti, vedi che glielo puoi segnalare alla banca. Io domani mattina sono là che
ricostruisco», dice Romeo cercando con scarso successo di non piangere. «A me se
mi ammazzano... La mia famiglia campa sempre là. Campa là perché non so dove
andare. A 50 anni non so dove andare. Non so rubare. Mi possono ammazzare. Sono
sempre là». Il funzionario di Unicredit riferisce ai superiori di Milano, che in
conference call reagiscono sghignazzando. Alla fine, uno dei manager replica,
finalmente preoccupato: «E adesso che cacchio gli vendiamo? Il suolo?» Ma il
titolare del chiosco è stato di parola e ha tenuto duro. La Perla dello Stretto,
il centro commerciale controllato dall’avvocato Romeo, è stata riaperta dopo il
sequestro giudiziario disposto nell’inchiesta Fata Morgana. Se passate da Villa
San Giovanni e vi servono fiori, sapete dove andare.
Massoneria, mafia, politica e servizi:
ecco la “nuova” ‘ndrangheta. “In Calabria 28 logge su 32 controllate da clan”, è
scontro. "Vorrei che fosse chiaro che questa è la
nuova ‘ndrangheta, che nasce dalla commistione tra la vecchia struttura
criminale di tipo mafioso e la massoneria", spiega il pentito Lo Giudice ai pm
che indagano sulla cupola degli "invisibili". Il Gran Maestro Bisi attacca sui
verbali del suo predecessore Di Bernardo: "Avrebbe avuto gli strumenti per
intervenire", scrive Lucio Musolino il 18 luglio 2016 su "Il Fatto Quotidiano".
“Vorrei che fosse chiaro che questa è la nuova ‘ndrangheta, che nasce dalla
commistione tra la vecchia struttura criminale di tipo mafioso e
la massoneria”. È il collaboratore di giustizia Antonino Lo Giudice detto il
‘Nano’, assieme al pentito Cosimo Virgilio, a dare al sostituto procuratore
della Dda Giuseppe Lombardo i riscontri sui cosiddetti “invisibili” che tirano
le fila a Reggio Calabria. Le carte dell’inchiesta “Mamma Santissima”,
nell’ambito della quale è stato chiesto al Parlamento l’arresto per associazione
mafiosa anche del senatore Caridi, rischiano così di riscrivere la storia, non
solo politica, di una città dove sono ancora troppe le domande che non hanno
avuto una risposta. Punti interrogativi che possono essere svelati solo dopo
aver letto tra le pieghe del rapporto massoneria -‘ndrangheta – politica -
servizi segreti deviati. A partire dai tre panetti di tritolo piazzati
nell’ottobre del 2004 in un bagno di Palazzo San Giorgio e trovati grazie a tre
informative firmate dal numero due del Sisde Marco Mancini. Una bomba, collegata
a un telefonino, che non poteva esplodere perché non aveva l’innesco. Le barbe
finte del Sismi avvertirono la squadra mobile di allora che era stata la
‘ndrangheta a piazzare l’ordigno e che questo era indirizzato al sindaco
Giuseppe Scopelliti, messo sotto scorta ancora prima del rinvenimento dei
panetti da parte degli uomini del questore Vincenzo Speranza. A distanza di 12
anni, nessuno era riuscito a scoprire quale famiglia mafiosa aveva gestito
l’operazione ma solo che il tritolo era quello della “Laura C”, la nave
affondata a largo della costa jonica con tonnellate di esplosivo nella stiva
diventata il supermarket della ‘ndrangheta. Solo pochi giorni fa, il
procuratore De Raho ha spiegato che la collocazione di quell’esplosivo sarebbe
stato un avvertimento del gruppo Romeo-De Stefano per ottenere un duplice
effetto: da una parte condizionare Scopelliti e dall’altro dare di lui
l’immagine di un amministratore bersaglio della ‘ndrangheta, favorendone
l’ascesa politica. Una messa in scena, quindi, organizzata nei minimi
particolari dalle stesse persone in grado di lasciare fuori l’ala militare delle
cosche, fare arrivare il messaggio al vice di Pollari e, allo stesso tempo,
creare le condizioni affinché di quel tritolo non si sapesse più nulla. Alla
luce anche di questo, è più comprensibile quanto il pentito Lo Giudice spiega al
pm Lombardo il 21 giugno scorso: “In questa nuova organizzazione, la parte
identificabile con la vecchia ‘ndrangheta è incaricata di gestire i rituali e di
svolgere una funzione di parafulmine rispetto alla componente più importante e
riservata, che attraverso i rapporti con ulteriori apparati massonici gestisce
un enorme potere anche in campo politico ed economico”. Nino il “Nano” riferisce
ai magistrati quello che in cella gli ha raccontato il collaboratore Cosimo
Virgilio, profondo conoscitore dei grembiulini calabresi che aveva svelato alla
Dda come le cosche della Piana di Gioia Tauro avevano imposto la mazzetta del 3%
alle imprese che hanno ammodernato la Salerno-Reggio Calabria. “(Virgilio, ndr)
mi confidò – dice Lo Giudice – che faceva parte di una società segreta
chiamata massoneria e che era costituita da tre tronconi: una legalizzata (di
cui facevano parte professionisti di alto livello come giudici, servizi segreti
deviati e uomini dello Stato), la seconda da politici, avvocati e
commercialisti, e la terza da criminali con poteri decisionali e uomini
invisibili che rappresentavano il tribunale supremo che giudicavano la vita e la
morte di ogni affiliato, tutti uniti in unica potenza incontrastata”. È ancora
più chiaro lo stesso Virgilio che al pm Lombardo illustra come “materialmente è
avvenuta l’interrelazione tra la componente massonica e quella tipicamente
criminale”. Nel gergo massonico lo chiamano la “breccia di Porta Pia”. In realtà
è una sorta di camera di compensazione a una sola entrata, un “varco” tra il
mondo della ‘ndrangheta e quello dei grembiulini costituito da una “nuova figura
criminale che è identificata con la Santa”. “È importante – continua Virgilio –
precisare che, attraverso quel “varco” costituito dai santisti (soggetti
insospettabili), il mondo massonico entra nella ‘ndrangheta e non viceversa, per
quello che io ho vissuto e percepito. Devo precisare ancora che il ruolo di
santista all’interno della ‘ndrangheta non consente in automatico il
contatto con la massoneria: è necessario, invece, perché questo contatto
avvenga, che si individuino ulteriori soggetti “cerniera”, che noi definivamo
soggetti in giacca, cravatta e laurea, che fossero in grado di curare queste
relazioni senza che fossero direttamente individuabili”. Mafiosi e massoni
insieme quindi. In numerose inchieste ci sono tracce del fascino per la squadra
e il compasso nutrito dai boss. Con l’operazione “Mamma Santissima”, però,
scopriamo che è avvenuto soprattutto il contrario: sono i massoni che aprono
quel “varco” dove i loro interessi si mescolano con quelli della
‘ndrangheta. “Il sistema allargato, composto tanto dagli elementi massonici che
da quelli tipicamente di ‘ndrangheta, – è sempre il pentito Virgilio a parlarne
con il pm Lombardo – aveva come obiettivo finale quello di garantire
alla componente massonica, fortemente politicizzata, la gestione dei flussi
elettorali. La componente di ‘ndrangheta mirava al consolidamento degli ingenti
capitali sporchi, già formati, che andavano ricollocati sul mercato, anche
estero, mediante strumenti finanziari evoluti, gestiti attraverso
gli appartenenti alla massoneria”. Nelle carte dell’inchiesta “Mamma
Santissima”, il racconto dei pentiti si incastra alla perfezione con quello dei
massoni. A parlare ai magistrati è il professore Giuliano Di Bernardo, Gran
maestro del Grande Oriente d’Italia, “non un quisque del populo” chiarisce il
gip nell’ordinanza di custodia cautelare. Interrogato nel marzo del 2014,
infatti, Di Bernardo “ha illustrato quella che lui stesso aveva percepito essere
una sorta di compenetrazione fra una certa massoneria e la criminalità
organizzata, specie calabrese”. “Entrato in massoneria nel 1961, – sono le sue
parole – nel 1993, dopo essere fuoriuscito dal Goi (in cui ero stato nominato
Gran Maestro), fondai La Gran Loggia Regolare d’Italia, nel 2002 … in quanto
rimasi deluso anche di questa nuova esperienza. La Gran Loggia Regolare d’Italia
è stata riconosciuta dalla massoneria inglese. Il Goi disconosciuto. In
relazione a queste vicende ho avuto diretti contatti con il Duca di Kent che è
al vertice della massoneria inglese che è la vera massoneria. Ettore Loizzo,
ingegnere di Cosenza, mio vice nel Goi, nel corso di una riunione della Giunta
(una sorta di cda del Goi in cui era presente anche il mio successore Gustavo
Raffi, attuale Gran maestro) che io indissi con urgenza nel 1993 dopo l’inizio
dell’indagine del dottor Cordova sulla massoneria, a mia precisa richiesta,
disse che poteva affermare con certezza che in Calabria, su 32 logge, 28 erano
controllate dalla ‘ndrangheta. Io feci un salto sulla sedia. Gli dissi subito: e
cosa vuoi fare di fronte a questo disastro. Lui mi rispose: nulla. Io ancora più
sbigottito chiesi perché. Lui mi rispose che non poteva fare nulla perché
altrimenti lui e la sua famiglia rischiavano gravi rappresaglie. Fu questo che
mi indusse prendere contatti con il Duca di Kent a cui esposi la suddetta
situazione. Lui mi disse che già sapeva questa situazione tramite notizie da lui
avuti dall’Ambasciata in Italia e dai servizi di sicurezza inglesi”. La
rievocazione dei verbali di Di Bernardo provoca la dura reazione di Stefano
Bisi, Gran maestro dl Grande Oriente d’Italia. “Il Grande Oriente d’Italia, pur
non avendo nulla a che fare in termini di ruolo, di logge e dei suoi iscritti”
con l’inchiesta, sostiene Bisi, “è stato poi strumentalmente e forzatamente
evocato in tale contesto dagli organi d’informazione”. Secondo il Gran Maestro,
“tirare in ballo un morto, che non può minimamente contraddire o puntualizzare
la versione dei fatti attribuitagli, è sin troppo facile e da furbi”. Poi
l’attacco a Di Bernardo, che “avrebbe avuto tutti gli strumenti massonici a sua
disposizione e sarebbe dovuto prontamente intervenire per sciogliere le Logge in
presunto odore d’illegalità di cui ha parlato nel 2014, o denunciarne i fatti
alle autorità competenti. Il non averlo fatto allora sarebbe ancora oggi un atto
estremamente grave e incomprensibile”. Dal racconto di Di Bernardo emerge
come massoneria, ‘ndrangheta, Cosa Nostra e destra eversiva erano impegnate a
sostenere i movimenti separatisti siciliani e meridionali. In sostanza l’oggetto
dell’inchiesta “Sistemi criminali” che l’ex procuratore aggiunto di Palermo
Roberto Scarpinato non riuscì a portare avanti. Un’indagine in cui era stato
coinvolto Paolo Romeo, uno dei presunti componenti della cupola degli
“invisibili” assieme al senatore di Gal Antonio Caridi e all’ex sottosegretario
regionale Alberto Sarra. “Seppi dai miei referenti calabresi e non solo – mette
a verbale il Gran maestro Di Bernardo – che all’interno del Goi all’inizio degli
anni 90, vi erano soggetti che sostenevano i movimenti separatisti siciliani e
meridionali in generale. Reggio Calabria era il centro propulsore, l’origine di
tali movimenti autonomisti che trovavano sostegno in numerosi esponenti della
massoneria e più esattamente del Goi. Ero molto preoccupato da questa
situazione. Nel nord vi era la Lega Nord, a sud si stavano creando questi
movimenti separatisti. Vedevo il nostro paese a rischio. In tutto questo, avevo
accertato che assai probabilmente la precedente gestione del Gran Maestro del
Goi era al centro di un traffico di armi con paesi extra-europei”. Intanto
oggi a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, c’è
stata una nuova perquisizione dei carabinieri del Ros e del Reparto Operativo.
L’obiettivo degli investigatori è trovare altri riscontri sulla posizione
dell’ex sottosegretario della Regione Alberto Sarra, fino al 2005 assessore al
Personale e nei cinque anni successivi consigliere di minoranza. Uomo di Paolo
Romeo (considerato la mente della ‘ndrangheta reggina), Alberto Sarra è uno dei
due politici regionali coinvolti nell’inchiesta “Mamma Santissima”. L’altro è il
senatore Caridi che, prima di essere eletto al Parlamento, è stato assessore
regionale alle Attività produttive. Entrambi, così come Paolo Romeo, erano di
casa a Palazzo Campanella dove, anche adesso, hanno i loro referenti. Non è
escluso che la Dda stia cercando di ricostruire come i due politici, che
gestivano importanti budget, possano aver contribuito con emendamenti e proposte
di legge a rafforzare gli amici dei clan.
'Ndrangheta: il senatore
Caridi al vertice della "cupola segreta" calabrese.
Cinque uomini tra politici e avvocati avrebbero condizionato gli appuntamenti
elettorali e deciso chi doveva sedere in Parlamento, scrive Nadia Francalacci il
15 luglio 2016 su "Panorama". Il senatore Antonio Caridi, sarebbe uno dei cinque
elementi della “cupola segretissima” di vertice della 'Ndrangheta.
Avrebbe condizionato gli appuntamenti elettorali in ambito comunale,
provinciale, regionale individuando, assieme ad altri quattro uomini, persino i
propri affiliati da proiettare in Parlamento. Questo è quello che hanno scoperto
i Carabinieri del Ros di Reggio Calabria che questa mattina, nell’operazione
“Mammasantissima”, hanno stroncato la cupola arrestando tutti gli illustri e
insospettabili appartenenti. Assieme a Caridi, senatore di Gal, la cui ordinanza
di custodia in carcere stata inviata alla Giunta per le autorizzazioni a
procedere del Senato, infatti, sono stati arrestati anche l'ex deputato del Psdi
Paolo Romeo, già in carcere dal 9 maggio scorso, l'ex consigliere regionale
e sottosegretario della Giunta regionale di centrodestra Alberto Sarra,
l'avvocato Giorgio De Stefano e Francesco Chirico. La "struttura segreta di
vertice" della 'Ndrangheta, in base all’indagine dei Ros, avrebbe dato le
direttive a tutta l'organizzazione e tenuto contatti di "alto livello", nei vari
ambienti politici, istituzionali ed imprenditoriali per infiltrarli ed
asservirli ai propri interessi criminali. L'ordinanza di custodia cautelare,
eseguita stamani dai carabinieri, è stata emessa su richiesta della procura
distrettuale antimafia di Reggio Calabria secondo cui i cinque destinatari del
provvedimento sono tutti accusati di associazione mafiosa. Sempre secondo la
procura, la “cupola” composta dai cinque uomini era in grado di condizionare gli
appuntamenti elettorali a tutti i livelli: dal locale al nazionale. "La misura
cautelare di oggi rappresenta un ulteriore sviluppo del quadro
'ndranghetistico-massonico descritto che figura in provincia di Reggio Calabria.
Si tratta di un livello superiore", ha commentato il procuratore di Reggio
Calabria, Federico Cafiero de Raho, in merito all'inchiesta". Solo pochi giorni
fa, un’altra operazione dei carabinieri aveva sgominato un’organizzazione
criminale facente capo alle ‘ndrine calabresi che era riuscita a gestire gli
impianti idrici e di depurazione delle acque in numerose località Italia. Un
vero e proprio "comitato d'affari" composto da dirigenti, funzionari pubblici e
imprenditori capaci di gestire la "macchina amministrativa comunale"
nell'interesse della 'ndrangheta, l’organizzazione criminale calabrese che era
riuscita ad infiltrarsi nell’apparato dello Stato e a gestire dall’interno
appalti milionari attraverso gare truccate, estorsioni e mazzette.
Antonio Caridi, il senatore
"dirigente della cupola di 'ndrangheta".
"Mammasantissima" è l'indagine sulla mafia calabrese che fa tremare la politica
italiana. Per il parlamentare ex Ncd è stato chiesto l'arresto. Ma nelle carte
spuntano i nomi di Gasparri e Alemanno, che non sono indagati, scrive Giovanni
Tizian il 15 luglio 2016 su “L’Espresso”. Il senatore Antonio Caridi è un
«dirigente ed organizzatore della componente "riservata" della ‘Ndrangheta».
Così scrive il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza con cui viene
chiesto l'arresto del politico calabrese. Punto di riferimento nazionale,
insomma, di quella che la procura di Reggio Calabria guidata da Federico Cafiero
De Raho definisce una struttura segreta e di vertice dell'organizzazione
criminale. Un'accusa pesantissima per il parlamentare ex Ncd, ora nel gruppo
Gal, Grande autonomia e libertà. Su Caridi dovrà ora esprimersi la giunta per le
autorizzazioni di palazzo Madama. Intanto la richiesta è già partita per Roma.
La componente riservata, dicevamo. Un'entità che assomiglia molto a una super
loggia massonica. E, del resto, in tempi non sospetti è stato uno dei padrini
più influenti della regione a spiegare, intercettato, la mutazione genetica
della mafia calabrese: «La ‘ndrangheta fa parte della massoneria» esclamava con
il suo sodale qualche tempo fa Pantaleone Mancuso, sovrano di Vibo Valentia. Di
questa cupola elitaria fanno parte al momento cinque persone. I capi sono due
avvocati (e già questo la dice lunga sulla natura di questa entità) Giorgio De
Stefano e Paolo Romeo. Entrambi hanno segnato la storia criminale dello Stretto.
Dai boia chi molla in poi, tra massoneria deviata, eversione nera e fittissimi
intrecci con il potere anche nazionale. Accanto a loro c'è, ipotizzano
investigatori e pm, Alberto Sarra, già sottosegretario nel governo regionale
guidato da Giuseppe Scopelliti. Poco più sotto nella gerarchia si trova
l'imprenditore Francesco Chirico. E infine, il politico che è arrivato a Roma:
Antonio Caridi. Del senatore Caridi, agli atti dell'inchiesta "Mammasantissima"
coordinata dal pm Giuseppe Lombardo, c'è tutta la sua carriera politica. Un
percorso, ora emerge, viziato dal continuo appoggio delle cosche reggine. Per
esempio: «Fruiva dell’appoggio della ‘ndrangheta, cosca De Stefano, in occasione
di tutte le consultazioni elettorali alle quali prendeva parte, dalla prima
candidatura (elezioni comunali 1997) alle elezioni regionali del 2010»; «Fruiva
dell’appoggio della ‘ndrangheta, clan Crucitti e Audino in occasione delle
elezioni regionali del 2005». Così anche, ma con sostegno di famiglie diverse,
per le regionali del 2000, per le comunali del 2007 e così via. Avrebbe,
inoltre, utilizzato una 'ndrina della città, i Tegano, per «individuare l'autore
di un'intimidazione subita nova anni fa». Non solo. Per il sistema di cui fa
parte avrebbe deciso nomine nella partecipate, fatto assunzioni pilotate e
canalizzato finanziamenti. Tutto questo per agevolare l'associazione. Anche
«mediante l’uso deviato del proprio ruolo pubblico, delle cariche di volta in
volta ricoperte all’interno del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, della
Giunta Comunale di Reggio Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria,
della Giunta Regionale della Calabria e del Senato della Repubblica». Da questo
e molto altro Caridi si dovrà difendere davanti ai colleghi senatori. Che, con
tutta calma, dovranno valutare se la richiesta d'arresto è fondata su solide
basi. Non è il solo politico di caratura nazionale citato nei documenti
dell'accusa. Gianni Alemanno (in fondo all'articolo la sua replica), per
esempio, viene tirato in ballo per le elezioni europee del 2004. Il gip scrive -
nella parte riguardante Alberto Sarra, uno degli arrestati - che l'ex sindaco di
Roma (imputato in mafia Capitale) ha ricevuto l'appoggio elettorale del
gruppetto finito sotto inchiesta. C'è anche Maurizio Gasparri, attualmente vice
presidente del Senato, nelle carte. Uno degli episodi, di qualche anno fa,
citati da un collaboratore riguarda delle assunzioni chieste da Giuseppe
Scopelliti, ex primo cittadino di Reggio e poi governatore della Regione. «Per
le assunzioni non parlava … solo una volta ha parlato con me di un suo protetto
… era il cameriere del Cordon Bleu, che era amico intimo di Gasparri. Infatti,
ha chiamato Gasparri direttamente a Scopelliti. È stata l’unica volta che
entrando a Palazzo San Giorgio che il Sindaco mi chiese di assumere direttamente
questo qua». Il riferimento, racconta un imprenditore-pentito, è ai posti di
lavoro promessi in una S.p.a., la Fata Morgana. Società che si occupava della
raccolta differenziata in città. L'imprenditore ha rivelato ai magistrati che la
politica, incluso Scopelliti, faceva enormi pressioni per pilotare assunzioni. E
a "cantare" non è un collaboratore di giustizia qualsiasi. Ma l'ex responsabile
tecnico della S.p.a., parente stretto di Orazio De Stefano, nome e volto del
gotha delle 'ndrine reggine. Clientele, criminalità, massoneria. L'intreccio è
diabolico. Ecco come il pentito Cosimo Virgiglio, in un recentissimo verbale,
descrive la commistione tra mafia e logge: «Ribadisco che il sistema allargato,
composto tanto dagli elementi massonici che da quelli tipicamente di
‘Ndrangheta, aveva come obiettivo finale quello di garantire alla componente
massonica, fortemente politicizzata, la gestione dei flussi elettorali. La
componente di ‘Ndrangheta mirava al consolidamento degli ingenti capitali
sporchi, già formati, che andavano ricollocati sul mercato, anche estero,
mediante strumenti finanziari evoluti, gestiti attraverso gli appartenenti alla
massoneria». Sembra l'incipit di un romanzo di le Carré. Invece è la realtà. Che
l'antimafia di Reggio Calabria ritiene di aver smascherato. Una rete di
"invisibili" che negli ultimi tempi stanno diventano sempre più visibili.
La nota di Gianni Alemanno in
risposta al nostro articolo: "Smentisco nella maniera più categorica qualsiasi
mio collegamento con gli uomini coinvolti nell'inchiesta sulla cosiddetta "Mamma
Santissima" dell'ndrangheta. Nella fattispecie non ho mai conosciuto nè
politicamente nè personalmente il senatore Antonio Caridi, mentre con l'ex
sottosegretario regionale Alberto Sarra non intrattengo più alcun rapporto da
almeno dieci anni. In ogni caso la mia azione nella regione Calabria è sempre
stata di natura politica ed elettorale senza nessun contatto con ambienti o
logiche di tipo affaristico. Vi diffido pertanto dal pubblicare il mio nome
negli articoli relativi a questa inchiesta senza alcun riscontro possibile nelle
carte che sono attualmente coperte dal segreto istruttorio".
Cosa nostra e 'ndrangheta?
"Una Cosa sola".
Le riunioni comuni per progettare le stragi del '92. Il no dei calabresi al
bagno di sangue. E la nuova saldatura nel dopo Riina. Così due organizzazioni
hanno modellato negli anni una joint venut che oggi fa paura, scrive Giovanni
Tizian il 15 luglio 2016 su "L'Espresso". Mentre la politica immaginava il mega
ponte sullo Stretto, le mafie che dominavo le rispettive sponde ne avevano già
realizzato uno, assai solido e resistente alle bufere. Nell'inchiesta
“Mammasantissima” coordinata dalla procura antimafia di Reggio Calabria che ha
svelato la cupola dei membri invisibili della 'ndrangheta c'è anche questo: lo
strettissimo rapporto tra mafiosi siciliani e calabresi. La ricostruzione dei pm
attraverso le dichiarazioni di numerosi pentiti è un tuffo nell'oceano di
misteri e alleanze che permetteranno di rileggere anche fatti drammatici
avvenuti nel Paese. Come gli anni delle stragi, per esempio, e le successive
trattative. Giuseppe Costa è uno dei collaboratori che ha raccontato questi
legami per molto tempo rimasti avvolti nel silenzio. E che in molti non volevano
neppure vedere: «Come ho già riferito in altri interrogatori, i legami fra Cosa
Nostra e ‘Ndrangheta erano strettissimi. Non so in concreto per quanto tempo, nè
con quali risultati operativi, ma, sicuramente, si arrivò, anche a progettare e
poi a dare forma (parliamo del periodo immediatamente successivo alle stragi di
Falcone e Borsellino) ad una super-struttura che comprendeva le due
organizzazioni: la c.d. Cosa Nuova. Si trattava di una sorta di organizzazione
mafiosa di vertice che ricomprendeva sia gli elementi di spessore e di peso di
Cosa Nostra che quelli della ‘Ndrangheta. Ciò avrebbe consentito uno scambio di
favori ancora più intenso e continuo fra siciliani e calabresi. Ma non solo:
Cosa Nuova serviva anche ad inserire in modo più organico nel tessuto del
crimine organizzato siciliano e calabrese, persone insospettabili, collegamenti
con entità politiche, istituzionali e massoniche...Tenga presente che, come pure
ho già spiegato, io ero legato alla cosca dei Piromalli, che, a loro volta,
insieme ai De Stefano, erano la famiglia storicamente più legata a Salvatore
Riina e a Cosa Nostra. Con riferimento ai rapporti fra Massoneria e mondo
criminale voglio precisare anche che a me era noto, in quanto ‘ndranghetista e
in quanto me lo aveva detto personalmente Giuseppe Piromalli nel corso di una
comune detenzione nel carcere di Palmi, che si trattava di rapporti molto
intensi specie in Calabria. Più in Calabria che in Sicilia... Un esempio
concreto delle sinergie fra Cosa Nostra e ‘Ndrangheta è costituito sicuramente
dall’omicidio del giudice Scopelliti». Anche pentiti siciliani hanno riferito di
queste relazione tra le mafie divise solo dallo Stretto. Gioacchino Pennino -
uomo d'onore, politico e massone - racconta di una joint venture economica e
culturale tra le organizzazioni: «Mio zio mi confidò di essere stato da
latitante, negli anni 60’, ospite del clan Nuvoletta nel napoletano. La cosa non
deve sorprendere in quanto Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Sacra Corona Unita, sono
da sempre unite fra loro. Sarebbe meglio dire sono una “cosa sola”. Da lì mio
zio, come mi raccontò, si recava in Calabria dove, mi disse, che aveva messo
insieme massoni, ‘Ndrangheta, servizi segreti, politici per fare affari e
gestire il potere. Una sorta di comitato d’affari perenne e stabile. In seguito,
essendone molto amico, pochi mesi prima della sua morte, nel 1980-81, mi trovai
a parlare con Stefano Bontate. Nel corso di questo incontro Bontate (boss della
mafia palermitana ndr) mi disse che avrebbe avuto molto piacere se lo avessi
aiutato a continuare “quel progetto di tuo zio” (il comitato d’affari fra
criminali, massoni e servizi) non solo in Calabria, dove si era consolidato, ma
anche in Sicilia dove il progetto era ancora in fase embrionale. Io con molta
diplomazia riuscii a svicolare e a declinare l’invito. Non volevo assumere
questo ruolo e non mi interessava farlo». C'è poi un aspetto, forse il più
inquietante, in questa storia di malacarne e notabili insospettabili. Lo rivela
l'ex autista di Leoluca Bagarella, braccio destro di Riina, ai magistrati.
L'uomo dei Corleonesi rivela «l’esistenza di una struttura “riservata”
all’interno di ‘ndrangheta e Cosa Nostra, destinata a gestirne le relazioni e
gli affari di maggior rilievo». Il leader del club dei “riservati” siciliani
sarebbe stato proprio Bagarella. Era lui, dunque, a dialogare con i
mammasantissima al di là dello Stretto. E sarebbero stati proprio questi due
“club” esclusivi a organizzare le riunioni in Calabria per progettare la
stagione stragista. O meglio: Cosa nostra voleva tirare dentro anche la
'ndrangheta. Ma l'unico dei boss calabresi che aveva dato la disponibilità era
stato Franco Coco Trovato, capo indiscusso di Milano ma legato a doppio filo con
il potere criminale reggino. Ma se per le bombe il gotha della 'ndrangheta ha
fatto un passo indietro, per il post-stragi - è questa l'ipotesi su cui la
procura di Reggio lavora da tempo - la storia ha preso una piega diversa. Perché
è dopo gli omicidi eccellenti che 'ndrangheta e Cosa nostra, ora in versione
sommersa, ritrovano obiettivi comuni. Impunità e business. Un unico grande
sistema criminale mafioso. Dove le differenze si assottigliano. Con l'obiettivo
di spartirsi il Paese. E non solo.
Platì è mafiosa? Già, ma ha eletto Rosy
Bindi, scrive Ilario Ammendolia il 7 giugno 2016 su
“Il Dubbio”. In questi giorni di vigilia elettorale, Platì, paese di tremila
abitanti della Locride, in Calabria, è andato sulla prima pagina di tutti i più
importanti quotidiani nazionali. Domenica s’è votato ed i candidati a sindaco
sono due normalissime persone del luogo: Ilaria Mittica, funzionaria regionale e
Rosario Sergi assicuratore. Elezioni normali come in tutti i paesi d’Italia ed,
a tratti, quasi noiose. Ma per gli inviati speciali che per tutta la giornata si
sono aggirati ai seggi con penna e taccuino, quella di ieri non è stata una
normale manifestazione di libertà e di democrazia. A Platì, dietro ogni cosa,
c’è sempre la ndrangheta anche se non è spuntata la lupara né il coltello. Anche
se uomini e donne sono andati gioiosamente ai seggi e senza pistola alla tempia.
Inutile. Qui si è colpevoli a prescindere. L’inviato di un importante quotidiano
nazionale dinanzi alla gente che va al voto scrive che a «Platì siamo al
Medioevo. Questa è una terra che è Italia solo sulla carta geografica». (La
Repubblica) Ed è vero. Questa è una Terra che non è Italia gli ospedali
somigliano tremendamente ai lazzeretti. Non è Italia perché ha il tasso di
disoccupazione più alto di Europa. Perché la garanzie costituzionali sono state
sospese da tempo. Perché uno Stato intriso di mentalità mafiosa si arroga di
sciogliere i consigli comunali democraticamente eletti. Non è Italia perché le
classi dirigenti hanno seminato per decenni la malapianta della ndrangheta
trasformando un popolo di lavoratori in popolo di emarginati. Non è Italia
perché i parlamentari e la classi dirigenti regionali ha scambiato per mezzo
secolo i voti della ndrangheta con favori accordati ai mafiosi. Infatti, la
ndrangheta per decenni è stata uno di strumento di governo cresciuta persino (o
soprattutto) nelle caserme e nei tribunali. Non è Italia perché le
disuguaglianze sono più evidente che altrove. Non è Italia perché qui è stata
eletta Rosy Bindi che, chiusa in una caserma di Locri, e debitamente a distanza
dai “lebbrosi” che l’hanno eletta, pontifica come una vestale del tempio sulla
mafiosità dei calabresi. Non è Italia perché il presidente del consiglio dei
ministri indica il candidato a sindaco di Platì dal palco della Leopolda. Perché
l’on. Fava si è permesso di affermare che i candidati di Platì pur essendo in
regola con i criteri dell’antimafia sono comunque sospetti, ci mancherebbe
altro! Non è Italia perché l’indegno spettacolo che in occasione del 2 giugno
del 2015 il PD ha messo in scena a Platì, ha dimostrato la consistenza e la
serietà dei partiti calabresi. Sostanzialmente uguali! Non è Italia perché il
procuratore della Repubblica di Reggio, ha dichiarato che sarebbe utile
affiancare al nuovo sindaco di Platì un funzionario per controllare ogni atto
della futura amministrazione. Un super controllo a Platì mentre le classi
dirigenti fanno sparire nel nulla i miliardi che sarebbero destinati alla sanità
o all’ambiente. Si vuole una Calabria ridotta tout-court alla sola dimensione
criminale (che esiste) perché ciò fa molto comodo alla “catena di comando”. I
mafiosi ci sono e vanno fieri dell’attenzione che ricevono dai giornali, dai
“partiti”, dalle istituzioni. In questa nottata in cui tutti i gatti sono neri,
loro ci sguazzano come pesci nel mare. In tutta la Calabria il voto è stato
espressione di un disagio estremo. Ovunque si notano segnali di una rivolta
strisciante contro lo Stato e che solo Dio sa come potrebbe andare a finire. A
Cosenza più che per il “buongoverno” del sindaco uscente si è votato contro gli
oligarchi del potere. A Napoli De Magistris, che in Calabria, si è mosso come
rigoroso custode dell’ordine costituito, è diventato il Masaniello che agita il
“Sud ribelle” contro il Gran Ducato di Toscana. Napoli e Platì sono distanti
solo in apparenza. Per usare il linguaggio di Sciascia è la linea della Palma
che avanza. Chi vuole ridurre la questione meridionale che oggi si allarga sino
a diventare una “questione Mediterranea” a mera questione criminale o di ordine
pubblico si assume sulle spalle e per intero le responsabilità storiche di
quanto potrebbe accadere. Nel Mezzogiorno, probabilmente la rabbia, lungamente
repressa, non troverà sbocco nel movimento “5 Stelle” ma potrebbe sbucare come
un fiume carsico nei luoghi più impensati con conseguenze che nessuno in questo
momento è in grado di prevedere.
I cento padroni di Palermo,
da “I Siciliani”, giugno 1983. Camminare a Palermo. Il viale bianco di sole. Le
grandi nuvole che arrivano da Punta Raisi, la loro ombra corre sul viale più
veloce delle auto. Il cielo sul mare è abbagliante, il cielo sulle montagne a
sud, è nero di tempesta. Il gelato da Roney. Tre signore di mezza età stanno
sulle poltroncine verdi, con le sopracciglia alte e le boccucce delle signore di
Tolouse Lautrec, sedute al divano rosso. Fumano con boccate avide, l’una
racconta e continuamente ride, scuote la cenere in aria, l’altra sorride
melliflua, la terza annuisce. Sorbiscono granita di mandorla. Tre boccucce
eguali come fossero state dipinte dalla stessa mano. Camminare a Palermo. Il
cuore del vecchio mercato a mezzogiorno. Almeno cinquemila persone in un
groviglio di vicoli che affondano tutti verso la piazzetta. Cento bancarelle
sormontate dai giganteschi ombrelloni rossi, pesce, verdura, carne, mele, noci,
aragoste, i quarti insanguinati di vitello, i capretti sventrati che pendono
dagli uncini, i banditori urlano tutti insieme, lottano così l’uno contro
l’altro, in mezzo alla folla. Camminare a Palermo. Il circolo della stampa, con
i soffitti bassi, il sentore e l’odore della catacomba, il buio, la luce verde
del bigliardo senza giocatori, tre bizzarri individui che ti vengono incontro da
tre direzioni diverse, si rassomigliano incredibilmente tutti e tre, saluti
gentilmente e nello stesso momento tutti e tre ti salutano con l’identico
sorriso, sono gli specchi che dagli angoli bui riflettono la tua immagine.
Silenzio. Un aroma di caffè, un cameriere vecchissimo, allampanato che appare
vacillando, da un angolo d’ombra all’altro, e scompare. Su un divano tre vecchi
signori impassibili dinnanzi a un televisore in bianconero che pispiglia
qualcosa. Uno dei signori ha il bastone col manico d’argento, le ghette, il
panama bianco. Si alza levando dolcemente il bastone a mo’ di saluto: “Ho fatto
tardi!”. Se ne va adagio, si volge solo un attimo con un mormorio. Non si
capisce se abbia detto: “Debbo morire!”. Camminare a Palermo? Gli osceni edifici
a dodici, quindici piani, che si affollano l’uno sull’altro, lungo la riva del
canalone che scende dalla collina al mare, con un rivolo d’acqua putrida al
centro, e giù in basso i tuguri dove si ammassano venti persone, a due metri da
quel rigagnolo giallo. I bambini che giocano da una riva all’altra. Bambini
così, anche cani così che corrono in mezzo ai bambini, li ho visti solo a Palma
di Montechiaro. Anche il colore, anche il fetore di quel rigagnolo è lo stesso
di quel liquame che scorre orribilmente fra le rupi di Palma. Tutto questo è
retorica, lo so. A Palma di Montechiaro però tre bambini su dieci muoiono prima
di arrivare all’età scolare. E da qualche parte, in questa immensa città, c’è
qualcuno che sta discutendo quale sarà il destino di questi bambini di Palermo
per i prossimi venti o trent’anni. E quale sarà il suo guadagno. Palermo è una
delle città più belle d’Europa e certamente una delle più infelici. Forse più
della stessa Napoli. Palermo è sontuosa e oscena. Palermo è come Nuova Delhi,
con le reggie favolose dei maharajà e i corpi agonizzanti dei paria ai margini
dei viali. Palermo è come Il Cairo, con la selva dei grattacieli e giardini in
mezzo ai quali si insinuano putridi geroglifici di baracche. Palermo è come
tutte le capitali di quei popoli che non riuscirono mai ad essere nazioni. A
Palermo la corruzione è fisica, tangibile ed estetica: una bellissima donna,
sfatta, gonfia di umori guasti, le unghie nere, e però egualmente, arcanamente
bella. Palermo è la storia della Sicilia, tutte le viltà e tutti gli eroismi, le
disperazioni, i furori, le sconfitte, le ribellioni. Palermo è la Spagna, i
Mori, gli Svevi, gli Arabi, i Normanni, gli Angioini, non c’è altro luogo che
sia Sicilia come Palermo, eppure Palermo non è amata dai siciliani. Gli
occidentali dell’isola si assoggettano perché non possono altrimenti, si
riconoscono sudditi ma non vorrebbero mai esserne cittadini. Gli orientali
invece dicono addirittura di essere di un’altra razza: quelli sicani e noi
invece siculi, quelli cartaginesi, saraceni, andalusi, napoletani; noi greci,
romani, svevi, milanesi. I catanesi hanno proposto due capitali dell’isola per
due popoli diversi, si tratta di uno sberleffo, ma nella realtà in cosa potranno
mai essere rassomigliati (concetto dell’uomo o pensiero sulla vita) Verga e
Tomasi di Lampedusa, oppure Vitaliano Brancati e Leonardo Sciascia? Pirandello,
che stava in contemplazione a metà strada fra questi due concetti dell’essere,
probabilmente dovette pensare quanto l’essere siciliano in definitiva fosse
fantastico e improbabile. I siciliani non amano Palermo e Palermo lo sa
perfettamente ma non se ne cura. I siciliani non amano Palermo poiché essa è la
capitale che esige soltanto tributi e obbedienza, e in verità Palermo vuole
questo soprattutto, come è giusto che sia il rapporto fra sudditi e sovrano. Il
catanese, il siracusano, il messinese, il ragusano, si azzannano a vicenda, ma
se qualcuno forestiero gli chiede la provenienza, dicono: Siciliano! E basta. Il
palermitano dice: palermitano, che a parer suo è cosa inimitabile e sovrana. I
Siciliani non amano Palermo. C’è qualcosa che impaurisce e respinge. Io ho visto
per le strade di Catania auto sbucare di colpo, e uomini balzare fuori con le
armi in pugno e cominciare a sparare addosso ad altri uomini, e chinarsi urlando
a sparare il colpo di grazia alla nuca. Ho visto corpi insanguinati di ragazzi
uccisi, giacere in mezzo alla strada e la gente che continuava ad andare, le
auto a correre. Ho visto cortili fracassati dalle raffiche di mitra e dalle
schegge delle bombe a mano, e colava dai muri e le polpette ancora fumanti sulla
mensa. Ho visto madri avanzare piangendo verso i corpi degli uccisi, sostenute
pietosamente da parenti che però avevano la sigaretta fumante in bocca. La morte
a Palermo è diversa, la morte violenta. Più profonda, più arcana e fatale. Esige
contemplazione: una fila di sedie tutt’intorno al corpo insanguinato, in mezzo
alla strada, e ai parenti seduti immobili, in silenzio, a guardare. I ragazzini
immobili e attenti. La morte è spettacolo da non perdere. La morte ha sempre una
ragione d’essere. A Palermo essa va meditata e capita. Chi sono i padroni di
Palermo? Coloro che hanno nel pugno il destino di questa grande, splendida e
infelice capitale del Sud? E’ una domanda essenziale poiché essere padroni di
Palermo non significa soltanto governare taluni giganteschi affari per migliaia
di miliardi, ma per infinite, invisibili vie governare anche lo sviluppo
politico dell’isola e quindi del Meridione: per esempio stabilire in quali
banche debba essere depositato il pubblico denaro, e chi debba dirigere queste
banche; per esempio indicare quali funzionari meritino carriera per propiziare e
garantire giganteschi affari di vertice; e via via, sempre per esempio, spirali
sempre più difficili e più alte e segrete, designare coloro i quali dovranno
essere deputati, assessori, sottosegretari, ministri. Bisogna stare attenti. In
Sicilia, e quindi naturalmente a Palermo, si verifica un fenomeno straordinario:
e cioè che in Italia tutto quello che accade, nel bene e nel male, dipende dai
partiti oramai despoti della vita nazionale, ma questo potere nel Sud si
sgretola, degrada, corrompe, privatizza. Un uomo politico può diventare
presidente o ministro, e la gente pensa che sia domineddio, ma nella realtà egli
è diventato ministro o presidente per amministrare una situazione, una proposta,
un compromesso che altri hanno discusso e deciso prima di lui e gli hanno
semplicemente affidato. Altrove, a Torino, Milano, Bologna, persino a Napoli, un
ministro può essere il padrone. Qui, non essere nessuno. Chi sono dunque i
padroni di Palermo? Badate bene: i padroni, non il padrone, poiché a Palermo
accade anche questo fenomeno straordinario, e cioè che non è ammesso il tiranno,
il condottiero, colui il quale per carisma, per virtù propria di talento o
violenza, possa emergere su tutti gli altri ed al quale tutti gli altri debbano
rispetto e obbedienza. Se spunta un Cesare ci sono subito le Idi di marzo.
Palermo rassomiglia alla Roma del basso impero con le congiure, i pretoriani, i
Caligola che fanno senatori i loro cavalli, le clientele che fluttuano dall’uno
all’altro vincente. Ma più ancora Palermo rassomiglia all’Atene della decadenza,
con gli oligarchi, oratori, guerrieri, reggitori che in mezzo a loro non
permisero mai venisse fuori un capo. Le virtù che contano a Palermo non sono
quelle di un Pericle, ma piuttosto di un cardinale Mazzarino, di chi sappia
intrigare, unire, collegare, non conoscere mai la vera identità dell’assassino e
tuttavia da quell’assassinio trarre sicuro vantaggio, né mai essere in prima
persona nell’affare da cento o mille miliardi, ma amabilmente avere la certezza
di un dieci per cento, metà del quale da distribuire ad amici, confidenti,
alleati e delicatamente anche a taluni avversari. Né Pericle, né Alcibiade. La
storia moderna di Palermo, che è anche la storia politica del Sud e in gran
parte anche della violenza che ciclicamente scuote la nazione, si potrebbe
raccontare attraverso storie esemplari di alcuni uomini. Ecco: qui diventa
perfetta la storia di Piersanti Mattarella, da raccontare tuttavia con umana
sincerità affinché ognuno possa capire le cose come veramente accaddero e quindi
trarre una ragione, un cifrario per le cose che continuano ad accadere.
Piersanti Mattarella, il cui personaggio oramai è entrato nella leggenda
politica siciliana dell’ultimo decennio, era figlio di Bernardo Mattarella,
padrone della Sicilia occidentale, quando Palermo ancora ammetteva un solo
padrone. Saggio e collerico, amabile e violento, culturalmente modesto, ma
irruento parlatore, Mattarella non disdegnava alcuna alleanza potesse servire al
potere del suo partito ed a quello suo personale. Non aveva scrupoli. Se parte
dei suoi voti provenivano dai ras delle province mafiose, che ben venissero,
erano egualmente voti di cittadini italiani. E se quei grandi elettori
chiedevano un favore in cambio, Bernardo Mattarella (come si suole dire) non si
faceva negare. Contro di lui dissero e scrissero cose terribili, ma in realtà
non riuscirono a provare praticamente niente, se non che la sua potenza, appunto
per questa assenza di testimoni contrari, era perfetta. Il vecchio Mattarella
aveva eletto il figlio Piersanti, suo delfino ed erede, lo avvezzò al potere con
la stessa puntigliosa prudenza, la medesima pignoleria, che la regina madre usa
di solito per il principino di Windsor: prima buon studente, poi eccellente
cavallerizzo, ufficiale della marina imperiale, un matrimonio di classe regale,
un viaggio per tutto il Commonwealth ad affascinare sudditi. Al momento
opportuno il trono. Piersanti era alto, bello, intelligente, amabile parlatore,
ottimo laureato, viveva a Roma, parlava con buona dizione. Era anche un uomo
molto gentile ed infine aveva una dote che poteva essere un difetto: era
candido. O forse fingeva di esserlo. Quando il padre ritenne il momento
opportuno, lo fece venire a Palermo perché fosse candidato al consiglio
comunale. Il Comune di Palermo è una palestra politica senza eguali, nella quale
si apprendono tutte le arti della trattativa per cui l’affare politico è sempre
diverso da quello che viene ufficialmente discusso, e si affinano le arti della
eloquenza per cui si dice esattamente il contrario di quello che è, anche gli
avversari lo sanno e però fanno finta di non saperlo, e quindi l’oratore riesce
a farsi perfettamente capire senza destare lo scandalo dei testimoni. Piersanti
imparò, quanto meno, a capire quello che gli altri dicevano. Poi venne eletto
dall’assemblea regionale siciliana, dove in verità – provenendo i deputati da
tutte e nove le province dell’isola – le arti sono più grossolane, ci sono anche
la cocciutaggine dei nisseni, la imprevedibile fantasia dei catanesi, la finta
bonomia dei siracusani, tutto è più facile e difficile, e tuttavia anche qui
Piersanti Mattarella fu diligente e attento. Valutava, ascoltava, sorrideva,
imparava, giudicava. Venne eletto assessore alle finanze. Fu in quel periodo che
vennero confermati gli appalti delle esattorie alla famiglia Salvo. Esigere le
tasse può sembrare odioso, e tuttavia è necessario, consentito, anzi preteso
dalla legge. L’esattore deve essere avido, preciso e implacabile. I Salvo erano
perfetti. Il loro impero esattoriale si estendeva da Palermo a Catania, un giro
di centinaia di miliardi, forse migliaia. C’era una bizzarra clausola
nell’accordo stipulato fra gli esattori Salvo e l’assessore regionale: cioè gli
esattori avevano facoltà di scaglionare nel tempo i versamenti. Premesso che la
Giustizia impiega magari due anni per riconoscere un’indennità di liquidazione a
un povero lavoratore, ma ha una capacità fulminea di intervento contro lo stesso
poveraccio che non paga le tasse, gli esattori Salvo avevano il diritto di
esigere subito le somme dovute dai contribuenti, epperò la facoltà (detratte le
percentuali proprie) di versare a scaglioni le somme dovute alla Regione.
Praticamente per qualche tempo avevano la possibilità di tenere in banca, per
proprio interesse, somme gigantesche. Non c’era una sola grinza giuridica.
Avevano fatto una proposta e la Regione aveva accettato. Infine Piersanti
Mattarella venne eletto presidente della Regione. E improvvisamente l’uomo
cambiò di colpo. Aveva studiato tutte le arti per diventare Mazzarino e
improvvisamente divenne Pericle. Indossò tutta la dignità che dovrebbe avere
sempre un uomo; dignità significa intransigenza morale, nitidezza nel governo,
onestà nella pubblica amministrazione. Piersanti Mattarella fu capace di pensare
in grande e pensare in proprio. Figurarsi la società palermitana degli
oligarchi, i cento padroni di Palermo. Come poteva vivere un uomo così, e per
giunta vivere da presidente? Nessuno capirà mai se Mattarella venne ucciso
perché aveva fermato una cosa che stava accadendo, oppure perché avrebbe potuto
fermare cose che invece ancora dovevano accadere. La storia di Mattarella è
davvero una storia esemplare all’interno del racconto sul potere a Palermo.
Palermo non può avere un solo padrone, nemmeno un primus inter pares: se
qualcuno tenta di esserlo viene distrutto in qualche modo, oppure più
semplicemente ucciso. Naturalmente non accade mai che la decisione
dell’assassinio sia presa dalla piccola società degli oligarchi, questo
appartiene alla fantascienza mafiosa, tutti hanno il medesimo interesse ma in
definitiva sono soltanto due o tre di loro, i più offesi o spietati, che
prendono la decisione. Individuarli non è possibile mai: bisognerebbe prima
identificare e catturare gli esecutori dell’assassinio; che costoro
confessassero da chi hanno avuto mandato di uccidere, e questi mandanti a loro
volta indicassero l’anonimo barone che ha commissionato il delitto. Una serie di
ipotesi assolutamente impossibile che, tutte insieme, configurano appunto il
perfetto delitto di mafia. Chi sono dunque i padroni di Palermo? I metodi di
identificazione sono due: l’uno politico, l’altro finanziario, cioè anzitutto
l’identificazione dei politici che attraverso leggi e azioni di governo
determinano i grandi affari pubblici, compresi i sistemi di affidamento; e
quindi la identificazione degli operatori che si aggiudicano tali grandi affari
e ne diventano perciò i protagonisti. Attualmente, nella città di Palermo ci
sono una ventina di grandi affari pubblici. Messi insieme formano un pacchetto
di duemila-tremila miliardi. Scegliamone quattro, i più semplici da capire: il
porto scogliera, l’appalto per la pubblica illuminazione, il risanamento del
centro storico, l’appalto per la manutenzione stradale. Il porto-scogliera
dovrebbe sorgere lungo quel tratto di litoranea fra la nazionale per Messina e
il Foro Italico, cioè in quel tratto di spiaggia dove si scaricano le immondizie
di mezza città e le acque luride delle fiumare, un tratto di mare che è divenuto
una sola immensa fogna, oramai perduto per qualsiasi utilizzazione commerciale e
turistica. Il problema è quello di bonificare la zona, evitando che essa diventi
una sempre più micidiale concentrazione di immondizie putrefatte, di topi,
mosche, cani randagi, zanzare, miasmi, epidemie. Il progetto è semplice:
costruire in mare a qualche centinaio di metri dalla riva una scogliera
artificiale, una specie di immensa barriera frangiflutti, in modo da creare
all’interno, fra tale scogliera e la spiaggia, una specie di mare morto nel
quale andranno a scaricarsi quotidianamente tutti i materiali da riporto
dell’intera città, pietre, rottami, rifiuti, calcinacci. Nel giro di pochi anni
il mare, o meglio quel putrido stagno, scomparirà per sempre e diventerà un
immenso pianoro di terraferma. La proposta è che la ditta appaltatrice dei
lavori, la Sailem, esegua i lavori gratuitamente, aggiudicandosi tuttavia la
proprietà delle aree di risulta, cioè di quell’immenso pianoro che si sostituirà
al mare. Naturalmente tutta area fabbricabile, nel cuore di Palermo, lungo il
mare, in una zona che – eliminato l’inquinamento – potrà diventare prezioso
luogo di insediamenti turistici, residenziali e alberghieri. Il tratto di
litoranea interessato è lungo circa due chilometri, la scogliera sarà costruita
a trecento metri dalla spiaggia, un’area dunque di circa sessantamila metri
quadrati. Il prezzo delle aree fabbricabili nelle zone urbanistiche di
eccellenza si aggira sulle cinquecentomila lire a metro quadrato. Fate i conti.
L’appalto per la pubblica illuminazione, per centodieci miliardi. Esso non è
avvenuto per pubblico concorso ma a licitazione privata. Con delibera della
giunta presieduta dell’ex sindaco Martellucci, che attende solo la ratifica del
consiglio comunale, è stato approvato il rinnovo dell’appalto alla ditta ICEM,
di cui è grande manager l’ingegnere Parisi. La grande storia di Palermo è fatta
di alcune grandi storie umane ma anche di tante piccole storie esemplari che si
debbono mettere tutte insieme, l’una accanto all’altra, nel posto giusto.
L’ingegnere Parisi è il presidente del Palermo calcio: pare abbia fatto egli
stesso candida ammissione di non avere per il calcio alcuna passione o
competenza. E tuttavia, soavemente invitato dagli ambienti politici della Dc ad
assumere la gestione del Palermo calcio per ricondurlo in serie A, altrettanto
soavemente egli accettò di rendere questo servizio alla città e agli uomini che
la governano. Gli è costato due miliardi! Non sono stati spesi bene, ma non sono
neanche molti. Il piano di risanamento del centro storico di Palermo. L’ultima
preda! L’alleanza criminale fra politici e imprenditori ha infatti letteralmente
divorato, sfregiato, saccheggiato oramai tutta l’immensa periferia della
capitale, rovinandola per sempre. Il prezzo pagato dalla città è stato tragico.
Almeno duemila assassinii: uomini giustiziati in mezzo alla strada, murati nei
piloni di cemento degli stessi palazzi, gettati in mare con una pietra alle
caviglie. Una pirateria di circa cinquantamila miliardi la cui spartizione ha
consentito l’insorgere di almeno cinque nuovi tremendi focolai di potenza
mafiosa che (per evoluzione criminale e capacità finanziaria) hanno potuto
impadronirsi anche del contrabbando della droga, determinando un terrificante
salto di qualità e di potenza dell’intera struttura criminale. L’unica area
urbanistica residua, nella quale sono possibili operazioni urbanistiche, appunto
l’ultima preda, è il centro storico di Palermo, cioè quella che fu la splendida,
orgogliosa capitale della civiltà mediterranea e nella quale arabi e normanni
profusero i tesori della loro architettura. Spettacolo di miseria e grandezza.
Vicoli nei quali dilaga un’umanità urlante e feroce, palazzi di straordinaria
bellezza che però cadono a pezzi, tuguri nei quali si intanano migliaia di
sventurate e fameliche famiglie del sottoproletariato, cattedrali, reggie,
teatri di ineguagliabile maestà, spazi fatiscenti dove si accumulano le
immondizie di interi quartieri, migliaia di edifici pericolanti dai quali gli
esseri umani sono stati stanati a forza come bestie. Il progetto di risanamento
che sta per essere ultimato, deve salvare i grandi palazzi prima che crollino,
cancellare migliaia di tuguri, programmare il restauro di centinaia di edifici
ora abbandonati e la costruzione di migliaia di altri nelle aree di risulta. Un
progetto gigantesco. Un affare che prevede un investimento pubblico di duemila
miliardi, e perlomeno quindici/ventimila miliardi di investimenti e quindi
profitti privati. Facile immaginare quale drammatica lotta si sia già scatenata
in quella fantastica città mafiosa, invisibile all’occhio e tuttavia
perfettamente compenetrata (una città sull’altra e dentro l’altra) a Palermo. Si
tratta di capire chi si presenterà a chiedere gli appalti e come essi saranno
dati, con quali facoltà e vantaggi. I grandi personaggi del potere si stanno
squadrando e valutando, cercando di leggersi negli occhi per capire chi sarà
alleato, concorrente o nemico. I catanesi che hanno un’ironia piuttosto ruvida,
quasi sempre conclusa con una grande risata direbbero: “Si stanno curando in
salute!”. I palermitani che sono più tristi e perciò anche più sottili
nell’ironia, dicono: “Si stanno guardando lo scarto”, che nel terziglio è il
momento in cui il giocatore solo contro gli altri due, va a riguardarsi le
quattro carte di scarto che solo lui conosce, per fare la giocata decisiva.
Gettare subitaneamente la scartina e brutalmente uscire di napoletana. Con
ironia più esplicita, qualcuno a Palermo più semplicemente dice: “Duemila
miliardi a chi sparerà per primo!”. Infine l’appalto per la manutenzione
stradale. Anche tale appalto, per un importo di centotrenta miliardi, sarà
rinnovato alla ditta LESCA di cui è protagonista e manager il conte Cassina.
Ecco un’altra piccola storia per raccontare la grande storia di Palermo. Cassina
è conte! I palermitani, la cui ironia spesso è così tagliente da sembrare
cinismo, dicono ai catanesi: “Voi avete i cavalieri del lavoro, noi abbiamo i
conti! C’è un abisso. Cassina è conte, è milanese ed è Gran Bali, per tutto il
Sud, dei cavalieri del Santo Sepolcro, associazione di personaggi eccellenti i
quali hanno diritto di paludarsi in cappa nera, feluca e spadino, e in tal guisa
scortare il Papa nelle grandi cerimonie ufficiali. Al Gran Bali spetta il
governo della loggia (si chiama così, come nella massoneria) e la designazione
dei nuovi cavalieri. Della loggia di Palermo, negli ultimi anni, sono entrati a
far parte questori, magistrati, professori di università, artisti, luminari
della medicina e delle lettere, operatori economici, cavalieri del lavoro. Il
conte Cassina li convoca, li governa e li affabula. Ecco, il conte Cassina è uno
dei padroni di Palermo. E’ amabile, colto, intelligente, non ha la prepotenza
mentale e la temerarietà dei cavalieri di Catania, per i quali non c’è impresa
che non possa essere tentata e che non si abbia il diritto di tentare, ma la
prudente saggezza di colui il quale vive in una capitale in cui c’è un limite a
tutto, anche alla potenza dell’uomo. E’ un uomo che può invitare a cena
ministri, prefetti, giudici e conversare affabilmente sul destino della Sicilia.
Da buon milanese ha uno straordinario rispetto per il denaro e quindi è anche
tenuamente avaro. Si dice che un cavaliere di Catania, invitando a cena nella
sua villa prefetti e ministri, facesse galantemente trovare, sotto il
tovagliolo, graziosi monili d’oro per le consorti dei convitati. Il conte
Cassina si limita agli spaghetti, e per le gentili signore, una piccola
orchidea. Un padrone di Palermo il quale sa perfettamente che non si deve mai
essere l’unico padrone di Palermo, ma che bisogna convivere con gli altri e
tutto sta semmai nel garbo con cui si è capaci di riconoscerli. E i politici.
Anche nella politica la situazione è mutata. Il tiranno non esiste più.
Mattarella tentò di imporre una regola morale a tutti, pensò di avere il carisma
del capo. Morì. Prima di lui aveva tentato, con altro stile e altre convinzioni,
Vito Ciancimino, certo il personaggio più famoso della democrazia cristiana e
quindi della politica palermitana. In effetti ci fu un momento storico in cui
parve il padrone di tutto, il solo e incontrastato governatore della volontà
politica nella capitale dell’isola. Non ci fu affare, né opera pubblica, né
appalto, né alleanza o compromesso che non fosse sua iniziativa o non si
avvalesse del suo consenso. Lo distrussero. Comandava troppo. Però sopravvisse.
Vito Ciancimino non era Piersanti Mattarella, egli era tanto astuto quanto
quello era candido, egli era tanto attore quanto quello condottiero. Non avendo
la vocazione di Alcibiade capì per tempo quanto meglio valesse essere Mazzarino,
cioè paziente, silenzioso, ironico. Fra gli uomini politici italiani,
rassomiglia più di ogni altro a Giulio Andreotti (nella speranza che nessuno dei
due si offenda). Parlando di potere politico a Palermo si deve subito pensare a
Vito Ciancimino, il geometra Ciancimino, come egli spavaldamente ama
presentarsi; ecco, questa è un’altra piccola storia da raccontare dentro la
grande storia di Palermo, e nemmeno tutta la storia dell’uomo, ma solo un
minuscolo episodio del personaggio, perché si possa ancora più perfettamente
capire Palermo. Vito Ciancimino crollò nell’ultima fase delle indagini
dell’antimafia. Venne accusato, lui prima assessore all’urbanistica e poi
sindaco, di aver lasciato sbranare Palermo dalla mafia. La democrazia cristiana
ebbe paura. Non poteva certo partecipare al linciaggio perché sarebbe stato come
mettere sotto accusa tutte le operazioni di potere che il partito aveva
sollecitato e giustificato, una specie di suicidio; e però non poteva nemmeno
difendere l’uomo perché le accuse erano troppo gravi, c’era il rischio di essere
coinvolti e travolti. La democrazia cristiana non ha lo stoicismo tra le sue
regole morali. Il suo principio è il silenzio estatico, la sua forza il tempo.
Il silenzio avvolge, confonde, non consente approfondimenti, dibattiti. Il tempo
ammorbidisce, logora, stanca, dilapida, suscita smarrimenti, la gente muore, la
gente dimentica. Col tempo e nel silenzio svanì e si perse per sempre anche il
come e il perché, vita e morte del bandito Giuliano. Figuratevi! Dinnanzi a Vito
Ciancimino la Dc si tirò addosso un velo sepolcrale: lo deferì ai probiviri del
partito perché stabilissero se poteva giustamente stare dentro il partito a
testa alta o dovesse esser cacciato con ignominia. Tempo e silenzio. Finché
vennero le elezioni politiche del 1979. Vito Ciancimino non poteva candidarsi
poiché era nel limbo, ma aveva però quaranta/cinquantamila voti di preferenza
sulla piazza di Palermo, un formidabile pacchetto elettorale che poteva
manovrare a suo piacimento. Erano voti suoi, conquistati, allevati, guadagnati,
difesi anno dopo anno, con mille amicizie, protezioni, minuscole alleanze,
favori, benevolenze. Li aveva proprio nel portafogli, cosa sua, manovrando quei
cinquantamila voti di preferenza, cioè spostandoli dall’un candidato all’altro,
poteva determinare disfatte e trionfi. Per i leaders politici palermitani
oltretutto non è importante solo essere eletti al parlamento, ma anche il numero
delle preferenze, poiché queste stabiliscono gerarchie, ingigantiscono
prestigio, candidano alle cariche ministeriali. Ora si racconta come nella fase
pre-elettorale, il ministro Ruffini mandasse segnali di fumo al geometra
Ciancimino per esprimere il suo gradimento a quei cinquantamila voti di
preferenza, e come il Ciancimino stanco di essere tenuto alla gogna, facesse
sapere che sì, quei cinquantamila voti sarebbero stati suoi, purché il ministro
Ruffini l’avesse aiutato ad avere finalmente una sentenza assolutoria dai
probiviri della Dc. E ancora si narra come il ministro Ruffini gli promettesse
il suo leale appoggio in tal senso, organizzando un incontro con il segretario
nazionale Piccoli a Roma: appuntamento a Roma alle sette del mattino, nella
villa del segretario Piccoli. Vito Ciancimino arrivò in tassì, con una valigetta
di cuoio piena di documenti che avrebbero dovuto comprovare la sua innocenza e
comunque indurre ad una benigna valutazione il segretario nazionale della Dc.
Erano i tempi della grande paura e del terrorismo trionfante. Gli uomini di
vertice viaggiavano in autoblindo. La villa di Flaminio Piccoli era circondata
dai carabinieri con i mitra puntati: si videro venire incontro questo
sconosciuto, con gli occhietti neri da siciliano, i baffetti, e quella valigetta
di cuoio. Sono il geometra Ciancimino, ho un appuntamento con l’onorevole
Piccoli, in questa valigia ci sono carte personali… Documenti, perquisizione,
verbale dei carabinieri: alle ore sette del mattino si è presentato un tale,
pretendendo di avere appuntamento con l’onorevole Piccoli, ha esibito documenti
intestati al ragioniere Vito Ciancimino, di Palermo…In quell’istante scortato da
motociclisti e auto della polizia, arrivò in auto blindata il ministro Ruffini.
Così narrano. Carabinieri sull’attenti. Il ministro spiegò che poteva garantire
lui per il signor Ciancimino, il quale effettivamente era atteso dall’onorevole
Piccoli. Agli ordini eccellenza. I carabinieri sono sempre carabinieri: misero
diligentemente a verbale. Quello che si dissero nello studio di Piccoli nessuno
lo sa. Il candidato Ruffini ebbe centocinquantamila voti di preferenza. E venne
il caso Sindona: lo scandalo, l’arresto di Spatola il quale era amico di
Ciancimino e disse agli inquirenti d’essere andato una volta a cena con il
ministro Ruffini, il quale a sua volta disse che non sapeva nemmeno chi fosse
questo Spatola, glielo avevano presentato un giorno per caso, piacere, molto
lieto e basta, e che comunque non conosceva quel tale Ciancimino di cui gli
parlavano. Allora Ciancimino scrisse una lettera a mano, con un foglio di carta
carbone sotto, per averne copia, “Caro Ruffini, leggo che dici di non conoscermi
nemmeno. Sei un…!”. L’epiteto fu crasso e stentoreo. Piegò il foglio, senza
nemmeno metterlo in busta e lo spedì per raccomandata espresso. Conservò nel
portafogli quella copia, ogni tanto la tira fuori e la tiene appesa a due dita
in faccia all’interlocutore. Ride: “Non mi conosce? C’è quel verbale dei
carabinieri: alle ore sette del mattino si è presentato il ragioniere Vito
Ciancimino. Il sopraggiunto ministro Ruffini, ecc., ecc… “. Chi sono i padroni
politici di Palermo? Il ministro Ruffini, l’onorevole Lima, l’ex sindaco
Valenzi? Certo! Forse ancora, da qualche parte, in qualche modo con qualche
pacchetto di cinquantamila voti in tasca, Vito Ciancimino. Epperò anche infiniti
altri. In realtà fino a non molto tempo fa, c’erano a Palermo i grandi,
inviolabili boss politici. Giovanni Gioia era Luigi XIV. Tutto passava per il
loro consenso. I grandi capi esistono ancora, ma sono stati esautorati, c’è
stata la rivolta dei peones, sono almeno cento: ognuno di loro restando
all’ombra del capo e rispettandone ufficialmente il potere si è costruito il suo
piccolo feudo di potere, secondo competenza. Tutto quello che passa per il suo
feudo paga, per taluni può essere soltanto la devota riconoscenza, per altri
invece un tenue dieci per cento sul totale dell’affare. Anche il suo legittimo è
pulito. Pensate a un galantuomo che deve avere un contributo o un mutuo da un
miliardo: se lo fanno aspettare un anno ci rimette gli interessi bancari attivi
quindi il 18%, e subisce l’impoverimento per svalutazione di un altro 14-15%.
Con quella garbata tangente del dieci per cento, li ottiene subito secondo
diritto. Ci guadagna! La figura giuridica sarebbe quella della cosiddetta
servitù di passaggio, oppure in taluni casi, i più sofisticati (i giuristi mi
perdonino l’audacia) dell’enfiteusi che è il diritto di godere di una cosa
altrui, con l’obbligo di pagare periodicamente un canone. Solo che la cosa
altrui, stavolta, è la cosa pubblica. Ma è un particolare ininfluente la cosa
pubblica a Palermo, è la cosa dei cento padroni che possiedono Palermo. Palermo!
Camminare per Palermo. Camminare sfiorando gli stupendi palazzi dove un giorno
vissero svevi, normanni, emiri, angioini, ed ora anche le facciate stanno
cadendo a pezzi, dietro queste facciate pavimenti e soffitti sono sfondati, le
scale crollate. Camminare nei vicoli di Palermo assordati dal grido di centinaia
di venditori, in mezzo ad una folla che sembra vagare con il moto pazzo delle
formiche su un torsolo di mela. Camminare nelle stradine fetide e senza
selciato, con le bancarelle fumanti attorno alle quali si aggruma la gente
povera a mangiare gli scarti bolliti dei macelli. Camminare in mezzo ai tuguri
di Palermo dove si intana la gente sradicata, cacciata via dalle case antiche
che stavano per crollare. Tutto questo è folclore, lo so. Però, in questa grande
capitale del Sud, migliaia di bambini vivono veramente dentro le tane come le
bestie umane; e decine di migliaia di uomini vivono miserabilmente di
espedienti, commerci infinitesimali, elemosine, ruberie; e centocinquanta esseri
umani sono stati assassinati in un anno in mezzo alle strade, ed altri
centocinquanta sono scomparsi, eliminati dalla lupara bianca. Tutto questo è
retorico. Quando la verità è insultante si dice che essa è retorica, è sempre
retorico tutto quello che non rientra nei limiti del possibile, trecento
assassinii sono dunque retorica. Salire la scalinata del Palazzo delle Aquile e
sapere che da qualche parte, in qualche stanza, venne perpetrata la spartizione
di cinquantamila miliardi per la devastazione urbanistica di Palermo, e alcuni
di quegli uomini furono o ancora saranno fra i governatori di questa città. In
qualche stanza di questo palazzo c’è il nuovo sindaco, Elda Pucci, medico,
cinquantenne, nubile, adamantina la quale dice: “L’ex sindaco Valenzi fu il mio
maestro. Il modello al quale mi ispiro!”. Vincente oratoria. A loro è lasciato
il compito difficile di governare nel modo più garbato possibile, elaborare i
grandi sistemi quali che siano, garantire che la macchina funzioni. Abbiamo
revisionato, cambiato i pezzi logori, guardate come corre.
Ecco a voi il "nano" e il circo
dell'antimafia, scrive Simona Musco il 10 ago 2016 su
“Il Dubbio”. Nino Lo Giudice, il più controverso dei collaboratori di giustizia
della Procura di Reggio Calabria, accusa il poliziotto Giovanni Aiello, "Faccia
di mostro", di essere l'autore della strage di via D'Amelio. «È stato il
poliziotto Giovanni Aiello, alias "Faccia da mostro", a far saltare in
aria Paolo Borsellino e i cinque agenti di scorta. Fu lui a schiacciare il
pulsante in via D'Amelio. Me lo confidò Pietro Scotto quando eravamo in carcere
all'Asinara. E anni dopo me lo confermò Aiello in persona. Aggiunse che a
Palermo aveva fatto anche altre cose, fra cui l'omicidio Agostino. Ma quando ho
raccontato tutto sono stato minacciato dai servizi». Sono parole forti quelle
riportate da Il Fatto Quotidiano, parole che portano la firma di Nino Lo
Giudice, alias "il nano" il più controverso dei collaboratori di giustizia della
Procura di Reggio Calabria. Parole che il due volte pentito, ex boss
dell'omonimo clan, mette a verbale tra Reggio e Catanzaro e che arrivano in
Sicilia, dove si indaga sulle stragi in cui hanno perso la vita i giudici
Falcone e Borsellino. In quei verbali, Lo Giudice spiega i motivi della sua fuga
e le sue paure. «Ho iniziato a ricevere strane visite a Macerata, la località
segreta in cui vivevo. Un giorno, due mesi dopo l'incontro
con Donadio (Gianfranco, ex procuratore aggiunto della Dna, ndr) mi vennero a
trovare due uomini in borghese che si qualificarono come carabinieri. Pensai
subito che fossero dei servizi. Mi fecero salire su una Punto e notai che erano
armati di Beretta. Mi portarono fuori città. La Punto si fermò vicino a una
Bravo marrone e mi fecero salire a bordo. C'erano altri due uomini ad
aspettarmi. A parlarmi fu uno, testa rasata e accento laziale. Sapeva che avevo
parlato di Aiello e mi disse di stare attento a toccare certi argomenti,
soprattutto in futuro». Chi è "faccia da mostro" - Il nome di Aiello, 69 anni,
originario di Montauro, in Calabria, in servizio al ministero degli Interni fino
al 1977, finisce in diverse inchieste. Da quella sul tentativo di
uccidere Giovanni Falcone all'Addaura fino alla strage di via D'Amelio, passando
per il delitto del commissario Cassarà e del poliziotto Nino Agostino. Lo
chiamano "faccia da mostro" per una ferita sul volto che lo rende
inconfondibile. Dopo il congedo si rifugia in Calabria, dove ufficialmente fa il
pescatore. Per lunghi periodi di lui si perdono le tracce. Il suo nome, però,
viene tirato in ballo più volte da diversi pentiti. Tra questi anche Consolato
Villani, ex braccio destro del "nano" e autore degli attentati contro i
carabinieri compiuti a Reggio Calabria tra il '93 e il 94. «Nino Lo Giudice mi
parlò di ex esponenti delle forze dell'ordine, appartenenti ai servizi segreti
deviati, che un uomo deformato in volto, insieme a una donna avevano avuto un
ruolo nelle stragi di Falcone e Borsellino dice in udienza a novembre 2014 -. Mi
disse che questi personaggi erano vicini alla cosca Laudani ed alla cosca
catanese di Cosa nostra». Il pentito controverso. Ma il "nano" può ritenersi
davvero credibile? Le sue parole stanno ancora confluendo nelle indagini della
Dda reggina. L'ultima, in ordine di tempo, è quella che ha messo in luce
l'esistenza della cupola di invisibili che governerebbe Reggio Calabria. Per il
pm Giuseppe Lombardo, che ha seguito l'indagine "Mamma santissima", le parole di
Lo Giudice sono attendibili. Così come lo sono quelle di Villani. Ma sul suo
curriculum di pentito pesano la fuga, dopo due anni e mezzo di collaborazione, e
due memoriali in cui smentisce le precedenti dichiarazioni e per i quali è
indagato a Catanzaro. Il suo nome è al centro di una stagione infuocata di
veleni tra toghe. Appena inizia a cantare, svela al magistrato Giuseppe
Pignatone di essere l'autore degli attentati in procura del 2010. Ma il "nano"
va oltre e insinua che tra il fratello Luciano ed alcuni magistrati, ci sia un
rapporto "speciale". Si tratta dell'allora numero due della Dna, Alberto
Cisterna, e l'attuale procuratore generale della corte d'appello di
Roma, Francesco Mollace. In un vortice di dichiarazioni contrastanti, Lo Giudice
arriva a dire che per far scarcerare suo fratello Maurizio, Luciano avrebbe
sborsato «molti soldi» a Cisterna. Che finisce indagato, vedendo la sua carriera
andare in pezzi: da vice di Pietro Grasso finisce a fare il giudice a Tivoli.
Poi, però, la sua posizione viene archiviata. Mollace, dall'altro lato, finisce
pure davanti ai giudici a Catanzaro, con l'accusa di aver omesso di svolgere
indagini sulla cosca in cambio di favori. Anche lui, però, viene assolto perché
il fatto non sussiste. Nel mezzo ci stanno i memoriali ritrovati dopo la fuga.
In quelli Lo Giudice nega di essere l'autore degli attentati e le accuse alle
toghe e parla di un vero e proprio complotto. «A Reggio c'erano due tronconi di
magistrati che si lottavano tra di loro facendo scempio degli amici di una delle
due parti». Una cricca, diceva, composta da «Di Landro, Pignatone, Prestipino,
Ronchi e il dirigente della Mobile Renato Cortese». Dopo essere stato
riacciuffato, si è chiuso in un lungo silenzio. Poi, alla fine dello scorso
anno, ha ripreso a parlare.
Lo Giudice: ''Faccia da mostro dietro via
d'Amelio''. Il pentito calabrese: "Fu lui a premere il
pulsante per la strage", scrive “Antimafia Duemila” il 09 Agosto 2016. Un altro
pentito torna a parlare di "faccia da mostro", l'uomo dei servizi che secondo
alcuni collaboratori di giustizia (tra cui i siciliani Vito Galatolo e Vito Lo
Forte, e il calabrese Consolato Villani) avrebbe preso parte a molte stragi ed
omicidi eccellenti. È Nino "il nano" Lo Giudice, scrive di Walter Molino il 9
agosto 2016 su Il Fatto Quotidiano, a parlare nuovamente di quel personaggio che
sarebbe stato riconosciuto nell'ex poliziotto Giovanni Aiello. “È stato il
poliziotto Giovanni Aiello, alias “faccia da mostro”, a far saltare in aria
Paolo Borsellino e i cinque agenti di scorta" ha detto il pentito calabrese,
aggiungendo che "fu lui a schiacciare il pulsante in via d’Amelio" e a
confidarglielo è stato, ha precisato, "Pietro Scotto quando eravamo in carcere
all’Asinara. E anni dopo me lo confermò Aiello in persona" ma "quando ho
raccontato tutto sono stato minacciato dai servizi”. Scotto, condannato in primo
grado ma poi assolto in appello per aver intercettato i telefoni di casa
Borsellino, è fratello di Gaetano, imputato per l’omicidio dell'agente Nino
Agostino e della moglie Ida Castelluccio, uccisi da Cosa nostra nel 1989, oggi
in libertà. La storia della collaborazione di Lo Giudice è tra le più
travagliate: tre giorni prima dell'udienza, nel giugno 2013, nella quale il
pentito doveva comparire a deporre al processo "Archi-Astrea" a Reggio Calabria,
l'ex mafioso si era allontanato dalla località protetta senza lasciare alcuna
traccia, tranne un memoriale nel quale ritrattava le sue deposizioni sostenendo
che era stato costretto e “spronato da più parti”. E una pen drive con delle
immagini dove il collaboratore diceva “non mi cercate, tanto non mi troverete
mai”. Poi però era stato arrestato, a novembre, in un appartamento alla
periferia della città. Ora che è tornato a collaborare le sue dichiarazioni sono
state verbalizzate dalle procure di Reggio Calabria e Catanzaro, oltre ad essere
condivise con quelle oltre lo Stretto in Sicilia. Sulle sue dichiarazioni
poggiava il lavoro del sostituto Gianfranco Donadio, allora incaricato dal
presidente del Senato Piero Grasso di fare luce sulle indagini riferite alle
stragi del '92 e '93, in particolare sul ruolo che avrebbero ricoperto elementi
riconducibili ai servizi segreti e ad ambienti “deviati” dello Stato. Lo
Giudice, nel memoriale, aveva accusato proprio Donadio di averlo costretto a
fare nomi di persone a lui sconosciute, tra cui anche quello di “faccia di
mostro”. Il superprocuratore Franco Roberti, il 6 settembre 2013, aveva avocato
su di sé le indagini. Poi ci fu una misteriosa fuga di notizie sulle colonne
de Il Sole 24 ore e L’Ora della Calabria in merito al resoconto di due riunioni
nel quale il pm aveva esposto gli sviluppi di un’indagine. Sarà solo a settembre
2014 che il pentito 'ndranghetista chiarirà il perchè del suo agire, spiegando
ai pm di aver "iniziato a ricevere strane visite a Macerata, la località segreta
in cui vivevo. Un giorno, due mesi dopo l’incontro con Donadio, mi vennero a
trovare due uomini in borghese che si qualificarono come carabinieri. Pensai
subito che fossero dei servizi". In seguito, proseguiva Lo Giudice, "mi
portarono fuori città" dove "c’erano altri due uomini ad aspettarmi. A parlarmi
fu uno, testa rasata e accento laziale. Sapeva che avevo parlato di Aiello e mi
disse di stare attento a toccare certi argomenti, soprattutto in futuro. Io
risposi che avevo una registrazione in cui smentivo tutto. Loro vennero a casa e
gliele consegnai”. Ora il collaboratore confermerebbe di aver riferito a Donadio
solo circostanze veritiere, aggiungendo poi altri dettagli su "faccia da
mostro": "Pietro Scotto mi parlò di Aiello come di un calabrese con la faccia
bruciata, coinvolto nella strage di via d’Amelio. Disse che era stato mandato
dai servizi deviati per far saltare Borsellino. Anche Scotto e suo fratello
avevano partecipato alla strage ma il pulsante, a suo dire, venne premuto da
Aiello. Io lo conobbi personalmente anni dopo. Mi fu presentato dal
capitano Saverio Spadaro Tracuzzi (condannato in appello a 10 di carcere per
concorso esterno in associazione mafiosa,ndr) che ne parlava come di un collega.
Mi disse che era uno dei servizi, che si erano conosciuti in Sicilia perché
Aiello aveva contatti con Cosa nostra. Io, pensando al racconto di Pietro
Scotto, lo riconobbi dalla faccia bruciata”. “La seconda volta - continuava
- Aiello venne a trovarmi nel 2007. Era insieme a una donna bionda, con accento
calabrese, che mi presentò come Antonella” e in seguito “Aiello mi confermò
quello che avevo saputo su di lui all’Asinara. Disse che a Palermo aveva fatto
anche altre cose, fra cui aver ucciso l’agente Agostino”. Anche per queste
dichiarazioni Lo Giudice è stato recentemente sentito dal pm di Palermo Nino Di
Matteo. Ed è proprio per l'omicidio Agostino che oggi lo stesso Aiello è
indagato a Palermo assieme ai boss Gaetano Scotto e Antonino Madonia. Vincenzo,
padre di Nino Agostino, pochi mesi ha riconosciuto "faccia da mostro" in Aiello,
durante un confronto all'americana nel quale ha confermato che si tratta dello
stesso personaggio presentatosi a casa sua pochi giorni prima dell'omicidio
chiedendo del figlio. Lo Giudice nelle sue dichiarazioni parla di Aiello anche
in riferimento all'assassinio del commissario Ninni Cassarà, datato 6 agosto
1985, alla barbara uccisione del piccolo Claudio Domino (colpito da proiettili a
11 anni), al fallito attentato all'Addaura e alla strage di Capaci, entrambi
contro il giudice Giovanni Falcone. "Il nano", tra l'altro, è il solo a
dichiarare di aver ricevuto "di prima mano" le parole confidenziali di Aiello.
Ma altri ex mafiosi di Cosa nostra parlano di "faccia da mostro" dichiarando
che “frequentava Fondo Pipitone” a Palermo (feudo della famiglia mafiosa dei
Galatolo, ndr) e che era “a disposizione della mafia anche per compiere
omicidi”.
«Io prete, vi ricordo mio padre:
giudice ucciso da Riina e dimenticato da tutti». Padre
Giuseppe, prete a Imola, è il figlio di Alberto Giacomelli, giudice ucciso a
Trapani il 14 settembre del 1988 su ordine di Totò Riina: «Mio padre non ha
nulla di meno di altri magistrati uccisi dalla mafia», scrive Nino Luca l'11
settembre 2016 su "Il Corriere della Sera". «Il coraggio di una firma». Questo
potrebbe essere il titolo di un libro dedicato al magistrato Alberto Giacomelli.
Ma quel libro non è stato mai scritto. Nessuno l’ha potuto leggere. Nessuno ci
ha pensato. Anche per questo il vile omicidio di Alberto Giacomelli è caduto
nell’oblio, in mezzo ai tanti morti negli anni di fuoco della lotta tra Stato e
Cosa nostra. Trovare una foto di Alberto Giacomelli su internet è una impresa.
Un solo video, di un vecchio Tg Rai, racconta la sua morte. Una mattina come
tante, quella del 14 settembre 1988. Alberto Giacomelli, magistrato, a sua volta
figlio di un giudice, è in pensione da quindici mesi. Alle 8 del mattino, saluta
la moglie ed esce dalla sua casa padronale immersa tra le palme e i gerani,
nelle campagne di Trapani, frazione Locogrande. A bordo della sua Fiat Panda,
percorre la strada sterrata, poi svolta a sinistra per immettersi sulla
provinciale che conduce in città. Gli assassini, probabilmente due, a bordo di
una vespa rally 200, lo attendono nascosti tra gli uliveti. Lo costringono a
fermarsi e a scendere dall’auto, poi gli sparano tre colpi con una Taurus,
calibro 38, con matricola abrasa, di fabbricazione brasiliana: alla testa, al
cuore e all’addome. Quando muore Alberto Giacomelli ha 69 anni. Nessuna targa in
queste strade polverose ne ricorda il sacrificio. Nel 1985 Giacomelli,
presidente della sezione del tribunale di Trapani «Misure di prevenzione», aveva
disposto il sequestro di una villetta e dei relativi terreni a Mazara del Vallo.
Beni riconducibili a Gaetano Riina, fratello del capomafia corleonese Salvatore
Riina. La sua firma doverosa sul documento di confisca derivava da una delle
prime sentenze di applicazione della legge «Rognoni -La Torre». Giacomelli aveva
compiuto il suo dovere di giudice. Due anni dopo i Riina impugnarono il
sequestro. Gaetano, fratello per più famoso capo dei capi, cercò di mantenere il
possesso della casa facendosi nominare «affidatario». Ma un’altra sentenza, di
altri giudici, confermò la confisca decisa da Giacomelli. L’anno dopo la
«vendetta» fu consumata. «Giacomelli - svelò il pentito di Mazara Vincenzo
Sinacori - fu ammazzato per “una questione di famiglia”. Non famiglia “Cosa
nostra” ma “famiglia di sangue”». Dopo 14 anni di depistaggi, il 28 marzo 2002,
Totò Riina viene condannato all’ergastolo per esserne stato il mandante. La
sentenza definitiva il 12 marzo 2003.Vincenzo Virga, capo mafia di Trapani è
stato assolto. I killer non sono stati mai individuati con certezza. Quello di
Alberto Giacomelli resta l’unico caso di omicidio di un magistrato in pensione
nella storia d’Italia. La sua firma di servitore dello Stato, lo condannò a
morte. A distanza di 28 anni, il figlio Giuseppe, sacerdote a Imola, ha voglia
di raccontare la storia del padre. Innanzitutto perché la sua figura rischia di
essere dimenticata dallo Stato e dall’opinione pubblica. Poi, per ristabilire la
verità, quella verità troppe volte «mascariata» (macchiata) da falsi pentiti:
«Giocava alle corse clandestine di cavalli organizzate a Locogrande», si disse.
Oppure: «Bisogna indagare nelle sue proprietà terriere...». Tutto falso. Un anno
prima, sconosciuti avevano bruciato la villa dei Giacomelli a Custonaci: «La
casa si riempì di fumo - racconta padre Giuseppe - ma allora non abbiamo dato
peso eccessivo all’episodio. Mio padre riceveva qualche telefonata di minacce...
ma lui riattaccava senza raccontare nulla». Oggi padre Giuseppe reclama per la
propria famiglia il riconoscimento di vittima della mafia. «Il rammarico più
grande - afferma dalla sacrestia della chiesa del Pio Suffragio di Imola - è
l’oblio in cui è caduto l’omicidio, quasi ci fossero vittime eccellenti ed altre
meno. Non c’è una gerarchia delle vittime della mafia. Lui si sentiva in
missione, mandato dallo Stato per applicare la giustizia. Ed è morto da
servitore dello Stato. Di fronte ad un uomo così, perché questo silenzio?».
E PARLIAMO PURE DI ANTIUSURA.
Usurati e ingannati: storie di ordinari
raggiri. Sempre più italiani si rivolgono a
associazioni che garantiscono cause “gratis”. Contro banche troppo esose. Ma poi
le promesse non vengono mantenute. E alcuni “benefattori” hanno fedine penali
poco pulite...scrive Francesca Sironi l'11 agosto 2016 su L’Espresso”. Li
incontri alla Camera nei caldi pomeriggi d’estate, impegnati a presentare
l’ultimo libro, l’ultima associazione nazionale. Sono ospiti a convegni al
fianco di imprenditori e rappresentanti delle istituzioni. E poi in televisione
e sul web. O nelle aule di tribunale: sono i paladini dell’anti-usura. Avvocati
o associazioni che offrono consulenze “gratis” - dietro corpose parcelle - per
fare causa alle banche. È un mercato di mezzo, popolato da enti in buona fede
come da ex truffatori, che si è scatenato sulle vittime d’usura bancaria. Su
chi, cioè, è stato costretto dal proprio istituto di credito a versare interessi
superiori rispetto a quelli previsti dalla norma. Evenienza frequente, spiegano
gli esperti. E chi denuncia, se ha buone basi per farlo ed è seguito bene, può
ottenere risarcimenti importanti. La prospettiva di riprendersi dei soldi -
miraggio per migliaia di italiani infragiliti dalla crisi - li convince a pagare
perizie e pareri legali pur di ottenere un rimborso. Le battaglie sui contratti
bancari hanno così preso il largo: nel 2015 ne sono state portate in mediazione
obbligatoria, passaggio necessario prima di arrivare a processo, 46.094, in
crescita rispetto all’anno precedente, come a quello prima. Inaugurando l’anno
giudiziario, a marzo, il presidente della Corte d’appello di Roma e quello di
Milano hanno notato il «rilevante e continuo aumento del numero di cause
bancarie». Nella capitale il salto è stato del 26,7 per cento in un anno: mentre
il resto del contenzioso civile cala o segna il passo, quello sul credito
aumenta, accumulando centinaia di arretrati. Ma in questo arrembaggio nazionale
agli istituti che lucrano sui propri correntisti c’è di tutto. Ci sono studi
seri. Come anche altre realtà. Più ambigue. La nave ammiraglia del settore
cause-alle-banche, in Italia, è Sdl Centrostudi. Sede nel bresciano, uffici
anche a Roma e Reggio Calabria, un fatturato nel 2014 di 45 milioni di euro,
oltre 4 milioni di utile, si presenta come specializzata nella «consulenza
aziendale gratuita in merito ad anatocismo, usura bancaria, anomalie
finanziarie, mutui e derivati». La parte gratuita riguarda però la sola
pre-analisi dei casi. Le valutazioni tecniche vanno invece dai duemila euro in
su, crescendo in proporzione agli interessi che si ritengono arpionati
ingiustamente dalla banca. Poi c’è l’avvocato, che dal 2016, spiegano, ha un
costo fisso di 700 euro a dossier; altrettanti per il tecnico di parte; e quindi
la spartizione del risarcimento, se arriverà: il 25 per cento andrà a Sdl, che
ne tiene l’11 per sé, ne dà il 10 ai legali e il resto lo distribuisce a chi «ha
generato il contatto». Già, perché la forza di Sdl è avere «migliaia di agenti
attivi in tutta la penisola», come spiega l’attuale presidente, l’ex magistrato
Piero Calabrò, insediatosi alla guida della S.p.a lo scorso autunno. Queste
migliaia di agenti sono motivati a darsi da fare: più vittime riusciranno a
trovare, quindi più clienti, maggiore sarà la loro provvigione su ogni mandato
firmato, come mostrano i dépliant distribuiti a una convention dell’azienda
dedicata ai futuri procacciatori d’affari. «Essere grandi non è una colpa, diamo
lavoro a tanti giovani avvocati in gamba, e portiamo risultati in tribunale. Da
quando sono arrivato stiamo cambiando le professionalità e le perizie ora sono
più serie che in passato», garantisce Calabrò. Sdl stava infatti accumulando
critiche: di analisi copia-incolla e difensori impreparati che lasciavano i
clienti con i cocci. A giugno del 2015 la società aveva risposto pubblicizzando
un accordo per la formazione con l’Istituto Nazionale Professionisti Gestione
del Debito. Che è però un ente di Sandro Musso, consigliere della stessa S.p.a
bresciana. «Lo rivedremo», promette Calabrò, che presenta le sue novità: dal
fondo internazionale che finanzierà le spese legali a chi non può permettersele
all’apertura di «sportelli anti-usura nelle città, in accordo con la Lega delle
autonomie. Ne ho appena inaugurato uno a Ladispoli», spiega. Ma non è
pubblicità? «Anche, ma anche un servizio». Nella galassia Sdl gravita anche
Giovanni Pastore, classe 1949, decine di interviste sulla stampa o in tv per
raccontare la propria esperienza di imprenditore immobiliare strozzato dalle
banche, coraggiosamente ribellatosi e vincitore, “grazie a Sdl”, di una causa
contro il proprio istituto di credito. Prima di diventare un paladino degli
usurati però Giovanni Pastore aveva dovuto patteggiare, lui, una condanna per
usura, con una pena (sospesa) di un anno e 10 mesi di reclusione. Era imputato
per aver dato prestiti per 100mila euro a una società di costruzioni, con tassi
d’interesse fra il 5 e il 10 per cento mensili, pretendendo in garanzia, e poi
ottenendo, in cambio, un complesso residenziale dal valore dichiarato di 400mila
euro, insieme a un altro immobile da 150mila euro a fronte di un prestito da
30. Tre volte tanto il valore anticipato insomma. A novembre scorso, Pastore era
in cattedra a Bari, nella sede del consiglio della Città Metropolitana, come
relatore a un convegno dell’associazione Favor Debitoris, di cui è fondatore
insieme all’avvocato Biagio Riccio. Il 30 maggio 2016 appuntamento a Firenze,
stesso tema: «Come difendersi dall’usura bancaria». Il 25 luglio erano entrambi
alla Camera. Per un Bilancio sulla legge anti-usura del 1996. Favor Debitoris è
una delle tante gemmazioni dell’ammiraglia bresciana. È un’associazione
culturale, mentre altri si sono buttati sul business, provando a replicare il
successo dei pionieri. «Un loro ex dipendente, che ha aperto la sua srl, mi ha
chiesto di collaborare. L’ho incontrato a Milano», racconta Maria Grazia
Carbonari, commercialista, consulente tecnico del tribunale di Perugia e
consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Le chiesero, spiega, di
quantificare nelle sue perizie sia l’usura oggettiva, che è il superamento della
soglia stabilita dalla Banca d’Italia per i tassi d’interesse, un calcolo
matematico, sia quella soggettiva, «per la quale ci vogliono invece molti più
presupposti, e bisogna conoscere bene, approfonditamente il caso. Non si può
imputare così, dai soli numeri», spiega lei: «Dissi che era sbagliato, ma loro
insistevano: “lei lo rilevi, poi ce la giochiamo noi”». Ha rifiutato. Racconta
che altri sono andati da suoi colleghi, in Umbria, «dicendo che se avessero
segnalato clienti in difficoltà di bilancio avrebbero avuto una percentuale del
rimborso». La caccia si fa grossa così su imprenditori semplici, potenzialmente
interessati alla lite perché afflitti dalla crisi e dalle banche. Sdl è stata
fondata nel 2010 da Stefano Pigolotti e Serafino di Loreto, tuttora al comando
della Blukivos Srl, il vertice di una rete di società che vanno dalla Sdl
Centrostudi (da cui sarebbero stati estromessi da poco) alla Tax and Duty
consulting, alla Personal finance Check srl. Di Loreto, fino a poco fa, era
solito salire sul palco per motivare i suoi agenti, invitando alle convention
personaggi come Gerry Scotti, o presentando alla stampa rapporti nazionali su
170mila conti analizzati e anomali nel 99 per cento dei casi. Adesso, però, si
occupa soprattutto di pallone: il 21 marzo è stato nominato infatti presidente
della Calcio Servizi Lega Pro, e ha da seguire, insieme al socio Sandro Musso,
la ricerca di nuovi sponsor per la squadra di Mantova, società che hanno
acquisito lo scorso anno. Nel suo curriculum vitae, si presenta come
collaboratore di tre università e docente di fondamenti dei mercati finanziari e
bancari alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università Popolare
degli Studi di Milano. Un ateneo che, seppur dal proprio sito web pubblicizzi
corsi di laurea e una scuola di giornalismo è stato più volte diffidato dal
ministero dell’Istruzione perché non potrebbe «rilasciare titoli accademici»,
come conferma a “l’Espresso” il Miur con una nota. C’è un altro timoniere del
mondo anti-usura legato da un ruolo allo stesso ateneo, di cui sarebbe, secondo
la sua biografia, rettore emerito. È Giuseppe Catapano. Nato a Ottaviano nel
1964, Catapano da mesi gira l’Italia per presentare il suo ultimo libro: “Banche
e anomalie. Come difendersi”, 266 pagine, pubblicato nel 2015, portato davanti a
platee di Roma, Termoli, Napoli, Spoleto, Bologna, Milano. Il 22 luglio era alla
Camera dei Deputati, per la presentazione della Accademia Universitaria degli
studi Giuridici Europei di cui veniva eletto quel giorno rettore. Catapano si
presenta infatti in varie vesti: è rettore di Auge, appunto, ma anche
rappresentante della Accademia europea per le relazioni economiche e culturali,
o ancora professore-portavoce di Assicont - Albo europeo assistenti del
contenzioso, ente per il quale promuoveva su Facebook, il 25 marzo 2016,
l’ultimo corso di alta specializzazione. Eppure la conferma in Cassazione della
sentenza di condanna per truffa, falso, bancarotta fraudolenta patrimoniale e
documentale in concorso è solo di un anno fa. Catapano aveva patteggiato nel
settembre 2011 una pena di 4 anni e 5 mesi. Le indagini del Gico di
Napoli l’avevano indicato infatti come vertice di un’associazione a delinquere
che attraeva aziende in crisi fingendo di salvarle, per poi invece costringerle,
attraverso società fittizie e prestanome, a cedere gli attivi e fallire. Così
aveva sottratto patrimoni a imprenditori di Ravenna, Pisa, Padova, Brescia,
Sassari e Bologna per milioni di euro. Uno dei membri dell’associazione imputati
(gli era stato chiesto di reclutare persone cui attribuire cariche da
prestanome) era Salvatore Onda, figlio di Arturo Onda, fratello di Umberto,
pluriomicida, considerato fino al suo arresto reggente del clan camorristico
Gionta. Giuseppe Catapano girava volentieri in auto blu, presenziava ai convegni
del Forum nazionale Anti Usura e promuoveva la sua Fondazione Ope impresa Onlus.
Ora sale su altri palchi, con altre associazioni, dichiara guerra alle banche e
a Equitalia. Il 22 luglio, al suo fianco, indossava la toga dell’Accademia di
studi Francesco Petrino, che si presenta come professore, siede nel consiglio
direttivo dell’Istituto Etico per l’Osservazione e la Promozione degli Appalti e
ha fondato un sindacato specializzato nel problema: Snarp, Sindacato nazionale
anti-usura mobilitazione protestati. «Viviamo in un mondo di pecore,
imprenditori che mi chiedono aiuto ma poi si tirano indietro». M. L. S. era
combattiva, il 21 maggio 2015, a un incontro organizzato da Assimpredil, l’ente
istituzionale delle imprese edili lombarde, uffici a 300 metri da piazza Affari.
Parlava dal palco in qualità di presidente della Associazione Nazionale
Antiracket Antiusura Lotta contro tutte le mafie Onlus. «Io purtroppo l’ho
provato sulla mia stessa pelle», diceva, per mettere in guardia da
«professionisti che non sono all’altezza». Quattro mesi prima il Consiglio di
Stato aveva respinto un ricorso presentato da lei per fermare le procedure
esecutive avviate su un imprenditore. Il ministero dell’Interno, mostra la
sentenza, rilevava che la sua associazione non aveva la «legittimazione a
ricorrere», «non essendo iscritta nell’elenco provinciale delle associazioni e
delle fondazioni antiracket e antiusura». Cosa ben diversa sono le fondazioni
antiusura, riconosciute e iscritte in un apposito elenco del Viminale, che
svolgono in favore di soggetti in difficoltà economiche un’importante opera di
solidarietà, di aiuto nel promuovere le denunce, di assistenza e di prestazione
di garanzie presso le banche, per un più facile accesso al credito. Titolare
oggi di due società - la Salute tutela risarcimento e il Centro tutela famiglia
e impresa dal sovraindebitamento – M. L. S. nel 2007 era stata condannata in
primo grado a Brescia a un anno e sei mesi di reclusione per esercizio abusivo
della professione e truffa. Il processo era partito dalla Dental Group, fallita
nel 2009: dove oltre che titolare, lei avrebbe lavorato da igienista dentale
senza averne la specializzazione e soprattutto avrebbe convinto almeno una
paziente a far causa ai dentisti precedenti, per ottenere un indennizzo e
sostenere nuove operazioni. Il reato è stato cancellato per prescrizione, ma dal
lato civile l’associazione nazionale dei dentisti aspetta ancora una sentenza
per il rimborso del danno. Dalla provincia di Brescia, a Erbusco, è partita
anche la cavalcata di Jd Group, che si presenta come la «prima e più importante
azienda italiana per la verifica dei rapporti bancari». Fatturato da quasi due
milioni di euro, oltre a uno studio legale in proprio, la Jd Group vanta
l’apertura in franchising di sportelli a Padova (aprile 2016), Modena,
Campobasso, Monza, Cremona, Verona. Il vento favorevole sembra avere origine
nell’ordine. Un Ordine, in particolare: la Confederazione dei cavalieri
crociati. Il rappresentante della società, Daniele Scandella, si presenta
infatti sul sito anche come Cavaliere templare e Gran Priore d’Italia, nonché
Cavaliere di Malta. Fra le società specializzate nel settore, c’è anche la Sarc
Srl.Fondata nel 2014, ha un punto di forza: è partner ufficiale di
Dirittialdiritto un’associazione il cui presidente onorario è Luigi Pelazza,
l’inviato della trasmissione tv delle Iene. Per l’ente, Pelazza è il volto
ufficiale, presente in tutte le comunicazioni. Due anni fa, in una serie di
servizi per Mediaset, Pelazza aveva trattato il tema dell’usura bancaria,
riscuotendo successo, per il coraggio delle denunce, e l’importanza del tema. In
video, interveniva più volte Gabriele Magno, un avvocato proprio di
Dirittialdiritto. L’azienda partner che offre poi i necessari Specialisti
nell’Analisi e Recupero del tuo Credito bancario, la Sarc srl, è stata
amministrata fino ad aprile da Federica Monica Arlandi. Che è a sua volta socia,
al 60 per cento, di una srl di cui Pelazza ha il resto delle quote: la Nea
Entertainment. In Rete sono centinaia i siti web che si definiscono “centri”,
“movimenti”, “onlus” e offrono consulenze per ottenere i rimborsi dagli istituti
di credito. A Roma e Milano piccoli e grandi studi legali si stanno buttando nel
campo «perché in fondo si raccoglie parecchio, come vittorie e risarcimenti,
nelle cause alle banche», spiega Roberto Marcelli, titolare di un noto studio di
commercialisti di Roma e presidente dell’Associazione nazionale dei consulenti
per i tribunali: «Quantomeno vendono spesso illusioni, però, questi soggetti,
perché raramente raggiungono quanto promettono. Quando non offrono proprio dei
pessimi servizi». «I ricorsi che arrivano a noi sono di frequente infondati»,
aggiunge Andrea Tina, professore alla Cattolica e consigliere dell’Arbitro della
Banca d’Italia, a cui nel 2014 sono arrivate 11mila richieste di mediazione, di
cui oltre 800 per usura (raddoppiate rispetto all’anno precedente): «Ci sono
somme improprie, errori, perizie che si vedono esser state spinte, e scritte, da
professionisti non “professionali”». Per fermare l’ondata di cause senza basi
alcuni giudici hanno iniziato a contro-denunciare per lite temeraria chi avanza
pretese fantasiose. Il rischio è che a soffrirne, e a dover quindi risarcire di
tasca propria, sia anche l’usurato. Doppiamente gabbato, così. La questione è
così importante e opaca da essere stata sottolineata durante l’inaugurazione
dell’anno giudiziario da Maria Chiara Malacarne, presidente vicario del
tribunale di Milano: «Anatocismo, interessi ultralegali, commissioni, valute
fittizie: il succedersi delle riforme normative, spesso frammentarie e di non
chiara comprensione quanto a contenuto e regime transitorio, in questo ambito,
alimenta nuovo contenzioso, incidendo su giudizi in corso e rallentando il
formarsi di orientamenti giurisprudenziali consolidati», ha detto. Vecchia e
nuova confusione si accumula fra i giudici. E fuori, sul mercato. A rimetterci,
gli stessi: le vittime d’usura bancaria.
LA PIU' FORTE DELLE MAFIE. Rapporti tra
'ndrangheta e altre organizzazioni criminali. Da
Wikipedia, l'enciclopedia libera. «La 'ndrangheta è un'organizzazione che non ha
problemi a fare affari con gente di ogni razza e nazione.» (Saverio Morabito,
pentito.) La 'ndrangheta rispetto alle altre realtà criminali si è sviluppata
più tardi, ma nonostante ciò con le altre mafie si è avuto in generale un
rapporto di reciproco rispetto e di parità, anche ora che viene considerata una
delle più potenti organizzazioni criminali in Europa e nel mondo e la più
potente in Italia. Non si è mai schierata nelle guerre di altre organizzazioni.
Vi è stato nel corso della storia invece una forte collaborazione per i traffici
di sigarette, droga e tutte le varie attività illecite.
Il rapporto con Cosa Nostra è
stato molto stretto tanto che capibastone di spicco come Antonio Macrì, Giuseppe
Piromalli, Mico Tripodo (compare d'anello di Totò Riina) si affiliarono a Cosa
Nostra e viceversa, capi della mafia siciliana si affiliano alle ndrine. Quindi
vi erano persone che possedevano due affiliazioni come per esempio il
messinese Rosario Saporito, personaggio di spicco della cosca
dei Mazzaferro o Calogero Marcenò, capo locale della cosca calabrese Zagari. La
mafia messinese inoltre nacque con l'appoggio della 'ndrangheta, dalla quale
apprese i riti e le usanze. Vennero sottomesse tutte le cosche messinesi grazie
all'operato di un certo Gaetano Costa. A Messina inoltre la cosca di Mangialupi
che opererebbe in città quasi completamente da sola ha strettissimi rapporti con
le cosche dell'area jonica, tale da custodire loro arsenali.
La 'ndrangheta e la Camorra.
Si è a conoscenza di doppie affiliazioni anche con la Camorra
napoletana: per esempio i calabresi De Stefano e Raffaele Cutolo. I Cutolo
uccisero addirittura Mico Tripodo per piacere dei De Stefano. Ci sono esempi di
camorristi come Antonio Schettini affiliato ai Flachi e viceversa lo
'ndranghetista Trovato Coco affiliato alla famiglia di Carmine Alfieri.
La 'ndrangheta e la mafia lucana.
I Basilischi sono una organizzazione criminale nata nel 1994 a Potenza, e poi
estesasi nel resto della Basilicata. Questa organizzazione ha assunto un ruolo
di controllo delle attività illecite della Regione. I Basilischi nascono come
una 'ndrina della 'ndrangheta calabrese e da essa dipendono, sono protetti e
aiutati. Per nascere ha ottenuto il nulla osta dalla 'ndrina
dei Pesce di Rosarno. La criminalità organizzata delle zone del materano, la Val
d'Agri e del Melfese è controllata, dunque dalle cosche che fanno capo alla
'ndrangheta di Rosarno[8]. Sembra abbiano avuto contatti con essa anche con
i Morabito.
La 'ndrangheta e la mafia pugliese.
La 'ndrangheta con la mafia pugliese e nella
fattispecie con la Sacra Corona Unita ha un rapporto ancora più influente e
fondamentale che con Cosa Nostra o la Camorra, poiché né è addirittura
l'artefice in parte della sua nascita. Dal rapporto del ROS dei carabinieri.
Dal 1993 si è a conoscenza che la Sacra Corona Unita fu fondata da Giuseppe
Rogoli, per volere di Umberto Bellocco (capobastone dell'omonima 'ndrina di
Rosarno), e che inoltre all'interno della SCU vi fossero altri elementi
appartenenti alla cosca calabresi come: Giuseppe Iannelli, Giosuè Rizzi, Cosio
Cappellari,Antonio e Riccardo Modeo. La 'ndrangheta fu d'aiuto anche alla
creazione della Rosa dei Venti, altra organizzazione criminale mafiosa che opera
nel territorio pugliese, e precisamente aLecce. Fu fondata da Giovanni De
Tomasi e Vincenzo Stranieri col volere e il permesso delle cosche calabresi.
Praticamente Bari, Brindisi e Lecce erano sotto il controllo ndranghetista,
e Taranto, tramite un accordo, fu lasciata alla Camorra. Il 18 ottobre 2012 si
conclude l'operazione Revolution che porta all'arresto 29 persone affiliate alle
cosche di Bovalino, Africo e San Luca accusate di associazione mafiosa e
traffico internazionale di cocaina e altri reati tra cui l'introduzione di un
titolo di stato statunitense falso del valore di 500.000.000 di dollari. Da
questa operazioni, oltre ad essere evidenziati i legami con narcotrafficanti
sudamericano si registrano contatti con esponenti della Sacra Corona Unita sin
dal 2010. Le basi logistiche europee per il traffico internazionale
erano: Anversa in Belgio, Amsterdam nei Paesi Bassi, Duisburg, Oberhausen e
Düsseldorf in Germania.
La 'ndrangheta e le organizzazioni
criminali sarde. Dall'indagine Santa
Barbara del 2005[11] si è scoperta un'alleanza fra la potente ndrina
dei Nirta di San Luca e la criminalità sarda di Cagliari, Nuoro e Oristano per
il traffico di cocaina ed eroina. I carabinieri sospettano anche che i proventi
della droga potessero servire per investire nel settore immobiliare turistico
sardo.
La 'ndrangheta e la Banda della Magliana.
Durante l'operatività della Banda della Magliana alcune 'ndrine hanno avuto
contatti con essa. In particolare i De Stefano di Reggio Calabria e
i Facchineri di Cittanova.
La 'ndrangheta e il clan dei Casamonica.
Il 25 marzo 2010 viene scoperto un sodalizio tra Pietro D'Ardes, Rocco
Casamonica e affiliati alla 'ndrangheta dei Piromalli-Molè e Alvaro per il
riciclaggio dei proventi illeciti e costituzione di società (15 sequestrate) per
la partecipazione ad appalti pubblici.
La 'ndrangheta e le organizzazioni criminali
internazionali.
'ndrangheta e mafia albanese.
La Ndrangheta con le organizzazioni criminali albanesi ha
rapporti basati sul traffico di esseri umani, prostituzioni e armi da come si
evince dall'ANSA del 13 dicembre del 2005 e dall'operazione Harem. Con il
beneplacito della mafia calabrese gli albanesi potevano agire in varie regioni
d'Italia portando prostitute albanesi, moldave, ucraine e romene in cambio di
droga ed armi. Sono state arrestate nell'operazione 80 persone di cui la metà
albanesi le altre italiane legate alle 'ndrine dei paesi di Corigliano Calabro e
di Cassano all'Ionio. In Lombardia commerciano anche in droga, durante
l'operazione Crimine 3 sono stati scoperti in alleanza con il Locale di Erba,
capeggiato da Pasquale Varca, e legato ai Nicoscia-Arena in un traffico di
cocaina con i colombiani e dove i Pesce-Oppedisano che dovevano recuperarla al
porto di Gioia Tauro se ne impossessarono mettendo nei guai il locale con gli
stessi albanesi (i cui capi risiedono in Nord Europa) e i colombiani da cui era
stata comprata. Nei Paesi Bassi per il controllo del porto di Rotterdam. Il 9
luglio 2015 si conclude l'operazione Overting, iniziata nel 2005 ha portato
all'arresto di 44 persone tra cui persone legate ai Mancuso, in collaborazione
con un gruppo criminale albanese di Fiano Romano per traffico internazionale di
cocaina. La droga proveniva dal Cile, Venezuela e Colombia e grazie anche al
broker ndranghetista Domenico Trimboli pentito dal 19 marzo 2015. L'incontro con
i narcos per l'accordo sullo scambio avveniva invece in Spagna. In Calabria,
a Spilinga c'era la raffineria per recupera la cocaina liquida impregnata in
partite di vestiti o allo stato solido in piastrelle per pavimenti. Gli albanesi
almeno una volta hanno tenuto in ostaggio un vibonese come garanzia del
traffico.
'ndrangheta narcos
colombiani e Autodefensas Unidas de Colombia.
La collaborazione con i narcos colombiani nasce dal crescente mercato
della cocaina che soprattutto in anni recenti si è sostituita
all'eroina proveniente dall'Asia per i continui conflitti presenti nell'area.
Portando così questa droga dei "ricchi" a diventare droga comune e diffusa. Uno
dei tanti protagonisti di spicco in questi traffici è Roberto Pannunzi, un
broker di origine calabrese internazionale che faceva da mediatore fra i
cartelli e i gruppi calabresi dei: Morabito, Coluccio-Aquino, Romeo, Bruzzaniti,
Sergi, Trimboli e Papalia. Hanno avuto contatti anche col movimento
paramilitare Autodefensas Unidas de Colombia tramite uno dei capi Salvatore
Mancuso Gómez sempre per motivi legati al traffico di droga. Il 29
aprile 2013 viene arrestato in Colombia dal ROS dei Carabinieri e dalla Policia
Nacional Grupo Siu il latitante, dal 2006, Santo Scipione (1933) detto papi
accusato di gestire un vasto traffico di cocaina tra la Autodefensas Unidas de
Colombia e i Mancuso per cui è stato condannato nel 2012 a 15 anni di carcere.
Grazie alla stretta collaborazione con i colombiani la ndrangheta dal 2000 in
poi è riuscita a ottenere il monopolio della cocaina in Europa raggiungendo
cifre da capogiro. A poco a poco si è sostituita a Cosa Nostra tanto che succede
a volte che per i clan siciliani e camorristici faccia da garante in caso di
mancati pagamenti e addirittura convenga alle altre mafia italiane comprare la
cocaina direttamente in Italia dai calabresi.
'ndrangheta e FARC.
Il 17 giugno 2015 si conclude un'operazione della Dda di Reggio Calabria e
del Gico di Catanzaro con il contributo della DEA statunitense e della Guardia
Civilspagnola che blocca un traffico internazionale di droga tra gli Alvaro,
i Pesce e i Coluccio-Aquino insieme ad un comandante delle FARC colombiane.
L'organizzazione aveva basi in Brasile, Argentina, Repubblica
Dominicana, Colombia, Spagna e Montenegro. Durante l'operazione è stato
sequestrato un carico di cocaina presente nell'imbarcazione Pandora Lys a largo
di Viana do Castelo tra Spagna e Portogallo.
'ndrangheta e Cartello del Golfo.
Il 14 luglio 2011 vengono arrestate oltre 40 persone nell'ambito dell'operazione
internazionale dei carabinieri Crimine 3. Le persone sono accusate di traffico
di droga internazionale e associazione mafiosa e sono state arrestate per lo più
in Italia, alcune in Spagna, Paesi Bassi e negli Stati Uniti. Il traffico veniva
gestito insieme al Cartello del Golfo e ai cartelli colombiani, per la
'ndrangheta c'erano presunti affiliati agli Ierinò, Commisso,
Coluccio, Aquino e Pesce. A ottobre 2013 viene arrestato a Roma il
venezuelano Edmundo Josè Salazar Cermeno detto Il chimico, latitante
dal 2011 (conclusione dell'operazione Solare 2) e presunto broker tra le cosche
Aquino-Coluccio e il cartello del Golfo e i Los Zetas per traffici di cocaina,
metanfetamine e cannabis proveniente dall'America del Sud. Era incaricato di
gestire tutta la logistica del traffico che coinvolgeva anche criminali dei
cartelli presenti a New York, la droga in Europa invece approdava in Spagna che
giungeva anche attraverso idrovolanti.
'ndrangheta e Los Zetas.
Il 17 settembre 2008 in un'operazione dell'FBI e della DEA americana, dell'ICE
messicana a cui hanno partecipato anche i carabinieri del ROS sono state
arrestate 200 persone appartenenti al cartello messicano dei Los Zetas e ad
altre organizzazioni criminali a cui vendevano la droga, tra cui la 'Ndrangheta,
nella fattispecie sono stati arrestati Vincenzo e Giulio Schirripa appartenenti
all'omonima 'ndrina,la quale faceva parte di un'alleanza con i Coluccio,
gli Aquino e i Macrì e con i quali avrebbero importato ogni volta 1000 chili
di cocaina. I contatti fra le due organizzazioni venivano prese tramite elementi
del cartello messicano a New York. Sono stati arrestati anche 16 esponenti dei
Coluccio e degli Aquino tra New York e la Calabria. L'accordo con i Los Zetas è
avvenuto dopo l'arresto dell'ecuadoriano Luis Calderon, principale fornitore per
queste 'ndrine. Durante l'operazione Crimine 3, si scopre che il trafficante di
droga calabrese Vincenzo Roccisano faceva da tramite con i Los Zetas e le
'ndrine calabresi e le cosche siciliane. A ottobre 2013 viene arrestato
a Roma il venezuelano Edmundo Josè Salazar Cermeno detto Il chimico, latitante
dal 2011 (conclusione dell'operazione Solare 2) e presunto broker tra le cosche
Aquino-Coluccio e il cartello del Golfo e i Los Zetas per traffici di cocaina,
metanfetamine e cannabis proveniente dall'America del Sud. Era incaricato di
gestire tutta la logistica del traffico che coinvolgeva anche criminali dei
cartelli presenti a New York, la droga in Europa invece approdava in Spagna che
giungeva anche attraverso idrovolanti.
'ndrangheta e Mafia serba e criminalità
montenegrina. Secondo Michele Altamura
dell'Osservatorio Italiano la mafia serba con l'aiuto della 'ndrangheta la mafia
serba è riuscita ad entrare nei traffici internazionali di stupefacenti. Negli
anni '90, dai serbi acquistò armi (tra cui bazooka ed esplosivi) costruite
in Serbia.
'ndrangheta e mafia russa.
Dagli anni '90 la 'ndrangheta è in relazione con la mafia russa per quanto
riguarda il traffico di droga e di armi.
'ndrangheta e Big Circle Boys.
Sempre negli anni '90 questa organizzazione criminale era
alleata anche con i Big Circle Boys per la gestione del traffico di droga
in Canada.
'ndrangheta e Cosa Nostra americana.
L'11 febbraio 2014 termina un'operazione della Polizia e dell'FBI statunitense
contro elementi presunti affiliati agli Ursino e ai Simonetta e ed esponenti
vicino ai Gambino di Cosa nostra statunitense, accusati di traffico
internazionale di droga. Tra gli arrestati anche Francesco Ursino, presunto
attuale capo della cosca e figlio di Antonio (in carcere) e Giovanni Morabito,
nipote di Giuseppe Morabito. Il 7 maggio 2015 durante
l'operazione Columbus vengono arrestate 16 persone per traffico internazionale
di droga proveniente dal Costa Rica. Fu coinvolto anche il titolare della
pizzeria "Cucino a modo mio" nel Queens a New York. Il proprietario della
pizzera Gregorio Gigliotti, originario di Pianopoli (CZ) ma residente da 30 anni
a Whitestone (New York) sarebbe stato in contatto anche con Anthony Federici,
vicecapo della famiglia Genovese di cosa nostra statunitense. In Calabria era
invece in contatto a Francesco e Carmine Violi vicini agli Alvaro di Sinopoli.
Gigliotti avrebbe occupato nel narcotraffico il posto di Giulio Schirripa dopo
il suo arresto nel 2008, il quale già doveva dei soldi allo stesso Gigliotti.
'ndrangheta e Primeiro Comando da
Capital. Nel 2016 una denuncia del Ministero pubblico
federale del Brasile afferma dell'esistenza di relazioni tra il gruppo criminale
brasiliano del Primeiro Comando da Capital con l'organizzazione calabrese, e
viene citata nel 2014 nell'operazione Oversea, la più grande operazione contro
il traffico di droga in Brasile. La droga veniva importata dalla Bolivia,
passava per il Brasile per giungere in Italia nel porto di Napoli...
GUERRA DEI BOSS, VINCE LA 'NDRANGHETA.
Da New York all'Australia, le inchieste delle polizie
di mezzo mondo ci dicono che i clan calabresi hanno sconfitto Cosa Nostra nella
lotta per il controllo delle rotte mondiali del narcotraffico. Ecco come i nuovi
padroni del crimine hanno messo fuori gioco i vecchi padrini, scrivono Giuliano
Foschini, Marco Mensurati e Fabio Tonacci l'8 agosto 2016 su “La Repubblica”.
Laval, sobborgo a nord di Montreal, Canada. Primo marzo. Lorenzo Giordano ferma
il Suv Kia blu sull’asfalto innevato del parcheggio del Carrefour Multisport,
vicino alla highway 440. Spegne il motore, il crocifisso legato allo specchietto
retrovisore sta dondolando. Sono le 8.45, la mattinata è gelida. Un killer sbuca
a lato della macchina e gli spara alla testa e alla gola, frantumando il vetro
del finestrino. Lorenzo “Skunk” Giordano, 52 anni, muore poco dopo, in ospedale.
Carlton, quartiere italiano di Melbourne, Australia. 15 marzo. Un signore
abbronzato con i capelli ben pettinati esce dal Gelobar, la sua gelateria. Sta
camminando, è da poco passata la mezzanotte. È solo, e la strada è buia. Lo
freddano alle spalle sparandogli da un’auto in corsa, senza neanche fermarsi.
Tre ore dopo un netturbino scende dal camioncino e si avvicina al cassonetto.
Accanto c’è il cadavere di Joseph “Pino” Acquaro, 50 anni, famoso avvocato.
Ancora Laval, 27 maggio. Alla fermata dell’autobus su boulevard St. Elzéar è
seduto un uomo, sui trent’anni, vestito completamente di nero. Scarpe nere,
pantaloni neri, giacca nera, occhiali neri. Sono le 8.30. La Bmw bianca di Rocco
Sollecito, come previsto, passa sul boulevard. Il semaforo è rosso, si ferma.
L’uomo nero si alza, e punta la pistola contro il finestrino della macchina.
Rocco “Sauce” Sollecito, 62 anni, scivola sul sedile imbrattato del suo sangue,
colpito a morte. Italiani che parlano inglese e sparano. Altri italiani che
parlano inglese e muoiono. Canada, Australia, Stati Uniti. Reggio Calabria. Il
terremoto di sangue ha un epicentro silente, New York. E nuovi clan emergenti
che hanno preso troppo potere, come gli Ursino, ‘ndranghetisti di Gioiosa
Ionica. L’onda d’urto si è propagata su tutto il pianeta. Le vite affogate nel
piombo di “Skunk”, “Pino” e “Sauce” sono scosse di assestamento. La chiamano la
"guerra mondiale della mafia". New York, quindi. Niente è come prima. Le cinque
grandi famiglie di Cosa Nostra, Gambino, Bonanno, Lucchese, Genovese e Colombo
non sono più quelle che erano. Lo documentano le ultime inchieste del Federal
bureau of investigation (Fbi), condotte insieme agli investigatori del Servizio
centrale operativo (Sco) della polizia italiana. Giovedì scorso l’Fbi ne ha
catturati altri 46, tra la Florida, il Massachusetts, il New Jersey, New York e
il Connecticut: capi, mezzi capi e paranza dei Gambino, dei Genovese, dei
Bonanno. È finito dentro anche il 23enne John Gotti jr, nipote dell’ultimo
grande boss di Cosa Nostra americana. Assediati dalle indagini e indebolite da
un ricambio generazionale difficoltoso, i siciliani stanno cedendo spazio, in
maniera apparentemente quasi del tutto incruenta, alla mafia calabrese. Nella
Grande Mela i clan dei Commisso e degli Aquino-Coluccio si sono insediati da
anni, ma chi sta rivendicando per sé il ruolo di “sesta famiglia” sono gli
Ursino di Gioiosa Ionica. E questo è un problema, per tutti. Una sesta famiglia,
infatti, c’è già. Pur non ammessa nel gotha criminale di New York, i Rizzuto di
Montreal, in Canada, hanno storicamente un legame stretto con i Bonanno. Se c’è
da mettere in piedi un affare di un certo peso - partite di cocaina, armi
clandestine, riciclaggio - i referenti sono loro. Un rapporto che da un po’ di
tempo non è più così solido. Tra il 2012 e il 2013 una fonte confidenziale
dell’Fbi rivela che Francesco Ursino, il boss della omonima cosca storica
alleata dei Cataldo di Locri, ha chiesto ai Gambino di poter lavorare sulla
piazza di New York "proprio come una sesta famiglia". Chiesto per modo di dire.
A questo giro sono i siciliani di Cosa Nostra a trovarsi di fronte a un’offerta
che non si può rifiutare, perché quando ha bussato alla porta dei Gambino,
Francesco Ursino in realtà si era già preso tutto: le rotte del narcotraffico, i
contatti con i cartelli messicani e colombiani, il controllo dei porti e dei
cargo. Il boss parlava a nome non di una famiglia sola, ma di quello che gli
investigatori nell’indagine New Bridge (che porterà alla cattura del capoclan)
definiscono "un consorzio" di clan della Locride. Rifiutare avrebbe voluto dire
per i Gambino ingaggiare una guerra senza senso, e dall’esito incerto. Meglio
mettersi d’accordo e accettare il dato di fatto. Sul mercato mondiale della
cocaina, ‘ndrangheta rules, comanda. Da anni i calabresi lavorano nell’ombra a
New York, negli scantinati delle loro pizzerie e nei retrobottega dei loro
“italian restaurant”. Volano a Bogotà e San José nel weekend, fingendosi
turisti. "Se volete sapere cosa succede a New York, cercate in Centro America;
se volete sapere cosa succede tra i Cartelli del Golfo guardate chi comanda a
New York", spiega Anna Sergi, criminologa dell’Università dell’Essex, studiosa
delle proiezioni dell’’ndrangheta all’estero. E in Centro-Sud America succede
che i calabresi comandano. Marcano il territorio. Agganciano intermediari.
Sparano il meno possibile. Più finanza meno casini. La gola profonda che ha
spiegato alla Dea e all’Fbi cosa si stava muovendo nel ventre criminale della
Grande Mela si chiama Cristopher Castellano. È proprietario di una discoteca nel
Queens, il Kristal’s, che usa per nascondere quello che in realtà è: un broker
dei Los Zetas, il pericolosissimo cartello messicano paramilitare dei disertori
dell’esercito che si avvale di lui per commerciare stupefacenti negli States e
in Europa. Con i narcotrafficanti, Cristopher ha fatto una montagna di soldi. La
festa dura poco, però. Lo arrestano nel 2008, e lui, pur di uscire dalla galera,
canta. Si vende ai poliziotti due calabresi: Giulio Schirripa e tale “Greg”.
Racconta di questi due italiani che, usando le pizzerie come copertura e i soldi
della ‘ndrangheta come garanzia, stanno muovendo tonnellate di cocaina nascosta
nei barattoli di frutta trasportati dalle navi portacontainer. "Hanno una
pipeline attraverso gli oceani", sostiene Castellano. Se girano grosse partite
di polvere bianca che dal Costarica raggiungono gli Usa, il Canada, il Vecchio
Continente e l’Australia, è roba loro. Distribuiscono, smistano, organizzano i
viaggi delle navi, aprono società fittizie di import-export, corrompono
doganieri. A New York vanno a cena con i Genovese. A San José si incontrano con
gli uomini di Arnoldo de Jesus Guzman Rojas, il capo del cartello di Alajuela. A
Reggio Calabria riferiscono al clan Alvaro. Sono dei “facilitatori”,
insospettabili perché incensurati: creano le condizioni per portare la polvere
bianca dai laboratori nella giungla del Costarica al naso dei consumatori.
Schirripa, arrestato insieme a Castellano, è l’archetipo dell’emigrato calabrese
alla conquista di New York. Gregorio “Greg” Gigliotti, l’epigono. Cristopher
Castellano è diventato carne morta nel momento stesso in cui ha aperto bocca con
gli agenti federali. Quattro luglio del 2010, negli Stati Uniti si festeggia il
giorno dell’Indipendenza. Ad Howard Beach, nel Queens, lo spettacolo di fuochi
d’artificio è iniziato poco prima di mezzanotte. Castellano però non ha gli
occhi al cielo, sta frugandosi le tasche per cercare le chiavi della macchina.
Un colpo solo, alla nuca. Nessuno si accorge di niente. Castellano non soffierà
più all’orecchio dell’Fbi. Intanto, però, gli investigatori hanno messo sotto
controllo i telefonini e riempito di cimici i ristoranti di Gigliotti nel
Queens, tra cui il famoso 'Cucino a modo mio' citato nelle riviste specializzate
di tendenza. "Non c’è un grammo di cocaina in Europa che non sia passata tra le
mani di Gregorio", ripetono spesso i complici dell’italiano, terrorizzati dalle
escandescenze di Gigliotti. Quando si arrabbia, col suo dialetto calabrese
impastato di slang americano può dire cose terribili: "Una volta mi sono
mangiato un pezzo di rene e un pezzo di cuore", sbraita con la moglie, irritato
da un altro calabrese che sta provando a inserirsi nel suo business. Il centro
dei suoi affari è il Costa Rica, dove ha contatti diretti con i narcotrafficanti
grazie a una fitta rete di broker e fiduciari. "E digli che non facciano troppo
i furbi…", ripete loro, quando li spedisce a trattare in Sudamerica. Lui
accumula denaro, i poliziotti dello Sco e dell’Fbi ascoltano e anticipano
qualcuna delle sue mosse. Porto di Anversa, 16 chili di cocaina sequestrati.
Porto di Valencia 40 chili, Wilmington 44 chili. Porto di Rotterdam 3
tonnellate. Poi l’8 maggio scorso lo arrestano. Finisce dentro anche suo figlio,
Angelo. Ma poche settimane dopo torna in libertà grazie a una cauzione da cinque
milioni di dollari. Pagata in contanti. Fuori gioco i referenti degli Alvaro,
New York se la sono presa gli Ursino. Compresi i contatti con i sudamericani. Le
scosse del terremoto si riverberano in Canada, dove le gerarchie si sgretolano.
E con esse la pax mafiosa. Dagli anni Ottanta i criminali italiani emigrati lì
si erano divisi gli affari, tra Toronto e Montreal. Ai siciliani del clan
Rizzuto la droga, ai calabresi arrivati da Siderno il gambling, il gioco
d’azzardo, e l’usura. La mappa l’hanno disegnata nel 2010 gli investigatori
italiani che hanno lavorato alla maxi inchiesta ‘Crimine’ (che per la prima
volta individuò i vertici dell’’ndrangheta) ed è ancora valida. Tre anni fa Vito
Rizzuto, il capo, muore di tumore. Nei mesi successivi, in coincidenza con
l’ascesa degli Ursino nel quadrante nordamericano, quattro dei sei membri del
“Consiglio” dei Rizzuto vengono uccisi. Gli altri due si salvano soltanto perché
sono in galera. L’ultimo a cadere è stato Rocco “Sauce” Sollecito. Poche
settimane fa a Montreal stava per finire in una bara Marco Pizzi, 46 anni,
importatore di cocaina per il clan secondo la polizia, sfuggito per un soffio ai
suoi sicari che lo avevano tamponato con una macchina rubata. Erano mascherati e
armati. "I calabresi hanno attaccato i vecchi poteri", ragiona un investigatore.
"È ‘ndrangheta contro mafia". La guerra mondiale, quindi. La scia di sangue si
allunga fino all’Australia, dove il golpe calabrese sulle rotte della cocaina ha
destabilizzato equilibri che si reggevano dalla fine degli anni Settanta. La
famiglia Barbaro sembra aver perso il passo, e i contatti con i nuovi
importatori sarebbero passati nelle mani di Tony e Frank Madafferi. A Melbourne
i calabresi combattono contro i calabresi. Frank Madafferi e Pasquale “Pat”
Barbaro furono indagati nel 2008 nel processo per il più grande carico di
metanfetamine mai intercettato nella storia della lotta al narcotraffico: 4,4
tonnellate di ecstasy, per un controvalore di 500 milioni di dollari australiani
(340 milioni di euro) in pasticche stivate in una nave che trasportava lattine
di pomodori pelati. Ma quel processo non è l’unica cosa che Tony Madafferi e Pat
Barbaro, poi condannato all’ergastolo, hanno in comune. A unirli, come spesso
accade, anche la scelta dell’avvocato: il professionista italo- americano Joseph
Acquaro. L’uomo trovato morto dal netturbino davanti alla gelateria, lo scorso
marzo. Le indagini sono ferme al palo anche se un paio di elementi hanno
attirato l’attenzione su Madafferi: in particolare alcune intercettazioni in cui
si dichiara proprietario di Melbourne ("È mia, non di Pasquale") e si dice
pronto ad uccidere il rivale ("gli mangio la gola"). Ma soprattutto il racconto
di un pentito che ha spiegato alla polizia come nel sottobosco malavitoso di
Melbourne tutti sapessero della taglia che Tony aveva da poco messo sulla testa
dell’avvocato, colpevole a quanto pare di aver cominciato a parlare un po’
troppo con giornalisti e investigatori: 200mila dollari australiani. Chi li
abbia incassati non si sa. Quello che si sa è che pochi giorni prima di
quell’omicidio, all’aeroporto di Fiumicino i carabinieri di Locri avevano
arrestato Antonio Vottari, 31 anni, accusato di gestire i traffici di droga tra
il Sudamerica e l’Europa per conto delle cosche di San Luca. Rientrava da
Melbourne, dove da anni trascorreva la sua latitanza, con un visto da studente.
Le sorti della guerra mondiale della mafia le decidono in Calabria. Tutto parte
da là. E tutto, prima o poi, là ritorna.
Inchiesta: i boss di Cosa nostra al
servizio della ‘ndrangheta, scrive Alberto Di Pisa su
“Sicilia Informazioni” il 28 giugno 2016. Intervenendo qualche giorno fa ad un
convegno organizzato “In memoria di Cesare Terranova” il Procuratore della
Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone ha affermato che la mafia siciliana è in
crisi e in difficoltà ed è subalterna alla mafia campana e calabrese. Ed ha
aggiunto: “Dal mio osservatorio di Roma, quando sento di tentativi di
ricostruzione di mandamenti o della vecchia Cupola, penso subito che, comunque,
si tratta di tentativi non riusciti e che la situazione rispetto al passato è
molto diversa, rispetto ai tempi degli omicidi eccellenti”. Questa supremazia di
altre organizzazione criminali quali la Ndrangheta o la camorra, sulla mafia
siciliana, sembra trovare un riscontro in quanto dichiarato dal Procuratore
aggiunto di Palermo, Teresa Principato la quale ha detto: “Possiamo affermare
dalle nostre indagini che la ‘ndrangheta ha sostenuto la latitanza di Matteo
Messina Denaro….Ed ancora: “I rapporti tra malavita organizzata calabrese e
Matteo Messina Denaro sono basati su punti incontrovertibili, contatti con la
‘ndrangheta ci sono dai tempi di Riina, non c’è niente di nuovo”. Ed ha spiegato
che “la leadership della ‘ndrangheta è dovuta al fatto che non c’è stato
obiettivamente lo stesso lavoro se non da cinque sei anni, da quando è arrivato
a Reggio Calabria il dottor Pignatone e adesso De Raho. Ma prima c’erano molto
pochi risultati”. Lo stesso Nicola Gratteri, ex Procuratore aggiunto di Reggio
Calabria, oggi Procuratore della Repubblica di Catanzaro, aveva già in passato
sottolineato come si fossero ormai invertiti i rapporti di forza tra calabresi e
siciliani. Aveva infatti detto: “Ora è Cosa Nostra che chiede alla ‘ndrangheta
la droga, si rifornisce dalla criminalità calabrese, che ha preso le redini di
questo traffico a tutti gli effetti (….) Adesso la mafia americana si affida ai
calabresi per spaccio e traffico soprattutto di cocaina”. E’ proprio quindi in
virtù della potenza economica e criminale che deriva alla ‘ndrangheta dal
traffico di droga a livello mondiale che Matteo Messina Denaro ha deciso di
affidarsi, per la propria latitanza, agli esponenti di tale organizzazione
criminale. Va poi sottolineato che fin dagli anni settanta la ‘ndrangheta è
riuscita a favorire l’ingresso di propri uomini nei partiti di governo, nelle
istituzioni in occasione delle competizioni elettorali. Ma a parte questa
caratteristica, la ‘ndrangheta ha assunto un vero e proprio ruolo
imprenditoriale per ciò che riguarda il traffico di armi e di droga, attività
che, come evidenziato da Gratteri, si è estesa al di fuori dell’ambito della
propria regione, così soppiantando quelle che era state alcune delle principali
attività criminali della mafia siciliana che oggi ha finito con l’assumere un
ruolo subalterno rispetto alla ’ndrangheta e alla camorra. Va ricordato, per
quanto riguarda l’infiltrazione della ‘ndrangheta nelle istituzioni, come, in
conseguenza della elezione di ‘ndranghetisti negli organi rappresentativi
comunali si verificò, negli anni 80-90 lo scioglimento di diversi consigli
comunali calabresi tra cui quelli di Taurianova e Lamezia Terme. Si legge in
proposito nella relazione Cabras: “L’ex sindaco di Reggio Calabria, Agatino
Licandro, che ha svolto davanti al Procuratore della Repubblica una dettagliata
confessione sulla corruzione politico-amministrativa della città, già nel luglio
del 1991 affermava: “(….) a proposito dei consiglieri comunali: ce ne sono
almeno 10-15 per cento eletti consapevolmente con voti della mafia” (relazione
cit., pag. 34). Per quanto riguarda il narcotraffico, mentre negli anni 60 la
‘ndrangheta era legata da un rapporto organico con la mafia siciliana per cui
trafficanti calabresi e siciliani operavano su un piano di parità, oggi, proprio
grazie al notevole potere economico e criminale raggiunto dalla ‘ndrangheta
insieme alla situazione di difficoltà in cui versa la mafia siciliana, è
quest’ultima che è costretta a rivolgersi, per rifornirsi di droga, alla
‘ndrangheta che ormai detiene il monopolio delle sostanze stupefacenti. È appena
il caso di ricordare che negli anni 70- 80 il traffico di droga era monopolio
della mafia palermitana che aveva realizzato, proprio a Palermo, dei laboratori
dove, con l’intervento di esperti chimici francesi, veniva raffinata e
trasformata in eroina la morfina base proveniente dal medio oriente, eroina che
poi veniva inviata negli USA dove, attraverso le pizzerie facenti capo a mafiosi
siciliani, veniva spacciata al minuto. La mafia americana, quale pagamento della
droga ricevuta, inviava in Italia valige contenenti migliaia di dollari. Un
pagamento di droga fu certamente il rinvenimento, da parte del Dirigente della
Squadra mobile di Palermo, Boris Giuliano, all’aeroporto di Punta Raisi, di una
valigia proveniente dagli Usa e contenente 500mila dollari. Una dimostrazione
del ruolo determinante della ‘ndrangeta nel traffico di stupefacenti è dato
dalla maxi operazione che, nel settembre del 2015, portò all’arresto di 48
persone con l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico
internazionale di stupefacenti. In questa operazione vennero colpite le famiglie
potenti della fascia jonica-reggina. In occasione di tale operazione Nicola
Gratteri ebbe a dichiarare: “Oggi è Cosa Nostra che chiede alla ‘ndrangheta la
droga, si rifornisce dalla criminalità calabrese, che ha preso le redini di
questo traffico a tutti gli effetti”. Questa operazione ha inoltre accertato
come la ‘ndrangheta abbia estromesso Cosa Nostra dai contatti con la mafia
americana nel traffico di droga indebolendo il legame che tradizionalmente
esisteva, come si è visto, con quest’ultima. In occasione di altra operazione
antidroga relativa ad un traffico internazionale di stupefacenti che ha visto
coinvolti esponenti di Cosa Nostra e della ‘ndrangheta, il comandante dei ROS ha
affermato: “Il ruolo centrale ce l’hanno le cosche della ‘ndrangheta che hanno
confermato ancora una volta lo straordinario livello raggiunto nel traffico
internazionale di cocaina, grazie anche alla solidità di rapporti instaurata nel
tempo con i broker sudamericani”. Si trattò di una operazione condotta dalla
Direzione distrettuale antimafia di Milano che nell ‘ottobre del 2012 portò
all’arresto di più di 50 persone. L’indagine accertò che gli esponenti delle
cosche calabresi avevano creato “un cartello” con la mafia siciliana per il
commercio della cocaina che avrebbe dovuto essere smistata tra Italia, Belgio,
Germania, Olanda e Austria. La droga arrivava dall’Ecuador e dalla Colombia ed
entrava in aereo o nei container della navi commerciali, occultata tra gamberi e
banane. Ma la potenza acquisita dalla ‘ndrangheta non deriva soltanto dal
traffico di droga ma anche dal fatto che ha raggiunto, in vaste aree, il
controllo militare del territorio, eliminando dal mercato numerose imprese, e,
come è stato scritto “ha conquistato quasi il monopolio del movimento terra,
negli inerti, nell’edilizia e ha costruito un fisco parallelo a quello dello
Stato imponendo un pizzo generalizzato”. La ‘ndrangheta dispone poi di killer
altamente professionali e temuti che uccidono le persone designate in qualunque
luogo esse si trovino anche nelle piazze dei paesi o delle città, sia di giorno
che di notte. Basta ricordare l’omicidio di Francesco Fortugno, consigliere
comunale e vice presidente della Regione, ucciso a Locri il 16 ottobre 2005 nel
giorno delle primarie dell’Unione, all’interno del seggio, da un killer a volto
coperto con cinque colpi di pistola. La DIA ha inoltre evidenziato come la
‘ndrangheta abbia parzialmente ma visibilmente, messo da parte i metodi
criminali aggressivi per creare “vere e proprie Holding imprenditoriali”. Ciò,
sempre secondo la DIA, avrebbe determinato una vera e propria fusione con
l’economia regionale grazie alla quale i clan sono “in grado di aggiudicarsi gli
appalti ed acquisire le concessioni”. La Dia ha inoltre segnalato come sia stata
accertata la presenza di esponenti delle ‘ndrine in Liguria, Piemonte, Veneto,
Lombardia, Toscana Lazio, Molise, esponenti attraverso i quali i clan calabresi
gestiscono le loro attività illecite. In particolare, per quanto riguarda il
Piemonte la DIA ha evidenziato come la ‘ndrangheta “interagisce con gli ambienti
imprenditoriali lombardi (…..) e c’è il coinvolgimento di alcuni personaggi
rappresentati da pubblici amministratori locali e tecnici del settore (…) che
hanno agevolato l’assegnazione di appalti e assestato oblique vicende
amministrative” La stessa DIA aveva chiesto un razionale programma di
prevenzione al fine di bloccare le possibili infiltrazioni della ‘ndrangheta in
previsione delle opere previste per l’Expo 2015. Dal rapporto della DIA emerge
poi come la ‘ndrangheta sia tra le organizzazioni criminali quella “meno
visibile sul territorio ma la meglio strutturata e la più diffusa sia a livello
nazionale che internazionale”. E si trae sempre dalla relazione della DIA come
la “ndrangheta si caratterizzi, più delle altre organizzazioni criminali, per la
sua straordinaria rapidità nell’adeguare valori arcaici alle esigenze del
cambiamento tanto che le sue ‘ndrine hanno dimostrato una elevata abilità
nell’utilizzare gli strumenti delle innovazioni tecnologiche”. Gli investigatori
della Direzione Investigativa Antimafia non trascurano poi di evidenziare la
crescente pericolosità della ‘ndrangheta “nel panorama criminale nazionale ed
internazionale” nonché la sua “grande determinazione nel volere accreditare
maggiormente la propria influenza nell’area del grande crimine mafioso”. Le
indagini quindi ci presentano una organizzazione criminale particolarmente viva
ed attiva nel circuito della finanza internazionale e per questo estremamente
pericolosa. La relazione della Commissione parlamentare antimafia parla di
rapporti tra la mafia calabrese ed “esponenti del mondo bancario ed
istituzionale di Milano” che è risultata essere la città di riferimento più
importante per la ‘ndrangheta e la più inquinata. E sempre la suddetta
Commissione, parla di “sistematica omissione di controlli da parte degli
amministratori pubblici”. Si diceva dell’utilizzo, da parte della ‘ndrangheta
degli strumenti delle innovazioni tecnologiche. Ebbene la ‘ndrangheta ha
tentato, fortunatamente senza successo, di inserirsi nella posta elettronica
della Deutsche Bank di Milano per clonare i titoli al portatore e rinegoziarli
presso altre banche, tentando quindi di attuare un sofisticato sistema di
riciclaggio. Per dare un idea del salto di qualità compiuto dalla ‘ndrangheta e
di come la stessa si sia, a differenza di Cosa nostra, adeguata ai tempi, basta
leggere quanto dichiarato da un ufficiale della Guardia di finanza il quale ha
detto di avere accertato l’esistenza di 120 tonnellate metriche di oro o
diamanti, o valuta libica, oppure dollari kuwaitiani scambiati contro dollari e
tutto con procedure bancarie telematiche che consentono di spostare milioni di
dollari senza che materialmente un euro esca dalle tasche. La Guardia di Finanza
ha anche individuato conti correnti all’estero, nella Bahamas, in Russia, nella
ex Jugoslavia, in Austria. Sono state inoltre accertate presenze, in alcune
logge massoniche, di personaggi collegati alla ‘ndrangheta in rapporto e
connivenza con uomini delle istituzioni, professionisti, avvocati, notai,
imprenditori, magistrati. La ‘ndragheta ha inoltre adottato un diverso sistema
di impiego degli enormi profitti che provengono dal traffico di cocaina. Questi
proventi infatti non vengono più impiegati, come avveniva tradizionalmente,
ripartendo il denaro tra i diversi prestanome ma inviandolo direttamente
all’estero. Alcuni anni fa infatti, un commercialista milanese trasferì il
capitale di 26 società della ‘ndranheta con una triangolazione
Milano-Lussemburgo-Lugano avvenuta in soli 15 giorni. Le mani della ‘ndrangheta
arrivarono anche al palazzo di giustizia di Milano come testimoniato
dall’arresto per mafia, qualche anno fa, di un alto magistrato in pensione che
era riuscito a pilotare sentenze anche dopo il pensionamento e di un legale che
dopo l’omicidio del collega Raffaele Ponzio sarebbe diventato il nuovo
collettore delle mazzette giudiziarie. Entrambi sono stati accusati di
corruzione e di associazione mafiosa. Secondo l’accusa sarebbero stati complici
esterni ma anche organici di due potenti famiglie della ‘ndrangheta. In cambio
di mazzette (da un milione a un miliardo) avrebbero aggiustato processi,
garantendo assoluzioni, irrogando condanne tenui, assicurando scarcerazioni. Una
pentita della ’ndrangheta, Rita Di Giovine ha parlato dell’ingresso del giudice
di cui sopra in una camera di consiglio tenuta da altri giudici con una
bustarella consegnatagli dal boss Emilio. Ha riferito anche della scarcerazione
di Antonio Morabito per la quale il giudice avrebbe ricevuto un assegno di venti
milioni e dell’annullamento, in appello, delle condanne di Francesco Sergi,
Antonio Parisi e Saverio Morabito, tutti affiliati alla ‘ndrangheta, che nel
1993 erano stati condannati per traffico di droga. Diverso il comportamento
della ‘ndrangheta nei confronti dei magistrati incorruttibili. In questo caso si
fa ricorso alle intimidazioni, agli attentati, alle bombe in ufficio. Alla luce
di quanto fin qui detto la ‘ndrangheta che è sempre stata considerata la parente
povera e rozza di Cosa Nostra ha compiuto un salto di qualità che ha fatto si di
ridurre Cosa Nostra ad una posizione subalterna non più in posizione di
preminenza tra le associazioni criminali mafiose. Nessuno oggi potrebbe più dire
che la ‘ndrangheta è un residuo arcaico. Alberto Di Pisa
La 'Ndrangheta si aprì la strada al
primato, dicendo no al terrorismo anti Stato di Riina,
scrive Giuseppe Baldessarro su “La Repubblica” il 13 gennaio 2013. Già nel 1993
le 'ndrine si potevano permettere di rifiutare gli inviti dei corleonesi. Poi in
vent'anni sono cresciute, arrivando a vantare il primato di essere l'unica mafia
al mondo presente in tutti e cinque i continenti. Che con i soldi della cocaina
possono comprare tutto, soprattutto in un periodo di crisi economica. Quando gli
emissari di Totò Riina chiesero alla 'Ndrangheta di entrare in guerra contro lo
Stato, i calabresi risposero che loro i magistrati "non li ammazzano", ma che
"se li comprano, o li distruggono minandone la credibilità". Era il 1993 e già
allora la 'ndrangheta poteva dire di no ai corleonesi. Erano potenti e avevano
capito tutto. Loro avevano i soldi della cocaina e lo Stato era concentrato
sulla Sicilia. Con Cosa nostra fuori gioco, per i clan dell'Aspromonte si apriva
una prateria sterminata. Territori criminali da conquistare. E in vent'anni i
boss reggini hanno occupato militarmente il mercato di mezza Europa, arrivando a
vantare il primato di essere l'unica mafia al mondo presente in tutti e cinque i
continenti. L'episodio chiave dell'ascesa dei calabresi è stato raccontato anche
di recente. A luglio scorso, durante il maxi processo "Meta" che si sta
celebrando nell'aula bunker di Reggio Calabria, in aula c'era Nino Fiume, killer
di fiducia della famiglia De Stefano del quartiere Archi, pentitosi all'inizio
degli anni 2000. Fiume racconta dell'assassinio del giudice Antonino Scopelliti,
ucciso a Campo Calabro (pochi chilometri da Reggio), su commissione dei
siciliani. Era il giudice di Cassazione che doveva gestire il Maxi processo di
Palermo e Riina lo voleva morto. Un favore in nome della vecchia amicizia tra
siciliani e calabresi. Non è un caso che don Mico Tripodo, capo indiscusso della
'Ndrangheta reggina (assassinato a Poggioreale, su ordine di Raffaele Cutolo e
richiesta dei De Stefano), qualche anno prima era stato ospite d'onore al
matrimonio di Totò u curtu e compare d'anello degli sposi. Nel '91 gli "amici"
furono accontentati. Due anni dopo no. Cosa Nostra tentò di coinvolgere la
'Ndrangheta calabrese nella strategia della tensione che Fiume definisce di
"attacco allo Stato". Furono anche convocate diverse riunioni, una a Milano e
due in Calabria. "Era il periodo delle stragi di Roma, Firenze, Falcone e
Borsellino erano stati uccisi", ha spiegato Fiume. La prima riunione, quella di
Rosarno, avvenne all'hotel Vittoria. "In quella occasione - ricorda - c'erano i
siciliani. Per i calabresi c'erano Carmine e Giuseppe De Stefano, Franco Coco,
il suo braccio destro, Nino Pesce. Forse qualcuno dei Bellocco. Pietro Cacciola,
che frequentava Coco Trovato a Milano". La seconda riunione, di poco successiva:
"Eravamo al residence Blue Paradise di Parghelia (in provincia di Vibo
Valentia). Franco Coco voleva stringere il cerchio attorno a Pasquale Condello,
bisognava chiarire il progetto dei siciliani e c'era anche un traffico di droga
da definire. C'erano presenti Luigi Mancuso, Peppe De Stefano, Peppe Piromalli,
Pino Pesce, e Coco Trovato. Tenete presente - spiega Fiume - che a queste
riunioni si partecipa non come famiglia, ma come rappresentanti di un territorio
più vasto". Ai siciliani, all'epoca, fu detto di no. Solo Franco Coco Trovato
era possibilista. Per Peppe De Stefano invece, la strategia dei siciliani era
controproducente. Diceva - riferisce Fiume -che era più facile avvicinare un
magistrato o al massimo distruggerlo con campagne denigratorie". Quella scelta
fece la fortuna della 'Ndrangheta. Con i siciliani impegnati a fare la guerra
con lo Stato, le 'ndrine si consolidarono al nord Italia e all'estero, dove
furono creati dei "locali" di mafia identici, per struttura e regole, a quelli
della casa madre. I broker si stabilirono direttamente in Colombia a trattare
con i cartelli della "coca" che iniziò ad arrivare in Europa a tonnellate. La
"droga dei ricchi non uccide", dicevano. "E noi la facciamo diventare la droga
di tutti". I calabresi sono affidabili, non hanno pentiti e pagano puntuali. Per
questo ottengono il monopolio. Oggi sono in grado di mettere sul mercato un
grammo di cocaina tagliata a meno di 40 euro. Robaccia, ma i "poveri non
guardano alla qualità". Gestendo il 70% dei carichi che arrivano in Europa,
secondo la Commissione parlamentare antimafia, contano su capitali spaventosi.
Con la droga sono arrivati i soldi e i soldi vanno reinvestiti. Comprano tutto e
comprano da tempo. C'è un'intercettazione tra un boss della 'Ndrangheta e un suo
contatto al nord, cui impartisce ordini negli anni dopo la caduta del Muro di
Berlino: "Vai all'Est e compra tutto, non mi interessa cosa, compra case,
ristoranti, negozi, compra quello che vuoi basta che compri". Ed è così ovunque.
Tanto più con la crisi di liquidità degli ultimi anni. Sono gli unici ad avere
contante, utile ad entrare nelle aziende con partecipazioni, per fare prestiti o
per rilevare aziende decotte. Secondo la recente relazione della Dia che fa
riferimento ai primi sei mesi del 2012, se da un lato c'è Cosa Nostra che, forse
per la prima volta, "inizia a confrontarsi con un'apprezzabile perdita di
consenso", dall'altro si registra un'ulteriore salto in avanti della
'Ndrangheta, che consolida la sua "evoluzione affaristico imprenditoriale". I
calabresi si stanno allargando in un contesto "in cui la crisi economica e la
contrazione del credito producono un effetto moltiplicatore dei fattori di
rischio". Entra nell'economia la 'ndrangheta calabrese, ma dilaga anche nella
politica. "La corruzione - scrive la Dia - rappresenta un punto di forza delle
mafie. I gruppi criminali sono adusi a coltivare cointeressenze con la
cosiddetta "zona grigia" dell'imprenditoria, della pubblica amministrazione e
della politica, al fine di ottenere agevolazioni e condividere gli illeciti
profitti". I numeri sono solo una spia. In sei mesi le persone denunciate per
scambio elettorale politico mafioso sono solo sette, ma ciò "non corrisponde
alla diffusione dei fenomeni corruttivi e concussivi". Soldi amicizie importanti
sono la chiave della 'ndrangheta. Gli emissari dei boss entrano dalla porta
principale della politica e dell'economia. E, quando è possibile, lo fanno senza
mettere bombe.
E ora la ’ndrangheta supera cosa nostra.
Intervista a cura di Sebastiano Gulisano del dicembre 2007. La struttura
familiare e “orizzontale” dell’organizzazione criminale calabrese la rende meno
vulnerabile, consentendole un più stretto controllo del territorio e
l’espansione di traffici e affari in altre Regioni italiane, in Europa, Stati
Uniti, Canada, Australia, America Latina. La strage di Duisburg, il suicidio del
pentito del caso Fortugno, Bruno Piccolo, le inchieste del pm di Catazaro Luigi
De Magistris e, infine, il pentimento di Angela Donato, la prima donna a tradire
la ’ndrangheta, hanno, anche se a intermittenza, riacceso i riflettori su quella
che viene ormai considerata la più potente organizzazione criminale italiana,
con radici in Calabria e diramazioni in tutta Europa e in buona parte del mondo.
Una holding criminale con un giro d’affari illegali da 30 miliardi di euro
l’anno, che diventano quasi il doppio se si considerano le attività legali. La
’ndrangheta è stata a lungo la meno indagata, la più sottovalutata delle mafie
italiane, anche se non meno pericolosa della camorra o di cosa nostra. A
differenza delle altre organizzazioni criminali meridionali, è fortemente
incentrata sulla famiglia di sangue, e ciò, da sempre, favorisce la segretezza e
provoca pochissimi pentimenti. Un controllo del territorio ferreo, asfissiante,
l’imposizione del pizzo a commercianti e imprenditori con una pervasività simile
a quella di cosa nostra a Palermo e Catania, il controllo dei grandi lavori
pubblici, come la Salerno-Reggio Calabria, “l’autostrada della ’ndrangheta”. Il
recente rapporto annuale di Sos Impresa, l’associazione della Confesercenti che
si occupa di racket e usura, a tal proposito, riporta una frase di Nicola
Gratteri, pm della Direzione distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, che non
lascia dubbi: “Qui né le imprese né la politica hanno la forza di imporsi,
perché la ’ndrangheta ha un potere più asfissiante di cosa nostra. Controllano
le loro zone come i cani quando fanno pipì e da lì non si passa”. La Commissione
parlamentare Antimafia, presieduta da Francesco Forgiane, calabrese di
Rifondazione comunista, ha deciso di concentrarsi sulla ’ndrangheta, con
l’obiettivo di arrivare alla prima relazione su questa potentissima
organizzazione criminale. (Sempre che la legislatura non finisca prima.) Sarebbe
un fatto storico. In passato, la Commissione ha fatto relazioni sulla Calabria,
ma mai sull’organizzazione in quanto tale e, dunque, su tutte le sue
ramificazioni anche fuori dalla regione originaria. Per capire cos’è
’ndrangheta, quale evoluzione storica ha avuto, in cosa differisce dalle altre
mafie italiane, abbiamo intervistato Enzo Ciconte, storico della ’Ndrangheta,
docente presso l’Università di Roma Tre, autore di numerosi saggi
sull’organizzazione criminale calabrese, sulle altre mafie, sul traffico di
esseri umani. E’ consulente della Commissione Antimafia.
Dottor Ciconte, don Masino Buscetta, storico
pentito di mafia, raccontò al giudice Falcone che i boss di ’ndrangheta e
camorra erano affiliati a Cosa Nostra, aggiungendo che non esistevano tre
organizzazioni mafiose, ma una sola, quella siciliana. Tanto che quando c’era
guerra in Sicilia, questa si propagava nelle altre regioni. Cos’è cambiato da
allora?
«Si dà per
scontato che Buscetta dicesse il vero, invece non lo diceva o non sapeva. È
vero, all’epoca c’era la pratica di affiliare a cosa nostra i boss delle altre
organizzazioni criminali del sud. Ma era una pratica reciproca. Il discorso di
Buscetta può valere per la camorra, che allora era pulviscolare e viveva di
contrabbando, dopo che all’inizio del Novecento era stata sbriciolata dal
procuratore Cuoco. E ciò fino all’avvento di Cutolo…»
Dopo il terremoto dell’80 e gli affari
conseguenti.
«Cutolo fonda
la nuova camorra organizzata, federando i clan, e apre una polemica politica con
coloro che non ci stanno, che definisce “asserviti ai siciliani”. Politica
criminale, ovviamente. Il rapporto di cosa nostra con la ’ndrangheta, che ha un
pedigree più solido della camorra, era invece paritario. E ci sono fatti che lo
dimostrano. Negli anni Cinquanta, il dottor Michele Navarra, capomafia di
Corleone, viene confinato a Gioiosa Marina dove, come racconta il collaboratore
Giacomo Lauro, aveva “rapporti di affetto, amicizia e ‘rispetto’ con don Antonio
Macrì”. Mico Tripodo, all’epoca capobastone di Reggio Calabria, è compare
d’anello di Totò Riina: ciò non sarebbe stato possibile senza un rapporto
paritario. In realtà, c’era la doppia affiliazione, una pratica che durante gli
anni Novanta è andata diffondendosi fra mafiosi siciliani, calabresi, campani e
pugliesi».
La pratica della doppia affiliazione ricorda la
leggenda dei tre fratelli spagnoli che, nel Seicento, si stabilirono in Sicilia,
Calabria e Campania dove avrebbero fondato le tre organizzazioni mafiose.
«Osso,
Mastrosso e Scarcagnosso: una leggenda che ha un suo fondamento. Non
dimentichiamo che, dopo le stragi, il pentito siciliano Leonardo Messina venne
in Commissione Antimafia e parlò di una “mafia mondiale”. E, a proposito delle
stragi, ricordiamoci che, prima, Riina e gli altri boss convocarono i
capibastone della ’ndrangheta chiedendo un sostegno che non ebbero. Le
organizzazioni di base sono uguali, mentre è diversa quella dei vertici; tutte
hanno relazioni con la politica, la Chiesa, il padronato. I luoghi degli
incontri, degli accordi, storicamente sono le carceri, le fiere e il Parlamento,
ché i diversi referenti politici delle mafie si conoscono, si parlano».
Oggi è ancora così?
«Il rapporto è
cambiato, oggi la ’ndrangheta è più forte: cosa nostra ha subito la forte
repressione dello Stato successiva alle stragi, è stata scompaginata da
tantissimi collaboratori di giustizia; la ’ndrangheta, invece, è stata meno
investigata, la sua struttura familiare la rende meno vulnerabile, rende più
difficile il pentitismo e, sotto l’aspetto criminale, la fa essere più
affidabile di cosa nostra».
In cosa consiste l’“orizzontalità” della
’ndrangheta? Come funziona un’organizzazione criminale non verticistica?
«Nel ’91, con
la “pace di Reggio Calabria”, che chiude la sanguinosa guerra degli anni
precedenti, si crea una federazione tra le famiglie della Piana, della Locride e
di Reggio i cui rappresentanti si riuniscono per decidere la spartizione degli
affari e, quando questi riguardano l’intera regione, partecipano anche i
rappresentanti delle famiglie delle altre province. A differenza di cosa nostra,
dove la Cupola decideva tutto, qui ci si riunisce solo per gli interessi comuni
e i grandi affari. La pace di Reggio, fra l’altro, sancisce la chiusura di tutte
le faide. Per i figli di Giuseppe Grimaldi la pace è dura da digerire, il padre
era stato ucciso, decapitato e la testa presa a fucilate e fatta rotolare in
strada. I Grimaldi preferiscono emigrare a Genova e, dopo qualche anno, si
pentono e mandano in galera i propri nemici».
La strage di Duisburg farebbe pensare alla fine
della pace. O una strage all’estero – con quell’impatto mediatico – è
ammissibile?
«Duisburg non è
poi così lontana, “confina” con S. Luca. È a nordest di S. Luca. No, la pace non
è finita. Però è vero che la Locride è il punto di maggiore sofferenza, dimostra
l’incapacità della famiglia di S. Luca di governare il territorio, ed è un
problema per tutta la ’ndrangheta. Negli ultimi anni, abbiamo assistito a due
fatti clamorosi che riguardano la Locride: l’omicidio di Francesco Fortugno e la
strage di Duisburg. In entrambi i casi, una scelta diversa avrebbe dato
significato diverso ai delitti: la strage di Duisburg non è frutto di necessità,
potevano ucciderli uno alla volta, in momenti diversi; Fortugno, invece, se
l’avessero ucciso un giorno prima o un giorno dopo, non sarebbe stata la stessa
cosa. Assassinarlo il giorno delle primarie dell’Unione è una scelta politica.
L’omicidio non è stato deciso a Locri, ma dalla cupola, saldando gli interessi
della ’ndrangheta con quelli di ambienti della sanità, pubblica e privata, ma
anche con ambienti e legami storici della “Santa”».
Cos’è la Santa?
«A metà degli
anni Settanta la ’ndrangheta decise il suo ingresso nella massoneria. O meglio,
lo decise in modo organizzato poiché pare che alcuni capibastone fossero già
massoni. La decisione si accompagnò a una modificazione nella struttura di
comando delle varie ’ndrine, utilizzata per creare una nuova denominazione,
nuovi capi, nuove gerarchie: chi raggiungeva il grado di dantista era
autorizzato a entrare nelle leggi massoniche. La ’ndrangheta, che prima era
subalterna alla massoneria, decise di affrancarsi e di entrare in contatto
diretto col mondo delle professioni e con gli interessi che erano direttamente
rappresentati dalle logge. Per tre motivi: gli affari economici, la
rappresentanza politica diretta, il rapporto coi magistrati».
Ovviamente, parliamo di logge massoniche
riservate, coperte, non quelle ufficiali. Logge come la P2 di Licio Gelli.
«Un vero e
proprio cambio di pelle, insomma; un cambio di ragione sociale che porta
l’organizzazione ad avere rapporti diretti con la politica. E, storicamente, la
’ndrangheta ha una “colorazione” diversa da cosa nostra. La ’ndrangheta è sempre
stata vicina alla destra, specie alla destra eversiva. Basti pensare ai moti di
Reggio, alla partecipazione al golpe Borghese, alla protezione di Franco Freda,
fuggito dopo il processo di Catanzaro per la strage di piazza Fontana; ma anche
al coinvolgimento nel caso Moro o ai rapporti con la banda della Magliana. Nella
Locride, dove la povertà era maggiore e forte il senso di abbandono da parte
dello Stato, c’era una vicinanza al Pci, che però finì durante secondo
dopoguerra. Da allora, i referenti politici della ’ndrangheta sono stati nella
Dc e nel Psi e, dopo, in Forza Italia».
Facciamo un passo indietro. Che vuol dire che
Duisburg confina con S. Luca?
«Semplice, vuol
dire che dagli anni Sessanta in poi, oltre alla normale emigrazione, la
’ndrangheta ha spostato pezzi di cosche dalla Calabria alle città italiane e
all’estero. E ormai le più importanti famiglie hanno due sedi».
Come Cutro e “Cutro due”, cioè Reggio Emilia?
«Esatto. Ma ciò
accade in tante altre città, in Italia e all’estero. In tal senso Duisburg
confina con S. Luca.»
Si spiega così il fatto che i due soli Consigli
comunali sciolti per infiltrazioni mafiose, fuori dalle cosiddette aree
tradizionali – Bardonecchia, in Piemonte, nel ’95; Nettuno, nel basso Lazio, nel
2005 – è coinvolta la ’ndrangheta?
«È la riprova
della capacità di infiltrazione e di condizionamento dell’organizzazione».
E le sue proiezioni internazionali? Oggi la
’ndrangheta viene riconosciuta come l’organizzazione leader in Europa nel
traffico di cocaina. In quali nazioni è radicata?
«La ’ndrangheta
è presente in tutti i Paesi europei. Ma anche in Australia, Stati Uniti, Canada,
America Latina».
E con le altre mafie, con quelle non italiane,
che tipo di rapporti intrattiene?
«Solo rapporti
finalizzati al traffico di droga. Niente che possa lontanamente somigliare a
quello con cosa nostra di cui si parlava prima».
Nel ’93 un rapporto della Dia sosteneva che il
27 per cento della popolazione calabrese sarebbe in qualche modo coinvolta con
la ’ndrangheta. Una percentuale abnorme, più di un quarto della popolazione. E
poi c’è il fatto che la Calabria, per la sua conformazione, è fatta di Comuni
piccoli e piccolissimi, molti dei quali sotto i mille abitanti. Ciò facilita la
capacità di condizionamento?
«Che significa
“coinvolta”? E poi, come si fa a quantizzare? A me sembra una percentuale
spropositata. Però, al di là delle dispute numeriche, c’è l’altro aspetto che è
fondamentale: la più grande città calabrese è Cosenza, 120mila abitanti, cioè
quanto un quartiere di Palermo. Nei piccoli centri, cioè nella maggior parte dei
Comuni calabresi, basta una decina di mafiosi per esercitare un controllo
fisico, visivo delle persone, per condizionargli la vita».
Come succedeva a Calanna, mille abitanti, dove
il boss locale, Giuseppe Greco, imponeva una sorta di jus primae noctis,
prendendosi tutte le donne che gli piacevano. Greco, in una telefonata
intercettata, si vantava anche di potere controllare come votava ogni cittadino,
di potere “mettere le mani nelle urne”. Avviene così in ogni Comune?
«Be’, il
controllo del voto non è una sua prerogativa e nemmeno della sola ’ndrangheta.
Con la preferenza multipla lo facevano anche i partiti. Ma anche con la singola
preferenza lo si può fare, trovando altri tipi di combinazioni: Mario Rossi,
dottor Mario Rossi, Rossi dottor Mario e così via. E poi c’è la “scheda matta”.
Ci si impossessa di una scheda elettorale, si esprime il voto di preferenza, la
si dà all’elettore, che la deposita nell’urna e riporta la scheda cianca che gli
è stata consegnata nel seggio, in modo che il mafioso possa votarla e
consegnarla a un altro elettore…»
Sembra la sorte dei comunisti di oggi…
Vogliamo fare la storia e non subirla: al lavoro!
Un milione di voti comincia ad essere un carico pesante per un Partito come il
nostro, scrive Benito Mussolini, pubblicata Martedì 02/08/2016 “Il Giornale”.
Bando alle illusioni e parliamoci chiaro, ora che il momento è opportuno. Che il
Partito Socialista abbia condotto una buona battaglia e che i suoi sforzi siano
stati coronati dal più lusinghiero successo, nessuno contesta più. È un fatto.
Sono cifre. Ma... son dolori se il Partito crede o s'illude di aver compiuta
l'opera spazzando via dalla scena politica parecchi rappresentanti della
reazione dernier cri, e i dolori aumenteranno se la elezione di 53 deputati
sembrerà a taluno giustificazione sufficiente per ricadere nell'inerzia
fatalistica che ha seguito sempre ogni agitazione elettorale. Diciamo la verità,
noi, prima degli stessi avversari: un milione di voti comincia ad essere un
carico alquanto pesante per un Partito come il nostro. Noi abbiamo vinto un po'
per virtù nostra, ma moltissimo per la debolezza dei Partiti che ci stavano di
fronte, e per un complesso di circostanze a noi propizie. Sulle quali si potrà -
a tempo opportuno - ragionare. Noi non sappiamo se in un'altra «congiuntura» per
dirla con un tedeschismo, riusciremo a strappare una così brillante vittoria. E
poiché i Partiti si organizzeranno come noi, formando gruppi e federazioni;
poiché la storia - checché si possa dire in contrario - non si ripete, ma
presenta sempre nuove situazioni di fatto e nuovi problemi, è necessario non
abbandonarci ai facili entusiasmi cui seguono immancabilmente le dolorose
sorprese. È necessario agguerrirci. È necessario agguerrire il Partito che è
l'organo delle nostre conquiste politiche. Questo diciamo ai deputati vecchi e
nuovi, i quali hanno dispiegato un'attività veramente encomiabile durante il
periodo elettorale; questo diciamo ai propagandisti - illustri o no - del
Partito che hanno corso in lungo e in largo l'Italia portando la parola del
socialismo dalle città ai borghi, alle campagne; questo diciamo ai quarantamila
inscritti del Partito che leggono, o dovrebbero leggere, le nostre parole. Noi
diciamo che paragonato a ciò che resta da fare, il già fatto è poco. Noi
sappiamo una cosa sola: che la piattaforma elettorale del Partito Socialista ha
trovato quello che si direbbe un ambiente «simpatico», ma niente ci autorizza a
ritenere che questo ambiente sarà lo stesso domani o non sarà invece
indifferente o refrattario. Noi non possiamo fare eccessivo calcolo sulla massa
elettorale e per ragioni intuitive: la nostra milizia è il Partito. Ora,
riflettano bene i socialisti italiani, il pericolo che si delinea è uno solo:
quello, cioè, che il Partito resti schiacciato sotto il pondo inaspettato delle
sue stesse vittorie elettorali. Il caso non è nuovo nella storia e nella vita.
Si può cadere toccando una meta, si può morire nell'atto di dare la vita, si può
essere dei vinti vincendo. Dinanzi a tali eventualità, noi, come si vede, non
indugiamo molto a lanciare il nostro grido d'allarme. Prima del suffragio
universale accadeva spesso di udire tra i socialisti italiani frasi di questo
genere: Ah se noi avessimo un milione di voti!...Ecco: il milione di voti c'è;
e, forse, abbondante. Questa enorme massa elettorale ci ha creduto, ha riposto
fiducia in noi e...aspetta. Ma noi saremo incapaci di realizzare uno solo dei
postulati del nostro programma elettorale, se il Partito non raddoppierà almeno
i suoi contingenti; se i quarantamila inscritti non diventeranno ottanta o
centomila; se questo giornale non circolerà sempre più diffusamente fra le
moltitudini che l'esperimento del 26 ottobre ha lanciato nel girone della vita
politica. Un Partito come il socialista, non può rassegnarsi ad avere
un'influenza meramente elettorale. Prima di tutto perché le elezioni non sono
che un episodio preliminare di una più vasta attività politica; in secondo luogo
perché nella vita dei popoli moderni ci sono avvenimenti dai quali - pena il
suicidio - il Partito non può essere dominato o travolto. Il milione di voti che
noi volevamo toccare e abbiamo toccato, è cagione di legittimo orgoglio, ma è
anche di gravissima preoccupazione e responsabilità. Noi non possiamo più
retrocedere, e nemmeno sostare. Alle prossime elezioni politiche - diciamo
prossime perché è convincimento generale che la nuova legislatura non avrà lunga
vita - se noi non aumenteremo ancora il numero dei voti, gli avversari
ritorneranno a cantarci più noioso e insistente l'elogio funebre. E se i nostri
voti diminuissero che cosa diventerebbero - nel ricordo - i funerali simbolici
che noi abbiamo fatto nei giorni scorsi agli altri? Questi interrogativi ci
dicono tutta la portata e l'«urgenza» del compito che il Partito è chiamato ad
assolvere. Avanzare! questa è la parola d'ordine. Gli uomini moderni vanno in
fretta più che i morti della ballata di Burger e noi socialisti abbiamo più
fretta degli altri. Noi vogliamo vedere trasformarsi sotto ai nostri occhi la
realtà e coll'opera delle nostre mani. Noi vogliamo «fare» la storia e non
subirla. Incidere sulle istituzioni e sugli uomini che ci circondano sempre più
profondo il segno della nostra volontà. Al lavoro! Al lavoro! La strada è aspra
e la meta è lontana. 4 novembre 1913
I PROFESSIONISTI DELL'ANTIMAFIA
Una polemica scatenata dallo scrittore
Leonardo Sciascia, scrive Giulia Grassi. Qualche anno
prima di morire Paolo Borsellino, e tutto il pool antimafia di Palermo, sono
stati coinvolti in una polemica nata da un articolo pubblicato sul "Corriere
della Sera" del 10 gennaio 1987. L'articolo era intitolato "I professionisti
dell'antimafia" e questa era la sua tesi di fondo: in Sicilia il modo migliore
per fare carriera in politica e in magistratura è dichiararsi antimafioso, usare
l'"antimafia come strumento di potere", come mezzo per diventare potenti ed
intoccabili. Era firmato da Leonardo Sciascia, uno scrittore molto famoso per i
suoi libri nei quali aveva parlato della violenza del potere mafioso, come il
bellissimo "Il giorno della civetta". Tra gli esempi di professionisti
dell'antimafia Sciascia citava proprio Paolo Borsellino, che qualche mese prima
era diventato capo della Procura di Marsala al posto di un collega più anziano
di età (evidentemente per la sua maggiore conoscenza del fenomeno mafioso).
Probabilmente Sciascia voleva solo mettere in guardia contro il pericolo che
qualche magistrato o politico disonesto potesse sfruttare la lotta alla mafia
per i suoi interessi personali. Sicuramente lo scrittore era in buona fede ...
ma citare Borsellino come "esempio attuale ed effettuale" di professionismo
mafioso, insinuare il dubbio che il magistrato avesse fatto carriera grazie alla
lotta alla mafia, è stato un errore, sfruttato abilmente dai nemici del pool.
Anche i grandi intellettuali possono sbagliare. Per i 15 giorni successivi i
giornali sono stati occupati da articoli contrari (pochi) e favorevoli (la
maggior parte) allo scritto di Sciascia, che a sua volta ribadiva il suo
pensiero in alcune interviste: "Ieri c'erano vantaggi a fingere d'ignorare che
la mafia esistesse; oggi ci sono vantaggi a proclamare che la mafia esiste e che
bisogna combatterla con tutti i mezzi" (Il Messaggero); il potere fondato sulla
lotta alla mafia "è molto simile, tutto sommato, al potere mafioso e al potere
fascista" (Il Giornale di Sicilia); "In nome dell'antimafia si esercita una
specie di terrorismo, perché chi dissente da certi metodi o da certe cose è
subito accusato di essere un mafioso o un simpatizzante" (Intervista al Tg2 -
secondo canale TV). E Borsellino? Non ha mai replicato a Sciascia, mai. Giuseppe
Ayala, un ex magistrato che ha lavorato con Falcone e Borsellino nel pool di
Palermo, nel suo libro "La guerra dei giusti" (1993) cita una frase di
Borsellino: "La risposta sarà il silenzio. Ho sempre ammirato Sciascia, e
continuerò a farlo". Ma l'amarezza deve essere stata profonda. Un mese dopo
l'assassinio di Falcone, e 23 giorni prima del proprio assassinio, Borsellino
dichiarava: "Giovanni ha cominciato a morire tanto tempo fa. Questo paese,
questo Stato, la magistratura che forse ha più colpe di ogni altro, cominciarono
a farlo morire nel gennaio 1988, quando gli fu negata la guida dell'Ufficio
Istruzione di Palermo. Anzi, forse cominciò a morire l'anno prima: quando
Sciascia sul "Corriere" bollò me e l'amico Leoluca Orlando come professionisti
dell'antimafia" (Palermo, 26 giugno 1992).
“Contro l’Antimafia”.
Matteo Messina Denaro, l’invisibile, è il più potente boss di Cosa nostra ancora
in libertà. È a lui che dalla radio della sua città, Marsala, si rivolge ogni
giorno Giacomo Di Girolamo nella trasmissione Dove sei, Matteo?, ed è a lui che
si rivolge in questo libro: stavolta, però, con un’agguerrita lettera di resa.
Di Girolamo non ha mai avuto paura di schierarsi dalla parte di chi si oppone
alla mafia. Ma adesso è proprio quella parte che gli fa paura. Ha ancora senso
l’antimafia, per come è oggi? Ha avuto grandi meriti, ma a un certo punto è
accaduto qualcosa. Si è ridotta alla reiterazione di riti e mitologie, di gesti
e simboli svuotati di significato. In questo circuito autoreferenziale, che
mette in mostra le sue icone – il prete coraggioso, il giornalista minacciato,
il magistrato scortato – e non aiuta a cogliere le complesse trasformazioni del
fenomeno mafioso, si insinuano impostori e speculatori. Intorno all’antimafia ci
sono piccoli e grandi affari, dai finanziamenti pubblici ai «progetti per la
legalità» alla gestione dei beni confiscati, e accanto ai tanti in buona fede
c’è chi ne approfitta per arricchirsi, per fare carriera o per consolidare il
proprio potere, in nome di un bene supremo che assolve tutto e tutti. Non è più
questione di «professionisti dell’antimafia»: oggi comanda un’oligarchia
dell’antimafia, e chiunque osi metterla in discussione viene accusato di
complicità. Di Girolamo scrive allora a Matteo Messina Denaro. Scrivere al
grande antagonista, al più cattivo dei cattivi, è come guardarsi allo specchio:
ne emerge, riflessa, l’immagine di una generazione disorientata, che assiste
inerme alla sconfitta di un intero movimento, alla banalità seriosa e
inconcludente delle lezioni di legalità a scuola, alle derive di un giornalismo
più impegnato a frequentare le stanze del potere, politico o giudiziario, che a
raccontare il territorio. Contro l’antimafia è un libro iconoclasta, amaro, che
coltiva l’atrocità del dubbio e giunge a una conclusione: per resistere alle
mafie serve ripartire da zero, abbandonando la militanza settaria per
abbracciare gli strumenti della cultura, della complessità, dell’onestà
intellettuale, dell’impegno e della fatica.
Giacomo Di Girolamo, giornalista, si occupa di
criminalità organizzata e corruzione per il portaleTp24.it e per la radio Rmc
101. Collabora con Il Mattino di Sicilia, la Repubblica e Il Sole 24 Ore. È
autore della biografia del boss Matteo Messina Denaro L’invisibile (2010),
di Cosa Grigia (il Saggiatore 2012, finalista al premio Piersanti Mattarella)
e Dormono sulla collina (il Saggiatore 2014). Per le sue inchieste ha vinto nel
2014 il Premiolino.
L’atto d’accusa contro l’antimafia di Di
Girolamo, scrive Antonino Cangemi il 23 febbraio 2016.
La babele dell’antimafia –folta, eterogenea, ambigua, la carovana degli
antimafiosi, e legata a centri di potere talvolta di per sé non cristallini,
tal’altra insospettabili– impone riflessione e indignazione. Una riflessione
indignata ce la offre Giacomo Di Girolamo nel suo ultimo libro, “Contro
l’antimafia”, edito da Il Saggiatore. Giacomo Di Girolamo non è uno qualsiasi.
E’ un giornalista che, da un’emittente del Trapanese, conduce da tempo, senza
tanti compagni di ventura, un monologo dedicato a Matteo Messina Denaro, tuttora
primula rossa di Cosa nostra, di cui pare essere divenuto il numero uno. Lo
segue in tutti i suoi passi, ossessivamente, dalla sua radio. Lo interroga, gli
chiede spiegazioni, lo tallona, lo incalza, ricordandogli le tappe della sua
escalation criminale. D’altra parte, pochi, nel mondo della carta stampata,
conoscono Messina Denaro come Giacomo Di Girolamo, che al boss di Castelvetrano
ha dedicato una biografia, oggi, chissà perché, introvabile, ricca di dettagli e
di particolari, “L’invisibile” (Editori Riuniti, 2010). In quella biografia, Di
Girolamo si rivolgeva al capomafia dandogli del tu, senza alcuna remora. In
“Contro l’antimafia” –che segue altri interessanti saggi, anch’essi editi da Il
Saggiatore, “Cosa grigia”, “Dormono sulla collina, 1969-2014” – Di Girolamo
continua a rivolgersi all’interlocutore di sempre, Matteo Messina Denaro, e
ancora dandogli del tu. Ma questa volta il giornalista spavaldo, aggressivo,
sprezzante, cede il passo –apparentemente- al cronista, vinto dalla malinconia,
che ammette la propria sconfitta. Il cronista che, come tantissimi della sua
generazione, dalle stragi di Falcone e Borsellino, aveva individuato un nemico
terribile, malefico, diabolico –la mafia- e contro di esso aveva speso ogni
energia, e che ora si rende conto che – Matteo Messina Denaro ancora libero e
professionisti dell’antimafia, giorno dopo giorno, smascherati nelle loro
pantomime- Cosa nostra è sempre più salda e il fronte antimafia sempre più
contraddittorio e fumoso. “Contro l’antimafia” è un libro scomodo,
dissacratorio, impertinente – come nello stile di Di Girolamo -, non fa sconti a
nessuno, rivela verità palesi e occulte, punta i riflettori sul panorama,
variegato e non di rado sinistro, dell’antimafia in doppiopetto, col piglio del
giornalismo investigativo e con le lenti di un sociologismo accorto. Le denunce
di Di Girolamo, tuttavia, per quanto accompagnate da un’accorata e dolorosa
autocritica – che rinvia alle osservazioni profetiche di Sciascia- e da un
lancinante e sofferto pessimismo, hanno in sé quella potenza reattiva che, lungi
dall’invitare a demordere, esorta implicitamente, pur nella consapevolezza delle
tante zone grigie dell’antimafia, a duplicare il proprio impegno. Esorta quelli
che ci credono davvero, naturalmente; non altri.
CONTRO L’ANTIMAFIA. Recensione di Nino Fricano. Un
libro rischioso, che provocherà durissime reazioni. Ci saranno tonnellate di
mugugni “privati” contro questo libro, ci saranno incazzature, indignazioni,
imprecazioni. Ci sarà poi una bolgia “pubblica” sui social network, ci saranno
interventi sui giornali, probabilmente fioccheranno querele, e chissà cos’altro
ancora. Ma il rischio maggiore è un altro, argomentano quelli che già hanno
cominciato a scagliarsi contro questo libro (almeno quelli che argomentano,
molti altri insultano e basta). Il rischio maggiore è quello di contribuire a
delegittimare l’antimafia “per principio”, “a prescindere”, “fare di tutta
l’erba un fascio”, “buttare via il bambino con l’acqua sporca”, “il cesto di
mele e le mele marce”, “alimentare la macchina del fango”, e così via di luoghi
comuni.
Non puoi denunciare così, senza concedere
attenuanti, le tante piccole grandi magagne dell’antimafia. Le tante piccole
grandi cose-che-non-vanno nell’antimafia, le sue vanità, i suoi egoismi, le sue
idiozie, le sue vigliaccate, le sue furberie, le sue prese in giro, le sue
arrampicate, i suoi affarismi, i suoi personaggi turpi e disonesti, le sue
truffe allucinanti, incredibili. Roba che cadono le braccia a terra, che c’è da
strapparsi i capelli, sbattersi la testa contro il muro. Non puoi farlo,
dicevamo, perché la gente rischia di generalizzare. Non puoi attaccare così
duramente l’antimafia perché questa rischia di perdere la sua credibilità e
quindi la sua efficacia. Il problema però è che l’antimafia – o forse è meglio
dire “il movimento antimafia”, o meglio ancora “la parte maggioritaria e più
visibile e più arrivista del movimento antimafia” – ci è riuscita da sola, a
perdere la propria credibilità e la propria efficacia. E l’autore lo dimostra
offrendoci lo scorcio giusto, mettendo a fuoco il panorama, riunendo e
collegando – cioè – le ultime notizie, gli ultimi scandali, le ultime oscenità,
le ultime nostre amarissime sconfitte. È un tunnel dell’orrore. Ci sono
dirigenti regionali che gestiscono beni sequestrati con logiche privatistiche e
affaristiche, di sfruttamento e arricchimento personale. Ci sono amministratori
delle aziende sequestrate che se ne fregano della buona gestione, che affamano
il territorio, che fanno fallire le aziende sequestrate, che lasciano in mezzo
alla strada 72mila lavoratori in tutta Italia. Ci sono sindaci e imprenditori
che fanno proclami antimafia e poi vengono beccati a braccetto con i mafiosi. Ci
sono soggetti che cavalcano le intimidazioni subite, vere o presunte, per fare
affari spudoratamente, arrivando perfino a truffare sui finanziamenti ricevuti.
C’è il business del progetto per la legalità. C’è il business del terreno
confiscato. C’è il business della costituzione di parte civile. Ci sono i
professionisti di questo grottesco business: presidi, insegnanti, ragionieri,
avvocati, azzeccagarbugli, faccendieri, traffichini, intrallazzatori. E poi ci
sono le cooperative antimafia, le associazioni antimafia, le manifestazioni
antimafia, i comitati antimafia, i politici antimafia, i giornalisti antimafia,
gli artisti antimafia. C’è l’utilizzo dell’etichetta di antimafia per portare
avanti operazioni poco pulite e senza nessun controllo. C’è l’utilizzo
dell’antimafia come un qualunque altro strumento della lotta politica e
affaristica, e dunque una cosa come un’altra, una cosa qualunque, che può
servire – come tutte le cose qualunque, in questa irrimediabile e irredimibile
terra – a perseguire interessi più o meno leciti. E questi sono i furbi, i
profittatori, che possono essere di grosso calibro e di piccolo calibro,
spostandosi lungo l’asse che va dal semplice accattonaggio da miserabili fino
alla delinquenza vera e propria, la delinquenza da delinquenti, il tutto condito
da una evidente dose di sciacallaggio. Poi però ci sono i cretini, gli utili
idioti. Ci sono anche loro, non mancano mai di questi tempi. Sono quelli che
portano avanti un’antimafia fatta di vuote celebrazioni, manicheismo ottuso,
cori da stadio, retorica, slogan. Nessuno spirito critico, nessun ragionamento,
nessuna intelligenza, nessuna voglia di abbracciare la complessità del reale,
nessun interrogarsi sul reale, nessuna voglia di comprendere il reale. Soltanto
un insieme di dogmi, santini e ritualità. Un campo dove tutto diventa idolo,
icona. E le icone, si sa, sono entità cristallizzate e iperuraniche, astrazioni
incapaci di dialogare con il presente e con il concreto. Le icone sono
soprammobili che si mettono su un ripiano che non dà fastidio a nessuno e sono
destinate a riempirsi di polvere. Le icone sono inutili, e nel campo
dell’antimafia ridurre a icone Falcone e Borsellino, Peppino Impastato e Libero
Grassi, ad esempio, è più che inutile, è dannoso. Dunque, i profittatori e i
cretini. Due facce della medaglia. E la medaglia è il fallimento dell’antimafia.
Una cosa buona avevamo in Italia, verrebbe da dire, e abbiamo rovinato pure
quella. Perché è avvenuto come uno sfasamento tra mafia e antimafia. Un processo
che adesso è giunto a una fase cruciale. Se la mafia, dopo le stragi del ’92/’93
ha cambiato pelle (per l’ennesima volta nella sua storia), si è resa invisibile,
liquida, meno radicata nel territorio, globalizzata e finanziaria, l’antimafia
si è invece istituzionalizzata, è diventata tronfia, vuota e retorica, si è
incancrenita, e molti suoi settori sono finiti in mano alla sconfortante fauna
umana descritta in precedenza: sciacalli, furbi, profittatori, accattoni,
delinquenti, cretini e utili idioti. Una fauna così ingombrante, chiacchierona,
rumorosa – per motivi di interesse o per semplice idiozia – che rischia di
seppellire definitivamente tutti i soggetti e le realtà associative che
nell’antimafia avrebbero invece qualcosa di buono da dire e da fare, energie da
spendere in modo utile, innovazioni e speranza da donare. Questo processo di
sfasamento, di traiettorie inverse e intrecciate tra mafia e antimafia, conduce
al paradosso di un’antimafia che lotta, o meglio finge di lottare, contro una
mafia che non esiste più, con mille distorsioni di conseguenza. Questa la
portata storica di questo libro qui. Un libro amarissimo, terribile. Un libro
personalissimo, uno sfogo di uno che “c’è dentro”, una critica all’antimafia da
parte di uno che fa antimafia e quindi, in qualche modo, anche una sorta di
autocritica, ma anche un documento di rilevanza storica, che fotografa un ben
preciso fenomeno collettivo.
Un libro che non è solo un’inchiesta
giornalistica, però, che non parla soltanto di mafia, politica ed economia, ma
che analizza anche un fenomeno “culturale” con passione e autorevolezza, un
fenomeno che riguarda la semantica e la narrazione dell’antimafia, e più in
generale la violenza e la disonestà intellettuale, la faziosità e
l’intolleranza, la pigrizia e il dilettantismo che cova sotto i dibattiti
pubblici dei giorni nostri. Un libro inoltre che presenta alcune tra le
suggestioni più potenti in cui mi sia imbattuto negli ultimi anni (i Moai
dell’Isola di Pasqua), racconti efficacissimi e strazianti (i dipendenti
licenziati dal gruppo 6Gdo che emergono dal silenzio come fantasmi), pagine –
insomma – di altissima letteratura. L’autore è Giacomo Di Girolamo, classe 1977,
credo il migliore giornalista che ci sia in Sicilia. È uno che da vent’anni,
tutti i giorni, si sporca le mani con l’informazione locale. Ha fondato e
diretto un notiziario online in provincia di Trapani, conduce una trasmissione
in radio (“Dove sei Matteo?”, sulle tracce di Messina Denaro), collabora con
numerose testate tra cui Repubblica e Il Sole 24 Ore, ha scritto libri magnifici
tra cui la prima autobiografia di (di nuovo) Matteo Messina Denaro. È un
giornalista di provincia che non è mai provinciale, ha una visione chiara e
luminosa delle cose, frutto di quasi vent’anni di informazione attenta,
quotidiana, sul territorio. Cronache, interviste, opinioni, inchieste. Il suo
“essere” antimafia è un “fare” antimafia. Il suo fare antimafia, il suo essere
molto probabilmente il più grande esperto di Matteo Messina Denaro in Italia, è
la logica conseguenza della sua quotidiana attività di informazione. È un
giornalista che racconta la mafia e che quindi fa antimafia. E per questo può
permettersi un libro come questo, sull’antimafia, contro l’antimafia. Un libro
rischioso ma anche tremendamente coraggioso. E onesto. E importante. Di
Girolamo, infine, è secondo me un personaggio emblematico anche per altre
ragioni. È uno che vive sulla sua pelle i prezzi da pagare che ci sono per chi
vuole raccontare la realtà che lo circonda in un contesto come quello della
Sicilia e della provincia siciliana. E cioè, come ha scritto una volta su
Facebook: “Ex amici che non ti salutano più, persone che ti odiano, tifosi di
questo o quel politico che ti insultano; querele e citazioni ad ogni piè
sospinto, via via sempre più pretestuose; minacce che arrivano a me, alla
redazione, alle persone a me vicine, telefonate anonime, biglietti con le croci,
incontri ravvicinati”. D’altronde Sciascia lo diceva tanti decenni fa, e le cose
almeno da questo punto di vista non sono cambiate di tanto: “Lo scrittore in
Sicilia è un delatore, un traditore, che racconta cose che l’opinione comune
preferisce restino sotto un silenzio carico di commiserazione”.
Giacomo Di Girolamo il 20 maggio 2014 su
“Facebook". Sono stanco di chi usa l'antimafia per conservare potere o per fare
carriera. Non abbiamo bisogno di un'antimafia un tanto al chilo, fatta di
simboli, di gestione di grandi e piccoli affari in nome del bene supremo che
tutto assolve. Abbiamo bisogno di un'antimafia che semini dubbi, che ponga
ragionamenti, dia contenuti. E siccome mi sono stancato davvero, ho deciso da un
po' di tempo a questa parte che questa cosa l'andrò ripetendo ovunque ci sarà
l'occasione, anche a costo di apparire più stronzo o più pazzo di quello che già
sembro di mio. Non serve a cambiare le teste quadrate, perché le truppe
dell'antimafia sono ben istruite dai leader di turno come una setta di Mamma Ebe
e tutto assorbono senza colpo ferire e rispondendo a tono con qualche frase del
vangelo di Falcone e Borsellino appena c'è un minimo di dissenso rispetto
all'antimafioso pensiero dominante. Però serve, da giornalista e cittadino
libero, ancora una volta, per dare un senso ad un mestiere. Parlate di mafia,
parlatene ovunque, diceva lo stracitato Borsellino (del quale si conoscono i
versetti principali, come Maometto...). Siccome tutti, dalle parti
dell'antimafia, si divertono a completare l'assioma: ah, se Falcone fosse vivo,
oggi..., ah, se Borsellino fosse vivo, oggi...Mi ci metto anch'io. Se Borsellino
fosse vivo oggi, direbbe anche: parlate di antimafia, parlatene ovunque. Ecco
perché lo faccio. E lo ripeto ancora una volta: oggi l'antimafia ha ragione
d'essere se è antimafia di cultura, di saperi, di formazione, di studio, di
analisi, di tutto ciò che richiede attenzione, tempo, fatica.
"Contro l’antimafia". Il nuovo libro di
Giacomo Di Girolamo. Sia maledetta questa luce
derisoria, che si prende gioco di noi: non ve lo meritate tutto questo – sembra
dire – non ve lo meritate. Pubblichiamo il prologo del nuovo libro di Giacomo Di
Girolamo, Contro l’antimafia, edito dal Saggiatore. Qui l’autore ne parla con
Attilio Bolzoni.
Io non ho mai avuto paura. Adesso sì. Sia
maledetto Goethe. Sia maledetto tutto, di quel suo viaggio in Sicilia, dalla
nave che lo portò a Palermo al taccuino su cui prese appunti: «il posto più
stupendo del mondo», «l’unità armonica del cielo con il mare», «la purezza dei
contorni». Siano maledetti tutti i viaggiatori d’Occidente, che hanno parlato di
«capolavoro della natura», «divino museo d’architettura», «nuvola di rosa sorta
dal mare». Siano maledetti i paesaggi da cartolina. Le cartoline, no. Quelle non
c’è bisogno di maledirle, già non esistono più. Siano maledette, però, tutte le
immagini sui social, i paesaggi su Instagram, i gruppi su Facebook del tipo «Noi
viviamo in paradiso». Siano maledetti i tramonti sul mare. Sia maledetta la
bellezza. Sia maledetta la luce nella quale siamo immersi, che sembra una
condanna. Sia maledetta questa luce derisoria, che si prende gioco di noi: non
ve lo meritate tutto questo – sembra dire – non ve lo meritate. Sia maledetto
tu, Matteo Messina Denaro. Ancora una volta: che tu sia maledetto. Perché tu e i
mafiosi come te ci avete condannati a non poter godere di tutto questo, a non
meritare davvero il paradiso nel quale viviamo. Troppa violenza, sotto questo
cielo. Troppo dolore. A che serve avere il paradiso, se ogni giorno va in scena
l’inferno? Sia maledetto Goethe. Non avrebbe dovuto scriverci il diario di
viaggio, in Sicilia, ma ambientare la tragica storia del Dottor Faust, in questo
proscenio di nebbie e di vapori invisibili. Tu sei il diavolo, Matteo, a te
abbiamo venduto l’anima. Sia maledetta la mafia, che tu rappresenti come ultimo
padrino ancora in circolazione, latitante dal 1993. Sia maledetta Cosa nostra,
Totò Riina e chi ne ha eseguito gli ordini di morte, i Corleonesi e la tua
famiglia, che dal piccolo borgo di Castelvetrano ha costruito un impero fondato
sul sangue, che mi fa vergognare di essere tuo conterraneo. Io non ho paura di
te, Matteo. Ti conosco ormai come un fratello maggiore. So tutto di te, tranne
dove sei. Non mi ha mai fatto paura raccontare la tua violenza, gli omicidi,
quelli commessi dalla tua gente, i vostri affari sporchi, dalle estorsioni agli
appalti truccati… Questo di mestiere faccio: raccontare quello che vedo, e anche
se sei invisibile ti vedo e ti vedo sempre, Matteo. Mi guardo intorno e scrivo.
Guardo le persone negli occhi e poi racconto il loro sguardo alla radio. Seguo i
tuoi passi e scrivo. E sorrido. Sorrido per prendermi gioco della luce che non
mi merito, sorrido perché penso di essere anche io un tassello della tua storia;
anche io faccio parte del tuo indotto. Come le famiglie dei carcerati: senza la
distribuzione dei soldi delle estorsioni, come camperebbero? Per me vale un po’
la stessa cosa: senza di te, Matteo, di cosa mi occuperei? Io non ho mai avuto
paura. Adesso sì. Senti, mi dicono, perché non fai una nuova edizione di quel
tuo libro su Matteo Messina Denaro? Va ancora alla grande, lo leggono i
ragazzini, lo adottano nelle scuole. Che coraggio che hai avuto, a scrivere quel
libro, tu che ti rivolgi al boss, questa conversazione senza peli sulla lingua.
Tanta ferocia messa nero su bianco. E allora perché non lo riprendi, questo bel
libro, lo aggiorni, ci aggiungi altre quattro-cinque cose? Già, perché non lo
faccio, Matteo? Quante cose so di te che ancora non ho scritto? Io sono quello
che ti chiama ogni giorno, per nome, alla radio. C’è il jingle che fa «Dove sei,
Matteo?», e poi la mia voce che dà un indizio, a volte un fatto di cronaca, a
volte uno scoop, a volte un modo un po’ paraculo di arrivare comunque a te
(«Oggi comincia la scuola, e allora perché non ricordiamo gli studi di Matteo
Messina Denaro…»). La nostra conversazione non si è mai interrotta, Matteo,
continua ogni giorno. Solo che non ha più senso parlare di te, della tua
stramaledettissima vita criminale. Qui voglio parlare d’altro. Della mia paura.
E ho bisogno di capire. Ho bisogno di parlarti di quello che succede su un
fronte che non è il tuo, in quella che chiamano antimafia. Di cosa è diventata
la lotta alla mafia oggi, quali mostri ha generato, quali storture si nascondono
sotto l’ombrello della legalità. Ti scrivo per raccontarti questa mia paura: che
la parte che ho sempre creduto giusta alla fine si sia trasformata in
qualcos’altro, un luogo di compromessi al ribasso, di piccole e grandi miserie,
di accordi nell’ombra per spartirsi soldi e potere. E a volte mi sembra come una
piccola mafia. Ho sempre lottato da una parte. Sono nato un sabato di maggio del
1992. Da allora ho sempre lottato da una parte. E adesso è proprio quella parte
che mi fa paura. Ti scrivo per sapere magari da te, che sei il male, chi sono i
buoni, dove sono i buoni. E per capire come mai, in questa fogna del potere che
è la mia terra, quelli che dovrebbero essere i buoni, perché tali si proclamano,
perché mi hanno insegnato così, perché da qualche parte sta scritto che è così,
alla fine, sembrano assomigliarti davvero tanto, Matteo. Che differenza c’è tra
la legalità e questa pantomima della legalità che abbiamo messo in scena? Devo
rifare i conti con tutto. Prima di tutto con me stesso. I dannati siamo noi. Mi
sento come un vampiro. Scappo dalla luce, evito gli specchi. Ho paura di
vedermi, di non riconoscermi più. E allora questa è una lettera di resa. Tu hai
vinto, Matteo. E non solo per la sfrontatezza della tua latitanza o per il nuovo
patto criminale che hai orchestrato, e che oggi coinvolge interi settori della
classe dirigente e della borghesia «impegnata» del nostro paese. Hai vinto
perché, più o meno inconsapevolmente, hai fatto in modo che nasca un senso di
nausea ogni volta che si parla di antimafia, il tarlo del sospetto: dov’è la
fottuta? Dove i tradimenti, i rospi da ingoiare, in nome di «supreme ragioni»?
Hai vinto per questo, Matteo, perché abbiamo fatto dell’Italia-Sicilia, e della
Sicilia, un pantano. Perché in tanti ti hanno venduto l’anima, pur di ottenere
un brandello di potere; ma ne conosco molti – più bestie di qualunque bestia –
che te l’hanno addirittura regalata. E sempre più spesso non me li trovo di
fronte, me li trovo accanto. Sia maledetta la mafia. Sia maledetta l’antimafia.
Sia maledetto anche io.
Giampiero Mughini per Dagospia il 5 giugno 2016.
Caro Dago, sarà perché non ho una grande opinione di tutto quanto attiene alla
produzione editoriale fatta all’insegna dell’ “antimafia”, una vera e propria
industria con le sue star e i suoi professionisti e i suoi occupati a pieno
tempo, fatto è che appena l’ho visto citato su “Il”, il supplemento mensile de
“Il Sole 24 ore” diretto da Christian Rocca, mi sono precipitato a leggere
questo ultimo libro di Giacomo Di Girolamo (edito dal Saggiatore) che ha per
titolo “Contro l’antimafia”. Un titolo leccornia per le mie orecchie. Un libro
che sto leggendo con molto piacere e curiosità. Non conosco di persona Di
Girolamo, che ha poco meno di quarant’anni, vive a Marsala e di mestiere fa il
giornalista, il mestiere di chi va a vedere di persona, e cerca i dati e li
mette assieme, e incontra le persone e le interroga con le domande giuste. A
Marsala, in Sicilia, dove la mafia non è un’astrazione letteraria ed è di mafia
che Di Girolamo si occupa da free lance. Lavora alla radio Rmc101, collabora ad
alcuni quotidiani. Se capisco bene è uno che lavora alla maniera di Giancarlo
Siani, il giornalista napoletano che si suicidò da quanto si reputava inerme
nella sua lotta solitaria contro la camorra; alla maniera di Alessandro Bozzo,
un giovane giornalista calabrese che si occupava di criminalità e che si suicidò
nel 2013; alla maniera di Giuseppe Impastato macellato dalla mafia siciliana
come ormai tutti voi sapete. Da quel che leggo Di Girolamo ne sa benissimo di
mafia, e soprattutto di Matteo Messina Denaro, l’imprendibile primula rossa
della mafia siciliana. Su di lui aveva scritto nel 2010 un libro pubblicato
dagli Editori Riuniti che venne ristampato più volte e di cui non gli hanno mai
pagato una sola copia. Per dire della sua vita a Marsala, i portinai del palazzo
dove abita non lo salutano più da quando hanno saputo che Di Girolamo riceve
continuamente minacce epistolari dai mafiosi. Non essendo una star
dell’“antimafia” mi pare di capire che la vita professionale dell’ottimo Di
Girolamo sia grama. A un quotidiano a tiratura nazionale cui aveva offerto la
sua collaborazione, gli hanno risposto che gli avrebbero pagato un articolo
lungo 11 euro e un articolo breve 6 euro. Da quanto leggo nella redazione di Rmc
101 dove Di Girolamo va tutti i giorni non c’è protezione alcuna, e chiunque
potrebbe salir su in qualsiasi momento del giorno a fare quello che hanno fatto
a “Charlie Hebdo”. Non mi pare, a meno che non abbia letto male, che Di Girolamo
abbia la benché minima scorta. E perché mai del resto? Mica è una star,
un’icona, un celebrato eroe televisivo dell’ “antimafia” 24 ore su 24? E adesso
continuo a leggere il suo bel libro. Giampiero Mughini.
Senza dimenticare i misteri d'Italia.
4 agosto 1974: la strage
del treno Italicus. Italicus: segreto di Stato? Fu apposto nel 1982, ma
tolto nel 1985.
Nell’anniversario della strage del treno si torna a parlare delle norme che
tolgono il segreto di Stato. In realtà la lenta desecretazione incide poco sulla
ricerca della verità, scrive Valeria Palumbo il 4 agosto 2016 su “Il Corriere
della Sera.” Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974 il treno espresso 1486
“Italicus” stava viaggiando da Roma a Monaco di Baviera. Alle ore 1.23 mentre
attraversava la galleria di San Benedetto Val di Sambro, in provincia di
Bologna, una bomba ad alto potenziale esplose nella quinta carrozza. I morti
furono 12, i feriti 44. Tra le vittime anche un giovane ferroviere di 24 anni,
Silver Sirotti, che era sopravvissuto alla bomba, ma morì cercando di salvare i
passeggeri dal terribile rogo che si era sviluppato. A Sirotti, già medaglia
d’oro al valor civile, il 4 agosto 2016, è stato intitolato un parco a Forlì, la
sua città (in via Ribolle): il sindaco e i familiari hanno partecipato alla
cerimonia commemorativa. I colpevoli della strage non sono stati mai
individuati, ma la Commissione parlamentare sulla loggia P2 scrisse negli atti
che: «La strage dell’Italicus è ascrivibile ad un organizzazione terroristica di
ispirazione neofascista o neonazista operante in Toscana»; che «la loggia P2 è
quindi gravemente coinvolta nella strage dell’Italicus e può ritenersene
addirittura responsabile in termini non giudiziari ma storico-politici quale
essenziale retroterra economico, organizzativo e morale». Il processo si
concluse con l’assoluzione generale di tutti gli imputati. Ma soprattutto, a
differenza di altre stragi (con cui condivide piste, depistaggi e inchieste
infinite e mai conclusive), per quella dell’Italicus fu effettivamente posto il
segreto di Stato: a proposito di Claudia Ajello, che fu sentita parlare della
strage da una tabaccaia, e che lavorava per il Sid, l’allora servizio segreto
italiano. Fu rinviata a giudizio per falsa testimonianza, prima condannata e poi
assolta. Ma ciò che interessa è che l’informativa chiesta dal tribunale di
Bologna ai Servizi segreti conteneva alcuni omissis. Il 14 maggio 1982 il
tribunale chiese una copia integrale del testo; Nino Lugaresi, allora capo del
Sismi (che nel 1977 aveva sostituito il Sid), rispose che le parti mancanti
erano coperte dal segreto di Stato. La questione fu girata all’allora presidente
del Consiglio, il repubblicano Giovanni Spadolini, che, in settembre, confermò
il segreto. Nel 1985, però, come annunziò il Corriere della Sera in prima pagina
il 5 febbraio (e richiamo in quarta), il premier Bettino Craxi fece togliere il
segreto sugli omissis per l’Italicus e per Piazza Fontana. Emerse che l’Ajello
era infiltrata negli ambienti degli esuli greci: proprio nel 1974, a seguito
della guerra per la questione di Cipro, cadde la giunta dei colonnelli greci,
che, come è emerso più volte, interessavano molto i nostri servizi segreti.
Questo però risultò ininfluente per la strage dell’Italicus e la faccenda finì
lì. Quindi oggi non dovrebbero esistere altri documenti inediti sull’attentato
al treno, oscurati dal segreto di Stato. In realtà la relativa inutilità della
rimozione anticipata del segreto di Stato, voluta dal premier Mateo Renzi nella
primavera del 2014, era già stata sottolineata allora. Il segreto non era già
opponibile ai magistrati sui fatti di strage, di mafia e di eversione
dell’ordine democratico. Con la legge 124 del 2007, che segnava l’ennesima
riforma dei servizi segreti, si stabiliva che il segreto sarebbe stato a tempo e
ci sarebbe stata un progressivo slittamento dei livelli di classificazione
(segretissimo-segreto-riservatissimo-riservato). In realtà non sono mai stati
completati i regolamenti attuativi. Fu questo che, nel 2014, gli esperti
chiesero al premier, oltre alla pubblicità di dove siano gli archivi.
Italicus: una strage, un
treno, tanti binari,
scrivono Paolo Rastelli e Silvia Morosi su “Il Corriere della Sera” tratto da
“Poche Storie” il 4 agosto 2016. Agosto. Improvviso si sente un odore di brace.
Qualcosa che brucia nel sangue e non ti lascia in pace, un pugno di rabbia che
ha il suono tremendo di un vecchio boato: qualcosa che urla, che esplode,
qualcosa che crolla. Un treno è saltato (Claudio Lolli, “Agosto”, 1976). Attorno
all’una di notte del 4 agosto 1974, all’uscita dalla galleria degli Appennini,
nei pressi della stazione di San Benedetto Val di Sambro (Bologna), un ordigno
ad alto potenziale esplode nella quinta vettura del treno Espresso 1486
Italicus, diretto a Monaco di Baviera. Il punto, vale la pena ricordarlo, è lo
stesso dove a distanza di dieci anni, il 23 dicembre 1984, si verificherà
la strage del Rapido 904 o strage di Natale, ai danni del rapido proveniente
da Napoli e diretto a Milano. L’attentato dell’Italicus, che provoca la morte di
dodici viaggiatori e il ferimento di circa 50 persone (se la bomba fosse esplosa
in galleria, la strage sarebbe stata ben peggiore), viene rivendicato con un
volantino nel quale si legge: «Abbiamo voluto dimostrare alla nazione che siamo
in grado di mettere le bombe dove vogliamo, in qualsiasi luogo, dove e come ci
pare […] seppelliremo la democrazia sotto una montagna di morti». Una delle
vittime, Silver Sirotti, ferroviere 25enne, era uscito incolume dall’esplosione,
ma imbracciò un estintore e risalì sulla carrozza devastata salvando molte vite,
prima di essere sopraffatto da fiamme e fumo. Racconta un testimone della
strage: «Il vagone dilaniato dall’esplosione sembra friggere, gli spruzzi degli
schiumogeni vi rimbalzano su. Su tutta la zona aleggia l’odore dolciastro e
nauseabondo della morte». I due agenti di polizia che hanno assistito alla
sciagura raccontano: «Improvvisamente il tunnel da cui doveva sbucare il treno
si è illuminato a giorno, la montagna ha tremato, poi è arrivato un boato
assordante. Il convoglio, per forza di inerzia, è arrivato fin davanti a noi. Le
fiamme erano altissime e abbaglianti. Nella vettura incendiata c’era gente che
si muoveva. Vedevamo le loro sagome e le loro espressioni terrorizzate, ma non
potevamo fare niente poiché le lamiere esterne erano incandescenti. Dentro
doveva già esserci una temperatura da forno crematorio. ‘Mettetevi in salvo’,
abbiamo gridato, senza renderci conto che si trattava di un suggerimento
ridicolo data la situazione. Qualcuno si è buttato dal finestrino con gli abiti
in fiamme. Sembravano torce. Ritto al centro della vettura un ferroviere, la
pelle nera cosparsa di orribili macchie rosse, cercava di spostare qualcosa.
Sotto doveva esserci una persona impigliata. ‘Vieni via da lì’, gli abbiamo
gridato, ma proprio in quel momento una vampata lo ha investito facendolo cadere
accartocciato al suolo» (da “Gli anni del terrorismo” di Giorgio Bocca). Il 1974
è l’anno che molti storici identificano con l’inizio dei cosiddetti «anni di
piombo», teatro, purtroppo, di omicidi mirati, attentati, stragi. Da Pasolini, a
Moro, da Piazza della Loggia alla Stazione di Bologna. I processi instauratisi a
seguito della strage sono stati caratterizzati da esiti diversi. Gli imputati,
appartenenti a gruppi dell’estremismo di destra aretino, vengono dapprima
assolti per insufficienza di prove, poi condannati in grado di appello e,
infine, definitivamente assolti nel 1993. Uno degli imputati, Mario Tuti, si
rende peraltro autore – durante le indagini sulla strage – degli omicidi del
brigadiere Leonardo Falco e dell’appuntato Giovanni Ceravolo (che stavano
procedendo a perquisizione nella sua casa) nonché, dopo l’arresto per tali
delitti, dell’omicidio di uno degli imputati che in primo grado erano stati
condannati per la strage di piazza della Loggia a Brescia, e che veniva ritenuto
disposto a collaborare. Secondo la Relazione che il ministro degli Interni Paolo
Emilio Taviani tenne durante la seduta parlamentare di lunedì, 5 agosto 1974: I
primi rilievi tecnici eseguiti dal personale della direzione di artiglieria e
dai vigili del fuoco, basati anche sul ritrovamento di un fondo di sveglia con
applicati due contatti, lasciano supporre che si sia trattato di un ordigno a
tempo, caricato con notevole dose (tra i tre e i quattro chilogrammi) di
tritolo. La Cassazione, pur confermando l’assoluzione degli estremisti di Arezzo
per la strage sul treno Italicus, ha peraltro stabilito che l’area alla quale
poteva essere fatta risalire la matrice degli attentati era «da identificare in
quella di gruppi eversivi della destra neofascista». A simile conclusione era
pervenuta anche la relazione di maggioranza della Commissione parlamentare
d’inchiesta sulla loggia massonica “Propaganda 2″ (più nota come P2), richiamata
anche in elaborati della Commissione parlamentare di inchiesta sulle stragi. In
mezzo a tante supposte verità e spiegazioni, negli anni se ne è fatta avanti una
dai tratti oscuri. La figlia di Aldo Moro (all’epoca Ministro degli Esteri del
Governo Rumor), Maria Fidia Moro, ha detto che era il padre il vero obiettivo
dell’attentato all’Italicus. Aldo Moro, infatti, era solito recarsi in
villeggiatura a Bellamonte, in Val di Fiemme e pare avesse scelto proprio quel
treno per recarvisi. Salito sul treno alla stazione Termini, venne fatto
scendere da alcuni funzionari del Ministero, suoi collaboratori, a causa di
alcune carte che avrebbe dovuto firmare. Ci misero un po’ e gli fecero perdere
il treno. Lo scorso 22 aprile, il Governo Renzi ha tolto il segreto di Stato su
tutte le stragi degli anni ’70 e ’80, Italicus compresa.
27 GIUGNO 1980. Ustica.
«Quella notte c’era una guerra. Chiedete alla Nato», scrive
Giulia Merlo il 30 luglio 2016 su "Il Dubbio”. Quei fatti sono coperti dal
segreto militare e ciò significa che, se gli ufficiali rivelassero ciò che è
successo rischierebbero 23 anni di carcere. Sono passati 36 anni dalla notte di
venerdì 27 giugno 1980, in cui l’aereo di linea DC-9 della compagnia italiana
Itavia esplose e si inabissò nel braccio di mare tra le isole di Ustica e Ponza,
nel mar Tirreno. Nel disastro persero la vita tutti e 81 i passeggeri, sulle
cause della strage, invece, nessun tribunale ha ancora accertato la verità. Nel
corso degli anni, le teorie più dibattute sono quella di un missile stranieri,
contrapposta a quella dell’attentato terroristico, con un ordigno esplosivo
piazzato nella toilette. Secondo la prima tesi, ad abbattere il DC-9 sarebbe
stata una testata francese, destinata ad abbattere un aereo libico con a bordo
Gheddafi. La seconda ricostruzione, invece, è quella avvalorata dai fantomatici
documenti cui il senatore Carlo Giovanardi ha fatto più volte riferimento. Il
giornalista Andrea Purgatori, che in quegli anni era inviato per il Corriere
della Sera e che ha pubblicato numerose inchieste sulla strage, smentisce in
modo secco la decisività di questo dossier».
Proviamo a fare chiarezza su queste carte
coperte dal segreto di Stato?
«Partiamo da un
dato incontrovertibile: sulla strage di Ustica non c’è mai stato il segreto di
Stato. Quei fatti sono coperti dal segreto militare e ciò significa che, se gli
ufficiali rivelassero ciò che è successo quella notte, rischierebbero 23 anni di
carcere. Nei documenti che ha visto Giovanardi non c’è nulla che possa davvero
chiarire cosa è successo».
E quindi lei cosa pensa che contengono?
«Probabilmente
si tratta di dossier che ricostruiscono i rapporti opachi intercorsi in quegli
anni tra l’Italia e la Libia, ma non sarebbe certo di una novità. Io penso che
quelle carte siano più importanti per capire cosa è successo alla stazione di
Bologna poco più di un mese dopo, sempre nel 1980».
Lei ha sempre sconfessato la tesi della bomba
nella toilette. Come mai?
«Non sono io a
sconfessarla, l’ordinanza di rinvio a giudizio del 1999 parla di aereo «esploso
in scenario di guerra aerea». Inoltre le perizie a sostegno dell’ipotesi della
bomba sono state scartate perchè i periti sono stati dichiarati infedeli dal
tribunale, per connivenze con i periti dei generali coinvolti».
La pista della presenza di caccia stranieri,
invece?
«Che quella
notte nei cieli italiani volassero aerei non identificati è stato confermato
dalla Nato. Attualmente non esiste una sentenza su quella strage, perchè
l’inchiesta è ancora in corso. In sede civile, invece, la Cassazione ha
condannato nel 2015 i ministeri dei Trasporti e della Difesa al risarcimento dei
danni, per responsabilità nell’«abbattimento» del DC-9 e - cito testualmente -
ha definito l’ipotesi del missile come causa «congruamente provata»».
C’è chi obietta che gli alti ufficiali
coinvolti sono stati tutti assolti nel 2006...
«Attenzione,
sono stati assolti in Cassazione dalla condanna per depistaggio, non nel
processo sulle cause della strage, tuttora in corso».
2 AGOSTO 1980. Bologna, il buco nero
della strage alla stazione. 36 anni dopo, Bologna si
prepara ad accogliere i famigliari delle vittime e le commemorazioni. Per non
dimenticare l'atto terroristico che provocò 85 vittime. La dinamica e i
mandanti, nonostante i processi e le condanne, non sono mai stati chiariti,
scrive Michele Sasso l'1 agosto 2016 su “L’Espresso”. La più grande strage
italiana in tempo di pace. Ottantacinque morti, più di duecento feriti. Il 2
agosto 1980, un giorno d’estate di un Paese che esiste solo nella memoria, è
diventato un tutt’uno con la strage di Bologna. È un sabato quel 2 agosto di 36
anni fa. Le ferie estive che svuotano le città del Nord sono appena iniziate.
Chi ha scelto il treno deve passare necessariamente per Bologna, scalo-cerniera
per raggiungere l’Adriatico o puntare verso Roma. La stazione è affollatissima
dalle prime ore del mattino. I voli low cost arriveranno sono trent’anni
dopo. Dopo la bomba alla stazione, che provocò 85 morti, il nostro settimanale
preparò un numero speciale e mise in copertina la riproduzione di un quadro
di Renato Guttuso, realizzato apposta per l'occasione. Guttuso dette all'opera
lo stesso titolo dell'incisione di Francisco Goya Il sonno della ragione genera
mostri ed aggiunse la data della strage, 2 agosto 1980, unico riferimento al
fatto specifico, vicino alla firma dell'autore. La tavola originale è esposta
nel Museo Guttuso. Raffigura un mostro con sembianze da uccello e corpo di uomo,
denti aguzzi, occhi sbarrati e di fuoco, che tiene un pugnale nella mano destra
e una bomba a mano nella sinistra, e colpisce alcuni corpi morti o morenti,
sopra i quali sta a cavalcioni Alle 10 e 25 però il tempo si ferma: 23 chili di
tritolo esplodono nella sala d’aspetto di seconda classe della stazione
ferroviaria. Le lancette del grande orologio, ancora oggi, segnano quel tempo e
quella stagione di morte e misteri. Un boato, sentito in ogni angolo della la
città, squarcia l'aria. Crolla l'ala sinistra dell'edificio: della sala
d'aspetto di seconda classe, del ristorante, degli uffici del primo piano non
resta più nulla. Una valanga di macerie si abbatte anche sul
treno Ancona-Basilea, fermo sul primo binario. Pochi interminabili istanti:
uomini, donne e bambini restano schiacciati. La polvere e il sangue si mischiano
allo stupore, alla disperazione e alla rabbia. Tanta rabbia per quell’attentato
così mostruoso e vile che prende di mira turisti, pendolari, ferrovieri. Perché
nessuno anche in quei primi istanti ha mai dubitato sulla matrice terroristica
della strage: l'odore dell'esplosivo era inconfondibile. Cominciò quel giorno
una delle indagini più difficili della storia giudiziaria italiana. Un iter che
ha portato a cinque gradi di giudizio, alla condanna all'ergastolo degli ex
Nar Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, e a quella a trent'anni di Luigi
Ciavardini. Con un corollario di smentite, depistaggi e disinformazione. Resta
la verità giudiziaria della pista neofascista e la strategia della tensione ma
rimangono senza nomi i mandanti. I responsabili dei depistaggi, invece, come
stabilito dai processi, sono Licio Gelli, P2, e gli ex 007 del Sismi Francesco
Pazienza, Pietro Musumeci, Giuseppe Belmonte. Il giorno dei funerali, il 6
agosto, «non era possibile determinare quante persone fossero presenti», come
scrisse Torquato Secci, che quel giorno perse il figlio e poi diventò il
presidente dell’associazione tra i familiari delle vittime della strage. Non
tutte le vittime ebbero, però, il funerale di Stato: solo sette le bare presenti
in chiesa in mezzo alle quali camminò il presidente della Repubblica Sandro
Pertini, giunto insieme a Francesco Cossiga, presidente del Consiglio dei
ministri. Fuori dalla chiesa, la gente in piazza iniziava a contestare le
autorità. Solo Pertini e il sindaco di Bologna, Zangheri, ricevettero degli
applausi. Ancora prima dei funerali si svolsero manifestazioni in Piazza
Maggiore a testimonianza delle immediate reazioni della città. Un moto di
indignazione e dolore scosse l’intero Paese. L'Espresso uscì la settimana
successiva con un numero speciale: in copertina un quadro a cui Renato Guttuso
ha dato lo stesso titolo che Francisco Goya aveva scelto per uno dei suoi 16
Capricci: «Il sonno della ragione genera mostri». Trentasei anni dopo, con
l’eredità di ombre, depistaggi e la strategia della tensione per controllare il
Paese, si rinnova il ricordo collettivo e personale della strage. Bologna si
prepara a rinnovare l’impegno con la “giornata in memoria delle vittime di tutte
le stragi”, organizzata dall’associazione dei familiari delle vittime del 2
agosto che tenne viva la memoria e la spinta civile durante l’intero processo.
Il grande vecchio,
scrive Gianni Barbacetto il 15 novembre 2009. Sono passati 20 dalla caduta del
muro di Berlino. A breve saranno 40 anni dalla bomba alla Banca
dell'Agricoltura, a Piazza Fontana a Milano. In questi giorni dove si è
celebrata la caduta del muro (e del regime comunista), mi chiedo quanti siano
ancora interessati a conoscere la storia oscura del nostro paese. A dare una
risposta ai tanti perché degli anni della strategia della tensione. Perché
quelle morti, perché quelle bombe. Quale era la strategia che perseguivano,
queste persone? Il libro di Barbacetto, che usa la metafora ancora attuale del
"Grande vecchio" dà una risposta, a queste domande. “Ci avete sconfitto, ma oggi
sappiamo chi siete” dice l'ex giudice che indagò sulla strage alla Stazione di
Bologna Libero Mancuso “e andremo in giro a dire i vostri nomi a chiunque ce li
chieda”. Compito degli storici o di quelli come me, con la passione per la
storia, col vizio di voler coltivare la memoria di ciò che è stato è ricordare.
E le pagine del libro, che mettono insieme i fatti di questa guerra che si è
consumata, senza che nessuno (o quasi) se ne sia preso la colpa, storicamente e
giuridicamente, hanno appunto questo fine: dare la parola ai magistrati che si
sono occupati di queste inchieste. Sono loro, una volta tanto, a raccontare una
storia di di attentati, stragi e bombe, e delle difficoltà che hanno dovuto
affrontare: omertà, depistaggi e veri e propri attacchi sia da parte degli
imputati (direttamente o tramite giornali “amici”), sia all'interno dello stato
(come nel caso dell'ex presidente Cossiga, nella sua guerra personale contro il
CSM). Per la strage di Piazza Fontana, i ricordi del giudice istruttore
Giancarlo Stiz e del pm Pietro Calogero, che seguirono il filone Veneto delle
indagini: i neofascisti di Ordine Nuovo Franco Freda, Giavanni Ventura, Carlo
Maria Maggi, e Pino Rauti (esponente del MSI, tirato in ballo nell'inchiesta
dalle confessioni del bidello Marco Pozzan) e Delfo Zorzi. Indagini riprese poi
a Milano dal giudice istruttore Gerardo D'Ambrosio e dal pm Emilio Alessandrini:
i primi a intravedere la pista nera sulla strage, mentre in Italia si sbatteva
il mostro in prima pagina (l'anarchico Pietro Valpreda e il "suicida reo
confesso" Giuseppe Pinelli). E in mezzo i servizi che invece che aiutare
l'indagine, si occupavano di esfiltrare dei testimoni: Pozzam, lo stesso agente
Guido Giannettini. Processo scippato ai giudici (una costante in tante altre
inchieste sull'eversione nera, in Italia) e spostata dalla Cassazione a Palermo.
La strage di Piazza della Loggia a Brescia: la bomba esplosa durante il comizio
antifascista il 28 maggio 1974. Raccontata attraverso il lavoro dei primi
giudici: Domenico Vino e Francesco Trovato; inchiesta riaperta poi dal g.i.
Francesco Zorzi, sulle confessioni del pentito Sergio Latini e Guido Izzo. Fra
tutti gli episodi raccontati, è l'unico ad avere un procedimento ancora
aperto: il processo a Brescia iniziato nel novembre 2008 ha portato a giudizio
tra gli altri, un ex politico come Pino Rauti e un generale dei carabinieri,
Francesco Delfino. L'inchiesta di Padova sulla Rosa dei venti del giudice
istruttore Giovanni Tamburino, che portò alla scoperta di questa organizzazione
con finalità eversive che coinvolgeva industriali, ex fascisti, vertici militari
(il colonnello dell'esercito Amos Spiazzi) e vertici dei servizi (il generale
del Sid Vito Miceli). L'ultimo filone di indagini su Piazza Fontana, portato
avanti dal giudice istruttore Guido Salvini a fine anni 80, che si è basato
sugli archivi ritrovati in via Bligny (gli archivi di Avanguardia Operaia che
contenevano dossier anche sul terrorismo nero, oltre che dossier sulle Br), le
rivelazioni del pentito Nico Azzi e dell'artificiere di Ordine Nuovo Carlo
Digilio, sul lavoro del capitano dei Ros Massimo Giraudo. Un lavoro che ha
permesso una rilettura degli anni del golpe, sempre ventilato, mai attuato, "il
golpe permanente". Il golpe Borghese della notte della Madonna del 1970, al
golpe bianco di Edgardo Sogno nella primavera del 1974. E prima ancora il
“tintinnar di sciabole" del Piano Solo. Un lavoro che permise di rileggere
episodi di cronaca, attentati dell'anno nero che fu il 1973. "Alla fine e
malgrado tutto, ribadisce Salvini, «un preciso giudizio si è radicato comunque
nelle carte dei processi. La strage di piazza Fontana non è un mistero senza
padri, paradigma dell’insondabile o, peggio, evento attribuibile a piacimento a
chiunque, che può essere dipinto con qualsiasi colore se ciò serve per qualche
contingente polemica politica. La strage fu opera della destra eversiva, anello
finale di una serie di cerchi concentrici uniti – come disse nel 1995 alla
Commissione stragi Corrado Guerzoni, stretto collaboratore di Aldo Moro – se non
da un progetto, almeno da un clima comune». «La giustizia vuole più dolore che
collera» scriveva Hannah Arendt nel 1961, all’apertura del processo al nazista
Adolf Eichmann a Gerusalemme. Alla chiusura dei processi per le stragi, la
banalità del male si presenta sotto forma di tentazione a dimenticare per sempre
una vicenda con tanti morti, un’insanabile ferita alla democrazia che ha
colpevoli, ma non condannati. La verità, nella sua interezza, è affidata ora
agli storici. O consegnata ai capricci della memoria: che custodisce i ricordi
nel tempo dell’indignazione, e poi li abbandona nel tempo della smemoratezza."
La bomba alla Questura nel 1973.
L'inchiesta portata avanti dal giudice istruttore Antonio Lombardi sulla bomba
alla Questura di Milano: in particolare, è questa vicenda svela bene quale fosse
il disegno dietro tutti gli episodi stragistici. Ovvero addossare tutta la colpa
della strage sulla sinistra: Gianfranco Bertoli, con un passato da informatore
del Sifar e poi del Sid, doveva recitare la parte dell'anarchico solitario che
uccide persone inermi (e il ministro Rumor, reo secondo Ordine Nuovo che aveva
organizzato il teatro, di aver avviato l'iter per il loro scioglimento).
Le bombe sui treni in Italia centrale: l'Italicus (4
agosto 1974) e gli altri attentati (il fallito attentato a Vaiano, ad es.),
avvenuti nella primavera estate del 1974, per mano dei neofascisti di Ordine
Nero: i quattro colpi grossi (assieme alla bomba a Brescia) che avrebbero dovuto
preparare il terreno l'ennesima reazione forte dello stato. Reazione che, come
nel 1969, non avvenne, come non ci fu nemmeno il golpe solo minacciato dell'ex
partigiano bianco Edgardo Sogno, su cui indagò il giudice Violante a Torino.
Per l'Italicus, il giudice che ha indagato sulla strage si chiama Claudio
Nunziata, che lavorò assieme a Rosario Minna. Ma stesso è lo scenario che si
scopre, come per le precedenti inchieste: un organizzazione neofascista (Ordine
Nero, di Mario Tuti e Augusto Cauchi), con coperture da parte dei carabinieri e
finanziata da un imprenditore di Arezzo, tale Licio Gelli. Nunziata fu definito
come un Torquemada dei treni, dai giornali della destra (come Il giornale di
Indro Montanelli e di Guido Paglia, esponente di Avanguardia Nazionale). Perché
era un magistrato zelante che non guardava in faccia a nessuno: nemmeno nella
ricca Bologna massonica. Nunziata non si trattenne nemmeno dal criticare il
comportamento della sua procura, per come venivano gestiti i carichi di lavoro e
per come non venivano seguite le indagini che riguardavano l'eversione. Su di
lui si concentrò un fuoco amico da parte del CSM e anche da parte dell'allora
presidente della Repubblica Francesco Cossiga: fu sospeso e lasciato senza
stipendio, fino alla sua riabilitazione, avvenuta anni dopo. "in fondo mi è
andata bene, altri hanno pagato con la vita" il suo amaro commento.
La strage alla stazione di Bologna.
Libero Mancuso iniziò la sua carriera a Napoli: seguì il rapimento da parte
delle Br di Ciro Cirillo e assistì alla trattativa di esponenti dello stato con
la Camorra di Cutolo per la liberazione dell'assessore. Nauseato, alla fine
della vicenda, chiese il trasferimento a Bologna, in cerca di una maggiore
tranquillità. Ma il 2 agosto 1980 scoppiò la bomba alla stazione. E il suo capo
alla procura gli assegnò un'indagine sull'ex colonnello Amos Spiazzi (un
personaggio già emerso nell'inchiesta di Tamburino sulla Rosa dei Venti). Da qui
l'inizio dell'inchiesta che lo portò fino alla strage, in cui emerse il ruolo
di depistaggio dei vertici del Sismi e della Loggia P2 (nonostante questo
l'avvocatura di Stato chiese l'archiviazione del reato di eversione per quanto
riguarda la Loggia P2 e Gelli, al processo di Appello). I processo fu, uno tra
pochi, ad arrivare a giudizio con una condanna per i responsabili della strage,
individuati negli estremisti dei Nar (Fioravanti, Mambro e Ciavardini). Come per
altri giudici, anche per Mancuso non mancarono polemiche, diffamazioni, attacchi
da parte dei Giornali (Il giornale, Il sabato ..) e persino dal capo dello
stato, allora Francesco Cossiga.
La loggia P2:
lo stato nello stato. Di questa storia, ne ha parlato Blu Notte recentemente: a
partire dai giudici istruttori Gherardo Colombo e Giuliano Turone che, nella
primavera del 1983, seguendo una indagine sul finto rapimento di Michele
Sindona, si imbattono in questo strano, all'apparenza sconosciuto ma potente
imprenditore. Licio Gelli da Arezzo. Dalla perquisizione in uno dei suoi uffici
emerge una struttura che comprende i vertici dei servizi, politici, magistrati,
giornalisti, politici, industriali (tra cui l'attuale presidente del Consiglio)
... Uno stato dello stato: dalla storia della P2 si capisce meglio l'evoluzione
della politica filoatlantica italiana, la guerra non ortodossa compiuta sugli
italiani: se nella prima metà degli anni 70 si parlava di golpe e si usavano le
bombe per destabilizzare, a partire dal 1974 si usò questa loggia massonica
segreta, come camera di compensazione per i poteri forti del paese. Come
struttura in qui selezionare la classe dirigente del paese: l'obbiettivo non era
più abbattere o sostituire le istituzioni, ma occuparle. Silenziosamente. Nella
politica, nei posti chiave della magistratura, nell'informazione,
nell'industria. Con l'attuazione del piano di rinascita democratica: un disegno
politico quanto mai attuale.
Gladio.
L'inchiesta del giovane giudice Felice Casson, a Venezia, che partendo dalla
strage di Peteano e dalle confessioni del pentito (con ritardo e con ancora
tanti punti aperti sulla sua sincerità), arriva a scoprire Gladio, la struttura
italiana dell'organizzazione Stay Behind. Una struttura misto civile militare,
addirittura fuori dall'organizzazione Nato e di cui nemmeno tutti i presidenti
del Consiglio ne furono a conoscenza (come ad esempio Amintore Fanfani). Una
struttura di cui l'opinione pubblica non fu informata: fino all'ammissione della
sua esistenza da parte del primo ministro Giulio Andreotti nel 1990, quando
ormai l'inchiesta veneziana stava arrivando al termine. Casson partì da qui
partì, dai legami tra Gladio e i gruppi della destra eversiva che negli anni 70
compirono attentati in Italia. Una indagine con gli stessi protagonisti delle
altre: gli ordinovisti veneti (il medico Carlo Maria Maggi, Franco Freda, Carlo
Digilio, l'artificiere-confidente dei servizi); i vertici dei servizi come
l'ammiraglio Fulvio Martini, legato anche al Conto Protezione di Craxi/Martelli,
che avrebbe portato fino a Gelli. Cosa è Gladio? Solo una storia di arsenali
nascosti sui monti del Friuli e forse qualche campo di concentramento in
Sardegna, che si sarebbe dovuto usare per gli enuclenandi del Piano Solo? O
forse, come in una struttura a scatole cinesi, una dentro l'altra, Gladio era
solo il guscio esterno, quelle più presentabile, di altre strutture (come
il Noto Servizio o Anello), più nascoste, dalle finalità più ambigue, ai limiti
(se non oltre) del codice. Campagne stampa diffamatorie contro esponenti
politici o sindacali da togliere di mezzo; l'utilizzo della corruzione come
normale sistema di trattativa politica; l'utilizzo della malavita (come la Banda
della Magliana, per l'individuazione della prigionia di Aldo Moro da parte della
BR) in funzione di braccio armato, che può essere sempre reciso alla bisogna,
allo stragismo e terrorismo della cui incredibile durata e virulenza nel nostro
paese non è stata data ancora una plausibile spiegazione. E soprattutto, la
domanda più importante: siamo sicuri che queste siano solo storie del passato?
Se qualcuno, nel passato, ha pensato di mettere una bomba per spostare il
baricentro della politica italiana, depistando le indagini della polizia,
insabbiandone altre grazie a Procure compiacenti (vi ricordate come veniva
chiamata la Procura di Roma? Il porto delle nebbie), cosa sarebbe disposto a
fare oggi, per evitare tutti cambiamenti in ambito sociale e politico? Siamo
sicuri che i servizi deviati (che poi non è nemmeno giusto chiamarli così,
essendo stati solo al servizio di quei poteri forti già attivi nei anni 70) oggi
non siano più operativi?
Ma esiste un’altra verità che i sinistroidi
tacciono.
L’ultimo segreto nelle carte di Moro: “La
Libia dietro Ustica e Bologna”. Da Beirut i servizi
segreti avvisarono: “Tripoli controlla i terroristi palestinesi”. I parlamentari
della Commissione d’inchiesta: “Renzi renda pubblici i documenti”, scrive il
05/05/2016 Francesco Grignetti su “La Stampa”. Tutto nasce da una direttiva di
Matteo Renzi, che ha fatto togliere il segreto a decine di migliaia di documenti
sulle stragi italiane. Nel mucchio, i consulenti della commissione d’inchiesta
sul caso Moro hanno trovato una pepita d’oro: un cablo del Sismi, da Beirut, che
risale al febbraio 1978, ossia un mese prima della strage di via Fani, in cui si
mettono per iscritto le modalità del Lodo Moro. Il Lodo Moro è quell’accordo
informale tra italiani e palestinesi che risale al 1973 per cui noi sostenemmo
in molti modi la loro lotta e in cambio l’Olp ma anche l’Fplp, i guerriglieri
marxisti di George Habbash, avrebbero tenuto l’Italia al riparo da atti di
terrorismo. Ebbene, partendo da quel cablo cifrato, alcuni parlamentari della
commissione Moro hanno continuato a scavare. Loro e soltanto loro, che hanno i
poteri dell’autorità giudiziaria, hanno potuto visionare l’intero carteggio di
Beirut relativamente agli anni ’79 e ’80, ancora coperto dal timbro «segreto» o
«segretissimo». E ora sono convinti di avere trovato qualcosa di esplosivo. Ma
non lo possono raccontare perché c’è un assoluto divieto di divulgazione. Chi ha
potuto leggere quei documenti, spera ardentemente che Renzi faccia un passo più
in là e liberalizzi il resto del carteggio. Hanno presentato una prima
interpellanza. «È davvero incomprensibile e scandaloso - scrivono i senatori
Carlo Giovanardi, Luigi Compagna e Aldo Di Biagio - che, mentre continuano in
Italia polemiche e dibattiti, con accuse pesantissime agli alleati francesi e
statunitensi di essere responsabili dell’abbattimento del DC9 Itavia a Ustica
nel giugno del 1980, l’opinione pubblica non sia messa a conoscenza di quanto
chiaramente emerge dai documenti secretati in ordine a quella tragedia e più in
generale degli attentati che insanguinarono l’Italia nel 1980, ivi compresa la
strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980». Ecco il messaggio destinato
al ministro degli Interni, ai servizi italiani e a quelli alleati in cui si
segnala che George Habbash, capo dei guerriglieri palestinesi del Fplp, indica
l’Italia come possibile obiettivo di un’«operazione terroristica». Va raccontato
innanzitutto l’antefatto: nelle settimane scorse, dopo un certo tira-e-molla con
Palazzo Chigi, i commissari parlamentari sono stati ammessi tra mille cautele in
una sede dei servizi segreti nel centro di Roma. Dagli archivi della sede
centrale, a Forte Braschi, erano stati prelevati alcuni faldoni con il marchio
«segretissimo» e portati, con adeguata scorta, in un ufficio attrezzato per
l’occasione. Lì, finalmente, attorniati da 007, con divieto di fotocopiare,
senza cellulari al seguito, ma solo una penna e qualche foglio di carta, hanno
potuto prendere visione del carteggio tra Roma e Beirut che riporta al famoso
colonnello Stefano Giovannone, il migliore uomo della nostra intelligence mai
schierato in Medio Oriente. Il punto è che i commissari parlamentari hanno
trovato molto di più di quello che cercavano. Volevano verificare se nel dossier
ci fossero state notizie di fonte palestinese per il caso Moro, cioè documenti
sul 1978. Sono incappati invece in documenti che sorreggono - non comprovano,
ovvio - la cosiddetta pista araba per le stragi di Ustica e di Bologna. O
meglio, a giudicare da quel che ormai è noto (si veda il recente libro «La
strage dimenticata. Fiumicino 17 dicembre 1973» di Gabriele Paradisi e Rosario
Priore) si dovrebbe parlare di una pista libico-araba, ché per molti anni c’è
stato Gheddafi dietro alcune sigle del terrore. C’era la Libia dietro Abu Nidal,
per dire, come dietro Carlos, o i terroristi dell’Armata rossa giapponese.
Giovanardi e altri cinque senatori hanno presentato ieri una nuova
interpellanza. Ricordando le fasi buie di quel periodo, in un crescendo che va
dall’arresto di Daniele Pifano a Ortona con due lanciamissili dei palestinesi
dell’Fplp, agli omicidi di dissidenti libici ad opera di sicari di Gheddafi,
alla firma dell’accordo italo-maltese che subentrava a un precedente accordo tra
Libia e Malta sia per l’assistenza militare che per lo sfruttamento di
giacimenti di petrolio, concludono: «I membri della Commissione di inchiesta
sulla morte dell’on. Aldo Moro hanno potuto consultare il carteggio di quel
periodo tra la nostra ambasciata a Beirut e i servizi segreti a Roma, materiale
non più coperto dal segreto di Stato ma che, essendo stato classificato come
segreto e segretissimo, non può essere divulgato; il terribile e drammatico
conflitto fra l’Italia e alcune organizzazioni palestinesi controllate dai
libici registra il suo apice la mattina del 27 giugno 1980». Dice ora il
senatore Giovanardi, che è fuoriuscito dal gruppo di Alfano e ha seguito Gaetano
Quagliariello all’opposizione, ed è da sempre sostenitore della tesi di una
bomba dietro la strage di Ustica: «Io capisco che ci debbano essere degli
omissis sui rapporti con Paesi stranieri, ma spero che il governo renda
immediatamente pubblici quei documenti».
Stragi, i palestinesi dietro Ustica e
Bologna? Il centrodestra: fuori le carte, scrive
giovedì 5 maggio 2016 “Il Secolo D’Italia”. Reazioni, polemiche ma anche
approvazione dopo che in una interpellanza presentata in vista della
celebrazione solenne il 9 maggio a Montecitorio della Giornata della memoria
delle vittime delle stragi e del terrorismo, i senatori Giovanardi,
Quagliariello, Compagna, Augello, Di Biagio e Gasparri, hanno chiesto al
Presidente del Consiglio di rendere pubbliche le carte relative alle stragi di
Ustica e della stazione di Bologna. Gli interpellanti – si legge in una nota –
citano gli autorevoli interventi del 2014 e 2015, in occasione della giornata
della memoria e dell’anniversario di Ustica, dei Presidenti della Repubblica
Napolitano e Mattarella e dei presidenti di Camera e Senato nei quali si chiede
di arrivare alla verità «pretendendo chiarezza oltre ogni convenienza» e
l’intervista del 3 maggio ultimo scorso del Ministro degli esteri Gentiloni sul
caso Regeni, dove afferma testualmente: «La nostra ricerca della verità è al
primo posto, e non può essere cancellata da interessi e preoccupazioni
geopolitiche». Gli interpellanti ricordano poi di aver potuto consultare il
carteggio dell’epoca tra la nostra Ambasciata a Beirut e i Servizi segreti a
Roma, relativo ai drammatici avvenimenti del 1979 e 1980, quando si sviluppò un
drammatico confronto fra l’Italia da una parte e dall’altra le frange più
estreme del Movimento per la liberazione della Palestina con dietro la Libia di
Gheddafi ed ambienti dell’autonomia, materiale non più coperto dal segreto di
Stato, ma che, essendo stato classificato come segretissimo, rende penalmente
perseguibile anche dopo 36 anni la sua divulgazione. La figlia di una vittima
chiede chiarezza sulle stragi: «Sconcertata, come figlia di una vittima
dell’esplosione del DC9 Itavia, e come Presidente onorario dell’Associazione per
la Verità sul disastro aereo di Ustica, nell’apprendere che dopo 36 anni da
quella tragedia non sono ancora divulgabili documenti che potrebbero contribuire
in maniera decisiva a far piena luce su quella strage», scrive Giuliana Cavazza,
presidente onorario dell’associazione citata. «Lunedì sarà celebrata a
Montecitorio la giornata della memoria delle vittime del terrorismo e delle
stragi: aggiungo la mia modesta voce a quella dei vertici istituzionali che
hanno più volte sottolineato la necessità di cercare la verità al di là di ogni
convenienza o calcolo politico. Mi auguro pertanto che per quella data il
Presidente del Consiglio abbia già assunto la decisione di rendere noto il
contenuto dei documenti che solo i membri della Commissione di inchiesta sulla
morte di Aldo Moro hanno già potuto consultare». Di diverso avviso Bolognesi:
«Ho letto le carte contenute nei faldoni messi a disposizione della Commissione
Moro e posso affermare che su Ustica e Bologna non ci sono né segreti, né
rivelazioni, né novità. I decenni passano ma i depistaggi sembrano resistere»,
ha detto infatti Paolo Bolognesi, deputato Pd, presidente dell’Associazione 2
agosto 1980, commentando le recenti notizie di possibili nuovi elementi sulle
stragi di Ustica e Bologna contenuti nei documenti consultati dai componenti
della Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Moro di cui Bolognesi fa
parte. C’è poi la tesi di Zamberletti: «Torniamo indietro al 2 agosto 1980, data
della strage di Bologna. Era il giorno in cui io, da sottosegretario, avrei
firmato un accordo italo-maltese. L’accordo, che fu poi firmato regolarmente,
prevedeva da parte italiana la garanzia militare sulla sovranità aerea e
marittima di Malta. La notizia della bomba alla stazione di Bologna, che ci
arrivò quando eravamo a La Valletta, mi diede subito la sensazione della
vendetta contro l’Italia». È questa la verità sulle stragi di Bologna e Ustica
secondo Giuseppe Zamberletti, all’epoca sottosegretario agli Esteri nel governo
Cossiga, in un’intervista a La Stampa. «I libici – dice – esercitavano fino a
quel momento un protettorato di fatto su Malta». Zamberletti afferma di essere
stato avvertito anche dall’allora direttore del Sismi, il generale Santovito,
che gli chiese di soprassedere, poiché Gheddafi considerava Malta “una cosa
sua”, «il governo Cossiga però decise di andare avanti. E se oggi Malta è nella
Unione europea e non in Africa, tutto cominciò quel giorno. Questi documenti che
sono stati desecretati sono un punto di inizio e non di arrivo. È proprio il
caso di andare avanti», dice in riferimenti all’interrogazione con cui alcuni
parlamentari chiedono di rendere pubblici tutti i documenti: «Nel febbraio 1978
c’era dunque questo accordo tra italiani e palestinesi, ma che ci fossero
rapporti tra Gheddafi e certe schegge palestinesi è una grande novità, di cui
all’epoca non avevamo assolutamente contezza».
«Vi dico la verità su Ustica: è stata una
bomba e veniva da Beirut», scrive Giulia Merlo il 2
ago 2016 su “Il Dubbio”. «Smettetela di chiedere a me di rivelare questi
documenti: mi costerebbe 3 anni di carcere e la decadenza da senatore. È il
governo Renzi ad avere il dovere morale di togliere il segreto sui dossier». «Il
presidente del Consiglio Matteo Renzi ha il dovere di togliere la dizione
"segretissimo" da quelle carte in modo da poterle divulgare, solo così le verità
nascoste per trentasei anni verranno finalmente svelate». Non ha dubbi, il
senatore Carlo Giovanardi. In qualità di membro della commissione Moro, ha avuto
modo di visionare dei documenti che getterebbero nuova luce sulla tragica
vicenda del volo Itavia DC-9, inabissatosi nel braccio di Mar Tirreno tra Ustica
e Ponza con a bordo 81 persone, il 27 giugno del 1980.
Cominciamo dal principio: cosa è successo a
bordo di quell'aereo?
«Nella toilette
è esplosa una bomba, che ha provocato la caduta del velivolo e la morte di tutti
i passeggeri».
Eppure molte voci sostengono che, quella notte,
nei cieli italiani fosse in corso una guerriglia aerea in cui erano coinvolti
caccia da guerra francesi e libici e che il volo Itavia sia stato abbattuto da
un missile.
«Io mi sono
interessato della questione quando ero ministro e su questi fatti ho risposto in
Parlamento, sulla base delle fonti ufficiali provenienti dalla Nato e dei
dossier dei nostri servizi di intelligence. Ciò che sostengo è suffragato non
solo da questo, ma anche da 4000 pagine di perizie, svolte dai maggiori esperti
internazionali di aereonautica. Aggiungo anche che ho letto in aula le missive
personali indirizzate all'allora premier Giuliano Amato dal presidente americano
Bill Clinton e da quello francese Jaques Chirac, in cui entrambi giurano sul
loro onore che, durante la notte della strage, nei cieli di Ustica non volavano
né aerei americani né francesi».
Gli scettici hanno sostenuto che la bomba nella
toilette sia smentita dal fatto che il lavandino è stato ritrovato intatto nel
relitto.
«Gli americani,
in un documentario prodotto dal National Geographic, hanno preso un vecchio DC-9
e riprodotto l'esplosione, verificando che è ben possibile che il lavello non si
sia rotto».
E quindi il mistero riguarda quale mano abbia
piazzato la bomba. La risposta sta nelle carte da lei visionate?
«Esattamente.
Si tratta di documenti che nessun magistrato ha mai potuto esaminare, su cui da
due anni è caduto il segreto di Stato ma che rimangono bollati come
"segretissimi" e dunque sono non divulgabili. Il carteggio fa riferimento ai
rapporti tra il governo italiano e la nostra ambasciata a Beirut negli anni 1979
e 1980. Io ho potuto esaminarlo in presenza dei membri dei servizi e con la
possibilità di prendere appunti, ma quei dossier contengono messaggi dalla
capitale libica, alcuni datati anche 27 giugno, che annunciano vittime innocenti
e parlano anche di un aereo come obiettivo del Fronte nazionale per la
liberazione della Palestina, organizzazione controllata dai libici».
In questi dossier ritorna la teoria del
cosiddetto "lodo Moro", ovvero il patto segreto tra Italia e filopalestinesi,
che permetteva ai gruppi palestinesi di trasportare e stoccare armi nel nostro
territorio a patto di non commettere attentati?
«Certo che quei
documenti riguardano il "lodo Moro". E' chiaro che quell'accordo non era stato
siglato in carta bollata, ma la sua esistenza è chiara e dalle carte emerge
anche come Il Fronte popolare per la liberazione della Palestina lo considerasse
violato nel 1979, quando il governo italiano sequestrò i missili trovati a
Ortona e arrestò il militante del Fplp Abu Anzeh Saleh, poi detenuto nel carcere
di Trani. Per questo minacciavano ritorsioni contro l'Italia. Tornando a Ustica,
ricordo che l'unico governo a non rispondere alle rogatorie italiane è stato
quello di Gheddafi».
Ustica è stata una rappresaglia libica, dunque?
«E' stato
l'allora ministro Zamberletti a definirla così. Lo stesso che, proprio il 2
agosto (data della strage alla stazione di Bologna) firmava un accordo
italo-maltese di assistenza militare e di estrazione petrolifera, che di fatto
subentrava a quello tra Malta e la Libia. Secondo Zamberletti, Bologna e Ustica
sono state entrambe un avvertimento dei libici al governo italiano e le due
stragi sono legate da un filo rosso arabo-palestinese».
Rivelare questi documenti, dunque, fugherebbe
qualsiasi ulteriore dubbio sull'ipotesi del missile sul volo Itavia?
«Certo. Eppure
faccio notare che, ora che queste carte sono state lette e che io ne chiedo la
desecretazione, la presidente dell'associazione delle vittime di Ustica, durante
le commemorazioni delle stragi di quest'anno, non ha più chiesto che i dossier
vengano pubblicati».
E questo che cosa significa?
«La senatrice
Daria Bonfietti (che ha perso un fratello nella strage di Ustica ndr) sostiene
che io abbia in mano un due di picche, invece io credo di avere un poker d'assi.
I dossier che ho letto svelano la verità su quegli attentati ma, evidentemente,
renderli pubblici potrebbe in qualche modo mettere in discussione i risarcimenti
che si aggiungono ai 62 milioni di euro già percepiti. La Cassazione in sede
civile, infatti, ha riconosciuto un risarcimento del danno di centinaia di
milioni di euro all'Itavia, agli eredi Davanzali (ex presidente dell'Itavia) e
alle famiglie delle vittime. Ciò nasce da una sciagurata sentenza civile di
primo grado, scritta dal giudice onorario aggiunto Francesco Betticani, che
teorizza appunto che ad abbattere l'aereo sia stato un missile non meglio
identificato. L'appello viene vinto dall'Avvocatura di Stato che, però, commette
un errore procedurale. La Cassazione allora annulla la sentenza di appello e
rinvia alla Corte, la quale, però, può conoscere solo gli elementi portati dalle
parti e non aggiungerne di nuovi. In questo modo è stata confermata in
Cassazione civile l'assurda ipotesi del missile, definita "più probabile che
no", totalmente smentita invece in sede penale».
In che modo l'ipotesi della bomba cambierebbe
le carte in tavola per i familiari delle vittime?
«La risposta è
semplice: se si fosse trattato di una bomba, come hanno stabilito le perizie
tecniche, la responsabilità di non aver vigilato a Bologna avrebbe coinvolto
anche la società Itavia e dunque il Ministero non dovrebbe risarcire le
centinaia di milioni di danni. Aggiungo che a ogni famiglia delle persone
decedute sono stati assegnati 200 mila euro e i 141 familiari superstiti godono
dal 2004 di un assegno vitalizio mensile di 1.864 euro netti, rivalutabili nel
tempo».
Che fare dunque ora?
«Innanzitutto
smetterla di chiedere a me di rivelare questi documenti, cosa che mi costerebbe
3 anni di carcere e la decadenza da senatore per indegnità morale. E' il governo
Renzi ad avere il dovere morale di togliere il segreto sui dossier per amore di
verità, così forse - almeno - ripuliremo una volta per tutte l'immaginario
collettivo su Ustica, inquinato da sceneggiati e depistaggi».
La colpevolezza dei Nar è un dogma
ideologico. Le strane relazioni che intercorrevano tra
l'Italia e gli arabi del Fplp, scrive il 02/08/2016 Dimitri Buffa su “Il Tempo”.
Anche oggi come da 36 anni a questa parte alle 10 e 25 in punto la città di
Bologna si fermerà per qualche minuto. Per commemorare gli 85 morti e i 200
feriti di un attentato che, al di là delle sentenze definitive e della
colpevolezza come esecutori materiali ormai appiccicata addosso in maniera
indelebile ai tre ex Nar Valerio Fioravanti, Luigi Ciavardini e Francesca
Mambro, rimane ancora avvolto nel mistero. Un po’ di luce però, almeno sul
movente lo può fare il libro «I segreti di Bologna», di Valerio Cutonilli e
Rosario Priore, rispettivamente un avvocato e un magistrato, entrambi coraggiosi
nell’andare contro corrente rispetto alla vulgata che ha voluto che questa
strage fosse fascista sin dai primi istanti. Il Tempo già si era occupato di uno
dei misteri di questa indagine, ossia la mancata identificazione di un cadavere
e la scomparsa di un corpo di una delle vittime. Ma l’indicibile segreto di
Stato che forse non sarà mai tolto, perchè è servito all’Italia a non subire più
attentati da parte di terroristi palestinesi e medio orientali in genere,
compresi quelli dell’Isis (toccando ferro), non è negoziabile nè rivelabile. E
dopo gli anni ’70 che avevano lasciato una lunga scia di oltre sessanta morti
del tutto rimossi dall’inconscio collettivo ad opera di settembre nero e altre
formazioni dell’epoca, oggi se ne conosce il nome: «Lodo Moro». E colui che gli
diede il nome non sapeva che un giorno, il 16 marzo 1978 ne sarebbe diventato
vittima. Molte indagini infatti hanno acclarato, e il libro le elenca tutte in
maniera che anche un bambino di sette anni potrebbe capire, che le armi alle Br
in Italia le portarono anche i palestinesi del Fplp di George Habbash. Quel
fronte popolare di resistenza palestinese di matrice marx leninista che invano
nel febbraio 1978 tramite gli informatori del colonnello Stefano Giovannone,
vero e proprio sacerdote della liturgia del «Lodo Moro», soffiò al Viminale
della preparazione di un attentato con rapimento di un’alta personalità politica
in Italia sul modello del sequestro di Hans Martin Schleyer, il presidente della
Confindustria della ex Germania Ovest sequestrato nel settembre 1977 dalla Raf.
Insomma se tutte le rivoluzioni finiscono per mangiarsi i propri figli il «lodo
Moro» si mangiò suo padre, Aldo Moro. Il libro in questione, quindi, rivela e
mette in fila tutti i segreti di Stato legati al «Lodo Moro» a cominciare dal
ruolo di Carlos e di Thomas Khram e dei suoi accoliti dell’Ori, organizzazione
rivoluzionaria internazionale, nella strage di Bologna, che potrebbe anche
essere avvenuta per errore, cioè esplosivo in transito, cosa che spiegherebbe la
mancata identificazione di almeno una delle vittime. Per non parlare degli
omissis legati alle minacce di ritorsione sempre segnalate dal Sismi di
Santovito, che venivano fino a tutto il luglio 1980 da parte dell’Fplp, legate
alla vicenda dei missili Strela Sam 7 sequestrati qualche mese prima
all’autonomo Daniele Pifano e destinati ai palestinesi. Con annessi arresto di
Abu Anzeh Saleh e trattativa per farlo rilasciare dai giudici di Chieti e
L’Aquila. Poi c’è la storia del trattato segreto tra Italia e Malta siglato
dall’allora sottosegretario Giuseppe Zamberletti a La Valletta proprio un’ora
prima della deflagrazione di Bologna. O quella dell’appoggio italiano,
sottobanco, al tentato golpe contro Gheddafi fomentato dall’Egitto di Sadat,
senza contare la vicenda di Ustica e via dicendo. Verità mai cercate anzi
sacrificate da alcuni magistrati sull’altare della ragion di Stato. Moventi
precisi, quasi certi, conosciuti da Francesco Cossiga, Giulio Andreotti,
Giuseppe Zamberletti, Bettino Craxi, Lelio Lagorio e Giuseppe Santovito. Tragici
segreti di Stato e insieme di Pulcinella. Ma che, per evitare che venissero
fuori i nostri accordi sottobanco con i palestinesi dell’Olp e del Fplp, nonchè
quelli con Gheddafi che includevano l’aiuto a scovare e uccidere i dissidenti
libici in Italia, si preferì seppellire sotto i depistaggi ai danni dei Nar. Che
in fondo, essendo tutti già condannati per altri omicidi e atti di terrorismo,
erano dei capri espiatori perfetti, Ma oggi quando si chiede di togliere i
segreti di Stato su Bologna, magari sperando di trovarci dietro chissà quale
appoggio occulto della P2 di Licio Gelli, con quale onestà intellettuale si
fanno questi appelli? Il «Lodo Moro» e il doppiogiochismo dell’Italia tra «la
moglie americana e l’amante libica, e magari l’amichetta palestinese», per
citare una felice battuta di Giovanni Pellegrino presidente della Stragi,
rimarranno sempre segreti. L’Italia deve accontentarsi dei colpevoli di
repertorio. Dimitri Buffa.
Come a sinistra si racconta sempre un'altra
storia.
La strage di Bologna: l’intervista di
Gianni Barbacetto al giudice Mastelloni. Ad ogni
anniversario della strage di Bologna spuntano le rivelazioni su nuove piste e
nuovi responsabili per la bomba. Piste e responsabili che spesso si sono
rivelati sbagliati o, peggio, dei depistaggi. L'ultimo libro sulla bomba alla
stazione: il saggio uscito per Chiarelettere di Rosario Priore e Valerio
Cutonilli "I misteri di Bologna". L’1 agosto 2016 sul Fatto Quotidiano Gianni
Barbacetto (autore tra gli altri del libro "Il grande vecchio" sulle stragi e
sui segreti italiani) intervista il giudice Carlo Mastelloni, che nel passato
aveva indagato sul disastro di Argo 16 e sui contatti tra Br e Olp per lo
scambio d'armi. Diversamente da Priore, Mastelloni ha pochi dubbi sull'origine
della bomba e sui responsabili: sono stati i neofascisti dei Nar, Valerio
Fioravanti e Francesca Mambro. Quest'intervista cancella la tesi dei due autori
del libro. E' la più grave delle stragi italiane: 85 morti, 200 feriti. È anche
l’unica con responsabili accertati, condannati da sentenze definitive: Valerio
Giusva Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini. Esecutori materiali
appartenenti ai Nar, i Nuclei armati rivoluzionari. La strage di Bologna del 2
agosto 1980, ore 10.25, è anche l’unica per cui sono state emesse sentenze per
depistaggio: condannati due uomini dei servizi segreti, Pietro Musumeci e
Giuseppe Belmonte, e due faccendieri della P2, Licio Gelli e Francesco Pazienza.
I depistaggi: fanno parte della storia delle indagini sull’attentato di Bologna
(come di tutte le stragi italiane, a partire da piazza Fontana) e arrivano fino
a oggi, dopo che sono passati 36 anni. Malgrado le sentenze definitive che
attribuiscono la responsabilità dell’attentato ai fascisti nutriti dalla P2,
sono continuamente riproposte altre spiegazioni, fantasmagoriche “piste
internazionali”. La pista palestinese, più volte presentata in passato, anche da
Francesco Cossiga, torna alla ribalta oggi aggiornata dal magistrato che ha
indagato sulla strage di Ustica, Rosario Priore. Continua a resistere la
pervicace volontà di non guardare le prove raccolte in anni d’indagini e
allineate in migliaia di pagine di atti processuali, per inseguire le
suggestioni evocate da personaggi pittoreschi e depistatori di professione. Del
resto Fioravanti e Mambro, che pure hanno confessato decine di omicidi feroci,
continuano a proclamare la loro innocenza per la strage della stazione: non
possono e non vogliono accettare di passare alla storia come i “killer della
P2”. La definizione è di Vincenzo Vinciguerra, protagonista dell’altra strage
italiana per cui c’è un responsabile condannato, quella di Peteano. Ma
Vinciguerra ha denunciato se stesso e ha orgogliosamente rivendicato l’azione di
Peteano come atto “di guerra politica rivoluzionaria” contro uomini dello Stato
in divisa. Su Bologna, sulle 85 incolpevoli vittime, sui 200 feriti, invece, 36
anni dopo restano ancora all’opera i dubbi, le menzogne, i depistaggi. Non ha
dubbi: “Cominciamo a mettere le cose al loro posto: la matrice neofascista della
strage di Bologna è chiara”. Carlo Mastelloni è dal febbraio 2014 procuratore
della Repubblica a Trieste. Non dà credito alla pista internazionale per
l’attentato: il giudice Rosario Priore, in un libro scritto con l’avvocato
Valerio Cutonilli, spiega la strage con una pista palestinese. “Non l’ho mai
condivisa”, dice Mastelloni. In estrema sintesi, secondo i sostenitori di questa
ipotesi, la Resistenza palestinese avrebbe compiuto la strage come ritorsione
per l’arresto nel novembre 1979 di Abu Saleh, uomo del Fronte popolare di
liberazione della Palestina (Fplp), componente radicale dell’Olp di Yasser
Arafat, fermato in Italia con tre missili terra-aria tipo Strela insieme a
Daniele Pifano e altri due esponenti dell’Autonomia romana. La strage come
vendetta per la rottura da parte italiana del cosiddetto “Lodo Moro”, cioè
dell’accordo di libero transito in Italia dei guerriglieri palestinesi, in
cambio della garanzia che sul territorio italiano non avrebbero compiuto
attentati. “Quella pista”, ricorda Mastelloni, “si basa sul fatto che a Bologna
la notte prima della strage era presente Thomas Kram; tuttavia, all’elemento
certo di quella presenza si è aggiunto il nulla indiziario”. Kram è un tedesco
legato al gruppo del terrorista Carlos, lo Sciacallo. Nuovi documenti, ancora
secretati perché coinvolgono Stati esteri, sono stati di recente acquisiti
dall’attuale Commissione parlamentare d’inchiesta sull’assassinio di Aldo Moro:
proverebbero che gli accordi con la Resistenza palestinese hanno tenuto almeno
fino all’ottobre dell’80, assicura lo storico Paolo Corsini, che ha potuto
leggere quelle carte in qualità di componente dell’organismo parlamentare.
Racconta Mastelloni: “Quando il vertice del Sismi (il servizio segreto militare
erede del Sid) dopo l’arresto di Pifano e degli altri fu costretto a rivelare la
persistenza del Lodo Moro a Francesco Cossiga – che già ne era stato
sommariamente informato attraverso le lettere inviate da Moro prigioniero nella
primavera 1978 – questi andò su tutte le furie. Soprattutto dopo aver appreso
che il transito dei missili era stato accordato al capo dell’Fplp George Habbash
dal colonnello del Sid Stefano Giovannone”. La furia di Cossiga, i contatti di
Giovannone. In quei mesi Cossiga era presidente del Consiglio. “Appunto. E si
arrabbiò moltissimo. Di qui l’atteggiamento furioso di Habbash che rivendicò i
missili e la copertura datogli “dal governo italiano” che lui evidentemente
identificava in Giovannone, capocentro Sismi a Beirut. Conosco un po’ la
personalità di Cossiga: gli piacevano assai certi intrighi internazionali e poi
credeva di avere le stesse capacità strategiche di Moro. Per questo è assai
facile che il Lodo abbia tenuto fino a tutto il 1980, almeno fino alla
conclusione del mandato di Cossiga. È però da escludere che di fronte a una
strage come quella di Bologna il Lodo Moro potesse essere idoneo a coprire il
fatto. Mi si deve poi spiegare quale utilità avrebbe mai conseguito il Kgb – che
aveva avuto alle sue dipendenze Wadi Haddad fino al 1978, così come nella sua
orbita si trovava Habbash e lo stesso Arafat capo dell’Olp – colpendo la rossa
Bologna”. Cossiga arrivò a dire, in un’intervista al Corriere del giugno 2008,
che la strage fu la conseguenza un transito di esplosivo finito male. “Non è
assolutamente plausibile. L’esplosivo usato per l’attentato poteva esplodere
solo se innescato, non per altri fattori accidentali. La strage fu causata dalla
deflagrazione di una valigia riempita con circa 20 chili di Compound B,
esplosivo di fabbricazione militare in dotazione a istituzioni come la Nato”.
Priore sostiene che l’Fplp di Habbash aveva una così forte influenza su
Giovannone e, tramite questi, sul governo italiano, da pretendere che le nostre
autorità rifiutassero a statunitensi e israeliani di esaminare i missili Strela
sequestrati. “Il dottor Habbash è stato un capo carismatico ma, francamente,
penso che i nostri alleati non avessero bisogno di analizzare gli Strela che già
conoscevano. Le rivelo che spesi ogni energia –tante missive di richiesta allo
Stato maggiore dell’esercito – per avere notizia dei missili sequestrati e poi
inviati agli organi tecnici dell’Esercito. Dove si trovavano? Silenzio. Mi fu
poi detto nel 1986, dal generale Vito Miceli, che erano stati spediti agli
americani per le analisi”. L’ipotesi è che il destinatario ultimo dei missili
sequestrati fosse niente di meno che il terrorista Carlos, che stava progettando
un’azione clamorosa, un attentato contro i leader egiziano Sadat. “Lo escludo.
Nel 1979, Carlos già da anni era stato espulso dal circuito di Fplp. Penso che
quei missili fossero in transito e che gli autonomi arrestati si sarebbero
dovuti limitare a trasportarli, probabilmente fino al confine svizzero. Si
trovava infatti in Svizzera quella che io chiamo la testa del motore, e cioè la
centrale del terrorismo palestinese. Mi pare che proprio in quel periodo a
Ginevra fosse in programma un’importante conferenza internazionale cui doveva
partecipare Henry Kissinger, da anni obbiettivo del Fplp. Carlos aveva assunto
il comando dell’organizzazione poi chiamata Separat, vicina ai siriani, e quindi
all’Unione Sovietica. Escludo perciò che Carlos avesse bisogno proprio dei due
missili di Habbash così come escludo che quest’ultimo si mettesse nelle mani di
Carlos per compiere un attentato eclatante nella rossa Bologna”. È dunque
solida, da un punto di vista giudiziario, la matrice fascista della strage di
Bologna. “Sì. Ricordiamoci innanzitutto il luogo e il contesto: agli inizi degli
anni Ottanta, Bologna era ancora la capitale simbolica del Pci. Finiti gli anni
del compromesso storico e degli accordi con la Dc, Enrico Berlinguer riposizionò
il Partito comunista all’opposizione”. Tanti i testimoni che parlano di Giusva.
Responsabile della strage, per la giustizia italiana, è il gruppo dei Nar, i
Nuclei armati rivoluzionari di Valerio Giusva Fioravanti. “Lo provano le
testimonianze di militanti di primo piano dei Nar: da Cristiano Fioravanti a
Walter Sordi, da Stefano Soderini a Luigi Ciavardini. Ma decisiva appare nel
contesto della strage la vicenda dell’omicidio Mangiameli. Francesco Ciccio
Mangiameli, leader nazionale di Terza Posizione, fu indicato dal colonnello Amos
Spiazzi nell’agosto del 1980 come coinvolto nell’attentato. Nel settembre dello
stesso anno, Mangiameli venne eliminato dai fratelli Fioravanti, Francesca
Mambro e Giorgio Vale a Roma, dopo essere stato attirato in una trappola.
Omicidio inspiegabile, se non con il pericolo che ‘Ciccio’ rivelasse quello che
sapeva sulla strage di Bologna”. Giusva Fioravanti e Francesca Mambro erano
stati a Palermo, da Mangiameli, nel mese di luglio 1980, per pianificare
l’evasione di Pierluigi Concutelli, capo militare di Ordine nuovo. “Sì. Ed è
proprio per paura di quanto avevano appreso durante quel viaggio in Sicilia che
Giusva era deciso a eliminare anche la moglie e la bambina di Mangiameli. Questo
lo ha raccontato il pentito Cristiano Fioravanti, fratello di Giusva”. Cristiano
Fioravanti è un personaggio drammatico, grande accusatore del fratello Giusva. È
un personaggio credibile? “Certamente sì. In diverse confidenze fatte nel
carcere di Palianolo si evince dalle dichiarazioni di Sergio Calore e Raffaella
Furiozzi – e in parziali confessioni rese alla Corte d’assise di Bologna, poi
ritrattate ma solo su fortissime pressioni del padre dei fratelli Fioravanti,
Cristiano ha additato il fratello come responsabile della strage che, nelle
intenzioni, non avrebbe dovuto assumere dimensioni così devastanti”. In aggiunta
c’è la testimonianza di Massimo Sparti. “Ed è molto importante. Sparti parla di
una richiesta urgente di documenti falsi per Francesca Mambro avanzata da un
Valerio Fioravanti molto preoccupato che la ragazza fosse stata riconosciuta
alla stazione di Bologna. Inoltre, è assolutamente certo che Giusva e Francesca
volevano eliminare Ciavardini per aver fatto incaute rivelazioni il 1° agosto
alla fidanzata. Stefano Soderini era già stato mobilitato per l’eliminazione del
giovane, allora minorenne e ferito in uno scontro a fuoco durante un’azione dei
Nar. Non le pare abbastanza per considerare definitiva la matrice fascista della
strage?”. Alcuni ritengono però che in tutta la vicenda processuale sia apparsa
indeterminata, se non assente, la figura dei mandanti e la motivazione profonda
per la strage. “Resta un buco di ricostruzione storica. Ma nessuno può levarmi
dalla testa che le continue e pervicaci campagne volte ad accreditare
l’innocenza degli attentatori materiali neofascisti non hanno avuto altro esito
– anche dopo la sentenza definitiva della Cassazione – che allontanare ancora di
più la ricerca dei mandanti e dei loro scopi”. Oggi resta intoccabile quella
grande lapide (“Vittime del terrorismo fascista”) all’interno della stazione,
con i nomi degli 85morti di Bologna. “Sì, e aggiungo una cosa: quella lapide è
tuttora scomoda per parecchi ambienti”.
«Le stragi di Ustica e Bologna? Cercate
in medioriente», scrive Giulia Merlo il 2 ago 2016 su
“Il Dubbio”. Il 2 agosto di 36 anni fa, la stazione di Bologna venne devastata
da un'esplosione che provocò 85 morti e oltre 200 feriti. Il giudice Rosario
Priore racconta la sua verità e spiega il “Lodo Moro”. Che cosa è successo alla
stazione Bologna, quel 2 agosto del 1980? A 36 anni dalla strage più sanguinosa
del secondo dopoguerra - in cui persero la vita in un’esplosione 85 persone e ne
rimasero ferite 200 - la verità processuale è stata stabilita in via definitiva
e ha riconosciuto colpevoli i militanti neofascisti dei Nuclei Armati
Rivoluzionari, Giusva Foravanti e Francesca Mambro. Secondo l’ex magistrato
Rosario Priore, titolare delle inchieste sulla strage di Ustica e autore con
Valerio Cutonilli del libro I segreti di Bologna, la verità storica apre scenari
completamente diversi.
Partiamo dall’inizio, perchè lei scarta la
pista neofascista?
«Da magistrato
rispetto la cosa giudicata, ma sul piano storico la ricostruzione presenta
numerose falle, dovute probabilmente al fatto che l’istruttoria del processo è
stata molto lunga, il che spesso si presta a inquinamenti di ogni genere. Gli
elementi che rimandano alla pista mediorientale, invece, sono molto evidenti e
in alcuni di questi mi sono imbattuto in prima persona nei processi da me
istruiti».
A che cosa si riferisce?
«Principalmente
alle dichiarazioni di Carlos, detto lo Sciacallo e membro del Fronte Popolare
per la Liberazione della Palestina. Non solo, però, io credo che il primo a
raccontare le cose per come andarono fu il presidente Francesco Cossiga, quando
parlò di esplosione prematura».
Non si trattò di una strage voluta?
«Io credo non
sia stato un atto doloso per colpire deliberatamente Bologna. La mia ipotesi è
che l’esplosivo si trovasse lì perchè doveva essere trasportato dai membri del
Fronte Popolare fino al carcere speciale di Trani, in cui era detenuto il
militante filopalestinese Abu Anzeh Saleh».
A che cosa serviva quell’esplosivo?
«Il
quantitativo fa pensare alla necessità di abbattere mura robuste, come quelle
del carcere di Trani. Io credo servisse a far evadere Saleh e che sia esploso
per errore a Bologna».
Era così facile per forze straniere trasportare
armi ed esplosivi in territorio italiano?
«In quel
periodo vigeva ancora il cosiddetto “lodo Moro”, che concedeva alle
organizzazioni palestinesi il libero passaggio sul suolo italiano con armi, al
fine di stoccarle e usarle successivamente, a patto che non agissero in
territorio italiano. Di questo patto esistono le prove, come i depositi di armi
in Sardegna e in Trentino».
Possiamo parlare di una sorta di disegno
internazionale?
«In quegli anni
gli attori in gioco erano molti e molto complessi. Da un lato i filopalestinesi,
dall’altro gli americani e la Nato. Noi ci trovavamo nel mezzo e Aldo Moro, da
politico raffinato quale è stato fino alla sua morte (nel 1978) sapeva che le
regole della partita andavano capite e interpretate».
Lei ha indagato anche sulla strage di Ustica,
che avvenne il 27 giugno, un mese prima della strage alla stazione, e in cui
persero la vita gli 81 passeggeri del volo Itavia, che viaggiava da Bologna a
Palermo. In questo caso una verità processuale chiara manca e le ipotesi
rimangono molte. Lei vede un legame con la strage di Bologna?
«Io credo
esista un legame generale tra i due eventi, come in tutti i fatti di quegli
anni. Anche in quella situazione si riverbera il “lodo Moro”, a cui ancora si
ispirava la nostra politica estera. In volo quella notte c’erano velivoli
stranieri non Nato, che sorvolavano i nostri cieli con il nostro benestare,
sfruttando i buchi sul controllo aereo del patto Atlantico».
Quindi lei scarta decisamente la teoria della
bomba a bordo dell’aereo?
«L’ipotesi
della bomba non regge. Non posso dire cosa sia successo quella notte, è
possibile che si sia trattato di una cosiddetta near-collision tra il volo di
linea e un altro aereo militare. Anche i radar indicano questa strada, così come
il ritrovamento sui monti calabresi di un aereo da guerra libico».
Tornando ai fatti di Bologna, il suo libro ha
scatenato molte polemiche e il presidente dell’associazione delle vittime Paolo
Bolognesi l’ha messa in guardia dal commettere il reato di depistaggio.
«Non voglio
alimentare polemiche ma trovo strane queste sue affermazioni. Lui si è battuto
una vita per capire cosa sia successo a Bologna, ma io ho fatto lo stesso, con
intento cronachistico. Entrambi abbiamo lo stesso obiettivo, trovare la verità».
E' nel 2014 quando Luigi Bisignani, uno degli
uomini più influenti della storia italiana, decise insieme al giornalista Paolo
Madron - ex firma de Il Foglio, Il Giornale, Panorama, Sole24ore e ora direttore
di Lettera43 - di svelare le verità più occulte che per moltissimo tempo mossero
l'Italia. Politici, industriali, papi, ministri protagonisti di un libro senza
precedenti che assume i toni di un romanzo. Il titolo "L'uomo che sussurra ai
potenti" è evocativo di un personaggio capo indiscusso del network che guida le
nomine più importanti del Belpaese dai ministri a quelle della Rai, dalle banche
all'esercito. Un capolavoro da decine di migliaia di copie, edito da
Chiarelettere, "L' uomo che sussurra ai potenti. Trent'anni di potere in Italia
tra miserie, splendori e trame mai confessate". Descrizione: Ministri, onorevoli
e boiardi di Stato fanno la fila nel suo ufficio per chiedergli consigli,
disegnare strategie e discutere di affari. Luigi Bisignani è unanimemente
riconosciuto come il capo indiscusso di un network che condiziona la vita del
paese. Non c'è operazione in cui non ci sia il suo zampino, dalle nomine dei
ministri a quelle in Rai, nei giornali, nelle banche e nell'esercito. La sua
influenza arriva persino in Vaticano. In questo libro, per la prima volta,
Bisignani decide di raccontarsi attraverso aneddoti ed episodi inediti. Da
Andreotti e la P2 a Berlusconi e Bergoglio. Lui che non appare mai in tv, non
scrive sui giornali e disdegna la mondanità. La sua testimonianza da questo
punto di vista è unica. Ecco come funziona il potere, quello vero, che non ha
bisogno di parole e agisce nell'ombra.
Chi è veramente Luigi Bisignani, uomo del
mistero? Un identikit dell'uomo che sussurra ai
potenti, scrive "Wuz". Un libro Chiarelettere che va esaurito nel giorno stesso
in cui arriva nelle librerie. Al centro della curiosità vorace dei lettori, la
figura di Luigi Bisignani, affarista conosciuto e temuto da moltissimi
politici. Di lui, Berlusconi ha avuto a dire che era "l'uomo più potente
d'Italia"... ma quali sono le cose che sappiamo con certezza, su questo
Richelieu in sedicesimo la cui discrezione è direttamente proporzionale al
potere che è in grado di esercitare? Ecco un breve estratto dal libro-intervista
pubblicato da Chiarelettere, e firmato dal giornalista Paolo Madron. Sono solo
poche righe, per tratteggiare un carattere che vedremmo bene portato sul grande
schermo da Sorrentino, magari sulla falsariga di quella grottesca commedia del
potere ammirata ne Il divo (che raccontava dell'esempio cui massimamente
Bisignani si è ispirato nella sua quarantennale carriera dietro le quinte, e
cioè Giulio Andreotti). Quello di Bisignani è un libro la cui lettura
consigliamo; ci permettiamo però di consigliare qualche cautela nel prendere per
buono tutto ciò che in esso viene raccontato. Se è vero che l'uomo è arrivato
dove è arrivato grazie alle sue capacità strategiche e alla sua grande cautela,
infatti, è difficile pensare che all'improvviso Bisignani abbia deciso di
mettere sul piatto i segreti di cui è geloso custode (e al cui mantenimento è
probabilmente legato l'ascendente di cui gode presso i politici). Più facile
invece che Mister B. abbia deciso, anche in seguito alle sue recenti,
travagliate vicende giudiziarie, di offrire a (tutti) i suoi potenziali lettori
l'assaggio di una cena che sarebbero in pochi ad aver voglia di gustare fino in
fondo. Diciamo che in queste pagine si respira il fumo (saporito, non c'è che
dire) di un arrosto che il nostro cuoco tiene ben caldo in forno, portata
principale che immaginiamo non arriverà a tavola tanto presto. Sul libro:
Ministri, onorevoli e boiardi di Stato fanno la fila nel suo ufficio per
chiedergli consigli, disegnare strategie e discutere di affari. Luigi
Bisignani è riconosciuto come il capo indiscusso di un network che condiziona la
vita del paese. Non c’è operazione - si dice - in cui non ci sia il suo zampino,
dalle nomine dei ministri a quelle in Rai, nei giornali, nelle banche e
nell’esercito. La sua influenza arriva persino in Vaticano. In "L'uomo che
sussurra ai potenti", per la prima volta, Bisignani "vuota il sacco" e decide di
raccontarsi attraverso aneddoti ed episodi inediti: da Andreotti e
la P2 a Berlusconi e Bergoglio. L'uomo che sussurra ai potenti non appare mai in
tv, naturalmente. Non scrive sui giornali e disdegna la mondanità. La sua
testimonianza - da questo punto di vista - è realmente unica. Quindi questo
libro ci offre un cannocchiale privilegiato per gettare uno sguardo da vicino
sul potere più forte e inossidabile: il potere vero, che fa economia di parole e
si muove con assoluta efficacia fra le stanze di Palazzo.
IDENTIKIT – cosa il signor B. dice di sé stesso:
1. Inguaribile ottimista, amo il sole e il mare;
2. Le mie conversazioni sono rapide, in genere non
superano i 15 minuti;
3. Il mio segreto è che resto sempre a
disposizione dei miei amici;
4. Non cerco ritorni;
5. So come va il mondo;
6. Non mi piace apparire;
7. Non partecipo a cene con più di sei persone;
8. Gianni Barbacetto mi ha definito L’uomo dei
collegamenti;
9. Maurizio Crozza dice che ho più amici di
facebook;
10. Qualcuno dice che sono un battitore
libero senza padroni né padrini;
11. Io direi che sono uno stimolatore
d’intelligenze: quando una persona valida mi piace immagino quale ruolo potrebbe
ricoprire.
L'uomo che sussurrava ai potenti. Alter
ego di Letta. Regista di mezzo governo. Ispiratore dei manager pubblici.
Bisignani è l'uomo ombra della seconda Repubblica. E ora fa tremare il sistema
Berlusconi, scrive Marco Damilano su “L’Espresso” il 23 giugno 2011. Al suo
successo avevano contribuito una congerie di potentati difficilmente collegabili
tra loro, ma che lui era sempre riuscito a usare, manovrandoli come pedine su
un'immaginaria scacchiera del potere...". Martedì 21 giugno, solstizio d'estate,
il calendario segna san Luigi Gonzaga, ma il san Luigi di piazza di Spagna,
confessore di ministre e di boiardi di Stato, non può più rispondere: è agli
arresti domiciliari. E qualcuno nei palazzi romani rilegge l'incipit di un
romanzo anni Ottanta denso di spioni, cardinali, belle donne, in cui l'autore
sembrava volersi descrivere, consegnare la verità più profonda su di sé. "Il
sigillo della porpora", si intitolava quella spy-story all'italiana che fu
presentata al teatro Eliseo, e peccato che non ci fosse ancora "Cafonal" a
immortalare la scena: il ministro degli Esteri Giulio Andreotti recensore
entusiasta ("Il gelido protagonista si commuove solo quando gli uccidono la
figlia: una pagina di toccante ed eloquente umanità"), il giovane e rampante
Giuliano Ferrara, il re dei critici Enzo Siciliano, e in mezzo a loro lo
scrittore, il 35enne Luigi Bisignani. Di quella serata indimenticabile resta
qualche scatto, null'altro. Dalla condanna per la tangente Enimont a due anni e
sei mesi (1994) Bisignani è scomparso dalle cronache: un'ombra che ha
attraversato l'intera Seconda Repubblica. E ora l'Ombra torna alla luce, con
l'inchiesta di Napoli dei pm Curcio e Woodcock, nel pieno di una nuova
traumatica transizione politica. Spiega un notabile a Montecitorio: "Siamo come
all'8 settembre: una corte in fuga, un governo che si dissolve, eserciti in
rotta. Pezzi di Stato contro pezzi di Stato, apparati contro apparati. Una
guerra di tutti contro tutti, che si può concludere solo con un ricambio di
classe dirigente. O che soffocherà tutti nei suoi miasmi". Nei palazzi rileggono
i verbali dell'inchiesta e riconoscono in controluce nella storia di Bisignani
la parabola della politica di questi vent'anni. "Ai tempi di Andreotti,
Bisignani era un piglia e porta. Stava in anticamera ed eseguiva. Su uno come
Geronzi, Giulio ironizzava: "È come un taxi, anche se conserva la ricevuta"",
spiega un ex democristiano di rango. "Dirigenti pubblici, banchieri, consiglieri
di Stato, i De Lise, i Calabrò, i Catricalà, erano guidati dai politici. Svaniti
i partiti con la bufera Tangentopoli hanno dovuto trovarsi altri
referenti". Interessi senza volto. Comunanze e affinità che sostituiscono le
sedi visibili. Filiere trasversali. Come quella, ad esempio, personificata da
Cesare Previti: in apparenza dormiente e condannato, ma ancora abbastanza
influente da far inserire nelle liste per la Camera del Pdl Alfonso Papa, il
magistrato distaccato nel ministero di via Arenula e oggi deputato Pdl amante di
Rolex e di Jaguar di cui i pm napoletani hanno richiesto l'arresto. La filiera
che più si sente minacciata e desiderosa di protezione, però, è un'altra:
bastava vedere il balletto improvvisato da Berlusconi nell'aula del Senato, un
inconsueto giro di strette di mano tra i banchi del governo per arrivare a
stringere davanti a tutti quella del sottosegretario alla presidenza del
Consiglio, il dottor Gianni Letta. A legare il sodalizio tra i due, un quarto di
secolo fa, fu Bisignani. All'imprenditore di Arcore serviva un presidio a Roma.
E Bisignani non ebbe esitazioni, indicò a Silvio l'uomo giusto: il dottor Letta,
appunto. Letta da direttore del "Tempo" diventa il decoder di Berlusconi nella
capitale, e poi il gran ciambellano di Palazzo Chigi, il governante che nessuno
ha votato e di cui nessuno conosce le idee politiche e che pure viene candidato
alle più alte cariche. L'inchiesta Bisignani lo fulmina alla vigilia della
possibile consacrazione istituzionale, la nomina a senatore a vita e perfino il
Quirinale. E se Letta risolve i problemi di Berlusconi, l'Ombra Bisignani è il
personaggio che spiccia le faccende di mezzo governo, dei vertici degli enti
pubblici, del Gotha dell'impresa privata e dei servizi segreti, da Cesare
Geronzi a Fabrizio Palenzona. A lui si affidano i ministri e le ministre di
Berlusconi: a Gigi si rivolge con familiarità il titolare della Farnesina Franco
Frattini, a lui ricorre il trio rosa Stefania Prestigiacomo, Mara Carfagna,
Mariastella Gelmini. Più confidenziale Stefania ("Se escono le intercettazioni
sono rovinata"), più prudente Mara, più ambiziosa Mariastella. Ruota attorno
all'ufficio di piazza Mignanelli lo stato maggiore della corrente del Pdl
Liberamente ("Forse avrebbero dovuto chiamarsi Bisignanamente", maligna un
deputato). Vicino a Bisignani è il titolare delle Infrastrutture Altero
Matteoli, tramite il braccio destro Erasmo Cinque. Mentre tra i finiani di
Futuro e libertà, capolavoro, si abbeverano ai consigli di Gigi entrambe le
anime: il falco Italo Bocchino e la colomba Andrea Ronchi, ministro nel 2008 per
grazia ricevuta, forse non solo di Gianfranco Fini. A Palazzo Grazioli l'Ombra
può contare sulla vecchia conoscenza Daniela Santanchè: fu lui il regista
dell'operazione Destra, quando la Sarah Palin di Cuneo si candidò premier con il
partito di Francesco Storace, fu ancora lui a spingerla a fondare l'agenzia
Visibilia, per raccogliere pubblicità per "Libero" degli Angelucci. E c'è il
sindaco di Roma Gianni Alemanno, che a leggere la testimonianza del suo ex capo
di gabinetto Maurizio Basile, usava cenare a casa della mamma di Bisignani, la
signora Vincenzina, per discutere del Gran premio a Roma e chiedere a san Luigi
di intercedere presso Flavio Briatore. L'aggancio giusto per la F1, manco a
dirlo: il figlio di Bisignani lavora in Ferrari e con il presidente del
Cavallino Rampante c'è una vecchia simpatia. "Di casa a New York come a Parigi,
amante delle lunghe gita in bicicletta e della scultura moderna, Luca Cordero di
Montezemolo è diventato un manager tenace con un notevole carisma che, a sentire
i sondaggi, l'ha imposto come uno degli italiani più conosciuti", magnificava
l'allora redattore ordinario dell'Ansa Bisignani in un sobrio lancio del 15
novembre 1991. Ma c'era da capirlo: emarginato nell'agenzia dopo lo scandalo P2,
costretto a occuparsi di camionisti o di poco eccitanti convegni come quello su
"Etica e professione" ("Il giornalista deve liberarsi dai cordoni ombelicali del
potere economico e politico", tuonava), era stato salvato da Montezemolo:
"Nell'89, in occasione dei Mondiali di calcio, noi dell'organizzazione ottenemmo
il suo distacco dall'Ansa", ha dichiarato l'ex presidente di Confindustria
interrogato dai pm sulle richieste di raccomandazione per l'amico Gianni Punzo e
per l'ex compagna Edwige Fenech. Naturale un po' di gratitudine, anche se sono
trascorsi vent'anni. Come appare del tutto normale, nel Bisi-mondo, la rete ai
vertici di Eni, Enel, Finmeccanica, Poste, Ferrovie. E la pubblicità di 100 mila
euro arrivata dall'Eni a Dagospia per interessamento di san Luigi. Più
complicato da spiegare, perfino per un professionista del potere come Bisignani,
perché il direttore generale della Rai Mauro Masi si rivolgesse a lui per farsi
scrivere la lettera con cui puntava a licenziare Michele Santoro, lo chiamasse
con l'assiduità del molestatore e con toni non certo da grand commis: "Je stamo
a spaccà er culo". "Mi occupavo di Rai perché ero convinto che Masi non fosse
all'altezza", ha provato a giustificarsi il povero Bisignani. E sì che Gigi ha
fatto con Mauro coppia fissa: entrambi legati a Lamberto Dini e a Letta, senza
trascurare la rive gauche. Tra il 2006 e il 2008 Masi è stato capo di gabinetto
di Massimo D'Alema vice-premier del governo Prodi. E anche Bisignani poteva
vantare ottima accoglienza dalle parti dell'ex leader Ds: fu lui a portare il
direttore dell'Aise, il generale Adriano Santini, dal presidente del Copasir.
"Il generale mi chiese una mano per la sua carriera e mi chiese di parlare bene
di lui con Letta. Chiesi a D'Alema se potevo portargli Santini, lui mi disse di
sì", ha raccontato a Curcio e Woodcock. Anche in questo caso, giurano i
protagonisti, nulla di strano: "Conosco Bisignani da 35 anni", ha testimoniato
D'Alema. "Lui conosceva mio padre, era presidente della commissione Finanze
della Camera, Bisignani era il portavoce del ministro". Nel '77 D'Alema aveva 28
anni ed era il capo dei giovani comunisti, Bisignani ne aveva appena 23 ed era
il più giovane piduista. Vite parallele, in un'Italia in cui tutti si conoscono.
E in cui, nonostante l'alternanza dei diversi schieramenti al governo, certi
nomi non tramontano mai. Ora siamo alla vigilia di un nuovo cambio. Se n'è
discusso tre mesi fa, sussurra chi sa, in un incontro a porte chiuse all'Aspen
sul tema della riforma dei servizi segreti. Pochi gli invitati, c'erano D'Alema
e Giuliano Amato, c'era il prefetto Gianni De Gennaro, incrollabile punto di
riferimento di questi anni travagliati anche oltre Atlantico, c'era il
presidente dell'Istituto Giulio Tremonti, da molti indicato come il vero
beneficiario di un terremoto che fa vacillare i suoi avversari nel governo.
Assente il procuratore aggiunto di Milano Francesco Greco, che indagò su
Bisignani ai tempi Enimont e alle cui analisi il ministro dell'Economia è molto
attento. In questi ambienti c'è preoccupazione per le conseguenze dell'inchiesta
e si discute già della fase successiva: un governo del Presidente. "Berlusconi
doveva avere il coraggio di voltare pagina. All'Italia serve un governo forte e
credibile e il Cavaliere non ha più carte da giocare", ripetono. Il premier non
ci sente, prova a blindarsi nel bunker di Palazzo Chigi tra un voto di fiducia e
l'altro, aggrappato a una maggioranza nel caos e a un Letta vistosamente
indebolito. Tremonti al Senato per il dibattito sulla verifica non si è fatto
neppure vedere. E l'Ombra, intanto, continuerà a far tremare con le sue
rivelazioni. Il più consapevole che il game is over, la storia è finita, è
proprio lui, Bisignani. "Ora che dalla cima si poteva guardare indietro, gli
capitava spesso di chiedersi, rabbrividendo, se avrebbe sfidato ancora l'azzardo
come gli era capitato tante volte durante l'ascesa", aveva scritto Bisignani nel
suo primo romanzo. Ma adesso il suo azzardo coinvolge un intero Sistema.
“Avrei voluto un amico come lui”
– David Gramiccioli omaggia Rino Gaetano, scrive il 14 settembre
2015 "lastella". Riceviamo & pubblichiamo da David Gramiccioli. Dagli anni 70 a
oggi non è cambiato niente. Ieri il braccio armato di quel potere occulto e
deviato (oggi sempre meno occulto e sempre più deviato) era Franco Giuseppucci
detto Er Negro, primo, indiscusso capo della banda della Magliana. Oggi Massimo
Carminati, forse non è un caso che il secondo rappresenti l’ideale contiguità
con quell’esperienza criminale. Negli anni 70 il fronte criminale romano si
arricchì con il commercio della droga, successivamente con il business
immobiliare. Oggi, che la droga sembra non essere più il filone aureo di una
volta e con la profonda crisi che sta vivendo l’edilizia, si “investe” sulla
disperazione umana (immigrati e zingari). Tangentopoli produsse, colossale
bluff, una nuova legge elettorale per l’elezione dei sindaci, in molti
esultarono all’idea che finalmente sarebbero stati i cittadini, per la prima
volta nella storia repubblicana e democratica del paese, a eleggere direttamente
un sindaco. In realtà si rafforzò ancora di più il potere politico di alcuni
leader che avevano a cuore tutto tranne che il bene e la ripresa del paese. La
televisione, il riscontro mediatico fissavano sempre di più i parametri del
successo in ogni campo della nostra società. Quando parliamo del nostro paese,
della nostra amata Italia, non dobbiamo dimenticarci mai cosa è accaduto dall’8
di settembre 1943 a oggi. Legge truffa subito dopo la morte di Stalin,
Capocotta. Tragedia del Vajont, Giorgiana Masi…i rapporti tra
massoneria-politica-criminalità. Nessuno come lui ha cantato la nostra storia,
nessuno come lui, cantava: “ma chi me sente”, era consapevole della solitudine
artistica e umana alla quale è condannato il genio, ma nel profondo del suo
animo Rino nutriva, lo disse pubblicamente una sera, una grande speranza; quella
che un giorno grazie alla comunicazione di massa la gente potesse finalmente
comprendere il significato dei testi delle sue canzoni.
Recensione di Giada Ferri dello spettacolo
teatrale “Avrei voluto un amico come lui. Omaggio a Rino Gaetano” di David
Gramiccioli. Finalmente uno spettacolo teatrale dai contenuti ben scelti e
approfonditi che tocca con estrema professionalità e non meno stile una sequenza
di vicissitudini italiane per lo più rimaste impunite. Spettacolo che dà il
giusto lustro alla figura del diretto ispiratore, il cantautore Rino Gaetano,
menzionato con intelligenza e garbo, non tentando di snaturarne la criptica
essenza con convinzioni pregiudizievoli nei suoi confronti, ma evidenziando il
suo genio nel trattare eventi, di diverse collocazioni spazio-temporali, che gli
stanno a cuore. Ci si immerge infatti in un viaggio nella Memoria, condotto
magistralmente da David Gramiccioli (giornalista e speaker radiofonico),
attraverso alcuni dei più rilevanti fatti di cronaca nera e scandali della
storia italiana, dal secondo dopoguerra agli anni ’70, per mezzo della chiave di
lettura che il cantautore dà a quei fatti, trasformandoli in frasi cardine delle
sue canzoni. Si pensi a “Spendi per opere assistenziali e per sciagure
nazionali” (in Fabbricando case) e a “Il numero 5 sta in panchina, s’è alzato
male stamattina” (in Nuntereggae più) riferite a personaggi coinvolti nella
strage annunciata del Vajont oppure a “Il nostro è un partito serio” (sempre
in Nuntereggae più) con tanto di imitazione dell’inflessione dell’allora
dirigente del PCI Berlinguer, all’indomani del “Governo delle astensioni”, nel
1976. La stessa frase viene pronunciata anche da Cossiga, sardo pure lui e al
tempo Ministro dell’Interno, quando è chiamato a rispondere degli incresciosi
fatti dell’anno successivo, che vedono cadere Giorgiana Masi raggiunta da un
misterioso proiettile durante una manifestazione. Ancora, ai nomi fatti
in Standard, ricordandoci dello scandalo Lockheed e ai nomi censurati alla
stessa Nuntereggae più, brano cardine della pièce poiché, come si vedrà,
racchiude in sé allusioni anche al delitto Montesi nella sua frase ormai
nota “…sulla spiaggia di Capocotta”. Ma questa non è che una modesta
anticipazione di quelli che sono gli argomenti toccati dall’autore. David
Gramiccioli ha conosciuto la grande forza di Rino Gaetano leggendo i suoi
testi. Non ha preteso di interpretarlo ed etichettarlo, ma affronta le vicende
contenute nelle sue parole senza preconcetti e infondati collegamenti, come a
volte, pur di dare un senso alla sua prematura scomparsa, si sia spinti a fare,
costruendone un lato oscuro invece di ammirare le sue doti straordinarie legate
alla sua dedizione a tenere sempre gli occhi aperti, nella scelta coraggiosa di
smascherare gli intrighi del Potere anziché farne parte. È così quindi che
l’autore scrive questa sceneggiatura, con estrema lucidità e oggettività, senza
attingere a dietrologie non provate e senza farcire di orpelli e convinzioni
personali quegli intrecci nefasti tutti italiani, bensì lasciando lo spettatore
alle proprie deduzioni, stimolandone tuttavia l’interesse a saperne di più e
favorendone l’utile ragionamento circa i casi trattati. Gramiccioli, oltre ad
aver creato uno spettacolo a scopo benefico, ha veramente reso “Omaggio a Rino
Gaetano”. I contenuti della sceneggiatura sono fedeli al titolo. Giada Ferri.
“Avrei voluto un amico come lui”, tour itinerante
della Compagnia Teatro Artistico d’Inchiesta guidata dal giornalista performer
David Gramiccioli. «Nessuno come Rino Gaetano – si legge nelle note di regia –
ha cantato la nostra storia, nessuno come lui, cantava “ma chi me sente”,
consapevole della solitudine artistica e umana alla quale è condannato il genio.
Ma nel profondo del suo animo Rino nutriva – e lo disse pubblicamente una sera –
la speranza che un giorno, grazie alla comunicazione di massa, gli italiani
potessero finalmente comprendere il significato vero dei testi delle sue
canzoni».
Nemmeno al mare si può stare tranquilli.
Cazzotti, toilette da incubo e sesso
sfrenato Le spiagge diventano gironi infernali. I
vigili di Follonica aggrediti dagli ambulanti ultimo capitolo del degrado
estivo, scrive Michela Giachetta, Martedì 02/08/2016, su "Il Giornale". Agenti
aggrediti da venditori abusivi in Toscana, centinaia di immigrati che, prima
ancora del sorgere del sole, invadono il bagnasciuga in Liguria. Ma anche coppie
che fanno sesso in riva al mare, in pieno giorno, senza curarsi dei bambini, che
sono lì, a pochi metri, a giocare con la sabbia. E poi la sporcizia, le
bottiglie di plastica o di vetro abbandonate, i cumuli di rifiuti che
incorniciano panorami che sarebbero solo da ammirare, se non ci fosse quel
degrado. Da Nord a Sud, le spiagge italiane sono in preda a incuria,
trascuratezza, trattate malissimo in alcuni casi, come se non fossero uno dei
nostri patrimoni da tutelare. Gli esempi negativi non mancano. A Castel
Porziano, a due passi da Roma, dove c'è anche la tenuta presidenziale, prima
ancora di arrivare in spiaggia si è accolti dai parcheggiatori abusivi. La
situazione poi si complica se durante la giornata bisogna andare in bagno: le
toilette o mancano o sono inavvicinabili per odore e sporcizia. Una situazione
di degrado che si può trovare anche in altri posti. A giugno Legambiente
Arcipelago ha denunciato le pessime condizioni in cui versa la spiaggia della
Cala, a Marciana Marina, nella splendida isola d'Elba: quello che resta di
vecchie imbarcazioni giace completamente abbandonato, così come sono abbandonate
e fatiscenti le strutture che le ospitano. «Per non parlare della tettoia, ormai
ridotta a pochi e pericolosi elementi di copertura». Rimanendo in Toscana,
qualche giorno fa, a Follonica (Grosseto), tre agenti della polizia municipale,
che stavano effettuando controlli di routine sulle spiagge, sono stati aggrediti
da una decina di venditori ambulanti, che si sono opposti a quei controlli,
reagendo con calci e pugni contro i vigili. Gli agenti sono riusciti a fermare
solo una persona, gli altri sono tutti scappati, creando il parapiglia in
spiaggia. Nella stessa località un episodio simile si era già verificato una
decina di giorni prima. Scene che hanno a che fare poco col degrado, ma molto
con quella serenità che dovrebbe regnare sulle spiagge. In Liguria, invece, ha
raccontato La Stampa, centinaia di immigrati, per lo più del Sud America, prima
dell'alba, arrivano sulla spiaggia libera di Laigueglia (Savona), per passare
una giornata al mare. Partono col buio da Milano o da Torino, spesso in pullman.
Quando il sole si sveglia, lì trova già tutti lì, con i loro teli, i giochi per
i bambini, i frigoriferi portatili che contengono i loro pranzi fai da te. Le
lamentele non mancano: perché la spiaggia a fine giornata bisogna pulirla, ma
gli immigrati non hanno speso nulla nelle strutture circostanti, i bagni inoltre
sono pochi e comunque insufficienti, così come i controlli. L'assenza di
controlli è un leitmotiv che accompagna tutta la penisola: già a maggio, i
giornali locali calabresi raccontavano il degrado e l'incuria di alcune spiagge
a Vibo Marina, frazione di Vibo Valentia. A giugno a Salerno le proteste dei
comitati di zona non sono mancate: nella parte orientale della città gli arenili
erano ostaggio di topi scorrazzanti fra i bagnati e blatte volanti, una
situazione disastrosa. Anche a Villasimius, in Sardegna, alcune spiagge sono
state lasciate al più completo abbandono e piene di rifiuti. Così come a
Brindisi, dove a maggio, alcune persone hanno preso il sole circondate non solo
dal rumore del mare, ma anche da un cumulo di sporcizia. Non ci sono però solo
l'immondizia e i rifiuti con cui fare i conti: che l'estate sia la stagione
degli amori, si sa, ma capita che alcuni quel detto lo prendano fin troppo alla
lettera: accade che, presi dalla passioni, si spoglino anche di quel poco che
hanno indosso per fare sesso in spiaggia, in pieno giorno, sono gli occhi dei
bimbi (che forse non capiscono) e sotto gli sguardi degli adulti che capiscono
bene e spesso sono costretti a chiamare le autorità competenti per far cessare
l'amplesso. È capitato a maggio nelle Marche, a Civitanova: due italiani sono
stati denunciati. Stessa sorte di una coppia di tedeschi: in una spiaggia vicino
a Venezia un uomo e una donna, completamente nudi, hanno scelto di fare sesso,
completamente nudi. Spiaggia che vai, degrado che trovi. E se non è degrado, è
trascuratezza. Da nord a sud. Per fortuna però le eccezioni esistono.
Come conoscere gli altri?
Chiedendogli se puoi accendere il climatizzatore
in auto o in casa. Una persona si dimostra veramente quello che è nella vita ed
il rispetto che questa non ha in confronto agli altri, quando da passeggera
(anche se posteriore) fa spegnere il climatizzatore in auto, accusando mal di
gola, mentre all’esterno ci sono 40°, costringendo gli altri passeggeri ed il
proprietario dell’auto a fare bagni di sudore. E la stessa cosa costringerà a
fare negli uffici e nelle case altrui. La mancanza di rispetto per gli altri,
specialmente verso i familiari, sarà costante ed alla fine, quando l’orlo è
colmo e lo farai notare, lo rinnegherà esaltando le sue virtù ed, anzi, ti
accuserà di intolleranza e per ritorsione ti affibbierà qualsiasi difetto
innominabile.
Chiedendogli come programma le cose da fare. Una
persona si dimostra veramente quello che è nella vita ed il rispetto che questa
non ha in confronto agli altri, quando pretende e dà per scontato l’ausilio
altrui, anche quando gli altri hanno programmi alternativi ai suoi.
Chiedendogli cosa pensa delle persone che dalla
vita e dal lavoro hanno avuto soddisfazione. Una persona si dimostra veramente
quello che è nella vita ed il rispetto che questa non ha in confronto agli
altri, quando da nullafacente e nullatenente sparlerà di chi ha successo nella
vita e lo accuserà di aver rubato per ottenere quello che egli stesso non ha.
Salvo eccezioni.
"Fiat brava gente": così gli Agnelli
hanno rapinato l'Italia lungo un intero secolo, scrive
“L’Antidiplomatico il 27 luglio 2016. Hanno deciso di abbandonarla
definitivamente anche come sede legale e fiscale, dopo che, scrive
correttamente Giorgio Cremaschi oggi, non resta più nulla da spolpare e poi è
sempre meglio essere lontano (tra Stati Uniti e Olanda) quando si tratta di
chiudere i prossimi stabilimenti o licenziare i prossimi dipendenti. "Come le
peggiori classi parassitarie che hanno saccheggiato questo paese nei lunghi
secoli della sua spesso triste storia, gli Agnelli lasciano l'Italia dopo aver
usato ed abusato del sacrificio di milioni di persone e di una montagna di soldi
pubblici. Migrano come cavallette, cavallette europeiste", scrive Cremaschi. Ma
la Fiat e la famiglia Agnelli hanno una storia molto lunga legata al nostro
paese. In un lungo e dettagliato articolo del 2011 Maria Rosa Calderoni su
Liberazione (ripreso anche da Marx 21) la ripercorreva tutto. Il 2011 è un anno
importante, l'inizio della rivoluzione di Marchionne di cui subiamo ancora oggi
tutti i drammatici effetti nell'Italia di Renzi. "Mani in alto, Marchionne!
Questa è una rapina", concludeva l'articolo di Calderoni. E' giunto il momento
che come contribuenti e cittadini derubati ci si mobilitasse per chiedere la
restituzione dei nostri soldi. Di Maria Rosa Calderoni su Liberazione. Gioanin
lamiera, come scherzosamente gli operai chiamavano l'Avvocato, ha succhiato di
brutto; ma prima di lui ha succhiato suo padre; e prima di suo padre, suo nonno
Giovanni. Giovanni Agnelli Il Fondatore. Hanno succhiato dallo Stato, cioè da
tutti noi. E' una storia della Fiat a suo modo spettacolare e violenta, tipo
rapina del secolo, questa che si può raccontare - alla luce dell'ultimo blitz di
Marchionne - tutta e completamente proprio in chiave di scandaloso salasso di
denaro pubblico. Un salasso che dura da cent'anni. Partiamo dai giorni che
corrono. Per esempio da Termini Imerese, lo stabilimento ormai giunto al
drammatico epilogo (fabbrica chiusa e operai sul lastrico fuori dai cancelli).
Costruito su terreni regalati dalla Regione Sicilia, nel 1970 inizia con 350
dipendenti e 700 miliardi di investimento. Dei quali almeno il 40 per cento è
denaro pubblico graziosamente trasferito al signor Agnelli, a vario titolo. La
fabbrica di Termini Imerese arriva a superare i 4000 posti di lavoro, ma ancora
per grazia ricevuta: non meno di 7 miliardi di euro sborsati pro Fiat dal solito
Stato magnanimo nel giro degli anni. Agnelli costa caro. Calcoli che non peccano
per eccesso, parlano di 220 mila miliardi di lire, insomma 100 miliardi di euro
(a tutt'oggi), transitati dalle casse pubbliche alla creatura di Agnelli. Nel
suo libro - "Licenziare i padroni?", Feltrinelli - Massimo Mucchetti fa alcuni
conti aggiornati: «Nell'ultimo decennio il sostegno pubblico alla Fiat è stato
ingente. L'aiuto più cospicuo, pari a 6059 miliardi di lire, deriva dal
contributo in conto capitale e in conto interessi ricevuti a titolo di incentivo
per gli investimenti nel Mezzogiorno in base al contratto di programma stipulato
col governo nel 1988». Nero su bianco, tutto "regolare". Tutto alla luce del
sole. «Sono gli aiuti ricevuti per gli stabilimenti di Melfi, in Basilicata, e
di Pratola Serra, in Campania». A concorrere alla favolosa cifra di 100
miliardi, entrano in gioco varie voci, sotto forma di decreti, leggi, "piani di
sviluppo" così chiamati. Per esempio, appunto a Melfi e in Campania, il gruppo
Agnelli ha potuto godere di graziosissima nonché decennale esenzione
dell'imposta sul reddito prevista ad hoc per le imprese del Meridione. E una
provvidenziale legge n.488 (sempre in chiave "meridionalistica") in soli quattro
anni, 1996-2000, ha convogliato nelle casse Fiat altri 328 miliardi di lire,
questa volta sotto la voce "conto capitale". Un bel regalino, almeno 800
miliardi, è anche quello fatto da tal Prodi nel 1997 con la legge - allestita a
misura di casa Agnelli, detentrice all'epoca del 40% del mercato - sulla
rottamazione delle auto. Per non parlare dell'Alfa Romeo, fatta recapitare
direttamente all'indirizzo dell'Avvocato come pacco-dono, omaggio sempre di tal
Prodi. Sempre secondo i calcoli di Mucchetti, solo negli anni Novanta lo Stato
ha versato al gruppo Fiat 10 mila miliardi di lire. Un costo altissimo è poi
quello che va sotto la voce "ammortizzatori sociali", un frutto della oculata
politica aziendale (il collaudato stile "privatizzazione degli utili e
socializzazione delle perdite"): cassa integrazione, pre-pensionamenti,
indennità di mobilità sia breve che lunga, incentivi di vario tipo. «Negli
ultimi dieci anni le principali società italiane del gruppo Fiat hanno fatto
147,4 milioni di ore di cassa integrazione - scrive sempre Mucchetti nel libro
citato - Se assumiamo un orario annuo per dipendente di 1.920 ore, l'uso della
cassa integrazione equivale a un anno di lavoro di 76.770 dipendenti. E se
calcoliamo in 16 milioni annui la quota dell'integrazione salariale a carico
dello Stato nel periodo 1991-2000, l'onere complessivo per le casse pubbliche
risulta di 1228 miliardi». Grazie, non è abbastanza. Infatti, «di altri 700
miliardi è il costo del prepensionamento di 6.600 dipendenti avvenuto nel 1994:
e atri 300 miliardi se ne sono andati per le indennità di 5.200 lavoratori messi
in mobilità nel periodo». Non sono che esempi. Ma il conto tra chi ha dato e chi
ha preso si chiude sempre a favore della casa torinese. Ab initio. In un lungo
studio pubblicato su "Proteo", Vladimiro Giacché traccia un illuminante profilo
della storia (rapina) Fiat, dagli esordi ad oggi, sotto l'appropriato titolo
"Cent'anni di improntitudine. Ascesa e caduta della Fiat". Nel 1911, la appena
avviata industria di Giovanni Agnelli è già balzata, con la tempestiva
costruzione di motori per navi e soprattutto di autocarri, «a lucrare buone
commesse da parte dello Stato in occasione della guerra di Libia». Non senza
aver introdotto, già l'anno dopo, 1912, «il primo utilizzo della catena di
montaggio», sulle orme del redditizio taylorismo. E non senza aver subito
imposto un contratto di lavoro fortemente peggiorativo; messo al bando gli
"scioperi impulsivi"; e tentato di annullare le competenze delle Commissioni
interne. «Soltanto a seguito di uno sciopero durato 93 giorni, la Fiom otterrà
il diritto di rappresentanza e il riconoscimento della contrattazione
collettiva» (anno 1913). Anche il gran macello umano meglio noto come Prima
guerra mondiale è un fantastico affare per l'industria di Giovanni Agnelli,
volenterosamente schierata sul fronte dell'interventismo. I profitti (anzi, i
"sovraprofitti di guerra", come si disse all'epoca) furono altissimi: i suoi
utili di bilancio aumentarono dell'80 per cento, il suo capitale passò dai 17
milioni del 1914 ai 200 del 1919 e il numero degli operai raddoppiò, arrivando a
40 mila. «Alla loro disciplina, ci pensavano le autorità militari, con la
sospensione degli scioperi, l'invio al fronte in caso di infrazioni disciplinari
e l'applicazione della legge marziale». E quando viene Mussolini, la Fiat (come
gli altri gruppi industriali del resto) fa la sua parte. Nel maggio del '22 un
collaborativo Agnelli batte le mani al "Programma economico del Partito
Fascista"; nel '23 è nominato senatore da Mussolini medesimo; nel '24 approva il
"listone" e non lesina finanziamenti agli squadristi. Ma non certo gratis. In
cambio, anzi, riceve moltissimo. «Le politiche protezionistiche costituirono uno
scudo efficace contro l'importazione di auto straniere, in particolare
americane». Per dire, il regime doganale, tutto pro Fiat, nel 1926 prevedeva un
dazio del 62% sul valore delle automobili straniere; nel '31 arrivò ad essere
del 100%; «e infine si giunse a vietare l'importazione e l'uso in Italia di
automobili di fabbricazione estera». Autarchia patriottica tutta ed
esclusivamente in nome dei profitti Fiat. Nel frattempo, beninteso, si
scioglievano le Commissioni interne, si diminuivano per legge i salari e in Fiat
entrava il "sistema Bedaux", cioè il "controllo cronometrico del lavoro": ottimo
per l'intensificazione dei ritmi e la congrua riduzione dei cottimi. Mussolini,
per la Fiat, fu un vero uomo della Provvidenza. E' infatti sempre grazie alla
aggressione fascista contro l'Etiopia, che la nuova guerra porta commesse e gran
soldi nelle sue casse: il fatturato in un solo anno passa da 750 milioni a 1
miliardo e 400 milioni, mentre la manodopera sale a 50 mila. «Una parte dei
profitti derivanti dalla guerra d'Etiopia - scrive Giacché - fu impiegata (anche
per eludere il fisco) per comprare i terreni dove sarebbe stato costruito il
nuovo stabilimento di Mirafiori». Quello che il Duce poi definirà «la fabbrica
perfetta del regime fascista». Cospicuo aumento di fatturato e di utili anche in
occasione della Seconda guerra mondiale. Nel proclamarsi del tutto a
disposizione, sarà Vittorio Valletta, nella sua veste di amministratore
delegato, a dare subito «le migliori assicurazioni. Ponendo una sola condizione:
che le autorità garantissero la disciplina nelle fabbriche attraverso la
militarizzazione dei dipendenti». L'Italia esce distrutta dalla guerra, tra fame
e macerie, ma la casa torinese è già al suo "posto". Nel '47 risulta essere
praticamente l'unica destinataria dell'appena nato "Fondo per l'industria
meccanica"; e l'anno dopo, il fatidico '48, si mette in tasca ben il 26,4% dei
fondi elargiti al settore meccanico e siderurgico dal famoso Piano Marshall. E
poi venne la guerra fredda, e per esempio quel grosso business delle commesse
Usa per la fabbricazione dei caccia da impiegare nel conflitto con la Corea. E
poi vennero tutte quelle autostrade costruite per i suoi begli occhi dalla
fidata Iri. E poi venne il nuovo dazio protezionistico, un ineguagliabile 45%
del valore sulle vetture straniere... E poi eccetera eccetera. Mani in alto,
Marchionne! Questa è una rapina.
Terrorismo, qualcosa non
torna…scrive
Diego Fusaro su "Il Fatto Quotidiano" il 26 luglio 2016. Stragi su stragi. Senza
tregua. Quasi una al giorno, ormai. Chissà perché, poi, questi orrendi attentati
si abbattono sempre nei luoghi pubblici facendo strage di povera gente, di
persone comuni, lavoratori e disoccupati, ragazzi e studenti. Mai una volta –
avete notato? – che l’ira delirante dei terroristi si abbatta nei luoghi del
potere e della finanza. Mai. Mai un signore della finanza colpito, mai uno
statista, mai un “pezzo grosso” dell’Occidente. Strano, davvero, che i pazzi
alfieri del terrorismo, che in teoria – si dice – avrebbero dichiarato guerra
all’Occidente non prendano di mira chi l’Occidente davvero lo governa. Se non ci
dicessero un giorno sì e l’altro pure che il terrorismo islamico ha dichiarato
guerra all’Occidente si avrebbe quasi l’impressione che si tratti di una guerra
di classe – gestita poi da chi? – contro lavoratori, disoccupati, classi
disagiate: una lotta di classe tremenda, ordita per tenere a bada i dominati,
per tenerli sotto tensione, proprio ora che, mentre stanno perdendo tutto,
iniziano a sollevarsi (è il caso della Francia della “loi travail”, uno dei
Paesi più colpiti dal terrorismo). E intanto, a reti unificate, ci fanno credere
che il nostro nemico sia l’Islam e non il terrorismo quotidiano permanente
dell’economia di mercato. Ci fanno credere che il nemico, per il giovane
disoccupato cristiano, sia il giovane disoccupato islamico e non il
delocalizzatore, il magnate della finanza, il fautore delle “riforme” che
uccidono il mondo del lavoro: il conflitto Servo-Signore è, ancora una volta,
frammentato alla base. Nell’ennesima guerra tra poveri, della quale a
beneficiare sono coloro che poveri non sono. Il terrorismo, quali ne siano gli
agenti, è un’arma nelle mani dei potenti: fa il loro interesse. E lo fa per più
ragioni. Intanto, perché frammenta il conflitto di classe e mette i servi in
lotta tra loro (Islamici vs Cristiani, Orientali vs Occidentali): lo “scontro di
civiltà” di Huntington va a occultare la “lotta di classe di Marx”. Il tutto
condito con le tirate à la Fallaci. In secondo luogo perché attiva il paradigma
securitario, modello “Patriot Act” Usa: per garantire sicurezza, si toglie
libertà. Et voilà, il gioco è fatto. In terzo luogo, si crea adesione al partito
unico della produzione capitalistica anche in chi avrebbe solo motivi per
contestarla: l’Occidente “buono” contro l’Oriente cattivo e terrorista. In
quarto luogo, si prepara il terreno – prepariamoci – per nuove guerre: guerre in
nome del terrore, come fu in Afghanistan (2001) e non molto fa con i
bombardamenti in Siria. Il terrorismo diventa una “opportunità” - sit venia
verbo – per guerre di aggressione imperialistiche. Questo lo scenario. V’è poco
da stare allegri. Ma è meglio essere informati, se non altro.
La faida dei Ricchi,
scrive Piero Sansonetti il 26 luglio 2016 su "Il Dubbio". È logico, è
ragionevole che un signore che guadagna circa 18 mila euro al mese (per non fare
molto: cioè, per fare il deputato...) si incazzi come un diavolo perché un
direttore di telegiornale guadagna troppo, sebbene questo direttore (o questa
direttrice) di telegiornale, guadagna circa la metà di lui? Vediamo prima i
fatti, e poi proviamo a ragionare, giusto per poche righe. Nel fine settimana è
scoppiato lo scandalo Rai. Perché l’azienda - unica in tutt’Italia - ha deciso
di rendere noti gli stipendi alti dei propri dipendenti. Cioè tutti gli stipendi
superiori ai 200 mila euro lordi all’anno (che, all’ingrosso, equivalgono a un
po’ meno di 7000 euro al mese). L’elenco è piuttosto lungo, ma i nomi innalzati
sulla croce sono una quindicina. Prima di tutti quello del direttore generale
(che è colui che ha dato via libera all’operazione trasparenza) e cioè il
famigerato Campo Dall’Orto che prende uno stipendio lordo di 650 mila euro. Poi
il presidente, Monica Maggioni, con uno stipendio un po’ superiore ai 300 mila.
Poi un gruppetto di direttori di rete o di telegiornale, tutti oscillanti, come
la presidente, sui 300 mila. Infine un certo numero di presunti nullafacenti, i
quali negli anni scorsi sono stati emarginati e privati dei loro incarichi (per
motivi politici, o professionali, o talvolta, magari, di scarsa obbedienza) ma
non licenziati in tronco. La pubblicazione di queste cifre ha scatenato un
putiferio. I giornali che le hanno riportate (dal “Fatto” al “Corriere della
Sera” a “Repubblica” a tutti gli altri), hanno gridato allo scandalo, al
tradimento, all’estorsione. E poi hanno gridato allo scandalo i politici, a
cominciare da Matteo Orfini, presidente moralizzatore del Pd, e -naturalmente –
Fico e tutti i cinque stelle d’Italia. E hanno chiesto innanzitutto che tutti
gli stipendi siano tagliati e riportati sotto i 240 mila euro, e poi che siano
cacciati via, o comunque privati dello stipendio, i giornalisti superpagati e
emarginati, compresi fior di professionisti come, ad esempio, Carmen Lasorella.
E’ giusta questa levata di scudi? Il problema – credo – non sono tanto gli
scudi, ma chi li leva. Nel senso che la maggior parte degli indignati prende
stipendi più alti di quelli per i quali si indigna. I parlamentari,
innanzitutto, ma anche i giornalisti. Voglio confessarvi un segreto: so per
certo che le grandi firme dei giornali italiani, quasi tutte, guadagnano più di
20 mila euro al mese (cioè, circa mezzo milione lordo all’anno), qualcuno di
loro guadagna anche di più. Voi pensate che ogni volta che vanno a ritirare la
busta paga si auto-indignano? No. E se glielo fai notare, ti dicono: ma io
lavoro per una azienda privata. Embe? Richiede più talento, più merito, e impone
più responsabilità dirigere un telegiornale della Rai o dirigere un quotidiano
privato, o scrivere un servizio per il tal giornale? E allora da dove nasce
questa indignazione? Nasce da una spinta popolare. Alla quale tutti si adeguano.
E strillano, strillano, per mettersi in vista. La spinta è anche giusta,
intendiamoci, perché – lo ho scritto altre volte – l’eccesso di ricchezze
secondo me non è una bella cosa. Il problema è che quelli che si incazzano come
api sono gli stessi che urlano plaudenti e ammirati se parlano Santoro, o
Floris, o Belpietro, o Giannini o – soprattutto – Crozza o Benigni. E’ questo
cortocircuito che mi fa paura: l’indignazione usata come carburante del proprio
potere da chi dovrebbe esserne l’oggetto. P. S. Ho una proposta: vietare il
diritto all’indignazione a chiunque guadagni più di 100 mila euro all’anno.
Immaginate voi che silenzio, nei giornali e in tv...
2 giugno 1946: monarchia o repubblica?
Nord e Sud sempre divisi su tutto. Gli italiani al
voto, scrive Giancarlo Restelli. Per decidere se l’Italia sarebbe stata una
repubblica o ancora una monarchia gli italiani andarono alle urne il 2 giugno
del ’46 con un referendum. Il risultato fu la vittoria della repubblica ma con
uno scarto poco ampio di voti: 12.717.923 per la repubblica e 10.719.284 per la
monarchia a cui dobbiamo aggiungere un milione e mezzo di schede bianche e
nulle. La repubblica ottiene quindi poco più del 54 per cento dei voti. A
esprimersi nel referendum è un’Italia spaccata tra Nord e Sud. Il Nord vota a
maggioranza repubblicana mentre il Sud è compattamente monarchico. Vediamo
qualche percentuale. In Piemonte, culla dei Savoia, la repubblica ottiene il 57
per cento, in Lombardia il 64 per cento, in Toscana il 71; percentuali simili
l’Umbria e le Marche. La regione dove il consenso alla repubblica è più alto è
il Trentino con l’85 per cento. Per la monarchia la percentuale più elevata è
nella circoscrizione Napoli-Caserta con il 79.9 per cento. I partiti di sinistra
(Partito comunista, Partito socialista, Partito d’Azione) si espressero
decisamente per la repubblica mentre la Dc non diede indicazioni di voto perché
nel partito c’era una forte spaccatura sulla questione istituzionale. La chiesa
dà indicazioni di voto a favore della monarchia. Gli americani cautamente si
esprimono per la repubblica. Churchill per la monarchia, ma Churchill non è più
al potere in Gran Bretagna. Perché questa spaccatura tra Nord e Sud? A parte le
storiche differenze tra le due parti d’Italia contarono molto le diverse
esperienze delle due aree durante la guerra: il Nord conobbe la Resistenza (il
“vento del Nord”) e una presa di coscienza politica che invece il Sud non ebbe
perché l’avanzata anglo-americana fu relativamente rapida almeno fino a
Montecassino e quindi non ebbe tempo di formarsi la resistenza ai nazifascisti.
Ma dietro il voto monarchico si celava il timore che le forze di sinistra
mutassero l’Italia sulla base dei propri obiettivi. Spaventava molto il legame
fortissimo tra il Pci e l’Unione Sovietica e nello stesso tempo il forte
radicamento del partito di Togliatti tra gli operai del Nord e i contadini del
Centro-Sud. La monarchia era vista quindi come baluardo conservatore di fronte
alle incognite del dopoguerra. Dopo aver appoggiato il fascismo per i propri
interessi, ora masse di borghesia piccola e media votavano a favore della
conservazione politica identificandosi con i Savoia. Vittorio Emanuele III tentò
un colpo a sorpresa per “lavare” l’immagine fosca della monarchia in Italia:
abdicò a favore del figlio Umberto (molto meno compromesso con il fascismo
rispetto al padre), che così divenne Umberto II. Il passaggio di potere avvenne
alla vigilia del referendum nel maggio ’46, così Umberto II divenne il “re di
maggio”. Nonostante l’estremo e tardivo tentativo di salvare il trono, la
monarchia è sconfitta perché ha dato il potere al fascismo al tempo della Marcia
su Roma, non ha agito contro Mussolini quando Matteotti fu assassinato, ha
accolto con soddisfazione la nascita dell’“Impero”, ha firmato senza battere
ciglio le Leggi Razziali, ha voluto la guerra al pari di Mussolini e si è
dissociata da Mussolini e dal fascismo solo quando la guerra era compromessa (25
luglio ’43) per conservare il trono. Con l’8 settembre del ‘43 il re, fuggendo
vergognosamente da Roma, condannava il Paese al caos dell’armistizio. È una
delle tante leggende che continuano a circolare nel nostro Paese: la presenza di
brogli che avrebbero favorito la vittoria della repubblica. Oggi non c’è storico
serio che dia credito a questa tesi. Furono i monarchici a sostenere l’idea di
una vittoria ottenuta manipolando i voti perché in quei giorni ci fu, dopo il
voto, una imbarazzante confusione agli alti livelli dello Stato. Basta pensare
che i risultati definitivi furono proclamati dalla Cassazione solo il 18 giugno
(!), sedici giorni dopo il voto. Altro fatto sconcertante, dopo la conta le
schede furono subito bruciate in tutta Italia, quindi fu impossibile il
riconteggio. Mentre la Cassazione tardava a fornire i risultati definitivi
corsero voci di golpe da parte delle forze monarchiche che cercarono di
coinvolgere Umberto II nel rovesciamento del governo retto in quel momento da De
Gasperi. Non ci fu nessun tentativo significativo di colpo di Stato
probabilmente perché Umberto II si rese conto che l’eventuale azione militare
non avrebbe riscosso molto successo nell’esercito e nel mondo economico; anche
gli americani non volevano che l’Italia precipitasse di nuovo nella guerra
civile. Fu così che il “re di maggio” lasciò l’Italia il 13 giugno per il
Portogallo non attendendo neppure il risultato definitivo del referendum.
L’entusiamo per la nascita della Repubblica durò pochi giorni perché sempre nel
giugno ’46 Togliatti (leader e figura storica del Pci), in quel momento ministro
di Grazia e Giustizia, emanò la famosa amnistia grazie alla quale migliaia di
fascisti furono scarcerati e tornarono a occupare posti di potere. La reazione
di molti partigiani fu prima di incredulità e poi di aperta protesta ma le cose
non cambiarono. Fu così che Togliatti diventò “ministro della Grazia ma non
della Giustizia”. Altra delusione di quei giorni fu l’elezione a Capo
provvisorio dello Stato dell’avvocato Enrico De Nicola, notorio monarchico così
come per la monarchia si era espresso il suo partito, il Partito liberale
italiano. De Nicola, esponente di quella classe dirigente liberale che con
troppa facilità aveva ceduto al fascismo al tempo della Marcia su Roma, è colui
che aveva spedito a Benito Mussolini un telegramma di auguri per il Congresso di
Napoli dei Fasci che preparò gli avvenimenti del 28 ottobre 1922. Ma De Nicola
fu anche colui che elogiò il re Vittorio Emanuele III quando conferì a Mussolini
l’incarico di formare il primo governo di fascisti e liberali nei giorni
convulsi della Marcia. Insomma un monarchico a capo della repubblica!
Contemporaneamente il 2 giugno del ’46 si votò a favore della Costituente, ossia
di quella assemblea che avrebbe avuto il compito di redigere la nuova Carta
costituzionale (1 gennaio ’48). I risultati sono a favore della Dc che ottiene
il 35 per cento mentre il Pci è fermo al 19 e il Psi al 20. Scompare il Pd’A di
Parri, Valiani, Bauer, Calamandrei, ossia un partito che nella Resistenza
espresse quadri politici e militari di notevole livello e fu a capo di numerose
organizzazioni partigiane. Ormai il sistema politico ruota attorno ai tre
partiti di massa mentre monarchici, repubblicani, liberali sono ridotti a
percentuali irrisorie. L’anno dopo, il 1947, le sinistre sarebbero state escluse
dal governo (maggio ’47, quarto governo De Gasperi) e la prima repubblica
italiana si preparava a una lunga egemonia democristiana.
“La costituzione più brutta del mondo”
di Federico Cartelli. Libro pubblicato nella collana “Fuori dal Coro" de “Il
Giornale” il 19 maggio 2016. La Costituzione «nata dalla Resistenza», concepita
settant’anni fa ed entro un contesto culturale dominato da ideologie illiberali,
continua ad apparire qualcosa di sacro e intoccabile. Mettere in discussione la
più bella del mondo è un’eresia. Ma una Costituzione non dev’essere bella:
dev’essere efficiente. La nostra invece è la radice di ogni male italiano, dal
debito pubblico al fisco, dai giochi di palazzo agli eccessi sindacali. La Carta
è la pietra angolare del conservatorismo che protegge quello status quo politico
ed economico che tutti, a parole, vorrebbero cambiare.
“Costituzione, Stato e crisi”,
intervista a Federico Cartelli di Riccardo Ghezzi del 31 agosto 2015 su
"Quelsi”. La Costituzione italiana è davvero la più bella del mondo? Non secondo
Federico Cartelli, direttore del sito The Fielder, che nel suo libro
“Costituzione, Stato e crisi – Eresie di libertà per un paese di sudditi”,
disponibile su Amazon, mette sotto processo uno dei miti della nostra società:
la Costituzione “nata dalla Resistenza”. Un libro con la prefazione del filosofo
liberale Carlo Lottieri. In questa intervista con l’autore ne approfondiamo le
tematiche.
Federico, innanzitutto, come è nata l’idea di
questo libro?
«Stavo
preparando un articolo sui difetti della nostra Costituzione e stavo ricercando
del materiale. Dopo un po’ mi sono accorto che trovare libri o paper critici nei
confronti della Carta era pressoché impossibile. Praticamente tutte le fonti che
stavo consultando non osavano metterne in dubbio la sacralità, né muovevano dei
rilievi su quelle parti che sono palesemente superate dalla Storia. A quel
punto, con un po’ di sana incoscienza e senza prendermi troppo sul serio, ho
deciso che mi sarei impegnato personalmente per colmare questa lacuna. Avevo
sempre pensato di scrivere un libro, e questa è stata l’occasione giusta».
Non ti sembra azzardato che una persona
“qualunque” possa scrivere un libro di critica nei confronti di quella che è pur
sempre la nostra Costituzione?
«Senz’altro. È
molto azzardato. Però credo che in questo libro, più che altro un manifesto,
si possano cogliere sia lo spirito polemico delle mie osservazioni, sia
l’intenzione di discostarmi da certi modelli populisti in salsa grillina che non
sanno andare oltre il pensiero breve. In verità, “Costituzione, Stato e crisi” è
proprio un manifesto contro il pensiero breve, più precisamente quel pensiero
breve sessantottino e progressista che da decenni blocca l’Italia e le impedisce
di diventare un Paese moderno. È un manifesto contro la retorica collettivista,
contro il benecomunismo che si respira in ogni articolo della nostra Carta e che
ogni giorno ci viene propinato da certi giornali e da certi politici. Bisogna
dirlo forte è chiaro: no, non è la Costituzione più bella del mondo. Anzi, è una
delle peggio riuscite».
Credi che i lettori abbiano apprezzato questo
messaggio?
«Per adesso,
direi proprio di sì. Sono rimasto sorpreso dai molti messaggi ricevuti e dalle
valutazioni lasciate su Amazon. Alcuni mi hanno scritto in privato per
complimentarsi e hanno apprezzato il fatto di poter leggere, finalmente, una
critica alla “più bella del mondo”. Posso già ritenermi soddisfatto, e spero che
le mie “eresie” si diffondano in più possibile».
Ma secondo te, perché c’è sempre questa
ossessiva retorica adulatoria nei confronti della Costituzione?
«Perché la
Costituzione è di fatto il lucchetto che mantiene tutto com’è. È la suprema
garanzia dello status quo. In nessun altro Paese europeo c’è questa ossessione
nei confronti della Costituzione sacra e intoccabile. Perché sì, è vero che è
stata cambiata nel corso degli anni: ma non sono mai state toccate né la parte
riguardanti i rapporti economici, né i principi fondamentali (che in ogni caso
non posso essere soggetti a modifiche). Non è mai stato toccato quel nucleo
che rappresenta, di fatto, l’Italia dell’immediato dopoguerra che vedeva nello
Stato un padre-padrone. La parte riguardante i rapporti economici è, di fatto,
un imbarazzante manifesto socialista. Servirebbe un’assemblea costituente,
perché questa Carta è davvero tutta da rifare».
C’è un capitolo del libro al quale sei più
legato?
«Il quinto,
senza dubbio, “Il lavoro non è un diritto”. Ed è anche il capitolo che più ha
suscitato la curiosità nei lettori. Molti, lasciandosi ingannare dal titolo –
evidentemente provocatorio – si sono detti: questo è matto, perché mai il lavoro
non dovrebbe essere un diritto? In realtà poi, una volta letto il capitolo, si
sono ricreduti».
Nel capitolo 8 fai una lunga critica al
cosiddetto “federalismo all’italiana”. Ha ancora senso parlare di federalismo in
Italia?
«Sì, e aggiungo
che in Italia si deve parlare di federalismo. Ma di vero federalismo, non di
quel pasticcio compiuto dal centrosinistra nel 2001 e poi degenerato
definitivamente con Monti. Il federalismo all’italiana non è vero federalismo, è
solo un altro salasso fiscale ai danni dei contribuenti, che si sono visti
aumentare le tasse e moltiplicare i centri di spesa, mentre certe regioni e
certi comuni in completo dissesto finanziario continuano a battere cassa a Roma.
È per questo che ho dedicato un capitolo al federalismo: perché ho voluto
mettere un po’ d’ordine e far capire ai lettori che una rivoluzione federalista
è l’unica vera possibilità di cambiare il Paese. Credo che anche in futuro
tornerò su questo argomento».
Come vedi l’attuale situazione politica ed
economica dell’Italia?
«Faccio parte
di quelli che il nostro magnifico presidente del Consiglio definisce “gufi”.
Purtroppo sono affetto da una malattia molto grave: il realismo. E non riesco
davvero ad emozionarmi per i tweet del nostro Matteo, che pensa di coprire i
fallimenti di questo governo con un modus operandi da bulletto di periferia. I
numeri dicono il tanto decantato Jobs Act è in realtà un Flop Act, e nonostante
tutti i fattori esterni favorevoli – politiche accomodanti dalla Banca Centrale
Europea, costo delle materie prime ai minimi storici solo per citarne alcuni –
non c’è stata alcuna reale ripresa, ma solo qualche “zero virgola” che in
termine concreti non vuol dire nulla. Dall’altra parte, non c’è alcune reale
opposizione. Il cosiddetto “centrodestra” è solo un cumulo di macerie,
senza alcun piano maggioritario per governare il Paese a lungo termine. Insomma,
di questo passo tra qualche anno l’Italia diventerà l’Argentina dell’Europa».
A proposito di Europa, cosa pensi dell’attuale
Unione Europea?
«Dieci anni fa,
ai tempi dell’università, ero un convinto sostenitore dell’Unione Europea e
della moneta unica. Ma davanti ai fatti – sempre a causa di quella malattia, il
realismo – mi sono dovuto ricredere. Quest’Unione non funziona più, è una
caricatura di se stessa, persa tra vertici infiniti dagli esiti mai chiari,
divisa in politica estera, sempre più lontana dai cittadini. Basta vedere
come, in questi giorni, viene gestito il problema dell’immigrazione: ognuno per
sé, con l’Italia che rischia – come spesso accade – di pagare il prezzo più
alto. Poi è inutile piangersi addosso perché aumenta il consenso ai cosiddetti
partiti populisti. Per ciò che concerne l’euro, è evidente che sono necessari
aggiustamenti, perché le calende greche dell’estate appena conclusa sono
destinate a ripetersi».
La Costituzione italiana: la più brutta
del mondo, si legge su “Risveglio nazionale”
il 09/05/2015. La costituzione che garantisce l’impunità e la protezione
all’eletto che tradisce i suoi elettori!… Ovvero: la costituzione più
antipopolare, più immorale, più demagogica, massonica, ebraica, rothschildiana e
tracotantemente truffaldina del mondo!…La nostra “sacra costituzione” voluta da
Rothschild è davvero la più brutta del mondo. Una costituzione a sovranità
limitatissima, che il popolo non può cambiare. I nostri “padri
costituzionalisti”, seguendo alla lettera le direttive di Rothschild, ci hanno
fatto credere di averci dato in eredità qualcosa di sacro, che se viene cambiato
ci farà solo del male. Oggi la Costituzione, oltre ai più che ambigui “principi
fondamentali”, presuppone un sistema decisionale lento, se non completamente
bloccato e un gioco di pesi e contrappesi a tutti i livelli che non dà una
chiara definizione di chi debba decidere cosa e praticamente permette tutto ed
il contrario di tutto al soggetto socialmente più forte: Rothschild. E’ ora di
riflettere, guardarci in faccia e di ammettere una volta per tutte che l’assetto
istituzionale italiano, sancito dalla Costituzione del 1948 e dalle successive
modifiche, comprese quelle sull’assetto regionalista del 1999, è il più grande
nemico del Paese, poiché i tempi sono evidentemente cambiati. Infatti, non
dobbiamo più leccarci le ferite morali e materiali aperte dai bombardamenti e
incancrenite per la fame e la miseria e avvelenate dalla umiliazione della
sconfitta e dalla paura di fronte ai vincitori e per la brutale invasione e la
feroce occupazione “alleata”, quindi l’assemblearismo estremo non è mai stato e
meno che mai è adesso un valore aggiunto. L’Italia non ha affatto bisogno di
superpartiti “assopigliatutto”, con annessi supersindacati, supertraditori e
superassociazioni varie che intrallazzano in tutti i modi, che sono sempre in
disaccordo fra loro per spartirsi qualche osso. Persone docili e ubbidienti col
loro signore e padrone Rothschild per fare le “riforme” contro il popolo più
povero per fargli buttare sangue a pagare l’usuraio, enorme, crescente ed eterno
“debito pubblico”. E’ necessario avere governi che governino realmente a favore
del popolo e non per finta, e di un legislatore controllato veramente dal
popolo, e che sia costretto dal popolo a fare leggi giuste per il bene del
popolo e non per il bene dei “mercati” di Rothschild. Siamo arrivati al punto da
capire sulla nostra pelle e di dire, e di urlare, che la “nostra” costituzione
non è affatto “nostra” e non è affatto la “costituzione più bella del mondo”,
perché non si salva neanche… uno… dei malignamente ambigui e contraddittori
articoli fondamentali, e che quella che gli scagnozzi di Rothschild ci hanno
appioppato è “la Costituzione più brutta del mondo”.
Questo volere difendere ad ogni costo questa loro
demagogica e truffaldina costituzione serve proprio, e solo, alle alte sfere del
potere antipopolare per potere preparare un ritorno forzato all’autoritarismo
più biecamente capitalista e schiavista assoluto. E’ bene ricordare che la
restaurazione “democratica” rothschildiana, seguita alla sconfitta della prima
guerra mondiale, regalò al povero popolo tedesco la corrotta, tirannica,
terribile e mostruosa “Repubblica di Weimar” con il popolo minuto che faceva la
fame molto, molto, molto peggio che in seguito gli ebrei ad Auschwitz e con gli
avidi, viziosi e debosciati capitalistoni ebraici, vassalli al seguito del
satanico Rothschild che debordavano a vista d’occhio in tutto e per tutto,
dappertutto nella società come porci da ingrasso scatenati e lasciati liberi in
un campo di grano!… Voglio solo ricordare: Art. 1: L’Italia è una repubblica
democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Tralasciando il “non
sense” del primo comma, fondata sul lavoro, che non vuol dire assolutamente
nulla, faccio solo notare che nel secondo con la mano destra dà ciò che con la
mano sinistra toglie (nello spazio di una virgola). Art. 8: Tutte le confessioni
religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni diverse
dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in
quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Quindi, la
religione cattolica può avere teoricamente norme in contrasto con l’ordinamento
italiano. Ergo, non tutte le confessioni sono egualmente libere (vedi a questo
proposito anche l’art. 7). Ultimamente abbiamo assistito a polemiche sulle croci
e sui presepi e ad attacchi contro la religione cattolica e contro la religione
islamica, che vengono spesso vilipese volgarmente, oscenamente e pesantemente in
pubblico anche dai mass media. Malgrado questo, si vede chiaramente che la
magistratura massonica ebraica rothschildiana, di questo regime coloniale
vigente in Italia, in Europa e in tutto l’Occidente, è estremamente tollerante.
Una magistratura che non dice nulla, chiude tutti e due gli occhi, non
interviene o, se lo fa, interviene addirittura a favore di chi le vilipende,
creando le premesse tra le masse popolari di forti contraddizioni ideologiche e
religiose, di profondo scontento e di gravi ed anche gravissimi e tragici
incidenti. Invece, ecco che dall’altra parte c’è tutto un fiorire di iniziative
mediatiche e legislative per conferire uno status privilegiato alla religione
ebraica, alla etnia ebraica, al sionismo, allo stato di Israele, a tutta la
questione dell’olocausto, della “shoah”, etc. Guai se ci si permette anche solo
di dire, di sussurrare o di pensare qualcosa anche solo di costruttivamente
critico nei confronti di questi argomenti, perché scatta subito l’accusa di
“antisemitismo”, e sono cavoli amari, condanne pesantissime, discriminazioni
addirittura odiosamente razziste e comunque seccature di ogni genere!… Ma da
tutto questo movimento di legiferazione e di attività giudiziarie
scandalosamente improntate al criterio dei due pesi e delle due misure, anche i
più ignoranti, i più ottusi ed i più ipocriti, capiscono e son costretti ad
ammettere che a quanto pare, anche se costituzionalmente si afferma formalmente
che “tutte le confessioni sono egualmente libere”, invece, gli ordini di
scuderia del vigente regime massonico, ebraico, rothschildiano sono
prioritariamente orientati a tenere un atteggiamento di estremo riguardo per i
soggetti e gli argomenti talmudici sopra accennati. Sembra quindi che questo
articolo della costituzione non valga un fico. Art. 13 comma V: la legge
stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Il mio diritto alla
libertà personale, il mio diritto a non essere privato di essa prima di un
regolare processo e di una condanna definitiva è nelle mani di deputati e
senatori (la parte migliore del paese, vero?), anziché essere fissati almeno
nelle linee guida. Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati
a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro
funzioni. Questo articolo, tanto breve quanto apparentemente “innocente”, è in
realtà il nocciolo della truffa rothschildiana sedicente “democratica” e quindi
della profonda ed anzi essenziale rothschildianità di questa costituzione
truffaldina ed antipopolare. Infatti è ovvio anche per uno sprovveduto che il
parlamentare, pur eletto a seguito di suoi solenni giuramenti e grandi promesse
ai suoi elettori che farà gli interessi, i loro interessi,… invece, il neo
eletto, strafregandosene altamente di giuramenti e promesse ha già voltato
gabbana e peggio di Giuda Iscariota si è già venduto al miglior offerente anche
per meno di trenta denari d’argento. Ovvero, trattandosi di soldi, chi più di
Rothschild, l’uomo più ricco e potente del mondo, potrà comprare chi vuole a
qualsiasi prezzo e dominare qualsiasi parlamento corrompendolo come gli pare? In
effetti succede sistematicamente ormai dal 1861, cioè da quando, più di un
secolo e mezzo fa, Rothschild impose a mano armata, e poi reimpose sempre “manu
militari” nel 1943 la sua truffaldina e farsesca “democrazia” massonica,
ebraica, antipopolare, proprio congegnata per fregare il popolo, appunto in nome
della “libertà di coscienza” di poter tradire impunemente il popolo, ovvero i
più poveri; e per poterlo fare a cuor leggero, sancì, beffa delle beffe, che il
tradimento potesse essere fatto proprio protetti dalla “sacra ed inviolabile”
costituzione e dalle “democraticissime” leggi conseguenti, invocate ed applicate
zelantemente da giudici, forze dell’ordine , massmedia, etc. In Italia, ormai,
tutti massonicamente condizionati e opportunamente assoggettati con le buone o
con le cattive agli ordini del più ricco, ovvero del solito Rothschild, ovvero
del più pericoloso associato a delinquere: il capo supremo di tutte le
massonerie del mondo!… e cioè sempre e comunque Rothschild. Tutto questo è tanto
vero che è famosissima la frase appunto: “datemi il controllo della moneta di
una nazione e non mi importa di chi farà le sue leggi”- Mayer Amschel Rothschild
1815. Art.75 comma II: Non è ammesso il “referendum” per le leggi tributarie e
di bilancio (quelle appunto che riguardano i… soldi… e sono proprio quelle che
interessano più di tutte a Rothschild), di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Decisamente il mio articolo
preferito. La Costituzione spiega come, per quanto riguarda le cose davvero
importanti (proprietà e soldi, libertà personale, ecc.), il cittadino italiano
sia troppo stupido per esprimere serenamente la propria opinione. Meglio
negargli la possibilità solo a chiacchiere e per modo di dire (ma non era una
repubblica democratica secondo l’art. 1?). La Costituzione della Repubblica
Italiana è la legge fondamentale della Repubblica italiana, ovvero il vertice
nella gerarchia delle fonti di diritto dello Stato italiano. Approvata
dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio
dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947, fu pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27
dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1º gennaio1948.
I Rothschild sono una famiglia europea di
origini tedesco-giudaiche. Cinque linee del ramo austriaco della famiglia sono
stati elevati alla nobiltà austriaca, avendo ricevuto baronie ereditarie
dell'Impero asburgico dall'Imperatore Francesco II nel 1816. Un'altra linea, del
ramo inglese della famiglia, fu elevata alla nobiltà britannica su richiesta
della regina Vittoria. Nel corso dell'Ottocento, quando era al suo apice, la
famiglia si ritiene abbia posseduto di gran lunga il più grande patrimonio
privato del mondo. Oggi, i business dei Rothschild sono su scala più ridotta
anche se comprendono una vasta gamma di settori, tra cui: gestione dei patrimoni
privati, consulenza finanziaria, policoltura.
La Costituzione italiana: ambigua,
immorale, demagogica, antipopolare. La costituzione
che garantisce l'impunità e la protezione agli eletti che tradiscono i propri
elettori!... Ovvero: la costituzione più immorale, più demagogica, più
antipopolare, massonica, ebraica, rothschildiana e tracotantemente truffaldina
del mondo!...La “sacra” costituzione dell’attuale classe dominante, al di là
della messa in scena retorica di facciata, è a limitatissima sovranità popolare,
anche se i suoi “padri costituzionalisti” hanno cercato di farci credere, con la
complicità del monopolio mediatico del loro regime, di aver scritto la
costituzione più bella del mondo. Anche i principi fondamentali in essa
contenuti sono talmente ambigui, contraddittori ed indeterminati che la classe
dominante può permettersi tutto ed il contrario di tutto a tutti i livelli, con
le buone o con le cattive, in modo tale da detenere sempre e comunque la
stragrande parte del potere possibile nelle sue mani. Infatti, perfino quando le
sue leggi elettorali truffa, i suoi brogli ed imbrogli senza fine, non
permettessero ai suoi politicanti di avere la maggioranza in parlamento e
senato, le permetterebbero comunque senza particolari difficoltà di ricorrere,
di nuovo come in passato, alle maniere forti di un regime apertamente militare
con tanto di coprifuoco e di leggi marziali per salvare il suo Stato, ovvero per
salvaguardare il primato del suo potere egemone sul popolo e contro il popolo.
La nostra costituzione è stata scritta nel 1947, ed è andata in vigore nel 1948.
Già l'art. 1 della Costituzione è una vera e propria presa in giro.
Art. 1: “L’Italia è una repubblica democratica
fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione”. Tralasciando il primo comma, che è una
formula ambigua che si fonda su una idea astratta e indeterminata di lavoro,
invece che sulle precise e concrete persone fisiche dei lavoratori o dei
cittadini. Nel secondo comma, a proposito della sovranità popolare, si dà con
una frase quello che, subito dopo una virgola, si toglie con una frase
sostanzialmente opposta.
Art. 8: “Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.” Anche su questo articolo potremmo
discutere a lungo. Oltre alle polemiche, alle prevaricazioni e alle ingiustizie
che specie in questi ultimi tempi si fanno contro i cristiani e contro gli
islamici, avallate dai mass media e dalla magistratura del regime, si assiste
anche a tutto un fiorire di leggi e controleggi, che privilegiano, contro la
stessa costituzione e contro lo stesso diritto di libertà di pensiero e di
parola, la religione ebraica, l'etnia ebraica, la shoah, l'olocausto, ecc...
Art. 59: “È senatore di diritto e a vita, salvo
rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della
Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la
Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario. In parlamento, in senato ed a capo dello Stato, in rappresentanza
del popolo sovrano, dovrebbero stare solo i rappresentanti eletti direttamente
dal popolo, e nessun altro.
Art. 67. “Ogni membro del Parlamento rappresenta
la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.”
Art. 68. ”I membri del Parlamento non possono
essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni”. Questi due articoli 67 e 68, tanto brevi
quanto apparentemente "innocenti", sono in realtà il nocciolo centrale della
truffa e della sedicente "democrazia" rothschildiana. Questi articoli
garantiscono l'impunità e la protezione agli eletti che tradiscono i propri
elettori, svuotando la vera rappresentatività popolare e democratica di
qualsiasi eletto ed annullando il reale e sovrano potere del popolo in qualsiasi
e sedicente democrazia.
Art.75 comma II: “Non è ammesso il “referendum”
per le leggi tributarie e di bilancio.” Ecco un altro articolo truffaldino nei
confronti del popolo, a cui viene sottratta la possibilità di esercitare un
controllo diretto su questioni economiche, che lo riguardano direttamente e che
spesso sono vitali. La Costituzione infatti afferma con detto art. 75 come, per
quanto riguarda le questioni economiche concrete e davvero importanti (appunto
proprietà e soldi, libertà personale, ecc.), il cittadino italiano debba essere
di proposito e maliziosamente trattato come se fosse troppo stupido per essere
in grado di esprimere saggiamente una giusta opinione. Meglio quindi dargli,
solo a chiacchiere e per modo di dire, la possibilità di esprimersi, ma poi,
perfidamente, negargliela nei fatti!...(ma non era una repubblica
"Democratica"?... che, all’art. 1, spiega che il Popolo è Sovrano?).
Non lasciamoci ingannare dalle parole dolci,
suadenti, sentimentali dei lupi travestiti da pecore...e se l'Italia ha la
Costituzione più bella del mondo come mai ha generato la classe politica e
dirigente più ladra, più corrotta, più criminale, più infame, più delinquente,
più mafiosa? La risposta si trova in un passo evangelico: «Guardatevi dai falsi
profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro son lupi rapaci. Dai
loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine, o fichi dai
rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce
frutti cattivi; un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero
cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non produce frutti buoni viene
tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li potrete riconoscere». Mt
7, 15-20. Sarebbe il caso di ammettere una volta per sempre che l'assetto
costituzionale, sancito dalla Costituzione del 1948 e dalle successive
modifiche, in particolare quelle sull’assetto regionalista del 1999, è il più
grande nemico del Paese. (s. brosal - d. mallamaci).
LA COSTITUZIONE ITALIANA
VOLUTA DAI MASSONI.
Costituzione, Diritto al
Lavoro e Sistema Massonico.
Rapporti tra costituzione
italiana e massoneria, secondo Paolo Franceschetti.
Sommario. 1. Premessa. 2. La
prima falla: gli organi costituzionali. 3. La seconda falla. Il sistema dei
referendum. 4. La terza falla: la Corte Costituzionale. 5. La quarta falla: i
valori massonici della costituzione. 6. Il cosiddetto "diritto al lavoro". 7.
L'effettivo stato di cose. 8. Effetti della normativa a tutela dei lavoratori.
9. Considerazioni conclusive e di diritto comparato.
1. Premessa.
La nostra Costituzione è
considerata dalla maggior parte dei costituzionalisti come una legge molto
avanzata, fortemente protettiva delle classi deboli e con un bilanciamento quasi
perfetto tra i vari poteri. Rappresenta la legge fondamentale per la tutela dei
diritti di qualunque cittadino, nonché il parametro di legittimità cui
rapportare tutte le altre leggi. All’università questa era l’idea che mi ero
fatta sui vari autori, Mortati, Martinez, Barile. Solo da qualche anno ho
cominciato a riflettere sul fatto che qualcosa non va nel modo in cui tutti ci
presentano la Carta Costituzionale. Vediamo cosa. In effetti la storia (quella
vera e non quella ufficiale) ci insegna che la Carta Costituzionale fu voluta
dalla massoneria. Oltre due terzi dei padri costituenti erano ufficialmente
massoni (e sospetto anche quelli che non lo erano ufficialmente). E la
massoneria rivendica a sé altre leggi importanti, come la dichiarazione dei
diritto dell’Uomo. Dato che il fine ultimo della massoneria è il nuovo ordine
mondiale, riesce difficile pensare che abbiano voluto consegnare ai cittadini,
al popolo cioè, una legge che tutelasse davvero tutti, e che non fosse invece
funzionale agli interessi massonici. Infatti, leggendo la Costituzione senza
preconcetti, e sgombrando il campo da tutte le sciocchezze che ci insegnano
all’università, è possibile farsi un’idea diversa della Costituzione. Essa è una
legge illiberale, pensata apposta per opprimere i cittadini anzichè tutelarli.
Però il punto è che è scritta così bene che è difficile capirne l’inganno.
Apparentemente infatti sembra una legge progredita e che tutela i diritti di
tutti. Ma la realtà è ben altra. E’ noto infatti che nessuno è così schiavo come
quelli che pensano di essere liberi senza sapere di essere schiavi. Ora, la
Costituzione è fatta apposta per questo: renderci schiavi, facendoci credere di
essere liberi. Purtroppo per capirlo occorre essere molto esperti di diritto, e
contemporaneamente conoscere anche la politica, la cronaca, l'economia, ecc.;
una cosa impossibile finchè si è giovani, e quindi una preparazione
universitaria non è sufficiente per individuare dove stanno le immense falle di
questa legge – burla. Bisogna inoltre avere alcune conoscenze del sistema
massonico. I laureati in legge quindi escono dall’università senza avere la
minima conoscenza del sistema reale, ma avendo a malapena mandato a memoria i
pochi libri che hanno letto per gli esami universitari. Vediamo dove stanno
queste falle, iniziando dalle meno importanti. Per finire poi occupandoci della
presa in giro più evidente, che non a caso è proprio quella contenuta
nell’articolo 1 della costituzione.
2. La prima falla. Gli
organi costituzionali.
Anzitutto nella costituzione
sono previste efficaci garanzie per tutti i poteri dello stato meno uno. Sono
previste garanzie per il governo, parlamento, la Corte Costituzionale, la
magistratura, ma non per i servizi segreti che, come abbiamo spiegato in un
articolo precedente, sono l’organo dello stato più potente e il più pericoloso.
Quindi i servizi segreti possono agire fuori da coperture costituzionali. Ciò ha
una duplice valenza a mio parere, una giuridica e una psicologica. Dal punto di
vista giuridico infatti questa mancanza consente ai servizi di operare
nell’illegalità. Dal punto di vista psicologico, invece, tale omissione fa
sembrare i servizi segreti quasi una sorta di organo secondario che svolge ruoli
di secondo piano per il funzionamento della Repubblica; si dà al lettore, allo
studioso di legge, e all’operatore del diritto in genere, l’impressione che essi
non siano in fondo così importanti; allo stesso tempo ci si assicura che nessuno
studente approfondirà mai la figura dei servizi dal punto di vista giuridico,
cosicchè ogni laureato esce dall’università con un’idea solo immaginaria e
fantastica di questo organo dello stato, quasi come fosse inesistente, da
relegare nelle letture romanzesche dell’estate o dei film di James Bond, e non
uno dei poteri più importanti del nostro stato, con un numero di dipendenti da
far impressione a una qualsiasi altra amministrazione pubblica.
3. La seconda falla. Il
sistema dei referendum.
Un'altra mancanza gravissima è
quella del referendum propositivo. Il referendum, che è un istituto
importantissimo per la sovranità popolare, può solo abrogare leggi esistenti, ma
non proporle. Il che, tradotto in parole povere significa che se con un
referendum è stata abrogata una legge, il parlamento può riproporla tale e
quale, oppure con poche varianti, solo per prendere in giro i cittadini a
fingere di adeguarsi alla volontà popolare. Una presa in giro bella e buona.
4. La terza falla: la Corte
costituzionale.
Un’altra immensa presa in giro
è il funzionamento della Corte Costituzionale. Tale organo dovrebbe garantire
che le leggi siano conformi alla Costituzione, annullando le leggi ingiuste. Il
problema è che il cittadino non può ricorrere direttamente contro le leggi
ingiuste. E questo potere non ce l’hanno neanche i partiti o le associazioni di
categoria. Per poter arrivare ad una dichiarazione di incostituzionalità di una
legge infatti è previsto un complesso sistema per cui bisogna dapprima che sia
instaurato un processo (civile o penale); dopodiché occorre fare una richiesta
al giudice che presiede il processo in questione (che non è detto che la
accolga). In gergo tecnico questo sistema si chiama “giudizio di rilevanza
costituzionale effettuato dal giudice a quo”; in gergo atecnico e popolare
potremmo definirlo “sistema per paralizzare la giustizia costituzionale”. Ne
consegue che è impossibile impugnare le leggi più ingiuste, per due motivi:
1) o perché per qualche motivo
giuridico non è possibile materialmente instaurare il processo (ad esempio: non
è possibile impugnare le leggi che prevedono gli stipendi e le pensioni dei
parlamentari; non è possibile impugnare le leggi elettorali; non è possibile
impugnare le leggi con cui la Banca d’Italia è stata di fatto privatizzata);
2) o perché – anche quando le
legge è teoricamente impugnabile - il cittadino non ha nessuna voglia di
instaurare un processo per poi andare davanti alla Corte Costituzionale. Ad
esempio; ipotizziamo che un cittadino voglia impugnare l’assurda legge che
prevede che ogni professionista debba versare allo stato il 99 per cento del
reddito dell’anno futuro, per incassi ancora non percepiti; in tal caso bisogna
dapprima rifiutarsi di pagare (quindi commettere un illecito); poi occorre
aspettare di ricevere la cartella esattoriale da parte dell’agenzia delle
entrate con le relative multe e sovrattasse; e solo dopo queste due mosse si poi
impugnare la cartella, peraltro senza nessuna certezza di vincere la causa. Se
invece si volesse impugnare l’assurda legge sul falso in bilancio prevista dagli
articoli 2621 e ss. Cc. (legge chiaramente incostituzionale perché rende di
fatto non punibile questo reato, con la conseguenza che chi ruba una mela in un
supermercato rischia diversi anni di galera, mentre chi ruba qualche milione di
euro da una grande azienda non rischia quasi nulla), la cosa diventa
praticamente impossibile, perché prima commettere il reato, poi occorre
aspettare di essere processati per quel reato, e che in tale processo colui che
impugna sia parte in causa. Una follia!
A tutto ciò occorre aggiungere
i rilevanti costi di un giudizio davanti alla Corte, tali da scoraggiare
qualunque cittadino con un reddito medio. La conseguenza è che la Corte
Costituzionale si occupa in genere della costituzionalità delle leggi più
stupide, ma i cittadini sono impotenti di fronte ai fatti più gravi. E il
risultato finale è che la Corte Costituzionale sostanzialmente ha le mani
completamente legate contro le leggi più ingiuste e più gravemente lesive dei
diritti del cittadino.
5. La quarta falla: i
valori massonici introdotti dalla Costituzione.
Ci sono poi altre lacune molto
gravi come quella relativa alla possibilità per lo stato di espropriare beni dei
cittadini senza corrispondere il valore di mercato. Ma l’aspetto più grave della
nostra Costituzione, e allo stesso tempo anche quello più difficile da
percepire, è relativa ai valori tutelati dalla Costituzione. Ci raccontano
sempre che la Costituzione tutela la persona umana. Ma è falso, perché in realtà
a ben guardare essa mortifica la persona umana relegandola a poco più che uno
schiavo. Vediamo perché.
6. Il cosiddetto diritto al
lavoro.
Il perché è in realtà sotto
gli occhi di tutti, messo in modo plateale, bene evidenziato già nell’articolo 1
della Costituzione, ove è detto che: “la repubblica italiana è fondata sul
lavoro”. Nessuno si sofferma mai a riflettere sull’assurdità logica, giuridica,
e filosofica, di questa norma. Cosa significa che una repubblica è fondata sul
lavoro? Nulla. Giuridicamente una repubblica si fonda su tante cose. Sulla
legalità. Sulla giustizia. Sull’equilibrio dei diritti. Sul rispetto delle
leggi. Sull’equilibrio tra poteri dello stato. Ma non si fonda, né dovrebbe
fondarsi, sul lavoro. Non a caso credo che il nostro sia l’unico caso al mondo
di una Costituzione che abbia messo il lavoro all’articolo 1, tra i fondamenti
della Repubblica. Non a caso neanche repubbliche dittatoriali come la Cina o la
Russia contengono una disposizione tanto demenziale. L’idea di uno stato fondato
sul lavoro è infatti una sciocchezza per vari motivi. Prima di tutto perché ciò
presuppone che il giorno che venga trovato un modo per far avere a tutti,
gratuitamente, cibo e un tetto, e la gente fosse dispensata dal lavorare, lo
stato dovrebbe crollare. Il che ovviamente è giuridicamente un non senso. Quindi
il primo dei presupposti errati di questa norma è proprio quello giuridico. In
secondo luogo perché se la repubblica fosse fondata sul lavoro, ne deriverebbe
che i soggetti peggiori della società sarebbero i preti, i monaci e le suore di
clausura, il Papa, il Dalai Lama, gli asceti, coloro che vivono di rendita, chi
si dedica solo al volontariato, i politici (la maggior parte dei quali non ha
mai lavorato in vita sua) ecc. L’articolo 1 della nostra Costituzione si apre
insomma con un concetto assurdo, ma straordinariamente nessuno ne ha rilevato il
non senso. Anzi, autori come Mortati (il costituzionalista più famoso) hanno
addirittura plaudito a questo articolo. La nostra Costituzione poi prosegue con
altri articoli dedicati al lavoro, e tutti inevitabilmente basati su presupposti
teorici sbagliati. Il lavoro infatti è considerato un diritto. Ma riflettendoci
bene, il lavoro non è un diritto. Il lavoro è – o dovrebbe essere - una libera
scelta per esplicare la propria personalità. Il lavoro è un dovere per coloro
che non hanno abbastanza denaro per vivere. Il lavoro è poi una scelta di vita,
in quanto dovrebbe essere l’espressione della personalità del soggetto. Chi ama
dipingere vivrà di pittura; chi ama la giustizia cercherà di fare il giudice o
l’avvocato; chi ama i soldi cercherà di lavorare in banca e così via. Ma ben
possono esserci scelte alternative altrettanto nobili. Basti ricordare che le
più grandi religioni del mondo si basano sulla figura dei loro fondatori, che
non erano certamente lavoratori e che i primi discepoli di queste persone tutto
erano tranne che lavoratori. Cristo non era un lavoratore e i anche i discepoli
non erano tali ; o meglio, lo erano proprio finchè non hanno incontrato Cristo.
La stessa cosa vale per Budda e i suoi discepoli che erano dei mendicanti, e
tutt’oggi i monaci buddisti vivono sempre di carità. Una persona che accudisce i
propri figli e fa vita solo casalinga non fa una scelta meno nobile di un
dipendente delle poste, o di un funzionario di banca, o di un magistrato o un
avvocato (che spesso passa la vita a dirimere questioni condominiali e cause
assicurative, cioè occupandosi di cose infinitamente meno nobili dell’educazione
di un figlio). Ricordiamo poi che la maggior parte dei politici non ha mai
lavorato in vita sua. D’Alema e Bertinotti, che difendono i diritti dei
lavoratori, non hanno mai lavorato né hanno mai creato veramente lavoro (al di
fuori di quello delle cooperative rosse che serviva e serve per mantenere i
partiti di sinistra). Quindi il concetto del lavoro come diritto, e come
fondamento della Repubblica, non sta in piedi né filosoficamente né
giuridicamente, né dal punto di vista logico. E’ una delle balle giuridiche più
colossali che ci abbiano mai raccontato. A questo punto occorre capire perché al
lavoro è stata data un’importanza così grande, introducendo nella Costituzione
dei concetti falsi e che non hanno alcune attinenza con la realtà.
7. L’effettivo stato di
cose.
Il reale significato delle
norme sul lavoro previste dalla nostra Costituzione possono essere capite se si
conosce il meccanismo effettivo con cui il nostro sistema massonico funziona. Il
sistema massonico funziona, effettivamente sul lavoro. Il lavoro è infatti il
grosso problema della società attuale. Se voi chiedete a qualcuno qual è la più
grande preoccupazione oggi, in Europa, vi diranno: il lavoro. Non c’è lavoro.
Cosa promette un politico in cambio di voti? Un lavoro. Perché la mafia al sud è
tenuta in considerazione più dello stato? Perché dà lavoro. Perché la maggior
parte delle persone, oggi, è spinta ad entrare in massoneria? Per cercare lavoro
o per aumentare quello che ha. Se non ti allinei alle direttive del sistema qual
è la punizione più immediata che subisci? La perdita del lavoro. Perché un
magistrato copre un omicidio, un poliziotto non indaga, un dipendente pubblico
commette una scorrettezza, un giornalista non pubblica una notizia importante?
Perché altrimenti perdono il lavoro. Perché si danno le mazzette per avere gli
appalti? Perché altrimenti l’appalto non ti viene assegnato (ovverosia non hai
lavoro). Perché la maggior parte della gente non sa cosa è il signoraggio, cosa
sono le scie chimiche, cos’è la massoneria? Perché la TV non informa su questo,
per informarsi da soli ci vuole troppo tempo, e la gente non ha tempo perché
“deve lavorare”. In altre parole, il lavoro, con i suoi perversi meccanismi per
il suo mantenimento, è lo strumento che viene usato dai poteri occulti e dalla
politica per poter piegare i cittadini. In tal senso, allora, l’articolo 1 è
perfettamente coerente col sistema attuale e allora acquista un senso. La
repubblica (massonica) si fonda sul lavoro. In altre parole l’articolo 1
dovrebbe più correttamente essere letto in questo modo: L’Italia è una
repubblica massonica, fondata sul lavoro, e il potere massonico, per mantenersi,
ha bisogno di gente che sgobbi 12 ore al giorno senza mai alzare la testa per
pensare, altrimenti capirebbe l’inganno in cui la teniamo”.
8. Effetti della normativa
a tutela dei lavoratori.
A questo stato di cose si sono
aggiunte le leggi che proteggono il lavoratore a scapito del datore di lavoro.
Queste leggi sono l’attuazione dell’articolo 4 della Costituzione, che dice
espressamente che “la repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che favoriscono il loro diritto”. Il risultato
delle leggi che hanno promosso la condizioni che favoriscono i diritti dei
lavoratori è sotto gli occhi di tutti: l’impossibilità per il lavoratore di
licenziare in tronco il lavoratore sgradito (anche se ha rubato, se è un
nullafacente, ecc.), nonché la nostra demenziale politica fiscale, che ci fa
pagare tasse anche per l’aria che respiriamo, hanno prodotto lavoro in nero,
stipendi ridicoli, e lo sfruttamento sistematico di intere categorie di
lavoratori da parte dei datori di lavoro. Questa normativa ha raggiunto il
risultato esattamente contrario a quello programmato dall’articolo 4; infatti
danneggia il lavoratore, perché distorce il rapporto di forza tra lavoratori e
datori di lavoro. Mi spiego. Il rapporto di lavoro dovrebbe essere basato sulla
parità delle parti. Io lavoratore ho bisogno di lavorare per vivere; ma anche
tu, datore di lavoro, hai bisogno del lavoratore altrimenti la tua azienda non
funziona. Il sistema di leggi che riguardano il mondo del lavoro invece,
tassando dissennatamente gli imprenditori, facendo mancare il lavoro ovunque
grazie alla crisi, e impedendo il licenziamento arbitrario, ha prodotto come
risultato un sistema in cui la gente va a mendicare il lavoro da datori di
lavoro che il più delle volte lo concedono come se fosse un favore; favore di
cui i lavoratori devono ringraziare, spesso facendosi umiliare pur di non
perdere il lavoro, subendo ricatti sessuali e non, ecc. La corruzione nei
concorsi pubblici, volta a selezionare non i migliori, ma i più corrotti e i più
raccomandati in tutti i settori della vita pubblica, nella magistratura, in
polizia, negli enti pubblici, ecc., ha portato come ulteriore conseguenza una
classe di lavoratori demotivata; la maggior parte di essi infatti non hanno
scelto il lavoro in base alle loro capacità, ma in base ai posti che ha reso
disponibile il sistema. Il risultato di questa politica del lavoro durata nei
decenni è la perdita di dignità di tutte le categorie di lavoratori, anche di
quelle dirigenziali. Ovverosia:
- la maggior parte dei
lavoratori fa lavori che non sono adatti a loro;
- la maggior parte dei
lavoratori accetta di essere sottopagata;
- la maggior parte dei
lavoratori pur di lavorare accetta anche umiliazioni e trattamenti disumani;
- spesso si sente dire “non ho
lavoro, quindi non ho dignità”; i valori massonici del lavoro infatti hanno
instillato nella gente l’idea che un disoccupato non abbia dignità: a ciò
contribuisce anche il demenziale detto, accettato da tutti, che “il lavoro
nobilita l’uomo”, brocardo che non so chi l’abbia inventato, ma certamente
doveva essere un imbecille;
- poliziotti, carabinieri,
magistrati, fanno il loro lavoro non per missione di vita, come dovrebbe essere,
ma dando la prevalenza allo stipendio, ai problemi di mobilità, di avanzamento
di carriera, ecc.
- i datori di lavoro sono
costretti dalla dissennata legislazione italiana ad assumere lavoratori in nero,
sottopagarli, ecc.
- Nella massa delle persone si
instillano concetti distorti; ad esempio non è raro sentir lodare una persona
con la frase “è un gran lavoratore, lavora tutti i giorni anche dodici ore al
giorno” come se questo fosse un pregio. E ci si dimentica che chi lavora dodici
ore al giorno non ha tempo per i figli, per riflettere, per evolvere. Anche
Pacciani, infatti, per dare di sé un’immagine positiva, al processo sul mostro
di Firenze disse che era “un gran lavoratore”. Tutto questo sistema fa si che il
cittadino sia un docile e remissivo strumento del sistema in cui viviamo, ove la
frusta è stata sostituita dallo spauracchio della perdita del lavoro.
9. Considerazioni
conclusive e di diritto comparato.
In conclusione, la nostra
Costituzione è organizzata e strutturata in modo molto abile, per favorire
l’illegalità e l’ingiustizia, grazie ai suoi principi e alle sue lacune,
difficilmente riscontrabili ad una prima lettura. Tra i vari partiti politici e
i costituzionalisti, non mi risulta che nessuno abbia mai rilevato questo stato
di cose, ad eccezione della Lega Nord, che nel 1993 aveva fatto una proposta di
modifica dell’articolo 1 per cambiarlo in: L’Italia è una repubblica democratica
basata sul mercato e sulla solidarietà. Ovviamente la proposta è stata
contestata dalla sinistra. Perché si sa. La sinistra è a favore di lavoratori. E
infatti il risultato della politica di sinistra si è visto nei pochi anni in cui
abbiamo avuto governi di questo colore. Uno sfascio se possibile anche peggiore
di quello di destra, perché in effetti il più acerrimo nemico dei lavoratori, in
questi decenni, non è stata la destra, ma la sinistra. In compenso, anche la
costituzione del Sudafrica è più progredita della nostra, ove il diritto al
lavoro non compare, ma compaiono invece la tutela della dignità umana e compare
il diritto dei datori di lavoro. In altre parole l’Italia è seconda anche a
stati che, culturalmente, in teoria dovrebbero essere più arretrati di noi.
L’articolo 1 della Costituzione del Sudafrica (all. 4), molto più avanti del
nostro, recita: La costituzione del Sudafrica provvederà all’istituzione di uno
Stato sovrano, di una comune cittadinanza sudafricana e di un sistema di governo
democratico, mirante a realizzare l’uguaglianza tra uomini e donne e fra genti
di tutte le razze. Tra gli stati europei, invece, sarebbe sufficiente citare il
caso della Spagna. La Spagna ha in gran parte mutuato dal nostro sistema i
principi giuridici più importanti. Tuttavia, non a caso, l’articolo 1 della
Costituzione spagnola non fa cenno al lavoro e dichiara di fondarsi – molto più
intelligentemente di noi – su libertà, giustizia e uguaglianza. Infatti, mi
disse un professore universitario di Lima, che aveva la docenza anche in Spagna,
un certo Juan Espinoza Espinoza: in Spagna nessuno si prostituisce per avere un
semplice posto da portiere o da cameriere, come da voi. Da voi occorre essere
raccomandati anche per avere un lavoro a termine per sei mesi alle poste. Non a
caso da loro il lavoro è collocato all’articolo 35, che dice il contrario di
quanto dice la nostra Costituzione: tutti i lavoratori spagnoli hanno il dovere
di lavorare e il diritto alla libera scelta di una professione o di un mestiere.
E non a caso nel campo di concentramento di Auscwitz compariva una scritta
all’entrata: arbeit macht frei. Il lavoro rende liberi. Più o meno lo stesso
concetto contenuto nell’articolo 1 della nostra Costituzione.
E’ il dio denaro e le ricchezze che da sempre
fanno muovere il mondo e le montagne religiose ed ideologico.
Le masse si smuovono dalla loro apatia solo se
indotti dai loro bisogni primari, non conoscendo altri virtù.
Già i romani indicavano in “Panem et Circenses”
le aspirazioni della plebe. Gli illuminati, pochi ricchi e potenti, sin
dall’antichità usano i bisogni della plebe per disegnare il loro Ordine
Mondiale. Gli strumenti per attuare le loro mire di destabilizzazione: religioni
ed ideologie, prime tra tutte il comunismo.
Marxismo e immigrazione proletaria
(da «il comunista»; N° 113; Luglio 2009). Il fenomeno dell'immigrazione dei
proletari non ha nulla di nuovo e i marxisti hanno spessissimo trattato questo
tema, a cominciare da Engels nel 1845 nel suo libro su «La situazione della
classe operaia in Inghilterra». Marx ne parla nel Capitale, fra gli altri nel
passaggio seguente: «Il progresso industriale che segue la marcia
dell'accumulazione, non soltanto riduce sempre più il numero degli operai
necessari per mettere in moto una massa crescente di mezzi di produzione,
aumenta nello stesso tempo la quantità di lavoro che l'operaio individuale deve
fornire. nella misura in cui esso sviluppa le potenzialità produttive del lavoro
e fa dunque ottenere più prodotti da meno lavoro, il sistema capitalista
sviluppa anche i mezzi per ottenere più lavoro dal salariato, sia prolungando la
giornata lavorativa, sia aumentando l'intensità del suo lavoro, o ancora
aumentando in apparenza il numero dei lavoratori impiegati rimpiazzando una
forza superiore e più cara con più forze inferiori e meno care, l'uomo con la
donna, l'adulto con l'adolescente e il bambino, uno yankee con tre cinesi. Ecco
diversi metodi per diminuire la domanda di lavoro e rendere l'offerta
sovrabbondante, in un parola per fabbricare una sovrapopolazione. «L'eccesso di
lavoro imposto alla frazione della classe salariata che si trova in servizio
attivo ingrossa i ranghi della riserva aumentandone la pressione che
quest'ultima esercita sulla prima, forzandola a subire più docilmente il comando
del capitale» (Il Capitale, Libro, I, 7,25). Riassumendo, la borghesia utilizza
l'importazione di lavoratori stranieri allo scopo di ingrossare l'esercito
industriale di riserva e aumentare la concorrenza, questa «guerra di tutti
contro tutti», fra proletari. Marx dettaglia questo fenomeno della concorrenza
fra operai «nazionali» e immigrati con i casi degli operai irlandesi in
Inghilterra e le sue osservazioni sono estremamente ricche di insegnamento: «A
causa della concentrazione crescente della proprietà della terra, l'Irlanda
invia la sua sovrabbondanza di popolazione verso il mercato del lavoro inglese,
e fa abbassare così i salari degradando la condizione morale e materiale della
classe operaia inglese. «E il più importante di tutto: Ogni centro industriale e
commerciale in Inghilterra possiede ora una classe operaia divisa in due campi
ostili, i proletari inglesi e i proletari irlandesi. L'operaio inglese medio
odia l'operaio irlandese come un concorrente che abbassa il suo livello di vita.
Rispetto al lavoratore irlandese egli si sente un membro della nazione
dominante, e così si costituisce in uno strumento degli aristocratici e dei
capitalisti del suo paese contro l'Irlanda, rafforzando in questo modo il loro
dominio su lui stesso. Si nutre di pregiudizi religiosi, sociale e nazionali
contro il lavoratore irlandese. La sua attitudine verso di luiè molto simile a
quella dei poveri bianchi" verso i "negri" degli antichi Stati schiavisti degli
Stati Uniti d'America. L'Irlandese gli rende la pariglia, e con gli interessi.
Egli vede nell'operaio inglese nello stesso tempo il complice e lo strumento
stupido del dominio inglese sull'Irlanda. «Questo antagonismo è artificialmente
mantenuto e intensificato dalla stampa, dagli oratori, dalle caricature, in
breve da tutti i mezzi di cui dispongono le classi dominanti. Questo antagonismo
è il segreto dell'impotenza della classe operaia inglese, a dispetto della sua
organizzazione. E' il segreto grazie al quale la classe capitalista mantiene il
suo potere. E questa classe ne è perfettamente cosciente» (Lettera di K. Marx a
S. Meyer e A. Vogt, 9/4/1870). Anche oggi la classe capitalista è perfettamente
cosciente che la divisione fra proletari immigrati e italiani è un fattore
chiave della paralisi della classe operaia, e naturalmente fa di tutto per
mantenere e rafforzare questa divisione, questa ostilità, questo razzismo,
questo sentimento di superiorità nazionale. Anche nel caso in cui, come succede
ora in Italia col governo Berlusconi, in cui ha una certo peso la Lega Nord, il
governo borghese si prenda il gusto di tormentare la popolazione proletaria
immigrata con leggi vessatorie sulle loro condizioni di esistenza. Mai era
successo che la situazione fisica di esistenza, come sbarcare in territorio
italiano alla ricerca di una sopravvivenza meno precaria, fosse trasformata in
reato penale (mentre sono stati depennati dal penale i falsi in bilancio,
bancarotta ecc.!). Un altro punto, il ruolo potenzialmente molto importante per
la lotta proletaria e per il suo internazionalismo che gioca l'immigrazione, è
sottolineato da Lenin: «Il capitalismo ha creato un tipo particolare di
migrazione di popoli. I paesi che si sviluppano industrialmente in fretta,
introducendo più macchine e soppiantando i paesi arretrati nel mercato mondiale,
elevano il salario al di sopra della media e attirano gli operai salariati di
quei paesi. «Centinaia di migliaia di operai si spostano in questo modo per
centinaia e migliaia di verste. Il capitalismo avanzato li assorbe violentemente
nel suo vortice, li strappa dalle località sperdute, li fa partecipare al
movimento storico mondiale, li mette faccia a faccia con la possente, unita
classe internazionale degli industriali. «Non c'è dubbio che solo l'estrema
povertà costringe gli uomini ad abbandonare la patria e che i capitalisti
sfruttano nella maniera più disonesta gli operai immigrati. Ma solo i reazionari
possono chiudere gli occhi sul significato progressivo di questa migrazione
moderna dei popoli. La liberazione dall'oppressione del capitale non avviene e
non può avvenire senza un ulteriore sviluppo del capitalismo, senza la lotta di
classe sul terreno del capitalismo stesso. E proprio a questa lotta il
capitalismo trascina le masse lavoratrici di tutto il mondo, spezzando il
ristagno e l'arretratezza della vita locale, distruggendo le barriere e i
pregiudizi nazionali, unendo gli operai di tutti i paesi nelle più grandi
fabbriche e miniere dell'America, della Germania, ecc.» E vi aggiunge: «La
borghesia aizza gli operai di una nazione contro gli operai di un'altra,
cercando di dividerli. Gli operai coscienti, comprendendo l'inevitabilità e il
carattere progressivo della distruzione di tutte le barriere nazionali operata
dal capitalismo, cercano di aiutare a illuminare e a organizzare i loro compagni
dei paesi arretrati» (Lenin, Il capitalismo e l'immigrazione operaia, 1913).
Ecco quale deve essere l'attitudine costante dei proletari e delle loro
organizzazioni di classe, ecco qual è la nostra prospettiva!
Il rapporto Chilcot, bufera
sull’invasione dell’Iraq. Una paese in guerra e un
paese fuori controllo: questi i risultati della decisione presa da Blair e Bush
nel 2003, scrive il 7 luglio 2016 Luciano Tirinnanzi su "Panorama". Quella di
ieri, mercoledì 6 luglio 2016, è stata una giornata difficile per la politica
britannica e, in buona parte, anche per quella americana. Mentre Londra faceva
la conta del numero di politici dimissionari dopo lo tsunami della Brexit, e
mentre a Washington l’FBI scagionava dalle accuse sull’emailgate Hillary
Clinton, sulla scena internazionale irrompevano le conclusioni del rapporto
Chilcot, ovvero la commissione d'inchiesta britannica sulla partecipazione del
Regno Unito all’intervento militare in Iraq del 2003. “Abbiamo concluso che la
scelta del Regno Unito di partecipare all’invasione in Iraq è stata compiuta
prima che fossero esaurite tutte le altre opzioni pacifiche per il disarmo.
Abbiamo altresì concluso che la minaccia delle armi di distruzione di massa in
possesso dell’Iraq, rappresentata come una certezza, non era giustificata.
Nonostante gli avvertimenti, le conseguenze dell’invasione sono state
sottovalutate e la preparazione del dopo Saddam è stata del tutto inadeguata”.
Sono queste in sostanza le osservazioni di John Chilcot, l’uomo che presiede
l’inchiesta sul ruolo britannico nell’invasione. Parole che verosimilmente
scateneranno una serie di polemiche destinate ad ampliare il terremoto in corso
nel mondo politico inglese e che hanno già fatto breccia nella campagna
elettorale americana. Anche se il rapporto Chilcot - dopo sette anni di lavori,
centinaia di testimonianze raccolte e 150mila documenti vagliati - ci racconta
delle ovvietà, poiché evidentemente tutti hanno sotto gli occhi i risultati di
cosa ha comportato, non può sfuggire l’importanza simbolica delle sue
conclusioni. L’ufficialità del rapporto pone, infatti, una questione politica
non da poco sia per il Regno Unito sia per la comunità internazionale,
soprattutto per il verdetto schiacciante che condanna in toto l’attività
dell’allora premier britannico Tony Blair, il quale “era stato avvertito”
dell’inopportunità di entrare in guerra e nonostante ciò ha perseverato nel
disastro, ma anche la decisione degli americani. Secondo gli storici, Blair agì
in questo modo per non rovinare il buon rapporto tra il Regno Unito e gli Stati
Uniti che si era cementato durante la presidenza Clinton e che rischiava di
sgretolarsi con l’arrivo del nuovo presidente repubblicano. In questo senso, la
commissione suggerisce che Blair avrebbe promesso a George W. Bush che lo
avrebbe affiancato nell'impresa bellica “a ogni costo”, convinto di poter
gestire il rapporto con l’inquilino della Casa Bianca. Mentre secondo il diretto
interessato, che non ha perso tempo e ha risposto immediatamente alle accuse, il
rapporto Chilcot per quanto lo riguarda afferma che non vi è stata “nessuna
falsificazione o uso improprio dell’intelligence” e neanche “alcun inganno nei
confronti del governo”, così come non è stato siglato “nessun patto segreto” tra
lui e il presidente George W. Bush per l’entrata in guerra britannica.
Nonostante la difesa di Tony Blair, però, il risultato non cambia. La parabola
politica dell’ex premier inglese si conclude con una bocciatura storica non da
poco da parte di un’inchiesta ufficiale. E non va meglio dall’altra parte
dell’oceano, dove il candidato repubblicano Donald Trump non ha perso tempo nel
commentare alla sua maniera il caso: “Saddam Hussein era un cattivo ragazzo.
Davvero cattivo. Ma sapete cosa? Ha fatto qualcosa di buono. Ha ucciso i
terroristi”. E ha poi aggiunto: “Guardate cos’è diventato oggi l’Iraq, è
l’Harvard del terrorismo”. Insomma, se a Londra ci si domanda come gestire il
rapporto Chilcot e come assorbire l’impatto di questa inchiesta, in America la
questione è già spostata in avanti. Il New York Times in un cupo editoriale si è
sentito in dovere di citare le parole pronunciate poche settimane fa dal capo
della CIA John Brennan il quale, commentando la forza dello Stato Islamico, si è
spinto a dire: “Abbiamo ancora molta strada da fare prima di poter affermare che
abbiamo fatto dei progressi significativi contro di loro”. Dunque, seguendo le
osservazioni di Londra e Washington: la guerra per deporre Saddam Hussein fu un
errore; la gestione del dopo-invasione ha generato il terrorismo; il terrorismo
a sua volta ha prodotto il Califfato; il Califfato è vivo e vegeto e gli Stati
Uniti non hanno idea di come fermarlo. Ma la cosa che più spaventa è
l’ammissione che l’Occidente da quindici anni a questa parte ha sbagliato tutto
sul Medio Oriente e ancora oggi non ha idea di come gestire il genio (del male)
fuoriuscito dalla lampada. E, come insegna la fiaba de Le mille e una notte, una
volta fuori è difficile ricacciarlo dentro. Il rapporto Chilcot incide sulla
pietra il fatto che l’invasione dell’Iraq fu un vero fallimento e che le
conseguenze negative di quella scelta sciagurata si stanno protraendo fino a
oggi. Questo significa anche ufficializzare il de profundis per la politica
occidentale nel Medio Oriente, e in Iraq in misura ancora maggiore, proprio
mentre Baghdad è ostaggio del tritolo dello Stato Islamico. Infatti il
Califfo Al Baghdadi, che con il Ramadan 2016 ha inaugurato una nuova strategia
del terrore, ha deciso di incrementare le azioni suicide sulla capitale per
costringere il governo sciita di Haider Al Abadi a far rientrare in città le
truppe che oggi combattono l’ISIS a nord e che minacciano Mosul (ancora in mano
allo Stato Islamico), per difendere dalle azioni dei kamikaze una capitale quasi
fuori controllo. La sicurezza a Baghdad, infatti, non esiste più e anche se il
Califfato non è arrivato mai a minacciare militarmente la città, ciò non
significa che tenerla in ostaggio con le bombe non produca lo stesso risultato:
quello di danneggiare il governo Al Abadi fino al punto da provocare una sua
caduta. In questo, il Califfato potrebbe trovare un alleato inconsapevole nello
sceicco Moqtad Al Sadr, il leader che a Baghdad comanda il gigantesco quartiere
sciita di Sadr City (impenetrabile anche alle autorità irachene e già
protagonista della resistenza all’invasione americana), che osteggia tanto i
sunniti di Al Baghdadi quanto il governo sciita in carica, accusandolo di
corruzione e di complicità con il terrorismo. Non più di due giorni fa, infatti,
Al Sadr ha affermato: “Questi attentati non avranno fine, perché molti politici
stanno capitalizzando sulle bombe” e ha poi aggiunto una frase che suona come
una minaccia diretta all’attuale governo: “solo il popolo iracheno potrà mettere
fine a questa corruzione”. Come a dire che, se Al Abadi non è in grado di
proteggere la popolazione, qualcun altro presto dovrà farlo. In ogni caso,
metaforicamente Baghdad è davvero la nuova Babilonia.
Così la guerra in Iraq ha sconvolto il
Medio Oriente e rafforzato il terrorismo. Lo scenario.
Dal rapporto della commissione chilcot emerge che Blair e Bush jr. ignorarono la
Storia e non ascoltarono i diplomatici: l'invasione spezzò i fragili equilibri
regionali, scrive Bernardo Valli il 7 luglio 2016 su “La Repubblica”. Ci sono
voluti 7 anni, 12 volumi, più di 2 milioni e mezzo di parole, quante ne ha
scritte Tolstoj in Guerra e Pace (ha calcolato il New York Times), per
stabilire, infine, che l'invasione dell'Iraq voluta da Bush Jr, con Tony Blair
al suo fianco, era non solo inutile, ma anche disastrosa. La titanica fatica
della commissione presieduta, a Londra, da John Chilcot ha condotto a una verità
già nota dal 2003, quando cominciò il conflitto. Aveva tuttavia bisogno di una
conferma solenne. La quale assomiglia a una sentenza, benché non preveda alcun
processo per "crimine di guerra" a carico dell'inquisito Blair, come chiedevano
ieri i manifestanti londinesi. La commissione Chilcot non aveva poteri
giudiziari. E del resto Blair ebbe l'autorizzazione del Parlamento, sia pur
strappata con quella che si può chiamare una menzogna. La questione delle
responsabilità penali è affiorata sempre ieri per iniziativa dei familiari dei
morti. Che furono duecento britannici (di cui centosettantanove militari),
quattromila cinquecento americani e più di 140mila iracheni. Limitando il
bilancio alla prima fase della guerra. Ai Comuni, dove non è stato tenero con il
suo predecessore alla testa del Labour, Jeremy Corbyn ha chiesto scusa a nome
del suo partito per "l'aggressione militare basata su un falso pretesto". E ha
parlato di "violazione della legge internazionale", da parte di un primo
ministro laburista, quel era all'epoca Blair. Il rapporto Chilcot equivale a una
condanna politica e morale per quanto riguarda l'inquisito britannico, e in modo
indiretto la stessa condanna vale anche per George W. Bush. Del quale, si disse
allora che l'obbediente Tony Blair fosse il "barboncino". Il risultato della
commissione britannica non arriva con tredici anni di ritardo rispetto alla
guerra del 2003. Il conflitto è ancora in corso. La mischia nella valle del
Tigri e dell'Eufrate ne è la conseguenza. Il detonatore di quel che accade oggi,
terrorismo compreso, è stata l'invasione di allora. La situazione era pronta per
un'esplosione. È vero. La guerra nell'Afghanistan, occupato dai sovietici, aveva
rafforzato il jihadismo di Al Qaeda, irrobustitosi con il decisivo aiuto
americano. Nella guerra fredda l'Islam servì agli Stati Uniti come arma contro
l'Urss. E il lungo conflitto, durante quasi tutto il decennio degli Ottanta, tra
l'Iraq di Saddam Hussein, a forte governo sunnita, e l'Iran sciita di Khomeini,
aveva risvegliato la tenzone tra le due grandi correnti dell'Islam adesso in
aperto confronto. Nonostante gli avvertimenti insistenti di esperti e
diplomatici, la coppia Bush-Blair si è inoltrata nel Medio Oriente incandescente
dichiarando di volervi portare la democrazia e al tempo stesso annientare le
armi di distruzione di massa, non meglio precisate se chimiche o nucleari, ma
delle quali non c'era prova. E che comunque si rivelarono immaginarie. Noi
cronisti, a Bagdad, la prima notte dei bombardamenti, indossammo le tute e le
maschere che avrebbero dovuto proteggerci dall'iprite e da non so quale altro
veleno. Dopo qualche ora ci liberammo di tutto, accorgendoci che tra i tanti
pericoli che ci attendevano non c'erano quelli propagandati dagli invasori in
arrivo. L'uso dei gas nella sterminata e popolata Bagdad sarebbe equivalso a un
auto-olocausto. La commissione di inchiesta accusa Blair, e di riflesso Bush jr,
di non avere approfittato di tutte le opzioni pacifiche a disposizione per
arrivare a un disarmo concordato. È un appunto di rilievo perché Blair rivendica
il fatto di avere comunque contribuito ad abbattere un dittatore feroce qual era
Saddam Hussein. Gli inquirenti, in sostanza, sostengono che restasse uno spazio
per trattare con il rais di Bagdad, considerato tra l'altro, quando era in
guerra con l'Iran, un alleato obiettivo. L'irresponsabilità più grave denunciata
da John Chilcot è quella dimostrata nella prima fase del dopo guerra, quando gli
occidentali Bush e Blair proclamano anzi tempo la vittoria. L'ignoranza è
sottolineata più volte. Il saccheggio delle città da parte della popolazione,
sia a Bagdad dove c'erano gli americani, sia a Bassora dove c'erano i
britannici, toglie ogni fiducia negli invasori stranieri. I quali risultano
incapaci di garantire la sicurezza. L'esercito nazionale viene sciolto, ma non
disarmato. Il partito Baath, funzionante da Stato, è subito disperso e i suoi
dirigenti imprigionati e privati dei loro beni. Giusta punizione ma il paese
resta senza un'amministrazione. I militari sunniti si danno alla macchia con
ufficiali e cannoni, presto raggiunti dai jihadisti provenienti da tutti i paesi
arabi. I saddamisti laici si alleano con i salafiti. Gli americani e gli inglesi
hanno offerto un campo di battaglia su cui affrontarli. Le milizie sciite,
emerse dopo una lunga sottomissione alla minoranza sunnita, sfidano spesso gli
occupanti. Che non considerano liberatori perché hanno cacciato il dittatore che
li opprimeva, ma invasori. L'impatto dell'intervento occidentale sgretola i
fragili confini disegnati sulle rovine dell'impero ottomano alla fine della
Grande Guerra. Nel 1918. I paesi del Medio Oriente si decompongono. Prima l'Iraq
poi la Siria. Nel frattempo le primavere arabe mettono in crisi i regimi dei
rais che funzionavano da gendarmi. L'intervento americano con l'appoggio
britannico spezza gli equilibri regionali. Il rapporto Chilcot, nei suoi dodici
volumi, non è soltanto un atto d'accusa sul piano politico e morale, ma
l'analisi sul come si è giunti al conflitto medio orientale di oggi. Bush jr e
l'amico Blair hanno ignorato la Storia.
«Sarò con te, sempre».
Scrive il 6 luglio 2016 “Il Corriere della Sera”. Tra le carte, fino ad oggi top
secret, analizzate e rese pubbliche nel rapporto di Sir John Chilcot sulle
responsabilità britanniche nella guerra in Iraq, ci sono anche alcune note che
l’allora premier Tony Blair scrisse a George W. Bush. In una di queste, datata
28 luglio 2002 (otto mesi prima che il 20 marzo 2003 prendesse il via la guerra)
Blair già promette appoggio incondizionato all’allora presidente Usa per
l’invasione dell’Iraq. Il dossier Chilcot contiene vari messaggi tra Blair e
Bush prima, durante e dopo il conflitto. In questa lettera, scritta a mano, l’ex
premier si complimenta con il presidente Usa per un suo «brillante discorso» in
merito alla necessità dell’intervento in Iraq. In tutto sono 29 le lettere
inviate dall’ex primo ministro del Regno Unito Tony Blair all’ex presidente Usa
George W. Bush e sono centinaia i documenti desecretati e pubblicati nel
Rapporto Chilcot. Il rapporto tra i due leader è considerato cruciale nella
decisione dell’invasione. Il rapporto Chilcot è un’inchiesta britannica portata
avanti dalla commissione parlamentare presieduta dall’ex diplomatico Sir John
Chilcot sulla guerra in Iraq. Istituita da Gordon Brown nel 2009, ha lo scopo di
far chiarezza sulle circostanze che portarono il governo di Tony Blair a entrare
in guerra assieme agli Stati Uniti contro Saddam Hussein Durante i lavori della
commissione sono stati analizzati oltre 150.000 documenti e sono stati sentiti
più di 150 testimoni, tra cui l’ex premier Tony Blair. È suddiviso in 12 volumi
e contiene 2,6 milioni di parole.
Iraq, come sarebbe il mondo oggi se
Saddam non fosse caduto? Dopo tredici anni e
un’infinita serie di attentati e violenze, cinque domande provano a creare una
realtà alternativa in cui il raìs sarebbe ancora al potere, scrive Michele
Farina il 6 luglio 2016 su “Il Corriere della Sera”. E se non avessero invaso
l’Iraq? O se almeno avessero preparato meglio il dopo guerra? Per il rapporto
Chilcot fu un intervento «sbagliato» e «le sue conseguenze perdurano ancora
oggi». Tony Blair dice che senza quell’intervento il mondo sarebbe peggiore,
meno sicuro. E che almeno adesso gli iracheni hanno una chance di libertà che
sotto Saddam Hussein non avevano. La libertà di morire a centinaia, una sera
d’estate del 2016, per l’esplosione di un camion bomba dell’Isis tra i negozi e
i ristoranti di Bagdad affollati di famiglie e bambini? Khaddim al-Jaburi dice
che, se incontrasse Blair oggi, «gli sputerebbe in faccia». Al Jaburi è l’uomo
che buttò già la prima statua di Saddam alla caduta di Bagdad. Faceva il
meccanico, riparava le moto del dittatore. Cadde in disgrazia, gli uccisero 15
familiari. Eppure oggi intervistato a Bagdad dalla Bbc dice che se potesse
tornare indietro, sapendo quanto è successo in questi tredici anni, lui quella
statua «la rimetterebbe in piedi». I curdi del nord e gli sciiti del Sud, per
decenni vittime dichiarate del regime, hanno una prospettiva differente. Senza
l’invasione del 2003 Saddam o chi per lui (Qusay, il figlio più astuto)
gaserebbe ancora bambini e avversari? Avrebbe fatto un’altra guerra con l’Iran?
E se la primavera araba nel 2011 avesse attecchito anche sulla riva al Tigri
oggi l’Iraq sarebbe comunque preda — come lascia intendere Blair — di una
sanguinosa guerra civile modello siriano? E il mondo sarebbe comunque alle prese
con l’Isis e il suo terrorismo in franchising? Tornare indietro. Immaginare la
storia provando a rimettere insieme i tasselli secondo un’altra combinazione,
seguendo il cartello del «what if», cosa sarebbe successo se. Lo fa l’ex premier
Blair e il meccanico al-Jaburi. E’ una tentazione che ognuno di noi sperimenta
nel proprio piccolo, a ogni angolo. E se Pellè non avesse provocato Neuer? Più
seriamente, pensando in grande: e se non avessero invaso l’Iraq? Un gioco
distopico per romanzieri, un esercizio per provare a non sbagliare direzione in
futuro.
1 Se avessero trovato le armi di distruzione di
massa? Tutto a posteriori sarebbe stato giustificato. Bush e Blair candidati al
Nobel per la pace?
2 Se Blair non si fosse legato al carro armato di
Bush? L’America sarebbe andata da sola all’invasione. La Gran Bretagna non
sarebbe stata meno sicura. Vedi Francia: nel 2003 con Chirac all’Eliseo disse no
all’intervento armato in Iraq. Ma questo non le ha risparmiato le ferite degli
attentati di Parigi.
3 Se la guerra fosse stata preparata meglio? Il
rapporto Chilcot accusa Londra (e di riflesso Washington) di impreparazione e
sottovalutazione. Anche da un punto di vista militare. Fin da subito gli stessi
comandi alleati dissero (inascoltati) che servivano più soldati e più mezzi. Gli
Usa rimasero con gli Humvees colabrodo che saltavano in aria sulle bombe
improvvisate, gli inglesi al Sud giravano con i gipponi che i soldati chiamavano
«bare mobili». Pensare che la Cia arrivò a Bagdad con casse di bandierine a
stelle e strisce: da distribuire alla popolazione che si immaginava festante.
Altro che resistenza. Gli Usa prospettavano un rapido «mordi e fuggi», o in
alternativa qualcosa di simile alla serena occupazione del Giappone dopo la
Seconda Guerra Mondiale.
4 Se non avessero sciolto l’esercito iracheno? Una
questione spinosa e complicata. Ma certo quella decisione presa dal governatore
Usa Paul Bremer non favorì la riconciliazione nazionale. Anzi.
5 Se avessero aspettato l’Onu? Francia e Russia
erano contro l’intervento armato. Di fronte alla paralisi diplomatica non c’era
un attimo da perdere, sostiene Blair. Ma le prove di intelligence contro Saddam
Hussein, come riafferma oggi la commissione Chilcot dovevano apparire gravemente
insufficienti anche 13 anni fa. E allora, prendere tempo sarebbe stato saggio e
non avrebbe necessariamente rafforzato Saddam. Questa era anche la posizione
tedesca. Una linea di prudenza che, con scenario tutto diverso, Angela Merkel va
applicando anche alla questione Brexit. La politica del «Schweigen»: calma e
silenzio. Meglio che «shock and awe», colpisci e terrorizza (la tattica adottata
nel primo giorno di attacco all’Iraq nel 2003). Il rapporto Chilcot (volendolo
guardare attraverso il filtro della diplomazia comunitaria) per certi versi
prova e allarga il solco tra Gran Bretagna ed Europa continentale. Un solco a
geometrie variabili, considerando per esempio l’impazienza francese
nell’attaccare la Libia di Gheddafi. Anche se i tedeschi mai l’ammetterebbero,
l’attendismo di Berlino sulla Brexit (aspettiamo l’estate) può ricordare il
nostro adda passà ‘a nuttata. Molto italiano, e anche molto iracheno: il
sentimento di un popolo che, 13 anni dopo la sua liberazione, si ritrova a
rimpiangere l’orco Saddam.
Massoneria. Rivoluzioni e
conquiste.
La Brexit come disegno ordito
dalla massoneria.
L’opinione del dr. Antonio
Giangrande. Scrittore, sociologo storico, blogger, youtuber, presidente
dell’Associazione Contro Tutte le Mafie.
«Non voglio passare per un
complottista, ma la saggistica scrive che la massoneria anglosassone, non
anglicana, non atea, ma pagana, ha sempre complottato contro la chiesa cattolica
per estirpargli l’egemonia di potere che esercita sul mondo occidentale. Per
avere il primato d’imperio sulla civiltà e sui popoli e per debellare questa
forza internazionale, prima temporale e poi spirituale, la massoneria ha
manipolato le masse povere ed ignoranti contro le dinastie regnanti cristiane.
Ha fomentato la rivoluzione francese, prima, americana, poi, ed infine, russa,
inventando il socialismo ateo e anticlericale, da cui è scaturito fascismo,
nazismo e comunismo, fonte di tante tragedie. La chiesa, ciononostante, non ha
capitolato. Non riuscendo nel suo intento, la massoneria, si è inventata,
attraverso i media ed i governi fantoccio, le guerre di democratizzazione del
Medio Oriente e Nord Africa, foraggiando, al contempo, gruppi estremistici e
terroristici, e contestualmente ha intensificato l’affamamento dell’Africa, con
lo sfruttamento delle sue risorse a vantaggio di tiranni burattini, con il fine
ultimo di incentivare l’invasione islamica dell’occidente, attraverso gli
sbarchi continui sulle coste dell’Europa di migranti, rifugiati e terroristi
infiltrati. L’islamizzazione dell’Europa come fine ultimo per arrivare
all’estinzione della cristianità.
La sinistra nel mondo è
soggiogata e manipolata da questo disegno di continua destabilizzazione
dell’ordine mondiale, di fatto favorendo l’invasione dell’Europa, incitando il
diritto ad emigrare.
“Nel contesto socio-politico
attuale, però, prima ancora che il diritto a emigrare, va riaffermato il diritto
a non emigrare, cioè a essere in condizione di rimanere nella propria terra”
afferma il Santo Padre Benedetto XVI nel suo Messaggio per la 99ma Giornata
Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che sarà celebrata domenica 13 gennaio
2013, sul tema “Migrazioni: pellegrinaggio di fede e di speranza”.
Il monopoli o domino massonico
destabilizzante continua il 23 giugno 2016. Il Regno Unito ha votato la sua
uscita dall'Unione Europea. Ma la domanda è: Il Regno Unito ci è mai entrato
nell'Unione Europea? E se lo ha fatto con quali intenzioni? Sia l’entrata che
l’uscita dall’Unione Europea dell’Union Jack non è forse un tentativo di
destabilizzare la normalizzazione dei rapporti tra gli Stati europei ed impedire
la loro unificazione politica, economia e monetaria, oltre che ostacolare
l’espandersi dei rapporti amichevoli con la Russia che è vista come antagonista
degli Usa nell’egemonizzazione del mondo?
Dominato dall'orgoglio
francese, ma anche perché non li considerava "europeizzabili", Charles de Gaulle
non voleva gli inglesi nella comunità. Li sospettava di essere una quinta
colonna degli Stati Uniti massoni.
"Leggo dello sconforto di
Jacques Delors, ex presidente della Commissione: «Avremmo fatto meglio a
lasciare fuori gli inglesi». Ero a Parigi nel 1966, quando si discuteva già se
permettere o no l’ingresso della Gran Bretagna nella Cee. De Gaulle era
contrarissimo, mentre la maggior parte degli altri partner europei erano
favorevoli. In uno dei tanti discorsi che soleva tenere alla tv, De Gaulle fece
questa profezia: «Fate entrare l’Inghilterra e l’Europa non sarà mai fatta». Può
dirmi, alla luce di quanto sta accadendo, se «l’Europa delle Patrie» dallo
stesso De Gaulle tanto auspicata, avrebbe intrapreso forse un cammino più rapido
verso una vera Unione europea simile a quella degli Usa?" Domanda di Rocco
Caiazza a Sergio Romano del 5 dicembre 2012 su “Il Corriere della Sera”. “Caro
Caiazza, Non ricordo la frase da lei citata, ma sul problema dell’adesione della
Gran Bretagna alla Comunità europea la posizione di De Gaulle fu sempre chiara
ed esplicita. Era convinto che Londra sarebbe stata il «cavallo di Troia»
dell’America nell’organizzazione europea e non esitò a boicottare i negoziati
con una clamorosa conferenza stampa il 14 gennaio 1963.” Fu la risposta di
Romano. In effetti, dal 1975, da quando cioè il Regno Unito attraverso un altro
referendum convocato sulla permanenza nell'Ue ad appena tre anni dal suo
ingresso ufficiale ha optato per il «sì» a Bruxelles, le relazioni tra Londra e
il blocco comunitario non sono mai state idilliache, scrive Arianna Sgammotta su
“L’Inkiesta” il 22 giugno 2016. Non soltanto. Oltremanica l'Unione europea è
sempre stata o ignorata o accusata di tutto quello che non funzionava in patria.
Non stupisce quindi che fino al 2008, agli anni precedenti la crisi economica e
finanziaria, l'etichetta euroscettico fosse a uso e consumo dei britannici,
quasi a porsi come un sinonimo del carattere nazionale. In trent'anni di
convivenza difficile il Regno Unito ha ottenuto una serie di deroghe
all'implementazione di vari regolamenti validi invece per tutti gli altri Stati
membri. Questo grazie alla cosiddetta clausola dell'opt-out. Ma non basta,
grazie alla leader di ferro, Margaret Tatcher, Londra gode di un deciso sconto
sul contributo annuale al bilancio comunitario. All'origine della diatriba tra
Regno Unito e resto delle capitali Ue, la visione stessa del progetto
comunitario. Per Londra una mera area di libero scambio solo se per sé
vantaggiosa, per i Paesi fondatori - tra cui l'Italia - le basi di un'unione
politica, economica e monetaria. Tant’è che il Regno Unito non è nell’area Euro
né nello spazio Schenghen.
Allora, anziché rammaricarci
del risultato, perchè non brindiamo per la vittoria che gli europeisti
continentali hanno ottenuto ed analizziamo le notizie ed i dati offerteci dai
media con maggior approfondimento e distacco ideologico? Come chiederci: gli
antieuropeisti come gli europeisti fallimentisti, che con il formalismo e la
burocrazia minano le basi dell’Unione, sono mica massoni?»
Massoneria come entità
sopranazionale e trasversale, comunque vincente, checchè ne dicano i soliti
idioti che stanno sempre lì a commentare le ovvie verità nei miei scritti. Ecco
perché a Strasburgo vediamo che il Parlamento Europeo vota per l’uscita
immediata dalla UE del Regno Unito ed a votare contro troviamo il leader inglese
che ha fomentato la Brexit e con lui hanno votato il Movimento 5 Stelle, ed i
movimenti di Le Pen e Salvini.
Ed i precedenti italiani di
destabilizzazione?
Per scaricare Renzi i poteri forti
rispolverano la massoneria, scrive il 20 febbraio 2016
Stefano Sansonetti su “La Notizia Giornale”. Ormai non c’è giorno senza che
arrivi un pessimo segnale per la tenuta del Governo guidato da Matteo Renzi. Se
poi questi segnali arrivano direttamente dall’estero, o sono comunque veicolati
da profili legati a centri di potere internazionali, per il premier l’effetto
non può che essere allarmante. Soprattutto quando tra le accuse viene ritirata
in ballo la “massoneria”. Tra quelli che stanno lanciando missili c’è senza
dubbio Mario Monti, ex commissario europeo, molto stimato da alcune cancellerie
nonché membro dei comitati esecutivi delle più influenti e chiacchierate lobby
mondiali, dalla Trilateral all’Aspen. Ebbene, qualche giorno fa Monti aveva dato
un antipasto a Montecitorio criticando il presidente del consiglio per la
strategia assunta in Europa. “Presidente Renzi, lei non manca occasione per
denigrare le modalità concrete di esistenza della Unione Europea, con la
distruzione sistematica a colpi di clava e scalpello di tutto quello che la Ue
ha significato finora”, aveva detto Monti in quell’occasione, aggiungendo che
“questo sta introducendo negli italiani, soprattutto in quelli che la seguono,
una pericolosissima alienazione nei confronti della Ue. Con il rischio di un
benaltrismo su scala continentale molto pericoloso”. Ieri, in un colloquio con
il Corriere della sera, Monti è stato ancora più affilato, evocando addirittura
la massoneria. Senza mai citare direttamente Renzi, l’ex premier ha spiegato che
“molti politici nazionali, che sovente si professano europeisti – e magari
perfino credono di esserlo – sono diventati maestri muratori della decostruzione
europea”. E’ appena il caso di far notare che in termini storici la massoneria
viene fatta risalire proprio alle corporazioni dei muratori del Medioevo. Lo
stesso termine “massoneria” deriva dal francese “maçon”, che significa appunto
muratore. Senza contare che in genere il “gran maestro” rappresenta il ruolo di
vertice all’interno della gerarchia massonica. Insomma, ci sono sin troppi
indizi che fanno capire come non sia stato certo casuale il riferimento di Monti
ai “maestri muratori”. Questa durissima insinuazione, seppur indiretta, ha
peraltro trovato spazio sulle colonne del Corriere della sera, non nuovo a
lanciare accuse di questo tipo. Nel settembre del 2014, in un editoriale
dell’allora direttore Ferruccio de Bortoli, il patto del Nazareno tra Renzi e
gli emissari di Silvio Berlusconi venne accostato allo “stantio odore della
massoneria”. Ma non è finita qui. Se nei giorni scorsi il Financial Times aveva
scritto che “la fortuna di Renzi si sta esaurendo”, ieri in un’intervista a Qn è
stato il politologo americano neocon, Edward Luttwak, a dare al premier italiano
l’avviso di sfratto: “Renzi ha fallito perché doveva fare riforme importanti e
non le ha fatte. Non ha fatto la spending review e non ha messo mano alla
burocrazia della pubblica amministrazione”. Quanto al possibile complotto Ue
contro Renzi, per Luttwak “non esiste, c’è stato sicuramente per Berlusconi, ma
non nei confronti di Renzi”. Infine la superstoccata finale, quella che può
aiutare a capire cosa si agiti nella mente di alcuni osservatori internazionali.
Basti leggere il modo in cui, secondo Luttwak, Renzi dovrebbe andare avanti:
“Innanzitutto lasciando a casa le ragazzine e i dilettanti e circondandosi di
personaggi qualificati”. Riferimento neanche troppo velato a Maria Elena Boschi
e a Marianna Madia. E chi dovrebbe essere recuperato da Renzi? “Pierluigi
Bersani per le liberalizzazioni, poi Romano Prodi ed Enrico Letta. E anche
Giorgio Napolitano, che potrebbe avere un ruolo nella riforma della giustizia
italiana”. Ora, da che pulpito vengano queste richieste è domanda più che
legittima. Ma è il contesto generale di pressione a dover far riflettere. Una
spia di come certi poteri stiano scaricando il premier può essere ravvisata
anche dal trattamento riservatogli da alcuni giornali. Per carità, il presidente
del consiglio può ancora “consolarsi” con il sostegno mediatico fornitogli da La
Repubblica del gruppo De Benedetti, da La Stampa della famiglia Agnelli, e da Il
Messaggero dell’immobiliarista Francesco Gaetano Caltagirone. Ma certo un bel
po’ di preoccupazione sarà indotta nel premier dagli strali lanciati dal
Corriere della sera nelle ultime 48 ore. E non è solo per via di Mario Monti.
Due giorni fa un editoriale di Antonio Polito era eloquentemente titolato “la
spinta smarrita di Renzi”. Ieri un commento economico del vicedirettore,
Federico Fubini, ha accusato Renzi si sbagliare completamente strategia quando
minaccia di opporsi alla proposta tedesca di mettere un tetto al possesso dei
titoli di Stato da parte delle banche. L’assunto è che Berlino “non sosterrà mai
un sistema europeo di garanzie sui depositi bancari”, a cui l’Italia dice di
tenere molto, “finché le banche stesse saranno così esposte sul debito dei
rispettivi governi”. La sintesi, allora, è che “quando Renzi respinge la
richiesta tedesca, di fatto rinuncia proprio a ciò che fino a ieri lui stesso
chiedeva con urgenza”. Per carità, da tutto questo dedurre un avviso si fratto
al premier sarà esagerato. Ma siamo molto vicini a una messa in mora.
L'ultimo tassello che dimostra il
complotto di Napolitano & C. Le carte pubblicate
da Repubblica sono solo la conferma dello scenario sul golpe del 2011. Prima
l'attacco speculativo sui mercati, poi le manovre per far cadere il governo
Berlusconi, scrive Renato Brunetta, Mercoledì 24/02/2016 su “Il Giornale”. Un
fatto di gravità inaudita è stato rivelato ieri da Repubblica, che ha attinto da
Wikileaks la notizia provata delle intercettazioni che uno Stato amico e alleato
ha compiuto ai danni del nostro Paese e della sua legittima autorità di governo,
rubando le telefonate del nostro presidente del Consiglio e dei suoi più stretti
collaboratori. Questo Stato si chiama Stati Uniti d'America, negli anni di
Barack Obama, e il presidente del Consiglio italiano è Silvio Berlusconi. Si
tratta di una violazione che si configura come attacco alla nostra sovranità
nazionale. Ma a questo credo che saprà (o no?) rispondere da par suo (ahinoi!)
Matteo Renzi. Il quale, visto che chiama gli oppositori interni gufi, come
minimo dovrà dare della iena a Obama. Figuriamoci. Qui restringiamo il campo a
chi ha fornito le prove di questo scempio: Repubblica. E Repubblica, se
possibile, è peggio degli spioni. Infatti la chiave di lettura che essa dà di
questo crimine è di compiacimento, poiché vuol convincere il mondo che questa
infamia fornisce nuovi proiettili contro il nemico storico, Silvio Berlusconi e
il suo governo. In particolare nell'editoriale di Claudio Tito usa le telefonate
carpite per negare l'esistenza di qualsivoglia complotto contro l'ultimo premier
legittimato dal voto e di conseguenza contro il nostro Paese. Lo scopo è chiaro:
volgarmente si direbbe, mettere le mani avanti. Più raffinatamente, trattasi
della classica operazione di disinformacija. Tito, e Calabresi-De Benedetti,
vogliono creare il mainstream, il pensiero unico su questa vicenda, obbligando
tutti i commenti a instradarsi su questi binari, ad accettare l'agenda proprio
di coloro che ordirono il complotto, i quali stavano e stanno non solo
all'estero, ma in Italia, e proprio molto vicino all'area politico-culturale di
Repubblica-Espresso. Perché queste intercettazioni sono solo nelle loro mani?
Hanno per caso pagato per averle? Perché non le hanno anche gli altri giornali?
Si fa per caso un uso selettivo di WikiLeaks? L'asino però casca sull'ignoranza,
voluta o determinata dal pregiudizio proprio e della casa madre, qui non
importa. Il diavolo sta nei dettagli. E i dettagli dicono topiche clamorose
nell'impostazione delle fondamenta di una tesi smentita dalla realtà. Ma è
proprio questa miseria morale e deontologica a essere la caratteristica
espressiva non solo del giornalismo del gruppo editoriale di De Benedetti, ma
della sinistra intellettuale e politica in quanto tale. Uno spirito di
diserzione rispetto agli interessi nazionali, abbandonando quel minimo di
patriottismo che sarebbe naturale riscontrare in chiunque ami il proprio Paese e
lo veda ferito con strumenti di scasso che mettono in pericolo la sicurezza di
tutti. Il Giornale ha, nel maggio del 2014, pubblicato e diffuso un libro che
porta la mia firma e si intitola Berlusconi deve cadere. Cronaca di un
complotto. Le rivelazioni odierne forniscono in realtà totale conferma della mia
narrazione di quegli eventi che videro l'Italia, soprattutto nel secondo
semestre del 2011, sotto attacco speculativo. Prima partì l'aggressione
finanziaria ai titoli di Stato, mentre i fondamentali della nostra economia
erano stati ben valutati dalla Commissione europea. Dal complotto finanziario si
passò senza soluzione di continuità al complotto politico, bene assecondato in
Italia dal Quirinale (e da Repubblica). Dalle telefonate intercettate in
particolare al consigliere politico e deputato Valentino Valentini, che
partecipò ai colloqui riservati di Berlusconi con i leader franco-tedeschi, si
evince che Sarkozy e Merkel misero sotto pressione fortissima Berlusconi anche
in privato. Contemporaneamente ordirono nei corridoi e in incontri riservati al
vertice del G20 di Cannes quello che il segretario del Tesoro americano Tim
Geithner ha definito nelle sue memorie the scheme, il complotto. A cui si
sottrasse, non volendosi «macchiare le mani del sangue» di Berlusconi. Ps. Ecco
a uso della scuola di giornalismo e magari alla attenzione dell'Ordine dei
giornalisti per la diffusione di notizie false. Prima il testo di Tito, poi la
confutazione delle topiche. «Il governo venne umiliato in Parlamento: incapace
di approvare la legge di Stabilità... La paura di essere travolti dal buco nero
italiano diventava il vero incubo dell'Unione europea e di tutti gli alleati
internazionali. Non è un caso che in quei giorni (autunno 2011, ndr) la Deutsche
Bank - allora ancora solida - si liberava in un colpo solo dell'88% dei titoli
di Stato italiani che aveva in cassaforte. Quasi in contemporanea, dal vertice
europeo di Nizza di ottobre arrivava un altro schiaffo. La Cancelliera tedesca
Merkel e il presidente francese Sarkozy ironizzavano con un sorriso eloquente
sulla capacità dell'esecutivo berlusconiano di mettere al riparo i conti dello
Stato». Il governo non era «incapace di approvare la legge di Stabilità». La
legge di Stabilità non era allora in questione. Si trattava, invece, del voto
sul rendiconto generale dello Stato, un atto dovuto, e peraltro approvato dalla
Camera. La Deutsche Bank non vende «per paura di essere travolti dal buco nero
italiano» dopo l'estate, ma sono le decisioni dei suoi vertici a causare ad arte
questa paura innescando la tempesta perfetta sui mercati. La Deutsche Bank
cedette i titoli di Stato italiani tra marzo e giugno 2011. La Bundesbank impose
lo stesso comportamento a tutti gli istituti presenti sul suolo tedesco ai primi
di luglio. Fu questa vendita preordinata e in blocco a causare la crescita
artificiosa dello spread. I sorrisetti di Merkel e Sarkozy non furono «durante
il vertice europeo di Nizza», ma durante una conferenza stampa a Bruxelles il 23
ottobre 2011. Il vertice europeo di Nizza si svolse un po' prima, esattamente
tra il 7 e il 9 dicembre 2000, e c'erano Giuliano Amato, Jacques Chirac e
Gerhard Schröder. In effetti lì non ci fu nessun complotto. Lo spread non ha mai
«sfiorato» 600 punti base, ma al massimo 529 il 15 novembre 2011, quando
Berlusconi, tra l'altro, si era già dimesso. Ciò detto, a chi giova oggi questa
divulgazione di informazioni? Chi è il vero obiettivo di questa campagna? È
l'operazione verità rispetto al passato, per cui noi abbiamo già chiesto
l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, oppure l'obiettivo è
l'attuale governo? È un avvertimento a Renzi? Domande inquietanti, che chiedono
risposte immediate. Ha niente da dire il solitamente ciarliero presidente del
Consiglio italiano?
Napolitano e tutto il PD hanno approvato
un piano massonico sequestrato nel 1981. Il senatore
del Movimento 5 Stelle Sergio Puglia, con un video pubblicato su “Libero
Quotidiano Tv” il 13 ottobre 2015, accusa l’ex presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano di aver portato avanti il programma della P2. Il senatore del
Movimento registra un video nel transatlantico di Palazzo Madama, dopo che il
suo gruppo è uscito dall’aula, quando l’ex presidente della Repubblica ha preso
la parola. Puglia dice: “Napolitano ha preso il programma della loggia massonica
P2 e lo ha imposto ai presidenti del Consiglio. Lui è l’autore di tutto questo
macello istituzionale”.
La sinistra massone lo sa che con i suoi apparati
politici, mediatici e culturali, influenza le masse ignoranti. E la massa vota
con la pancia, non con la testa.
Ed allora parliamo del Gruppo Bilderberg.
I massoni e la sinistra italiana,
scrive Andrea Cinquegrani, tratto da "La Voce della Campania". Il Gruppo
Bilderberg nasce nel 1952, ma viene ufficializzato due anni più tardi, a giugno
del 1954, quando un ristretto gruppo di vip dell’epoca si riunisce all’hotel
Bilderberg di Oosterbeek, in Olanda. Da quel momento le riunioni si sono svolte
una o due volte all’anno, nel più totale riserbo. In occasione di una delle
ultime, nella splendida e appartata resort di Sintra, in Portogallo, il
settimanale locale News riportò una notizia secondo cui il Governo avrebbe
ricevuto migliaia di dollari dal Gruppo per organizzare «un servizio militare
compreso di elicotteri che si occupasse di garantire la privacy e la sicurezza
dei partecipanti». Ma torniamo agli esordi. I primi incontri si sono svolti
esclusivamente nei paesi europei, ma dall’inizio degli anni ’60 anche negli Usa.
Tra i promotori - precisano alcuni studiosi della semi sconosciuta materia -
occorre ricordare due nomi in particolare: sua maestà il principe Bernardo de
Lippe, olandese, ex ufficiale delle SS, che ha guidato il gruppo per oltre un
ventennio, fino a quando, nel 1976, è stato travolto dallo scandalo Lockheed;
e Joseph Retinger, un faccendiere polacco al centro di una fittissima trama di
rapporti con uomini che per anni hanno contato sullo scacchiere internazionale
della politica e dell’economia. «La loro ambizione - viene descritto - era
quella di costruire un’Europa Unita per arrivare a una profonda alleanza con gli
Stati Uniti e quindi dar vita a un nuovo Ordine Mondiale, dove potenti
organizzazioni sopranazionali avrebbero garantito più stabilità rispetto ai
singoli governi nazionali. Fin dalla prima riunione vennero invitati banchieri,
politici, universitari, funzionari internazionali degli Usa e dell’Europa
occidentale, per un totale di un centinaio di personaggi circa». Ecco cosa hanno
scritto alcuni giornalisti investigativi inglesi nel magazine on line di Bbc
News a pochi giorni dal meeting di Stresa. «Si tratta di una delle associazioni
più controverse dei nostri tempi, da alcuni accusata di decidere i destini del
mondo a porte chiuse. Nessuna parola di quanto viene detto nel corso degli
incontri è mai trapelata. I giornalisti non vengono invitati e quando in qualche
occasione vengono concessi alcuni minuti a qualche reporter, c’è l’obbligo di
non far cenno ad alcun nome. I luoghi d’incontro sono tenuti segreti e il gruppo
non ha un suo sito web. Secondo esperti di affari internazionali, il gruppo
Bilderberg avrebbe ispirato alcuni tra i più clamorosi fatti degli ultimi anni,
come ad esempio le azioni terroristiche di Osama bin Laden, la strage di Oklaoma
City, e perfino la guerra nella ex Jugoslavia per far cadere Milosevic. Il più
grosso problema è quello della segretezza. Quando tante e tali personalità del
mondo si riuniscono, sarebbe più che normale avere informazioni su quanto sta
succedendo». Invece, tutto top secret. Scrive un giornalista inglese, Tony
Gosling, in un giornale di Bristol: «Secondo alcune indiscrezioni che ho
raccolto, il primo luogo nel quale si è parlato di invasione dell’Iraq da parte
degli Usa, ben prima che ciò accadesse, è stato nel meeting 2002 dei
Bilderberg». Di parere opposto un redattore del Financial Times, Martin Wolf,
più volte invitato ai meeting: «L’idea che questi incontri non possano essere
coperti dalla privacy è fondamentalmente totalitaria; non si tratta di un
organismo esecutivo, nessuna decisione viene presa lì». Fa eco uno dei
fondatori, anche lui inglese, lord Denis Healey: «Non c’è assolutamente niente
sotto. E’ solo un posto per la discussione, non abbiamo mai cercato di
raggiungere un consenso sui grandi temi. E’ il migliore gruppo internazionale
che io abbia mai frequentato. Il livello confidenziale, senza alcun clamore
all’esterno, consente alle persone di parlare in modo chiaro». Ed ecco cosa
scrive un altro studioso di ordini paralleli e di gruppi e associazioni che
agiscono sotto traccia, Giorgio Bongiovanni. «Bilderberg rappresenta uno dei più
potenti gruppi di facciata degli Illuminati (una sorta di super Cupola mondiale,
ndr). Malgrado le apparenti buone intenzioni, il vero obiettivo è stato quello
di formare un’altra organizzazione di facciata che potesse attivamente
contribuire al disegno degli Illuminati: la costituzione di un Nuovo Ordine
Mondiale e di un Governo Mondiale entro il 2012. Sembra che le decisioni più
importanti a livello politico, sociale, economico-finanziario per il mondo
occidentale vengano in qualche modo ratificate dai Bilderberg». «Il Gruppo -
scrive ancora Bongiovanni - recluta politici, ministri, finanzieri, presidenti
di multinazionali, magnate dell’informazione, reali, professori universitari,
uomini di vari campi che con le loro decisioni possono influenzare il mondo.
Tutti i membri aderiscono alle idee precedenti, ma non tutti sono al corrente
della profonda verità ideologica di alcuni membri principali». I veri
“conducator”- secondo questa analisi - i quali a loro volta fanno anche parte di
altri segmenti strategici nell’organigramma degli Illuminati. Due in
particolare: la Trilateral e la Commission of Foreign Relationship, nata nel
1921, la quale riunisce a sua volta tutti i personaggi che hanno fra le loro
mani le leve del comando negli Usa. «Questi membri particolari - prosegue
Bongiovanni - sono i più potenti e fanno parte di quello che viene definito il
‘cerchio interiore’. Quello “esteriore”, invece, è l’insieme degli uomini della
finanza, della politica, e altro, che sono sedotti dalle idee di instaurare un
governo mondiale che regolerà tutto a livello politico e economico: insomma, le
‘marionette’ utilizzate dal cerchio interiore perché i loro membri sanno che non
possono cambiare il mondo da soli e hanno bisogno di collaboratori motivati e
mossi anche dal desiderio di danaro e potere». Passiamo, per finire, alla
Trilateral, vero e proprio luogo cult del Potere nascosto, in grado comunque di
condizionare i destini del mondo. Ovviamente ‘sponsorizzato’ della star
dell’imprenditoria multinazionale, come Coca Cola, Ibm, Pan American, Hewlett
Packard, Fiat, Sony, Toyota, Mobil, Exxon, Dunlop, Texas Instruments,
Mutsubishi, per citare solo le più importanti. L’associazione nasce nel 1973,
sotto la presidenza “democratica” di Jimmy Carter e del suo consigliere speciale
per la sicurezza, Zbigniew Brzezinsky, il vero deux ex machina. A ispirare il
progetto, le famiglie Rothschield e Rockfeller, i Paperoni d’America. Un
progetto che ha irresistibilmente attratto i potenti del mondo, a cominciare
proprio dai presidenti Usa, con un Bill Clinton in prima fila. Così
descriveva Giovanni Agnelli la Trilateral: «Un gruppo di privati cittadini,
studiosi, imprenditori, politici, sindacalisti delle tre aree del mondo
industrializzato (Usa, Europa e Giappone, ndr) che si riuniscono per studiare e
proporre soluzioni equilibrate a problemi di scottante attualità internazionale
e di comune interesse». Il solito ritornello. Di diverso avviso il
giornalista Richard Falk, che già nel 1978 - quindi a pochissimi anni dalla
nascita - scrive sulle colonne della Monthly Review di New York: «Le idee della
Commissione Trilaterale possono essere sintetizzate come l’orientamento
ideologico che incarna il punto di vista sopranazionale delle società
multinazionali, che cercano di subordinare le politiche territoriali a fini
economici non territoriali». E’ la filosofia delle grandi corporation, che
stanno privatizzando le risorse di tutto il pianeta, a cominciare dai beni
primari, come ad esempio l’acqua: non solo riescono a ricavare profitti
stratosferici ma anche ad esercitare un controllo politico su tutti i Sud - e
non solo - del mondo. La logica della globalizzazione. E i bracci operativi di
questo turbocapitalismo sono proprio due strutture che dovrebbero invece
garantire il contrario: ovvero la Banca Mondiale e il Fondo Monetario
Internazionale. «Entrambi - scrive uno studioso, Mario Di Giovanni - sotto lo
stretto controllo del ‘Sistema’ liberal della costa orientale americana.
Agiscono a tutto campo nell’emisfero meridionale del pianeta, impegnate nella
conduzione e ‘assistenza’ economica ai paesi in via di sviluppo». E proprio
sull’acqua, la Banca Mondiale sta dando il meglio di sé: con la sua
collegata IFC (Internazionale Finance Corporation) infatti sta mettendo le mani
sulla gran parte delle privatizzazioni dei sistemi idrici di mezzo mondo,
soprattutto quello africano e asiatico, condizionando la concessione dei fondi
all’accettazione della privatizzazione, parziale o più spesso totale, del
servizio. Del resto, è la stessa Banca a calcolare il business in almeno 1000
miliardi di dollari… Scrive ancora Di Giovanni: «Le decisioni assunte dai
vertici della Trilateral riguarderanno sempre di più quanti uomini far morire,
attraverso l’eutanasia o gli aborti, e quanti farne vivere, attraverso
un’oculata distribuzione delle risorse alimentari. Decisioni che riguarderanno
l’ingegneria genetica, per intervenire nella nuova ‘umanità’. In una parola,
tutto ciò che definitivamente distrugga il ‘vecchio’ ordine sociale, cristiano,
per la creazione di un nuovo ordine. Ma tutto questo senza particolari scossoni.
Non vi sarà bisogno di dittature, visto che le democrazie laiche e progressiste,
condotte da governi di ‘centrosinistra’, servono già così efficacemente allo
scopo. Governi che riproducono - conclude - una formula già sperimentata lungo
l’intero corso del ventesimo secolo e plasticamente rappresentata dal passato
governo Prodi-D’Alema: l’alleanza fra la borghesia massonica e la sinistra,
rivoluzionaria o meno».
LE 13 FAMIGLIE CHE
COMANDANO IL MONDO,
scrive “Informare per resistere” l'8 agosto 2012. “Illuminati” o “portatori di
luce”. Appartengono a tredici delle più ricche famiglie del mondo e sono i
personaggi che veramente controllano e comandano il mondo da dietro le quinte.
Vengono, da molti, anche definiti la “Nobiltà Nera”. La loro caratteristica
principale è quella di essere nascosti agli occhi della popolazione mondiale. Il
loro albero genealogico va indietro migliaia di anni, alcuni dicono che risale
alla civiltà sumera/babilonese o addirittura che siano ibridi, figli di una
razza extraterrestre, i rettiliani. Sono molto attenti a mantenere il loro
legame di sangue di generazione in generazione senza interromperla. Il loro
potere risiede nel controllo specie quello economico (gruppo Bilderberg ecc…),
“il denaro crea potere” è la loro filosofia. Il loro controllo punta a possedere
tutte le banche internazionali, il settore petrolifero e tutti i più potenti
settori industriali e commerciali. Sono infiltrati nella politica e nella
maggior parte dei governi e degli organi statali e parastatali. Inoltre negli
organi internazionali primo fra tutti l’ONU e poi il Fondo Monetario
Internazionale. Ma qual è l’obiettivo degli Illuminati? Creare un Nuovo Ordine
Mondiale (NWO) con un governo mondiale, una banca centrale mondiale, un esercito
globale e tutta una rete di controllo totale sulle masse. A capo ovviamente loro
stessi, per sottomettere il mondo ad una nuova schiavitù, non fisica, ma
“spirituale” ed affermare il loro credo, quello di Lucifero. Questo progetto va
avanti, secondo alcuni, da millenni ma ebbe un incremento nella prima metà del
1700 con l’incontro tra il “Gruppo dei Savi di Sion” e Mayer Amschel Rothschild,
l’abile fondatore della famosa dinastia che ancora oggi controlla il Sistema
Bancario Internazionale. L’incontro portò alla creazione di un manifesto: “I
Protocolli dei Savi di Sion”. Suddiviso in 24 paragrafi, viene descritto come
soggiogare e dominare il mondo con l’aiuto del sistema economico. Rothschild
successivamente aiutò e finanziò l’ebreo Adam Weishaupt, un ex prete gesuita,
che a Francoforte creò il famigerato gruppo segreto dal nome “Gli Illuminati di
Baviera”. Weishaupt prendendo spunto dai “Protocolli dei Savi di Sion” elaborò
verso il 1770 “Il Nuovo Testamento di Satana” un piano che porterà una piccola
minoranza di persone al controllo globale. La sua strategia si basava sulla
soppressione dei governi nazionali e alla concentrazione di tutti i poteri sotto
unici organi da loro controllati. Loro hanno un piano ben preciso che portano
avanti a piccoli passi, proprio per non destare alcun sospetto. Creare la
divisione delle masse, è un passo fondamentale, in politica, nell’economia,
negli aspetti sociali, con la religione, l’invenzione di razze ed etnie ecc…
Scatenare conflitti tra stati, così da destabilizzare l’opinione pubblica sui
governi, l’economia e incutere timore e mancanza di sicurezza nella popolazione.
Corrompere con denaro facile, vantaggi e sesso, quindi rendere ricattabili i
politici o chi ha una posizione di spicco all’interno di uno stato o di un
organo statale. Scegliere il futuro capo di stato tra quelli che sono servili e
sottomessi incondizionatamente. Avere il controllo delle scuole: dalla scuola
infantile all’Università per fare in modo che i giovani talenti siano
indirizzati ad una cultura internazionale e diventino inconsciamente parte del
complotto. Indottrinando la popolazione su come si può o non può vivere, su
quali sono le regole da rispettare, gli usi e i costumi ecc… Infiltrarsi in ogni
decisione importante (meglio a lungo termine) dei governi degli stati più
potenti del mondo. Facendo coincidere queste decisioni con il progetto
finale. Controllare la stampa e l’informazione in generale, creando false
notizie, false emozioni, paura ed instabilità. Abituare le masse a vivere sulle
apparenze ed a soddisfare solo il loro piacere ed il materialismo così da
portare la società alla depravazione, stadio in cui l’uomo non ha più fede in
nulla. Arrivare a creare un tale stato di degrado, di confusione e quindi di
spossatezza, che le masse avrebbero dovuto reagire cercando un protettore o un
benefattore al quale sottomettersi spontaneamente. Uno dei loro obbiettivi
è scippare la popolazione così da manipolare il loro pensiero ed il loro
comportamento, oltre che rendere molto facile la loro identificazione e
localizzazione. Tutto questo con la scusante della sicurezza personale. Nel 1871
il piano di Weishaupt viene ulteriormente confermato e completato da un suo
seguace americano, il gran maestro, Albert Pike che elaborò un documento per
l’istituzione di un Nuovo Ordine Mondiale (NWO) attraverso tre Guerre Mondiali.
Lui sosteneva che attraverso questi tre conflitti la popolazione mondiale,
stanca della violenza e della sofferenza, avrebbe richiesto spontaneamente
protezione e pace e la creazione di organi mondiali che controllassero ciò. Dopo
la Seconda Guerra Mondiale venne fatto il primo passo in questa direzione con la
formazione dell’ONU. Per Pike, la Prima Guerra Mondiale doveva portare gli
Illuminati, che già avevano il controllo di alcuni Stati Europei e stavano
conquistando attraverso le loro trame gli Stati Uniti di America, ad avere anche
la guida della Russia. Quest’ultima sarebbe poi servita alla divisione del mondo
in due blocchi. La Seconda Guerra Mondiale sarebbe dovuta partire dalla Germania
(cosa che accadde), manipolando le diverse opinioni tra i nazionalisti tedeschi
e i sionisti politicamente impegnati. Inoltre avrebbe portato la Russia ad
estendere la sua zona di influenza e reso possibile la costituzione dello Stato
di Israele in Palestina. La Terza Guerra Mondiale sarà basata sulle divergenze
di opinioni che gli Illuminati avranno creato tra i Sionisti e gli Arabi
(occidente cristiano contro l’Islam cosa che si sta avverando e anche
velocemente), programmando l’estensione del conflitto a livello mondiale.
Ovviamente non potevano pensare di conseguire i loro obiettivi da soli, avevano
ed hanno bisogno di una “struttura operativa”, composta da organizzazioni o
persone che esercitando del potere ed operino più o meno consapevolmente nella
stessa direzione. La loro strategia ha fatto leva su 2 capisaldi: la forza del
denaro, loro hanno costituito e controllano il sistema bancario internazionale;
la disponibilità di persone fidate, ottenuta attraverso il controllo delle
società segrete (logge massoniche). Gli Illuminati e chi con loro controlla
queste società, sono pressoché Satanisti e praticano la magia nera e sacrifici
umani. Il loro Dio è Lucifero e attraverso pratiche e riti occulti manipolano e
influenzano le masse. Molti asseriscono che è anche da questa scienza di tipo
occulto che gli Illuminati hanno sviluppato la teoria sul controllo mentale
delle masse. Poco tempo fa sono emersi anche i nomi delle suddette famiglie:
ASTOR, BUNDY, COLLINS, DUPONT, FREEMAN, KENNEDY, LI, ONASSIS, ROCKFELLER,
ROTHSCHILD, RUSSELL, VAN DUYN, MEROVINGI.
Famoso discorso, fatto da John
Fritzgerald Kennedy, il 27 aprile 1961, sulla reale minaccia, che le società
segrete, costituiscono per tutto il mondo, e per la libertà, di ogni essere
umano. Kennedy denunciò apertamente i poteri occulti che nell’ombra governano il
mondo, poi quando decise di stampare una banconota di stato svincolata dalla FED
fu fatto fuori. Casualità???
L’INGHILTERRA E’
CONTROLLATA DAI ROTHSCHILD,
scrive “I Complottisti” il 30/06/2016. L’Inghilterra è un’oligarchia finanziaria
gestita dalla corona che si riferisce alla City of London e non alla Regina. La
City of London è gestita dalla Banca d’Inghilterra, una società privata. La City
è uno stato sovrano, come il Vaticano del mondo finanziario, e non è soggetta
alla legge britannica, al contrario i banchieri danno gli ordini al Parlamento
Britannico. Nel 1886 Andrew Carnegie scrisse che "6 o 7 uomini possono spingere
il paese in una guerra senza consultare il Parlamento”. Vincenzo Vickers
direttore della Banca d’Inghilterra dal 1910 al 1919 ha accusato la City per le
guerre nel mondo. L’impero britannico era un’estensione degli interessi
finanziari dei banchieri. In effetti, tutte le colonie non bianche (India, Hong
Komg, Gibilterra) erano corone colonie. Appartenevano alla City e non erano
soggetti alla legge inglese. La Banca d’Inghilterra ha assunto il controllo
degli USA durante l’amministrazione Roosevelt (1901-1909) quando il suo agente
J.P. Morgan acquisì oltre il 25% del business americano. Secondo l’American
Almanac i banchieri fanno parte di una rete chiamata club of Isles che è
un’associazione informale di famiglie reali prevalentemente europee tra cui la
Regina. Il club of Isles gestisce una cifra stimata di 10 miliardi di dollari in
assets come la Royal Dutch Shell, Imperial Chemical Industries, Lloyds of
London, Unilever, Lonrho, Rio Tinto Zinc, e anglo americana De Beers. Domina la
fornitura mondiale di petrolio, oro, diamanti, e molte altre materie prime
vitali ed impiega questi assets a disposizione della propria agenda geopolitica.
Il loro obiettivo è ridurre la popolazione mondiale ad 1 miliardo di persone
entro le prossime 2/3 generazioni, per mantenere il proprio potere globale e
feudale. La storia Jeffrey Steinberg scrisse: “Inghilterra, Scozia, Galles ed in
particolare l’Irlanda del Nord sono oggi poco più di piantagioni di schiavi e
laboratori di ingegneria sociale per soddisfare le esigenze della City of
London”. Queste famiglie costituiscono un’oligarchia finanziaria e sono il
potere dietro il trono Windsor. Considerano se stessi come eredi dell’oligarchia
veneziana che si sono infiltrati ed hanno sovvertito l’Inghilterra dal periodo
1509-1715 ed ha stabilito un nuovo più virulento ceppo anglo-olandese svizzero
del sistema oligarchico dell’impero di Babilonia, Persia, Roma e Bisanzio…La
City of London domina i mercati speculativi del mondo. Un gruppo strettamente
interdipendente di imprese, materie prime coinvolte nell’estrazione, finanza,
assicurazioni, trasporti e produzioni di cibo, fa la parte del leone nel
controllo del mercato mondiale. Sembra che molti membri di questa oligarchia
erano ebrei. Cecil Roth scrisse “il commercio di Venezia è stato il nodo
schiacciante concentrato nelle mano degli ebrei, i più ricchi della classe
mercantile (La storia degli ebrei a Venezia 1930). William Guy Carr nel libro
Pawns in the game spiega che sia Oliver Cromwell che Gugliemo d’Orange sono
stati finanziati da banchieri ebrei. La Rivoluzione Inglese (1649) è stata la
prima di una serie di rivoluzioni progettate per dare loro egemonia mondiale.
L’Inghilterra è stato uno stato ebraico per oltre 300 anni.
I 25 PUNTI SCRITTI DAI
ROTHSCHILD PER LA CONQUISTA DEL MONDO,
scrive “I Complottisti” il 22/03/2016. PREMESSA: I ROTHSCHILD, SONO UNA DELLE
POCHE FAMIGLIE A CONTROLLARE SIN DAGLI ALBORI LE BANCHE, QUINDI LE ECONOMIE E
QUINDI I GOVERNI MONDIALI. Anno 1773. Poco prima di presentare il suo piano, in
25 punti, per “dominare le ricchezze, le risorse naturali e la forza lavoro di
tutto il mondo”, Amschel Mayer Rothschild, ai suoi dodici ascoltatori, svelò
«come la Rivoluzione Inglese (1640-60) fosse stata organizzata e mise in risalto
gli errori che erano stati commessi: il periodo rivoluzionario era stato troppo
lungo, l’eliminazione dei reazionari non era stata eseguita con sufficiente
rapidità e spietatezza e il programmato “regno del terrore”, col quale si doveva
ottenere la rapida sottomissione delle masse, non era stato messo in pratica in
modo efficace. Malgrado questi errori, i banchieri, che avevano istigato la
rivoluzione, avevano stabilito il loro controllo sull’economia e sul debito
pubblico inglese». Rothschild mostrò che questi risultati finanziari non erano
da paragonare a quelli che si potevano ottenere con la Rivoluzione francese, a
condizione che i presenti si unissero per mettere in pratica il Piano
rivoluzionario che egli aveva studiato e aggiornato con grande cura. Questi 25
punti sono:
1. Usare la violenza e il
terrorismo, piuttosto che le discussioni accademiche.
2. Predicare il “Liberalismo”
per usurpare il potere politico.
3. Avviare la lotta di classe.
4. I politici devono essere
astuti e ingannevoli – qualsiasi codice morale lascia un politico vulnerabile.
5. Smantellare “le esistenti
forze dell’ordine e i regolamenti. Ricostruzione di tutte le istituzioni
esistenti.”
6. Rimanere invisibili fino al
momento in cui si è acquisita una forza tale che nessun’altra forza o astuzia
può più minarla.
7. Usare la Psicologia di
massa per controllare le folle. “Senza il dispotismo assoluto non si può
governare in modo efficiente.”
8. Sostenere l’uso di liquori,
droga, corruzione morale e ogni forma di vizio, utilizzati sistematicamente da
“agenti” per corrompere la gioventù.
9. Impadronirsi delle
proprietà con ogni mezzo per assicurarsi sottomissione e sovranità.
10. Fomentare le guerre e
controllare le conferenze di pace in modo che nessuno dei combattenti guadagni
territorio, mettendo loro in uno stato di debito ulteriore e quindi in nostro
potere.
11. Scegliere i candidati alle
cariche pubbliche tra chi sarà “servile e obbediente ai nostri comandi, in modo
da poter essere facilmente utilizzabile come pedina nel nostro gioco”.
12. Utilizzare la stampa per
la propaganda al fine di controllare tutti i punti di uscita d’ informazioni al
pubblico, pur rimanendo nell’ombra, liberi da colpa.
13. Far sì che le masse
credano di essere state preda di criminali. Quindi ripristinare l’ordine e
apparire come salvatori.
14. Creare panico finanziario.
La fame viene usata per controllare e soggiogare le masse.
15. Infiltrare la massoneria
per sfruttare le logge del Grande Oriente come mantello alla vera natura del
loro lavoro nella filantropia. Diffondere la loro ideologia ateo-materialista
tra i “goyim” (gentili).
16. Quando batte l’ora
dell’incoronamento per il nostro signore sovrano del Mondo intero, la loro
influenza bandirà tutto ciò che potrebbe ostacolare la sua strada.
17. Uso sistematico di
inganno, frasi altisonanti e slogan popolari. “Il contrario di quanto è stato
promesso si può fare sempre dopo. Questo è senza conseguenze”.
18. Un Regno del Terrore è il
modo più economico per portare rapidamente sottomissione.
19. Mascherarsi da politici,
consulenti finanziari ed economici per svolgere il nostro mandato con la
diplomazia e senza timore di esporre “il potere segreto dietro gli affari
nazionali e internazionali.”
20. L’obiettivo è il supremo
governo mondiale. Sarà necessario stabilire grandi monopoli, quindi, anche la
più grande fortuna dei Goyim dipenderà da noi a tal punto che essi andranno a
fondo insieme al credito dei dei loro governi il giorno dopo la grande
bancarotta politica.
21. Usa la guerra economica.
Deruba i “Goyim” delle loro proprietà terriere e delle industrie con una
combinazione di alte tasse e concorrenza sleale.
22. Fai si che il “Goyim”
distrugga ognuno degli altri; così nel mondo sarà lasciato solo il proletariato,
con pochi milionari devoti alla nostra causa e polizia e soldati sufficienti per
proteggere i loro interessi.
23. Chiamatelo il Nuovo
Ordine. Nominate un Dittatore.
24. Istupidire, confondere e
corrompere e membri più giovani della società, insegnando loro teorie e principi
che sappiamo essere falsi.
25. Piegare le leggi nazionali
e internazionali all’interno di una contraddizione che innanzi tutto maschera la
legge e dopo la nasconde del tutto. Sostituire l’arbitrato alla legge.
“COME (NON) FUNZIONA LA DEMOCRAZIA
DELL’UNIONE EUROPEA. INDAGINE SUI TRATTATI EUROPEI” –
SPECIALE COMPLETO in TRE PARTI (a cura dell’avvocato Giuseppe PALMA del 3 luglio
2016).
PREMESSA. Dopo il voto britannico
sulla Brexit (cioè sulla volontà del popolo del Regno Unito di restare o meno
all’interno dell’Unione Europea), giornalai di regime e professoroni
universitari, visto l’esito, hanno scatenato il putiferio! Il referendum in Gran
Bretagna di giovedì 23 giugno si è concluso con una inequivocabile vittoria del
LEAVE (fatta eccezione per Londra, il resto dell’Inghilterra e del Galles hanno
votato per uscire dall’UE, mentre Scozia e Irlanda del Nord per rimanere). Ciò
ha determinato, come ci si aspettava, un terremoto sui mercati. Ed ecco che il
“vero potere” ha scatenato un’offensiva senza precedenti contro la democrazia.
C’è addirittura chi, dall’alto del proprio ruolo di docente universitario
ordinario, ha follemente ipotizzato la necessità di sostituire il voto
eguale (cioè una testa un voto) con il voto ponderato (cioè che alcuni voti
valgano più di altri a seconda dell’età e/o del titolo di studio). A questo
punto, c’è da chiedersi: ma se è vero (e non lo è) che l’Unione Europea si fonda
sui principi di democrazia, pace e benessere, per quale motivo una semplice
consultazione elettorale (per di più di natura consultiva e non vincolante) ha
determinato il crollo dei mercati e la reazione scomposta
dell’establishment? Sarà mica l’Unione Europea ad essere INCOMPATIBILE con la
democrazia? Giudicate Voi.
PARTE PRIMA. PERCHE’ LE NORME GIURIDICHE
DELL’UNIONE EUROPEA PREVALGONO SU QUELLE NAZIONALI?
Il rapporto gerarchico nel sistema delle Fonti del
diritto: gravi problematiche. Fatta salva – nei termini che si esporranno di
seguito – la supremazia gerarchica della Costituzione nei confronti delle norme
europee di qualunque fonte (supremazia meramente formale visto che le norme
costituzionali sono state sostanzialmente superate dal contenuto dei Trattati),
la produzione legislativa nazionale di rango ordinario (le leggi e gli atti
aventi forza di legge) si colloca su un livello inferiore (rapporto gerarchico)
rispetto alla produzione legislativa dell’UE, tant’è che, qualora una norma
nazionale non fosse conforme ad una norma europea, il giudice nazionale (al
quale i cittadini si rivolgono per ottenere giustizia) deve disapplicare la
norma nazionale e applicare quella europea, anche se questa è antecedente alla
norma interna. Ma andiamo per gradi. Cosa vuol dire rapporto gerarchico? Vuol
dire che un atto giuridico deve essere conforme ad un altro atto giuridico posto
su un livello superiore nella scala gerarchica delle Fonti del diritto, cioè
– ad esempio – un regolamento del Governo deve essere conforme alla legge
ordinaria, questa deve essere conforme al Regolamento dell’UE (che è un atto
giuridico che fa parte del diritto derivato dell’Unione) e quest’ultimo non deve
essere in contrasto con i Principi Fondamentali dell’ordinamento costituzionale,
con la Parte Prima della Costituzione e con la forma repubblicana (intesa nel
suo significato più ampio). La conformità alla Costituzione è richiesta anche al
diritto europeo originario (rappresentato dai Trattati dell’UE), e a tal
riguardo va evidenziato che gli atti legislativi dell’Unione sono adottati
attraverso le procedure stabilite dai Trattati che nulla hanno a che fare con le
procedure democratiche dettagliatamente stabilite dalla Parte Seconda della
nostra Costituzione, la quale attribuisce la funzione legislativa esclusivamente
ad un Parlamento eletto direttamente dal popolo (fatta eccezione per i casi del
decreto legge e del decreto legislativo che sono invece di competenza del
Governo, la cui funzione legislativa è comunque limitata al verificarsi di
specifiche condizioni). Ciò detto, i cittadini italiani sono soggetti a norme
europee (che superano quelle nazionali) adottate attraverso procedure
legislative meno garantiste e meno democratiche di quelle stabilite dalla
Costituzione, le quali sono costate milioni di morti. Capito adesso perché la
Costituzione è stata – di fatto – esautorata sin dalle sue viscere? Come si fa a
dire di essere europeisti di fronte a tali verità? Come si può accettare che la
Commissione europea e il Consiglio dell’UE (quindi funzione esecutiva,
iniziativa legislativa e funzione legislativa), deputati rispettivamente a
proporre e ad emanare atti legislativi direttamente vincolanti e superiori alle
leggi nazionali, siano composti da soggetti nominati (e quindi non eletti) che
non ricevono neppure un vero e proprio voto di fiducia da parte del Parlamento,
unico organismo europeo eletto direttamente dal popolo? In pratica, se la
Rivoluzione francese aveva strappato la funzione legislativa dalle mani del
re (e del suo “Consilium Principis”) per attribuirla ad un’assemblea elettiva
che rappresentasse ed esercitasse la sovranità popolare, l’UE ha annullato le
conquiste rivoluzionarie attribuendo sostanzialmente la potestà legislativa
dell’Unione (il cui frutto supera la produzione legislativa nazionale) ad un
organismo – il Consiglio dell’UE – i cui componenti (al pari dei componenti
della Commissione), non essendo eletti dai cittadini, rispondono unicamente a
logiche di potere e di interesse del tutto contrapposte alle “naturali” esigenze
dei popoli. I Trattati europei (da ultimo quello di Lisbona) prevedono che la
funzione legislativa dell’UE sia esercitata congiuntamente da Parlamento europeo
e Consiglio dell’UE, ma la potestà legislativa del Parlamento europeo è
circoscritta al mero ruolo di “compartecipe” o di “notaio in differita”. Nella
sostanza, gli atti giuridici dell’Unione sono adottati dal Consiglio e dalla
Commissione, due organi non eletti dal popolo e che non rispondono a criteri
democratici! La funzione legislativa dell’Unione mira esclusivamente alla tutela
del capitale internazionale (anche attraverso l’euro), al perseguimento degli
scopi delle multinazionali e alla salvaguardia degli interessi dei mercati. Il
rispetto della sovranità popolare e la tutela dei diritti fondamentali non fanno
parte dell’agenda politica e legislativa dell’UE! Ma entriamo nello specifico.
Ferma restando la palese manipolazione interpretativa dell’art. 11 Cost. La
nostra Corte Costituzionale, già nel 1964, affermava che le norme comunitarie
sono da porre sul medesimo piano delle leggi ordinarie, e che un eventuale
conflitto tra norma interna e norma comunitaria si sarebbe dovuto risolvere
attraverso il criterio della successione delle leggi nel tempo (il c.d.
principio lex posterior derogat priori), ossia che la norma successiva deroga
(sostituisce) quella precedente (Sent. n. 14 del 7 marzo 1964 – Costa c. Enel).
Successivamente, nel 1973, la Consulta si spinge addirittura oltre riconoscendo
sia il primato del diritto comunitario sul diritto interno che l’efficacia
diretta dei Regolamenti (Sent. n. 183 del 1973 – conosciuta come Sentenza
Frontini). Forse toccata da un sussulto di indipendenza, nel 1975 sempre la
nostra Corte Costituzionale (con Sentenza n. 232/1975) enuncia il principio che,
affinché potesse essere disapplicata, la norma nazionale doveva essere abrogata
o dichiarata costituzionalmente illegittima dall’organo costituzionale
competente, lasciando in tal modo allo Stato (attraverso se stessa) un minimo di
controllo sull’efficacia della normativa comunitaria nell’ordinamento giuridico
nazionale. Ma nel 1978 interviene un’importante Sentenza della Corte di
Giustizia europea (causa Simmenthal – Sent. 9 marzo 1978) che risolve
ogni empasse in favore della legislazione comunitaria: “il giudice nazionale,
incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni
del diritto comunitario, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali
norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi
disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza
doverne chiedere od ottenere la previa rimozione in via legislativa o mediante
qualsiasi altro procedimento costituzionale”. Trascorrono circa sei anni durante
i quali la Consulta mantiene sostanzialmente le proprie posizioni, ma nel
1984 il conflitto tra la giurisprudenza della Corte di Giustizia e quella della
Corte Costituzionale viene definitivamente risolto da quest’ultima con
l’emanazione della Sentenza n. 170 dell’8 giugno 1984 (causa Granital c.
Ministero delle Finanze), con la quale la nostra Consulta si è allineata
totalmente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, stabilendo che il
giudice nazionale è tenuto a disapplicare addirittura anche la normativa
nazionale posteriore confliggente con le disposizioni europee, superando in tal
modo l’obbligo previsto nel 1975 di un preventivo giudizio di legittimità
costituzionale. Successivamente, nel 1985 (Sent. del 23 aprile 1985 n. 113 –
causa BECA S.p.A. e altri c. Amministrazione finanziaria dello Stato), la
Consulta – oltre a ribadire quanto già affermato con Sentenza n. 170/1984 –
chiarisce che la normativa europea entra e permane in vigore in Italia senza che
i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato, ogni qualvolta
la normativa europea soddisfa il requisito dell’immediata applicabilità, quindi
i Regolamenti UE e – per espressa previsione – le statuizioni risultanti dalle
Sentenze interpretative della Corte di Giustizia. Tuttavia, l’applicazione e
l’efficacia diretta delle norme del diritto europeo incontrano un limite
invalicabile (quanto meno da un punto di vista formale) rappresentato dai
Principi Fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dai diritti inalienabili
della persona, infatti la stessa Corte Costituzionale – con Sentenza del 13
luglio 2007 n. 284 – afferma: “Ora, nel sistema dei rapporti tra ordinamento
interno e ordinamento comunitario, quale risulta dalla giurisprudenza di questa
Corte, consolidatasi, in forza dell’art. 11 della Costituzione, soprattutto a
partire dalla sentenza n. 170 del 1984, le norme comunitarie provviste di
efficacia diretta precludono al giudice comune l’applicazione di contrastanti
disposizioni del diritto interno, quando egli non abbia dubbi – come si è
verificato nella specie – in ordine all’esistenza del conflitto. La non
applicazione (del diritto interno – nda) deve essere evitata solo quando venga
in rilievo il limite, sindacabile unicamente da questa Corte, del rispetto dei
principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili
della persona”. A tal proposito, Luciano Barra Caracciolo sostiene che tra i
limiti che incontra la prevalenza del diritto europeo rispetto al diritto
interno, anche in relazione all’interpretazione dell’art. 11 Cost., non vi sono
solo quelli di parità con gli altri Stati o di promozione della pace e della
giustizia fra le Nazioni, ma anche quello sancito dall’art. 139 Cost. (La forma
repubblicana, intesa nella sua accezione più vasta) e quello – come stabilito
anche dalla Consulta – del rispetto dei Principi Fondamentali dell’ordinamento
costituzionale e dei diritti inalienabili della persona. Il novero di questi
limiti (cosiddetti CONTROLIMITI), inoltre, non si ferma ai diritti inalienabili
della persona, ma si estende – come si è visto –, oltre che ai Principi
Fondamentali dell’ordinamento costituzionale, anche alle disposizioni di cui
alla Parte Prima della Costituzione che rappresentano la proiezione
programmatica dei Principi Fondamentali. Sempre in merito ai rapporti tra
ordinamento costituzionale italiano e prevalenza del diritto comunitario, Barra
Caracciolo riporta un’illuminante argomentazione di uno dei Padri Costituenti,
il calabrese Costantino Mortati, tra i più importanti giuristi italiani del XX
Secolo: “Passando all’esame dei limiti, è da ritenere che essi debbano
ritrovarsi in tutti i principi fondamentali, sia organizzativi che materiali, o
scritti o impliciti, della Costituzione: sicché la sottrazione dell’esercizio di
alcune competenze costituzionalmente spettanti al Parlamento, al Governo, alla
giurisdizione,…dev’essere tale da non indurre alterazioni del nostro Stato come
Stato di diritto democratico e sociale”; il che renderebbe fortemente dubbia –
scrive Barra Caracciolo – la stessa ratificabilità del Trattato di Maastricht e
poi di Lisbona. Tutto ciò premesso, chiarita la subordinazione gerarchica del
diritto europeo ai Principi Fondamentali dell’ordinamento costituzionale, alla
Parte Prima della Costituzione e alla forma repubblicana (dove per “forma
repubblicana” non si intende solo la forma di Stato opposta alla monarchia, ma
anche quell’ampio spazio creativo del concetto di Repubblica necessariamente
assunto come inscindibile da quello di democrazia e di uguaglianza sostanziale),
“non mi spiego” come sia stato possibile che si siano poste le basi per il
superamento della legislazione nazionale a vantaggio di una legislazione
sovranazionale adottata (secondo quanto previsto dai Trattati, quindi dal
diritto europeo originario) attraverso meccanismi meno democratici e meno
garantisti di quelli dettati dalla nostra Carta Costituzionale, cioè quelli
sanciti nella Parte Seconda. La nostra Costituzione, tutta, rappresenta la madre
delle Fonti del diritto dell’ordinamento giuridico italiano, quindi è la Carta
fondamentale dello Stato alla cui difesa deve provvedere (da un punto di vista
giuridico) la Corte Costituzionale. Pertanto, considerato che la Consulta ha la
funzione di sindacare sulla conformità delle leggi alla Costituzione, si può
affermare che essa non è stata sufficientemente “vigile” nei confronti del
diritto europeo originario (e, nello specifico, nei confronti delle leggi
nazionali di autorizzazione alla ratifica dei Trattati), il quale, nonostante
sia anch’esso posto nella scala gerarchica delle Fonti del diritto su un livello
inferiore rispetto alla Costituzione, ha sostanzialmente sostituito le norme
costituzionali che disciplinano la funzione legislativa e il procedimento di
adozione delle leggi (contenute nella Parte Seconda della nostra Costituzione)
con norme meno garantiste che, anche da un punto di vista formale, tradiscono
addirittura tutte quelle conquiste democratiche (costate milioni di morti) che
sono l’essenza stessa dello Stato di Diritto[5]. Una su tutte quella
dell’attribuzione della funzione legislativa unicamente ad un’assemblea eletta
direttamente dal popolo, pilastro di civiltà costituzionale che l’Unione Europea
(insieme ai Parlamenti nazionali che hanno approvato con larghe maggioranze le
leggi di autorizzazione alla ratifica dei Trattati) ha palesemente tradito
attribuendo la predetta funzione ad organismi sovranazionali non eletti e
sostanzialmente immuni dai processi elettorali.
PARTE SECONDA: L’ASSETTO ISTITUZIONALE DELL’UE
E LA MANCANZA DI DEMOCRAZIA NELLE PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI
GIURIDICI DELL’UNIONE.
La FUNZIONE LEGISLATIVA dell’Unione Europea.
Secondo quanto previsto dai Trattati dell’Unione Europea (TUE e TFUE) la
FUNZIONE LEGISLATIVA dell’Unione (vale a dire il potere legislativo, cioè quello
di fare e leggi) è esercitata – nella sostanza – dal duo Commissione
europea/Consiglio dell’Unione Europea (quest’ultimo detto anche Consiglio dei
Ministri o semplicemente Consiglio). In pratica la Commissione – che esercita il
potere esecutivo – ha anche la titolarità dell’iniziativa legislativa, cioè
sottopone sia al Consiglio dell’UE (da non confondere con il Consiglio europeo)
che al Parlamento europeo le proprie proposte degli atti giuridici da adottare
e, nella sostanza, il Consiglio adotta l’atto uniformando quasi sempre la sua
posizione alla proposta della Commissione. Nella realtà, infatti, benché sia
formalmente prevista una procedura legislativa consistente nell’adozione
congiunta dell’atto da parte di Consiglio e Parlamento (che in passato era
chiamata “procedura di codecisione”), quest’ultimo è di fatto esautorato da
quella che dovrebbe essere la sua “funzione naturale”, cioè l’esercizio
esclusivo della potestà legislativa (fare le leggi). L’aspetto drammatico, tra
tutti i gravissimi aspetti di criticità evidenziabili, è quello che sono morte
milioni di persone perché si giungesse alla conquista del sacrosanto principio
che a fare le leggi fosse esclusivamente un’assemblea eletta direttamente dal
popolo ed esercitante la sovranità popolare, ma, con l’avvento dell’Unione
Europea, tale principio è stato quasi del tutto calpestato e tradito. La
conquista democratica del binomio inscindibile “Parlamento eletto – Legge” ha
quindi avuto attuazione attraverso le disposizioni contenute in ciascuna delle
Costituzioni nazionali degli Stati membri dell’Unione, ma i Trattati
dell’UE (per ultimo il Trattato di Lisbona) ne hanno – non solo sostanzialmente
– evirato l’essenza! Il Consiglio dell’UE, infatti, è composto da un
rappresentante per ciascuno Stato membro, a livello ministeriale, di volta in
volta competente per la materia trattata, il quale é abilitato ad impegnare il
governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di
voto, ma trattasi di soggetti non eletti che il popolo il più delle volte
neppure conosce; e stesso discorso dicasi anche per la Commissione, un organismo
potentissimo composto da soggetti non eletti da nessuno (fatta eccezione per
quanto si dirà più avanti). Riassumendo questi concetti, è bene che il lettore
ricordi che la Commissione europea (esercitante sia il potere esecutivo che
l’iniziativa legislativa) e il Consiglio dell’UE (esercitante la funzione
legislativa), essendo entrambi composti da membri non eletti dai cittadini, sono
totalmente immuni dagli eventuali “scossoni” scaturenti dai processi
elettorali. E il Parlamento? Pur essendo l’unica Istituzione europea eletta
direttamente dal popolo, e quindi alla quale sarebbe dovuta legittimamente
spettare – come ci insegnano le conquiste democratiche costate milioni di morti
–l’esercizio esclusivo della funzione legislativa, svolge sostanzialmente il
ruolo di “assistente” alle decisioni del duo Commissione – Consiglio! Per di
più, considerato che i due grandi partiti europei sono il PSE (Partito del
Socialismo Europeo) e il PPE (Partito Popolare Europeo), in Parlamento v’è e vi
sarà sempre la maggioranza assoluta per non bloccare le decisioni di Commissione
e Consiglio! Ma non è finita qui: mentre la nostra Costituzione prevede che il
Governo (al quale è affidato sia l’esercizio della funzione esecutiva che
l’iniziativa legislativa) debba godere necessariamente della fiducia del
Parlamento (altrimenti non può esercitare a pieno le sue funzioni ed è
addirittura obbligato a dimettersi), in Europa non è così! Il Parlamento
europeo, nella sostanza, non vota e non revoca alcuna fiducia alla Commissione
(e neppure al Consiglio), la quale esercita la funzione esecutiva e l’iniziativa
legislativa unicamente per volere di coloro che hanno scritto i Trattati e senza
alcun controllo – neppure indiretto – da parte dei rappresentanti del popolo (in
merito all’argomento fiducia/sfiducia Parlamento/Commissione, leggasi
l’approfondimento tecnico a seguire). Il Parlamento europeo, per la prima volta
a partire dal 2014, ha solo il diritto di eleggere (a maggioranza dei suoi
membri) il Presidente della Commissione europea: considerato che alle ultime
elezioni del maggio 2014 nessuno tra PSE e PPE ha ottenuto la maggioranza
assoluta dei seggi, questi hanno “pensato bene” di mettere insieme i propri
numeri in Parlamento esprimendo un voto corale in favore del candidato del PPE
Jean-Claude Juncker (sulla base del fatto che il PPE ha ottenuto la maggioranza
relativa dei seggi). Quindi a nulla – o quasi – sono valse le vittorie
elettorali di Marine Le Pen in Francia e di Nigel Farage in Inghilterra: nel suo
complesso, il sistema elettorale per l’elezione del Parlamento europeo è stato
concepito e realizzato proprio perché siano sempre il PSE e/o il PPE a farla da
padrona!
APPROFONDIMENTO TECNICO. I Trattati dell’UE, oltre
a prevedere che il Presidente della Commissione europea sia eletto dal
Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono e tenuto conto dei
risultati elettorali per l’elezione del Parlamento medesimo (circostanza sopra
evidenziata), prevedono anche che quest’ultimo (cioè il Parlamento) esprima
un VOTO DI APPROVAZIONE nei confronti della Commissione (e più precisamente nei
confronti del Presidente, dell’Alto rappresentante per gli affari esteri e degli
altri commissari collettivamente considerati), il quale non equivale
assolutamente ad un voto di fiducia come quello che – ad esempio – il Parlamento
italiano esprime nei confronti del Governo; si tratta infatti di una cosa ben
diversa che, nella sostanza, si traduce in un mero “giudizio di gradimento” del
tutto ovvio e scontato in quanto il voto di approvazione del Parlamento è
preceduto dal voto con cui questo ha già eletto il Presidente della Commissione.
Per di più, dopo che il Parlamento europeo ha espresso il voto di approvazione
nei confronti della Commissione, è necessario un ulteriore passaggio consistente
nella nomina ufficiale della Commissione da parte del Consiglio europeo (da non
confondere con il Consiglio dell’UE), e ciò dimostra come il voto di
approvazione espresso dal Parlamento nei confronti della Commissione non possa
considerarsi tecnicamente come un vero e proprio voto di fiducia. Per quanto
riguarda, invece, un eventuale “voto di sfiducia” del Parlamento nei confronti
della Commissione (che obbligherebbe quest’ultima alle dimissioni), è opportuno
anzitutto evidenziare che è del tutto azzardato parlare di “sfiducia” perché è
quasi impossibile che ciò possa verificarsi nella realtà: la cosiddetta MOZIONE
DI CENSURA prevista dai Trattati è una mera previsione formale del tutto
irrealizzabile nella sostanza, infatti perché il Parlamento europeo possa
“sfiduciare” la Commissione occorre che l’eventuale mozione di censura venga
approvata con una maggioranza di addirittura i 2/3 dei voti espressi dall’aula
parlamentare, sempre che il predetto risultato non sia inferiore alla
maggioranza dei membri che compongono il Parlamento. Una vera e propria “truffa”
che rende la forma palesemente soccombente al cospetto della sostanza. E in
democrazia, si sa, la forma è elemento fondamentale e irrinunciabile. E’ pur
vero che – nella forma – il Trattato di Lisbona prevede l’esercizio congiunto
della funzione legislativa da parte del Consiglio dell’UE e del Parlamento
europeo (posti formalmente sullo stesso piano quanto meno nella procedura
legislativa ordinaria), ma è altrettanto vero che – nella sostanza – il
Parlamento non esercita a pieno la funzione legislativa come invece avviene per
tutte le assemblee legislative di ciascuno degli Stati membri. Il Parlamento
europeo ha – di fatto – un misero ruolo di “compartecipe” o di “notaio in
differita”.
Le procedure legislative dell’UE per l’adozione
degli atti giuridici dell’Unione. Le procedure legislative di adozione degli
atti giuridici dell’Unione Europea si distinguono in ordinaria e speciali.
LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA (che
rappresenta la regola nella formazione degli atti giuridici dell’UE) è composta
di quattro fasi:
Iª FASE (fase della prima lettura) – La
Commissione europea presenta una proposta congiuntamente sia al Consiglio
dell’UE che al Parlamento europeo, e su di essa quest’ultimo formula la sua
posizione (cioè il Parlamento può presentare o meno una serie di emendamenti) e
la invia al Consiglio. Qualora quest’ultimo non elabori proposte di emendamento,
ovvero accetti gli emendamenti (la posizione) proposti dal Parlamento, l’atto
viene adottato senza ulteriori adempimenti. Se invece il Consiglio non approva
la posizione del Parlamento, adotta una propria posizione in prima lettura e la
trasmette al Parlamento;
IIª FASE (fase della seconda lettura) – Se entro
un termine di tre mesi da tale comunicazione il Parlamento: a) approva la
posizione espressa dal Consiglio in prima lettura oppure non si pronuncia,
l’atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde
alla posizione del Consiglio; b) respinge, a maggioranza dei membri che lo
compongono, la posizione espressa dal Consiglio in prima lettura, l’atto
proposto si considera non adottato; c) propone, sempre a maggioranza dei membri
che lo compongono, emendamenti alla posizione espressa dal Consiglio in prima
lettura, il testo così emendato è inviato al Consiglio e alla Commissione che
formula un parere su tali emendamenti. A questo punto (cioè in quest’ultima
ipotesi), entro un termine di tre mesi dal testo così emendato, il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata, può: 1) approvare tutti gli emendamenti e
quindi l’atto in questione si considera adottato; 2) non approvare tutti gli
emendamenti e il suo Presidente, d’intesa con il Presidente del Parlamento,
convoca entro sei settimane un organo denominato Comitato di conciliazione;
IIIª FASE (fase della Conciliazione) – Il Comitato
di conciliazione (composto da membri o rappresentanti del Consiglio e del
Parlamento) ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune
(“testo di compromesso”) sulla base delle posizioni del Parlamento e del
Consiglio in seconda lettura. Se entro un termine di sei settimane dalla sua
convocazione il Comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l’atto
in questione si considera non adottato;
IVª FASE (fase della terza lettura) – Qualora
entro il termine di sei settimane il Comitato di conciliazione riesce invece ad
approvare un progetto comune, il Parlamento e il Consiglio dispongono ciascuno
di un termine di sei settimane (a decorrere dall’approvazione del progetto
comune da parte del Comitato di conciliazione) per adottare l’atto in questione
in base al progetto comune. Il Parlamento delibera a maggioranza dei voti
espressi mentre il Consiglio a maggioranza qualificata. Se entrambe le
Istituzioni deliberano l’adozione dell’atto in questione, questo si intende
adottato e la procedura si conclude; in mancanza invece di una decisione, ovvero
qualora l’atto non venga adottato con le maggioranze predette, lo stesso si
considera non adottato e la procedura si conclude.
LE PROCEDURE LEGISLATIVE SPECIALI, invece, non
godono di una descrizione analitica da parte dei Trattati quindi, in mancanza di
specifiche indicazioni e in attesa che si consolidi una prassi nel merito, si
ritiene che si possa parlare di procedure legislative speciali tutte le volte
che i Trattati prevedono procedure legislative differenti da quella ordinaria.
Nell’ambito delle procedure speciali, ritengo sia necessario soffermarsi
sull’ipotesi in cui è il Consiglio ad adottare l’atto con la partecipazione del
Parlamento. In questo caso si hanno due tipi di procedure: la “procedura di
consultazione” e la “procedura di approvazione”:
La procedura di consultazione: prima che il
Consiglio adotti un atto, è necessaria la consultazione del Parlamento (in tal
caso la consultazione può essere obbligatoria o facoltativa, a seconda di quanto
prevedono i Trattati). Il parere espresso dal Parlamento non è vincolante né per
la Commissione (che non è obbligata ad uniformare la sua proposta alle
osservazioni ivi contenute), né per il Consiglio, che può disattenderlo;
La procedura di approvazione: il Consiglio non può
validamente legiferare in talune materie se il Parlamento non concorda
pienamente, a maggioranza assoluta dei suoi membri, con il contenuto dell’atto.
In mancanza di tale approvazione l’atto non può essere adottato. In pratica si
tratta di un diritto di veto da parte del Parlamento nei confronti del
Consiglio.
Concentrando l’analisi sulla PROCEDURA LEGISLATIVA
ORDINARIA, uno dei suoi aspetti di maggiore criticità è quello che nella fase
della seconda lettura il Parlamento può respingere la posizione espressa dal
Consiglio in prima lettura solo a maggioranza dei suoi membri (cioè a
maggioranza assoluta), quindi occorre un voto del 50% più uno dei componenti
l’assemblea, una maggioranza che – come abbiamo visto – è possibile raggiungere
solo se si sommano i deputati di PSE e PPE. Considerato che si tratta di partiti
(entrambi) sui quali si fonda l’intero apparato eurocratico, è praticamente
impossibile per le opposizioni parlamentari trovare la forza numerica (che
ricordo è della metà più uno dei membri del Parlamento) per respingere una
posizione espressa dal Consiglio. Inoltre, come il lettore ha avuto modo di
rendersi conto, in seconda lettura l’atto si intende adottato nel testo
corrispondente alla posizione espressa dal Consiglio in prima lettura se il
Parlamento, entro il termine di tre mesi, non si pronuncia sulla predetta
posizione. Oppure, rimanendo sempre nell’esempio della fase della seconda
lettura, il Parlamento può, sì, proporre emendamenti alla posizione espressa dal
Consiglio in prima lettura, ma solo e sempre a maggioranza dei suoi membri.
Appare dunque evidente che, rispetto ad esempio alla normale procedura di
adozione delle leggi prevista dalla nostra Costituzione (artt. 70 e segg.
Cost.), le procedure dettate dai Trattati europei presentano un pericoloso
deficit di democrazia, tanto più che non è previsto neppure un controllo come
quello che la nostra Costituzione assegna al Presidente della Repubblica, il
quale ha la facoltà di rinviare la legge alle Camere per chiederne una nuova
deliberazione (art. 74 Cost.)! Il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica
del Trattato di Lisbona con un voto all’unanimità nel luglio 2008, senza alcun
adeguato dibattito né parlamentare né mediatico. Tutto quanto sinora premesso
prova che la DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE è stata ormai superata dai Trattati
dell’UE, nati non per fare gli interessi dei popoli ma per esautorarne – nella
sostanza – la sovranità e l’autodeterminazione!
TERZA ed ULTIMA PARTE: MONETA UNICA E
PAREGGIO DI BILANCIO: LA MORTE DELL’UE.
I principali aspetti di criticità della moneta
unica. Rapporto €uro/lavoro. Abraham Lincoln, Presidente degli Stati Uniti
d’America dal 1861 al 1865, ebbe modo di affermare che: “Il Governo non ha
necessità né deve prendere a prestito capitale pagando interessi come mezzo per
finanziare lavori governativi ed imprese pubbliche. Il Governo deve creare,
emettere e far circolare tutta la valuta ed il credito necessari per soddisfare
il potere di spesa del Governo ed il potere d’acquisto dei consumatori. Il
privilegio di creare ed emettere moneta non è solamente una prerogativa suprema
del Governo, ma rappresenta anche la maggiore opportunità creativa del Governo
stesso. La moneta cesserà di essere la padrona e diventerà la serva
dell’umanità. La democrazia diventerà superiore al potere dei soldi”. Era il
1865. Quello stesso anno Lincoln venne assassinato. Tra i maggiori aspetti di
criticità di questo euro, oltre a quello che trattasi di moneta da prendere in
prestito dai mercati dei capitali privati (es. banche private) ai quali va
restituita con gli interessi (costringendo i Governi ad aumentare le tasse,
inasprire gli strumenti di accertamento fiscale, porre limiti troppo bassi
all’utilizzo del denaro contante e tagliare selvaggiamente lo stato sociale),
v’è quello che è un accordo di cambi fissi, per cui, nei periodi di crisi
economica, gli Stati sono costretti – non potendo far leva sulla svalutazione
monetaria – a SVALUTARE IL LAVORO, quindi a contrarre le garanzie contrattuali e
di legge, a ridurre i salari e a rendere eccessivamente flessibile il rapporto
di lavoro (vedesi Riforma Fornero e Jobs Act). Il tutto a scapito dei diritti
fondamentali e del principio supremo del lavoro sul quale la Costituzione stessa
fonda la Repubblica. L’euro è una moneta costruita non per la realizzazione
concreta dei principi supremi sanciti dalla Costituzione (uno su tutti il
lavoro), bensì per la tutela del capitale internazionale, e ciò comporta la
necessità – addirittura ammessa esplicitamente – di mantenere tendenzialmente
alto il tasso di disoccupazione (o comunque di non ridurlo sotto una certa
soglia), ovvero di conseguire un più alto livello occupazionale ma mantenendo
salari bassi e comprimendo le garanzie contrattuali e di legge in favore del
lavoratore: se non si comprende questo concetto è impossibile rendersi conto di
quanto è accaduto. L’UE nasce, come espressamente scritto nei Trattati, su
principi del tutto in contrasto con quelli sui quali trovano fondamento le
Costituzioni degli Stati membri: l’art. 3, comma 3, del TUE stabilisce infatti –
tra gli obiettivi dell’Unione –la stabilità dei prezzi in un’economia di mercato
fortemente competitiva, e ciò lede palesemente l’obiettivo della piena
occupazione sul quale la Repubblica italiana trova fondamento (art. 1 co. I e
art. 4 Cost.) e verso il quale tendono (ipocritamente) addirittura anche gli
stessi Trattati europei, i quali prevedono il perseguimento della piena
occupazione e del progresso sociale ma all’interno della cornice (davvero
assurdo!) della stabilità dei prezzi e della competitività selvaggia: in
pratica, per dirla con parole povere, l’UE persegue principalmente due
obiettivi: da un lato la piena occupazione e il progresso sociale, dall’altro la
stabilità dei prezzi e l’economia di mercato competitiva, i quali non possono
coesistere senza che l’uno non divori l’altro! Inoltre, a completamento
dell’orribile quadro sin qui delineato, va sottolineato che la BCE (Banca
Centrale Europea) – come previsto dal suo stesso Statuto (quindi chi ha
costruito l’UE e l’euro sapeva benissimo cosa stava facendo) – NON FUNGE DA
PRESTATRICE DI ULTIMA ISTANZA, cioè non può garantire – come invece hanno sempre
fatto tutte le Banche Centrali prima dell’introduzione dell’euro – i debiti
pubblici di ciascuno degli Stati dell’Eurozona, i quali, trovandosi espropriati
di una delle funzioni fondamentali di politica monetaria ed economica, sono
continuamente assoggettati al terrore del famigerato debito pubblico!
Negli Stati che invece conservano la sovranità monetaria, il debito pubblico non
costituisce affatto un problema perché, potendo la Banca Centrale (o il Tesoro)
fungere da prestatrice di ultima istanza, essa sarà sempre in grado di
“acquistare” (e quindi di garantire) l’intero ammontare del debito
pubblico senza che il Governo scarichi il relativo peso su cittadini, imprese e
stato sociale. Ed è proprio da questa argomentazione che nasce l’esigenza di
spiegare, seppur brevemente, la funzione delle “tasse”: se negli Stati privi di
sovranità monetaria l’imposizione fiscale serve principalmente per far fronte
alla spesa pubblica (le cui voci più sensibili quali la sanità, gli stipendi dei
dipendenti pubblici e le pensioni sono ovviamente soggetti a tagli selvaggi) e
per “ripagare” – con gli interessi – i mercati dei capitali privati che hanno
dato in prestito la moneta, negli Stati che godono di sovranità monetaria le
tasse servono invece per non creare altro debito pubblico (ovvero per tenerlo
“sotto controllo”) e a controllare la massa monetaria in circolazione, quindi il
Governo può benissimo evitare di scaricare il peso del debito su popolo e
welfare. Ciò premesso, la domanda sorge spontanea: chi svolge la funzione di
prestatrice di ultima istanza negli Stati che hanno adottato l’euro? Ovviamente
il popolo, attraverso l’aumento della tassazione, l’inasprimento dei sistemi di
accertamento fiscale, l’abbassamento della soglia massima per l’utilizzo del
denaro contate e soprattutto i tagli selvaggi alle voci di spesa pubblica più
delicate (istruzione, pensioni, stipendi, sicurezza, sanità, giustizia etc…).
Tutto ciò premesso, i 19 Stati dell’Eurozona – non potendo più creare moneta dal
nulla – devono pertanto andarsi a cercare la moneta. In che modo? Prendendola in
prestito dai mercati dei capitali privati (ai quali va restituita con gli
interessi) e/o andando a prenderla da cittadini e imprese attraverso le tasse,
la lotta selvaggia all’evasione fiscale di sopravvivenza e i tagli allo stato
sociale. Inoltre, tanto per intenderci, l’euro è una moneta fiat, cioè creata
dal nulla dalla BCE (nello specifico da ciascuna Banca Centrale dei Paesi
dell’Eurozona ma su decisione della BCE), quindi il crimine è doppio, infatti
ciascuno Stato è costretto – nonostante l’euro sia creato dal nulla – a farsi
prestare la moneta dalle banche private che, prima di prestarla, valutano con la
lente di ingrandimento la capacità finanziaria dello Stato richiedente a poterla
restituire. Ecco perché c’è il terrore della spesa e del debito pubblico; ecco
perché l’evasione fiscale costituisce un problema… tutto questo perché si è
deciso di adottare l’euro, una moneta completamente sbagliata! Ma torniamo
al rapporto euro/lavoro/diritti fondamentali. Ecco un esempio pratico di come
questa moneta unica – per sopravvivere – imponga ai Paesi che l’hanno adottata
la SVALUTAZIONE DEL LAVORO: se la Riforma Fornero (Legge n. 92/2012) – in merito
ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo – rendeva il reintegro nel
posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato un’ipotesi residuale
circoscritta a sole tre circostanze (licenziamenti orali, discriminatori e nei
casi di carente motivazione o manifesta infondatezza del motivo addotto),
il Jobs Act (Legge delega n. 183/2014 e successivi decreti attuativi del 2015)
cancella del tutto la tutela del reintegro (sia per i licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo che per quelli per giustificato motivo soggettivo
o per giusta causa), fatte salve le ipotesi meramente residuali dei
licenziamenti orali, discriminatori e – solo per i licenziamenti per
giustificato motivo soggettivo o per giusta causa – nel caso di insussistenza
del fatto materiale contestato al lavoratore, lasciando fuori dal perimetro
della tutela reale (reintegro) la sproporzionalità tra fatto contestato al
lavoratore e provvedimento di licenziamento. Il Jobs Act riduce anche la forbice
della tutela obbligatoria (economica), infatti, per entrambe le tipologie di
licenziamento sopra indicate, la predetta tutela passa dalle 12-24 mensilità
previste dalla Fornero alle 4-24 mensilità del Jobs Act! Per dirla con parole
più semplici, l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori è stato quasi interamente
smantellato in risposta alle criminali esigenze di sopravvivenza di questa
moneta unica sbagliata. E a farlo è stata una politica di centro-sinistra che ha
trovato asilo in un Parlamento di nominati, “eletto” con meccanismi elettorali
dichiarati incostituzionali (Corte Costituzionale, Sent. n. 1/2014), oltre che
per volontà di un Governo presieduto dal terzo Presidente del Consiglio dei
ministri consecutivo privo di qualsivoglia legittimazione democratica. La folle
costituzionalizzazione del vincolo del pareggio di bilancio. Possibili rimedi
giuridici. In ordine a tutto quanto predetto nel precedente paragrafo, si
precisa altresì che se i “principi supremi” sui quali trova fondamento il nostro
ordinamento costituzionale (in parte coincidenti con i Principi Fondamentali
rubricati dall’art. 1 all’art. 12 della Costituzione) non possono essere
soggetti a procedura di revisione costituzionale(limite implicito al quale va
aggiunto quello esplicito della forma repubblicana di cui all’art. 139
Cost.), la Parte Prima della Costituzione – rappresentando la proiezione
programmatica dei Principi Fondamentali – è anch’essa sottratta da eventuale
procedura di revisione, se non in melius! A tal riguardo mi preme portare
all’attenzione del lettore quanto accaduto con la Legge costituzionale 20 aprile
2012, n. 1 (“Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta
costituzionale”), attraverso la quale il Parlamento italiano (pur rispettando la
procedura di revisione costituzionale dettata dall’art. 138 Cost.) ha inserito
in Costituzione il vincolo del pareggio di bilancio (art. 81 Cost., quindi Parte
Seconda della Costituzione e pertanto soggetta a revisione), ledendo – se non
addirittura esautorando – uno dei “principi supremi” dell’ordinamento
costituzionale che è il lavoro (artt. 1 co. I, 4 e 35 e seguenti della
Costituzione). In pratica, pur rispettando la forma (COSTITUZIONE FORMALE), il
Legislatore ha palesemente violato e tradito la sostanza (COSTITUZIONE
MATERIALE). Partiamo da un presupposto inconfutabile: l’art. 1, primo comma,
della Carta costituzionale (“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul
lavoro”) rappresenta la norma più importante della nostra Costituzione, il faro
dell’intera legislazione, il limite supremo ad ogni sopruso, la rotta maestra
che tutte le Istituzioni della Repubblica devono necessariamente percorrere sia
nell’esercizio del potere legislativo ed esecutivo, sia nell’esercizio della
funzione giurisdizionale! Se i Padri Costituenti decisero di fondare la
Repubblica sul lavoro (avrebbero potuto fondarla benissimo, ad esempio, sulla
democrazia rappresentativa o sulla lotta ai totalitarismi) vuol dire che
ammettevano senz’ombra di dubbio che lo Stato possa spendere a deficit al fine
di creare piena occupazione e tutelare il diritto al lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni. Se così non fosse, per quale motivo i Padri Costituenti
avrebbero fondato la Repubblica “sul lavoro”? Per quale motivo avrebbero scritto
la parola “lavoro” addirittura al primo comma del primo articolo? E’ ovvio che
l’intenzione dell’Assemblea Costituente era quella di creare uno Stato
democratico che garantisse a tutti la possibilità di vivere liberi dal bisogno,
garantendo a chiunque un medio benessere non scaturente dalla rendita o dalla
proprietà, bensì dal lavoro (sia manuale che intellettuale)! Ma la Costituente,
indomita, si spinse addirittura oltre e scrisse anche sia l’art. 4 co. I e II
(“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di
svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”), sia
gli artt. 35 e seguenti (sulla tutela del lavoro, della libertà sindacale e del
diritto di sciopero). Il “principio supremo” del lavoro, rubricato sia nei
Principi Fondamentali (artt. 1 co. I e 4 Cost.) che nella Parte Prima della
Costituzione (artt. 35-40 Cost.), e quindi non soggetto a revisione
costituzionale (se non in melius per quel che concerne la rubricazione che va
dall’art. 35 all’art. 40 Cost.), di fronte alla costituzionalizzazione del
vincolo del pareggio di bilancio (avvenuta – come si è già evidenziato – nel
rispetto formale della procedura di revisione costituzionale dettata dall’art.
138 Cost.) perde di efficacia sostanziale! Ciò detto, il nostro Parlamento ha
volutamente calpestato i principi inderogabili della Costituzione (Costituzione
primigenia) rendendo la Repubblica non più fondata sul lavoro bensì sulla
stabilità (si fa per dire!) dei conti pubblici, mutandone completamente – con un
atto di forza formalmente corretto ma sostanzialmente illegittimo – sia l’anima
che l’impianto! Ciò premesso, la costituzionalizzazione del vincolo del pareggio
di bilancio è del tutto incompatibile con i “principi supremi” dell’ordinamento
costituzionale. L’obbligo del pareggio di bilancio, introdotto in Costituzione
nel 2012, sarebbe dovuto entrare in vigore a partire dal 2014, tuttavia il
Governo Renzi – in cambio delle cosiddette riforme strutturali [soprattutto
della riforma del mercato del lavoro (Jobs Act) e dell’avvio a ritmi serrati
della revisione della Parte Seconda della Costituzione] – ha ottenuto da
Bruxelles prima un rinvio al 2018, poi al 2019. In pratica lo “schiavo”, dopo
essersi flagellato da solo convincendosi che flagellarsi fa bene, e dopo aver
spontaneamente rinunciato alla libertà che gli è stata donata dai suo Padri,
attende consapevole e felice la data della sua “morte” ch’egli già conosce.
Tutto ciò premesso, i rimedi che offre il nostro ordinamento giuridico al fine
di risolvere le gravi problematiche sinora esposte sono due: a) che il
Parlamento, attraverso la procedura aggravata di cui all’art. 138 Cost.,
provveda all’abrogazione dell’art. 81 della Costituzione con la quale esso
stesso ha introdotto il vincolo del pareggio di bilancio; b)che la Corte
costituzionale, chiamata secondo le norme vigenti ad esprimersi sulla
legittimità costituzionale della Legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1,
dichiari l’incostituzionalità della nuova formulazione dell’art. 81 Cost. per
palese violazione dei principi inderogabili della Costituzione primigenia. Alla
luce di tutto quanto sinora argomentato, appare quindi sufficientemente
dimostrato come la moneta unica e il pareggio di bilancio incidano negativamente
(se non di peggio!) non solo nei confronti del principio fondamentale
del lavoro, ma anche nei confronti della DEMOCRAZIA di tutti gli Stati
dell’Eurozona. Provi uno Stato che ha adottato l’euro ad indire un referendum
(anche solo consultivo) sull’abbandono della moneta unica: la democrazia sarebbe
soggetta ad un attacco spietato sia da parte dei mercati e della finanza, sia da
parte dell’establishment eurocratico (Istituzioni europee, media, giornalisti,
politici e professoroni… quelli a libro paga del sistema). Avvocato Giuseppe
PALMA
Vivere sotto perenne giudizio.
Ognuno di noi, durante la sua esistenza, perennemente, è sempre sottoposto al
giudizio degli altri ed a questo deve essere conforme. In famiglia i genitori
hanno l’obbligo di educare ed istruire i figli secondo canone generale. A scuola
si insegna subdolamente la dottrina di Stato: quella laicista e di sinistra. Nei
concorsi pubblici o negli esami di Stato si è sottoposti al giudizio di canoni
di Stato attraverso commissari divenuti vincitori o abilitati in virtù del
trucco. Nei rapporti confessionali ci si deve attenere al dettato religioso
interpretato. Viviamo tra il martello del clericalismo e l’incudine
dell’anticlericalismo. In questa democrazia menzoniera non c’è spazio per la
libertà.
ANTICLERICALISMO e la Chiesa in Italia.
Dizionario Storico Tematico La Chiesa in Italia. Volume I - Dalle Origini
All'Unità Nazionale. Voce pubblicata il 14/01/2015. Autore: Antonio Trampus.
L’espressione anticlericalismo indica generalmente un complesso di idee e di
atteggiamenti opposti polemicamente alle posizioni del clero cattolico espresse
attraverso il clericalismo e il confessionalismo. L’aggettivo anticlericale, nel
senso proprio di chi è ostile al clero, inizia a comparire nella lingua italiana
alla metà del XIX secolo, divenendo poi di uso più comune negli anni sessanta e
ottanta attraverso periodici come L’anticlericale. Giornale settimanale
pubblicato dalla lega popolare anticlericale di Milano (1883) e il saggio di C.
Lupano, La gran questione del nostro secolo: clericalismo e
anticlericalismo (1889). In questo contesto il clericalismo era identificato nel
governo temporale della Chiesa in Italia e l’anticlericalismo, quindi,
rappresentava la sintesi delle posizioni di coloro che combattevano questo
potere e si battevano per l’unità d’Italia attraverso la scomparsa dello Stato
pontificio e con Roma capitale. In senso più ampio, l’espressione
anticlericalismo nella cultura contemporanea italiana ha finito per indicare
retrospettivamente ogni atteggiamento critico nei confronti del clero cattolico
e ogni sua tendenza a estendere la sua influenza nell’ambito della società
civile e dello Stato, sin dal tardo Medioevo e dalla prima età moderna. Vi
vengono riassunte, quindi, tutte le tendenze razionaliste confluite nella
cultura libertina di fine Seicento e in quella illuministica del Settecento.
Emblematico e precorritore delle idee anticlericali appaiono, in questo senso,
gli orientamenti deisti da chi, come Voltaire, sosteneva la necessità di un
credo morale, di una religione naturale e di una concezione di Dio che rifiutava
tanto le Chiese organizzate, quanto il loro arbitrio sui temi della
superstizione e della tolleranza nonché la corruzione e la cupidigia dell’ordine
sacerdotale di Antico Regime. Si tratta di atteggiamenti presenti anche in una
parte della cultura illuministica italiana e in particolare negli scritti di
Carlantonio Pilati e nei suoi atteggiamenti, vicini al panteismo, espressi in Di
una riforma d’Italia, ossia dei mezzi di riformare i più cattivi costumi e le
più perniciose leggi d’Italia (1767), ove si rinviene un intero capitolo
dedicato alla necessità di impedire al clero di abusare del suo potere a danno
dello Stato e dei suoi cittadini. Un diverso tipo di anticlericalismo è stato
poi individuato storiograficamente nelle posizioni di quanti, in età moderna e
dall’interno della Chiesa cattolica, si fecero portatori di esigenze di
rinnovamento e di riforma che riportassero il cristianesimo ai suoi valori
originari, recuperando i caratteri di umiltà e di carità propri del ministero
ecclesiale e rivendicando l’immagine di una Chiesa semplice e povera, come
sostenuto anche dai giansenisti. Le origini politiche dell’anticlericalismo
risalgono invece alla rivoluzione francese, quando per la prima volta venne
costruito un ordinamento statale laico, divenuto nell’Ottocento un modello per
quanti si trovarono a combattere l’alleanza fra il trono e l’altare e la
coalizione militare rappresentata dalla Santa Alleanza. In questo contesto
l’anticlericalismo incontrò le istanze del laicismo e divenne strumento di lotta
politica anche attraverso l’esperienza della Carboneria e della massoneria,
soprattutto dopo la vicenda della Repubblica romana del 1848-49 e il
rafforzamento dell’opposizione antipapale. Nel Regno di Sardegna, nell’agosto
1848, venne soppresso l’ordine dei Gesuiti e tutti i collegi vennero destinati
ad usi militari, con una decisione ben presto imitata da altri Stati italiani.
Posizioni anticlericali e antitemporaliste si ritrovano in scrittori come
Giovanni Battista Niccolini, Francesco Domenico Guerrazzi e Giuseppe La Farina e
nella dimensione filosofica e spirituale di Giuseppe Mazzini. Con le leggi
Siccardi (1850, 1855) vennero poi aboliti i privilegi del clero nel Regno di
Sardegna, tra cui il foro ecclesiastico, il diritto di asilo e la manomorta fino
a che, nel 1855, si giunse su iniziativa di Cavour all’abolizione di tutti gli
ordini religiosi privi di utilità sociale e al conferimento dei loro beni nella
Cassa ecclesiastica. Le cosiddette leggi eversive degli anni 1866-1867
stabilirono infine incameramento nel Demanio dello Stato di tutti i beni
appartenenti agli enti soppressi, fra cui le congregazioni religiose, e la
soppressione di tutti gli enti secolari ritenuti superflui per la vita religiosa
con eccezione dei seminari, delle cattedrali, delle parrocchie e dei canonicati.
Con la questione romana l’anticlericalismo divenne un orientamento condiviso da
differenti correnti politiche, sia liberali e moderate, sia democratiche,
incrociando anche istanze provenienti dalla massoneria. In particolare, la
polemica venne assumendo caratteri di radicalità concentrandosi sul potere
temporale dei papi, sul clero regolare (specie i Gesuiti, ricostituiti con la
Restaurazione) e sul controllo della scuola da parte del clero, almeno fino alla
promulgazione delle leggi volute dalla Destra storica. Si tratta di
atteggiamenti ripresi e resi popolari anche da Giuseppe Garibaldi attraverso le
sue invocazioni a “liberare l’Italia dalla piaga dei preti” e dalla curia
vaticana considerata il “governo di Satana”. Si comprendono perciò anche le
posizioni assunte dalla massoneria italiana, attraversi il Gran Maestro del
Grande Oriente d’Italia, che nel 1886 poteva considerare il clericalismo come
“destituito dal nerbo principale delle sue forze” e ormai finito “nell’agonia”.
L’anticlericalismo trovò poi significativo spazio nel movimento fascista delle
origini e venne sostenuto da esponenti della cultura futurista tra cui Filippo
Tommaso Marinetti che all’adunata nazionale dei fasci a Firenze del 9 ottobre
1919 auspicò lo “svaticanamento d’Italia”. Si tratta di posizioni
sostanzialmente abbondante dal partito fascista in coincidenza con le trattative
che portarono alla nascita dei Patti lateranensi (1929). Nel secondo dopoguerra
l’anticlericalismo nella vita politica italiana venne espresso attraverso il
Partito Comunista Italiano e il Partito Socialista e, soprattutto, attraverso il
Partito radicale sorto nel 1955 con l’obiettivo principale di promuovere la
laicità dello Stato italiano e una revisione dei Patti Lateranensi in accordo,
dal 1973, con la Lega italiana per l’abrogazione del Concordato (LIAC). In
questo quadro, e come parziale successo degli orientamenti anticlericali, viene
posta anche la revisione dei Patti Lateranensi, avvenuta nel 1984, che ha
portato ad abbondare la concezione del cattolicesimo come religione di Stato e
ha reso facoltativo l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche.
Al clericalismo si contrappone politicamente
il laicismo e ideologicamente l'anticlericalismo.
Il Clericalismo.
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. La
parola clericalismo indica un agire in senso politico che mira alla salvaguardia
e al raggiungimento degli interessi del Clero e, conseguentemente, si
concretizza nel tentativo di indebolire la laicità di uno Stato attraverso il
diretto intervento nella sfera politica e amministrativa da parte di sostenitori
anche non appartenenti al Clero, o talvolta non credenti.
Il clericalismo nel mondo.
Furono chiamati «clericali» nella metà del XIX secolo, in Francia e in Belgio,
quei cattolici impegnati in politica ed organizzati in movimenti o partiti che
si richiamavano esplicitamente alla loro confessione religiosa. I "clericali"
francesi che erano stati tra i maggiori sostenitori dell'imperatore Napoleone
III, influenzarono pesantemente la sua politica estera, in specie per i rapporti
con il Regno d'Italia e per il problema di Roma capitale. L'invasione
della Repubblica Romana e la restaurazione di papa Pio IX (1849), il fallito
tentativo di instaurare un impero cattolico in Messico (1862-67), l'episodio di
Mentana sempre a difesa di papa Pio IX (1867), sono gli esempi più rilevanti
della subordinazione politica al Clero durante il regime di Luigi Napoleone che
a garanzia dell'inviolabilità della Roma papale aveva stabilito nella città un
presidio militare francese ritirato solo dopo la Convenzione di settembre nel
1864. Gli stessi eccidi della "settimana di sangue" seguiti all'instaurazione
della Comune parigina (1871) con l'uccisione dell'arcivescovo di Parigi Georges
Darboy possono essere considerati come effetti del duro scontro in Francia tra
clericali e anticlericali socialisti. L'affaire Dreyfus (1894) la cui accusa era
sostenuta anche dai clericalisti antisemiti, organizzati
nello squadrismo dell'Action française, era il segno che, alla fine
dell'Ottocento, in Francia era forte la presenza di una Chiesa conservatrice
contrapposta ad intellettuali laici, progressisti e in parte massoni. Il termine
si diffuse poi in Spagna ed in Italia, meno in Germania e per nulla in
Inghilterra, segno di una situazione tipica di aree cattoliche dove possono
nascere contrasti tra Clero e società civile. Durante la Guerra civile
spagnola i clericali di tutta Europa si schierarono apertamente con Francisco
Franco, di cui appoggiarono il regime dittatoriale dopo la vittoria. Unica voce
cattolica apertamente contraria fu quella di Jacques Maritain. Durante
la seconda guerra mondiale il clericalismo supportò i regimi di Jozef
Tisoin Slovacchia e di Ante Pavelić in Croazia. Quest'ultimo si salvò dal
processo dopo la guerra grazie alla fuga in Spagna agevolata dal Vaticano.
Entrambi i regimi furono ferocemente antisemiti.
Il clericalismo in Italia.
Cavour, fin dal 1850 si era messo in luce pronunziando un
discorso in difesa delle leggi Siccardi che abolivano il diritto d'asilo e il
foro ecclesiastico ancora in vigore dall'età medioevale nel Regno di Sardegna.
Formato nel 1852 il "grande ministero" con Urbano Rattazzi, si era proposto di
modernizzare il Piemonte laicizzando lo Stato ma dovette scontrarsi nel 1855 con
i clericali piemontesi guidati dal vescovo di Casale e senatore, Luigi Nazari di
Calabiana contrario alla soppressione degli ordini contemplativi al punto da
causare una crisi politica che provocò le dimissioni del primo ministro.
Ritornato al governo dovette affrontare un nuovo contrasto con i clericali,
questa volta sostenuti dal re Vittorio Emanuele II, per l'introduzione
del matrimonio civile in Piemonte che sarà attuato diversi anni dopo. Lo stesso
Nazari di Calabiana, nominato arcivescovo di Milano, dopo l'unità d'Italia, nel
1864, si distinguerà per le sue polemiche contro gli intransigenti antiliberali.
Fin dal 1857 era comparso sul giornale torinese l'Armonia diretto dal
giornalista don Giacomo Margotti l'esortazione diretta ai cattolici: «Né eletti.
Né elettori». Non meraviglia quindi che, sebbene lo Stato italiano dichiarasse
di rinunciare a ogni controllo giurisdizionalistico, tuttavia i tentativi di
regolare i rapporti con la Chiesa secondo la formula cavouriana di «Libera
Chiesa in libero Stato», effettuati dallo stesso Cavour tramite il suo
collaboratore Diomede Pantaleoni, e in seguito dai primi governanti della Destra
storica, fallissero per l'intransigenza del rappresentante papale. Non ancora
intransigenti ma cattolici di stretta osservanza, tra il 1861 e il 1878 i
credenti italiani si appartano dalla vita nazionale e si esprimono in giornali
dal tono estremamente polemico. «Lentamente s'instaura quel costume, che durerà
decenni e decenni, fino alla prima guerra europea per cui il cattolico politico
ha associazioni professionali, circoli, scuole cui inviare i figli,
esclusivamente suoi, forma una società chiusa e riduce gli incontri con persone
che non dividano la sua fede al minimo possibile » La data di nascita in Italia
del clericalismo coincide con l'emanazione del Sillabo (1864) di papa Pio
IX (1846-1878) che, considerandosi "prigioniero dello stato italiano",
condannava ogni aspetto del liberalismo e del modernismo dando vita così al
movimento degli «intransigenti» cattolici che rifiutavano di riconoscere il
nuovo Regno d'Italia. La Chiesa tuttavia, sente la difficoltà di non avere nel
Parlamento del Regno d'Italia suoi rappresentanti ed emana una disposizione
nel 1866 che consente l'elezione di deputati cattolici purché nel formulare il
giuramento allo Stato essi aggiungano, alla presenza di almeno due testimoni, la
formula: «salvis legibus divinis et ecclesiasticis» ("salvo quanto dispongono le
leggi divine e della Chiesa"). La Camera ritenne nullo il giuramento e da quel
momento la voce dei deputati cattolici fu quasi assente dalle aule parlamentari.
Questa chiusura della Chiesa influì negativamente sulla politica italiana
post-unitaria, acuendo il forte anticlericalismo di gran parte dei politici
italiani del tempo. L’allontamento definitivo dei cattolici dalla partecipazione
diretta alla vita politica dello Stato italiano si ebbe quando il 30
gennaio 1870 la Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari espresse
il parere che non fosse conveniente (non expedit) per i cattolici italiani
partecipare alle elezioni politiche. Inoltre il Concilio Vaticano Primo iniziato
nel dicembre del 1869, che si caratterizzava principalmente per la definizione
del dogma dell'infallibilità del Papa quando parla ex cathedra in materia di
fede e di morale (18 giugno 1870), rendeva ancora più accentuata la durezza
delle posizioni del Clero nei confronti di chi cercasse con esso un compromesso.
Ben 55 vescovi "antinfallibilisti", prima della approvazione del dogma si
allontanarono dal Concilio che, interrotto dalla presa di Roma, non fu più
ripreso. Il 13 maggio 1871 lo Stato italiano emana un originale atto di accordo
internazionale unilaterale: la Legge delle Guarentigie (Legge delle Garanzie)
voluta dal Parlamento per regolare i rapporti con la Santa Sede dopo la presa di
Roma (20 settembre 1870). Respinta da papa Pio IX con l'enciclica Ubi nos e mai
accettata dalla Santa Sede, rimase tuttavia in vigore sino alla Conciliazione
del 1929. Su questa linea si costituì in seguito l'Opera dei congressi (1874)
che può essere considerata come la nascita di un vero e proprio partito
cattolico italiano. L'organizzazione rivendicava la rappresentanza del "paese
reale" contro lo Stato liberale e si assumeva il compito di coordinare tutte le
attività cattoliche di tipo sociale, cooperativistico, scolastico,
giornalistico. Dopo la morte di papa Pio IX nel 1878, e l'assunzione al trono
papale di papa Leone XIII (1878-1903) che mostrava dall'inizio del suo
pontificato attenzione ai problemi sociali, al mondo del lavoro e dei suoi
conflitti (vedi Rerum Novarum), sembrava potersi sperare in un'attenuazione
dello scontro tra Chiesa e Stato. In un'enciclica del 1885 si raccomandava
infatti ai cattolici europei di partecipare alla vita politica dei propri stati
per non rimanere esclusi dalle decisioni dei loro governi, ma con la limitazione
che questa adesione alla politica attiva «in qualche luogo…non convenga affatto
(nequaquam expediat) per ragioni grandissime e giustissime». Ciò che era
consentito per i paesi cattolici europei non lo era per l'Italia. Nel 1886 una
circolare del Sant'Uffizio recitava così: «A togliere ogni equivoco, udito il
parere degli Eminentissimi signori Cardinali inquisitori generali miei colleghi,
ho ordinato che si dichiari il Non expedit contenere un divieto (prohibitionem
importat) Card. Monaco.» All'interno del partito clericale italiano stava
intanto nascendo una corrente che rifletteva l'azione sociale della Chiesa
specie nelle campagne dove si organizzavano società cattoliche di mutuo
soccorso, cooperative di consumo contadine, sindacati bianchi. Era la nuova
corrente della Democrazia Cristiana che chiedeva che la sua azione sociale
trovasse legittima rappresentanza e valido riconoscimento nel parlamento
italiano. Senza politici che la difendessero l'organizzazione sociale cattolica
non poteva sperare di sostenersi. Per questi obiettivi si batterono don Romolo
Murri e il sociologo ed economista Giuseppe Toniolo subito osteggiati dai
cattolici veneti, dai gesuiti e dalla Curia romana. Se prima non si risolveva il
problema del rapporto Chiesa-Stato, sostenevano gli intransigenti, non si poteva
affrontare la questione sociale e politica. Per i democristiani risorgeva il
muro del non expedit che però sembrava potesse incrinarsi con l'avvento del
nuovo papa Pio X (1903-1914), uomo di costumi semplici e popolari. Ma
nel 1903 compariva invece sull'Osservatore Romano una nota ufficiale così
redatta: «Siamo autorizzati a smentire le voci messe di questi giorni in giro
dalla stampa cittadina e dagli altri giornali riguardo all'abolizione del Non
expedit, essendo esse assolutamente prive di fondamento.» Nel 1904 Pio X decise
di sciogliere l'Opera dei Congressi dove i "sovversivi" di Romolo Murri avevano
acquistato la maggioranza. Il Murri sarà sospeso a divinis nel1907 e diventerà
deputato nelle file dei radicali. Un altro sacerdote don Luigi Sturzo, che si
era distinto in Sicilia per la sua azione sociale, obbedì all'ingiunzione
pontificia in attesa di tempi migliori. Nello stesso anno la corrente moderata
del clericalismo organizzata nell'Unione Elettorale Cattolica realizzò accordi
prelettorali con candidati liberali moderati in maggioranza giolittiani.
Giovanni Giolitti in difficoltà dopo lo sciopero generale degli anarco
sindacalisti socialisti aveva infatti deciso di ricorrere alle elezioni convinto
che la parte moderata del paese avrebbe punito l'ala massimalista dei
socialisti. E in quest'occasione stipulò un accordo per cui i candidati liberali
avrebbero avuto il voto dei cattolici, ma si sarebbero impegnati a non
appoggiare leggi che contrastassero l'interesse del Clero. Il compromesso era
sintetizzato dalla formula: «deputati cattolici no, cattolici deputati sì.» Lo
stesso papa Pio X si mostrava favorevole in quanto tra i due mali: accordo con i
liberali e la nascita di un partito cattolico democratico, che avrebbe portato a
divisioni nella Chiesa, preferiva quello per lui minore. Non così la pensavano i
cattolici democratici, che parlarono di «prostituzione di un voto.» Giolitti e i
socialisti riformisti di Filippo Turati conseguirono una chiara vittoria
elettorale, ma l'ingresso dei cattolici aveva prodotto un'accentuazione in senso
conservatrice della politica italiana, quando lo stesso partito liberale avrebbe
dovuto invece uscire dal suo moderatismo che non soddisfaceva più le classi
contrapposte che si andavano viepiù estremizzando. Le difficoltà di governo con
i socialisti, dopo l'impresa coloniale in Libia, spinsero Giolitti a ricercare
un nuovo accordo con i cattolici con il Patto Gentiloni del 1912. Vincenzo
Ottorino Gentiloni (1865-1916) propose ai candidati del "Partito Liberale" se
avessero voluto il sostegno dei votanti cattolici di sottoscrivere i seguenti
sette punti programmatici:
difesa delle congregazioni religiose,
difesa della scuola privata,
difesa dell'istruzione religiosa nelle scuole
pubbliche,
difesa dell'unità della famiglia,
difesa del "diritto di parità alle organizzazioni
economiche e sociali, indipendentemente dai principi sociali e religiosi ai
quali esse s'ispirino",
salvaguardia di una migliore applicazione dei
principi di giustizia nei rapporti sociali,
conservazione e rinvigorimento “delle forze
economiche e morali del paese”, per un incremento dell'influenza italiana in
campo internazionale.
Alle Elezioni politiche italiane del 1913, le
prime in Italia a suffragio universale maschile, il Partito Liberale ottenne una
schiacciante vittoria con il 51 % dei voti e 260 eletti e di questi ben 228
avevano sottoscritto i sette punti programmatici desiderati dai cattolici. Dopo
il sanguinoso intervallo della guerra mondiale, dove il cattolicesimo schierato
con i neutralisti aveva apertamente espresso con papa Benedetto XV (1914-1922)
la sua condanna per l'"inutile strage", nella crisi degli anni 1919 – 1922
dapprima l'Unione nazionale di Carlo Ottavio Cornaggia Medici (1919), poi il
Centro Nazionale Italiano di Paolo Mattei-Gentili (1924) ed Egilberto Martire,
provocarono scissioni nel Partito Popolare Italiano fondato da Don Sturzo nel
1919. Il partito che nello stesso anno aveva ottenuto un buon successo alle
elezioni, nasceva minato al suo interno per la eterogeneità delle posizioni, e
all'esterno per la diffidenza di Pio XI (1922-1939) e della gerarchia. Era
quindi inevitabile quella scissione nel 1923 che portò una parte del partito
all'opposizione al fascismo mentre l'altra, i clericofascisti, s'illudevano,
collaborando con il regime, di condizionarlo. Inizialmente benvisti
da Mussolini, i clericofascisti vennero ben presto emarginati sia dal fascismo
che dalla stessa Chiesa, salvo la concessione di un qualche ruolo diplomatico
per la soluzione della questione romana con i Patti Lateranensi del 1929. Con
i Patti Lateranensi sembrò acquietarsi lo scontro tra Chiesa e Stato
rappresentato dal regime fascista che colse un vasto consenso popolare dalla
pacificazione con la chiesa cattolica. Ma la matrice anarchica e socialista di
Mussolini rendeva poco affidabile quella politica di «buon vicinato» che i
cattolici si auguravano. I primi dissensi emersero nel 1931 quando il fascismo
chiese la chiusura dell'Azione Cattolica, rilanciata invece da papa Pio XI come
forza organizzata di presenza nella società. L'alleanza di Mussolini con
la Germania nazista e pagana, l'emanazione delle leggi razziali del 1938 resero
sempre più difficili i rapporti con il regime fascista. Eletto nel 1939 a pochi
mesi dallo scoppio della seconda guerra mondiale, papa Pio XII (1939-1958) passò
da una dichiarata neutralità ad una adesione sempre più accentuata alle potenze
occidentali e ad una condanna sempre più esplicita dei fascismi e della Russia
sovietica, pur rinunciando a clamorosi atti di denuncia. Finita la guerra, per
il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, la Chiesa appoggiava apertamente
la causa monarchica trasformando l'alternativa tra monarchia e repubblica in
quella tra cristianesimo e comunismo. Il 1º giugno 1946, il giorno precedente il
referendum, lo stesso papa Pio XII, rivolse un appello agli Italiani: senza
accennare esplicitamente alla monarchia o repubblica invitò i votanti perché
scegliessero tra il materialismo e il cristianesimo, tra i sostenitori e i
nemici della civiltà cristiana. Considerato che nella campagna elettorale il
fronte repubblicano annoverava in prima linea i partiti marxisti materialisti,
sarebbe stato difficile fraintendere il senso di questo appello papale. Nel
secondo dopoguerra Pio XII promosse un piano di grande mobilitazione dei
cattolici riformando l'Azione Cattolica e sostenendo l'azione mediatica del
"Movimento per un mondo migliore " di padre Riccardo Lombardi e di Luigi Gedda,
cattolico intransigente, fondatore alla vigilia delle elezioni
del 1948 dei Comitati Civici a sostegno della Democrazia Cristiana contro il
Partito Comunista Italiano. Gli iscritti al PCI furono scomunicati da Pio XII
nel 1949. Suoi i ripetuti tentativi di dirigere la politica italiana come
attestano lettere del Pontefice, timoroso per l'elezione (1952) di un sindaco
comunista a Roma, dirette al Presidente del consiglio Alcide De Gasperi per
indurlo a formare un'alleanza politica in funzione anticomunista con il
Movimento Sociale Italiano. De Gasperi si batté invece, nei limiti delle sue
convinzioni cattoliche e delle opportunità politiche, per
l'aconfessionalità dello Stato contenendo le spinte clericali della destra
cattolica e dell'Azione Cattolica di Luigi Gedda. Il pontificato di Giovanni
XXIII (1958-1963) segnò una svolta nelle posizioni del Clero rispetto alla
politica in Italia, e lo stesso Concilio Vaticano II fu espressione di questo
nuovo spirito di "aggiornamento" che animava la Chiesa cattolica. In quegli anni
la formazione di un governo di centro-sinistra non venne infatti ostacolata
dalle gerarchie ecclesiastiche. Anche il pontificato di papa Paolo
VI (1963-1978) fu improntato ad uno spirito innovatore, sebbene per alcuni
aspetti venissero tenute in considerazione istanze conservatrici che già avevano
animato il dibattito nel Concilio. Paolo VI riformò la Curia romana
introducendovi prelati da tutto il mondo, volle la riforma liturgica, introdusse
la collegialità episcopale con il Sinodo dei vescovi; interrompendo una lunga
tradizione, compì alcuni viaggi all'estero, trasformò il Sant'Uffizio, abolì
l'Indice dei libri proibiti. Durante il suo pontificato, L'Azione Cattolica
guidata da Vittorio Bachelet compì la "scelta religiosa", che segnava la fine
del collateralismo dell'associazione alla politica della Democrazia Cristiana.
Contemporaneamente, però, l'Azione Cattolica smise di essere
l'unica associazione laicale in Italia: in un periodo di fioritura di diversi
movimenti ecclesiali, nel 1969 viene fondata da don Luigi Giussani Comunione e
Liberazione, caratterizzata da un forte senso di appartenenza reciproca e da una
religiosità neointransigente e di impegno sociale (Compagnia delle Opere) e di
influsso sulla vita politica. La contrapposizione tra lo stile associativo
dell'Azione Cattolica e quello di Comunione e Liberazione avrebbe segnato per i
decenni a venire l'associazionismo cattolico del Paese. Nel corso del
pontificato di Paolo VI fu introdotto in Italia l'istituto del divorzio (1970)
fortemente contrastato dai cattolici, che promossero il successivo referendum
abrogativo del 1974 ma ne risultarono sconfitti; nel 1978 fu anche approvata,
nonostante le ripetute condanne del Clero, l'interruzione volontaria di
gravidanza. Anche in questo caso, il successivo ricorso al referendum non sortì
gli effetti sperati dai promotori di parte cattolica. Nello stesso 1978,
l'elezione di Giovanni Paolo II, primo papa non italiano dopo molti secoli,
determina il progressivo attenuarsi dell'attenzione del pontefice alle vicende
politiche dell'Italia, sebbene dal 1985 la Conferenza Episcopale Italiana, sotto
la guida del card. Camillo Ruini rivolgesse attenzioni crescenti alla politica e
alla società italiane. La fine della Guerra Fredda in campo internazionale
(1989-1991) e gli avvenimenti di Tangentopoli (1992) mutarono in pochi anni il
panorama politico italiano. La stessa Democrazia Cristiana fu sciolta nel 1993:
venne così meno il punto di riferimento dei cattolici nella vita politica
italiana. Negli anni successivi, pertanto, il Clero avviò un atteggiamento di
dialogo con partiti politici sia conservatori sia progressisti, influenzando
significativamente entrambi gli schieramenti. Secondo gli osservatori più
critici, tale atteggiamento ha assunto talvolta modi vicini a quelli propri
dei gruppi di pressione. In ambiente cattolico il termine "clericale" designa la
posizione di coloro che tendono a ridurre al minimo la partecipazione attiva dei
laici all'esercizio spirituale del Clero. Ma al di là dei termini del dibattito
politico e religioso, per cui si preferisce parlare di "teodem" e "teocon"
contrapposti a "laicisti", sembra essere in atto uno scontro tra clericali e
anticlericali, considerati, come portatori di un'ideologia relativista,
materialista, con l'obiettivo di cancellare o ridurre il ruolo della religione
nella vita sociale. Dal punto di vista dei laici, tuttavia, questo scontro si
manifesta come un tentativo della Chiesa di imporre, attraverso una strategia di
comunicazione e di lobbying, i suoi valori anche a coloro che professano fedi
diverse o non credono affatto. Costoro comunque, nell'interpretazione della
Chiesa, condividono gli universali principii umani che vanno salvaguardati al di
là delle proprie convinzioni religiose o laiche. La contrapposizione non verte
più, come in un lontano passato, sulla partecipazione o meno dei cattolici alla
vita politica, ma su temi sociali di rilevanza etica, riguardo ai quali, secondo
gli esponenti del clericalismo, i cattolici devono battersi per difenderne gli
aspetti umani e cristiani. Una questione oggi dibattuta è sul significato da
attribuire al termine "ingerenza". La gerarchia cattolica rivendica alla Chiesa,
depositaria della tradizione apostolica, il diritto-dovere, secondo la sua
funzione, di guidare i fedeli, e di predicare i principi morali, che i cattolici
devono seguire. I sostenitori dell'ingerenza del Clero nella vita politica e
morale dei cittadini rifiutano l'accusa di clericalismo ed anzi accusano di
"laicismo" (ritengono infatti che si possa distinguere fino alla
contrapposizione tra laicità e laicismo) chi sostiene posizioni opposte.
Cosicché, quando, ad esempio, la gerarchia ecclesiastica si pronuncia
sulla fecondazione medicalmente assistita e sulla ricerca scientifica
sulle cellule staminali, afferma di farlo da posizioni "laiche" poiché difende
il valore della vita (che del resto non è negato neppure dai laici) ritenendolo
un valore non solo cristiano, ma umano. Per questo essa giudica legittimo
avvalersi di cattolici impegnati nella vita politica, che sostengano non solo le
posizioni della Chiesa cattolica, ma anche i principi laici della dignità umana.
D'altra parte i laici, non solo rivendicano il diritto di legiferare su questi
temi connessi a valori etici, ma obiettano di voler lasciare libera scelta ai
cittadini, in nome della loro libertà di coscienza, se aderire o meno alle
opportunità che offre la legge. Secondo questa posizione, il Clero non ha
l'obbligo di astenersi, secondo la sua missione, da tutti quei pronunciamenti
che abbiano significato religioso e morale ma da quelli che vogliano incidere
sulle decisioni politiche; il che appare al Clero stesso una negazione della
propria libertà di parola e di espressione. In questo senso gli esponenti più
propriamente laici sottolineano che lo Stato italiano è costituzionalmente uno
Stato non confessionale, come afferma chiaramente il combinato disposto degli
art.7 e 8 della Costituzione. Sui rapporti tra Stato e Clero può servire a
chiarire il problema quanto ha lasciato scritto nel febbraio 2001 Pietro
Scoppola, storico, docente e politico italiano, uno dei principali esponenti
italiani del cattolicesimo democratico. «La Chiesa sembra porsi di fronte allo
Stato e alle forze politiche italiane come un altro Stato e un'altra forza
politica; l'immagine stessa della Chiesa risulta appiattita sulle logiche
dello scambio, impoverita di ogni slancio profetico, lontana dal compito di
offrire a una società inquieta e per tanti aspetti lacerata, motivi di fiducia,
di speranza, di coesione. Le responsabilità del laicato cattolico sono del tutto
ignorate. La sorpresa e il disorientamento sono forti per tutti i cattolici che
hanno assorbito la lezione del Concilio Vaticano II su una Chiesa popolo di Dio
nella quale il ruolo della gerarchia non cancella ma anzi è al servizio di un
laicato che ha proprie e specifiche responsabilità. Tra queste vi è proprio
quella di tradurre nel concreto della vita politica e della legislazione di uno
Stato democratico esigenze e valori di cui la coscienza cattolica è portatrice.
È legittimo e doveroso per tutti i cittadini, e perciò anche per i cattolici,
contribuire a far sì che le leggi dello Stato siano ispirate ai propri
convincimenti ma questo diritto dovere non è la stessa cosa che esigere una
piena identità tra i propri valori e la legge. È in questa complessa dinamica
che si esprime la responsabilità dei cattolici nella vita politica. Urgente si è
fatta l'esigenza della formazione del laicato cattolico alle responsabilità
della democrazia. Perché mai l'Italia e i cattolici italiani debbono sempre
esser trattati come "il giardino della Chiesa"?» Compromesso storico è il nome
con cui si indica in Italia la tendenza al riavvicinamento tra Democrazia
Cristiana e Partito Comunista Italiano osservata negli anni settanta. Questo
possibile sviluppo politico fu chiamato anche con il nome di terza fase in
ambito democristiano, mentre i comunisti preferivano la definizione alternativa
democratica. Questa politica in ogni caso non portò mai il Partito Comunista a
partecipare al governo in una grande coalizione ai sensi del cosiddetto
consociativismo. La proposta dal neo-segretario del Partito Comunista
Italiano Enrico Berlinguer alla Democrazia Cristiana per una proficua
collaborazione di governo (aperta anche alle altre forze democratiche) doveva
interrompere così la cosiddetta conventio ad excludendum del secondo partito
italiano dal governo. In tal modo, si voleva anche mettere al riparo
la democrazia italiana da pericoli di involuzione autoritaria e dalla strategia
della tensione che insanguinava il paese dal 1969. Berlinguer si vedeva peraltro
sempre più deciso a sottolineare l'indipendenza dei comunisti italiani
dall'Unione Sovietica e di rendere quindi il suo partito una forza della società
occidentale. Il compromesso venne lanciato da Berlinguer con quattro articoli
su Rinascita a commento del golpe cileno che aveva portato le forze reazionarie
in collaborazione con gli USA a rovesciare il governo del socialista Salvador
Allende (11 settembre 1973). La politica del compromesso storico fu vista
negativamente dal Partito Socialista Italiano e da diversi suoi esponenti, in
particolare Bettino Craxi e Riccardo Lombardi, che vedevano in questo disegno un
chiaro tentativo di marginalizzare il PSI e di allontanare definitivamente
l'idea di un'alternativa di sinistra che portasse il PCI al governo, tuttavia
con la guida dei socialisti. La scelta di Berlinguer, fondamentalmente legata
alla politica di eurocomunismo, era un esempio di politica reale che non
riscontrò i favori dell'area di sinistra del suo partito. Il compromesso trovò
una sponda nell'area di sinistra della DC che aveva come riferimento il
presidente del partito Aldo Moro e il segretario Benigno Zaccagnini, ma non ebbe
mai l'avallo dall'ala destra della DC, rappresentata da Giulio Andreotti. Lo
stesso Andreotti in un'intervista dichiarò: "secondo me, il compromesso storico
è il frutto di una profonda confusione ideologica, culturale, programmatica,
storica. E, all'atto pratico, risulterebbe la somma di due guai: il clericalismo
e il collettivismo comunista.". Un compromesso minimo si raggiunse mediante
l'appoggio esterno assicurato dal PCI al governo monocolore di Solidarietà
Nazionale, costituito da Giulio Andreotti nel 1976. L'incontro comunque
problematico fra PCI e DC spingerà l'estrema sinistra a boicottare il PCI e
porterà i terroristi delle Brigate Rosse a rapire (e in seguito a uccidere) Aldo
Moro proprio nel giorno del primo dibattito sulla fiducia al nuovo governo
Andreotti IV (16 marzo 1978). Caduto quest'ultimo governo per il ritiro del PCI,
e senza il prezioso aiuto di Moro, la DC archiviò definitivamente la linea della
terza fase col XIV congresso del febbraio 1980, quando prevarrà con il 57,7%
l'alleanza tra dorotei, fanfaniani, Proposta e Forze nuove che approvò il
cosiddetto «preambolo» al documento finale che escludeva alleanze con il PCI.
L'opposizione, composta dall'area Zaccagnini e dagli andreottiani, ottenne il
42,3%. Berlinguer e il PCI tenteranno ancora di riproporre il compromesso
storico alla nuova DC di Flaminio Piccoli, ma vanamente. Del resto, la
resistenza interna al partito Comunista sarebbe rimasta notevole. Con quella
che Macaluso definisce la seconda svolta di Salerno, il 28 novembre 1980,
Berlinguer annunciò dopo otto anni di voler abbandonare la linea del compromesso
storico per abbracciare quella dell'«alternativa democratica». Ciò significa che
l'obiettivo diventava quello di ricercare governi di solidarietà nazionale che
escludessero la DC. Decisivo per il mutamento tattico fu il terremoto
in Irpinia della sera del 23 novembre precedente e la conseguente denuncia del
pessimo modo di operare dello Stato da parte del presidente della
Repubblica Sandro Pertini in diretta tv il 26 novembre. Oltre al fatto storico,
Moro era un teorico del valore del compromesso in politica, della ricerca
dell'accordo e della mediazione. Il compromesso in politica non viene inteso
come un atto moralmente negativo e riprovevole, al contrario è il compito
principale di chi viene eletto. La politica non deve essere personalizzata,
luogo di affermazione del singolo e del suo programma elettorale, sebbene questi
abbia avuto la maggioranza delle preferenze alle elezioni. Se in democrazia la
maggioranza vince, persegue un fine democratico il compromesso che mette
d'accordo la maggior parte dei partiti e dei singoli rappresentanti eletti dal
popolo, e ciò resta un dovere anche per chi beneficia di una vasta maggioranza
elettorale e parlamentare, laddove l'accordo sia compatibile e non tradisca le
attese e il programma dell'elettorato.
Anticlericalismo.
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. L'anticlericalismo (nella
sua accezione più comune) è una corrente di pensiero laicista, sviluppatasi
soprattutto in riferimento alla Chiesa cattolica, che si oppone al clericalismo,
ossia all'ingerenza degli ecclesiastici e della loro dottrina, nella vita e
negli affari dello Stato e della politica in generale. In quanto "tendenza", non
convogliata in un manifesto o in qualche movimento principale,
l'anticlericalismo ha subito una serie di evoluzioni storiche e si è sviluppato
in molteplici sfaccettature, tanto che è difficile darne una definizione
condivisa. Per alcuni esso è l'opposizione allo sconfinamento del clero in
qualsiasi ambito diverso dalla pura spiritualità (quindi economia, politica,
interessi materiali). Questa forma di pensiero si colloca ideologicamente sia
nell'ambito del liberalismo, sia delle sinistre radicali ma anche in
alcuni partiti socialisti democratici, ed in Italia, storicamente, nei partiti
che traggono origine dal pensiero mazziniano (in particolare, il Partito
d'Azione ed il Partito Repubblicano Italiano), nel Partito Socialista Italiano e
nel Partito Radicale. Dal punto di vista ideologico e filosofico, talvolta
l'anticlericalismo si sviluppa parallelamente a quello della non credenza.
L'anticlericalismo esplicito o velato da quella che Torquato Accetto chiamava la
«dissimulazione onesta» è tanto più diffuso quanto più il clero, in particolare
nei suoi vertici cardinalizi e vescovili, tende a sovrintendere alla vita e
all'organizzazione politico-civile dello Stato. In Europa, l'anticlericalismo si
è sviluppato lungo parte della storia cristiana ed ha avuto come precursori
figure di cristiani come Erasmo da Rotterdam, Immanuel Kant, Paolo
Sarpi, Gottfried Arnold e Thomas Woolston, che considerava quale vero unico
autentico miracolo di Gesù la cacciata dei mercanti dal Tempio.
L'anticlericalismo italiano (tra i primi esponenti sono oggi annoverati
personaggi come Marsilio da Padova, Niccolò Machiavelli, Francesco Guicciardini,
il Platina e Giordano Bruno), giungerà ad avere i suoi primi "martiri" nella
prima metà del settecento con Pietro Giannone, morto in carcere a Torino,
e Alberto Radicati di Passerano, morto esule all'Aia. Vanno poi ricordati
gli illuministi francesi - tra i quali Voltaire e Diderot - che si opposero a
ogni forma di clericalismo. Elementi anticlericali, secondo alcuni, sono
presenti nella prima fase della Riforma luterana che abolisce gli ordini
regolari, non riconosce né il sacramento dell'ordine, né l'obbligo del celibato
ecclesiastico, proclamando il sacerdozio universale di ogni cristiano che ha la
sua guida nella sola Sacra Scrittura. In particolare,
gli anabattisti riconoscevano Cristo come unico capo della Chiesa, e negavano il
valore della gerarchia e del magistero, affidandosi all'insieme dei credenti e
dalla loro quotidiana imitazione dell'esempio di Cristo.
La Controriforma inaugurata dal Concilio di Trento è stata anche una risposta a
tali istanze antigerarchiche presenti, sia pure con grandi diversità e con
differenti gradi di intensità, nel mondo protestante e, per Paesi come l'Italia,
la Spagna, il Portogallo, l'Austria, la Baviera, la Polonia, la Croazia,
l'America Latina un'istanza di rinnovata clericalizzazione non solo della vita
religiosa, ma anche nella vita socio-politica, in particolare attraverso il
controllo della formazione scolastica e del costume femminile. Nel Settecento si
diffonde l'anticurialismo, una tendenza giuridica che si ergeva a difesa
dello Stato assolutista contro i privilegi della Chiesa e particolarmente contro
le prerogative del Tribunale dell'Inquisizione, che sottraeva allo Stato parte
del suo ruolo nell'amministrazione della giustizia. L'origine
dell'anticurialismo risale alla seconda metà del Cinquecento, quando a Napoli il
viceré spagnolo Pedro Afán de Ribera, che pure represse duramente
i valdesi in Calabria, si oppose alla pubblicazione dei decreti del Concilio di
Trento e all'istituzione dell'Inquisizione spagnola nel Regno di Napoli. Nel
Settecento l'anticurialismo assume l'aspetto di una corrente filosofica e
giuridica con autori come il sacerdote salernitano Antonio Genovesi,
il cavese Costantino Grimaldi, autore delle Considerazioni intorno alle rendite
ecclesiastiche del Regno di Napoli (Napoli, 1708) e delle Discussioni istoriche
teologiche e filosofiche (Lucca, 1725) e il foggiano Pietro Giannone, che a
Ginevra, patria del calvinismo, già inviso alla Chiesa per la sua opera storica,
compose un altro lavoro dal forte sapore anticlericale Il Triregno. Del regno
terreno, Del regno celeste, Del regno papale, che sarà pubblicato postumo solo
nel 1895. Nel 1730 Alberto Radicati di Passerano, esule a Londra, pubblicò un
opuscolo anticlericale, sotto il titolo A Comical and True Account of the Modern
Cannibal's Religion, in cui rigetta il cattolicesimo e ne dipinge una mordace
caricatura, sulla scorta degli autori illuministi francesi. Nel 1732 pubblicò
la Dissertazione filosofica sulla morte, un'opera in cui rivendicava il diritto
al suicidio e all'eutanasia. In tutto il secolo si rafforza anche
l'antigesuitismo, un movimento di ostilità contro la Compagnia di Gesù, un
istituto religioso simbolo della fedeltà al papa, che si riteneva protagonista
di ingerenze clericali in politica e nella scienza. Mentre l'aspirazione
illuministica alla libertà diveniva il marchio del secolo, la presenza dei
gesuiti si faceva via via inaccettabile, tanto che furono espulsi da tutti gli
Stati cattolici, a cominciare dal Portogallo (1750). Il primo Stato italiano ad
espellere i Gesuiti fu il regno di Napoli (1767), seguito dal ducato di Parma e
Piacenza. Nel 1773 papa Clemente XIV con il breve Dominus ac Redemptor decise la
definitiva soppressione della Compagnia di Gesù. Nella seconda metà del XVIII
secolo l'infante Filippo I di Parma e il suo ministro Guillaume du
Tillot adottarono nel ducato di Parma e Piacenza una politica anticlericale, che
poneva pesanti limitazioni nella capacità della Chiesa di acquisire e possedere
beni immobili e di ereditare. Addirittura gli ecclesiastici furono esclusi della
successione ereditaria delle loro famiglie. Ai vescovi furono proibiti impiegati
che non fossero laici e fu loro sottratta la giurisdizione sugli ospedali e
sulle opere pie. Con Ferdinando di Borbone non cessarono le vessazioni del clero
e papa Clemente XIII fece affiggere un breve di protesta (Monitorium), che
suscitò tali reazioni che in breve tempo quasi tutti gli Stati d'Europa presero
posizione contro il Papa. A Napoli la tendenza anticuriale è rappresentata in
politica dal primo ministro Bernardo Tanucci. Con il concordato del 1741,
la Santa Sede aveva concesso larghi privilegi ai monarchi napoletani che erano
sempre stati vicini al papato, non prima di lunghe trattative condotte
dall'arcivescovo di Taranto Celestino Galiani, che agiva come ministro
plenipotenziario del Regno di Napoli ed era egli stesso un uomo di cultura,
fiancheggiatore delle tendenze anticuriali. Il Tanucci volle applicare il
Concordato in una chiave di imposizione di una politica ecclesiastica statale
(regalismo), che andava a infrangere la tradizionale armonia tra il potere
civile e quello religioso. Sulla scorta delle rivendicazioni gallicane già
applicate in Francia, le entrate di episcopati e abbazie vacanti affluirono alla
corona, conventi e monasteri superflui vennero soppressi, le decime abolite e
nuove acquisizioni di proprietà da parte delle istituzioni ecclesiastiche
tramite la manomorta vietate. La pubblicazione delle bolle papali necessitava
della previa autorizzazione reale (il cosiddetto exequatur). Anche le nomine
vescovili nel Regno caddero, seppure non direttamente ma solo tramite
raccomandazioni, grazie anche all'abilità politica del Tanucci, nelle mani del
sovrano. Il Re era soggetto soltanto a Dio, gli appelli a Roma erano proibiti a
meno che non vi fosse stato l'assenso del re, il matrimonio venne dichiarato un
contratto civile. Papa Clemente XIII reagì con la scomunica, al che Tanucci
rispose occupando le enclave pontificie nel territorio napoletano
di Benevento e Pontecorvo, che saranno restituite alla Santa Sede solo dopo la
soppressione della Compagnia di Gesù. Le proteste dei vescovi contro i nuovi
insegnamenti nelle scuole a seguito dell'espulsione dei Gesuiti vennero
liquidate come non valide. Uno degli ultimi atti di Tanucci fu l'abolizione
della chinea (1776), il tributo annuale che i re di Napoli versavano al papa
come segno del loro vassallaggio sin dal tempo di Carlo I d'Angiò. Tuttavia, le
proteste popolari costrinsero a ritirare il provvedimento di Tanucci e la chinea
fu regolarmente corrisposta fino al 1787. Durante il periodo napoleonico, molti
dei regni italiani furono trasformati in stati satelliti della Francia e i loro
sovrani vennero deposti; lo stesso papa Pio VII fu deportato in Francia.
Proclamando a gran voce i principî della Rivoluzione francese, si abolirono i
privilegi tanto del clero che della nobiltà. In realtà la rivoluzione fu, a
livello locale, spesso condotta da ecclesiastici e nobili subalterni, che talora
colsero l'occasione di tentare in tal modo di ottenere una promozione sociale
loro preclusa secondo il precedente ordine tradizionale socio-politico. Le
autorità napoleoniche appoggiarono all'interno della Chiesa cattolica le
posizioni dei gallicani e dei giansenisti contro quelle degli ultramontani.
Furono aboliti ed espropriati gli ordini contemplativi, mentre i beni della
Chiesa furono a vario titolo espropriati per finanziare lo Stato. Per la prima
volta si mise in discussione l'egemonia sociale del clero a favore delle
autorità civili. L'anticlericalismo italiano ebbe notevole sviluppo nella lotta
al potere temporale del papa, che costituiva oggettivo impedimento
all'unificazione sotto la monarchia sabauda ed alla modernizzazione del
Paese. Papa Pio VII, rientrato in Italia, tornò a segregare gli ebrei nel ghetto
di Roma, dove resteranno fino alla liberazione nel 1870. Papa Gregorio
XVI (1831-1846) bollava il treno come "opera di Satana", mentre il suo
segretario di Stato, il cardinal Luigi Lambruschini (1776-1854), osteggiava
l'illuminazione a gas e instaurava nello Stato pontificio un regime di arbitrio
poliziesco, censura e inquisizione. In questo clima, anche tra gli stessi
cattolici liberali italiani presero corpo posizioni di stampo anticlericale; ad
esempio, una violenta polemica oppose il padre del cattolicesimo liberale
italiano, Vincenzo Gioberti (1801-1852), ai gesuiti e ai cattolici reazionari.
Giuseppe Garibaldi, l'eroe nazionale italiano, fu il più celebre degli
anticlericali del Risorgimento e definì la Chiesa cattolica una «setta
contagiosa e perversa», mentre rivolse a papa Pio IX l'epiteto di "metro cubo di
letame". La formazione dello Stato nazionale del 1861 fu preceduta e
accompagnata dal tentativo di una riforma religiosa di ispirazione cristiana
protestante, sul modello della Chiesa nazionale d'Inghilterra, appoggiata dalle
chiese valdesi, memori delle persecuzioni, che, nei propositi di alcuni
esponenti delle classi dirigenti piemontesi, si proponeva l'ambizioso obiettivo
di sradicare dal cuore del popolo la fede cattolica: la cosiddetta Chiesa Libera
Evangelica Italiana. San Leonardo Murialdo scrisse: «Gesù Cristo è bandito dalle
leggi, dai monumenti, dalle case, dalle scuole, dalle officine; perseguitato nei
discorsi, nei libri, nei giornali, nel papa, nei suoi sacerdoti». Alla Camera,
il deputato Filippo Abignente si augurava «che la religione cattolica sia
distrutta d'un colpo». Un altro deputato, Ferdinando Petruccelli della Gattina,
giornalista e patriota durante le insurrezioni del 1848 nel Regno delle Due
Sicilie si riprometteva di eliminare con il potere temporale anche il potere
spirituale della Chiesa. Il 20 luglio 1862, espresse senza giri di parole la sua
avversione contro il Cattolicesimo: «Noi dobbiamo combattere la preponderanza
cattolica nel mondo, comunque, con tutti i modi. Noi vediamo, che questo
Cattolicismo è uno strumento di dissidio, di sventura, e dobbiamo
distruggerlo.... La base granitica della fortuna politica d'Italia deve essere
la guerra contro il Cattolicismo su tutta la superficie del mondo». Dopo
la presa di Roma, Petruccelli della Gattina promosse l'abolizione della Legge
delle Guarentigie e, durante una seduta alla Camera, gridò: «Il principio
generale della rivoluzione Italiana è stato l'abolizione del Papato!». Egli
voleva fare del sacerdote «un uomo e un cittadino», dargli «la libertà
individuale nei limiti dello Stato» e il «diritto d'invocare la protezione della
legge comune», il che significava l'abolizione del foro ecclesiastico. Il
giornalista fu anche autore di una controversa opera, Memorie di Giuda, in cui
l'apostolo viene raffigurato come un rivoluzionario che combatte l'oppressione
romana. Il romanzo suscitò un enorme scandalo e trovò problemi di distribuzione,
e La Civiltà Cattolica, il maggiore organo di stampa pontificio, lo etichettò
«libraccio infame» e l'autore «sporco romanziere». Secondo il laico Giovanni
Spadolini, Cavour volle «fissare e delimitare le competenze specifiche della
Chiesa nel suo magistero ecclesiastico, escludendola dalla società civile, dal
mondo della politica, dall'istruzione, dalla scienza, dove il dominio
incondizionato sarebbe stato quello dello Stato e dello Stato soltanto». Tale
tentativo prese avvio nel Regno di Sardegna, con la legge del 25 agosto 1848 n.
777 che espelleva tutti i gesuiti stranieri, ne sopprimeva l'ordine e ne
incamerava tutti i collegi, convertendoli ad uso militare. Negli anni seguenti i
gesuiti furono nell'occhio del ciclone in tutta Italia e dopo il 1848 (durante
il quale alcune residenze gesuite furono assaltate da folle inferocite), saranno
soppressi in tutti gli Stati italiani (escluso lo Stato pontificio). La legge
del 1848 e le analoghe successive saranno caratterizzate da ostilità verso la
Chiesa cattolica che, nella visione dei politici di ispirazione liberale
(sovente aderenti alla Massoneria), costituiva un freno al progresso civile,
ritenendo che la religione non fosse altro che superstizione, mentre la verità
andava ricercata avvalendosi del metodo scientifico. Si trattava di un aperto
contrasto con la realtà italiana - e soprattutto piemontese - del primo
Ottocento, in cui per assenza d'intervento dello Stato era la Chiesa ad
organizzare e finanziare scuole, istituzioni sociali e ospedali. Non di rado
docenti e scienziati erano essi stessi ecclesiastici. Secondo la studiosa
cattolica Angela Pellicciari «la nuova identità che i grandi del mondo
progettano per la nazione culla dell'universalismo romano e poi cristiano è
anticattolica, mentre la storia, la cultura e la popolazione sono tutte
cattoliche.» A partire dal 1850, furono promulgate le leggi Siccardi (n. 1013
del 9 aprile 1850, n. 1037 del 5 giugno 1850, e n. 878 del 29 maggio 1855), che
abolirono tre grandi privilegi di stampo feudale di cui il clero godeva nel
Regno di Sardegna: il foro ecclesiastico, un tribunale che sottraeva alla
giustizia dello Stato gli uomini di Chiesa oltre che per le cause civili anche
per i reati comuni (compresi quelli di sangue), il diritto di asilo, ovvero
l'impunità giuridica di chi si fosse macchiato di qualsiasi delitto e fosse poi
andato a chiedere rifugio nelle chiese, nei conventi e nei monasteri, e
la manomorta, ovvero la non assoggettabilità a tassazione delle proprietà
immobiliari degli enti ecclesiastici (stante la loro inalienabilità, e quindi
l'esenzione da qualsiasi imposta sui trasferimenti di proprietà). Inoltre, tali
provvedimenti normativi disposero il divieto per gli enti morali (e quindi anche
per la Chiesa e gli enti ecclesiastici) di acquisire la proprietà di beni
immobili senza l'autorizzazione governativa. L'arcivescovo di Torino Luigi
Fransoni venne processato e condannato ad un mese di carcere dopo aver invitato
il clero a disobbedire a tali provvedimenti. Fu del 29 maggio 1855 la legge che
abolì tutti gli ordini religiosi (tra i quali agostiniani, carmelitani,
certosini, cistercensi, cappuccini, domenicani, benedettini) privi di utilità
sociale, ovvero che «non attendessero alla predicazione, all'educazione, o
all'assistenza degli infermi», e ne espropriò tutti i conventi (334 case),
sfrattando 3733 uomini e 1756 donne. I beni di questi ordini soppressi furono
conferiti alla Cassa ecclesiastica, una persona giuridica distinta ed autonoma
dallo Stato. L'iter di approvazione della legge, proposta dal primo ministro
Cavour, fu contrastato da re Vittorio Emanuele II e da un'opposizione
parlamentare agitata dal senatore Luigi Nazari di Calabiana, vescovo di Casale
Monferrato, che determinarono le temporanee dimissioni dello stesso Cavour. Con
l'avvento del Regno d'Italia avvenuto nel 1861, il Governo adottò nei confronti
della Chiesa (che contrastava l'affermarsi di "compiti di benessere" dello Stato
a favore dei cittadini) una politica limitativa, in particolare rispetto agli
enti ecclesiastici tramite le cosiddette Leggi eversive:
La Legge n. 3036 del 7 luglio 1866 con cui fu
negato il riconoscimento (e di conseguenza la capacità patrimoniale) a tutti gli
ordini, le corporazioni, e le congregazioni religiose regolari, ai conservatori
ed i ritiri che comportassero vita in comune ed avessero carattere
ecclesiastico. I beni di proprietà di tali enti soppressi furono incamerati
dal demanio statale, e contemporaneamente venne sancito l'obbligo di iscrizione
nel libro del debito pubblico di una rendita del 5% a favore del fondo per il
culto (in sostituzione della precedente cassa ecclesiastica del Regno di
Sardegna). Venne inoltre sancita l'incapacità per ogni ente morale ecclesiastico
di possedere immobili, fatte salve le parrocchie.
La Legge n. 3848 del 15 agosto 1867 previde la
soppressione di tutti gli enti secolari ritenuti superflui dallo Stato per la
vita religiosa del Paese. Da tale provvedimento restarono esclusi seminari,
cattedrali, parrocchie, canonicati, fabbricerie e gli ordinariati. Nel tentativo
di colmare i gravi disavanzi causati dalla terza guerra d'indipendenza,
nel 1866 il primo ministro Giovanni Lanza estese l'esproprio dei beni
ecclesiastici a tutto il territorio nazionale e, con la legge del 19
giugno 1873 anche a Roma, la nuova capitale. Negli anni Settanta del XIX secolo
il ministro dell'istruzione Cesare Correnti abolì le facoltà teologiche,
sottrasse gli educandati femminili siciliani al controllo dei vescovi e infine
tentò la soppressione dei direttori spirituali nei ginnasi, ma in seguito alle
proteste della Destra dovette rassegnare le dimissioni il 17 maggio 1872. Il
tentativo mazziniano di instaurare la Repubblica Romana (febbraio-luglio 1849)
fu accompagnato da assassinii di sacerdoti, saccheggi di chiese e requisizioni
forzose. Nei pochi mesi di vita della Repubblica, Roma passò dalla condizione di
stato tra i più arretrati d'Europa a banco di prova delle nuove idee liberali
che allora si diffondevano nel continente, fondando la sua vita politica e
civile su principi - quali, in primis, il suffragio universale maschile, la
libertà di culto e l'abolizione della pena di morte (facendo seguito, in questo
caso, all'esempio del Granducato di Toscana che aveva definitivamente abolito la
pena capitale nel 1786) e - che sarebbero diventate realtà in Europa solo circa
un secolo dopo. Nella difesa di Roma dall'esercito francese, che accorse a
sostenere lo Stato pontificio insieme alle armate austriache, borboniche e
spagnole, persero la vita numerosi padri della patria tra cui Goffredo Mameli.
Tra i politici di maggior spicco in questa fase storica emerge la figura di
Camillo Benso Conte di Cavour, che nel 1861, poco dopo la proclamazione
dell'Unita d'Italia, formulò, inascoltato, il principio della «Libera Chiesa in
libero Stato», tentando con questa principio di regolare la convivenza tra
Chiesa e Stato. Nel 1869 quando venne convocato il Concilio Vaticano I,
a Napoli si riunì un anticoncilio di liberi pensatori, soprattutto massoni,
organizzato dal deputato Giuseppe Ricciardi. Il Concilio Vaticano I fu poi
interrotto dalla presa di Roma e non più convocato. Negli anni seguenti Roma
divenne teatro di numerosi episodi di anticlericalismo, soprattutto in occasione
di manifestazioni pubbliche: «fra il 1870 e il 1881 si possono contare oltre
trenta casi gravi di intolleranza, di provocazione, talora scontri fisici». Per
lungo tempo il Papa, rifugiatosi in Vaticano, impose ai cattolici di non
partecipare alla vita pubblica del Regno d'Italia con un pronunciamento
conosciuto come non expedit. Nel 1850 dopo l'approvazione delle leggi
Siccardi nel Regno di Sardegna l'arcivescovo di Torino Luigi Fransoni fu
arrestato per un mese e poi mandato, nelle stesso anno, in esilio a Lione per la
sua ferma opposizione alle leggi anticlericali. Dopo l'Unità, circa la metà
delle diocesi italiane resterà vacante, per il rifiuto del Governo di concedere
il necessario 'placet' o 'exequatur' ai vescovi. Nel 1864 ben 43 vescovi erano
in esilio, 20 in carcere, 16 erano stati espulsi e altri 16 morti per le
vessazioni subite. A metà degli anni sessanta di 227 sedi vescovili, 108 erano
vacanti. I motivi di questi arresti erano spesso arbitrari: il
cardinale Corsi, arcivescovo di Pisa, fu arrestato il 13 maggio 1860 per non
aver voluto cantare il "Te Deum" per Vittorio Emanuele II. Nel luglio dello
stesso anno il vescovo di Piacenza Antonio Ranza e dieci canonici furono
condannati dal tribunale a quattordici mesi di reclusione per antipatriottismo.
Si trattò di una condanna politica, perché il vescovo si era allontanato dalla
città in occasione della visita del re e non aveva celebrato la festa
dello Statuto. Nelle province meridionali, dopo la spedizione di Garibaldi con
vari pretesti furono arrestati e processati 66 vescovi. Durante i quattro anni
successivi subirono la stessa sorte anche nove cardinali. Il problema delle sedi
vacanti si avviò verso la soluzione nell'ottobre del 1871, quando furono
nominati 41 nuovi vescovi. Altri 61 saranno nominati negli anni successivi.
Tuttavia, nel 1875 Minghetti annunciava ancora alla Camera che delle 94 domande
di exequatur presentate per la nomina di nuovi vescovi, soltanto 28 erano state
accettate dal Governo. Dopo l'Unità d'Italia si verificarono episodi di
intolleranza anticlericale come l'assalto al Congresso cattolico di Bologna del
9 ottobre 1876 e i tumulti in occasione della traslazione della salma di Pio IX
il 13 luglio 1881. Nel 1889, l'erezione del monumento a Giordano Bruno in Campo
de' Fiori avvenne in un contesto di violenta lotta politica in cui si
confrontarono le posizioni più oltranziste delle fazioni anticlericali e
clericali. L'opera fu realizzata dallo scultore Ettore Ferrari, che più tardi
divenne gran maestro del Grande Oriente d'Italia. Fra i promotori non mancarono
toni di sfida al Pontefice, che minacciava di lasciare Roma per rifugiarsi in
Austria, e il monumento divenne uno dei simboli dell'anticlericalismo. Francesco
Crispi ottenne dal re Umberto I un decreto di destituzione nei confronti del
sindaco di Roma Leopoldo Torlonia, che aveva fatto una visita ufficiale al
cardinale vicario Lucido Maria Parocchi, portando un messaggio per papa Leone
XIII. Nello stesso periodo a Roma la Massoneria metteva in scena sotto i Palazzi
apostolici banchetti nei venerdì di Quaresima, per dileggiare
il digiuno cristiano. Gli episodi di violenza continueranno anche nella prima
parte del XX secolo: fra questi l'assalto alla processione del Corpus Domini a
Fabriano, avvenuto il 21 giugno 1911, condotto da socialisti e anticlericali,
terminò in un clamoroso processo. Il principale esponente dell'anticlericalismo
in ambito accademico e culturale fu il poeta e poi docente di letteratura
italiana Giosuè Carducci. Pubblicò nel 1860 nella raccolta Juvenilia la
poesia Voce dei preti: «Ahi giorno sovra gli altri infame e tristo, Quando
vessil di servitù la Croce. E campion di tiranni apparve Cristo!» (Giosuè
Carducci, Voce dei preti), e nel 1863 l'Inno a Satana, che poi ristamperà
nel 1868 in occasione del Concilio Vaticano I. L'anticlericalismo accademico
derivò in larga parte dall'adesione di molti docenti al positivismo e
allo scientismo. All'università di Torino il positivismo fece la sua comparsa
negli anni sessanta del XIX secolo presso la facoltà di medicina, dove insegnava
l'olandese Jacob Moleschott. Cesare Lombroso, fondatore dell'antropologia
criminale, Salvatore Cognetti de Martiis, professore di economia
politica garibaldino, e Arturo Graf, docente di letteratura italiana, furono
celebri esponenti di teorie anticlericali. Il darwinismo ebbe come centri di
diffusione Torino, Pavia e Firenze. Anche l'associazionismo studentesco risentì
della polemica anticlericale e costituì un anello di quella che poteva apparire
una «koinè positivista e anticlericale largamente condivisa nel mondo
accademico». Nel 1871 i professori dell'Università di Roma furono chiamati a
pronunziare il giuramento di fedeltà al re e allo Statuto. I professori della
facoltà di teologia furono esentati dal giuramento, ma in maggioranza si
rifiutarono di riprendere l'insegnamento in un ambiente ora ostile. Papa Pio
IX li ricevette in udienza dicendo loro: «L'Università, quale ora è divenuta,
non è più degna delle vostre dottrine e di voi, e voi stessi vi contaminereste
varcando quelle soglie, entro le quali si insegnano errori così perniciosi».
Appelli analoghi furono rivolti agli studenti e fu dato vita ad un tentativo di
un'università alternativa. Quando però il tentativo fallì, agli studenti fu
concesso di frequentare le università statali, ammonendoli però ad evitare
l'influsso dei cattivi maestri. All'Università di Catania fu professore di
letteratura italiana Mario Rapisardi, spirito anticlericale e garibaldino, che
considerava le religioni come intralcio al progresso scientifico e morale. Il
ritiro dei docenti della facoltà di teologia diede occasione allo Stato di
sopprimere le facoltà di teologia con la legge Scialoja-Correnti del 26
gennaio 1873, determinando la scomparsa degli studi ecclesiastici dalle
università di Stato. Al di fuori dell'ambito strettamente accademico, ebbe
straordinario successo la letteratura di Edmondo De Amicis, che proponeva con il
libro Cuore un codice di morale laica e quella di poeti come Antonio
Ghislanzoni, librettista di Giuseppe Verdi, Felice Cavallotti, che fu anche un
celebre politico e deputato, e Olindo Guerrini, che nel 1899 fu condannato e poi
assolto in appello per diffamazione del vescovo di Faenza. Cavalli di battaglia
dell'anticlericalismo divennero in questo periodo una ricostruzione storica in
stile illuminista, a volte arbitraria, del Medioevo (i secoli bui), la leggenda
della Papessa Giovanna, la classificazione della storia delle Crociate come
guerra di religione, e della lotta alle eresie in generale e
dell'Inquisizione in particolare come fenomeni dell'intolleranza cristiana
(vedi Leggenda nera dell'Inquisizione). L'anticlericalismo non restò confinato
alle classi dirigenti, ma trovò eco anche nelle società operaie e di mutuo
soccorso di fine ottocento, prevalentemente di ispirazione socialista. Secondo
questa ideologia, Gesù Cristo era stato il "primo socialista", ma il suo
insegnamento era stato corrotto dalla Chiesa ("dai preti") per tornaconto. Un
esempio emblematico di questa ideologia fu La predica di Natale del 24
dicembre 1897 di Camillo Prampolini. Diffuse erano anche le rappresentazioni
teatrali di spettacoli anticlericali: ad esempio nel 1851 a Vercelli erano in
scena due commedie, intitolate "Gli orrori dell'Inquisizione" e "Il diavolo e i
Gesuiti". A Roma il primo carnevale dopo Porta Pia fu organizzato
dall'associazione anticlericale "Il Pasquino", che propose numerose parodie. Un
enorme dito di cartapesta fu fatto sfilare per le vie di Roma: era il "dito di
Dio", una formula tipica con cui la stampa cattolica commentava sventure e
disgrazie. L'anticlericalismo trovò eco anche in polemiche giornalistiche, che
spesso vedevano confrontarsi giornali di tendenze opposte. A Torino la Gazzetta
del Popolo diretta dall'anticlericale Felice Govean, che fu anche gran
maestro del Grande Oriente d'Italia, battagliava contro l'Armonia cattolica,
diretta da Giacomo Margotti. Le vendite vedevano primeggiare il foglio
anticlericale, che distribuiva 10 000 copie contro le 2 000 del concorrente.
Il Partito Nazionale Fascista, guidato da Benito Mussolini, fortemente
anticlericale e ateo in gioventù, presentava inizialmente, influenzato anche
dal futurismo, un programma di "svaticanizzazione" dell'Italia, con progetti di
sequestri di beni ed abolizione di privilegi. Ma Mussolini, dopo essere
diventato duce dell'Italia fascista, resosi conto del gran peso sociale e
culturale che la Chiesa cattolica rivestiva nel Paese, cambiò i suoi propositi
iniziali e volle concordare un'intesa con la Chiesa al fine di consolidare e
accrescere il proprio potere, ancora instabile, ed ottenere un più ampio
consenso di popolo. Tuttavia il capo del fascismo intimamente rimaneva un ateo
anticlericale, come testimoniano la sua nota avversione a farsi fotografare
accanto a religiosi e la conseguente censura di tutti i ritratti in cui era
presente qualche prelato o simile e la confidenza che Dino Grandi fece a Indro
Montanelli nella quale raccontava come Mussolini, appena uscito dal palazzo
Laterano in cui l'11 febbraio 1929 aveva appena firmato il concordato, bestemmiò
pesantemente per sottolineare la sua personale avversione alla Chiesa cattolica
e ai preti. L'accordo con la Segreteria di Stato vaticana per la stipula
dei Patti Lateranensi, formalmente siglati nel1929 avvenne grazie ad un
atteggiamento, nonostante le differenti visuali, diplomaticamente dialogante tra
le parti. In cambio il dittatore impose una compressione dello spazio di
intervento dell'Azione Cattolica, unica organizzazione giovanile non fascista
che sopravvisse durante il regime. Con quest'accordo ci furono alcuni membri del
clero, a vari livelli, che diedero la loro adesione, come cittadini italiani, al
fascismo. Nello stesso Partito Popolare Italiano, una parte dei membri aderì al
governo fascista ante-dittatura, contro il parere di don Luigi Sturzo. Il
partito subì una forte crisi che fu determinante per l'ascesa del PNF. Ci furono
così aspetti, come nel regime franchista spagnolo, di
cosiddetto clericofascismo. Alla caduta del fascismo, mentre i gerarchi e i
rappresentanti della monarchia fuggivano, le autorità ecclesiastiche rimasero al
loro posto, svolgendo, a volte in collaborazione con il CLN, opere caritatevoli
e assistenziali a vantaggio della popolazione, esercitando nel contempo un ruolo
civile e sociale. Questo interesse degli ecclesiastici per le questioni
politiche ed economiche si scontrava sia con la cultura liberale, che riduceva
il problema religioso alla sfera individuale, sia con la cultura marxista, che
annoverava le religioni fra le forze reazionarie. Se la Chiesa pretendeva di
offrire alla società i valori fondamentali su cui costruire la democrazia,
marxisti e liberali consideravano un'indebita ingerenza ogni intervento della
Chiesa nell'ambito sociale e politico. Dopo la fine della seconda guerra
mondiale, l'anticlericalismo ebbe le sue espressioni, seppur in forma
minoritaria ed incostante, nel Partito Comunista Italiano, nel Partito
Repubblicano Italiano e nel Partito Socialista per divenire centrale
nell'attività del Partito Radicale a partire dagli anni settanta, in
contrapposizione alla Democrazia Cristiana e all'influenza vaticana nella
politica italiana. Uno dei punti principali di contrasto fu la scure censoria
che si abbatté sulle migliori opere cinematografiche italiane del dopoguerra,
accusati di offesa alla morale o vilipendio della religione cattolica, partendo
da La dolce vita di Federico Fellini, a La ricotta di Pier Paolo Pasolini, fino
a Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Gli anticlericali sostennero che
questi furono solo alcuni esempi tra i tanti di come la morale cattolica
influenzasse ed imponesse il proprio punto di vista anche in materia di arte e
spettacolo. Si impegnò in una lunga filmografia anticlericale il regista Luigi
Magni, che diresse Nell'anno del Signore (1969), In nome del Papa Re (1977) e In
nome del popolo sovrano (1990), una trilogia ambientata nella Roma papalina del
Risorgimento. Il fronte laico riuscì ad ottenere l'istituzione
del divorzio (1970, confermato dopo il referendum abrogativo del 1974) e la
legalizzazione dell'aborto (1978). Nel 1984 il presidente del
Consiglio socialista Bettino Craxi attuò una revisione dei Patti Lateranensi,
rimuovendo la prerogativa di «Religione di Stato» in precedenza accordata alla
Chiesa cattolica. Venne mantenuto, seppur rendendolo facoltativo, l'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche, affidato a insegnanti pagati
dallo Stato ma nominati dalla Curia, e l'esenzione dal pagamento delle imposte
sugli immobili di proprietà della Chiesa cattolica in cui vengono svolte
attività "che non abbiano natura esclusivamente commerciale". Contestualmente
venne introdotta la destinazione dell'otto per mille del gettito IRPEF dei
contribuenti a 7 confessioni religiose, tra cui la Chiesa cattolica. L'otto per
mille viene destinato alle varie confessioni in proporzione delle scelte
espresse dai soli contribuenti che forniscono un'indicazione al riguardo. La
quota del reddito dei contribuenti che non ha espresso alcuna scelta viene, in
altre parole, ripartita tra le confessioni religiose che hanno siglato l'intesa
con lo stato italiano in misura pari alla percentuale delle scelte espresse. Per
esempio, nel 2000 il 35% degli italiani si espresse a favore della Chiesa
cattolica, il 5% circa a favore dello Stato o di altre religioni, e il 60% non
espresse alcuna scelta. Di conseguenza, l'87% del gettito è stato devoluto
alla Conferenza Episcopale Italiana. Dal 1984 gli anticlericali italiani,
inizialmente dell'area anarchica e libertaria, in seguito anche i socialisti,
i radicali, i liberali e i comunisti si diedero appuntamento per discutere dei
maggiori temi politici di confronto e scontro con il Vaticano, ai Meeting
anticlericali di Fano presso i quali, nel 1986, venne fondata anche
l'Associazione per lo Sbattezzo. Oggi è contestato, da taluni, in una società
sempre più secolarizzata, l'intervento della Chiesa cattolica, mediante
indicazioni di comportamento ai fedeli e indicazioni di voto ai parlamentari
cattolici, sull'azione legislativa e regolamentare dello Stato. Si ricorda la
presa di posizione del cardinale Camillo Ruini nel referendum sulla procreazione
assistita del 2005, rivolte in particolare contro l'utilizzo delle cellule
staminali embrionali, e quelle di vari esponenti e prelati cattolici contro
le unioni civili, l'eutanasia e il testamento biologico, oltre che la
controversia sull'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane.
Dalla parte della Chiesa invece si rivendica un diritto alla parola e un dovere
morale nella guida del cristiano su questioni etiche.
Anticlericalismo in Francia. «La civiltà non
raggiungerà la perfezione finché l'ultima pietra dell'ultima chiesa non sarà
caduta sull'ultimo prete.» (Émile Zola). Voltaire, illuminista e anticlericale,
autore del motto Écrasez l'Infâme ("schiacciate l'infame"), con cui incitò alla
lotta contro la Chiesa e il fanatismo religioso. A partire dall'Illuminismo, si
sviluppò in Francia una forte corrente anticlericale, che ebbe la sua piena
espressione in alcune leggi varate durante la Rivoluzione Francese, come
la costituzione civile del clero, l'obbligo di sposarsi o abbandonare i voti per
i preti, la trasformazione delle chiese in templi della Ragione, il calendario
rivoluzionario francese e il culto dell'Essere Supremo, l'introduzione del
matrimonio civile e del divorzio. Anche Napoleone varò una politica di
separazione tra Stato e Chiesa.
In un contesto politico anticlericale, il 7
dicembre 1830 i redattori de L'Avenir, giornale cattolico liberale, riassumono
le loro rivendicazioni: chiedono libertà di coscienza, separazione tra Stato e
Chiesa, libertà d'insegnamento, di stampa, d'associazione, decentramento
amministrativo ed estensione del diritto elettorale. L'anticlericalismo è un
tema di particolare rilevanza nel contesto storico della Terza Repubblica e
nelle divergenze che ne derivarono con la Chiesa cattolica. Gli eccidi della
"settimana di sangue" seguiti all'instaurazione della Comune parigina(1871) con
l'uccisione dell'arcivescovo di Parigi Georges Darboy, possono essere
considerati come gli effetti del duro scontro in Francia tra clericali e
anticlericali socialisti. Tuttavia, prima del 1905, la Chiesa godeva di un
trattamento preferenziale da parte dello stato francese (insieme alle
minoranze ebraiche, luterane e calviniste). Nel corso dell'Ottocento, sacerdoti
insegnavano nelle scuole pubbliche tutte le materie, religione compresa. E
inoltre la Chiesa fu implicata in attacchi antisemiti come nell'Affare Dreyfus.
Di conseguenza molti appartenenti alla sinistra chiesero la separazione tra
Chiesa e Stato e l'imposizione di una reale laicità. Si noti che la divisione
tra "clericali" e "anticlericali" non aderisce esattamente alle categorie di
"credenti" e "non credenti" poiché alcuni cattolici, come Victor Hugo, pensavano
che la Chiesa non dovesse intervenire nella vita politica, mentre non credenti
come Charles Maurras favorivano il potere temporale della Chiesa perché
ritenevano fosse essenziale per la coesione del Paese e per i loro obiettivi
politici (vedi anche reazionario). Dal punto di vista culturale non mancavano
rappresentazioni anticlericali nei teatri, come la commedia Pourquoi elles vont
à l'église di Nelly Roussel. In definitiva, la separazione del 1905 tra Stato e
Chiesa innescò aspre polemiche e forti controversie, la maggioranza delle scuole
cattoliche e delle fondazioni educative venne chiusa e molti ordini religiosi
furono sciolti. Papa Pio X reagì con tre diverse encicliche di condanna:
la Vehementer Nos dell'11 febbraio 1906, la Gravissimo Officii Munere del 10
agosto dello stesso anno e l'Une Fois Encore del 6 gennaio 1907.
Anticlericalismo in Messico.
In seguito alla rivoluzione del 1860, il presidente Benito Juárez, appoggiato
dal governo statunitense, varò un decreto per la nazionalizzazione delle
proprietà ecclesiastiche, separando Chiesa e Stato e sopprimendo gli ordini
religiosi. All'inizio degli anni dieci del XX secolo, i Costituzionalisti
di Venustiano Carranza denunciarono l'ingerenza clericale nella politica
messicana. Protestavano di non perseguitare il Cattolicesimo, ma di voler
ridurre l'influenza politica della Chiesa. Tuttavia, la campagna dei
Costituzionalisti non sfociò immediatamente in un nessun'azione formale. Il
movimento dei Costituzionalisti rappresentava gli interessi degli Stati Uniti
d'America e delle sue lobby massoniche. Successivamente Álvaro Obregón e i
Costituzionalisti intrapresero delle misure volte a ridurre la profonda
influenza politica della Chiesa cattolica. Il 19 maggio 1914, le forze di
Obregón condannarono il vescovo Andrés Segura e altri uomini di Chiesa a 8 anni
di carcere per la loro presunta partecipazione ad una ribellione. Durante il
periodo in cui Obregón ebbe il controllo di Città del Messico (febbraio 1915),
impose alla Chiesa il pagamento di 500.000 pesos per alleviare le sofferenze dei
poveri. Venustiano Carranza assunse la presidenza il 1º maggio 1915. Carranza e
i suoi seguaci ritenevano che il clero sobillasse il popolo contro di lui
attraverso la propaganda. Divennero sempre più frequenti le violenze, tollerate
dalle autorità, nei confronti dei cattolici: nel 1915 vennero assassinati ben
160 sacerdoti. Subito dopo che Carranza ebbe il totale controllo del Messico,
emanò una nuova Costituzione con l'intento di ridurre il potere politico della
Chiesa.
La Costituzione del 1917. Nella Costituzione
Messicana furono introdotti articoli anticlericali:
L'articolo 3 rese obbligatoria l'istruzione laica
nelle scuole messicane.
L'articolo 5 mise fuori legge i voti religiosi e
gli ordini religiosi.
L'articolo 24 proibì il culto fuori dagli edifici
ecclesiastici.
Con l'articolo 27 alle istituzioni religiose fu
negato il diritto di acquisire, detenere o amministrare beni immobili e tutti i
beni ecclesiastici, compresi quelli di scuole e ospedali, furono dichiarati
proprietà nazionale.
Con l'articolo 130 il clero fu privato del diritto
di voto e del diritto di commentare questioni politiche.
Il governo messicano fu estremamente pervicace nel
suo intento di eliminare l'esistenza legale della Chiesa cattolica in Messico.
La costituzione ebbe il risultato di acuire il conflitto fra Chiesa e Stato. Per
otto anni questi provvedimenti non furono rigorosamente messi in atto dal
governo messicano. Intanto le violenze continuavano. Nel 1921 un attentatore
tentò di distruggere il più importante simbolo del cristianesimo messicano: il
mantello con l'immagine della Madonna di Guadalupe, conservato nell'omonimo
santuario. La bomba, nascosta in un mazzo di fiori deposto vicino all'altare,
produsse gravi danni alla basilica. Questa politica ebbe termine nel giugno
del 1926, quando il Presidente del Messico Plutarco Elías Calles (che affermava
che "la Chiesa è la sola causa di tutte le sventure del Messico"), emanò un
decreto noto come “Legge Calles”, con cui metteva in atto l'articolo 130 della
Costituzione. La Chiesa era urtata dalla rapidità della decisione di Calles e in
particolare dall'articolo 19, che prevedeva la registrazione obbligatoria del
clero, perché permetteva al governo di immischiarsi negli affari religiosi. La
Chiesa cattolica prese quindi posizione contro il governo. I cattolici
messicani, di concerto con il Vaticano, risposero inizialmente con iniziative di
protesta non violente, tra le quali il boicottaggio di tutti i prodotti di
fabbricazione statale (ad esempio il consumo di tabacchi crollò del 74%) e la
presentazione di una petizione che raccolse 2 milioni di firme (su 15 milioni di
abitanti). Il governo non diede alcuna risposta e la Chiesa decise infine un
estremo gesto simbolico: la sospensione totale del culto pubblico. A partire dal
1º agosto 1926, in tutto il Messico non si sarebbe più celebrata la Messa né i
sacramenti, se non clandestinamente. Il 18 novembre papa Pio XI denunciò la
persecuzione dei cattolici messicani con l'enciclica Iniquis Afflictisque. Lo
scontento degenerò in aperte violenze quando oltre 5.000 Cristeros diedero
inizio ad una ribellione armata. Il governo messicano e i cattolici ingaggiarono
un sanguinoso conflitto che durerà per tre anni. Nel 1927 si formò un vero e
proprio esercito ribelle, forte di ventimila uomini, che in seguito aumentarono
fino a cinquantamila, al comando del generale Enrique Gorostieta Velarde.
All'esercito si affiancavano le "brigate Santa Giovanna d'Arco", formazioni
paramilitari femminili che giunsero a contare 25000 membri, tra cui anche
giovani di soli 14 anni. Tra il 1927 e il 1929 tutti i tentativi di schiacciare
la ribellione fallirono; gli insorti anzi presero il controllo di vaste zone nel
sud del paese. La Chiesa messicana e il Vaticano, tuttavia, non diedero mai il
loro aperto sostegno alla ribellione (il che non impedì al governo di
giustiziare anche numerosi sacerdoti che non ne facevano parte), e agirono per
giungere ad una soluzione pacifica. Il 21 giugno 1929 furono così firmati gli
Arreglos ("accordi"), che prevedevano l'immediato cessate il fuoco e il disarmo
degli insorti. I termini dell'accordo, mediati (o piuttosto imposti)
dall'ambasciatore degli Stati Uniti, erano però estremamente sfavorevoli alla
Chiesa: in pratica tutte le leggi anticattoliche rimanevano in vigore. Questo
periodo di anticlericalismo messicano ha ispirato a Graham Greene la scrittura
del romanzo Il potere e la gloria.
Anticlericalismo in Portogallo.
Nel 1750 il Portogallo fu il primo paese ad espellere i gesuiti.
Una prima ondata di anticlericalismo si verificò
nel 1834 sotto il regno di Pietro IV, quando il ministro Joaquim António de
Aguiar decretò la soppressione degli ordini religiosi. Parallelamente, alcune
delle più note scuole religiose del Portogallo furono obbligate a cessare
l'attività. In questo periodo lo scrittore e politico Almeida Garrett pubblicò
la commedia anticlericale A sobrinha do Marquês (1848). La caduta della
monarchia a seguito della Rivoluzione repubblicana del 1910 causò un'ulteriore
ondata di anticlericalismo. La rivoluzione colpì in primo luogo la Chiesa
cattolica: vennero saccheggiate le chiese, vennero attaccati i conventi. Furono
presi di mira anche i religiosi. Il nuovo governo inaugurò una politica
anticlericale. Il 10 ottobre il nuovo governo repubblicano decretò che tutti i
conventi, tutti i monasteri e tutte le istituzioni religiose fossero soppresse:
tutti i religiosi venivano espulsi dalla repubblica e i loro beni confiscati. I
gesuiti furono costretti a rinunciare alla cittadinanza portoghese. Seguirono,
in rapida successione, una serie di leggi anticattoliche: il 3 novembre venne
legalizzato il divorzio. In seguito passarono leggi che legittimavano i figli
nati fuori dal matrimonio, che autorizzavano la cremazione, che secolarizzavano
i cimiteri, che sopprimevano l'insegnamento religioso a scuola e che proibivano
di indossare l'abito talare. Inoltre al suono delle campane e ai periodi di
adorazione furono poste alcune restrizioni e la celebrazione delle feste
popolari fu soppressa. Il governo interferì anche nei seminari, riservandosi il
diritto di nominare i professori e determinare i programmi. Questa lunga serie
di leggi culminò nella legge di separazione fra Chiesa e Stato che fu approvata
il 20 aprile 1911. Il 24 maggio dello stesso anno papa Pio X deplorò la legge
portoghese con l'enciclica Iamdudum.
Anticlericalismo in Spagna.
Già tra il XV ed il XVI secolo si nota nella letteratura e nel teatro spagnolo
la presenza di opere, o parti di esse, di contenuto anticlericale, spesso
generate dall'ammirazione per Erasmo da Rotterdam. Si nota quindi Alfonso de
Valdés, con la sua Discorso de Latancio y del Arcediano, dove si compiace di
descrivere la corruzione della Roma papale punita con il sacco di Roma; a causa
del controllo esercitato dal Sant'Uffizio, si trovano tracce di anticlericalismo
celato, come nella commedia di Luis Belmonte Bermúdez, El diablo predicador, o
negli aforismi perduti di Miguel Cejudo. In seguito alla prima guerra
carlista del 1836, il nuovo regime chiuse i maggiori conventi e monasteri
della Spagna. In questo contesto, il radicale Alejandro Lerrouxsi caratterizzava
per un'oratoria violenta e incendiaria. Dal punto di vista economico la Chiesa
cattolica in Spagna fu pesantemente colpita dalle leggi di esproprio e confisca
dei beni ecclesiastici, che si susseguirono dal 1798 al 1924: il più famoso di
questi provvedimenti è noto con il nome di Desamortización di
Mendizábal del1835. Circa un secolo dopo, instaurata la Seconda repubblica e
approvata la Costituzione del 1931, proseguì la legislazione anticlericale,
inaugurata il 24 gennaio 1932con lo scioglimento in Spagna della Compagnia di
Gesù e l'esilio della maggioranza dei gesuiti. Il 17 maggio 1933, il governo
varò la controversa Legge sulle Confessioni e Congregazioni Religiose (Ley de
Confesiones y Congregaciones Religiosas), approvata dal parlamento il 2
giugno 1933, e regolamentata mediante un decreto del 27 luglio[54]. La legge
confermava la proibizione costituzionale dell'insegnamento per gli ordini
religiosi, mentre si dichiararono di proprietà pubblica i monasteri e le chiese.
La legge fu un duro colpo al sistema scolastico (le scuole gestite dagli ordini
religiosi contavano 350.000 alunni) in un Paese dove il 40% della popolazione
era analfabeta. Reagì contro la legge papa Pio XI, con l'enciclica Dilectissima
Nobis del 3 giugno 1933. Durante la guerra civile spagnola del 1936, molti
appartenenti all'armata Repubblicana erano
volontari anarchici e comunisti fortemente anticlericali e provenienti da varie
parti del mondo. Nel corso dei loro assalti, (in risposta all'atteggiamento del
clero, che con toni da crociata si era schierato dalla parte dell'insurrezione
antirepubblicana di Francisco Franco e che denunciava spesso gli anarchici alle
autorità, condannandoli a morte certa) parecchi edifici di culto e monasteri
vennero bruciati e saccheggiati. Al termine del conflitto, la stima delle
vittime religiose ascende a più di 6.000 religiosi trucidati, tra cui 259
clarisse, 226 francescani, 155 agostiniani, 132 domenicani e 114 gesuiti. Gli
episodi raccapriccianti non furono isolati: stupri di suore, fucilazioni rituali
di statue di santi, preti cosparsi di benzina e arsi, taglio di orecchie e
genitali "papisti" e persino corride con sacerdoti al posto di tori[55]. La
stragrande maggioranza della Chiesa cattolica salutò la vittoria di Franco,
militarmente sostenuto da Hitler e Mussolini, come un provvidenziale intervento
divino nella storia di Spagna. Nonostante la guerra fosse stata per Hitler
nient'altro che il banco di prova della tragedia che stava preparando per
l'Europa, papa Pio XII nel suo radiomessaggio del 16 aprile 1939, Con immensa
gioia, parlò di una vera e propria vittoria "contro i nemici di Gesù Cristo". La
Chiesa cattolica, sotto il papato di Giovanni Paolo II, tra il 1987 ed
il 2001 ha riconosciuto e canonizzato 471 martiri della guerra civile spagnola;
altri 498 sono stati poi beatificati nel 2007 da Benedetto XVI. Recentemente,
anche il premier Zapatero è stato avvicinato all'anticlericalismo per le sue
politiche laiche.
Anticlericalismo negli Stati Uniti.
L'anticlericalismo statunitense (o meglio
l'anticattolicesimo) degli anni cinquanta del secolo XIX trovò espressione
nel Know Nothing: un movimento xenofobo ("nativista"), che traeva forza dalle
paure popolari che il paese potesse essere sopraffatto dall'immigrazione
massiccia dei cattolici irlandesi, ritenuti ostili ai "valori americani" e
controllati dal papa. Sebbene i cattolici asserissero di essere politicamente
indipendenti dal clero, i protestanti accusavano papa Pio IX di aver posto fine
alla Repubblica Romana e di essere un nemico della libertà, della democrazia e
del protestantesimo. Questi rilievi fomentarono teorie di cospirazione che
attribuivano a Pio IX il disegno di soggiogare gli Stati Uniti mediante
un'immigrazione continua di cattolici controllati da vescovi irlandesi
obbedienti e personalmente selezionati dal Pontefice. Un'eco di anticlericalismo
è presente nelle elezioni presidenziali del 1928, in cui il Partito
Democratico candidò il governatore dello stato di New York Al Smith, (il primo
cattolico candidato alla presidenza da un grande partito), che fu attaccato come
"papista". L'elettorato temeva che "se Al Smith fosse eletto presidente, gli
Stati Uniti sarebbero governati dal Vaticano". L'anticlericalismo ha trovato
anche esponenti laici, non legati al protestantesimo e all'opposizione agli
immigrati, in epoca recente: ad esempio il giornalista
anglo-americano Christopher Hitchens, accusato spesso di
anticattolicesimo, ateo e antislamista; i laici americani riprendono le
posizioni del presidente Thomas Jefferson che fu uno dei più forti sostenitori
di uno stato non legato alla religione all'epoca della nascita degli Stati
Uniti. Uno dei cavalli di battaglia più recenti degli anticlericali statunitensi
è la lotta contro l'ingerenza evangelicista nella politica interna nonché la
critica contro il clero cattolico per loscandalo pedofilia che ha coinvolto
molte diocesi americane.
Anticlericalismo nella Germania nazista.
La propaganda nazista ebbe tratti anticlericali. Ad esempio Himmler, capo
supremo delle SS e della Gestapo, riprende alcuni motivi cari
all'anticlericalismo: la depravazione e perversione del clero, la
svalorizzazione della donna, la corruzione della grandezza di Roma: «Sono
assolutamente convinto che tutto il clero e il cristianesimo cercano soltanto di
stabilire un'associazione erotica maschile e a mantenere questo bolscevismo che
esiste da duemila anni. Conosco molto bene la storia del cristianesimo a Roma, e
ciò mi permette di giustificare la mia opinione. Sono convinto che gli
imperatori romani, che hanno sterminato i primi cristiani, hanno agito
esattamente come noi con i comunisti. A quell'epoca i cristiani erano la peggior
feccia delle grandi città, i peggiori ebrei, i peggiori bolscevichi che vi
possiate immaginare. Il bolscevismo di quell'epoca ha avuto il coraggio di
crescere sul cadavere di Roma. Il clero di quella Chiesa cristiana che, più
tardi, ha sottomesso la Chiesa ariana dopo lotte infinite, cerca, dal IV o V
secolo, di ottenere il celibato dei preti. [...]dimostreremo che la Chiesa, sia
a livello dei dirigenti che a quello dei preti, costituisce nella maggior parte
un'associazione erotica di uomini che terrorizza l'umanità da 1.800 anni, che
esige che questa umanità le fornisca una grandissima quantità di vittime e che,
nel passato, si è dimostrata sadica e perversa. Posso soltanto citare i processi
alle streghe e agli eretici.» (Testo del discorso segreto tenuto da Heinrich
Himmler il 17-18 febbraio 1937 ai generali delle SS in relazione ai "pericoli
razziali e biologici dell'omosessualità. Ciononostante, il Partito del Centro
Cattolico di Germania, guidato da Franz von Papen, aveva appoggiato l'ascesa del
nazismo in Germania e, nel gennaio 1933, la nomina di Hitler a Cancelliere, di
cui von Papen divenne vice-Cancelliere. Nel marzo dello stesso anno, il partito
di von Papen votò la concessione dei pieni poteri a Hitler in cambio di
privilegi che sarebbero stati concessi alla Chiesa nel Concordato con la
Germania nazista, che venne firmato nel 4 mesi più tardi dal cardinale Pacelli
(futuro papa Pio XII). Hitler stesso aveva dichiarato più volte ai suoi
collaboratori la sua ostilità verso la Chiesa: "Ho conquistato lo Stato a
dispetto della maledizione gettata su di noi dalle due confessioni, quella
cattolica e quella protestante. (13 dicembre 1941) I preti oggi ci insultano e
ci combattono, si pensi per esempio alla collusione tra la Chiesa e gli
assassini di Heydrich. Mi è facile immaginare come il vescovo von Galen sappia
perfettamente che a guerra finita regolerò fino al centesimo i miei conti con
lui... (4 luglio 1942) - I preti sono aborti in sottana, un brulichio di cimici
nere, dei rettili: la Chiesa cattolica stessa non ha che un desiderio: la nostra
rovina- La dottrina nazionalsocialista è integralmente antiebraica, cioè
anticomunista ed anticristiana. (Notte tra il 29 e il 30 novembre 1944) -
schiaccerò la chiesa come un rospo " e aveva mostrato con fatti concreti il suo
anticlericalismo, violando continuamente il Reichskonkordat. Oltre a far
togliere i crocefissi dalle aule scolastiche e pubbliche, nella sola Germania
più di un terzo del clero secolare e un quinto circa del clero regolare, ossia
più di 8000 sacerdoti furono sottoposti a misure coercitive (prigione, arresti
illegali, campi rieducativi), 110 morirono nei campi di concentramento, 59
furono giustiziati, assassinati o perirono in seguito ai maltrattamenti
ricevuti.
Anticlericalismo in Argentina.
Durante il primo periodo peronista, ci furono alcuni
atteggiamenti e leggi anticlericali. Inizialmente i rapporti tra il governo di
Juan Domingo Perón e di sua moglie Evita e le gerarchie ecclesiastiche furono
buoni, e il peronismo non era affatto antireligioso, ma si incrinarono quando
Perón legalizzò l'aborto e facilitò il divorzio, introducendo leggi che
ostacolavano l'istruzione religiosa. Il governo di Juan Domingo Perón in un
primo momento fu legato alle Forze Armate, e l'esercito e la Chiesa erano
all'epoca considerati il baluardo contro le ideologie socialiste e comuniste. La
Chiesa, inoltre, sosteneva la dottrina politica della "giustizia sociale", e
condivideva con il peronismo l'idea che fosse compito dello Stato mediare nei
conflitti di classe e livellare le disuguaglianze sociali. Ci furono, tuttavia,
settori della Chiesa cattolica, già reduce dai provvedimenti antiecclesiastici
del Messico di Calles un ventennio prima, che accusavano il peronismo di
statalismo per l'eccessiva interferenza del governo nazionale nella vita privata
e in contesti che non gli competevano. Il motivo della critica era dovuto anche
al fatto che spesso lo Stato invadeva le sfere tradizionalmente di competenza
della Chiesa nel momento in cui si interessava, ad esempio, dei piani di
assistenza e della pubblica educazione. Le alte gerarchie ecclesiali argentine
erano rimaste alleate dell'oligarchia, nonostante la Costituzione del
1949 trattasse con moltissimo riguardo il cattolicesimo, facendone religione di
Stato nell'articolo 2, e affermasse che il Presidente dovesse essere un
cattolico. Nel 1946 il Senato approvò una legge che riaffermava e confermava
tutti i decreti stabiliti dalla giunta militare del precedente governo
dittatoriale. Tra questi decreti c'era anche la legge sull'istruzione religiosa
obbligatoria varata nel 1943. Questa legge era stata duramente discussa alla
Camera dei Deputati, ed era passata solo grazie al voto dei peronisti. Gli
argomenti che apportarono a favore della legge furono nazionalistici ed
antiliberali: si sottolineò il legame esistente tra l'identità della nazione e
il profondo cattolicesimo della Spagna, e si enfatizzò il ruolo che la religione
avrebbe avuto nella formazione delle coscienze e della società. Questa
riaffermazione della legge sull'educazione religiosa, tuttavia, limitò i poteri
della Chiesa dando ragione a coloro che all'interno della stessa Chiesa
tacciavano il peronismo di statalismo: i programmi scolastici e i contenuti dei
libri di testo erano responsabilità dello Stato, il quale avrebbe potuto
consultare le autorità ecclesiastiche qualora ce ne fosse stato bisogno; le
altre materie scolastiche continuarono ad essere insegnate secondo lo spirito
della Legge 1420 del 1884, e quindi continuarono a seguire la
tradizione laicista dello stile di formazione argentino; l'educazione scolastica
divenne un mezzo di propaganda per il culto della personalità del Presidente e
di sua moglie Eva; nel giugno 1950, infine, Perón nominò Armando Méndez San
Martín, un massone anticattolico, Ministro della Pubblica Istruzione,
cominciando a guardare la Chiesa con sospetto. Durante il suo secondo mandato
Perón non condivise l'aspirazione della Chiesa di promuovere partiti politici
cattolici. Infine, alcune leggi peroniste provocarono malumori tra i vescovi:
nel 1954 il governo soppresse l'educazione religiosa nelle scuole, tentò di
legalizzare la prostituzione, di far passare una legge sul divorzio, e di
promuovere un emendamento costituzionale per separare completamente Stato e
Chiesa. Perón, poi, accusò pubblicamente il clero di sabotaggio. Il 14
giugno1955, durante la festa del Corpus Domini, i vescovi Manuel Tato e Ramón
Novoa fecero discorsi antigovernativi. Fu il punto di rottura: durante quella
stessa notte gruppi di peronisti attaccarono e bruciarono alcune chiese di
Buenos Aires. Perón divenne apertamente anticlericale e, due giorni dopo questi
fatti, venne scomunicato da papa Pio XII. Perón venne deposto nel 1955, ma tornò
al potere nel 1973. Alla sua morte (1974) il potere passò alla terza
moglie Isabelita Perón, che venne deposta a sua volta da un golpe militare. La
dittatura di Jorge Rafael Videla, sosteneva la religione come mezzo di controllo
sociale, anche se vi furono molti preti e religiosi che finirono nel numero
dei desaparecidos. Con il ritorno della democrazia, ci sono stati alcuni
contrasti fra la Chiesa e il governo di Néstor e Cristina Fernández de Kirchner.
Campagna elettorale per la Costituzione
dell'Ecuador. In occasione del referendum
costituzionale del settembre 2008, la Chiesa cattolica ha preso posizione
guidando il fronte del no e ha invitato gli elettori a votare contro la proposta
dell'Assemblea costituente ecuadoriana perché, a giudizio dei vescovi, la nuova
Costituzione non avrebbe tutelato il diritto alla vita del concepito, lasciando
intravedere il diritto per le donne all'aborto. La nuova Costituzione
ecuadoriana, all'articolo 66.3.a, tutela infatti l'integrità fisica, psichica,
morale e sessuale di ogni persona, senza specificare, come avrebbe voluto la
Chiesa, un primato del concepito sulla madre. L'articolo 66.9 garantisce il
diritto di decidere sulla propria sessualità e orientamento sessuale. L'articolo
66.10 garantisce il diritto di decidere quanti figli generare e quando. Secondo
i vescovi gli articoli sarebbero vaghi e generici e permetterebbero
l'introduzione del diritto all'interruzione di gravidanza e del matrimonio
omosessuale. Il governo di Rafael Correa ha reagito fermamente alle critiche
avanzate dai vescovi cattolici, invitando gli elettori a non farsi catechizzare
dai preti, accusati, senza mezzi termini, di mentire e di esercitare indebite
ingerenze nella politica nazionale. Il presidente del Tribunale supremo
elettorale, Jorge Acosta, ha invitato pubblicamente la Conferenza Episcopale
Ecuadoriana a registrarsi come soggetto politico per continuare la sua «campagna
di catechesi costituzionale», accusandola al contempo di non aver rispettato le
norme giuridiche e di non aver nominato un tesoriere per il finanziamento della
campagna stessa. L'episcopato cattolico ha invocato il diritto di esprimere la
propria opinione richiamandosi alla Dichiarazione universale dei diritti umani e
ha protestato per gli epiteti offensivi rivolti a vescovi e sacerdoti nella
campagna del governo, costata milioni di dollari. Anche il Centro
Latinoamericano dei Diritti Umani ha espresso la sua preoccupazione per gli
attacchi verbali del presidente Correa contro la Conferenza Episcopale. Gli
elettori ecuadoriani hanno poi, nel referendum, approvato la Costituzione con
un'ampia maggioranza di circa il 64% contro circa il 29%. Durante la visita ad
limina a papa Benedetto XVI nell'ottobre del 2008, i vescovi ecuadoriani hanno
espresso disappunto per i rapporti con il governo ecuadoriano, giudicato
anticlericale.
Anticlericalismo negli Stati comunisti.
Molti governi comunisti, che praticavano l'ateismo di Stato, sono stati
violentemente anticlericali, abolendo le festività religiose, imponendo il solo
insegnamento dell'ateismo nelle scuole, chiudendo chiese, monasteri, scuole ed
istituti religiosi. Il culto privato rimase ufficialmente consentito, tranne
nell'Albania, che imponeva l'ateismo anche nella propria Costituzione. A Cuba le
manifestazioni religiose pubbliche sono state rese legali solo nel 1993. In
alcuni stati fortemente cattolici, come la Polonia, la Chiesa era tollerata fino
a quando restava in ambito religioso e non interferiva o criticava il governo
comunista. In Russia, poi Unione Sovietica, nel marzo del 1922 viene decisa la
requisizione degli oggetti di culto preziosi appartenenti al clero,
ufficialmente allo scopo di rimediare agli effetti della carestie che si erano
accompagnate durante la guerra. Tuttavia, molti ritengono che tale provvedimento
fosse in realtà finalizzato a provocare la reazione degli ecclesiastici (che
consideravano i paramenti liturgici sacri), per poterli perseguitare "con
ragione". Infatti si ebbero circa un migliaio di episodi di "resistenza", a
seguito dei quali i Tribunali rivoluzionari comminarono la pena di morte a 28
vescovi e 1215 preti e la pena detentiva a circa 100 vescovi e diecimila
preti. In tutto, durante tale "iniziativa", vennero uccisi circa ottomila membri
del clero. In dicembre viene organizzata una campagna pubblica per irridere
il Natale; simili manifestazioni si avranno l'anno seguente anche in occasione
della Pasqua e della festa ebraica del Yom Kippur. Migliaia di monaci e
sacerdoti sono stati condannati a morte o ai lavori forzati nei gulag durante il
regime di Stalin. La separazione tra Stato e Chiesa venne decisa nel territorio
dell'URSS il 23 gennaio 1918 dai soviet, poco dopo la fine della Rivoluzione
russa. Lo Stato divenne laico e ufficiosamente ateo, sostenendo l'ateismo di
Stato, anche se ciò non venne mai sancito esplicitamente nelle Costituzioni, che
si limitavano a nominare la religione solo affermando la divisione netta tra
Chiesa e Stato e la libertà di culto e coscienza; l'ateismo di stato venne
attuato in forma di politica governativa anticlericale e antireligiosa, dal
punto di vista pratico e culturale, tramite leggi ordinarie e propaganda. La
religiosità venne ridotta a semplice scelta privata, secondo l'ideologia
di Lenin e del marxismo, da considerare lecita ma da scoraggiare, al di fuori
della sfera personale. La chiesa ortodossa russa fu costretta a rinunciare a
tutti i privilegi, come l'esenzione dalle tasse e dal servizio militare per i
sacerdoti e i monaci, e per un certo periodo perseguitata. Con la Costituzione
sovietica del 1918, emanata per la Repubblica Socialista Federativa Sovietica
Russa e poi estesa alle altre repubbliche federate, venne permesso di svolgere
formalmente "propaganda religiosa e non-religiosa", anche se svolgere attiva
propaganda di religione o di idee ritenute "superstizioni" in luogo o edificio
pubblico (come la propaganda religiosa nelle scuole, l'esposizione di immagini
religiose nei luoghi di lavoro, le processioni, ecc.) poteva essere sanzionato
con multe o lavori forzati fino a 6 mesi. Coloro i quali non svolgevano lavori
socialmente utili (non solo ecclesiastici, ma anche ex agenti zaristi, privati,
ad eccezione di artigiani e contadini dei colchoz, ecc.) venivano esclusi dal
voto e non pagati, restrizione poi eliminata nel 1936. Quindi questi ultimi, una
volta esaurite le risorse di cui erano dotati, dovettero svolgere un altro
lavoro per sostentarsi, secondo il principio "chi non lavora non mangia". Venne
introdotto il matrimonio civile e negata validità legale a quello religioso,
vennero distrutte alcune chiese che occupavano suolo pubblico, altre vennero
convertite in uffici e musei pubblici e vennero inoltre abolite tutte le feste
religiose come ad esempio il Natale o lo Yom Kippur ebraico. Con Stalin il
processo antireligioso dello Stato fu completato. La costituzione sovietica del
1924 non conteneva esplicitamente norme sulla religione, in quanto era stata
votata come integrazione per sancire la nascita dell'unione federale delle
repubbliche come Unione sovietica, mentre per quanto riguarda i diritti e doveri
dei cittadini, restò in vigore la relativa parte della costituzione del 1918.
Infine, solo in alcune località remote venne concesso di svolgere cerimonie
religiose. Secondo fonti ortodosse, nel 1917 erano attive circa 80.000 chiese,
mentre è stato calcolato che erano circa 20.000 nel 1954 e 10.000 nel 1965. La
Costituzione sovietica del 1936 sancì la libertà di culto privato, e autorizzò
solo la propaganda antireligiosa, ribadendo nuovamente la netta divisione tra
Chiesa e Stato. Restarono valide le normative penali del 1922 contro le
"superstizioni religiose" diffuse in pubblico. Nel 1927 venne approvato
l'articolo del codice penale che sanciva, tra l'altro, che svolgere propaganda
religiosa in tempo di guerra o crisi, se considerato fatto con lo scopo preciso
di abbattere il regime comunista o danneggiare direttamente o indirettamente lo
Stato, poteva essere punito anche con la pena di morte. Durante la seconda
guerra mondiale, nel1943, Stalin diede una tregua alla campagna antireligiosa e
chiese al patriarca Sergio I di Mosca (in seguito a un incontro avvenuto tra i
due) di supportare moralmente i soldati al fronte contro i nazisti. Nello stesso
periodo Sergio I rientrò a Mosca e morì nel 1944. Stalin concederà poi alla
Chiesa ortodossa la possibilità di celebrare funzioni religiose, ma solo
all'interno delle chiese autorizzate e nel privato. Con Nikita Khruščёv riprendono
le misure più restrittive verso la Chiesa, e si
riprende la propaganda attiva dell'ateismo di Stato dopo la tregua iniziata
nel 1943 e durata sino al 1954. Soltanto negli anni ottanta, dopo la
continuazione della politica antireligiosa dei
governi Breznev, Andropov e Cernenko, vi fu una nuova tregua nella lotta attiva
contro la religione, a partire dall'ascesa al potere diMichail Gorbačëv. La
situazione di tolleranza pratica perdurò fino al 1990, quando Gorbačëv permise
la libera propaganda religiosa e instaurò la libertà di culto in via ufficiale,
al posto dell'ateismo di stato. Istituì inoltre l'Istituto per l'ateismo
scientifico di Leningrado, che durò fino allo scioglimento dell'URSS,
nel 1991. Nell'Unione Sovietica vennero introdotti il divorzio (1º dicembre
1917) e l'aborto nel 1920 (reso molto più difficile da Stalin nel 1935, poi
reintrodotto nel 1955) e negata la validità del matrimonio religioso (dicembre
1917). Anche in Cina l'anticlericalismo ha comportato la soppressione (spesso
anche fisica) del clero di varie religioni, compreso anche il monachesimo
buddista del Tibet. La libertà religiosa ufficialmente è assicurata, anche se in
realtà alcuni movimenti sono perseguitati e la stessa Chiesa cattolica e la
nomina dei suoi vescovi sono subordinate all'avallo del Partito Comunista
Cinese.
Anticlericalismo negli stati islamici.
Influenzati dall'occidente anche alcuni Paesi islamici, principalmente
la Turchia negli anni venti e l'Iran negli anni sessanta, vararono provvedimenti
anticlericali contro il clero musulmano. «Per quasi cinquecento anni, queste
regole e teorie di un vecchio arabo e le interpretazioni di generazioni di
religiosi pigri e buoni a nulla hanno deciso il diritto civile e penale della
Turchia. Loro hanno deciso quale forma dovesse avere la Costituzione, i dettagli
della vita di ciascun turco, cosa dovesse mangiare, l’ora della sveglia e del
riposo, la forma dei suoi vestiti, la routine della moglie che ha partorito i
suoi figli, cosa ha imparato a scuola, i suoi costumi, i suoi pensieri e anche
le sue abitudini più intime. L’Islam, questa teologia di un arabo immorale, è
una cosa morta. Forse poteva andare bene alle tribù del deserto, ma non è adatto
a uno stato moderno e progressista. La rivelazione di Dio! Non c’è alcun Dio! Ci
sono solo le catene con cui preti e cattivi governanti inchiodano al suolo le
persone. Un governante che abbisogna della religione è un debole. E nessun
debole dovrebbe mai governare.» Mustafa Kemal Atatürk, militare e politico
membro del movimento dei Giovani Turchi e della Massoneria, prese il potere
nel 1923. Egli era anticlericale e in favore di un forte nazionalismo, il suo
modello di riferimento trovava radici nell'Illuminismo. Aveva l'ambizione di
creare una moderna forma di civiltà turca. Durante tutto il periodo e anche
oltre, l'esercito rimase il pilastro della nazione e la scuola fu riformata in
modo da essere laica, gratuita e obbligatoria. La nuova capitale fu posta
ad Ankara, scelta a scapito di Istanbul (due volte capitale imperiale: Impero
Romano d'Oriente ed Impero Ottomano). La lingua fu riformata nello stile e
nell'alfabeto: l'alfabeto ottomano di origine araba venne sostituito
dall'alfabeto latino nel 1928. Nello stesso periodo la storia venne riscritta
per dare radici alla nazione, e legarla all'occidente. Kemal, la cui ideologia è
detta kemalismo, introdusse il cognome al posto del patronimico arabo: a lui il
parlamento assegnò il cognome Atatürk, cioè "padre dei turchi". Usanze
islamiche, come portare la barba, i baffi alla turca o i copricapi arabi come
il fez furono scoraggiate o vietate (ai militari fu proibito di portare i baffi
e tuttora devono essere sbarbati). Dalla rivoluzione del 1908, i diritti delle
donne uscirono rinforzati. Nel 1919, sotto l'influsso dei militari, furono
adottate misure per cambiare lo status delle donne: la parità con gli uomini fu
riconosciuta nel codice civile, il matrimonio civile reso obbligatorio per chi
volesse sposarsi, fu introdotto il divieto di poligamia, vietati il ripudio
(divorzio unilaterale maschile) e l'uso del velo islamico nei luoghi pubblici
(possibilità resa nuovamente lecita solo nel 2011), legalizzata la produzione e
la vendita delle bevande alcoliche, resa obbligatoria l'iscrizione a scuola per
le bambine, incentivata l'assunzione di donne in vari posti di lavoro e così
dicendo. Nel 1934 fu riconosciuto alle donne il diritto di votare e
nel 1935 furono elette delle donne al parlamento turco. La Turchia kemalista era
risolutamente laica. Il califfato fu abolito il 3 marzo 1924. Questo gesto fu
considerato come un sacrilegio da parte del mondo arabo-musulmano. Nel 1928,
primo paese del mondo musulmano, l'Islam non era più la religione di Stato e,
nel 1937, il secolarismo venne sancito nella Costituzione. Fu adottato
il calendario gregoriano, e la domenica divenne il giorno settimanale di riposo.
Proseguendo la secolarizzazione delle leggi cominciata
nel 1839 dalleTanzimat (riforme) dell'Impero Ottomano, il regime kemalista
adottò nel 1926, un codice civile sulla base del codice svizzero, un codice
penale sulla base del codice italiano e un codice commerciale basato sul Codice
tedesco. Furono abolite le pene corporali previste dalla legge islamica, i reati
di apostasia e adulterio. L'anticlericalismo del regime era pronunciato, ma lo
spiritualismo musulmano non fu mai completamente abbandonato. L'Islam e le altre
religioni, compreso il cristianesimo, erano inoltre controllate attraverso
l'Organo per la Direzione degli Affari Religiosi, creato nel 1924. Sotto
l'influsso del kemalismo anche dopo la morte del leader continuarono le riforme:
fu depenalizzata l'omosessualità, anche se i gay turchi vengono tuttora
discriminati, non potendo, ad esempio, far parte dell'esercito. In tempi recenti
l'avvento al potere di un partito islamico moderato, anche se non ha abolito lo
Stato laico, ha incrementato tuttavia la rinascita di movimenti e sentimenti
"islamisti". Nel 2008 i militari, guardiani del secolarismo secondo la visione
di Atatürk hanno tentato un colpo di Stato, fallito, in difesa della laicità e
contro il governo eletto di Recep Tayyip Erdoğan. Mohammad Reza Pahlavi, scià di
Persia, varò la cosiddetta rivoluzione bianca, che modernizzò il Paese in senso
occidentale; benché egli, a differenza di Atatürk, fosse un fervente praticante
musulmano (nonché formalmente capo supremo dell'Islam sciita duodecimano), era
fortemente e violentemente avverso al clero e all'influenza dei mullah. Reza
proibì, ad esempio, l'uso del velo in luoghi pubblici e perseguitò il clero che
si opponeva alle riforme occidentalizzanti, uccidendo, imprigionando o esiliando
i mullah e gli imam, compreso l'Ayatollah Khomeini inviato in esilio nel 1964.
Lo scià modernizzò il paese con la forza, ma vietò ogni tipo di opposizione alla
sua monarchia. Furono resi legali il gioco d'azzardo, la prostituzione, le
bevande alcoliche, istituito il suffragio femminile e il matrimonio civile. Tra
il fronte di rivolta alle riforme pahlavidi, soprattutto per la loro
impronta giurisdizionalista, si schierò soprattutto il clero sciita perché
veniva privato dei benefici assolutisti, nonché gruppi religiosi che si erano
opposti alla sua riforma agraria e sociale, che venivano espropriati di molti
beni di manomorta, controllati dalle gerarchie religiose. Tuttavia, la sua
posizione ambivalente nei confronti della religiosità iraniana, della quale era
virtualmente anche il capo (incarnando un modello cesaropapistico), lo poneva in
difficoltà impedendogli di prendere provvedimenti drastici onde evitare lo
scontento aperto e manifesto delle masse popolari. Alla rivoluzione iraniana,
nel 1979, Khomeini prese il potere e lo scià dovette fuggire. I religiosi
instaurarono un regime clericale ed islamista, la repubblica islamica, che
cancellò le riforme del periodo Pahlavi e perseguitò anche la sinistra che aveva
contribuito a combattere l'autocrazia dello scià.
Anticlericalismo oggi in Italia.
Il potere temporale dei papi ha cessato di esistere, ad
esclusione ovviamente del diritto a legiferare e governare nei limiti
territoriali della Città del Vaticano, ma rimangono tuttora fortemente
contestati, da parte di alcuni ambienti laici, la ripetuta attività di
pressione, diretta e indiretta, esercitata dalla Chiesa, in nome dei propri
valori e delle proprie finalità, nella società e nella politica, anche
attraverso la ramificata presenza delle sue organizzazioni all'interno di
partiti, associazioni, enti pubblici e privati. L'anticlericalismo rimane
presente in varie forme in alcuni giornali satirici come il settimanale
parigino Le Canard enchaîné, e nel dibattito politico e culturale di vari stati,
come reazione all'influsso esercitato dalla chiesa sui partiti politici che
dichiarano di richiamarsi ai valori cristiani e sui governi degli stati a
maggioranza cattolica. Oggi l'anticlericalismo in Italia si esplica nelle
tensioni della attualità politica; l'etica e la morale sono ancora terreno vivo
e fertile dello scontro tra parti, tra Stato e Chiesa, tra comunità
scientifiche. Tra le questioni dibattute sono sicuramente al vertice la libertà
di ricerca scientifica, in particolare sulle cellule staminali embrionali,
la procreazione medicalmente assistita sia eterologa che omologa, l'eutanasia e
la terapia del dolore, le unioni civili, la legalizzazione dell'aborto,
la contraccezione e la pillola RU486. L'anticlericalismo contemporaneo spesso
focalizza l'attenzione sugli aspetti più arretrati che ritiene presenti, sia
pure con diversi livelli di gravità, in diverse religioni, come l'Islam quali,
ad esempio, la condizione di subalternità della donna. In questo senso, si
potrebbe ritenere come anticlericale la recente legge varata in Francia che
vieta l'uso del velo e dei simboli religiosi all'interno delle aule scolastiche.
La possibilità che, su invito del rettore, papa Benedetto XVI potesse inaugurare
l'anno accademico all'università la Sapienza di Roma, il 17 gennaio 2008, è
stata contestata fortemente da alcuni gruppi studenteschi e da 67 professori, in
particolare di materie scientifiche. Richiamandosi ad una lettera aperta
di Marcello Cini al rettore apparsa su il manifesto, i contestatori ritenevano
inopportuna la visita del papa sulla base di una citazione del Pontefice,
risalente ad un suo discorso del1990 tenuto a Parma. L'allora cardinale
Ratzinger aveva citato il filosofo Feyerabend: «La Chiesa dell'epoca di Galileo
si attenne alla ragione più che lo stesso Galileo, e prese in considerazione
anche le conseguenze etiche e sociali della dottrina galileiana. La sua sentenza
contro Galileo fu razionale e giusta, e solo per motivi di opportunità politica
se ne può legittimare la revisione». Questa citazione costituiva, secondo i 67
professori (tra cui il presidente del CNR), una minaccia alla laicità della
scienza. La contestazione portò all'annullamento della visita del Papa, che
preferì declinare l'invito del rettore, in quanto non era condiviso da tutta
l'università.
Alla testa dei cattocomunisti ci stanno i
comunisti, con i cattolici che fanno da prestanome, pronti ad essere sfrattati
quando necessario, scrive Diego Gabutti il 28 ottobre
2015 su “Italia Oggi”. Vittima prima del libro Cuore e della retorica
risorgimentale, poi del fascismo, quindi del clericalismo e del comunismo,
infine del giustizialismo e del berlusconismo, mai che sull'Italia brilli una
buona stella, come sa bene Massimo Teodori. Radicale storico, uno dei rari
intellettuali laici e liberali in un paese di bacchettoni, devoti soltanto a
ubbìe ideologiche e a idee fisse religiose, Teodori continua la sua esplorazione
dell'Italia sotto sortilegio illiberale (e luogo di catastrofi culturali) con il
suo ultimo libro, Il vizietto cattocomunista (Marsilio 2015, pp. 176, 14,00
euro, ebook 9,99 euro). È la storia lunga settant'anni «del connubio tra eredi
del Pci e della sinistra democristiana» che ha per capolinea il partito
democratico di Matteo Renzi. Teodori ripercorre nel suo libro tutta la vicenda:
la guerra di Togliatti contro Benedetto Croce e gli altri nemici del Concordato
con la Chiesa, il congresso della gioventù comunista in cui un Enrico Berlinguer
poco più che ventenne invitava le giovani militanti a prendere esempio (in fatto
di morale sessuale) da Santa Maria Goretti, gl'innumerevoli tentativi
d'arruffianarsi la sinistra cattolica, le titubanze in tema d'aborto e di
divorzio, l'epoca in cui Berlinguer (sempre lui) predicava il compromesso
storico tra comunisti e democristiani contro le derive (non sembra vero, visto
il pulpito) clericali e autoritarie, l'odio per il laicismo craxiano, la guerra
contro il consumismo e l'elogio dell'austerità, l'invenzione della «questione
morale», poi la crisi del comunismo internazionale e la caduta dell'Urss.
Arrivano i giorni di Tangentopoli, Craxi se ne va in esilio come Trotzky, i
laici si raccolgono intorno al nascente partito di plastica, sparisce la Dc, il
Pci cambia nome. In questa generale rovina una sola forza ideologicamente e
politicamente attiva porta a casa la pelle: il cattocomunismo, con i suoi
ingombri religiosi e i suoi pregiudizi ideologici. Alla testa dei cattocomunisti
ci sono i comunisti e i cattolici (tra cui lo stesso Romano Prodi) fanno più che
altro da prestanome (come gli «utili idioti» d'un tempo, che potevano essere
sfrattati senza preavviso da ogni incarico). Poi Matteo Renzi chiede banco, come
a baccarat. Sono i cattolici, non appena il suo astro comincia a salire, a
distribuire le carte: la sinistra mesozoica e stalinista, nata con Togliatti nel
1944, viene rottamata di prepotenza. Finiscono tra i rottami anche i cattolici
di sinistra troppo compromessi con la Ditta post comunista. Che la storia dei
cattocomunisti prosegua oltre, è naturalmente possibile, specie in un paese
sventurato come il nostro, che per i mostri della ragion politica ha sempre
avuto un debole. Ma il partito renziano, dopo tanti esperimenti falliti, sembra
un esperimento finalmente riuscito, diversamente dall'alleanza più o meno
organica «tra forze popolari e cattoliche» vagheggiata da Palmiro Togliatti nei
primi giorni della repubblica, o dal «compromesso storico» berlingueriano, dalla
«solidarietà nazionale» e dall'Ulivo prodiano. Duri tanto o poco, sempre più
«catto» e sempre meno «comunista», il partito democratico a guida renziana ha
messo definitivamente in crisi la ragion sociale del cattocomunismo. È probabile
che già al prossimo passaggio elettorale resti soltanto l'ala cattolica e che i
comunisti lascino la scena una volta per tutte. Può darsi, come si diceva, che
la storia finisca qui, col trionfo dei cattolici dossettiani d'antan, non si sa
se più populisti o più clericali, di cui Renzi è insieme l'erede e la
caricatura. E già questo sarebbe un pessimo finale di partita. Ma c'è il rischio
che, finita questa storia, ne cominci un'altra, più minacciosa ancora. Se ne
intravedono i primi segni nel gesto da Papa Re col quale Francesco I prima ha
congedato il sindaco Marino dal Campidoglio e poi ha chiesto scusa ai romani per
la sua sindacatura. Stanno tornando i clericali, e i loro «utili idioti» sono i
talk show sempre più devoti e i comici televisivi che abbracciano la teologia
della liberazione.
Il libro di Massimo Teodori: "Il vizietto
cattocomunista. La vera anomalia italiana". Si svelano qui le ambiguità di
settant’anni di egemonie cattoliche e comuniste che - combinate nel «vizietto
cattocomunista» - hanno reso l’Italia una democrazia anomala. Nei grandi Paesi
europei l’alternarsi al potere di conservatori e riformatori ha prodotto
l’espansione del benessere e delle libertà. In Italia, invece, la sinistra
comunista e postcomunista, confluita con i democristiani nel Partito
democratico, è rimasta estranea al riformismo socialista di stampo europeo e ha
guardato con ostilità alla laicità dello Stato, con effetti negativi sui diritti
civili e la giustizia sociale. L’anomalia cattocomunista italiana è destinata a
continuare all’infinito? Con il rigore dello storico e lo spirito critico del
laico, Massimo Teodori mette in luce l’intreccio perverso tra il conservatorismo
burocratico comunista e il rapace «attaccamento alla roba» dei clericali: dalla
versione di Palmiro Togliatti, che votando il Concordato pensava di giocare il
Vaticano e ne fu giocato, al fatale moralismo di Enrico Berlinguer, attratto dal
mondo cattolico, fi no ai postdemocristiani d’oggi, Matteo Renzi e Sergio
Mattarella, assurti al massimo potere con il benestare dei postcomunisti. «Se è
vero che Renzi ha rimosso le scorie veterocomuniste - scrive Teodori - è
altrettanto incontestabile che non ha tagliato i ponti con il cattocomunismo, la
vera palla al piede del riformismo italiano insediato al centro del Partito
democratico».
Ora ci impongono lo Stato (diet)etico.
"Repubblica" rilancia l'appello "liberal" a mangiare vegano, per essere coerenti
coi principi di giustizia anche verso gli animali. Un animalismo caricaturale
che cela un'ideologia anti-umanista e totalitaria. Il prossimo passo sarà la
dieta di Stato? Scrive Corrado Ocone su “L’Intraprendente" del 27 gennaio 2016.
Un virus si aggira per il mondo culturale americano. È contagioso e pericoloso
perché causa seri danni all’organismo vitale. Dai sintomi che lo accompagnano
potremmo definirlo come la “chiusura della mente occidentale”. Ed è pericoloso
perché si annida nel settore dominante delle accademie, del giornalismo,
dell’editoria e di certo mondo giornalistico: il pensiero liberal. L’ultima
manifestazione è davvero stupefacente: ce ne ha dato notizia, con un certo
compiacimento, l’antropologo Marino Niola sulle pagine di Repubblica. Essa si è
appalesata sulla rivista onlinecultural-chic “Salon” sotto forma di un appello
lanciato agli intellettuali dal medico e psichiatria Steve Stankevicius. In
esso, gli sciagurati, che sicuramente come la monaca di Monza risponderanno,
sono chiamati a dare finalmente coerenza al loro pensiero a farsi tutti
vegani in nome dei “diritti degli animali”. Siete per i diritti di tutti,
indifferentemente e a prescindere da quello che essi sono e fanno, fossero pure
dei delinquenti? Volete eliminare la sofferenza dal mondo e farci vivere in un
eden ovattato di sicura e rassicurante felicità, casomai sotto il manto
protettivo di uno Stato e di un welfare che ci accompagni “dalla culla alla
bara” in nome di astratti “principi di giustizia”? Bene, dice Stankevicius, non
potete non estendere anche agli animali questa etica utilitaristica e, in quanto
tale, direi, profondamente immorale. In questo modo di ragionare, che aveva
avuto come capostipite qualche decennio fa un sopravvalutato filosofo di
Princeton, Peter Singer, vediamo all’opera, quasi in modo paradigmatico, tutte
le contraddizioni e tutti i vizi del pensiero liberal. Le contraddizioni, sol
che si pensi che quasi sempre coloro che vorrebbero equiparare le bestie agli
uomini, in nome dell’astrattissimo concetto di “vita organica” o “sensibile”,
sono gli stessi che negano all’embrionela vita in nome del diritto della donna
ad abortire (e poi perché fermarsi al mondo vegetale: non sono anche le verdure,
seppur a uno stadio minimo, forme di vita?). Ma anche i vizi del pensiero
liberal, sia teorici che pratici. I primi sono riconducibili a quello che già
Hegel chiamava “intelletto astratto”, incapace di vedere il senso ultimo delle
cose del mondo, che è storico e umano. I secondi riconducibili invece
all’intolleranza di chi non si limita a fare una personale e legittima scelta
dietetica ma, ammantandola di valori etici, vuole imporla agli
altri apostrofando come immorale qualsiasi altro regime alimentare. Statene
certi: il passo successivo sarà l’imposizione per legge della “dieta giusta”, la
“dieta di Stato” (secondo i dettami socialisti dello Stato etico rimodellato
come Stato dietetico). Ancora più preoccupante è poi il fatto che al fondo di
questo acritico animalismo ci sia un’ideologia ecologista e
quindi antiumanista che, sconfessando il valore ultimo della nostra civiltà
cristiano-liberale, cioè appunto l’uomo nella sua singolarità e libertà, vuole
mettere in discussione lo stesso sistema di sviluppo e civiltà che chiamiamo
Occidente. Una civiltà, quella occidentale, che è umanistica perché
profondamente cristiana, checché ne possa dire un Papa tendenzialmente succube
dei tempicome il Francesco che, ad esempio, fa proiettare bestie di ogni tipo
sul cupolone. E che è altresì umanistica perché profondamente liberale, cioè
ponente l’individuo al centro di ogni etica e ontologia. Il buon Niola, cercando
un supporto alla tesi animalistica, non si accorge di citare per lo più eresie
cristiane fondate sul pericoloso concetto di “purificazione” (in uno spettro che
va dalla gnosi ai catari) o pensatori profondamente illiberali come Rousseau.
D’altronde, e non sembri una esagerazione dirlo qui perché ha una sua logica e
coerenza, sembra che anche Hitler amasse gli animali e fosse rigorosamente
vegetariano. Tutto si tiene e tutto coopera affinché noi si gridi forte, prima
di tutto ai cosiddetti “intellettuali”, di lasciarci vivere e mangiare come
meglio ci aggrada. La scelta vegana? No, grazie.
SANTA INQUISIZIONE: COME LA RELIGIONE COMUNISTA
CAMBIA LA STORIA.
La BBC conferma: l’Inquisizione una
truffa culturale per colpire la Chiesa. Addio ad
uno dei suoi grandi calunniatori, Umberto Eco, scrive il 21 febbraio
2016 antimassoneria. Se oggi pensare al medioevo e alla Chiesa dell’epoca alla
maggior parte del popolo poco informato vengono subito in mente roghi, streghe,
superstizione e barbarie di tutti i generi lo dobbiamo sicuramente alla
massoneria: si sa, sono i vincitori che scrivono la storia, o almeno quella
storia ricca di reticenze, omissioni, spesso di vere e proprie
falsità; accuse che si continuano a scagliare anche a distanza di molti secoli.
Infatti, una ricerca storica al di fuori dei libri di testo ci dà un quadro
chiaro -e del tutto diverso come vedremo- da quello cosiddetto ufficiale. Il 19
Febbraio 2016 se ne va uno dei grandi calunniatori e mistificatori del medioevo
e soprattutto, della Chiesa e della Santa Inquisizione. E così Umberto Eco pieno
di sè fino all’orlo ha dovuto piegarsi anche lui davanti al ciclo naturale della
vita, e alla natura come Dio l’ha creata, a cosa gli è servita tanta superbia se
anche lui, “filosofo illuminati”, ha dovuto piegarsi-come i tutti i comuni
mortali- alla sua ora? Il suo romanzo “Il Nome della Rosa” è uno dei libri più
venduti di tutti i tempi insieme al “Codice da Vinci” di Dan Brown e a “50
sfumature di Grigio”, ciò la dice lunga sui gusti dei lettori occidentali, che
sembrano chiedano: “ci vuole meno fede e ci vuole più sesso”. Ateo incallito,
Eco ha fatto del suo meglio per trascinare il pubblico mondiale in direzione
delle sue vedute personali contro la Cristianità, anche se questo ha significato
mentire senza scrupoli. Umberto Eco – intervistato dal Corriere in occasione
degli eventi di Charlie Hebdo– si schierò in favore della cancellazione di tutte
le religioni, portatrici, secondo lui di odio e di distruzione, appoggiando in
pieno il piano di dell’Unica Religione Globale in piena sintonia coi signori del
potere e della globalizzazione. Non una parola ovviamente sulle cause reali di
questi attentati, -che di islamico, a dir la verità hanno poco o nulla,- ma a
questi eventi verranno contrapposti quelli della Santa Inquisizione, come dire?
Due false flag a confronto. E fu così che anche Eco ha dovuto chiudere gli occhi
e passare dall’aldilà, se abbia invocato la Divina Misericordia– l’unica
possibilità di salvezza- non lo sapremo mai, ma sappiamo per certo che le sue
menzogne, i suoi romanzi e le sue affermazioni continueranno ad essere riprese
dai grembiulini (o massoni senza grembiule) che continueranno a servirsene per
attaccare ingiustamente la Chiesa Cattolica e i suoi fedeli.
Introduzione a cura di Floriana Castro Testo in
basso tratto da Appuntiitaliani.com. (Le foto riportate nell’articolo sono
tratte dal dalla versione cinematografica de “Il nome della Rosa” di
Jean-Jacques Annaud. Raffigurano il falso scenario medievale che si è inculcato
nella mente del popolo medio: volti raccapriccianti, torture, donne innocenti
accusate e scene di sesso tra presunte streghe e monaci, la più grande
mistificazione di tutti i tempi). Finalmente un documentario della BBC, una
fonte sicuramente non di parte Cattolica, che smonta il mito sulla Santa
Inquisizione con il quale la Chiesa Cattolica è stata calunniata per secoli.
Tutto falso signori, è tutto falso. La Chiesa non è quel covo di torturatori
sadici depressi e maniaci che ha compiuto stragi, anzi, questa accusa torna al
mittente, ossia la propaganda rivoluzionaria francese, i protestanti, gli
inglesi anglicani che hanno attaccato la Chiesa Cattolica con accuse infamanti
coprendo invece i loro misfatti. Ebbene sì, sono loro i torturatori sadici
depressi e maniaci che hanno ucciso e torturato civili soprattutto Cattolici in
quanto oppositori dei loro regimi. Basti pensare ai 2 milioni di francesi uccisi
dalla massonica Rivoluzione Francese, ai Vandeani trucidati, ai Cattolici
perseguitati in Inghilterra, facendo 70.000 vittime. Un clima di terrore
quotidiano, ghigliottine, carceri, omicidi e genocidi. Questi sono coloro che
accusano gli altri di colpe che invece sono le loro. Forza Cattolici, non fatevi
intimidire, la Chiesa non deve chiedere scusa di niente e tantomeno bisogna
vivere in soggezione per un presunto passato oscuro. Lo stesso Napoleone, invasa
la Spagna, credeva di trovare archivi insanguinati ed invece non trovò niente.
Forse avrebbe dovuto indagare sui suoi fratelli a Parigi. Vorrei proporvi questo
interessante articolo che riassume i nuovi studi storici sulla cosiddetta
leggenda dell’Inquisizione Cattolica, uno dei cavalli di battaglia della
Massoneria ma soprattutto del Protestantesimo anglosassone fresco di tradimento
nei confronti di Roma ed in competizione con l’egemonia del nascente Impero
Spagnolo. Altro interessantissimo documento a supporto dei fatti è il
documentario della BBC inglese -fonte sicuramente non di parte Cattolica- che
dimostra come i fatti storici siano stati ingigantiti e manipolati in chiave
anticattolica dalla propaganda protestante. Naturalmente i cavalieri
anticattolici si stracciano le vesti e si inneggiano a difensori della dignità
umana solo quando si tratta della storia del Cattolicesimo, dimenticandosi
invece delle colpe ben più gravi e maggiori per esempio di Lutero che perseguitò
i Cattolici e fece uccidere 100.000 anabattisti, oppure degli eccidi di
Cattolici da parte dell’anglicanesimo, e non dimentichiamo i 2.000.000 di
francesi, il 10% della popolazione delle Francia inclusi i 600,000 Vandeani,
uccisi durante la Rivoluzione Francese, la quintessenza della libertà e della
superiorità anticlericale ed invece dimostratasi la madre di tutte le
dittature. E che dire del Comunismo che fece 100 “milioni” di morti nel mondo,
dei quali 30 “milioni” solo in Russia, per i quali però non c’è memoria nè si
grida allo scandalo? Per non parlare del genocidio armeno e quello in corso di
Cristiani in medio oriente. Nessuna menzione riguardo agli eccidi dell’impero
Azteco che sacrificava la popolazione con riti propiziatori in quantità
industriale fino a raggiungere i 30.000 morti ogni anno e che giustamente sono
stati travolti dagli spagnoli che hanno letteralmente liberato la popolazione
locale da tale tirannia satanica, non solo si vorrà vedere quei territori
liberati da quel male, ma si accuserà persino il condottiero spagnolo, Hernan
Cortes di inciviltà e barbarie contro quel civile e pacifico popolo. Ma si sà,
l’unica liberazione accettabile è quella della dittatura liberale che ha portato
guerra in Europa negli ultimi tre secoli ed ora bombarda civili per esportare
la falsa democrazia, nel silenzio totale dei sostenitori degli eroi che
avrebbero liberato il mondo dalla millantata tirannia della Chiesa Cattolica
Streghe e Inquisizione: la verità storica
oltre i luoghi comuni, di Bartolo Salone. Quando si
parla di caccia alle streghe, nell’immaginario collettivo è immediato
l’accostamento all’Inquisizione cattolica. Centinaia di migliaia, anzi milioni
di donne sarebbero state sterminate per colpa di quell’esecrabile Istituzione,
che certa storiografia liberal ci ha abituati a vedere come un covo di fanatici
e integralisti religiosi assetati di sangue. Ma sono andate veramente così le
cose? La ricerca storica, di recente, ha ribaltato questa prospettiva,
dimostrando la falsità di una delle più diffuse “leggende nere” anticattoliche.
Possiamo definire la stregoneria come quell’insieme di pratiche che una persona,
in particolare relazione col Maligno, possa esercitare per nuocere ai suoi
simili (secondo la credenza popolare). Benché si parli sovente di streghe e di
caccia alle stesse, in realtà – come risulta dai documenti storici – la
persecuzione riguardò, seppur in misura più ridotta, anche gli uomini e, in
qualche raro caso, perfino i bambini. Contro un diffuso luogo comune di stampo
femminista, va dunque rilevato come la “caccia” non era rivolta al sesso
femminile in quanto tale, nascendo invece da una più generale ossessione per il
diabolico. Ossessione – e qui va sfatato un altro luogo comune – sorta non nella
Cristianità medievale, bensì nell’Europa moderna, proprio in quella osannata
Europa della Riforma e del Rinascimento. Se nel Medioevo la credenza nella
stregoneria non attecchì presso il popolo si deve proprio alla Chiesa cattolica,
la quale, in numerosi Concili dal VI al XIII secolo (si pensi al Concilio di
Praga del 563 o di Lione dell’840, fino ad arrivare ai Concili di Rouen e di
Parigi, rispettivamente celebrati nel 1189 e nel 1212), condannò come
superstiziosa idolatria la credenza che esistessero persone capaci di esercitare
la magia nera in forza dei loro rapporti con il diavolo. A partire dalla fine
del XIII secolo, le credenze stregonesche, per ragioni storiche che in questa
sede non è possibile riepilogare, si fanno sempre più diffuse sia presso il
popolo che presso alcuni ecclesiastici ed uomini di cultura. Sul piano dogmatico
la posizione ufficiale della Chiesa sulla stregoneria (formulata nei predetti
Concili) non muta, tuttavia muta la risposta al fenomeno: streghe e stregoni,
proprio perché contravvengono agli insegnamenti della Chiesa e al divieto di
esercitare le arti magiche, vengono considerati alla stregua degli eretici, e
pertanto la competenza giurisdizionale, nei Paesi cattolici, viene sottratta ai
tribunali civili e assegnata ai tribunali inquisitoriali. Secondo una certa
vulgata (sostenuta con forza da intellettuali “liberal” e da romanzieri asciutti
di storia alla Dan Brown) questo avrebbe segnato l’inizio di una vera e propria
mattanza, che nell’arco di tre secoli avrebbe portato al rogo non migliaia, ma
addirittura milioni di donne (tutte ascrivibili, manco a dirlo, al fanatismo e
alla misoginia propri del mondo cattolico). Fin qui la “leggenda”. La verità è
però ben diversa e per rendercene conto basterà riferirsi ad alcuni dati tratti
dall’opera più completa ed aggiornata di cui ad oggi si dispone in tema di
stregoneria e di caccia alle streghe: si tratta della “Enciclopedia della
stregoneria, la Tradizione occidentale” edita nel 2007 dalla Abc-Clio e curata
dallo storico anglosassone Richard Golden, per un totale di ben 752 voci,
compilate da 172 studiosi di 28 diverse nazionalità. Innanzitutto, facciamo
attenzione alla periodizzazione e alla “geografia” del fenomeno: la cosiddetta
“caccia alle streghe” (ma, come visto, non mancarono anche roghi di stregoni) va
dal 1450 al 1750 (siamo dunque in piena età moderna, non nel “buio” Medioevo) e
interessò un po’ tutti i Paesi europei, sia cattolici che protestanti. Quante le
persone giustiziate per stregoneria? Centinaia di migliaia o milioni, come ci
ripetono alcuni? Ebbene, la cifra “vera” si aggira tra le 30.000 e le 50.000
unità, da “spalmare” nel corso di tre secoli: una cifra considerevole, ma
comunque irrisoria se paragonata ai milioni di morti delle grandi rivoluzioni e
guerre dell’800 e delle stragi del ‘900, e in ogni caso non tale da giustificare
la definizione di “genocidio” né tantomeno di “olocausto”. Un fenomeno
prevalentemente cattolico, dovuto alla furia dei tribunali inquisitoriali? Anche
questa è una falsità bell’e buona. Infatti nei Paesi che avevano l’Inquisizione,
le “streghe” giustiziate furono soltanto 310 (precisamente, 300 in Italia e
Spagna e soltanto 10 in Portogallo), a cui si aggiungono (per rimanere in ambito
cattolico) i 600 casi della Francia e i 4 dell’Irlanda. La grande massa (tra le
15.000 e le 25.000 vittime) è concentrata in Germania, mentre la piccola
Svizzera contribuì al massacro con 3.000, la Scandinavia con 2.000 e la Scozia
con 1.000. Si ha quindi conferma che la mattanza fu concentrata soprattutto nei
Paesi luterani, calvinisti, anglicani o in quei piccoli Stati tedeschi che non
avevano l’Inquisizione cattolica. Dunque, l’Inquisizione costituì non un
incentivo (come a lungo ci è stato fatto credere), bensì un freno (e molto
efficace) contro la persecuzione delle “streghe”. Le ragioni ci sono spiegate
dallo storico Richard Golden in questo modo: “Nelle terre dove regnava la legge
dell’Inquisizione cattolica vi furono meno vittime rispetto ad altre regioni
d’Europa. Questo si deve al fatto che le tre Inquisizioni applicavano regole
omogenee ovunque, avevano propri tribunali composti da giudici con nozioni
basilari di diritto e applicavano la legge seguendo canoni universali,
rispondendo a un unico potere. In Germania, invece, dove si ebbe il numero più
alto di streghe uccise, la realtà era opposta: ognuno degli oltre trecento
principati e staterelli aveva un sovrano con un suo tribunale che applicava la
legge a piacimento e di conseguenza i pericoli per le presunte streghe
aumentavano. I tribunali laici del nord e del centro dell’Europa condannarono a
morte molte più streghe di quanto fecero quelli dell’Inquisizione cattolica
romana, che facevano maggiore attenzione al rispetto di garanzie legali e di
conseguenza limitavano il ricorso alla tortura”. Non penso ci sia bisogno di
aggiungere altro, se non che da cattolici realmente maturi e amanti della verità
dovremmo imparare ad andare oltre certi luoghi comuni e a guardare con più
serenità ed obiettività al nostro passato. E non solo per un dovere di carità
verso quanti ci hanno preceduto nella fede, ma anche per saper rispondere a
ragion veduta a quanti vorrebbero farci vergognare della nostra fede
presentandoci una visione parziale e in molti casi deformata della storia della
Chiesa. Introduzione Floriana Castro testo seguente tratto
da appuntiitaliani.com
L’eresia, la propaganda e la leggenda della chiesa
assassina. La Santa Inquisizione, scrive il 29 agosto 2015 antimassoneria.
Sicuramente alcuni lettori al semplice suono della parola “medioevo” avranno già
davanti scenari cupi e tenebrosi di cumuli di cadaveri ammassati sui carri nel
periodo della peste bubbonica o i roghi della chiesa assassina! Quando parliamo
di Inquisizione è proprio il caso di dire: basta la parola. Basta pronunciare il
termine Inquisizione ed ecco che noi cattolici restiamo senza parole,
ammutoliti. Beh, la chiesa non è più come quella di una volta, oggi i papi non
fanno altro che inchinarsi e chiedere perdono davanti a chi ha perseguitato
impenitentemente la Chiesa di Cristo. Oggi i papi prendono le distanze dalla
tenacia con la quale i loro predecessori hanno difeso l’etica cristiana.
Suppliche di perdono che tra l’altro non vengono nemmeno accettate -come nel
caso dei valdesi-, che si scissero dalla Chiesa rifiutando la sottomissione alle
autorità episcopali ed in seguito combatterono ferocemente la Chiesa Cattolica,
anche con la violenza: Essi si diedero alla rapina, al saccheggio, alle stragi
di cattolici, a violenze gratuite di ogni genere nel corso dei secoli. Fino a
poco più di cent’anni fa misero a punto vari attentati con lo scopo di
assassinare San Giovanni Bosco. Invano il vescovo Bellesmaius li richiamò
all’ordine. Il papa Lucio III finì per condannarli, nel concilio di Verona e
nella Bolla Ad abolendam, del 4 novembre 1184. In seguito i valdesi si
organizzarono come setta separata dalla Chiesa. Dallo scisma passarono presto
all’eresia. Molto più tardi, verso il 1533, adottarono le principali dottrine
della Riforma protestante: Fu questo ad attirare su di essi le repressioni
legali sotto Francesco I. Essi furono allora, per ordine del Parlamento di
Aix-en-Provence, le vittime di una tremenda spedizione punitiva, durante la
quale vi furono migliaia di morti (le cifre variano fra 800 e 4.000 per 22
villaggi distrutti). Oggi i Valdesi si dichiarano ecumenici e desiderosi di
collaborare nella Chiesa targata “Vaticano II” dopo aver chiarito alcuni punti
teologici con Bergoglio, ricordiamo i punti teologici sulla quale si basano i
valdesi: matrimoni gay, sostegno a movimenti LGBT, contraccezione, aborto,
eutanasia, testamento biologico (i cui registri, in diverse città, sono gestiti
proprio dai valdesi). Chiudiamo la parentesi dei valdesi; andiamo al cuore del
problema: cosa ha fatto la chiesa per difendere la sua dottrina nel passato?
Davvero gli scenari erano quelli descritti nel libro “Il nome della rosa” di
Umberto Eco? E’ vero che tante povere donne innocenti venivano date al rogo solo
per tenere un gatto nero in casa? “Come è possibile che la Chiesa cattolica sia
stata capace di istituire i tribunali dell’Inquisizione?” domandano e ci
ricordano i laicisti e gli avversari della Chiesa. E noi, spesso, non sappiamo
che cosa rispondere. Anzi, molti cattolici spesso per ignoranza accusano i
cristiani del passato, chiedendo scusa alle presunte vittime. Scusa? Ma
conoscete la Santa Inquisizione?
COSA FU L’INQUISIZIONE? L’inquisizione è
l’argomento privilegiato dai signori della sovversione per denigrare la storia
della Chiesa e con questo pretesto anche la fede cattolica. La Santa
Inquisizione fu istituita da Papa Gregorio IX nel 1232, per reprimere eresie,
sacrilegi, stregonerie e gravi delitti. Quando ci si trovava davanti a delitti
gravi e gli accusati non si pentivano, erano consegnati all’autorità civile, che
li castigava secondo la legge. Ovviamente bisogna giudicare le cose secondo la
mentalità dell’epoca. In Europa erano tutti obbligati a seguire la religione del
re, secondo il principio “CUIUS REGIO, EIUS ET RELIGIO” (di chi è la regione,
dello stesso è la religione) per cui un delitto nel campo religioso (eresia) era
considerato come attentato contro lo Stato, che interveniva con tutto il peso
della legge. Ad accendere i roghi furono prima la gente comune e poi le
autorità, tanto che la Chiesa dovette intervenire per avocare a sé il problema.
Cioè: in tema di religione solo la Chiesa ha la competenza necessaria nonché la
misericordia occorrente affinché sul rogo non ci finisca qualche sprovveduto.
Perciò creò l’Inquisizione, un tribunale di esperti teologi con tanto di
garanzie che accertava che l'“eretico” fosse veramente tale e non un poveraccio
tratto all’eresia da ignoranza. Se l’imputato persisteva nelle sue “idee”, la
Chiesa non poteva fare più nulla per lui e passava la mano all’autorità civile.
Pertanto, servirsi di questo fatto per attaccare il cattolicesimo e la sua
dottrina è storicamente scorretto. Ricordate quanti cristiani furono dati in
pasto ai leoni? quanti cristiani furono decapitati ai tempi della Roma pagana?
Come mai nessuno ricorda le vittime cristiane sacrificate in nome della
“libertà, uguaglianza e fraternità”? E le vittime cristiane durante gli anni 30
in Spagna? e le vittime causate dal Comunismo in Russia e in tutti i paesi
comunisti? E i cattolici martirizzati ai tempi dell’istituzione
dell’Anglicanesimo in Inghilterra, come si può dimenticare ciò? Anche perchè
stiamo parlando di ben 70.000 martiri uccisi per impiccagione e squartamento che
avveniva prima della morte per soffocamento,- Beh, a me non sembra corretto non
ricordare mai nemmeno le vittime causate dall’inquisizione protestante, numero
assai superiore di quella Spagnola. Non c’è obiettività…mi sembra ovvio che il
bersaglio da colpire è sempre la chiesa cattolica e la sua dottrina. E'
abitudine citare il processo e l’atto di abiura di Galileo Galilei, sospettato
di eresia. Il conflitto che egli stava affrontando contro una parte della
Chiesa riguardava l’interpretazione di Galileo verso alcuni passi biblici che
sostengono l’immobilità della terra e del movimento del sole distorti a favore
dell’eliocentrismo. Consideriamo che la Chiesa prima delle prese di posizioni di
Galileo era stata favorevole all’ “ipotesi copernicana”. Si evita di
chiarire che dopo il processo Galileo non finì sul rogo, ma fu trasferito presso
l’arcivescovo di Siena, dopo pochi mesi gli fu concesso di trasferirsi presso la
sua abitazione. Pochi conoscono il “segreto” del processo alla quale fu
sottoposto Galileo. Proprio di questo “caso” parla il libro “Lezioni da Galileo”
recentemente pubblicato da APRA in italiano, scritto dal celebre storico della
scienza Stanley Jaki (scomparso nel 2009). Jaki ha smontato diverse leggende,
chiarendo che la Chiesa non era affatto interessata a prendere posizione sul
sistema copernicano in sé e che non lo temeva affatto. Anche perché, come
abbiamo scritto, già quattro secoli prima di lui san Tommaso d’Aquino
(1225-1274) disse che la concezione tolemaica, proprio perché non suffragata da
prove, non poteva considerarsi definitiva. Inoltre, diversi pontefici,
come Leone X e Clemente VII, si mostrarono aperti alle tesi del sacerdote
cattolico Copernico (nessun “caso Copernico”, infatti), tanto che
nell’Università di Salamanca, proprio negli anni di Galilei, si studiava e si
insegnava anche la concezione copernicana (e lo stesso Galilei ne era
consapevole). Nel 1533 papa Clemente VII, affascinato dall’eliocentrismo,
chiese, ad esempio, a Johann Widmanstadt di tenergli una lezione privata sulle
teorie di Copernico nei Giardini Vaticani. L’opposizione all’eliocentrismo venne
invece in modo compatto dal mondo protestante, tanto che Lutero scrisse di
Copernico: «Il pazzo vuole rovesciare tutta l’arte astronomica». Ancora oggi i
protestanti hanno grossi problemi con il mondo scientifico (creazionismo Vs
evoluzione) a causa della mancanza di interpretazione della Bibbia. La critica a
Galileo da parte della Chiesa fu basata invece dalla mancanza di prove
sufficienti a favore dell’eliocentrismo e dunque sulla sua inopportuna
presentazione come unica descrizione scientifica dell’universo, tale da
costituire criterio di interpretazione della Sacra Scrittura. Galilei, inoltre,
utilizzò come unica prova l’argomento dell’esistenza delle maree, che invece gli
astronomi gesuiti collegavano non alla rotazione della terra ma all’attrazione
lunare (e avevano ragione loro, non certo lo scienziato pisano). Tuttavia molti
ecclesiastici erano d’accordo con Galilei, come ha perfettamente spiegato lo
storico ateo Tim O’Neill, «tutta la vicenda non era basata su “scienza vs
religione”, come recita la favola della fantasia popolare.
QUANTE VITTIME FECE
L’INQUISIZIONE? Nell’immaginario popolare si pensa che i tribunali
dell’Inquisizione siano stati istituiti per mandare tutti gli eretici al rogo.
Si pensa che tutti gli inquisiti, tutti coloro che cadevano nelle terribili
braccia dell’inquisitore finivano al rogo. Questo è quello che si pensa, questo
è quanto molto spesso ci viene detto ed insegnato e affermazioni di questo
genere zittiscono ogni possibile difesa. Noi ci domandiamo: le cose stanno
proprio così? Vediamo qualche dato storicamente documentato, che ci aiuti a
formulare un giudizio più vicino alla verità storica. Innanzitutto, ricordiamo
che la condanna al rogo per gli eretici era una pena stabilita dal diritto
penale e non dal diritto canonico. Non esiste nel diritto canonico la condanna
al rogo. Fu l’imperatore Federico II di Svevia, che dichiarò per tutto l’impero
– e lui era la massima autorità dell’impero e poteva farlo, allora, – l’eresia
come crimine di lesa maestà, e stabilì la pena di morte per gli eretici. Ogni
sospetto doveva essere tradotto davanti a un tribunale ecclesiastico e arso vivo
se riconosciuto colpevole. Dunque, è vero che quando il tribunale
dell’Inquisizione abbandonava un eretico al braccio secolare, questi veniva
condannato a morte dalla giustizia secolare, se non si pentiva, ma non era la
Chiesa a condannarlo a morte, nè era la Chiesa ad ucciderlo. La Chiesa si
limitava a riconoscerlo come eretico che rifiutava ogni pentimento. Era il
diritto penale e il braccio della legge che prevedevano la morte ed eseguivano
la sentenza. Detto questo, entriamo un po’ nel merito e qui emergono sorprese:
quale stupore ci coglie tutti se esaminiamo quante sono state le condanne al
braccio secolare. L’esame dei dati ci indica che i tribunali dell’Inquisizione
furono molto prudenti nel consegnare gli eretici al braccio secolare. I dati,
documentati storicamente, non mancano, basta conoscerli. Facciamo l’esempio di
Bernardo Gui, che ha esercitato con una certa severità l’ufficio di inquisitore
a Tolosa. Bene: dal 1308 al 1323 egli ha pronunciato 930 sentenze. Abbiamo
l’elenco completo delle pene da lui inflitte: 132 imposizioni di croci – 9
pellegrinaggi – 143 servizi in Terra Santa – 307 imprigionamenti – 17
imprigionamenti platonici contro defunti – 3 abbandoni teorici al braccio
secolare di defunti – 69 esumazioni – 40 sentenze in contumacia – 2 esposizioni
alla berlina – 2 riduzioni allo stato laicale – 1 esilio – 22 distruzioni di
case -1 Talmud bruciato – 42 abbandoni al braccio secolare e 139 sentenze che
ordinavano la liberazione degli accusati. Soltanto l’ 1% ! Questi dati
contestano il mito della crudeltà dell’Inquisizione spagnola. E non solo. Lo
storico statunitense Edward Peters ha confermato questi dati. Sentiamo che cosa
scrive: “La valutazione più attendibile è che, tra il 1550 e il 1800, in Spagna
vennero emesse 3000 sentenze di morte secondo verdetto inquisitoriale, un numero
molto inferiore a quello degli analoghi tribunali secolari”. Come vedete, grazie
a questi dati, va sfatata la leggenda che tutti coloro che venivano giudicati
dall’ inquisizione finivano a rogo. È una leggenda che gli storici hanno
smontato, ma che perdura ancora nell’immaginario popolare. Nei documenti
inquisitoriali, abbiamo incontrato condanne alla prigione “perpetua e
irremissibile”. Ma attenti a non farsi ingannare da certi modi di esprimersi del
tempo. Abbiamo condanne al “carcere perpetuo per anni uno”.
Solitamente “perpetuo” vuoi dire 5 anni, “irremissibile” vuoi dire 8 anni. La
pena dell’ergastolo non era prevista.
CHI ERANO QUESTI CITTADINI CHE L’IMMAGINARIO VUOLE
ESSERE STATI PERSEGUITATI PER LE LORO IDEE RAZIONALI? QUALI ERANO QUESTE IDEE?
Ora, diciamo subito una cosa molto scomoda e fuori moda: non si deve pensare
come è abbastanza diffuso nell’immaginario popolare che i condannati fossero
pacifici cittadini adibiti a pratiche religiose del tutto innocue e le donne
delle pie sante devote accusate ingiustamente senza alcuna prova, non e’ affatto
la verità! essi erano in realtà colpevoli di praticare stregoneria e omicidi
rituali, basti pensare a quante donne improvvisate ”ostetriche” compivano aborti
fino alle ultime settimane di gravidanza per poi sacrificare i resti delle
povere creaturine in rituali satanici. Gli eretici spesso costituivano un
autentico pericolo per la pace sociale. Pensiamo ai Catari. Condannavano il
matrimonio, la famiglia e la procreazione. Per i Catari non bisognava comunicare
la vita, ma distruggere la famiglia, in poche parole: distruggere l’intera
società medievale, lottavano anche con violenza contro la Chiesa. Negavano il
valore del corpo, che consideravano prigione dell’anima. Questa soffre e si può
liberare solo sopprimendo il corpo. Talvolta praticavano il suicidio e
istigavano a compierlo, causavano rivolte e caos. I catari erano potenti e privi
di scrupoli. L’autorità civile non intendeva permettere che, a furia di vietare
la procreazione, l’umanità si estinguesse (tra l’altro, i catari proibivano il
giuramento, che era la base della società feudale). Ben pochi sanno tutto
questo. I settari sorvegliano attentamente e si affrettano ad intervenire perciò
onde soffocare ogni timido accenno (non oseremmo mai parlare di restaurazione
cattolica dopo il Vaticano II) di rievocazione della grandezza dell’Europa
medioevale: la Leggenda Nera dei secoli caliginosi e bui deve essere mantenuta e
un torrente di anatemi è scagliato ogniqualvolta si cerchi di metterla in
discussione. Eloquente in proposito un articolo comparso nel maggio 1990 sul New
York Times – testata giornalistica di proprietà della ricchissima famiglia
ebraica dei Sulzberger – a firma di Dominique Moisi, vicedirettore dell’IFRI,
l’Istituto per gli Affari Internazionali francese, intitolato: “Uno spettro
ossessiona l’Europa: il suo passato”. Vi si dice: “Disgraziatamente (ora che
l’Est si è liberato), nell’ombra esiste un’altra Europa, dominata da uno spirito
di ritorno alle sue cattive inclinazioni di un tempo, nei richiami alle nere
tentazioni della xenofobia, del razzismo e dello sciovinismo”. “[…] Noi non
dovremmo sognare di ricostruire un’Europa cristiana sulle ceneri del
mondo comunista o nei limiti di un certo capitalismo. L’Europa che Giovanni
Paolo II desidera è quella nella quale la maggioranza degli Europei non si
troverà molto a suo agio. La Chiesa – che storicamente è responsabile
dell’antisemitismo – non saprà offrire soluzioni a una nuova Europa; soltanto i
valori umanisti e le istituzioni democratiche sapranno farlo. O altrimenti il
muro di Berlino sarà caduto invano”. Non esiste, né può esistere, una società
che non si basi su un corpus strutturato di idee (chiamateli, se volete, valori,
princìpi, religione civile) e che non lo difenda se vuole continuare a
sussistere, ieri come oggi (basti pensare alle leggi sull’omofobia). (Il
corriere della sera equipara l’ISIS ai roghi dell’Inquisizione). Eh si, che
fortuna che abbiamo, i tempi sono cambiati, adesso non siamo più nel medioevo.
Oggi paghiamo il 50 per cento dei nostri introiti ai prestatori di capitale,
mentre nel medioevo il cittadino doveva solo la decima alla Chiesa o al
feudatario. Oggi si può liberamente bestemmiare senza vergogna, si può ostentare
con orgoglio il peccato, e si possono esigere diritti per i suoi perpetratori;
si possono aprire pagine blasfeme su Facebook (in linea con i termini della
community) create appositamente affinchè ognuno scriva la propria bestemmia
sulla pagina; si possono tranquillamente ammazzare i propri figli nel ventre
materno con la benedizione delle istituzioni e i soldi dei contribuenti; si può
tranquillamente essere iniziati al satanismo comodamente da casa; ci si può
arruolare tra i miliziani dell’ Isis con dei semplici click davanti ad un
computer… Un uomo senza radici, infatti, privo di riferimenti, senza terra,
senza uno scopo di vita diverso dal piacere e dall’accumulo di beni materiali
fine a se stesso, è esattamente il prototipo ricercato dai mondialisti, docile
burattino massificato, le cui pretese non travalicano il benessere biologico e
la cui visione del mondo – solo a prima vista ampia, essendo egli una specie di
apolide senza tradizioni. Che fortuna che abbiamo noi ad essere nati in una
società così moderna ecumenica e progressista!
LE BOLLE PAPALI CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO:
SIAMO SCHIAVI DAL 1302 D. C. LO SAPEVATE?
Il quaderno di Giorgio da Batiorco su Veja del 5
aprile 2013…Vivi libero…e fai le domande che non hanno risposta. Il Sistema
delle Bolle Papali costituisce storicamente il fondamento giuridico della nostra
attuale schiavitù finanziaria. Perché ha senso parlarne espressamente in questo
momento, in cui un papa ha appena annunciato le proprie dimissioni? Perché il
precedente storico dell’evento attuale, rappresentato di Celestino V, Papa che
fu costretto a dimettersi nel 1294, rappresenta l’inizio della storia che ci ha
condotto fino alla critica situazione che stiamo vivendo oggi. Facciamo un passo
indietro e vediamo come. Celestino V, che le note della ormai notoriamente
“addomesticatissima” Wikipedia ci fanno passare per uno sprovveduto ignorante,
era invece un papa che intendeva rivoluzionare la Chiesa basandola nuovamente su
un cristianesimo profondo. Per passare da un cristianesimo corrotto e di potere
– la “ecclesia carnalis” – ad un cristianesimo aperto, pieno di veri valori
spirituali sul modello del Cristo: l’ “ecclesia spiritualis”. Tuttavia la chiesa
di potere operò su più livelli per difendersi e bloccare l’opera di Celestino
Quinto. E il manovratore cardinal Caetani (stranamente via Caetani è la via in
cui fu trovato il corpo esanime di Aldo Moro, statista italiano che aveva osato
uscire dalle righe del controllo finanziario internazionale n.d.r.) lo indusse
alle dimissioni nel dicembre del 1296. Caetani poi, diventato Papa con il nome
di Bonifacio VIII, lo fece imprigionare ed infine uccidere con un chiodo
piantato nel cranio. La fine di Celestino Quinto e la conseguente fine dei
Templari qualche anno dopo, mutarono profondamente la chiesa, facendola
diventare solamente chiesa di potere e cancellando la gran parte delle correnti
autenticamente spirituali. A Bonifacio VIII, uno dei papi più oscuri e
controversi della storia, che Dante nell’inferno pone nella bolgia dei
Simoniaci, ossia i corrotti che fanno commercio di cose spirituali, si deve la
redazione della famosa bolla “Unam Sanctam Ecclesiam” che istituì il primo
fondamento giuridico dell’infame sistema che ora ci ha ridotto nella schiavitù
finanziaria di cui ognuno di noi, ogni santo giorno della nostra vita, si trova
a patire le vessazioni. Le tre Bolle e l’istituzione dei Trust. Le informazioni
che di qui in poi leggerete sono particolarmente dense e, dato che hanno il
potere di trasformare letteralmente la visione della realtà che viviamo, è bene
affrontarne la lettura con calma ed attenzione. Noi siamo qui essenzialmente in
veste di compilatori, altri prima di noi hanno fatto un egregio lavoro di
ricerca, sintesi e divulgazione. Il nostro compito nel momento attuale, è quello
di distribuire questi materiali in modo che quante più persone possibile abbiano
l’opportunità di comprendere che sotto l’apparenza più o meno rassicurante della
realtà che conosciamo c’è qualcosa di diverso, che difficilmente potremmo
immaginare.
LE BOLLE PAPALI CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO. La
lettura di questo articolo è impegnativa ma ha un’importanza vitale nella
comprensione del mondo occidentale moderno e dei fatti storici che lo hanno
portato allo status quo. Parla di come la legge universale del Libero
Arbitrio nel corso della storia sia stata sfruttata e distorta dalla forze del
Male per imprigionare ed asservire gli esseri umani. Se oggi le cose non vanno
come vorremmo, è perchè noi abbiamo dato il nostro consenso affinchè
accadessero, anche se non ne siamo consapevoli perchè questo ci è stato estorto
in malafede con l’inganno. Tutto ha avuto inizio il 18 novembre del 1302, la
data della pubblicazione della Bolla Papale di Papa Bonifacio VIII intitolata
“Unam Sanctam Ecclesiam” le cui ripercussioni storiche fanno ancora oggi in modo
che noi alla nascita diamo il nostro consenso per essere di fatto sfruttati come
schiavi per tutta la vita. Armatevi di pazienza e scoprirete come…Perché stiamo
diventando sempre più poveri? Perché siamo governati da un individuo non eletto
o nominato da altri (non eletti di nuovo), per tassarci e versare il nostro
denaro o valore equivalente direttamente nelle casse dei banchieri
internazionali privati? Perché anche l’Italia ha ceduto ogni sovranità nazionale
ad un gruppo di potere europeo privato? Perché questa bancarotta di tutte le
economie occidentali pianificata a tavolino dai primissimi anni ’30, viene fatta
col nostro consenso, di cui apparentemente non sappiamo nulla? La prima cosa da
fare è capire come ottengono o come hanno ottenuto il nostro consenso e perciò,
una volta compreso, saremo in grado di attuare una strategia per ritirarlo e per
spezzare definitivamente questo gioco al massacro. Cos’è questo consenso? Se non
partiamo da qui, prima di parlare di recupero della sovranità monetaria, di
elezioni democratiche e di riforme, siamo disarmati e non ne usciremo mai.
Qualsiasi cosa vorremmo o potremmo fare sarà inutile, inefficace, avremo già
perso in partenza. Perciò la seconda cosa su cui ragionare è: perché per il
potere mondiale chiamato anche Cabala nera è fondamentale il nostro consenso?
Perché costoro sanno benissimo che esiste una legge universale, una legge
suprema, che regola e domina tutto l’Universo, che va al di sopra di tutte le
possibili leggi umane, che è la legge del Libero Arbitrio.
LA STORIA DEL CONSENSO E LA LEGGE UNIVERSALE DEL
LIBERO ARBITRIO. Prima di parlare della storia dell’applicazione della legge del
Libero Arbitrio, facciamo qualche esempio di applicazione di questa legge
Universale, partendo da casi semplici, per arrivare a quelli che riguardano più
da vicino ognuno di noi quotidianamente. Se tu hai firmato un contratto di mutuo
con la banca, che poi ti porta via la casa in caso d’insolvenza, hai dato il tuo
consenso (= libero arbitrio) a quel contratto. Nessuno ti ha mai costretto. Se
poi ti rechi in tribunale per la causa di pignoramento e riconosci quegli organi
legislativi e quindi quei tribunali e così facendo li legittimi, hai dato il tuo
consenso (= libero arbitrio) a quelle legittimazioni. Quindi, in parole povere,
siamo noi a rinnovare il contratto con questo “sistema” ogni giorno, utilizzando
quei mezzi “impropri e fraudolenti” che loro ci hanno fatto credere, con un
ingegnoso mezzo-inganno, indispensabili. La prima reazione spontanea a queste
affermazioni è la seguente: tutta la nostra società funziona così e nessuno di
noi per vivere, lavorare, comprarsi la casa, la macchina, andare in vacanza,
sposarsi, fare dei figli, educarli e farli studiare potrebbe fare altrimenti. Ma
dunque è giusto, immediatamente dopo, chiedersi: “Perché funziona così?”
(Domanda che ci facciamo troppo poco, quando invece è la DOMANDA fondamentale da
farsi, ma siamo programmati per benino proprio per non farcela mai). Per
rispondere torniamo indietro di parecchi anni, secoli, millenni…Vi esorto a
leggere i libri e a guardare i video di Mauro Biglino, che ha tradotto
letteralmente dall’ebraico antico, con tanto di testo originale a fronte, tutto
l’Antico Testamento della Bibbia. Le sue traduzioni sono convalidate dagli
anziani delle comunità ebraiche e sono divenute incontrovertibili, perché
letterali e non interpretate. Con rivelazioni davvero, davvero, davvero,
davvero per menti… “aperte”. Nel nostro caso lo studio di ciò che viene
rivelato nella vera Bibbia, ci serve per capire l’importanza del “libero
arbitro” nei giochi di potere e del legame indissolubile che esiste tra diritto,
denaro, RELIGIONE E POLITICA. Questa incredibile scoperta, con la traduzione
letterale del testi, rivela la vera natura della Bibbia, che in realtà è
un Codice di Diritto Mercantile Marittimo, VALIDO, APPLICATO ANCORA OGGI,
pressoché inoppugnabile in qualsiasi tribunale del mondo. Si racconta, nelle
“cronache” dell’Antico testamento che il “dio” Jahvè (che si trova riportato in
altri testi come Jahwe, Yahweh, Yahveh… poi vedremo chi sia questo “dio” perché
non lo è affatto, ma nella traduzione “manipolata” diffusa dalla Chiesa è stato
tradotto come Dio) non può obbligare Mosè a seguirlo nel cammino per la Terra
Promessa (una conquista quindi, con la necessità di un piccolo esercito?). Jahvé
infatti non è “Dio”, ma è precisamente descritto come un ALTO E POTENTE “Eloah”
(da cui poi deriva il termine Allah). È quindi UNO DEI TANTI Elohìm (plurale di
Eloah), la stirpe che governava quei territori, forse discendente da un altro
pianeta (molto probabile, da verificare, ma non è essenziale per noi adesso…).
Una civiltà rappresentata da una gerarchia di individui di cui la Bibbia ci dà
conto quando distingue Elohìm, Malachìm, Nefilìm, Anakìm, Refaìm, Emìm,
Zamzummìm… Individui che si sono divisi il controllo del pianeta, come ci
narrano il Libro della Genesi ed il Deuteronomio, combattendo tra di loro per
affermare ed incrementare il loro potere utilizzando i popoli sottomessi. Sta di
fatto che di questi Elohìm ce n’erano tantissimi, appunto, sparpagliati sulla
Terra e organizzati in accampamenti (formati da due settori in genere, uno per
l’autorità, l’Eloah, e l’altro per le “truppe”…angeli fiammeggianti e dotati di
spada?). N.d.r – Conferma esatta di queste cronache si trovano anche nei testi
sumerici antecedenti alla Bibbia stessa. Questo Jahvè, anche se dotato di un
arma potentissima, che dalla dettagliatissima descrizione biblica sembrerebbe
un’arma al plasma (Arca dell’Alleanza?), capace d’incenerire ogni cosa, non
poteva comunque obbligare Mosè a seguirlo. Fu costretto perciò a stipulare
“un’alleanza” con il popolo ebraico, con delle regole e delle clausole precise
reciproche (io ti dò tanto, tu mi ridai tanto), tra le quali il sacrificio del
primogenito di ogni coppia ecc… di cui ormai sappiamo bene la “versione” che è
arrivata fino ai nostri giorni. Sempre nella Bibbia si racconta che quando
decisero quindi di seguire Jahvè e furono condotti alle porte della Terra
Promessa, si riunirono in assemblea per decidere se continuare a seguirlo o
meno, o se ritornare sotto i vecchi Elohìm, o se affidarsi ai nuovi Elohìm che
comandavano in questa nuova terra in cui erano arrivati. Questo era l’o.d.g
dell’assemblea. Così, ancora una volta col loro libero arbitrio decidono di
seguire Jahvè, che con la sua potentissima arma scatena la carneficina e
distrugge tutte le città che incontrano nel loro cammino, uccidendo uomini,
donne, vecchi e bambini (tra le quali Sodoma e Gomorra… e ci sono aneddoti
significativi sulla “scelta dei giusti” da salvare dalla distruzione da parte di
Jahvè e l’origine della circoncisione, oltre al mito negativo della
sodomizzazione praticata in quelle regioni). Tutta questa lunga premessa,
apparentemente divagatoria, oltre a segnalare una lettura diversa della Bibbia e
quindi delle nostre origini e della storia dell’Umanità, serve per definire
meglio la necessità del Potere di avere il consenso, perché possa perdurare e
agire. Ma serve soprattutto per porre le basi del primo legame indissolubile,
come dicevo, tra la legge del Libero Arbitrio, la religione, la politica,
il Codice di Diritto Mercantile Marittimo, il denaro e quel che viviamo oggi.
Ovviamente, come ogni regola e legge ha le proprie eccezioni, che in questo caso
sono i massimi livelli di “disonore” che l’umanità ha raggiunto nel disattendere
la legge del Libero Arbitrio:
– la riduzione in schiavitù degli africani, in
secoli abbastanza recenti, perché non hanno ricevuto il beneficio di essere
avvisati e quindi di scegliere che reazione avere (che è alla base di questa
legge, come abbiamo detto);
– senza andare troppo lontano, la strategia della
tensione, qui in Italia, negli anni di piombo, perché le stragi sono state fatte
in modo totalmente disonorevole.
Ma questo è il comportamento più autodistruttivo e
meno sostenibile che il potere possa compiere e l’élite lo sa benissimo. Perché
perfino il peggiore dei satanisti massoni, che si appresta ad effettuare un
sacrificio umano – la cosa più aberrante a cui noi umani comuni possiamo pensare
– è obbligato a seguire queste regole e quindi a scegliere la prima vittima che
si offre volontariamente, spinta da un’inspiegabile attrazione. Oppure, un
esercito che sta per invadere una nazione straniera è obbligato a dare un
avvertimento allo Stato che sta per mettere a ferro e fuoco, spiegando tutte le
proprie richieste. Il governo dello Stato assediato ha il libero arbitrio di
rispondere sì o no. Orribile o meno, c’è stato comunque un preavviso, quindi
l’onore è stato mantenuto. Abbiate pazienza, non stiamo divagando, tutto serve
per arrivare al punto focale, perché comprendere l’universalità della legge del
consenso, è alla base di ciò che viviamo oggi, e andando avanti sarà dimostrato
che l’élite mondiale dominante sta seguendo questa legge fin dall’inizio e la
mette in pratica in ogni momento e in ogni aspetto della nostra vita. Se non la
conoscessero così dettagliatamente e se non la seguissero così scrupolosamente,
il loro potere non sarebbe durato fino ad oggi. Ecco perché Jahvè aveva bisogno
del consenso per agire, ecco perché, i governanti oggi, ci fanno votare. Poiché
hanno quindi bisogno assoluto del nostro consenso, come fanno ad aggirare il
sistema (rendendolo però meno chiaro e decifrabile possibile) e a preservarlo
nei secoli? Hanno ideato un sistema perfetto che funziona secondo i principi
descritti precedentemente: “avvertimento” e “silenzio assenso”; se non mi
rispondi vuol dire che sei d’accordo e quindi peggio per te. Facciamo un esempio
banale che capita a tutti noi: quando la banca cambia le condizioni e lo fa
spessissimo, è obbligata a mandarti un documento di trasparenza bancaria –
avvertimento – che credo pochissimi di noi leggano (purtroppo!). Se tu non
rispondi è silenzio assenso. Tutta la storia del nostro mondo da millenni
funziona secondo questo principio.
LE LEGGI CANONICHE E LE BOLLE PAPALI. Per capire
come funziona questo principio, che regola la nostra intera vita abbiamo bisogno
di fare ulteriori premesse. Cosa sono le leggi? Tutte le leggi derivano da
Canoni, ovvero dal Diritto Canonico, perché tutte le leggi, direttamente o
indirettamente, hanno a che fare con la Legge Divina ed Ecclesiastica. Ma i
Canoni in particolare sono norme o principi che traggono valore dal fatto di non
essere mai stati contestati (tacito assenso). Ecco alcuni canoni, norme o
principi, universalmente riconosciuti, perché nessuno ha mai detto che non lo
debbano essere (molti sono per altro condivisibili perché sono alla base della
civile convivenza).
1) tutti debiti devono essere pagati;
2) tutti i contratti devono essere onorati;
3) tutte le controversie portate di fronte alla
legge, devono essere risolte di fronte alla legge (ovvero, se tu ricevi
un’accusa, per quanto infondata, per quanto ingiusta, per quanto immorale, per
quanto illegale non puoi ignorarla. E tuo l’onere di dimostrare l’infondatezza
di quella accusa davanti alla legge di fronte alla quale è stata portata);
4) qualsiasi affermazione, se non viene contestata
diventa valida. (Importantissimo punto! Ricevi una multa, una sanzione ingiusta,
viene fissata un’udienza e tu non ti presenti, cavoli tuoi, sarà chi di dovere a
decidere per te e senza di te).
• Nota al punto 4): il 99% delle procedure
giudiziarie si basa sulla presupposizione di qualcosa, ma il 99% degli esseri
umani non si preoccupa di comprendere quali siano queste presupposizioni, o non
si preoccupa di rifiutarle. In altre parole il Sistema è ancora adesso basato
sul sacramento della confessione, proprio come ai tempi dell’Inquisizione, cioè
è indispensabile che tu accusi te stesso. In mancanza di questo atto di auto
accusa non si può procedere. Il Diritto è gerarchico, discende sempre e comunque
dal Diritto Divino: sopra a tutto c’è il Diritto Divino che, come tale, discende
dal Divino Creatore, poi c’è il Diritto Naturale e poi il Diritto Positivo
(leggi nazionali, internazionali, amministrative, private ecc…), il Diritto
Positivo appartiene al gradino più basso nella scala gerarchica.
• Nota al punto 5): ogni proprietà costituisce un
diritto associato ad un trust, cioè ad un sistema fiduciario. I potenti, l’élite
mondiale, sanno da sempre che la proprietà è un concetto fittizio. Infatti come
puoi possedere un pezzo di terra?
La terra, i fiumi, i laghi, i mari appartengono al
Pianeta. Ma anche una casa; come puoi fisicamente possedere una casa o
un’automobile? Sono tutte cose per cui esistono “titoli di proprietà” e sono
titoli fittizi, costituiscono cioè diritto d’uso della casa, dell’automobile e
della terra finché sei vivo. Quando sarai morto, cosa succederà a quella casa, a
quell’automobile o a quel pezzo di terra, se non esistono disposizioni
testamentarie, non dipende più da te. Così la casa, intesa come muri, mattoni e
intonaco e la casa intesa come titolo e cioè come trust, o come sistema
fiduciario, sono quindi DUE COSE BEN DIVERSE. Il sistema fiduciario, il titolo,
prevede tre parti in gioco: un esecutore, un amministratore e un beneficiario.
L’esecutore è sempre quello che “concede il titolo” e in questo caso è sempre lo
Stato, l’amministratore è quello che amministra il titolo (catasto o Comune), il
beneficiario, in questo caso sei tu, cioè il cosiddetto “proprietario” di quel
bene. Fin qui tutto più o meno normale, è tutto chiaro e non c’è nulla di
strano; rimane da capire se e come, questo sistema, venga usato contro di noi.
Facciamo un enorme passo indietro nel tempo. L’attuale sistema, che è basato sul
concetto di proprietà, è stato creato dagli antichi romani, i quali hanno
disseminato il loro “diritto” in giro per il mondo e sappiamo come (è un karma
pesantissimo che noi “italici” dobbiamo espiare nei confronti di tutto il
mondo). Ogni terra conquistata e distrutta veniva iscritta in un “registro”
conservato a Roma e ogni nuova terra dell’Impero poteva essere di proprietà solo
di un cittadino romano. Ancora oggi quindi noi viviamo in un sistema che si
tramanda dall’esistenza dell’Impero Romano che di fatto, non è mai finito. Con
le invasioni longobarde, Papa Leone III, incorona Pipino il Breve come Re dei
Franchi e poi Carlo Magno come Imperatore del Sacro Romano Impero. Quindi il
sistema che abbiamo oggi nell’organizzazione della proprietà e del diritto e
quindi del denaro e quindi della politica, nasce nel 1302 (il 18 novembre), che
è la data della pubblicazione della Bolla Papale scritta da Papa Bonifacio VIII,
che aveva come titolo “UNAM SANCTAM ECCLESIAM”. Bonifacio VIII è considerato uno
degli uomini più corrotti, malvagi e potenti della storia della Chiesa e del
mondo, tanto che lo stesso Dante lo mette nei gironi più bassi dell’Inferno.
Questa Bolla Papale determina il primo sistema fiduciario ancora valido
oggi. Bonifacio VIII, in questa Bolla, afferma che Dio aveva affidato tutti i
titoli e le proprietà della Terra al Vaticano. Questa affermazione non venne mai
contestata e quindi, in base al punto 4) del Canone di Diritto (vedi sopra)
divenne valida. Il Vaticano perciò, nomina l’esecutore, l’amministratore e il
beneficiario di questo sistema fiduciario. L’Esecutore è l’Ordine Minore dei
Francescani unito con L’Ordine dei Gesuiti (braccio armato?) ed è ben visibile
nello stemma sulla pubblicazione dell’enciclica. L’amministratore è il Papa e i
beneficiari di questo trust sono tutti gli uomini del mondo. In pratica e
tradotto in altri termini, la Bolla Papale del 1302 usa la metafora del Diritto
Marittimo e dell’Ammiragliato (Bibbia) affermando che l’Unam Sanctam Ecclesiam e
quindi la Prima e Unica Santa Chiesa è l’Arca di Noè, perché mentre tutto il
mondo era sommerso dalle acque, l’unica cosa che si elevava al di sopra era
l’Arca. Quindi tutti gli esseri umani, a partire da quel giorno, certificato
dalla Bibbia come Codice di Diritto Nautico, sono dispersi in mare. E il Papa
dunque reclama tutta l’autorità, tutta la proprietà, sia spirituale che
temporale, fino a quando i “dispersi” torneranno a reclamare i loro diritti.
Cosa che finora, dal 1302, non è mai avvenuta, perché tutte le Nazioni si basano
su quel sistema giuridico. Questo Diritto proclamato da Papa Bonifacio VIII si
basa per Diritto Divino, ecco perché non possiamo parlare di politica senza
parlare di religione o di economia e finanza senza parlare di religione. Il
secondo trust, creato sempre in Vaticano, risale al 1455, cioè circa 150 dopo la
Bolla di Bonifacio VIII (quindi ancora mai contestata dopo 150 anni). Questa
seconda Bolla è di natura testamentaria, cioè il Papa dispone, al momento della
sua morte e della morte dei futuri Papi, come deve funzionare il diritto d’uso
di tutti i privilegi e di tutte le proprietà derivanti dalla Bolla precedente di
Bonifacio VIII. Testamento di cui l’esecutore è la Curia Romana,
l’amministratore è il Collegio dei Cardinali e il Beneficiario, questa volta è
il Re, sulla terra di proprietà del Papa. Quindi in due parole Dio ha dato tutto
il mondo al Papa e il Papa concede pezzi di questo mondo ai Re. Per cui da quel
momento i Re del mondo hanno un mandato divino. Questa enciclica del 1455 (l’8
gennaio) si chiama “ROMANUS PONTIFEX” e fu emanata da Papa Niccolò V. Cito un
breve estratto significativo: “Poiché abbiamo concesso precedentemente, con
altre lettere nostre, fra le altre cose, piena e completa facoltà al Re Alfonso
V di invadere, ricercare, catturare, conquistare, soggiogare tutti i Saraceni e
qualsiasi pagano e gli altri nemici di Cristo, ovunque essi vivano, insieme ai
loro regni e ducati, principati, signorie, possedimenti e qualsiasi bene, mobile
e immobile, che sia di loro proprietà e di gettarli in schiavitù perpetua e di
occupare, appropriarsi e volgere ad uso e profitto proprio, signorie,
possedimenti e beni, in conseguenza della garanzia data dalla suddetta
concessione, il Re Alfonso V (di Portogallo n.d.r), o il detto infante a suo
nome, hanno legittimamente e legalmente occupato isole, terre, porti , acque e
le hanno possedute e le posseggono e ad essi appartengono e sono di proprietà
“de jure” del medesimo Re Alfonso V e dei suoi successori, possono compiere e
compiano questa pia e bellissima opera, degna di essere ricordata in ogni tempo,
che noi essendo da essa favoriti per la salvezza delle anime e il diffondersi
della fede e la sconfitta dei suoi nemici, consideriamo un compito che concerne
Dio stesso, la sua fede, la Chiesa Universale, con tanta maggiore perfezione, in
quanto rimosso ogni ostacolo, diverranno consapevoli di essere fortificati dai
più grandi favori e privilegi concessi da noi e dalla Sede Apostolica.” Appena
30 anni dopo circa, nel 1481 (il 21 giugno), viene emanata la terza Bolla, il
terzo trust, o diritto fiduciario da Papa Sisto IV, chiamata “AETERNIS REGIS
CLEMENTIA”, che si diversifica dalla Bolla precedente di poco, in quanto il
“bene” concesso ai Re non è più la terra, ma sono gli esseri umani che abitano
quella terra, che da quel momento vengono considerati incompetenti, incapaci e
dunque soggetti ad amministrazione coatta. In realtà questa Bolla di Sisto IV
realizza la visione illuminata di Bonifacio VIII per cui gli esseri umani sono
dispersi in mare e quindi nulla ci appartiene, siamo in bancarotta, perché non
siamo mai tornati a reclamare i nostri averi e diritti e quindi è lo Stato che
si deve prendere cura di noi per il nostro bene. Questo è il sistema in vigore
ancora oggi. [piccola postilla: gli originali delle Bolle del 1302, del 1455 e
del 1481, non sono visibili, questo perché fino al XVIII secolo, il Vaticano
scriveva le proprie Bolle non su carta, considerata un mezzo privo di vita e
quindi privo di valore: a quei tempi (solo due secoli fa!) un documento per
essere valido doveva essere scritto su un materiale vivente. Era perciò firmato
con il sangue ed era scritto su una pergamena di pelle umana. Parentesi nella
parentesi: la recentissima firma della Regina Elisabetta del – criminale! –
trattato di Lisbona, è stata fatto su una pergamena di capretto, poiché la
Regina, come beneficiaria di un diritto divino, non può firmare un documento
“morto”. Non è tutto, la storia notifica, che le Bolle Papali erano scritte su
pergamene di pelle di bambini, questo spiegherebbe perché sarebbe imbarazzante
per il Vaticano mostrare gli originali.] Approfitto di questa piccola
interruzione del racconto per sottolineare che non c’è nessun riferimento
negativo a tutte le persone di Buon Cuore (con la B e C maiuscole!) che seguono
e vivono secondo l’etica giusta e generosa della Chiesa Cattolica. Il
riferimento semmai è solo rivolto a quella “setta” che gestisce il mondo
all’interno della Città del Vaticano. E sarebbe importante invitare i Veri
Cristiani che si riconoscono in un Dio giusto e misericordioso, a pretendere,
indagare e far luce su quello che avviene all’interno di quelle mura.
Altrimenti, davvero, non ne usciremo mai!
COSA SIAMO NOI E COSA È LA REPUBBLICA ITALIANA.
Nel 1933 c’è stata la peggiore bancarotta concordata, ormai famigerata: furono
azzerati i debiti e fu anche proibito il possesso dell’oro da parte dei privati
(vi ricordate “l’oro alla patria”?) e gli Stati hanno conferito tutto il proprio
oro, insieme a quello confiscato e raccolto, in un unico fondo globale, per
custodire il quale è stata fondata la BIS, Bank for International Settlements
(Banca per le Transazioni Internazionali) — che darà il via ad un’altra
sconcertante storia, come il Sukarno Trust e le denunce attualissime tuttora in
corso alla Federal Reserve, (ma ora non è il caso di parlarne, altrimenti
rischiamo di mettere troppa carne al fuoco) — che ha sede a Basilea, in Svizzera
e fu fondata e controllata dai Gesuiti e dai Cavalieri di Malta. Come per tutto
il resto, è facilmente verificabile e certificato, sempre per la legge del
Libero Arbitrio. Vi esorto a fare tutte le verifiche possibili e se vi va anche
a fare ricerche su quel che sta succedendo con il fondo di oro globale e le
richieste di risarcimento alla Federal Reserve. Ma, sempre nel 1933 (udite,
udite!) le Nazioni diventano Società di Diritto Privato, registrate presso la
SEC (Security Exchange Commission) con sede a Washington D.C., che è
l’equivalente della nostra CONSOB (organismo che controlla la Borsa). Queste
Società di Diritto Privato chiamate Nazioni, apparentemente pubbliche e
repubbliche, ma in realtà privatissime, in base alle tre Bolle
Papali, possiedono oggi il DIRITTO DI PROPRIETÁ sulle persone nate in quello
stato. La prima istintiva reazione è: non l’Italia! Che è una Repubblica fondata
sul lavoro e che ha la sua meravigliosa Costituzione! Purtroppo invece è vero.
Andate a controllare voi stessi (cliccate qui → www.sec.gov): c’è la
registrazione e il numero di registrazione di “ITALY REPUBLIC OF” – Company
Registration Number 0000052782, con tanto di documenti di quotazioni di borsa,
cessioni di quote ecc…Il “Business Address è: “Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Via XX Settembre, 97 – Roma” e il mailing Address è: “C/O Studio
Legale Bisconti, Via A. Salandra, 18 – Roma”. Quindi l’Italia NON è una
Repubblica libera e pubblica, ma una Private Company e lo Stato possiede il
diritto di proprietà delle persone (noi tutti) nate sul suo territorio. Ma
abbiamo detto che la proprietà costituisce un diritto associato ad un trust, un
atto fiduciario. Perché i potenti sanno che la proprietà è un concetto fittizio
e quindi anche le persone puoi possederle solo con un titolo di proprietà che
conferisca il diritto d’uso. Al momento della tua nascita, senza avvisarti, è
stato creato un trust, cioè un sistema fiduciario, che ha per oggetto la tua
esistenza in vita. E i tuoi genitori hanno avvallato e firmato questo trust (io
ho tre figli e mi sento morire per averlo fatto tre volte!) senza essere stati
avvisati. Infatti è proprio negli anni ’30 che diventa obbligatorio, guarda
caso, registrare le nascite, appropriandosi così del consenso, anche se in
questo caso senza essere stati doverosamente “avvisati”. Ecco perché questo
sistema è, in parte, fraudolento. In realtà il Certificato di Nascita è un
avvertimento, perché è la costituzione di una personalità fittizia, che non
appartiene a te, ma a loro. Infatti se erroneamente si potesse pensare che il
Certificato di Nascita appartenga a noi, basterebbe provare ad andare in una
qualsiasi anagrafe di competenza a chiederne l’originale: possiamo averne una
copia, un estratto, ma MAI l’originale. Come a dire che dal momento della
creazione del Certificato di Nascita esistono due entità (ricordate la casa di
mattoni e il titolo di proprietà su quella casa che ha bisogno di un esecutore,
di un amministratore e di un beneficiario?), che sono l’essere umano in carne ed
ossa e la persona, cioè un intermediario fittizio o una finzione giuridica,
quindi un trust. Questo trust è creato secondo le Leggi Marittime e
dell’Ammiragliato (Bibbia) che trascendono sempre le leggi delle varie nazioni e
che è la giurisprudenza segreta dei potenti e dell’élite. Di questo trust che
viene creato al momento della nascita, sulla tua esistenza in vita, l’esecutore
è sempre un organo dello Stato, ma chi è il beneficiario di questo certificato
di nascita? È la Società di Diritto Privato chiamata Repubblica Italiana
(un’azienda quindi). Ma beneficiario di cosa? È beneficiario di un bond, di un
titolo di possesso, o di una quota societaria che attualmente viene stimato
approssimativamente intorno ai 2 milioni di dollari. In pratica lo Stato
Italiano crea alla tua nascita due milioni di dollari a mezzo di un bond o
titolo e il collaterale di questo bond è la tua esistenza in vita, che
significa: produttività, forza lavoro (sempre meno pagata e tutelata così ci
guadagnano di più), valore reale! L’equivalenza perversa è: nascita = creazione
di un bond e di denaro fittizio = collaterale la tua esistenza in vita e quindi
il tuo futuro lavoro (pagato pochissimo se possibile e come stanno evidentemente
facendo) = schiavitù! Il “tuo bond” è depositato alla S.E.C, come security, o
titolo fiduciario ed entra a far parte del patrimonio di quella Private Company
registrata in modo ingannevole come Repubblica Italiana. Per favore verificate
tutto ciò che vi è stato detto, bastano pochi secondi su Google. Ma manca ancora
la terza parte per dar vita a questa finzione
giuridica: l’amministratore, quello che per contratto (trust o certificato di
nascita in questo caso) si accolla l’obbligo di prendersi cura del “bene”. Chi è
che ha questo ruolo? Ogni qual volta, qualsiasi autorità (dal vigile urbano, al
giudice della Corte Costituzionale) ti domanda “è lei Pinco Pallino?” e tu
rispondi “sì”, in quel preciso momento ti sei autonominato amministratore di
quel trust. Sei quindi caduto nel tranello in cui ti hanno messo fin dalla
nascita, perché nella finzione hanno bisogno che tu ti creda l’amministratore di
quella “esistenza in vita”, nella realtà invece, tu e quel trust che porta il
tuo nome siete due entità completamente distinte e separate. L’essere umano in
carne ed ossa si scrive con le iniziali maiuscole e le altre lettere minuscole
(come ci hanno sempre insegnato anche a scuola), la persona giuridica invece,
fittizia, si scrive con tutte le LETTERE MAIUSCOLE. Controllate tutti i vostri
documenti d’identità, le comunicazioni bancarie, le notifiche erariali, il
tesserino sanitario ecc…Se provaste ad andare per esempio in banca e chiedeste
all’impiegato di scrivere il vostro nome con le iniziali maiuscole e il resto
minuscolo, se è un ignorantone ci proverà, ma sarà costretto a rispondervi che è
impossibile perché il “sistema” non lo permette. Quindi, ricapitolando: se il
99% del diritto è basato sulla presupposizione, si presuppone che qualcosa sia
vero e nessuno mette in discussione quella presupposizione perché il sistema è
ancora basato sul meccanismo della “confessione”, esattamente come ai tempi
dell’Inquisizione; per funzionare il sistema ha bisogno che tu accusi te stesso
e quindi tutto è basato sul tuo consenso, sul tuo libero arbitrio! È necessario
infatti che tu accusi te stesso, ma di cosa? Del “peccato originale”. E che
cos’è? La frode! L’utilizzo del nome che non ti appartiene, quel nome che da
quando sei nato è stato scritto a lettere maiuscole e che è una proprietà
intellettuale dello Stato, che ti ha messo in condizioni di usare
fraudolentemente. Nel momento in cui lo usi dichiari: che sei nato privo di
diritti, che sei in bancarotta, perché la tua vita, il tuo nome e la tua
esistenza sono gestiti da altri che non sei tu; sei, perciò, da quando sei nato,
in un regime di amministrazione controllata, dove il tuo nome non appartiene a
te ma ad altri. Ma è ancora peggio di così! Secondo il Codice dell’Ammiragliato,
o Codice Marittimo (Bibbia), sei nato disperso in mare, perché questo dicono le
Bolle Papali, sulle quali si basa tutto il sistema; tu, al momento della nascita
e attraverso il canale uterino, sei caduto in acqua e sei disperso in mare e non
sei mai riuscito a raggiungere la terra ferma, in modo da poterti alzare in
piedi e affermare “io sono un essere umano libero davanti a Dio”. Poiché le
Bolle Papali si giustificano secondo mandato divino. Perché sono loro che usano
la parola Dio, sono loro che hanno chiamato in causa Dio, sono loro che hanno
tradotto la Bibbia con il termine Dio, che originariamente non viene mai
citato (a proposito la Bibbia diventa Codice di Diritto Nautico sostituendo la
parola “peccato” con “debito” n.d.r). Il diritto quindi è sempre di provenienza
divina, noi siamo perciò creature “divine” (vedi. vera traduzione della Bibbia)
e loro lo sanno benissimo; non possono quindi creare un diritto fittizio, hanno
assoluto bisogno di far discendere il loro diritto da Dio. Quindi loro usano
questo Dio (diritto) e se tu usi il loro stesso Dio, ti sei autodefinito
incapace, disperso, senza diritti. Pensate la perversione, se tu utilizzi quello
che loro ti hanno detto, imposto di utilizzare, dichiari e confermi di essere
incapace di prenderti cura di te stesso. Quindi, ricapitoliamo: usano una
Società di Diritto Privato, quotata, fingono che sia uno Stato, un ente
pubblico, in realtà è privatissimo, e lo usano per fare business (quattrini,
denaro, profitto! E ci chiedono anche di pagare le tasse per mantenere una
Società di Diritto Privato che non è nostra!) attraverso la tua esistenza,
oggetto di quell’entità fittizia scritta tutta a lettere maiuscole, quotata alla
S.E.C. di Washington D.C. Il concetto è, quindi, che se tu accetti questo
presupposto, ti autodefinisci incapace, bisognoso di essere amministrato in modo
coatto, perché oltre ad essere disperso in mare, quindi senza diritti e in
bancarotta (non hai mai reclamato ciò che è tuo), non sai neanche chi sei! Per
assurdo, ogni autorità, infatti, deve chiederti chi sei, altrimenti non ti può
toccare nemmeno con un dito. Non avrebbe la giurisdizione per farlo (si parla di
diritto amministrativo, tributario, civile ecc… se uccidi qualcuno, quindi
codice penale, è un po’ diverso, ma non troppo…). I nostri tribunali infatti
sono tribunali di diritto privato, quindi tribunali aziendali! Stessa cosa vale
per il denaro, le banconote “euro”: siamo stati avvertiti, sopra c’è scritto
“proprietà della Banca Centrale Europea”, non è nostro è della BCE, ma se noi
accettiamo di usarlo, come per il nome fittizio, ci autoproclamiamo incapaci e
incompetenti ai loro occhi (disperso in mare, ecc…). Hanno creato quindi un
sistema di governo chiamato Cosa Pubblica, che invece è privatissima, che
include partiti, Parlamento, Governo, elezioni e se tu accetti di partecipare a
questo gioco ti autodefinisci di nuovo incapace e incompetente (disperso in
mare, ecc…), bisognoso di amministrazione coatta. A fronte di questo lungo e,
immagino sconvolgente racconto per molti di voi, la prima riflessione è: Come
facciamo a cambiare in meglio una cosa che non ci appartiene affatto? Ma del
resto il nostro inconscio ce lo dice, nelle ultime amministrative ha votato il
50% degli aventi diritto; una persona su due considera offensivo per la propria
intelligenza andare a votare. Quindi a questo punto, se è tutto chiaro, gli
interrogativi sono solo due:
1. Cosa possiamo fare per sottrarre il nostro
consenso a questa frode che ci vede protagonisti “involontari” fin da quando
siamo nati? “Cosa possiamo fare” comprende il salvare il salvabile, dai
pignoramenti per esempio, da Equitalia, perché non siamo noi, persona fisica in
carne ed ossa a dover pagare le tasse, ma è l’entità fittizia che noi
legittimiamo nel momento che la usiamo fraudolentemente (lettere maiuscole).
Quindi, in modo individuale possiamo utilizzare noi le loro stesse leggi, Codice
Nautico e dell’Ammiragliato (Bibbia) in maniera tale che siano loro a cadere in
disonore? Conoscendo la legge possiamo fare qualcosa?
2. Cosa possiamo fare invece collettivamente per
creare un’alternativa a questo sistema marcio, fraudolento che è stato creato a
loro favore a nostro totale sfavore? Come possiamo modificarlo se non ci
appartiene? Intanto, mentre ci pensiamo, possiamo soltanto smettere di
partecipare. Concludendo, i nodi cruciali sono due: il denaro e come si prendono
le decisioni, che è sinonimo di politica. Ma c’è un punto in più che è diventato
chiarissimo: non si possono trattare separatamente denaro (economia, finanza,
crisi ecc…), la politica, cioè il modo in cui si prendono le decisioni, la
religione e il diritto, perché per i potenti, l’élite, sono la stessa identica
cosa.
INDIANI D’AMERICA: “NOI NON DERIVIAMO
DALLE SCIMMIE, MA DALLE PLEIADI…” Articolo di Bisonte
Che Corre (Enzo Braschi) su “Il Mondo alla rovescia” del 31 maggio, 2016. Gli
Indiani e la Conoscenza perduta sulle origini dell’uomo a causa dei
colonizzatori criminali europei. I Cherokee (Ani Yonwiyah) ovvero “Il popolo
capo” è antico come le pietre. “Ne ho conosciuti alcuni – biondi e con gli occhi
azzurri – durante la "Danza del Sole" del 1998, nella Riserva dei Lakota Sicangu
di Rosebud, in Sud Dakota. Erano un padre e due figli”. “Sembrate inglesi,
scozzesi, non so… ” dissi, “ma non Cherokee”. I tre risero: “Veniamo da
Atlantide, e prima ancora dalle Pleiadi.” “Raccontami” dissi. Il ragazzo spiegò:
“La nostra lingua, la sua radice originaria, oggi parlata da un’esigua minoranza
di ultra ottantenni, si chiama Elati. Io non la so parlare, qualcuno ancora la
ricorda, ma contiamo quel qualcuno sulla punta delle dita. Si tratta di suoni
crescenti e decrescenti che vengono pronunciati senza quasi muovere la bocca.
Ciò che ne scaturisce possiede una bellezza e una musicalità del tutto
particolari, considerato che si tratta di una lingua gutturale”. “Più che di
parole si deve parlare di suoni di potere che racchiudono una forte energia
spirituale. Per i Cherokee parlare significa infatti essere più che comunicare.
Questa lingua, Elati, è detto "il linguaggio degli Antenati" o "il linguaggio
delle Stelle", un modo di esprimersi che i vecchi uomini sacri della nostra
gente consideravano provenire da lassù, dall’alto. La tradizione orale della
tribù puntualizza infatti che i Cherokee arrivarono sulla Terra 250.000 anni fa
dalle Pleiadi, che nella nostra antica lingua vuole dire per l’appunto
Antenati.” “A tal proposito vorrei precisare che l’uomo non discende affatto
dalla scimmia ma dal Popolo delle Stelle. Nella cosmologia cherokee, la Terra è
detta il Pianeta dei Bambini, ovvero il Pianeta dei Figli delle Stelle.” “Il
sapere della nostra antica Società dei Capelli Intrecciati ha inizio al tempo in
cui esistevano dodici pianeti abitati da esseri umani, i cui progenitori si
riunivano su un pianeta chiamato Osiriaconwiya, vale a dire il quarto pianeta
della costellazione del Cane Maggiore, cioè Sirio. Su quel pianeta grandi
sapienti si trovarono un giorno a discutere delle sorti dell’Ava Terra, la
nostra terra, detta in lingua cherokee Eheytoma, il pianeta dei figli, ovvero il
tredicesimo pianeta”. “Poiché il nostro mondo era il meno evoluto rispetto agli
altri, quei dotti stabilirono di trasferire tutta la loro conoscenza all’interno
di dodici teschi di cristallo, che chiamarono Arca di Osiriaconwiya, che
portarono sulla nostra Terra, affinché un giorno potessimo consultarli e sapere
tutto delle nostre vere origini”. “I nostri avi fecero di più: aiutarono infatti
i loro figli a fondare quattro civiltà: Lemuria, Mu, Mieyhun e Atlantide,
servendosi della conoscenza dei teschi, per dare avvio alle grandi scuole del
mistero, veri centri di sapienza arcana, e alle segrete società di medicina.”
“Queste informazioni giunsero circa 750.000 anni fa e cominciarono a diffondersi
sul nostro pianeta tra i 250 e i 300.000 anni fa. I dodici teschi corrispondenti
ai dodici pianeti, venivano sistemati in cerchio attorno a un tredicesimo
teschio di ametista di dimensioni più grandi, che raccoglieva la consapevolezza
collettiva di tutti quei mondi”. Ma poi…arrivarono Cortès e i suoi assassini (i
nostri antenati europei) che interruppero lo sviluppo della conoscenza. “Coloro
che furono incaricati di compiere il viaggio sulla Terra per farci dono dei
teschi di cristallo furono detti Olmechi. Questi passarono quella conoscenza ai
Maya, quindi agli Aztechi e infine ai Cheorkee e a tutti gli altri indiani del
Nord America. Pare che l’Arca si trovasse ancora a Teotihuacan, allorché
arrivarono Cortès e i suoi assassini che interruppero lo sviluppo della
conoscenza” concluse il Cherokee. La cosa non sembra essere priva di fondamento:
risulta infatti che Cortès venne a conoscenza di qualcosa di potentemente
misterioso e che arrivò quasi a impossessarsi dell’Arca, grazie all’aiuto di un
traditore; ma i sacerdoti giaguaro e i guerrieri aquila riuscirono a trarla in
salvo. Alcuni teschi di cristallo vennero nascosti in America Meridionale, altri
andarono dispersi nel mondo. La Terra attenderebbe che la conoscenza sia
finalmente svelata al genere umano attraverso la riunione dei tredici teschi di
cristallo. Secondo i Lakota Sioux, la Prima Sacra Pipa fu portata loro in tempo
remoto da Ptesan Win, “Donna Bisonte Bianco”, una donna proveniente dal cielo,
probabilmente dalle Pleaidi. Tayamni è il nome che i Lakota danno a una
costellazione che equivale a un bisonte bianco nel cielo. Tayamni è infatti
formato dalle Pleiadi come testa, le tre stelle della cintura di Orione come
spina dorsale, le stelle Betelgeuse e Rigel come costole, e Sirio come coda.
Unendo tutti questi punti, in cielo si forma l’immagine di un bianco
bisonte…Miti, favole. Miti e favole come sempre, vero? Ma certo. A proposito di
“fantascienza”… perché non vi riguardate l’ultimo film di Indiana Jones relativo
ai tredici teschi di cristallo? Fantasia, miti e favole come sempre. Ma la NASA
e il potere occulto amano la fantascienza, vi pare?
Un Mondo Impossibile ..."“Contra factum non valet
argumentum”. Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac
Newton. In questo blog si vuole commentare ed analizzare l'attualità e la storia
ma sopratutto scoprire ed evidenziare le ipocrisie, le falsità ed i soprusi di
questo mondo appunto ormai impossibile da vivere, scrive martedì 19 gennaio 2016
Arturo Navone su “Un Mondo Impossibile”. “La storia ha due volti: quello
ufficiale, mendace e quello segreto e imbarazzante, in cui però sono da
ricercarsi le vere cause degli avvenimenti occorsi”. Honorè de Balzac.
Propaganda, Stereotipi e Lavaggio del Cervello, l'Allontanamento dalla Soluzione
e come Ritrovarla. Carl Gustav Jung e gli Indiani d'america ... Il delirante
percorso della civiltà occidentale e dell'uomo bianco come è noto ha causato
danni incalcolabili, dove sempre per interessi reconditi ma sempre più chiari ci
viene raccontato che siamo vicini al punto di non ritorno che nulla si può fare.
E' un chiaro esempio di propaganda e lavaggio del cervello, che ho già
evidenziato in altri articoli, studiato a tavolino che aggiunto a degli
stereotipi fa il gioco di chi ora lasciamo comandare. Un esempio ne sono proprio
i pellerossa che ci han voluto far credere essere dei demoni quando invece lo
eravamo noi, è il nostro mondo, quello che è nero lo dipingono per bianco e
viceversa, con l'uso poi dei vari sistemi ormai fin troppo conosciuti, cinema,
televisione, media, opinionisti, influencer, pubblicità e messaggi subliminali
ti incatenano la menzogna alla coscienza, ne viene poi difficile venirne fuori,
ci sono degli esempi incredibili, filmati dove le vittime sono poi finite ad
essere i carnefici, le montagne di morti non hanno la targa di circolazione, poi
l'ha detto "la televisione", le immagini dei cadaveri del popolo X uccisi da Y
li han rappresentati come morti di Z et voilà X erano i criminali e Y e Z santi
e martiri, poi un X si vede in un documentario rieducativo in un posto che
nemmeno sapeva esistesse perchè in effetti così come era stato rappresentato non
esisteva, non stò nemmeno a dire i protagonisti è fin troppo evidente per chi ha
occhi, orecchie e soprattutto cervello .... pochi ma così è la vita. Questo
scritto era iniziato con un altro intento poi cammin facendo si è evoluto,
andremo a vedere come quelli che crediamo "barbari" non lo siano affatto e che
la soluzione l'hanno sempre culturalmente avuta, abbiamo cercato di distruggerli
ma ora gioco forza cerchiamo di recuperare ciò che è l'unica salvezza ...Il noto
psicologo Carl Gustav Jung, nel suo scritto Ricordi, sogni, riflessioni racconta
di un suo incontro con un capo pellerossa Taos Pueblos mentre era alla ricerca
della propria ombra. La conversazione che ne seguì è significativa per
comprendere i nostri condizionamenti culturali. «Vedi - diceva il capo indiano -
i bianchi vogliono sempre qualcosa, sono sempre scontenti, irrequieti. Noi non
sappiamo cosa vogliono. Non riusciamo a capirli. Pensiamo che sono pazzi». Jung
chiese a questo capo perché mai pensasse che l’uomo bianco fosse pazzo. E
l’indiano gli rispose, mostrando tutta la sua meraviglia: «Dicono di pensare con
la testa!». «Ma certamente pensano con la testa! – disse Jung - E tu, con cosa
pensi?». E lui: «Noi pensiamo qui!», disse, indicando con la mano il cuore. E
Jung conclude: «Mi immersi in una lunga meditazione. Per la prima volta nella
mia vita, così mi sembrava, qualcuno mi aveva tratteggiato l’immagine del vero
uomo bianco. Era come se, fino a quel momento, non avessi visto altro che stampe
colorate, abbellite dal sentimento. Quell’indiano aveva centrato il nostro punto
debole. Aveva svelato una verità, alla quale siamo ciechi»."il mondo dell'Uomo
bianco è Koyaanisqatsi, un Mondo Disarmonico, privo di equilibrio, un Mondo
malato al quale la saggezza degli Indiani d'America può arrecare
giovamento, affinchè l'Uomo Bianco possa vivere le stagioni.....nel cuore della
vita...in armonia con sè stesso e la Natura!!!!!" Nella cultura indiana il
percorso di risanamento dell’anima ha delle tappe ben precise che devono essere
rispettate: innanzitutto le quattro direzioni dei punti cardinali e, poi, il
rapporto con la terra come madre dell’universo e con il cielo come dimora degli
spiriti. Il processo si completa nel cerchio sacro, una forma che diventa il
simbolo dell’armonia tra gli uomini e ciò che li circonda. Questo viaggio senza
fine, perché il miglioramento fisico, emotivo, mentale e spirituale non può mai
essere completato, è lo scopo dell’esistenza di ogni Indiano, qualunque sia il
gruppo tribale d’appartenenza. Le quattrocento nazioni originarie del continente
nordamericano erano caratterizzate da differenze marcatissime a livello
geografico, sociale, linguistico e culturale. I Lakota-Sioux si muovevano
liberamente nel grande oceano d’erba, le praterie e pianure sconfinate che si
estendevano dalla Valle del Mississippi alle Montagne Rocciose. Erano nomadi
che, spostando le proprie tende (tepee), seguivano le migrazioni del bisonte in
cerca di nuovi pascoli. Gli Zuni e gli Hopi, stanziati nell’arida terra del
sud-ovest americano, ricavarono le loro case dal deserto. I Cherokee praticavano
l’agricoltura. Avevano un sistema sociale preciso basato su principi democratici
e si organizzarono in insediamenti piuttosto ampi. Gli Tsimshian vivevano sulle
coste nordoccidentali del Canada. I Chippewa e i Wintu appartenevano al gruppo
degli Indiani dei boschi. Ma un filo comune emerge dalle loro parole, dal
ricchissimo patrimonio orale di canti, miti, leggende, narrazioni sacre e
profane: la consapevolezza che la Terra è madre e deve essere rispettata. La
meta di questa avventura spirituale è la comprensione che l’uomo è parte
integrante di un cerchio che comprende le piante, gli animali, i minerali, la
Terra, il Cielo, l’acqua, le stelle, la notte e il giorno, la Luna e il Sole. Il
corpo umano è tutt’uno con la terra che lo nutre e lo sostiene: «Noi siamo la
terra. Noi le apparteniamo. Noi siamo una parte della terra e la terra fa parte
di noi. I fiori profumati sono nostri fratelli. Il cervo, il cavallo, la grande
aquila sono nostri fratelli. Le coste rocciose, il verde dei prati, il calore
dei pony e l’uomo appartengono tutti alla stessa famiglia». Non c’è separazione
tra mondo naturale e mondo umano. L’uomo non è il Signore del Creato e il mondo
non è a suo beneficio. Ogni creatura ha un eguale diritto all’esistenza e merita
rispetto semplicemente perché è viva. Il ritmo della natura porta la salute,
l’equilibrio, l’armonia la bellezza. Il ciclo annuale delle stagioni è garanzia
di ordine e di benessere: il tepore primaverile verrà sempre a riscattare il
gelo invernale. Non bisogna spezzare il fluire del cielo naturale, altrimenti ne
deriveranno malattia, paura, incubi e insicurezza. La natura batte il tempo, il
suo orologio regola la vita del pianeta e dell’uomo. L’uomo non stabilisce
quindi solamente un rapporto equilibrato con la natura ma arriva a conoscere se
stesso grazie a questa armonia. Joseph Bruhac ci racconta una storia che
riassume questo viaggio interiore: «Dopo che Wakan Tanka, il Grande Spirito,
ebbe messo in ordine le altre sei direzioni, l’est, il sud, l’ovest, il nord, il
cielo e la terra, restava sempre una direzione senza destinazione. Ma poiché la
settima direzione era la più potente di tutte, in quanto racchiudeva la saggezza
e la forza più grandi, Wakan Tanka, il Grande Spirito, desiderò metterla in un
luogo dove non sarebbe stato facile trovarla. Ecco perché la nascose nell’ultimo
posto dove gli uomini generalmente pensano di guardare: nel loro
cuore». Nonostante siano stati privati della propria terra, della propria
cultura e della propria identità, gli Indiani d’America sono riusciti a
trasmettere la loro fede in questo modo di vivere. Hanno parlato con il cuore,
di padre in figlio, per indicare il sentiero che porta alla rigenerazione e la
loro voce è rimasta. Anche con queste parole: Accanto alla montagna, spianato
dai nostri passi, il terreno del campo risuona. Ti dice: la terra è un tamburo,
pensaci. Noi, per seguirne il ritmo, dobbiamo fare attenzione ai nostri passi.
I DIECI COMANDAMENTI INDIANI:
La Terra è la nostra Madre, abbi cura di Lei.
Onora (rispetta) tutti i tuoi parenti.
Apri il tuo cuore ed il tuo Spirito al Grande
Spirito.
Tutta la vita è sacra, tratta tutti gli esseri con
rispetto.
Prendi dalla Terra solo ciò che è necessario e
niente di più.
Fai ciò che bisogna fare per il bene di tutti.
Ringrazia costantemente il Grande Spirito per ogni
giorno nuovo.
Devi dire sempre la verità, ma soltanto per il
bene degli altri.
Segui i ritmi della natura, alzati e ritirati con
il sole.
Gioisci nel viaggio della vita senza lasciare
orme.
Trovo delle straordinarie similitudini con la
fisica quantistica e le filosofie orientali, se una cosa la trovi in più culture
e studi è inequivocabilmente segno che è la strada giusta, personalmente credo
che la grandezza di Jung sia anche provata dalla capacità di aprirsi allo studio
delle altre culture, prova ne è che la coscienza collettiva, la sincronicità
quindi, è trattata anche nella Bhagavad gītā, testo millenario, sacro indù.
L’amore è un concetto estensibile che va dal cielo all’inferno, riunisce in sé
il bene e il male, il sublime e l’infinito.
Incontro Occidente-Oriente di Mario Thanavaro.
Tratto da “Spiritualità Olistica” (Venexia Editore). “E’ giunto il momento in
cui dobbiamo lasciar cadere questa divisione tra esterno e interno, tra ciò che
è inferiore e ciò che è superiore, tra la mano destra e la mano sinistra.
Dobbiamo lasciar perdere questa divisione fra l’uomo e la donna, fra l’Oriente e
l’Occidente. Dobbiamo creare un essere umano integro, abile in entrambe le
dimensioni”. Osho Rajneesh. Il principio dei vasi comunicanti afferma che quando
in un’area si crea il vuoto e in un’altra c’è il pieno, il travaso dal pieno
verso il vuoto si produce inevitabilmente. Viviamo oggi in un’epoca
straordinaria, il grande progresso tecnologico ci ha dato i mezzi e gli
strumenti per spostarci da una parte all’altra del pianeta, permettendoci di
entrare in contatto con altre etnie, tradizioni e culture. Tutto il mondo ci
entra in casa via satellite grazie al piccolo e al grande schermo e questo ci
consente di analizzare la grande diversità tra le varie culture, la diversità
della loro organizzazione socio-politica ed economica. Con la scienza e la
tecnologia abbiamo assistito al prevalere della secolarizzazione e del
modernismo sulle antiche istituzioni religiose, ma lo sviluppo tecnologico ha
preso la direzione di uno sconsiderato utilitarismo senza riguardo ai valori e
ai diritti umani, accentuando la disparità tra nazioni, popoli e culture. Per
quanto la tecnologia ci dia l’impressione di essere vicini l’uno, le leggi di
mercato ci impongono il Super Dollaro come sola unità di misura valida nel
quantificare il valore di un individuo o di un popolo. La grande famiglia umana
è stata inesorabilmente divisa in ricchi e poveri, e i grandi flussi migratori,
oggi come in passato, sono la risposta spontanea della natura che tende al
riequilibrio. Il problema demografico ed economico spinge i Paesi più poveri
verso l’Occidente, il quale, da sempre in contatto con altre civiltà, prima con
i grandi viaggi e scoperte poi con il colonialismo, ha fatto delle fortune degli
altri Paesi la sua fonte di ricchezza. Il primo contatto con l’Oriente risale al
principio dell’800 e avviene sul piano ideologico dell’intellettualismo
filosofico e religioso. A quel periodo risalgono le prime traduzioni degli
antichi testi sacri dell’India, i Veda, le Upanishad e il canone buddhista. Già
da quei primi approcci risultò evidente la grandezza del messaggio spirituale
dell’Oriente, per molti versi incomprensibile agli occidentali, tanto che gli
Inglesi, dopo un secolo di dominazione coloniale, dovettero ammettere di non
aver capito il modo di pensare degli indiani. L’Inghilterra spinse le sue
colonizzazioni fino in Cina, in Birmania e nel lontano Tibet. Il Museo
Britannico di Londra conserva molti dei tesori letterari e artistici presi
durante quella dominazione. Gli studiosi autentici di quei cimeli ci hanno
insegnato a guardare all’Oriente con rispetto e forse in modo un po’ onirico. Il
fascino che ancora oggi l’Oriente esercita sulla mente degli occidentali
risponde forse a un’esigenza di libertà, sempre più difficile da esperire per
l’uomo del XXI secolo, chiuso in una società tecno-virtuale, afflitto da un
senso di solitudine e alienazione senza pari. L’avvicinamento delle varie
culture presenta degli aspetti molto positivi, ci può indirizzare verso
un’apertura di mente e cuore, un dialogo e una comunicazione veramente nuovi se
vissuti come scelta consapevole, fino a un cambiamento radicale delle secolari
impalcature e strutture concettuali, fino allo movimento di pensieri coscienti e
non coscienti secondo il principio dei vasi comunicanti. Tutti possono
beneficiare dell’apporto di altre culture e tradizioni. Ci può arricchire in
tutti i sensi e contribuire al risveglio di una Nuova Civiltà. Il messaggio dei
saggi del Medio ed Estremo Oriente così pure delle antichissime tradizioni
sciamaniche (le origini dello sciamanesimo si possono far risalire a circa
30.000 anni fa) può offrire una nuova visione, permettendo di riprendere
contatto con le radici spirituali e finalmente uscire dal vicolo cieco. Il
riemergere oggi della cultura e filosofia degli indiani d’America sotto la
spinta dell’Occidente è indicativo dell’estremo tentativo da parte dell’uomo
bianco di ritrovare un collegamento diretto con la Natura. È proprio a causa
della separazione dell’uomo bianco dal principio del rispetto della Terra e di
ogni essere vivente che ci troviamo di fronte a problemi ecologici enormi,
effetto del suo agire sconsiderato. Secondo diversi ricercatori e scienziati, a
causa della pressione ambientale, nel 2050 le condizioni di vita sul pianeta
saranno pessime. È per questo motivo che in diverse culture spirituali è stata
profetizzata una grande Purificazione Planetaria. In un antico testo del
buddhismo tibetano, le preghiere rivolte a una divinità protettrice sono
precedute dal seguente testo: «In quest’epoca degenerata la contraddizione tra
le intenzioni e gli atti degli esseri e le perturbazioni degli elementi esterni
e interni provocano epidemie e malattie finora sconosciute che colpiscono uomini
e animali, sofferenze causate da pianeti, naga (una categoria di esseri
intelligenti con volto umano e lunga coda di serpente, n.d.t.),demoni ed esseri
elementari cattivi. I raccolti sono colpiti da malattie, gelo e grandine, sono
annate dure nelle quali scoppiano dispute, lotte e guerre. Le piogge sono
irregolari, la neve cade troppo abbondante e appaiono calamità causate dai
roditori. Vi sono terremoti, incendi e disastri dovuti ai quattro elementi».
Oggi come in passato la confusione e la sofferenza che proviamo è imputabile
prima di tutto a una situazione di disequilibrio. Mentre la saggezza millenaria
dell’Oriente ci insegna a guardare dentro per le risposte ai problemi dell’uomo,
l’Occidente guarda fuori. In cerca di soluzioni e risposte, l’uomo moderno
occidentale ha cercato la verità assoluta nella razionalità. È convinto di
garantirsi una vita comoda, sul piano sociale e politico semplicemente
rafforzando l’economia e, sicuro del suo modello di sviluppo, lo ha promosso e
molto spesso imposto in tutti i Paesi del mondo. Dominato dal delirio della
scienza, pensa di occultare ancora per molto la sua paura della morte affidando
le sue speranze di immortalità all’ingegneria genetica. Il suo agire imprudente
sull’ambiente non lo ha messo al riparo dagli elementi, anzi ha accentuato la
precarietà della sua esistenza, esponendolo a disastri naturali di ogni tipo che
lo colgono fragile e psicologicamente impreparato ad affrontare il dolore della
tragedia. Nel campo religioso, la ferrea convinzione di essere il detentore
dell’unica verità assoluta, ha accentuato la sua distanza dal prossimo e da Dio
al quale si affida in modo fideistico per allontanarsene ogni qualvolta non
trova risposta ai suoi mille ‘perché’. Il suo smarrimento è grande e ha bisogno
dell’aiuto dell’intuito della antica saggezza dell’Oriente per tornare alla
riflessione, alla meditazione, alla contemplazione della bellezza del creato,
per ritrovare pace e armonia con se stesso, i suoi simili, la terra e il cosmo.
Ho scritto questo articolo per evidenziare come con dei mezzi banali, se
vogliamo, si può far credere tutto ed il contrario di tutto e che la soluzione
ai "nostri problemi" non sia poi chissà cosa, è semplicemente dentro di noi,
quello è il difficile, è ovviamente più facile dare la colpa ad altri e far
finta di nulla. Parecchi anni fa, tanti, dopo la lettura di quanto segue avevo
intuito che quella era la soluzione ed ora me la ritrovo confermata anche da
Jung tra gli altri, chiaramente c'era arrivato prima ma non ne ero a conoscenza
... "Non vi potrà mai essere una rivoluzione socio-politica, finché non avrà
luogo una rivoluzione individuale, perché la rivoluzione deve nascere
dall’interno di ciascun singolo essere umano perché poi può diventare
collettiva, del resto, si può privare l’essere umano della libertà politica,
senza fargli alcun male, ma se lo si priva della sua libertà di essere o
sentire, lo si distrugge. La nostra cultura occidentale disprezza le culture
primitive ma quei popoli vivono in armonia con la terra, le foreste e gli
animali. Occorre una rivoluzione interiore radicale, occorre varcare le proprie
porte interiori, per poter essere davvero liberi, liberi di essere e sentire,
occorre spazzare via dal proprio intimo tutta l’immondizia che ci è stata
inserita dentro nel corso degli anni, fin dal momento in cui siamo nati. Ma la
stragrande maggioranza della gente, questo non lo vuole fare, non è disposta a
cambiare nulla". !!!!!!!!!! Jim Morrison.
La Storia Segreta Dell’Unione Europea: Il
Piano Kalergi, scrive “No Censura” il 7 novembre 2013.
Pertanto per comprendere meglio il fenomeno paneuropeista è necessario non
fermarsi ai falsi miti (multi-culturalismo, multietnicismo, distruzione degli
Stati Nazione, favoreggiamento del regionalismo, ecc.) propinati da questo
contenitore estremamente influente e pericoloso, bensì è necessario capire chi
finanziò questo istituto globalista. Oltre agli agenti industriali e finanziari,
Richard Coudenhove-Kalergi ebbe il sostegno del banchiere Max Warburg, che
rappresentava la banca tedesca di Amburgo (la Banca Warburg). All’epoca suo
fratello, (trasferitosi negli Usa) Paul Warburg, era stato uno dei fondatori
della FED (la Federal Reserve statunitense) oltre che leader del Council on
Foreign Relation (il CFR). Esistono due storie che raccontano la nascita
dell’Unione Europea. Una ufficiale, di facciata, sponsorizzata dall’intero
apparato accademico che narra di un gruppo eterogeneo di persone, i cosiddetti
padri fondatori della “nuova Europa”, il quale successivamente al conflitto
mondiale iniziò a progettare la pace, l’unità e la prosperità nel Vecchio
continente per poi dare vita ad una comunità di Stati in cooperazione tra di
loro. E poi c’è una storia reale ma oscurata, che rivela il progetto di un uomo,
l’aristocratico Richard Koudenove-Kalergi (giapponese di madre e austriaco di
padre), il quale non fu mai protagonista degli eventi ma che fu, nel retroscena,
artefice allo steso modo dei vari De Gasperi, Shuman, Monnet e Adenauer,
probabilmente ancor più influente poiché a differenza di questi ultimi, aveva
una visione planetaria e non europea. Nel 1922, Koudenove-Kalergi fonda la
Paneuropa (o Unione Paneuropea) con lo scopo apparente di impedire un nuovo
conflitto continentale, tuttavia nel 1925 in una relazione presentata alla
Società delle Nazioni i fini dell’austro-giapponese si manifestano chiaramente.
Il suo obiettivo primario era quello di unificare l’Europa, al fine di
integrarla all’interno di un’organizzazione mondiale politicamente unificata, in
poche parole un governo mondiale, che a sua volta federasse nuove federazione
continentali (“continenti politici”, proprio come la “Paneuropa”). Inoltre nel
suo libro «Praktischer Idealismus» pubblicato nel 1925, Kalergi espone una
visione multiculturalista e multi-etnicista dell’Europa, dichiarando che gli
abitanti dei futuri “Stati Uniti d’Europa” non saranno i popoli originali del
Vecchio continente, bensì una sorta di subumanità resa bestiale dalla mescolanza
razziale”, e affermando senza mezzi termini che “è necessario incrociare i
popoli europei con razze asiatiche e di colore, per creare un gregge multietnico
senza qualità e facilmente dominabile dall’elite al potere. L’uomo del futuro
sarà di sangue misto. La razza futura eurasiatica-negroide, estremamente simile
agli antichi egiziani, sostituirà la molteplicità dei popoli, con una
molteplicità di personalità”. Nel 1926 Koudenove-Kalergi organizzò la prima
conferenza paneuropea di Vienna, sotto gli auspici del suo presidente onorario,
il presidente Aristide Briand (1862-1932) e fu proprio in questo convegno che si
decise di scegliere l’inno europeo, l’Inno alla gioia di Beethoven, che in
seguito diventerà l’inno ufficiale dell’Unione Europea. Ma è durante questo
primo congresso che sono esposti in modo chiaro, lucido, gli obiettivi a breve,
medio e lungo termine di questo contenitore di idee: “l’Unione Pan-europea
ribadisce il suo impegno al patriottismo europeo, a coronamento dell’identità
nazionale di tutti gli europei. Nel momento dell’interdipendenza e delle sfide
globali, solo una forte Europa unita politicamente è in grado di garantire il
futuro dei suoi popoli ed entità etniche. L’Unione Paneuropea riconosce il
diritto all’autodeterminazione dei gruppi etnici allo sviluppo (…) culturale,
economico e politico”. Negli anni Trenta, Koudenove-Kalergi condanna fermamente
il modello nazional-socialista di Adolph Hitler e quello sovietico di Stalin,
tanto che l’industria tedesca revoca definitivamente i finanziamenti all’Unione
paneuropea, mentre gli intellettuali filo-sovietici lasciano l’associazione.
Durante la Seconda Guerra Mondiale il fondatore della Paneuropa si rifugia negli
Stati Uniti, nei quali insegnò in un seminario presso la New York University –
“La ricerca per una federazione europea del dopoguerra” – a favore del
federalismo europeo. Nel 1946, Koudenove-Kalergi torna in Europa e la sua
personalità gioca un ruolo di estrema rilevanza. La Paneuropa riprende le forze
e si creano in tutti Paesi europei delle delegazioni (Paneurope France,
Paneuropa Italia, ecc.) che in pochi mesi diffusero gli ideali paneuropeisti a
quelli che poi furono considerati i “padri fondatori della nuova Europa”. Queste
delegazioni contribuirono alla realizzazione dell’Unione parlamentare europea,
che successivamente consentì la creazione nel 1949, del Consiglio d’Europa. Il
suo “impegno” intellettuale e politico gli permisero di aggiudicarsi nel 1950 il
prestigioso premio prettamente continentale “Carlo Magno” e, persino in suo
onore fu stato istituito il premio europeo Coudenhove-Kalergi che ogni due anni
premia gli europeisti che si sono maggiormente distinti nel perseguire il suo
“ideale” confederativo e mondialista. Tra questi troviamo nomi come Angela
Merkel e Herman Van Rompuy. Pertanto per comprendere meglio il fenomeno
paneuropeista è necessario non fermarsi ai falsi miti (multi-culturalismo,
multietnicismo, distruzione degli Stati Nazione, favoreggiamento del
regionalismo, ecc.) propinati da questo contenitore estremamente influente e
pericoloso, bensì è necessario capire chi finanziò questo istituto globalista.
Oltre agli agenti industriali e finanziari, Richard Coudenhove-Kalergi ebbe il
sostegno del banchiere Max Warburg, che rappresentava la banca tedesca di
Amburgo (la Banca Warburg). All’epoca suo fratello, (trasferitosi negli Usa)
Paul Warburg, era stato uno dei fondatori della FED (la Federal Reserve
statunitense) oltre che leader del Council on Foreign Relation (il CFR). Da qui
vediamo lo stretto legame tra Wall Street, quindi gli Stati Uniti d’America e la
volontà già negli Venti di federare l’Europa sotto una sola guida politica,
probabilmente per dominarla meglio. Richard Coudenhove-Kalergi non fu un
visionario del suo tempo proprio perché egli fu un manovratore della partita.
Non a caso l’Europa sognata dall’aristocratico austro-giapponese è la stessa di
oggi, quella del terzo millennio.
Ecco la condanna a morte che ci attende.
Pubblicato il testo del TPP. Pubblicato il 6 novembre
2015 da Claudio Messora su “Byo Blu”. “Peggiore di qualunque cosa avessimo mai
immaginato”. “Un atto di guerra al clima”. “Un omaggio all’agricoltura
intensiva”. “Una condanna a morte per la libertà della rete”. “Il peggior
incubo”. “Un disastro”. Questo è il tenore dei commenti di chi ha letto e
studiato il testo del TPP, il fratello gemello del TTIP, l’accordo di libero
scambio commerciale tra Usa e Ue, negoziato in segreto, di cui vi ho parlato
mercoledì sera a La Gabbia. Il TTIP fa parte di una gigantesca strategia globale
degli Usa, le cosiddette “Tre T”, che comprendono anche il TTP e il TISA. Il
TTIP è l’accordo di liberalizzazione commerciale che stanno negoziando (in
segreto) Usa e UE. Il Tisa (Trade in Services Agreement) è l’accordo, anche
peggiore, sulla liberalizzazione dei servizi e il TPP (Trans Pacific
Partnership), è l’omologo del TTIP sul fronte pacifico, che includerà 12 paesi,
tra cui Singapore, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, l’Australia, il Messico,
il Giappone e il Canada. Caso vuole che in nessuno dei tre accordi siano
presenti i cosiddetti Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). Caso
vuole? No, in effetti non è un caso, ma esattamente lo scopo per cui le Tre
T sono state create: aggirare il peso che i paesi emergenti hanno assunto
nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), isolare la Cina (con la
strategia militare e commerciale definita “Pivot to Asia”) e assicurare il
dominio delle grandi corporation USA nell’economia mondiale. Questi trattati
sono negoziati in segreto (perché se no non glieli lasceremmo fare): per la UE
ci pensa quella simpaticona indefessa adoratrice dei più stringenti principi
democratici che si chiama Cecilia Malmström (la
signora io-non-rispondo-ai-cittadini). Solo le lobby hanno libero accesso al
testo del negoziato. Se gli europarlamentari vogliono visionarlo, devono
chiamare l’ambasciata americana, farsi dare un appuntamento che è disponibile
solo due volte a settimana, in una fascia oraria di sole due ore, solo due alla
volta, all’ingresso devono consegnare ogni dispositivo elettronico, firmare un
impegno di riservatezza e finalmente possono avere davanti agli occhi intere
sezioni di codici e codicilli legali, per due ore, senza poter prendere appunti
e guardati a vista da due guardie americane. Se questo lo chiamate democrazia,
fatevi visitare da uno bravo! Lato Usa invece usano la Fast Track Negotiating
Authority for Trade Agreement, che è uno strumento che consente al Presidente
degli Stati Uniti d’America di negoziare trattati commerciali per i fatti suoi,
e poi presentare un pacchetto fatto e finito al Congresso, che può solo
approvarlo o respingerlo in toto, a maggioranza semplice, (un po’ come la nostra
fiducia): i deputati USA non possono in alcun modo proporre emendamenti o fare
ostruzionismo. E’ nato per consentire l’approvazione di trattati commerciali che
altrimenti non avrebbero mai visto la luce, e per consentire ai deputati di
votare a favore senza perdere la poltrona (negli Usa c’è il recall), dato che
chi li ha eletti ne sarebbe probabilmente scontento. Figuratevi quanta
democrazia ci sia anche da quelle parti: hanno creato uno strumento per fare in
modo di poter votare quello che democraticamente non potrebbero! Chapeau! (E
questa è la più grande democrazia del pianeta, figuriamoci le altre!). Dunque
cosa succede? Succede che il testo del TPP finalmente è stato rilasciato, dopo
essere stato finalizzato dalle ultime negoziazioni di Atlanta, in Georgia. La
pubblicazione dei contenuti del trattato ha così avviato il periodo di tre mesi
che precede il suo atterraggio al Congresso, chiamato ad approvarlo. Ecco il
testo ufficiale: TPP FINAL TABLE OF CONTENTS. La reazione di chi ha avuto lo
stomaco di leggerselo è stata questa: “Dai leaks, avevamo saputo qualcosa
sull’accordo, ma capitolo dopo capitolo la lettura del testo finale è peggiore
di quello che ci aspettavamo: le richieste di 500 lobbisti che rappresentano gli
interessi delle corporation sono state soddisfatte a svantaggio dell’interesse
pubblico. Questo accade quando le lobby possono negoziare in privato,
nell’oscurità, e i cittadini vengono tagliati fuori”. “Il TTP è un disastro per
il lavoro, per l’ambiente e per la democrazia. E’ l’ultimo passo verso la resa
della nostra società alle corporation. L’enorme accordo tra 12 nazioni sulle
coste del Pacifico ha meno a che fare con la vendita delle merci di quanto,
piuttosto, abbia a che fare con la riscrittura delle regole dell’economia
globale in favore del grande business. Esattamente come il North American Free
Trade Agreement (il NAFTA), 20 anni fa, sarà una cosa ottima per i più ricchi
e un disastro per chiunque altro. Il NAFTA ha radicato le disuguaglianze e
causato la perdita di un milione di posti di lavoro negli USA. E il TPP non è
altro che una versione del NAFTA iperpotenziata”. “Ora che abbiamo visto il
testo definitivo, viene fuori che il TTP, vero e proprio assassino
dell’occupazione, è peggiore di qualunque altra cosa che sia mai stata
immaginata. Questo accordo abbatterà i salari, inonderà il nostro Paese di
alimenti importati e non sicuri, innalzerà i prezzi delle medicine salva-vita, e
tutto questo mentre si faranno affari con paesi dove gli omosessuali e le mamme
single possono essere lapidate”. “Il testo è pieno di sussidi per le società che
fanno affari sui combustibili fossili e di incredibili possibilità per queste
compagnie di fare causa ai singoli governi che cercano di diminuire l’uso dei
combustibili fossili. Se una provincia mette una moratoria sul fracking, le
corporation possono perseguirla legalmente; se una comunità cerca di fermare una
miniera di carbone, le corporation possono prevalere in punta di diritto. In
breve, queste leggi minano la capacità dei singoli stati di attuare quello che
gli scienziati dicono che sia la sola cosa più importante da fare per combattere
la crisi climatica: abbattere i consumi di carburanti fossili”. “E’ un accordo
disegnato per proteggere il commercio libero di prodotti energeticamente
sporchi come i depositi non convenzionali di catrame e bitume, depositi di
carbone e gas naturale liquefatto spedito dai porti della costa occidentale. Il
risultato sarà un’accelerazione dei cambiamenti climatici derivante delle
emissioni di CO2 in tutto il Pacifico. Il presidente Obama ha venduto agli
americani false promesse: il TTP tradisce la promessa di Obama di fare
dell’accordo un trattato amico dell’ambiente”. “Il capitolo ambientale conferma
molti dei peggiori incubi dei gruppi ambientalisti e degli attivisti contro il
cambiamento climatico”. “Con le sue disposizioni che tagliano le mani agli
ispettori alimentari sulle frontiere e danno più potere alle compagnie che
operano nella biotecnologia, il TPP è un regalo alle grandi multinazionali del
settore dell’agricoltura intensiva e del cibo biotech. Questo genere di società
useranno gli accordi come il TPP per attaccare le misure di sicurezza sugli
alimenti sensibili, per indebolire le possibilità di ispezionare il cibo
importato e per bloccare ogni sforzo di rafforzare gli standard di sicurezza
alimentare degli Stati Uniti. Innanzitutto quelli per etichettare correttamente
gli alimenti OGM. Inoltre, qualunque criterio di sicurezza alimentare
sull’etichettatura dei pesticidi o degli additivi che sia più elevato rispetto
agli standard internazionali, potrà essere additato come una barriera
commerciale illegittima. Sotto al regime del TTP, il business dell’agricoltura
intensiva e le multinazionali biotech delle sementi hanno adesso un modo più
semplice per sfidare a quei paesi che vietano l’importazione di alimenti
geneticamente modificati, che controllano la contaminazione OGM, che non
approvano prontamente nuovi prodotti OGM o anche solo richiedono
un’etichettatura adeguata”. “Se il Congresso degli Stati Uniti firmerà questo
accordo malgrado la sua sfacciata pericolosità, firmerà la condanna a morte per
la rete internet aperta e metterà il futuro della libertà di opinione a
repentaglio. Tra le molte sezioni del documento che destano gravi
preoccupazioni, ci sono quelli relative ai marchi commerciali, ai brevetti delle
case farmaceutiche, alla protezione del copyright e ai segreti commerciali. La
sezione J, che riguarda gli internet service providers, è una delle sezioni
peggiori che impatta sulla libertà della rete. Richiede ai fornitori di servizi
internet di comportarsi come poliziotti della rete e collaborare con le
richieste di oscuramento, ma non obbliga i paesi a dotarsi di un sistema di
contestazione. Così, una società potrebbe ordinare a un sito web di essere
oscurato in un altro paese e non ci sarebbe nessuno strumento per il
proprietario del sito di confutare la legittimità della richiesta nel caso, per
esempio, dei blog di critica politica che usano materiale protetto da copyright
sotto il regime del fair use. La sezione J è scritta in maniera tale che gli
internet service provider non saranno perseguibili per nessuno degli errori che
dovessero commettere sull’oscuramento dei contenuti, incentivandoli così a
“sbagliare” a favore dei detentori di copyright invece che a favore di chi
esercita la libertà di opinione”. “Anche una parte dell’opinione pubblica
canadese è molto preoccupata sulle conseguenze dell’accordo commerciale sui
diritti umani, sulla salute, sull’occupazione e sulla democrazia. Il Consiglio
dei canadesi, un’organizzazione alla testa di un largo network impegnata nella
difesa dell’equità sociale, ha chiesto formalmente al nuovo primo ministro
Trudeau di organizzare una consultazione pubblica che includa un ampia analisi
indipendente del testo, dal punto di vista dei diritti umani, delle conseguenze
economiche e di quelle ambientali, prima di procedere oltre nella
ratifica. Trudeau è sottoposto a enormi pressioni per adottare l’accordo il più
presto possibile, con numerose insistenti telefonate da Barack Obama e dal
presidente giapponese Shinto Abe, ma una approfondita revisione pubblica
dell’accordo è necessaria prima di poter stabilire se il TPP è nell’interesse
del Canada”.
State molto attenti, perché quello che c’è nel TPP
è con grandissima probabilità quello che troveremo nel TTIP, quando la
nostra Malmströmavrà finito di farsi i cazzi suoi in privato con le lobby e
deciderà finalmente di pubblicare un testo che poi il Parlamento Europeo sarà
chiamato ad approvare. Per quella data, dobbiamo essere pronti a fargli un culo
così.
Ecco perché hanno ammazzato Gheddafi. Le
email Usa che non vi dicono, scrive Claudio Messora il
9 gennaio 2016 su "Byo Blu". Il 31 dicembre scorso, su ordine di un tribunale,
sono state pubblicate 3000 email tratte dalla corrispondenza personale di
Hillary Clinton, transitate sui suoi server di posta privati anziché quelli
istituzionali, mentre era Segretario di Stato. Un problema che rischia di minare
seriamente la sua corsa alla Casa Bianca. I giornali parlano di questo caso in
maniera generale, senza entrare nel dettaglio, ma alcune di queste email
delineano con chiarezza il quadro geopolitico ed economico che portò la Francia
e il Regno Unito alla decisione di rovesciare un regime stabile e tutto sommato
amico dell’Italia, come la Libia di Gheddafi. Ovviamente non saranno i media
mainstream generalisti a raccontarvelo, né quelli italiani né quelli di questa
Europa che in quanto a propaganda non è seconda a nessuno, tantomeno a quel
Putin spesso preso a modello negativo. A raccontarvelo non poteva essere che un
blog, questa volta Scenari Economici di Antonio Rinaldi e del suo team, a cui
vanno i complimenti. “Due terzi delle concessioni petrolifere nel 2011 erano
dell’ENI, che aveva investito somme considerevoli in infrastrutture e impianti
di estrazione, trattamento e stoccaggio. Ricordiamo che la Libia è il maggior
paese produttore africano, e che l’Italia era la principale destinazione del gas
e del petrolio libici. La
email UNCLASSIFIED U.S. Department of State Case No.
F-2014-20439 Doc No. C05779612 Date: 12/31/2015 inviata il 2
aprile 2011 dal funzionario Sidney Blumenthal (stretto collaboratore prima di
Bill Clinton e poi di Hillary) a Hillary Clinton, dall’eloquente titolo
“France’s client & Qaddafi’s gold”, racconta i retroscena dell’intervento
franco-inglese. Li sintetizziamo qui. La Francia ha chiari interessi economici
in gioco nell’attacco alla Libia. Il governo francese ha organizzato le fazioni
anti-Gheddafi alimentando inizialmente i capi golpisti con armi, denaro,
addestratori delle milizie (anche sospettate di legami con Al-Qaeda),
intelligence e forze speciali al suolo. Le motivazioni dell’azione di
Sarkozy sono soprattutto economiche e geopolitiche, che il funzionario
USA riassume in 5 punti: Il desiderio di Sarkozy di ottenere una quota maggiore
della produzione di petrolio della Libia (a danno dell’Italia, NdR);
Aumentare l’influenza della Francia in Nord Africa; Migliorare la posizione
politica interna di Sarkozy; Dare ai militari francesi un’opportunità per
riasserire la sua posizione di potenza mondiale; Rispondere alla preoccupazione
dei suoi consiglieri circa i piani di Gheddafi per soppiantare la Francia come
potenza dominante nell’Africa Francofona. Ma la stessa mail illustra un altro
pezzo dello scenario dietro all’attacco franco-inglese, se possibile ancora più
stupefacente, anche se alcune notizie in merito circolarono già all’epoca. La
motivazione principale dell’attacco militare francese fu il progetto di Gheddafi
di soppiantare il Franco francese africano (CFA) con una nuova valuta pan
africana. In sintesi Blumenthal dice: Le grosse riserve d’oro e argento di
Gheddafi, stimate in 143 tonnellate d’oro e una quantità simile di
argento, pongono una seria minaccia al Franco francese CFA, la principale valuta
africana. L’oro accumulato dalla Libia doveva essere usato per stabilire una
valuta pan-africana basata sul dinaro d’oro libico. Questo piano doveva dare ai
paesi dell’Africa Francofona un’alternativa al franco francese CFA. La
preoccupazione principale da parte francese è che la Libia porti il Nord
Africa all’indipendenza economica con la nuova valuta pan-africana.
L’intelligence francese scoprì un piano libico per competere col franco CFA
subito dopo l’inizio della ribellione, spingendo Sarkozy a entrare in
guerra direttamente e bloccare Gheddafi con l’azione militare.
Libia, le carte di Hillary Clinton: "La
Francia distrusse l'Italia". La guerra che portò il
caos in Libia venne scatenata dai francesi con l'avallo degli americani.
L'obiettivo era uno solo: affermare la potenza transalpina ed eliminare ogni
influenza italiana nel Maghreb, scrive Ivan Francese, Mercoledì 03/08/2016, su
"Il Giornale". La guerra di Libia - un'altra - cent'anni dopo. Correva l'anno
2011, i dodici mesi che cambiarono il mondo ma soprattutto la storia d'Italia.
Eravamo ormai abituati a ricordarlo come l'anno della caduta del governo
Berlusconi IV e dell'arrivo dell'ultra-europeista Mario Monti a Palazzo Chigi
dopo mesi di attacchi politici e finanziari (non senza speculazioni assai poco
trasparenti). Tutti ricordiamo gli insopportabili risolini di Angela
Merkel e Nicolas Sarkozy al Consiglio Europeo del 23 ottobre 2011. Ebbene, ora
su quei giorni cruciali potremmo apprendere qualcos'altro. Se possibile,
qualcosa di ancora più inquietante. Come ha rilevato Scenarieconomici,
spulciando fra le mail dell'allora Segretario di Stato UsaHillary Clinton si
scopre che l'attacco internazionale che portò alla caduta del regime di Muhammar
Gheddafi e all'uccisione del Colonnello venne lanciato solo ed esclusivamente
per rispondere a precisi interessi geostrategici francesi, con l'avallo
statunitense. A tutto detrimento degli interessi italiani. Certo, sapevamo già
che la guerra voluta da Sarkozy era un mezzo per estromettere il nostro Paese
dal controllo del petrolio libico, ma vederlo scritto nero su bianco resta
comunque impressionante. E allora vediamo cosa contengono, quelle mail
famigerate. Il 2 aprile del 2011 l'attuale candidata democratica alla Casa
Bianca riceveva un messaggio dal suo consigliere per il Medio Oriente Sidney
Bluementhal dai toni assai espliciti. Da quelle righe emerge infatti che il
presidente francese dell'epoca, Sarkozy, ha finanziato e aiutato in ogni modo le
fazioni anti gheddafiane con denaro, armi e addestratori, allo scopo di
strappare più quote di produzione del petrolio in Libia e rafforzare la propria
posizione tanto sul fronte politico esterno quanto su quello geostrategico
globale. Di più. A motivare definitivamente la decisione dell'Eliseo di entrare
nel conflitto sarebbe stato il progetto del raìs di soppiantare il franco
francese africano con una nuova divisa pan-africana, nell'ottica di un'ascesa
della Libia come potenza regionale in grado di raccogliere intorno a sè
un'alleanza regionale di Stati. Sostituendo così proprio la Francia, a suon di
oro e di argento (Gheddafi ne avrebbe conservate poco meno di trecento
tonnellate). Le conseguenze dell'intervento sono storia nota, con la Libia
precipitata in un'atroce guerra civile, l'Isis che spadroneggia sulle coste
meridionali del Mediterraneo e un'ondata di migranti senza precedenti che si
riversa sulle nostre coste. All'epoca l'Italia, all'oscuro di tutto, prese
addirittura parte alla guerra contro Gheddafi, sia pure a malincuore. Ora però è
chiaro che quella manovra, insieme all'attacco speculativo portatoci dalla
Germania, aveva un solo obiettivo: l'Italia. Che ancora oggi ne sconta le
terribili conseguenze.
Le mail segrete di Hillary smascherano
Sarkò: da Gheddafi per un furto all'Italia, scrive
Marco Gorra su "Libero Quotidiano” il 18 Gennaio 2016. Il sospetto che la storia
della Francia che muove guerra a Gheddafi perché unicamente interessata ad
«assumere il proprio ruolo di fronte alla storia» ed a «difendere i libici che
vogliono liberarsi dalla schiavitù» (parola dell'allora presidente Nicolas
Sarkozy) fosse una solenne presa in giro era venuto. Adesso arrivano le
conferme. E viene fuori che no, dietro la decisione di Parigi di rovesciare con
le cattive il Colonnello di idealismo ce n' era ben poco. In compenso, c' erano
altre considerazioni di carattere assai più venale: petrolio e quattrini. Due
fondamentali interessi francesi in nome dei quali ci si è armati e si è partiti.
E non solo chi, come i transalpini, aveva da guadagnarci. Ma anche chi, come
l'Italia, dell'operazione ostile ordita a Parigi era la prima vittima designata.
A fare luce su quegli eventi del 2011 soccorrono oggi le famose mail di Hillary
Clinton, recentemente desecretate in seguito alle polemiche divampate intorno ai
famigerati server privati dell'ex Segretario di Stato. Nella mole di documenti
declassificati, spiccano i messaggi inviati alla Clinton da Sidney Blumenthal,
consigliere privato della signora e suo principale esperto sul campo di
questioni libiche. Dal carteggio emergono le reali preoccupazioni dei francesi
in ordine alla crisi libica. La prima è quella relativa al petrolio, business
faraonico da cui le aziende transalpine erano tagliate fuori ad opera - anche -
di quelle italiane (prima dell'inizio della guerra due terzi della concessioni
erano dell'Eni). Tramite il riconoscimento preventivo del Cnt e la di esso
successiva installazione al potere, Parigi contava di riequilibrare la
situazione a proprio vantaggio: l'accordo coi ribelli era di trasferire in mano
ai francesi, a titolo di ringraziamento per il supporto fornito, il 35% del
crude oil del Paese. A questo scopo, elementi dell'intelligence francese avevano
iniziato fin dalla primavera del 2011 a fornire supporto di ogni tipo agli
anti-Gheddafi. La seconda preoccupazione dei francesi era di ordine monetario.
Si trattava di impedire che il Colonnello desse seguito al proprio vecchio
pallino di creare una valuta panafricana. All' uopo, Gheddafi era pronto ad
impiegare le proprie riserve (143 tonnellate d' oro e quasi altrettante d'
argento, per un valore complessivo di circa sette miliardi di dollari). Scenario
da incubo per la Francia, dacché la nuova moneta avrebbe pensionato il franco
Cfa, valuta creata nel '45 ed utilizzata da 14 ex colonie con svariati e
benefici ricaschi per il Tesoro francese. A completare il quadro dei veri
motivi dietro all' attacco, secondo il carteggio, ci sono poi due grandi
classici di queste situazioni: i sondaggi, con l'esigenza per Sarkozy di
riguadagnare popolarità in vista delle incombenti elezioni presidenziali, e i
militari, cui premeva avere un'occasione per riaffermare la propria posizione di
potenza di livello mondiale. Come è andata a finire è cosa nota: l'azzardo di
francesi e britannici funziona, Casa Bianca e Palazzo di Vetro danno l'ok e la
guerra a Gheddafi si fa. Guerra in cui, pur avendo intuito che non sarebbe stato
esattamente un affarone, partecipa anche l'Italia. Questione di qualche mese e
il gioco è fatto: Gheddafi è rovesciato e al suo posto ci sono gli ormai ex
ribelli del Cnt. I risultati non tardano ad arrivare: la moneta panafricana
finisce in archivio prima ancora di essere nata e si procede alla grande
redistribuzione del petrolio (in cui, ironia della sorte, i francesi porteranno
a casa meno di quanto sperato a vantaggio di russi e cinesi). Soprattutto,
l'influenza italiana nell' area si riduce drasticamente. Proprio come auspicato
dall' inquilino dell'Eliseo. Marco Gorra
I megaprogetti nei Balcani spianano la
via alla Grande Eurasia. Hillary Clinton e
l'orientamento del potere: è lei la vera candidata guerrafondaia alla Casa
Bianca, scrive Andrea Spinelli Barrile su “ibtimes” l'1.03.2016 . Hillary Rodham
Clinton è il candidato democratico che in questo momento sembra avere più chance
non solo per la vittoria del Super Tuesday e delle primarie dell'asinello a
stelle e strisce ma soprattutto per tornare ad essere inquilina alla Casa
Bianca, dove ha già trascorso 8 anni come first lady. La candidata democratica,
non è un mistero, piace ai colletti bianchi di Wall Street, piace ai
neoconservatori - un editoriale di Robert Kagan sul Washington Post del 25
febbraio è qualcosa di più di un endorsement – e alla medio-alta borghesia
americana, mentre meno gradita sembra essere sia alla base del partito
democratico che ai “poorly educated” (questi ultimi vanno pazzi per Donald
Trump). Questo fa di Hillary Clinton una sorta di Matteo Renzi, con qualche anno
e diversi chilometri in più sul curriculum, dell'era post-ideologica americana?
Non esattamente. In realtà la signora Clinton è quanto di più vicino ci sia
all'establishment americano e alle lobby, almeno tra i vari candidati alla Casa
Bianca. Compreso Donald Trump. Un interessante profilo della signora Clinton lo
ha pubblicato l'Huffington Post americano. Jeffrey Sachs, direttore dell'Earth
Institute presso la Columbia University, descrive così il background della
candidata democratica: “Gli stretti rapporti di Hillary e Bill Clinton con Wall
Street contribuirono ad alimentare due bolle finanziarie (1999-2000 e 2005-2008)
e la Grande Recessione che seguì il tracollo di Lehman. […] Anche i legami di
Hillary con il complesso militare-industriale sono inquietanti”. Nel nostro
immaginario i democratici sono quelli che cercano di fare da contrappeso alla
sete guerrafondaia repubblicana nel Congresso ma anche in questo Hillary si
dimostra essere una democratica piuttosto atipica. È stato evidente nel
dibattito televisivo di sabato sera tra i candidati dem: la Clinton ha sempre
difeso la scelta della missione NATO in Libia nel 2011, che ha eliminato
Gheddafi e fatto sprofondare il Paese nordafricano nel caos assoluto, ma
nell'ultimo dibattito è andata leggermente oltre. Alla domanda su quali fossero
le responsabilità dell'allora Segretario di Stato Hillary Clinton sulla realtà
libica di oggi ha risposto così: “Non mi arrendo sulla Libia, penso che nessuno
debba farlo. […] C'è sempre una retrospettiva, uno spazio per dire 'quali errori
sono stati fatti' ma io so che abbiamo offerto molto aiuto e so che è stato
difficile per i libici accettarlo”. In quella frase c'è tutta l'esperienza in
politica estera della signora Clinton: da first lady, da senatrice e da
Segretario di Stato Hillary Clinton ha appoggiato sempre e incondizionatamente
qualsiasi guerra gli Stati Uniti abbiano intrapreso da quando lei è sulla scena
politica. Secondo Sachs tutto ebbe inizio il 31 ottobre 1998: l'allora
Presidente Bill Clinton firmava il Decreto per la Liberazione dell'Iraq rendendo
ufficiale la strategia atta al “cambiamento di regime” nel paese mediorientale,
la base legislativa sulla quale è stato costruito l'intervento armato dal suo
successore George W. Bush. Nel 2003, quando il Congresso fu chiamato a decidere
se bombardare o meno l'Iraq sulla base delle prove - risultate fasulle - fornite
dalla CIA Hillary Clinton, allora senatrice, non esitò a sostenere
quell'intervento armato, costato uno sproposito in termini economici per gli USA
e geopolitici per la stabilità del Medio Oriente. L'anno successivo al decreto
sull'Iraq ci fu la guerra in Kosovo. Il 24 marzo 1999 la signora Clinton si
trovava in viaggio in Africa quando telefonò al marito: “Lo esortai a
bombardare” disse alla giornalista Lucinda Franks qualche anno dopo. Quel
frangente e la schiena dritta tenuta durante lo scandalo sexgate alla fine del
secondo mandato del marito connotano il carattere di Hillary Clinton,
determinato e power-oriented: la ragion di Stato (o di famiglia) su tutto. Dopo
8 anni di Bush jr un Premio Nobel per la Pace, il democratico Barack Obama,
diventò il primo presidente nero degli Stati Uniti. E con lui Hillary Clinton
divenne la prima ex-first lady a diventare Segretario di Stato, che in America è
il vero numero due del Presidente: nel periodo in cui la signora Clinton è stata
Segretario di Stato gli Stati Uniti hanno inanellato una serie di insuccessi e
di scelte militariste sbagliate che non hanno precedenti nella storia moderna
americana. Il 21 aprile 2009 Hillary Clinton riceveva alla Segreteria di Stato
Mutassim Gheddafi, figlio del Colonnello, all'epoca a capo della sicurezza
nazionale libica: “Sono onorata di dare il benvenuto al ministro Gheddafi […]
apprezziamo il valore profondo delle nostre relazioni e avremo molte occasioni
di approfondire e ampliare la nostra collaborazione”. Mutassim, tra i figli di
Gheddafi quello più simile al padre, sfoggiò un sorriso magnetico mentre
stringeva la mano alla Clinton. Il 20 ottobre 2011 la stessa Hillary Clinton,
preparandosi a un'intervista con la CBS, riceveva durante un fuori onda –
ripreso ugualmente dall'operatore - l'inattesa notizia della cattura di
Gheddafi sul BlackBerry di una sua collaboratrice: “Wow” esclamò con l'aria
sinceramente sorpresa “ci sono notizie non confermate sulla cattura di
Gheddafi”. Pochi minuti dopo, prima di cominciare a girare, sistemandosi la
giacca e con un sorriso estatico sul volto, rivolgendosi alla giornalista, la
signora Clinton declinò addirittura Giulio Cesare: “Siamo venuti, abbiamo visto,
è morto!”. Era il periodo nel quale gli Stati Uniti, e la signora Clinton, si
esprimevano con dichiarazioni infuocate anche verso il Presidente siriano Bashar
al-Assad: nel mese di agosto la Clinton suggeriva ad Assad di “togliersi di
torno”, sposando in toto la teoria della CIA e dell'Arabia Saudita che la
rimozione del dittatore siriano sarebbe stata rapida, priva di costi e
sicuramente un successo. Il risultato di quelle scelte lo osserviamo oggi, ma ci
serve un mappamondo per guardarlo tutto: la crisi è diffusa in un'area che va
dal Mali fino all'Afghanistan – e si allarga verso est – e nel cuore di questo
grande spazio ci sono due scenari apocalittici: Libia e Siria. Durante il
periodo da Segretario di Stato Hillary Clinton ha avuto un'influenza enorme sul
Presidente Barack Obama, determinante per alcune scelte determinanti in politica
estera, e spesso è stato proprio il parere della signora Clinton a far prendere
a Obama una decisione piuttosto che un'altra. Nella vita reale, le scelte
dell'amministrazione americana durante il periodo di Hillary Clinton alla
Segreteria di Stato possono essere rappresentate tramite un numero: 10 milioni
di profughi siriani, che quando non muoiono sotto le bombe, di fame durante il
viaggio, di malattie nei campi profughi o annegati nel Mediterraneo, si
ritrovano in Europa alimentando una crisi politica senza precedenti, indebolendo
paesi già in difficoltà come Grecia e Italia e creando una realtà che sta
minando alla base i valori fondanti della stessa Unione Europea. Ma l'operato
della signora Clinton non riguarda soltanto il Medio Oriente e il nord Africa:
da senatrice Hillary ha approvato, votandola, la Risoluzione 439 del Senato che
permise l'inclusione di Ucraina e Georgia nella NATO, un atto che fu l'embrione
di quella che oggi la Russia definisce “nuova Guerra Fredda”. Gli americani
negano, ma le operazioni di rafforzamento dei contingenti americani in
Europa sono un dato di fatto che racconta una storia diversa da quella
ufficiale. Il suo successore come Segretario di Stato John Kerry è ancora al
lavoro per riparare i buchi immensi provocati dalla sete di bombe della signora
Clinton: lo scenario libico, raccontato in questo articolo di grande giornalismo
del New York Times, è oggi la conseguenza di numerose scelte scellerate fatte da
Hillary Clinton ed oggi un Paese con una popolazione inferiore a quella dello
stato del Tennessee preoccupa due colossi mondiali come gli Stati Uniti e
l'Unione Europea: “Abbiamo avuto un'occasione d'oro per ridare vita a questo
paese. Purtroppo quel sogno si è infranto” ha detto Mahmoud Jibril, che fu primo
ministro ad interim del governo provvisorio nato durante la rivoluzione
libica. Era stato il principale interlocutore di Hillary Clinton prima che
morisse Gheddafi.
Email di Hillary, dinari d’oro e
Primavera araba, scrive F. William Engdahl, New
Eastern Outlook il 17 marzo 2016. Sepolto tra decine di migliaia di pagine
e-mail segrete dell’ex-segretaria di Stato Hillary Clinton, ora rese pubbliche
dal governo degli Stati Uniti, c’è un devastante scambio di e-mail tra Clinton e
il suo confidente Sid Blumenthal su Gheddafi e l’intervento degli Stati Uniti
coordinato nel 2011 per rovesciare il governante libico. Si tratta dell’oro
quale futura minaccia esistenziale al dollaro come valuta di riserva mondiale.
Si trattava dei piani di Gheddafi per il dinaro-oro per l’Africa e il mondo
arabo. Due paragrafi in una e-mail di recente declassificate dal server privato
illegalmente utilizzato dall’allora segretaria di Stato Hillary Clinton durante
la guerra orchestrata dagli Stati Uniti per distruggere la Libia di Gheddafi nel
2011, rivelano l’ordine del giorno strettamente segreto della guerra di Obama
contro Gheddafi, cinicamente chiamata “Responsabilità di proteggere”. Barack
Obama, presidente indeciso e debole, delegò tutte le responsabilità
presidenziali della guerra in Libia alla segretaria di Stato Hillary Clinton,
prima sostenitrice del “cambio di regime” arabo utilizzando in segreto i
Fratelli musulmani ed invocando il nuovo bizzarro principio della
“responsabilità di proteggere” (R2P) per giustificare la guerra libica, divenuta
rapidamente una guerra della NATO. Con l’R2P, concetto sciocco promosso dalle
reti dell’Open Society Foundations di George Soros, Clinton affermava, senza
alcuna prova, che Gheddafi bombardasse i civili libici a Bengasi. Secondo il New
York Times, citando fonti di alto livello dell’amministrazione Obama, fu Hillary
Clinton, sostenuta da Samantha Power, collaboratrice di primo piano al Consiglio
di Sicurezza Nazionale e oggi ambasciatrice di Obama alle Nazioni Unite, e Susan
Rice, allora ambasciatrice di Obama alle Nazioni Unite, e ora consigliere per la
Sicurezza Nazionale, che spinse Obama all’azione militare contro la Libia di
Gheddafi. Clinton, affiancata da Powers e Rice, era così potente che riuscì a
prevalere sul segretario alla Difesa Robert Gates, Tom Donilon, il consigliere
per la sicurezza nazionale di Obama, e John Brennan, capo antiterrorismo di
Obama ed oggi capo della CIA. La segretaria di Stato Clinton guidò la
cospirazione per scatenare ciò che venne soprannominata “primavera araba”,
l’ondata di cambi di regime finanziati dagli USA nel Medio Oriente arabo,
nell’ambito del progetto del Grande Medio Oriente presentato nel 2003
dall’amministrazione Bush dopo l’occupazione dell’Iraq. I primi tre Paesi
colpiti dalla “primavera araba” degli USA nel 2011, in cui Washington usò le sue
ONG per i “diritti umani” come Freedom House e National Endowment for Democracy,
in combutta come al solito con le Open Society Foundations dello speculatore
miliardario George Soros, insieme al dipartimento di Stato degli Stati Uniti e
ad agenti della CIA, furono la Tunisia di Ben Ali, l’Egitto di Mubaraq e la
Libia di Gheddafi. Ora tempi e obiettivi di Washington della destabilizzazione
via “primavera araba” del 2011 di certi Stati in Medio Oriente assumono nuova
luce in relazione alle email declassificate sulla Libia di Clinton con il suo
“consulente” e amico Sid Blumenthal. Blumenthal è l’untuoso avvocato che difese
l’allora presidente Bill Clinton nello scandalo sessuale di Monika Lewinsky
quando era Presidente e affrontava l’impeachment. Per molti rimane un mistero
perché Washington abbia deciso che Gheddafi dovesse essere ucciso, e non solo
esiliato come Mubaraq. Clinton, quando fu informata del brutale assassinio di
Gheddafi da parte dei terroristi di al-Qaida dell' “opposizione democratica”
finanziata dagli USA, pronunciò alla CBS News una perversa parafrasi di Giulio
Cesare, “Siamo venuti, l’abbiamo visto, è morto” con una fragorosa risata
macabra. Poco si sa in occidente di ciò che Muammar Gheddafi fece in Libia o
anche in Africa e nel mondo arabo. Ora, la divulgazione di altre e-mail di
Hillary Clinton da segretaria di Stato, al momento della guerra di Obama a
Gheddafi, getta nuova drammatica luce. Non fu una decisione personale di Hillary
Clinton eliminare Gheddafi e distruggerne lo Stato. La decisione, è ormai
chiaro, proveniva da ambienti molto potenti dell’oligarchia monetaria degli
Stati Uniti. Era un altro strumento a Washington del mandato politico di tali
oligarchi. L’intervento era distruggere i piani ben definiti di Gheddafi per
creare una moneta africana e araba basata sull’oro per sostituire il dollaro nei
traffici di petrolio. Da quando il dollaro USA ha abbandonato il cambio in oro
nel 1971, il dollaro rispetto all’oro ha perso drammaticamente valore. Gli Stati
petroliferi dell’OPEC hanno a lungo contestato il potere d’acquisto evanescente
delle loro vendite di petrolio, che dal 1970 Washington impone esclusivamente in
dollari, mentre l’inflazione del dollaro arrivava ad oltre il 2000% nel 2001. In
una recentemente declassificata email di Sid Blumenthal alla segretaria di Stato
Hillary Clinton, del 2 aprile 2011, Blumenthal rivela la ragione per cui
Gheddafi andava eliminato. Utilizzando il pretesto citato da una non
identificata “alta fonte”, Blumenthal scrive a Clinton, “Secondo le informazioni
sensibili disponibili a questa fonte, il governo di Gheddafi detiene 143
tonnellate di oro e una quantità simile in argento… l’oro fu accumulato prima
della ribellione ed era destinato a creare una valuta panafricana basata sul
dinaro d’oro libico. Questo piano era volto a fornire ai Paesi africani
francofoni un’alternativa al franco francese (CFA)“. Tale aspetto francese era
solo la punta dell’iceberg del dinaro d’oro di Gheddafi. Nel primo decennio di
questo secolo, i Paesi OPEC del Golfo persico, tra cui Arabia Saudita, Qatar e
altri, iniziarono seriamente a deviare una parte significativa dei ricavi delle
vendite di petrolio e gas sui fondi sovrani, basandosi sul successo dei fondi
petroliferi norvegesi. Il crescente malcontento verso la guerra al terrorismo
degli Stati Uniti, con le guerre in Iraq e Afghanistan e la loro politica in
Medio Oriente dal settembre 2001, portò la maggior parte degli Stati arabi
dell’OPEC a deviare una quota crescente delle entrate petrolifere su fondi
controllati dallo Stato, piuttosto che fidarsi delle dita appiccicose dei
banchieri di New York e Londra, come era solito dagli anni ’70, quando i prezzi
del petrolio schizzarono alle stelle creando ciò che Henry Kissinger
affettuosamente chiamò “petrodollaro” per sostituire il dollaro-oro che
Washington mollò il 15 agosto 1971. L’attuale guerra tra sunniti e sciiti o lo
scontro di civiltà sono infatti il risultato delle manipolazioni degli Stati
Uniti nella regione dal 2003, il “divide et impera”. Nel 2008 la prospettiva del
controllo sovrano in un numero crescente di Stati petroliferi africani ed arabi
dei loro proventi su petrolio e gas causava gravi preoccupazioni a Wall Street e
alla City di Londra. Un’enorme liquidità, migliaia di miliardi, che
potenzialmente non potevano più controllare. La primavera araba, in
retrospettiva, appare sempre più sembra legata agli sforzi di Washington e Wall
Street per controllare non solo gli enormi flussi di petrolio dal Medio Oriente
arabo, ma ugualmente lo scopo era controllarne il denaro, migliaia di miliardi
di dollari che si accumulavano nei nuovi fondi sovrani. Tuttavia, come
confermato dall’ultimo scambio di email Clinton-Blumenthal del 2 aprile 2011,
dal mondo petrolifero africano e arabo emergeva una nuova minaccia per gli “dei
del denaro” di Wall Street e City di Londra. La Libia di Gheddafi, la Tunisia di
Ben Ali e l’Egitto di Mubaraq stavano per lanciare la moneta islamica
indipendente dal dollaro USA e basata sull’oro. Mi fu detto di questo piano nei
primi mesi del 2012, in una conferenza finanziaria e geopolitica svizzera, da un
algerino che sapeva del progetto. La documentazione era scarsa al momento e la
storia mi passò di mente. Ora un quadro molto più interessante emerge indicando
la ferocia della primavera araba di Washington e l’urgenza del caso della Libia.
Nel 2009 Gheddafi, allora Presidente dell’Unione africana, propose che il
continente economicamente depresso adottasse il “dinaro d’oro”. Nei mesi
precedenti la decisione degli Stati Uniti, col sostegno inglese e francese, di
aver una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per aver la
foglia di fico del diritto alla NATO di distruggere il regime di Gheddafi,
Muammar Gheddafi organizzò la creazione del dinaro-oro che sarebbe stato
utilizzato dagli Stati africani petroliferi e dai Paesi arabi dell’OPEC per
vendere petrolio sul mercato mondiale. Al momento Wall Street e City di Londra
erano sprofondati nella crisi finanziaria del 2007-2008, e la sfida al dollaro
quale valuta di riserva l’avrebbe aggravata. Sarebbe stata la campana a morto
per l’egemonia finanziaria statunitense e il sistema del dollaro. L’Africa è uno
dei continenti più ricchi del mondo, con vaste inesplorate ricchezze in minerali
ed oro, volutamente mantenuto per secoli sottosviluppato o preda di guerre per
impedirne lo sviluppo. Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale negli
ultimi decenni furono gli strumenti di Washington per sopprimere un vero
sviluppo africano. Gheddafi invitò i Paesi produttori di petrolio africani
dell’Unione africana e musulmani ad entrare nell’alleanza che avrebbe fatto del
dinaro d’oro la loro valuta. Avrebbero venduto petrolio e altre risorse a Stati
Uniti e resto del mondo solo in dinari d’oro. In qualità di Presidente
dell’Unione africana, nel 2009 Gheddafi presentò all’Unione Africana la proposta
di usare il dinaro libico e il dirham d’argento come unico denaro con cui il
resto del mondo poteva comprare il petrolio africano. Insieme ai fondi sovrani
arabi dell’OPEC, le altre nazioni petrolifere africane, in particolare Angola e
Nigeria, creavano i propri fondi nazionali petroliferi quando nel 2011 la NATO
bombardava la Libia. Quei fondi nazionali sovrani, legati al concetto del dinaro
d’oro di Gheddafi, avrebbe realizzato il vecchio dell’Africa indipendente dal
controllo monetario coloniale, che fosse sterlina, franco francese, euro o
dollaro statunitense. Gheddafi attuava, come capo dell’Unione africana, al
momento dell’assassinio, il piano per unificare gli Stati sovrani dell’Africa
con una moneta d’oro negli Stati Uniti d’Africa. Nel 2004, il Parlamento
panafricano di 53 nazioni aveva piani per la Comunità economica africana, con
una moneta d’oro unica entro il 2023. Le nazioni africane produttrici di
petrolio progettavano l’abbandono del petrodollaro e di chiedere pagamenti in
oro per petrolio e gas; erano Egitto, Sudan, Sud Sudan, Guinea Equatoriale,
Congo, Repubblica democratica del Congo, Tunisia, Gabon, Sud Africa, Uganda,
Ciad, Suriname, Camerun, Mauritania, Marocco, Zambia, Somalia, Ghana, Etiopia,
Kenya, Tanzania, Mozambico, Costa d’Avorio, oltre allo Yemen che aveva appena
scoperto nuovi significativi giacimenti di petrolio. I quattro Stati africani
nell’OPEC, Algeria, Angola, Nigeria, gigantesco produttore di petrolio e primo
produttore di gas naturale in Africa dagli enormi giacimenti di gas, e la Libia
dalle maggiori riserve, avrebbero aderito al nuovo sistema del dinaro d’oro. Non
c’è da stupirsi che il presidente francese Nicolas Sarkozy, che da Washington
ricevette il proscenio della guerra contro Gheddafi, arrivò a definire la Libia
una “minaccia” alla sicurezza finanziaria del mondo. Una delle caratteristiche
più bizzarre della guerra di Hillary Clinton per distruggere Gheddafi fu che i
“ribelli” filo-USA di Bengasi, nella parte petrolifera della Libia, nel pieno
della guerra, ben prima che fosse del tutto chiaro che avrebbero rovesciato il
regime di Gheddafi, dichiararono di aver creato una banca centrale di tipo
occidentale “in esilio”. Nelle prime settimane della ribellione, i capi
dichiararono di aver creato una banca centrale per sostituire l’autorità
monetaria dello Stato di Gheddafi. Il consiglio dei ribelli, oltre a creare la
propria compagnia petrolifera per vendere il petrolio rubato, annunciò: “la
nomina della Banca Centrale di Bengasi come autorità monetaria competente nelle
politiche monetarie in Libia, e la nomina del governatore della Banca centrale
della Libia, con sede provvisoria a Bengasi”. Commentando la strana decisione,
prima che l’esito della battaglia fosse anche deciso, di creare una banca
centrale per sostituire la banca nazionale sovrana di Gheddafi che emetteva
dinari d’oro, Robert Wenzel del Economic Policy Journal, osservò, “non ho mai
sentito parlare di una banca centrale creata poche settimane dopo una rivolta
popolare. Ciò suggerisce che c’è qualcos’altro che non una banda di straccioni
ribelli e che ci sono certe piuttosto sofisticate influenze”. È chiaro ora, alla
luce dei messaggi di posta elettronica Clinton-Blumenthal, che tali “influenze
abbastanza sofisticate” erano legate a Wall Street e City di Londra. La persona
inviata da Washington a guidare i ribelli nel marzo 2011, Qalifa Haftar, aveva
trascorso i precedenti venti anni in Virginia, non lontano dal quartier generale
della CIA, dopo aver lasciato la Libia quando era uno dei principali comandante
militari di Gheddafi. Il rischio per il futuro del dollaro come valuta di
riserva mondiale, se Gheddafi avesse potuto procedere insieme a Egitto, Tunisia
e altri Stati arabi di OPEC e Unione Africana, introducendo le vendite di
petrolio in oro e non dollari, sarebbe stato chiaramente l’equivalente
finanziario di uno tsunami. Il sogno di Gheddafi di un sistema basato sull’oro
arabo e africano indipendente dal dollaro, purtroppo è morto con lui. La Libia,
dopo la cinica “responsabilità di proteggere” di Hillary Clinton che ha
distrutto il Paese, oggi è lacerata da guerre tribali, caos economico,
terroristi di al-Qaida e SIIL. La sovranità monetaria detenuta dal 100% dalle
agenzie monetarie nazionali statali di Gheddafi e la loro emissione di dinari
d’oro, è finita sostituita da una banca centrale “indipendente” legata al
dollaro. Nonostante ciò, va notato che ora un nuovo gruppo di nazioni si unisce
per costruire un sistema monetario basato sull’oro. Questo è il gruppo guidato
da Russia e Cina, terzo e primo Paesi produttori di oro nel mondo. Questo gruppo
è legato alla costruzione del grande progetto infrastrutturale eurasiatico della
Nuova Via della Seta della Cina, comprendente 16 miliardi di fondi in oro per lo
sviluppo della Cina, decisa a sostituire City di Londra e New York come centri
del commercio mondiale dell’oro. L’emergente sistema d’oro eurasiatico pone ora
una serie completamente nuova di sfide all’egemonia finanziaria statunitense.
Questa sfida eurasiatica, riuscendo o fallendo, deciderà se la nostra civiltà
potrà sopravvivere e prosperare in condizioni completamente diverse, o affondare
con il fallimentare sistema del dollaro. F. William Engdahl è consulente di
rischio strategico e docente, laureato in politica alla Princeton University, è
autore di best-seller su petrolio e geopolitica, in esclusiva per la rivista
online “New Eastern Outlook”. Traduzione del 12 luglio 2016 di Alessandro
Lattanzio – SitoAurora.
Modesto contributo alla chiacchiera su guerra di
religione. In forma di catechismo, scrive Maurizio Blondet il 29 luglio 2016. Un
caro lettore, travolto come tutti dallo stato d’animo collettivo indotto, mi ha
scritto: “Stamani tutti i media riportano queste parole di Bergoglio che quella
in essere non è una guerra di religione. Ovviamente il senso della gente comune
sa che questa è una menzogna. Non riesco a capire la logica di questo messaggio
subito ripreso, ad esempio, dal presidente della repubblica. Spero possa
accennare una risposta in un suo prossimo articolo. La ringrazio. Prego per Lei
e la sua famiglia.” Mi sono quindi risolto a riportare qualche argomento di cui
il nostro amico - e chiunque vorrà interloquire nella chiacchiera frenetica
sulla guerra di religione in corso - potrà fare riferimento. Sul terrorismo
islamico, riporto fatti incontrovertibili. Sotto forma di catechismo, così spero
sia più semplice. Il terrorismo islamico non esisteva “prima”. Esisteva il
terrorismo islamico, “prima”? Ossia quando l’Afghanistan era sotto un governo
comunista, l’Irak sotto Saddam Hussein, l’Egitto governato da Mubarak, la Siria
dalla famiglia Assad e la Libia da Gheddafi? No. Quelli erano regimi laici,
modernizzanti, nazionalisti – ossia promotori attivi dell’unità nazionale, al
disopra delle plurime entità etniche e religiose che governavano. Per questo
erano ostili ad ogni islamismo settario. Lo tenevano a freno, se si manifestava
nel loro stati. In Irak e in Siria, le minoranze cristiane erano rispettate
e spesso, anzi, erano la spina dorsale di quei regimi. Chi ha fatto cadere quei
regimi con forze militari imponenti, destabilizzandone i paesi, gettandoli nel
caos e nella guerra intestina? Gli Stati Uniti: alla testa di coalizioni
occidentali, a cui hanno partecipato Gran Bretagna, Francia, stati membri della
NATO oppure no, come Australia o Polonia (nella prima guerra del Golfo); la NATO
ha preso il controllo dell’Afghanistan (missione ISAF). Per quale motivo
l’Occidente a guida americana ha messo a ferro e fuoco quei paesi, massacrato i
loro governanti anti-islamisti, e li ha gettati nel caos in mano a forze
settarie? In esecuzione del piano israeliano (detto Piano Kivunim) che dal 1982
propugnava la spaccatura di questi Stati “secondo le loro linee di frattura
etniche e religiose”. Nella rivista ebraica Kivunim, si leggeva al proposito:
“l’Iraq, ricco di petrolio e lacerato internamente, è sicuramente un candidato
degli obiettivi d’Israele. La sua dissoluzione è ancora più importante per noi
di quella della Siria. L’Iraq è più forte della Siria. … Ogni confronto
inter-arabo ci aiuterà nel breve periodo e accorcerà la strada all’obiettivo più
importante, spezzare l’Iraq in domini come Siria e Libano. In Iraq, la divisione
in province lungo linee etno-religiose, come in Siria durante il periodo
ottomano, è possibile. Così esisteranno almeno tre Stati attorno alle tre
principali città: Bassora, Baghdad e Mosul, e le aree sciite del sud si
separeranno dal nord sunnita e curdo. … L’intera penisola arabica è un candidato
naturale della dissoluzione su pressioni interne ed esterne, e la questione è
inevitabile soprattutto per l’Arabia Saudita”. Israele non poteva sentirsi
sicura senza creare il caos attorno a sé. Ma perché il governo Usa avrebbe
aderito a questo piano? Perché vi conversero gli interessi petroliferi
(esemplificati da Dick Cheney, presidente della Halliburton) e il sistema
militare-industriale. Si aggiunga il regno dei Saud, che vide il proprio
interesse in questo progetto per ragioni settarie: portatore della versione più
reetriva del Sunnismo (il wahabismo) voleva distruggere gli Sciit, e
segnatamente l’Iran. Quando Bush figlio prese la presidenza, attorno a lui
tutto era pronto per questo progetto. Quando si è sentito parlare per la prima
volta di “terrorismo islamico”? L’11 Settembre 2001, quando gli Stati Uniti sono
stati proditoriamente aggrediti da un gruppo di terroristi islamici che hanno
dirottato dei Boeing e li hanno lanciati contro le Twin Tower e il Pentagono,
facendo oltre 3 mila morti. I terroristi erano guidati da Osama Bin Laden. Chi
era Osama Bin Laden? Era un miliardario saudita la cui famiglia è amica, e
socia in affari, della famiglia Bush. Aiutò gli americani a rovesciare il regime
comunista in Afghanistan negli anni ’80; per loro arruolò migliaia di
combattenti in tutto il Medio Oriente per mandarli a debellare i sovietici: con
armamenti americani, e instaurare un regime religioso’, composto dai Talebani
(studenti islamici preparati in Pakistan). Questa organizzazione agli ordini
americani si chiamava Al Qaeda (database – l’elenco degli arruolati). Quando Bin
Laden è diventato nemico degli Usa? Improvvisamente. Ancora il 9 settembre 2001,
due sue uomini (fingendosi giornalisti) uccisero il generale Massoud, il Leone
del Panshir, inviso agli americani perché sarebbe stato in grado – come eroe
nazionale – di unificare e stabilizzare l’Afghanistan. L’intelligence francese
sostenne che il capostazione della Cia andò a far visita a Bin Laden
all’ospedale americano di Dubai a luglio, dove era ricoverato per dialisi. Lo
scrisse il Figaro, senza essere smentito. Dunque il 9 settembre era ancora
amico, e il 21 era divenuto nemico degli Usa. Ma queste sono ipotesi
complottiste, che non si possono dimostrare! Lo disse il generale Wesley Clark,
che era stato capo della NATO durante l’intervento in Kossovo: il giorno dopo
l’11 Settembre, andò al Pentagono e un ufficiale suo amico, che aveva appena
parlato col ministro (Donald Rumsfeld), lo chiamò nell’ufficio, chiuse la porta
e gli sussurrò, incredulo: “Andiamo ad attaccare 7 paesi in 5 anni. Adesso
cominciamo con l’Irak, poi Siria, Libano, Libia, Somalia, Sudan, e per finire,
Iran”. D’accordo, però nella religione islamica è insita la violenza, il jihad,
la conversione forzata. Sì, certo. Però era un aspetto dormiente, e tenuto a
freno dai governi laici di Irak, Siria, Libia. Quell’aspetto atroce dell’Islam
fu risvegliato e istigato volontariamente. Gruppi fanatici furono armati ed
addestrati apposta. Anche questa è una teoria complottista senza alcuna prova!
Sempre il generale Wesley Clark – ricordo, l’ex comandante supremo NATO in
Europa – disse alla CNN kil 21 febbraio 2015: “Abbiamo reclutato Zeloti e
estremisti takfiri”, creato “un Frankenstein”; in quell’intervista spiegò anche:
“L’ISIS è stato creato dai nostri alleati per battere fino alla morte
Hezbollah”. Intendeva: creato dalla monarchia Saudita per debellare la
componente sciita che vive in Libano, Hezbollah. Dunque gli Usa avrebbero
creato, o lasciato creare, i movimenti terroristico-jihadisti, per poi
combatterli? Ma è assurdo! A che scopo? Secondo Samuel Huntington, che è il
principale scienziato politico americano, la cosa è utile al potere americano.
Egli scrisse nel 1996 un saggio, “Scontro di Civiltà e Nuovo Ordine Mondiale”,
in cui profetizzò che “la principale fonte di conflitti nel mondo post-Guerra
fredda diverranno le identità culturali e religiose”; non ci saranno più guerre
fra Stati fra “civiltà”. Di fatto, ragionava Huntington, dopo la caduta
dell’Urss dove trovare un nemico comune che tenga unito l’Occidente sotto la
guida americana? Lo scontro di civiltà era la risposta; e la lotta all’Islam,
una popolosa cultura “aliena” e poco solubile nel nuovo ordine mondiale, era
la soluzione. Che piaceva anche a Israele e alla lobby giudaica a Washington. E
questa strategia ha avuto successo? Sì, il piano Kivunim ha avuto successo.
Tutti i paesi islamici circostanti Israele, e quasi tutti quelli più lontani,
sono sconvolti da lotte intestine etnico-religiose: sciiti contro sunniti, curdi
contro turchi, cirenaici contro tripolitani, alawiti contro sunniti…. Nessuno
di questo tornerà più ad essere uno Stato ordinato, quindi che possa
rappresentare un pericolo politico o militare per Israele. Il progetto però è
incompiuto in due casi: l’Iran non è stato ancora destabilizzato (troppo grosso
e lontano), e i tentativi di Israele di indurre Washington a bombardarne le
centrali nucleari è andato finora a vuoto; e la Siria. Qui la caduta del regime
laico di Assad è stata sventata dalla Russia, che l’aiuta militarmente; ed anche
dal fatto che le minoranze siriane non si battono contro il regime in numero
sufficiente, né aderiscono al jihadismo di ISI e Al Qaeda, preferendo di fuggire
come profughi. Al punto che oggi a combattere in Siria contro Assad non sono le
opposizioni siriane, ma jihadisti ceceni, azeri, europei reclutati in Francia,
Belgio Gran Bretagna, e spesso attratti dalle paghe: reclutati come mercenari
coi soldi Sauditi e l’addestramento della Cia. Però adesso l’ISIS manda i suoi
terroristi in Europa. L’ISIS? Abbiamo visto che si tratta di una creazione
americano-saudita. Gli israeliani li sostengono nella lotta in Siria,
silenziosamente, curano i feriti del Califfato nei loro ospedali (esiste ampia
documentazione). Gli americani stanno ostacolando le azioni militari russe;
hanno intimato a Putin di non colpire Al Nusra (nome nuovo di Al Qaeda) perché
quelli sono “l’opposizione democratica” che intendono mettere al potere in
Siria, dopo detronizzato Assad. Comunque l’ISIS ha il suo daffare a
difendersi, altro che spedire jihadisti in Europa. Però rivendica tutti gli
attentati islamici che avvengono sempre più spesso in Europa. Le rivendicazioni
sono opportuniste. E lei è proprio sicuro che sia l’ISIS a farle?
Dopotutto, le rivendicazioni dell’ISI vengono diffuse dal SITE, un’azienda della
israeliano-americana Rita Katz. Sono tutte probabilmente false, create dalla
propaganda israeliana. Ma i jihadisti ammazzano davvero! A Nizza, a Rouen
hanno ammazzato il prete! Non è questa guerra di religione? E’ scontro di
civiltà come voleva Huntington. È strategia della tensione: qualcuno vuole
tenere gli europei nella paura. Diversi esponenti israeliani hanno detto:
“è bene che gli europei provino quello che proviamo noi, che quando andiamo al
ristorante non siamo sicuri di tornare a casa”, perché un palestinese può
accoltellarli. Anche certi governi europei possono trovare conveniente tenere i
loro cittadini nella tensione e nella paura, nel clima della lotta perpetua al
Nemico Islamico, che è fra noi e colpisce quando vuole. Il Piano Kivunim,
tradotto in inglese dall’ebraico dal compianto amico Israel Shahak. Come scrisse
Orwell nel suo “1984”, dove immagina uno stato totalitario futuro: “C’erano
attentati continui e ingiustificati. Fatti a caso. Servivano allo Stato per
limitare le libertà dei cittadini. Ad ogni attentato, si facevano leggi
restrittive della libertà!” Ma qui siamo in democrazia! Sì, certo. Hollande però
ha approfittato degli attentati per prolungare lo stato di emergenza, ossia
leggi restrittive della libertà dei cittadini. Ma non dirà che sono gli stessi
governi a indurre due diciannovenni islamici a sgozzare il povero prete a Rouen.
Quelli hanno agito spontaneamente, a nome dell’ISIS. Certamente. E’ un
meccanismo che noi italiani conosciamo bene. Negli anni di piombo, di strategia
della tensione, le Brigate Rosse commettevano omicidi; ebbene, più ne
commettevano, più trovavano favore nelle fabbriche e nelle scuole, fra frange
notevoli di studenti e di operai “di sinistra”. E anche molti intellettuali
simpatizzavano: “Né con lo stato né con le BR”, scrissero in molti. I più
giovani e suggestionabili, sognavano di arruolarsi nelle Brigate Rosse,
cercavano contatti, volevano andare in clandestinità – era uno stato d’animo
collettivo, ed era anche una moda travolgente. Oggi sappiamo che strategia
della tensione e BR erano “gestite” da servizi esteri e da Gladio,
organizzazione clandestina della NATO. Ma i giovani di allora erano sedotti da
quello stato d’animo, sparavano “spontaneamente”. Come i marginali di oggi in
Europa, col nome e cognome islamico, sono sedotti da un ISIS – che è una
creazione americana. Non mi ha convinto…Lo so. So che lei è sotto
influsso psico-emotivo dello stato d’animo collettivo che ci vuole spaventati:
l’Islam ci attacca! E’ una guerra di religione! Sì, è una guerra di religione.
Indotta, però, da centrali che hanno fatto di tutto per provocarla. Le centrali
di cui sopra vogliono che la civiltà europea venga devastata – come hanno voluto
la devastazione di Palmyra in Siria – e scompaia. Ma perché? Perché la cultura e
civiltà europea, greco-romana e cristiana, formava uomini liberi, e il potere
globale non vuole liberi, ma consumatori. Perché odiano Cristo e la sua
civiltà. Perché quelle centrali – diciamo, gli usurai (per usare un termine
poundiano) mai hanno avuto la capacità di edificare un Partenone, un Pantheon;
mai hanno prodotto nulla che ricordi anche lontanamente Fidia o Caravaggio, né
tra di loro è mai nato un Dostojewski, o uno Shakespeare o un Dante. I loro
scrittori sono dei pornografi. La loro “arte” è quella del MOMA di New York,
una bruttezza che si vendono e comprano tra loro a prezzi stratosferici;
bruttezza che si accompagna necessariamente alla menzogna e all’odio per il
Vero: Vero e Bello sono la stessa cosa, diceva Tommaso d’Aquino. Vogliono
renderci come loro. Spaventati e pieni d’odio e d’invidia per il genere umano.
Perché DAESH vuole Killary presidente.
Proprio come tutti i Katz, scrive Maurizio Blondet il
2 agosto 2016. Come si diceva, Daesh minaccia Putin il giorno dopo che Hillary
ha accusato Putin, coi suoi hackers, di aver diffuso le mail più discutibili su
di lei e il suo partito democratico. “Daesh per Hillary!”, era il nostro
titolo. Meno paradossale di quel che sembra: per forza Daesh aiuta la Clinton
a entrare nella Casa Bianca – dopo tutto quello che lei ha fatto per lui. La
cosa è saltata fuori, ma subito sepolta, dopo l’11 settembre 2012, il giorno in
cui l’ambasciatore americano Chris Stevens fu trucidato a Bengasi insieme ai
Marines che gli facevano da guardie del corpo, in un oscuro combattimento. Reso
più oscuro dal fatto che i commandos pronti a partire da Sigonella per
soccorrere l’ambasciatore – sarebbero arrivati in meno di mezz’ora – ricevettero
da Obama l’ordine di stand-down, ossia di non muoversi: dal che si sospetta che
Stevens sia stato deliberatamente sacrificato, per seppellire con lui una storia
sporca i cui liquami sarebbero schizzati fino alla Clinton. Hillary, Panetta
a desta e Dempsey mentono durante l’audizione al senato nel 2013. Questa vicenda
sporca consisteva nel fatto che Stevens era stato mandato a Bengazi per comprare
armamenti dai ribelli islamisti che avevano svuotato gli arsenali di Gheddafi,
onde inviarli ai jihadisti che combattevano contro il regime di Assad: lo
Stato Islamico, guarda caso, che per i media nasce proprio nel
2012, distaccandosi da Al Qaeda con tanto di comunicato ufficiale. In una
udienza al Senato del maggio 2012, Hillary Clinton – affiancata da Leon Panetta
allora segretario alla Difesa, e all’ammiraglio Dempsey (capo degli stati
maggiori) – negarono l’esistenza del piano per armare occultamente i terroristi
in Siria. O meglio: raccontarono che sì, avevano avuto l’idea, ne parlarono ad
Obama, ma lui la bocciò – sicché non se ne fece nulla. Lo stesso Bill Clinton
ha raccontato in un’intervista alla CNN che il piano esisteva e che lui l’aveva
raccomandato, ma niente. Menzogne su menzogne. Come ha dimostrato una
approfondita ed esplosiva inchiesta condotta da Aaron Klein. Il quale non è
solo ebreo, ma è anche un noto columnist del New York Times, ed oggi è capo
della redazione di Gerusalemme per il Breitbart News Network.
E il suo libro-accusa, “The REAL Benghazi
story: what the White House and Hillary don’t want you to know” è stato un best
seller nel 2014, quando è uscito. Che cosa ha
scoperto Klein? Che contrariamente alla versione ufficiale, Obama aveva
autorizzato l’operazione segreta (e illegale) di acquistare dai tagliagole
libici le armi per mandarle ai tagliagole siriani. Come l’ha scoperto? Nel
modo più facile: un lancio della Reuters che ai primi del 2012 rendeva noto
quanto segue: il presidente Obama ha firmato un ordine esecutivo “che permette
alla Cia ed altre agenzie di fornire sostegno ai ribelli per cacciare Assad”:
mandato “broadly”, ossia ampio e generico. Da attuarsi, aggiungeva
l’agenzia, attraverso un “centro di comando segreto operato dalla Turchia e i
suoi alleati” (sic). Sempre la Reuters, citando una “fonte Usa”, avvertiva però
che la Casa Bianca non aveva autorizzato l’invio di armi letali, “anche se certi
alleati Usa lo fanno” (sic). Che Chris Stevens fu mandato in Libia senza lo
status di ambasciatore, “a bordo di un cargo battente bandiera greca che portava
forniture e automezzi”, già durante la rivoluzione che eliminò Gheddafi. Il suo
compito? Diventare “il primo interlocutore fra l’amministrazione Obama e i
ribelli basati a Bengasi” – e fare il mercante d’armi. Era affiancato in
questo compito da un professionista: come rivelò lo steso New York Times nel
dicembre 2012, da un tale Marc Turi, definito dallo stesso medium mainstream “un
mercante d’armi americano che voleva fornire armamenti in Libia”, e per il quale
Stevens chiese al Dipartimento di Stato una autorizzazione – che è agli atti.
Anche dopo essere stato nominato ambasciatore, Stevens continuò – dice Klein –
a trattare armi coi tagliagole. Che membri armati della “Brigata Martiri 17
Febbraio” (tagliagole libici collegati alla Ansar al Sharia, definita
organizzazione terroristica dagli Usa) furono assunti dal Dipartimento di Stato
– ossia da Hillary – per fornire la “security interna a una missione speciale”
– ossia par di capire a far da guardie del corpo a Stevens, visto che non
essendo ancora ambasciatore non gli si potevano assegnare del Marines. Secondo
Klein, i capi della Brigata Martiri 17 Febbraio furono anche usati come
agevolatori, diciamo, della compravendita ai arsenali da mandare ai tagliagole
siriani. Nell’autorizzazione concessa ufficialmente dal Dipartimento di Stato a
Marc Turi, e risalente al maggio 2011, si legge che il Turi aveva “il progetto
di spedire armamenti del valore di 200 milioni di dollari al Katar” – uno dei
massimi nemici di Assad. Facile capire in che mani sarebbero finite quelle
armi. Una “grossa spedizione di armi da Bengasi ai ribelli siriani partì
nell’agosto 2012 (poche settimane prima la tragica fine di Stevens, 11
settembre) su una nave, e arrivò al porto turco di Iskenderum, a 35 chilometri
dalla frontiera con la Siria. Ufficialmente, portava aiuti umanitari. Altri
trasporti avvennero per via aerea in quel periodo. Il New York Times stesso
raccontò in uno dei suoi articoli che “da uffici in località segrete”, membri
dell’intelligence Usa “aiutavano i governi arabi a comprare armi – e “hanno
selezionato accuratamente (sic) i comandanti e i gruppi ribelli per
determinare chi di loro avrebbe ricevuto le armi all’arrivo”. La Reuters ha
intervistato il 18 giungo 2013 Abdul Basit Haroun, un ex capo della Brigata
Martiri 17 Febbraio, che ammise di essere il facilitatore di uno dei più grossi
invii di materiale bellico da Bengazi ai ribelli siriani; precisando che le armi
erano spedite in Turchia, da cui venivano contrabbandate ai terroristi siriani.
Secondo la testimonianza di un altro capo della Brigata, Ismail Salabi, questo
Haroun s’era messo in proprio costituendo una sua milizia, poco dopo. Aveva i
mezzi, visti i milioni di dollari che entrarono nell’affare, per mezzo di Marc
Turi. Naturalmente, quando poi Stevens fu attaccato e morì, si raccontò che era
a Bengasi per recuperare i MANPaD (missili anti-aerei a spalla) che si sapeva
erano negli arsenali saccheggiati da Gheddafi, e che i ribelli non volevano
dare. Un’operazione. Ma se era meritoria, perché Chris Stevens fu lasciato
trucidare e non salvato dalle Forze Speciali, che ascoltarono in diretta le
disperate richieste di aiuto che gli rivolgevano, mentre sparavano assediati
nella “casa sicura della Cia”, i Marines a Bengasi, quell’11 settembre 2012?
Perché ricevettero l’ordine di stand down? Se non per coprire il porcilaio
condotto dagli americani e dai loro terroristi preferiti? Probabilmente Stevens
fu ucciso, diciamo, nel corso di un litigio per soldi fra i “ribelli” e
l’americano; forse persino da elementi della Brigata che lo “proteggeva”. Si
doveva proteggere Hillary. La candidata che l’intero Establishment ha scelto, e
che sta cercando di imporre con tutti i mezzi contro il candidato Trump,
l’inaffidabile, o l’oggetto degli odii più frenetici, “il complice di Putin”
(come ha detto Leon Panetta alla convention democratica), la cui moglie “ha
posato nuda”, quello che sputa sui soldati medaglie d’oro solo perché islamici.
Ho paura che le elezioni saranno truccate, ha detto Trump. E perché tutto
questo? Perché, ha detto la stessa Hillary in una mail spifferata da Wikileaks,
“il modo migliore di aiutare Israele contro l’Iran e la sua crescente capacità
nucleare è aiutare il popolo di Siria a rovesciare il regime di Bashar Assad”.
Obama non ha mai ricevuto il capo della DIA. Eppure ci sono notizie succose. Il
generale Michael Flynn, già capo della DIA, ha fatto una rivelazione più
significativa delle nudità dell’ex modella moglie di Trump. Ha raccontato che
Obama, pur avendo nominato lui – generale Flynn – due volte come responsabile
dell’intelligence militare, non l’ha mai voluto incontrare di persona. Mai l’ha
convocato, in quattro anni. Come ha avuto modo di spiegare in un’altra
esplosiva intervista a Seymour Hersh, Flynn avrebbe messo in guardia dalle
losche operazioni che il Dipartimento di Stato, con la Cia, stava conducendo per
armare i tagliagole dell’IS. I quella stessa intervista, Flynn ha raccontato
come e qualmente lui, e l’ammiraglio Dempsey allora capo degli SM Riuniti,
mandarono a monte spedizioni di armi della Cia, collaborando con Putin e con
Assad. Roba da corte marziale. Se, s’intende, Obama avesse mai convocato Flynn
e chiesto spiegazioni. Non l’ha mai fatto. Non voleva sapere cosa facevano le
erinni del Dipartimento di Stato, armando e finanziando i terroristi islamici
che fingeva di combattere? O lo sapeva fin troppo bene? In ogni caso, giriamo la
notizia alla valorosa corrispondente RAI da New York, che per 200 mila euro
annui – da noi contribuenti pagati – copre quella sede prestigiosa e adora
Obama, e ovviamente sostiene la Clinton contro Trump. Magari un servizietto sul
generale Flynn e su come mai Obama non l’abbia mai voluto ascoltare né abbia mai
letto un suo rapporto in quattro anni? Gli diamo anche la fonte, pubblica.
E gli diamo lo scoop gratis, non deve spendere nessuno dei 200 mila euro annui
che riceve da noi. (Una lettura che farebbe bene anche ai giornalisti,
commentatori, cattoliconi che strillano sugli “islamisti che ci sgozzano in
chiesa”. Sì, quegli islamisti sono una creatura di queste operazioni sopra
descritte. Perché non lo dite mai?). Mentre finisco di scrivere, i giornali e
tg italiani sono tutti eccitati perché Obama “ha dato direttamente ordine” di
bombardare “i terroristi islamici dell’IS in Libia”. Certo, bisogna ripulire i
segni, gli indizi e i testimoni scomodi di quel che fece Hillary coi ribelli,
oggi IS, prima Al Qaeda, sempre un asset americano.
Ed altra condanna a morte ci attende.
Mario Giordano su Libero Quotidiano del 1 agosto
2016 vs islamici: "Andate pure a messa, ma la verità su Maometto è questa
qua" (devastante). Pubblichiamo Posta Prioritaria, la rubrica in cui Mario
Giordano risponde alla missiva di un lettore. Oggi si parla della differenza tra
Gesù e Maometto.
Caro Giordano, nella sua “posta prioritaria” lei,
oltre ad apprezzare giustamente quanto scritto dalla lettrice Marina Pacini, le
risponde evidenziando due differenze fondamentali tra cristianesimo e islam: il
cristianesimo ha avuto un Nuovo Testamento che ha superato il Vecchio Testamento
e ha un Papa che ne dà l’interpretazione valida per tutti i cristiani. È quello
che tutte le persone colte sostengono ma, a parer mio, sono due cose ineludibili
per i teologi ma superflue per i fedeli. Il Cristianesimo è nato quando Cristo è
sceso in terra e ha detto «Ama il prossimo tuo come te stesso» e «Non fare ad
altri ciò che non vuoi venga fatto a te»: con queste semplici ed inequivocabili
parole ha cancellato, emarginato tutta la violenza contenuta nei precedenti
testi sacri indicando, da quel momento in poi, la strada per separare il bene
dal male. Tutto il resto è teologia, importantissima, ma teologia: quello che
conta è Cristo con la sua parola che non può essere fraintesa. Confrontare
cristianesimo e islam sulla base di disquisizioni interpretative è deviante e
può divenire, grazie alla cultura dei “contendenti”, tanto cavilloso da perdere
di vista la realtà: Cristo ha predicato la pace, Maometto no. Punto. Nessuno può
uccidere in nome di Cristo (anche se è stato fatto, bestemmiando le sue parole),
chiunque può uccidere in nome di Maometto citando le sue parole. Punto. Roberto
Bellia, Vermezzo.
Grazie Roberto per la sua precisazione. È davvero
chiara, molto più chiara di come sono stato io in quelle poche righe che mi
erano rimaste alla fine dell'elenco delle sure improntate alla violenza del
Corano. Lei ha ragione da vendere, in effetti: è vero che in passato sono stati
commessi crimini orrendi in nome del cristianesimo, ma il cristianesimo è e
resta una religione di pace, così come è una religione di pace il buddismo. Ci
potrà pur essere qualche svitato nel mondo che uccide proclamandosi buddista, ma
la religione buddista resta in ogni modo una religione di pace. Allo stesso modo
ci sono stati troppi cristiani che hanno ucciso in nome di Cristo, ma il
messaggio di Cristo è «Ama il prossimo tuo come te stesso». Quello di Maometto
no. Quello di Maometto è un messaggio di violenza e di morte. E non rendersene
conto, o illudersi soltanto perché un gruppetto di musulmani fa finta di andare
a messa alla domenica, non è soltanto molto sbagliato. È soprattutto, come
ripetiamo da tempo, temo inutilmente, molto pericoloso...Mario Giordano.
"Corano, leggetevi questa roba...":
Mario Giordano il 30 luglio 2016, furia contro il libro sacro.
Pubblichiamo Posta Prioritaria, la rubrica in cui Mario Giordano risponde alla
missiva di un lettore. Oggi si parla di islam e delle più agghiaccianti sure del
Corano, dove si predica morte e conquista.
Caro Giordano, il Papa dicendo che le vere
religioni sono di pace, ha dimostrato di non conoscere il Corano e neppure il
Vecchio Testamento che è pieno di violenza. O forse lo sa ma continua a tenerci
calmi come quelli che suonavano sul Titanic. Continuiamo dunque a inneggiare i
nostri valori, che sono quelli che ci fanno accogliere amorosamente questi
invasati. Le mando qualche sura del Corano...Marina Pacini, Lucca.
La ringrazio, cara Marina, e riporto una parte del
suo agghiacciante elenco.
* Circa gli infedeli (coloro che non si
sottomettono all'Islam), costoro sono «gli inveterati nemici» dei musulmani
[Sura 4:101]. I musulmani devono «arrestarli, assediarli e preparare imboscate
in ogni dove» [Sura 9:95]. I musulmani devono anche «circondarli e metterli a
morte ovunque li troviate, uccideteli ogni dove li troviate, cercate i nemici
dell'Islam senza sosta» [Sura 4:90]. «Combatteteli finché l'Islam non regni
sovrano» [Sura 2:193].
«Tagliate loro le mani e la punta delle loro dita»
[Sura 8:12]
* Se un musulmano non si unisce alla guerra, Allah
lo ucciderà [Sura 9:93].
* I musulmani devono far guerra agli infedeli che
vivono intorno a loro [Sura 9:123]
* I musulmani devono essere «brutali con gli
infedeli» [Sura 48:29]
* Un musulmano può uccidere ogni persona che
desidera se è per «giusta causa» [Sura 6:152]
* Allah ama coloro che «combattono per la Sua
causa» [Sura 6:13]. Chiunque combatta contro Allah o rinunci all'Islam per
abbracciare un'altra religione deve essere «messo a morte o crocifisso o mani e
piedi siano amputati da parti opposte» [Sura 5:34]
* «Chiunque abiuri la sua religione islamica,
uccidetelo». [Sahih Al-Bukhari 9:57]
* «Assassinate gli idolatri ogni dove li troviate,
prendeteli prigionieri e assediateli e attendeteli in ogni imboscata» [Sura 9:5]
* «Prendetelo (l'infedele n.d.t.) ed incatenatelo
ed esponetelo al fuoco dell'inferno» [Sura 69:30]
* «Instillerò il terrore nel cuore dei non
credenti, colpite sopra il loro collo e tagliate loro la punta di tutte le dita»
[Sura 8:12]
* «Essi (gli infedeli ndr) devono essere uccisi o
crocefissi e le loro mani ed i loro piedi tagliati dalla parte opposta» [Sura
5:33]
(Qualcuno osa ancora dire che l’Islam è una
religione di pace? Aggiungo solo un dettaglio non irrilevante: anche nell’Antico
Testamento ci sono frasi ispirate alla violenza. Ma poi c’è il Nuovo Testamento
che lo reinterpreta e la Chiesa cattolica che ne dà la lettura ufficiale, valida
per ogni cristiano. Nell’Islam, come è noto, invece…)
"...allora creperemo tutti".
Islam, c'è solo una possibilità: la cupa profezia di Mario Giordano su “Libero
Quotidiano del 28 luglio 2016. Un altro mattacchione? Un altro pazzo isolato? Un
altro depresso? E adesso come reagirà l'Europa di fronte a un prete sgozzato in
chiesa, mentre dice messa, da due islamici che gridavano Allah Akbar?
Organizzerà un convegno di psichiatri? Si affiderà agli antidepressivi? Più
Prozac per tutti? Continueranno a raccontarci la favoletta dei malati di mente
che in quest' estate 2016, anziché mettersi in testa il cappello di Napoleone,
vanno in giro a massacrare cristiani? Insisteranno con le bugie, le
minimizzazioni, «per favore», «non generalizziamo», «i profughi non c' entrano
nulla», «l'Islam? Figuriamoci», «la nostra risposta sono le porte aperte» e già
che ci siamo «inauguriamo una mezza dozzina di moschee»? Davvero faranno così?
Ce lo dicano, perché nel caso prepariamo il collo: se non ci difenderemo,
infatti, finiremo presto tutti sgozzati. Proprio come quell' anziano sacerdote
sull' altare di Saint-Etienne-du-Rouveray. Il tempo è scaduto, ne abbiamo perso
fin troppo in chiacchiere e dibattiti da salotto. Adesso siamo arrivati all'ora
della scelta: o si combatte o si muore. O si capisce che c' è una guerra di
religione in corso o siamo già stati sconfitti. L'abbiamo già scritto tante
volte, ma adesso il nemico ha alzato il tiro: l'attacco a una chiesa, durante
una messa, con i fedeli e le suore prese in ostaggio, il prete scuoiato come un
agnello sacrificale sotto il crocifisso, nel pieno dell'Europa cristiana,
ebbene: un atto del genere dovrebbe aprire gli occhi anche ai più ottusi. Che
aspettiamo ancora? Che ci vengano a sgozzare nel Duomo di Milano? Nella basilica
di Assisi? O magari sotto il Cupolone di San Pietro? Il messaggio è già chiaro.
Vi ricordate la bandiera nera che sventolava sul Vaticano? Vi ricordate i
cristiani copti uccisi sul bagnasciuga della Libia per insanguinare il nostro
mare? Vi ricordare le minacce del Califfo, che ripeteva «arriveremo a Roma per
uccidere tutti gli infedeli»? Sembravano esagerazioni, paradossi, boutade.
Invece l'attacco è in corso. Houellebecq ha sbagliato tutto: la sottomissione
non avverrà in maniera pacifica, ma con le armi in pugno, non ci conquisteranno
con democratiche elezioni ma con il coltello per le decapitazioni. Di che cosa
abbiamo ancora bisogno per convincercene? Finora, fateci caso, hanno mantenuto
tutte le promesse. Anche nelle ultime settimane. Avevano annunciato attacchi in
Francia, e così è stato. Avevano annunciato attacchi in Germania, e così è
stato. Avevano annunciato attacchi in riva al mare, e c' è stata la strage sulla
passeggiata di Nizza. Avevano annunciato che sarebbe stata un'estate di sangue,
e così purtroppo è. Sono assassini, questi islamici, ma non cialtroni. A modo
loro, sono persone di parola: dicono che vogliono tagliare le teste, e zac, lo
fanno. Dicono che vogliono distruggere i cristiani, e zac, rispettano l'impegno.
Non mancano mai l'appuntamento con la morte, che per loro, per altro, significa
vergini in fiore e fiumi di latte. A noi lo sgozzamento, a loro il paradiso. E
di fronte a questo attacco frontale, davanti a questa offensiva violenta e
spregiudicata, l'Europa dei tremebondi che fa? L' avete sentita in questi
giorni: discute di pazzia, follia, gesti isolati, minimizza, specifica, precisa,
si perde nei distinguo, organizza sessioni plenarie sulle teorie dei discendenti
di Freud, si autoflagella, si colpevolizza, esulta se trova che un assassino
(iraniano) ha in casa una foto di Breivik («lo vedete: i cattivi siamo noi»),
erige processi sulla diffusione delle armi, come se le armi sparassero da sole,
«ah signora mia non sa com' è facile procurarsi una pistola» (in effetti, in
Europa non tanto: ma per un coltello basta entrare in cucina), si comporta come
se la colpa delle sparatorie fosse delle fabbriche di pistole e la colpa degli
sgozzamenti delle coltellerie. Alcuni giornali hanno persino messo sotto
processo i videogiochi (lo giuro: i videogiochi). Tutto pur di non dire la
piatta e brutale verità: il Corano ordina, i musulmani sgozzano. È la guerra
santa dell'Islam. Questa verità sta lì da tempo, sotto i nostri occhi, oggi è
rossa come il sangue di quel sacerdote. Ma noi non vogliamo ammetterla.
Preferiamo raccontarci balle, nascondere la verità, come hanno fatto
ripetutamente in questi giorni il governo francese, e forse anche quello
tedesco. Preferiamo non dire quello che sappiamo, e cioè che è in atto un
attacco coordinato e organizzato contro di noi. Preferiamo chiudere gli occhi,
liberare dalle carceri soggetti pericolosi, come uno di due assalitori della
Normandia, come i terroristi appena usciti a Bari, come tanti altri, preferiamo
esporci al rischio della morte piuttosto che al rischio della verità. È
pazzesco: sembra quasi che la civiltà occidentale, oggi, scelga di farsi
ammazzare piuttosto che ammettere di dover fare i conti con la religione
islamica. Sceglie di soccombere piuttosto che ammettere che i sacri principi
della tolleranza e del dialogo non possono funzionare sempre, perché se qualcuno
ti vuole uccidere non basta sventolargli in faccia la bandiera della pace. È
così duro prenderne atto che andiamo diritti verso la macellazione avvolti dal
nostro morbido involucro di bugie. Anche ieri, le prime dichiarazioni dopo lo
sgozzamento del prete, sono andate in questa direzione. Il premier francese ha
parlato di «barbaro attacco», il Papa ha «condannato l'odio». Come vedete, manca
una parola, sempre la stessa. Non sono stati i marziani ad attaccare ma gli
islamici, l'odio non nasce sotto il cavolo ma dentro le moschee. Noi continuiamo
a tacerlo. E perciò finiremo tutti come padre Jacques, 58 anni di sacerdozio,
lacerati con una lama al collo, mentre celebrava la messa del mattino nella sua
chiesa in Normandia. Se il Papa avesse le palle, lo dovrebbe proclamare santo
subito. San Jacques Martire, ucciso per difendere la nostra fede dall'
aggressione dei seguaci di Allah. Suona anche bene. Suona ormai un po' inutile,
però. Mario Giordano
L'altro volto della storia: l'attacco
della massoneria alla civiltà cristiana, scrive
Francesco Pio Meola. La nota di Giorgio Vitali. "L'articolo qui sotto, pur
provenendo da ambienti del conservatorismo cattolico, è esemplare e
assolutamente degno di essere preso in considerazione per le sue implicazioni
storiche e politiche. In effetti, per chi vuole fare politica, queste conoscenze
sono essenziali, nella misura in cui si riesce con facilità ad individuare le
linee di condotta che motivano certi personaggi della politica e quanto di una
qualsiasi iniziativa in campo politico nazionale o comunitario la componente
"ideologica" primaria sia quella maggiormente determinante nei confronti di una
quasi sempre poco probabile, necessità "contingente". Che a motivare i singoli
"uomini politici" ad iniziative di grande respiro pubblico siano l'appartenenza
a gruppi iniziatici con le loro credenze e le loro pratiche, è ampiamente
dimostrato l'appartenenza di questi "politici" a particolari organizzazioni più
o meno occulte. Ma il fatto che queste associazioni siano "occulte" non
significa nulla, perchè anche gli Organismi, specie quelli internazionali e/o
comunitari sono composti da individui selezionati sulla base dell'appartenenza a
queste organizzazioni. Non solo, in un libro che consiglio vivamente, ("L'altra
Europa", di Giorgio Galli e Paolo Rumor, ed. Hobby & Work, 2010, euro 16,50) si
dimostra con documenti attendibili l'appartenenza a gruppi esoterici di varia
natura dei cosiddetti "creatori dell'UE". In particolare il "cattolico" Maurice
Schumann. Un altro particolare importante è costituito da Giorgio Galli, famoso
politologo, anzi il primo vero politologo italiano, che per decenni ha fatto
della politologia un elemento di analisi della realtà nazionale e geopolitica.
Questo illustre professore universitario, già di area socialcomunista, giunto
alla fine della carriera, ha maturato l'esigenza di approfondire gli aspetti
"esoterici" dei rapporti politici sia nazionali che comunitari o internazionali.
Ciò significa che, partendo con intelligenza dall'analisi di superficie degli
avvenimenti, alla fine ha dovuto confrontarsi con una realtà ben più profonda di
quanto la sua cultura d'impostazione materialiste e razionalista gli permettesse
di "vedere". Nel suo intervento pubblicato nel libro sopra citato, trovandosi a
trattare della "Storia", che è una componente essenziale della base culturale su
cui si costruisce il comportamento delle èlites, egli scrive: «... La storia,
come teoria del comportamento umano, comprende non solo la "decostruzione", ma
anche la "costruzione" del mito». In altre parole, è la storia che costruisce il
mito, perchè gli storici sono persone per lo più motivate dalla necessità di
diffondere specifici "miti", come possiamo ben vedere in questi decenni post-
secondo conflitto mondiale, caratterizzati dalla costruzione di miti dal nulla
documentale. Infine è necessario ricordare che in un'opera recente, dedicata al
movimento teosofico d'inizio novecento, scritta da Marco Pasi dell'Università di
Amsterdam, ("Teosofia ed Antroposofia nell'Italia del primo novecento", in
Annale 25 della Storia d'ItaliaEinaudi, dedicata all'Esoterismo) si dimostra
quanto un movimento come quello citato, poco conosciuto e valutato fino ad oggi,
ad esclusione dei seguaci dell'Antroposofia, che aumentano sempre a livello
mondiale a fronte delle constatate conferme scientifiche e tecniche legate a
quell'impostazione culturale, o dei lettori di "Maschera e volto dello
spiritualismo contemporaneo " di J. Evola (prima ed. Bocca, 1931), abbia invece
permeato tutti gli aspetti della cultura italiana, dal Futurismo al Fiumanesimo,
fino all'elaborazione della pedagogia montessoriana ed all'istituzione del corso
universitario di Storia delle Religioni e dello Studio comparato di Storia delle
Religioni voluto da Raffaele Pettazzoni che scrisse anche "Teosofia e Storia
delle Religioni", per finire col noto Balbino Giuliano, ministro nel 1929,
autore del famoso decreto sul "giuramento dei professori". Su questa capacità di
una specifica cultura nell'influenzare il corso dei pensieri di una o più
generazioni, creando anche èlites capaci di imporre la loro ideologia, sarà
utile riprendere il dibattito." Giorgio Vitali.
La massoneria è una setta segreta le cui origini
risalgono alle corporazioni medievali inglesi e tedesche dei liberi muratori
(operativa). La Massoneria moderna (speculativa) s'ispira agli ideali
razionalisti e illuministi di Libertà, Uguaglianza e Fratellanza. Fu fondata a
Londra il 24 giugno 1717 dal rifugiato ugonotto Thèophile Desaguliers e dal
pastore anglicano James Anderson, i quali riassunsero i suoi principi nelle
cosiddette Costituzioni. Essa trae origine anche e soprattutto da un patrimonio
di scienze occulte che vanno dalla magia egizia e rinascimentale all'ebraismo
cabalistico-talmudico, dal platonismo al Manicheismo, dalla tradizione Rosa
Croce al vecchio paganesimo naturalista, dall'astrologia alla teosofia,
dall'alchimia ad altre fisime minori. Contiene elementi delle vecchie eresie
cristiane e si basa sulla fisica newtoniana. E'chiaro come questo concentrato di
dottrine esoteriche non poteva che provocare la scomunica della Chiesa, che l'ha
condannata per quasi ben 580 volte, detenendo il primato assoluto. L'insieme di
tutte queste tradizioni trova unità nella Gnosi. Essa è una speciale conoscenza
religiosa dalla quale per rivelazione, indipendentemente dalla fede e dalle
opere, deriva la salvezza, ossia da una sorta di "illuminazione", riservata solo
a pochi iniziati. Si noti come questa idea sia radicalmente contraria alla fede
cattolica, la quale invece proclama che la salvezza è accessibile a tutti. La
Gnosi pretende di concepire il reale come qualcosa di totalmente negativo, per
cui viene, di conseguenza, la necessità di aspirare a una sorta di palingenesi,
di trasformazione totale, da cui potrà realizzarsi un mondo completamente nuovo,
e in cui potrà vivere un uomo completamente nuovo, contrassegnato da una
perfetta autosufficienza (C. Gnerre). Il fenomeno gnostico è come un fiume
carsico, ritornando improvvisamente in auge nelle varie epoche storiche.
Pensiamo alle vecchie eresie cristiane, a quella catara soprattutto, la più
pericolosa, al modernismo e a tutte le religioni diverse dalla cattolica o
ortodossa, Islam e Giudaismo compresi. Lo gnosticismo sostiene l'opposizione tra
lo spirito (il bene) e la materia (il male). Gli gnostici sostengono che un Dio
buono non può aver creato un mondo così malvagio, quindi la sua creazione è da
disprezzare, mentre il principio del male, Satana, sarebbe il dio buono, il
serpente che sedusse Eva e che indusse al peccato Adamo. Da qui la leggenda
massonica di Adamo come "primo iniziato", e come lui sono considerati Gesù, S.
Giovanni Battista (la Massoneria è nata il 24 giugno), Mosè, Maometto, Buddha,
S. Francesco, Lutero, ecc . Per quanto riguarda Cristo e il Battista basta
pensare alle folli elucubrazioni gnostiche del "Codice da Vinci" del seguace New
Age Dan Brown, mentre S. Francesco oggi è considerato un profeta pacifista ed
ecologista. Furono invece influenzati dalla gnosi Lutero, Buddha e Maometto.
Mons. Leone Meurin, un sacerdote francese del XIX sec, per tutti questi motivi
nella sua opera "La Frammassoneria sinagoga di Satana", considerava la Gnosi il
culto di Lucifero, l'angelo decaduto portatore di luce, l'illuminato, il più
grande iniziato. In molti testi esoterici Lucifero è accostato a Prometeo, la
figura mitologica ribelle a Zeus che voleva donare il fuoco agli uomini, a
Dioniso, dio dell'orgia e del divertimento sfrenato, al buddha, inteso come
l'individuo iniziato ("buddha" significa appunto "l'illuminato"). I massoni
usano chiamarsi tra loro "fratelli"; si distinguono in vari gradi, tra i quali
gli apprendisti, i compagni, i maestri, i sublimi cavalieri eletti, i grandi
maestri architetti, ecc. Si raccolgono in logge presiedute da un venerabile; più
logge associate costituiscono una gran loggia, presieduta da un gran maestro,
mentre nell'ambito di uno Stato tutte le logge dipendono da un grande oriente.
La Massoneria venera un dio impersonale (il "Dio orologiaio" degli illuministi)
chiamato Grande Architetto dell'Universo o Essere Supremo. Essa ha vari riti e
obbedienze. Tra i riti più importanti ricordiamo quello scozzese, inglese,
nazionale spagnolo, egizio (detto anche di Menfi e Misraim), simbolico italiano,
swedemborghiano, noachita, ecc. Il più importante è quello scozzese, che si rifà
all'esoterismo templare e ha 33°, tra cui i più alti sono quelli dal 18° in poi.
Quando si parla di templarismo in massoneria in realtà viene ripresa una
tradizione in parte errata, scorretta e diffamatoria. L'obbedienza più
importante al mondo è quella che fa capo alla Gran Loggia Unita d'Inghilterra,
detta anche "Sancti Quatuor Coronati", che ha per gran maestro il duca di Kent
(attualmente è il principe Edoardo Windsor). Per le sue posizioni deiste, non
riconosce la maggiore obbedienza francese, il Grande Oriente di Francia, che è
violentemente antireligiosa e ammette anche gli atei. Le massonerie scandinave
hanno una particolarità: riconoscono come gran maestro il re dei loro rispettivi
stati; ad esempio in Svezia è l'attuale re Carlo Gustavo XVI. Esistono anche
massonerie esclusive come la Prince Hall negli USA che ammette solo personalità
afroamericane, di cui ne fa parte il presidente americano Barack Obama, oppure
la B'nai B'rith, riservata ai soli ebrei. Caratteristiche fondamentali delle
logge sono la segretezza e l'esclusione delle donne, anche se ci sono obbedienze
rigorosamente femminili o addirittura miste come la Gran Loggia d'Italia di
piazza del Gesù. L'Inghilterra di inizio '700 era vista dalla nobiltà liberale
europea un faro di civiltà, soprattutto per il suo ordinamento
monarchico-costituzionale. Le caste aristocratiche illuminate anglofile erano
ambiziose e gelose delle prerogative tradizionali dei re e volevano limitarle.
Si studiavano i principi costituzionali britannici con l'ansia di esportare gli
ideali illuministi. La nobiltà europea era affascinata dal costituzionalismo,
dal deismo, dalla tolleranza religiosa e dal liberismo economico. Insieme a
tutte queste suggestioni provenienti da oltre Manica, cominciò a diffondersi la
massoneria, dapprima in Olanda, Francia, Germania (Hannover) e poi negli altri
paesi europei, tra cui l'Italia; il primo libero muratore italiano fu il medico
beneventano Antonio Cocchi, iniziato a Firenze nel 1732 alla loggia detta "degli
Inglesi". In Francia uno degli esponenti dell'aristocrazia anglofila fu il
barone Charles de Montesquieu, grande teorico del liberalismo e del
costituzionalismo, uno dei padri riconosciuti dell'Illuminismo. La Massoneria
francese cominciò quasi subito a rivendicare una certa autonomia, ispirandosi
all'esoterismo templare e dandosi un'impostazione di tipo cavalleresca;
raccoglieva gli esponenti nobili e alto-borghesi riformatori che si fecero
portavoce di quel clima culturale che portò alla stagione dell'enciclopedismo
illuminista che ha avuto per protagonisti Diderot, D'Alembert e Voltaire. La
critica enciclopedista attaccava la società di Ancièn Règime, la Chiesa
Cattolica, vista come fonte di oscurantismo, pregiudizi e superstizione, i
privilegi nobiliari che causavano diseguaglianze, la storia passata, considerata
inutile e piena di errori; esaltava invece il pensiero scientista, la libertà in
tutte le sue forme, l'uguaglianza sociale, il progresso in tutti i campi, la
fratellanza tra gli esseri umani e il potere illimitato della ragione,
identificata come strumento infallibile di indagine della realtà. Lo spirito
corrosivo dei liberi pensatori, impregnato di razionalismo e di scetticismo
antireligioso, provocò nel 1738 la scomunica da parte della Chiesa, con la bolla
di papa Benedetto XIV. In quegli anni la Massoneria prendeva sempre più,
soprattutto in Francia, una piega politica radicale e antidispotica; in
Inghilterra si tenne invece favorevole al mantenimento dell'ordine
costituzionale, appoggiando il partito liberale whig. Intanto però le logge si
diffusero anche nelle colonie americane. Nel 1751 fu pubblicato quel feroce
manifesto anticristiano che fu l'Enciclopedia di Diderot e D'Alembert, diretta
emanazione delle logge che preparò una forte ostilità nei confronti della
tradizione e del cattolicesimo. Un altro illuminista franco-svizzero, Rousseau,
teorizzò la "democrazia totalitaria", ossia il rovesciamento violento
dell'ordine costituito in favore di un governo popolare, in cui la moltitudine
avrebbe delegato il potere a propri rappresentanti in grado di interpretare "la
volontà generale", in pratica la prefigurazione del Terrore giacobino della
Rivoluzione francese. Nel periodo pre-rivoluzionario furono pubblicati migliaia
di libri, pamphlet, riviste, giornali, tutti tesi a screditare e a diffamare la
Corona di Francia e la Chiesa cattolica. Il 1776 fu l'anno dell'indipendenza
delle 13 colonie americane dalla madrepatria inglese; i capi del movimento
anticoloniale da George Washington a Thomas Jefferson, da Benjamin Franklin a
John Adams, erano tutti massoni. Il marchese francese di La Fayette, che era un
"fratello" e aveva combattuto a loro fianco, sperava che un giorno anche in
Francia si potesse lottare per gli ideali rivoluzionari. La Massoneria francese
nel frattempo infiltrava suoi uomini nelle istituzioni ecclesiastiche e a corte:
il banchiere ginevrino Jacques Necker, ministro delle finanze di Luigi XVI, il
cugino del re, il duca Filippo d'Orléans, detto in seguito anche Philippe
Egalitè, per il suo acceso fervore rivoluzionario, Jacques Roux , soprannominato
il "curato rosso", e l'abate Sieyès. Obiettivo principale era disintegrare il
sistema dal di dentro. L'anno stesso della Rivoluzione americana, il 1° maggio
1776 fu fondata a Ingolstadt, grazie all'appoggio finanziario dei banchieri
Rothschild, la società segreta cospiratoria degli "Illuminati di Baviera". Il
capo di questa potente e pericolosa organizzazione era un ex gesuita discendente
da una ricca famiglia di ebrei convertiti, Adam Weisshaupt. Feroce
anticattolico, era seguace dell'Illuminismo ateo e materialista ma allo stesso
tempo coinvolto nell'occulto, in particolare della tradizione rosacrociana e
templare. L'obiettivo della setta era distruggere le monarchie cattoliche o
comunque cristiane e il papato, al fine di instaurare una "repubblica
universale". Il disegno dei Rothschild era conquistare tutte le nazioni e
assoggettarle al potere delle banche e della finanza, nonché stampare
privatamente le monete nazionali (signoraggio). Il loro patrimonio era stimabile
di gran lunga superiore alla ricchezza dello stesso re di Francia; erano la
famiglia più potente dell'epoca. I congiurati di Weisshaupt entrarono nella
massoneria ufficiale. Lo storico Alan Stang attesta che nel 1788 tutte le 266
logge del Grande Oriente di Francia erano sotto il controllo degli Illuminati;
il gran maestro era diventato Filippo di Orleans. L'ossessione degli Illuminati
era vendicare la condanna a morte dell'ultimo gran maestro templare Jacques De
Molay (di cui si dicevano continuatori), fatto giustiziare da re Filippo IV il
Bello di Francia il 13 ottobre 1314; il loro progetto era sterminare la "razza
dei Capeti", i Capetingi. Prima e durante la Rivoluzione, i massoni si riunivano
intorno alla tomba di De Molay per celebrare rituali esoterici e giuramenti di
vendetta. Il boia che giustiziò materialmente il 21 gennaio 1793 Luigi XVI era
un discendente dell'ultimo gran maestro dell'Ordine del Tempio. Con questo
orrendo delitto i giacobini dell'Illuminato di Baviera Maximilien Robespierre
scatenarono una feroce persecuzione contro i loro nemici, i controrivoluzionari,
accanendosi in particolar modo proprio contro quel popolo di cui tanto si
facevano paladini, che invece voleva rimanere fedele ai Borbone e alla Chiesa.
La persecuzione antireligiosa era cominciata in maniera più blanda già dopo il
14 luglio 1789, ma con il Terrore giacobino raggiunse vette molto più alte. Beni
confiscati, ruberie di stato, chiese distrutte e incendiate, ostie e reliquie
profanate, preti imprigionati e massacrati, suore stuprate e uccise, credenti
umiliati e trucidati, in nome degli "immortali" principi di Libertè, Egalitè,
Fraternitè. Da non dimenticare l'orribile genocidio della Vandea (130.000
morti), che disgustò perfino Babeuf e Napoleone, ma di cui nessuno parla. Questa
regione doveva diventare, nelle parole del generale giacobino Westerman, un
"cimitero nazionale". Il furore spietato e distruttivo contro la Vandea si
spiegava perché era la regione più religiosa e lealista della Francia. P.
Augustine Barruel scrisse chiaramente in una sua opera che gli Illuminati
avevano complottato contro il Trono e l'Altare. Erano membri della setta
Robespierre, il duca di Orléans, Necker, La Fayette, Barnave, il duca di
Rouchefoucault, Mirabeau, Fauchet, Clootz e Talleyrand, e appartenevano al
Grande Oriente di Francia tutti i principali capi rivoluzionari: Sieyès,
Saint-Just, Marat, Danton, Desmoulins, Hèbert (l'ideatore della
"scristianizzazione") e Brissot. La scristianizzazione portata avanti da Hèbert,
accanitamente antireligiosa, non trovò l'appoggio di Robespierre, che sostenne e
impose il culto dell'Essere Supremo e della Dea Ragione. Il capo giacobino
sperava in tal modo di rendere "popolari" i principi massonici. All'Ente
Supremo, equivalente del Gadu, fu conferito come simbolo un grande e robusto
albero, una quercia, che alla fine rappresenta la Natura; notiamo bene che
questo simbolo pagano era lo stesso che campeggiava sullo stemma del Pds di
Achille Occhetto, che nel 1991 aveva appena abbandonato il vecchio nome di Pci.
Alla Dea Ragione fu data l'immagine di una donna con il petto scoperto dove
spunta l'occhio onniveggente, altro simbolo cabalistico ed esoterico. Che la
Rivoluzione francese fosse influenzata dalla massoneria è dimostrato da più
parti: basta controllare il frontespizio dell'Enciclopedia e le fedeli
riproduzioni della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino, dove le
allegorie massoniche sono evidentissime. La reazione del 9 Termidoro che portò
alla ghigliottina Robespierre e i suoi seguaci il 27 luglio 1794, segnò l'ascesa
al potere dei gruppi borghesi liberal-moderati. Intanto le frange più estremiste
si organizzavano, e un triumvirato ultragiacobino composto da Gracco Babeuf,
Filippo Buonarroti e Silvain Marèchal, tutti e tre massoni, diede vita alla
Congiura degli Eguali del marzo-maggio 1797. La cospirazione fu soffocata nel
sangue e Babeuf condannato a morte. Buonarroti e Marèchal continuarono nel
segreto la loro attività rivoluzionaria, fornendo insieme a Jakob Kats, un
patrimonio politico di rilevante importanza, perché questi gruppi proto
comunistici furono gli antesignani diretti del socialismo marxista. L'ascesa di
Napoleone Bonaparte segnò l'inizio della conquista massonica dell'Europa.
L'esercito francese disseminava logge in tutti i territori occupati, Italia
compresa. Il 20 giugno 1805 nacque a Milano il Grande Oriente d'Italia, la più
grande obbedienza della penisola, però non riconosciuta dalla Loggia Madre di
Londra. In quel periodo nacque anche la Carboneria, una metamorfosi rurale della
Massoneria, che ebbe come gran protettore il cugino di Napoleone, Gioacchino
Murat, "re" di Napoli e delle Due Sicilie. Scopo delle società segrete italiane
era "liberare" l'Italia dai vecchi Stati feudali e dalla Chiesa cattolica.
Possiamo scorgere l'azione della Massoneria dietro tutte le rivoluzioni in
Europa e in America del 1820-21, 1825, 1830-31 e del 1848. Il Risorgimento
italiano, guidato dal massone Cavour e aiutato dai "fratelli" Mazzini,
Garibaldi, Manin, D'Azeglio e tanti altri, portò alla "indipendenza" italiana
nel 1861. Lo Stato Pontificio fu conquistato solo il 20 settembre 1870 con la
breccia di Porta Pia per opera dei bersaglieri dell'esercito sabaudo, nonostante
l'eroica resistenza di papa Pio IX, spesso ingiustamente accusato dalla
storiografia progressista come un anti-italiano. Anzi, esisteva un progetto
dello stesso pontefice volto ad unificare in maniera federativa gli Stati
italiani, onde evitare il pericolo di una rivoluzione laicista e anticlericale.
Fatto sta che dal 1870 al 1929 il papa è stato prigioniero in Vaticano e che dal
1861 al 1922 il Regno d'Italia è stato governato da un regime oligarchico e
liberal-massonico, nonostante il patto Gentiloni-Giolitti del 1913. Dalle
società segrete socialiste francesi che avevano dato vita alla congiura di
Babeuf emigrate in Germania, nacque nel 1834 la Lega dei Proscritti. Questi
gruppi cospiratori discendevano in linea diretta dagli Illuminati di Weisshaupt.
Nel 1836 ci fu una scissione all'interno dei Proscritti; nasceva così la Lega
degli Uomini Giusti. Nel 1840 circa, entrarono a far parte di questo gruppo
Kiessel Mordechai Levi, alias Karl Marx e Friederich Engels, i padri del
comunismo. Marx, secondo la notizia riportata sulla rivista massonica italiana
"Hiram" il 1° maggio 1990, fu iniziato alla loggia "Apollo" di Colonia. Nel 1847
gli Illuminati inglesi affidarono ai due filosofi il compito di rielaborare i
principi di Weisshaupt e Babeuf in forma nuova e scientifica, mentre i fondi
necessari per la pubblicazione del "Manifesto Comunista" del 1848 provennero da
Clinton Roosevelt e Horace Greely (avo di Hjalmar Schact, ministro dell'economia
del Terzo Reich), entrambi membri della loggia "Columbia", fondata a New York
dagli Illuminati bavaresi. Le agitazioni rivoluzionarie fomentate da comunisti,
socialisti, anarchici e radical-democratici sfociarono nella Comune di Parigi
del 1871, un violento rivolgimento politico indirizzato contro il governo del
conservatore Adolphe Thiers. La rivolta fu domata in poche settimane. A cavallo
tra l' '800 e il '900 i principali governi europei e americani erano
anticlericali, soprattutto la Francia e l'Italia, egemonizzati da partiti
liberal-moderati, progressisti e radical-socialisti. Durante la cosiddetta
"belle èpoque" (1900-1914) le logge studiavano come disfarsi dei governi
autocratici che ancora resistevano dopo le ondate rivoluzionarie ottocentesche;
gli obiettivi da abbattere erano l'Impero Austro-Ungarico, la Germania del
Kaiser, la Russia zarista (sconvolta da attentati e moti fino a prima del 1914),
ma anche la Turchia Ottomana. L'odio di grembiulini e rivoluzionari era
concentrato soprattutto contro gli Asburgo d'Austria, visti come eredi dei
Carolingi e del Sacro Romano Impero Germanico, fondatore dell'Europa cristiana.
L'Impero asburgico era multietnico e si volevano strumentalizzare le
rivendicazioni per l'indipendenza di alcune nazionalità: i serbi ortodossi
alleati della Russia, i cechi, gli slovacchi, ma anche l'élite ebraica che mal
sopportava essere governata da una dinastia cattolica. Gli ebrei sostenevano il
Partito Socialdemocratico, guidato dal loro correligionario Viktor Adler, il cui
figlio Friederich uccise il primo ministro Stürgkh. La Massoneria internazionale
voleva un grande scontro sul continente che avrebbe dovuto portare alla
federazione repubblicana degli Stati europei. Il 28 giugno 1914 il terrorista
ebreo serbo Gavrilo Princip appartenente alla società segreta della "Mano Nera"
e alla setta democratica "Giovane Serbia", uccise l'erede al trono d'Austria il
granduca Francesco Ferdinando e la moglie a Sarajevo, provocando lo scoppio
della Prima guerra mondiale. Gli schieramenti erano questi: da una parte gli
Imperi centrali, Austria - Ungheria, Germania e Turchia Ottomana, dall'altra la
Triplice Intesa che comprendeva Inghilterra, Francia, Russia (poi costretta ad
abbandonare per lo scoppio della Rivoluzione bolscevica) e più tardi Italia e
Stati Uniti. La Grande Guerra si concluse con la vittoria delle potenze
massoniche e la distruzione dei vecchi imperi europei. L'Austria – Ungheria fu
smembrata e la Germania umiliata. Ottennero l'indipendenza la Cecoslovacchia,
guidata dai "fratelli" Beneš e Masaryk, la Polonia, l'Ungheria e il Regno di
Jugoslavia. L'Impero Ottomano fu lentamente logorato all'interno con la presa
del potere dei "Giovani Turchi" nel 1908, una setta democratica modernizzante i
cui membri risultavano affiliati alla loggia "Macedonia Resurrecta" di
Salonicco. Il governo massonico turco pianificò il genocidio armeno nel 1915;
furono trucidati 1.500.000 di armeni. Con la fine del conflitto l'Impero si
sfaldò. Nel 1923 il generale massone Kemal Atatürk abolì definitivamente il
sultanato; nasceva così la Repubblica di Turchia, profondamente occidentalizzata
e proiettata verso l'Europa. La Russia fu sconvolta dalla Rivoluzione di
febbraio che spodestò lo zar Nicola II, guidata dai massoni L'vov e Kerenskij,
affiliati alla Gran Loggia di Russia. La rivolta di febbraio ebbe un carattere
liberale e socialdemocratico. Ma il 25 ottobre successivo il potere fu preso dai
comunisti bolscevichi, capitanati dagli altrettanti "fratelli" Lenin, Trotzkij,
Zinov'ev, Parvus, Litvinov, Bucharin, Sverdlov, Lunačarskij, Radek, Rakowskij,
Krasin, tutti iniziati al Grande Oriente di Francia; è forse da escludere
l'appartenenza di Stalin, il quale non risulta affiliato. Lenin fu iniziato a
Parigi nel 1908 alla loggia "Union de Bellevillle" e ottenne il 31° grado. Il
governo sovietico del 1920 era molto particolare: su 21 Commissari del Popolo 17
erano di origine ebraica; su 545 funzionari di Stato, 447 erano ebrei. In
effetti la comunità israelitica vedeva di buon occhio la Rivoluzione nel paese
degli zar. Non è un mistero che essa fu finanziata da ambienti ebraici
anglosassoni nordamericani ed europei contigui alla B'nai B'rith tramite Parvus
(Rockefeller, Morgan, Kuhn & Loeb, Rothschild, Schiff, Warburg). Molti
correligionari però, appartenenti alla piccola borghesia, furono ferocemente
perseguitati e spogliati dei beni perché conservatori e fedeli al vecchio
regime. La "Civiltà Cattolica", autorevole rivista dei gesuiti, parlò di un
complotto giudaico-massonico-bolscevico. Il governo comunista di Russia è stato
il primo a legalizzare la pratica genocida dell'aborto, voluto dal Commissario
del Popolo agli Affari Familiari Goichberg su pressione di Lenin, ispirato a sua
volta dal "miliardario rosso" americano Armand Hammer, uomo dei Rockefeller (i
più grandi pianificatori del controllo delle nascite a livello globale), maestro
dell'ecologista radicale Al Gore. Un grande storico magiaro-francese, François
Fejtö, ha ammesso nella sua opera più conosciuta "Requiem per un Impero
defunto", il ruolo determinante delle società segrete nello scoppio della Prima
guerra mondiale. Gli stessi capi politici delle potenze vincitrici, il
democratico Wilson (USA), il liberale Lloyd George (Gb), il radical-socialista
Clemenceau (Fra) e il liberaldemocratico Orlando (Ita) erano tutti massoni.
Woodrow Wilson fu l'ideatore della Società delle Nazioni, un organismo
sovranazionale, antenato dell'ONU, che avrebbe dovuto portare secondo lui alla
pace universale e ad un unico governo mondiale; essa avrebbe dovuto riuscire
dove il Cristianesimo aveva fallito. Clemenceau era un anticlericale incallito;
apparteneva ad una loggia i cui membri si facevano tumulare da morti ritti in
piedi, in segno di odio e di sfida contro Dio. Nel '900 particolarmente
travagliata è stata la storia del Messico. Scosso da rivoluzioni e da vari
rivolgimenti politici (1910-1914), la lotta anticristiana fu molto virulenta.
Presidenti massoni come Madero, Carranza, Obregòn, Cardenas e soprattutto Calles
furono i protagonisti in negativo di un'epoca. Quest'ultimo scatenò una
ferocissima persecuzione, che provocò come reazione la guerra cristera del
1927-1929. Il regime era controllato dal Partito Rivoluzionario Istituzionale,
che ideologicamente professava un socialismo di tipo ottocentesco con venature
democratico-giacobine; per essere più pratici lo si potrebbe paragonare al Psoe
di Zapatero. È unanimemente riconosciuto che la Massoneria messicana, secondo
anche la testimonianza di P. Carlos Blanco, è la più anticlericale che esiste.
Manovrata dagli USA o da ambienti sinarchici europei vicini alla Spagna e alla
Francia, si sforza di dare al Messico un'identità laica e protestante in grado
di cancellare le radici cattoliche del paese, viste come il maggiore ostacolo
alla fusione di tutte le nazioni americane. Il rapporto tra la Libera Muratoria
e i grandi nazionalismi europei è stato piuttosto complesso. In Italia Benito
Mussolini nel 1922 mise fine a 61 anni di regime oligarchico - liberale, ma
inizialmente già dal 1919, il fascismo godette del sostegno della Massoneria
italiana, poiché lo credeva un movimento socialista e nazional-giacobino. Il
massone anticlericale Arturo Reghini fu, insieme all'esoterista Julius Evola, il
principale assertore del "fascismo pagano". Personalmente il Duce detestava i
poteri occulti, e nel 1925 li mise fuori legge, suscitando le ire di Antonio
Gramsci. Nonostante ciò, molti gerarchi fascisti erano "fratelli" come Grandi,
Balbo, Badoglio, Bottai, Costanzo Ciano, Farinacci, Starace, Sante Ceccherini,
Acerbo, ma anche due tecnici del governo come Giuseppe Volpi di Misurata e
Alberto Beneduce. La cosa a quanto pare fu sottovalutata da Mussolini che se ne
rese conto troppo tardi quando il 25 luglio 1943 fu sfiduciato dal Gran
Consiglio da un gruppo di fascisti dissidenti capeggiati da Dino Grandi.
Quest'ultimo ha scritto nelle sue memorie che voleva far pagare al Duce e al
regime le scelte fatte dal 1936 in poi, anno dell'inizio della guerra civile di
Spagna, che vide l'Italia fiancheggiare senza riserve i nazionalisti di Franco,
impegnati in una dura lotta al bolscevismo e alla massoneria internazionale. Lo
stesso Badoglio si oppose all'entrata in guerra dell'Italia. La massoneria negli
anni '30 accentuò la propaganda antifascista, e in molte carte segrete, oggi
recuperate, si esprimeva la necessità di abbattere il Duce con una grande
alleanza internazionale, che si concretizzò con la Seconda guerra mondiale. In
realtà la Massoneria non perdonava al regime anche la stipula dei Patti
Lateranensi dell'11 febbraio 1929, che mettevano fine al decennale contenzioso
tra Stato italiano e Chiesa cattolica. Il nazismo di Hitler era profondamente
avverso alla massoneria, perché la considerava una pedina degli ebrei.
Nonostante ciò, ministro dell'Economia del Reich e presidente della Deutsche
Bank era il protestante frammassone Hjalmar Schact, "miracolosamente" sfuggito
al processo di Norimberga, evidentemente salvato dai "fratelli" americani,
inglesi, francesi e sovietici. Bisogna dire che il nazionalsocialismo fu in
parte emanazione di circoli iniziatici pangermanisti e neopagani facenti capo
alla loggia "Thule". Molti esponenti nazisti facevano parte di questo gruppo
esoterico: Adolf Hitler, Alfred Rosenberg, Otto Rahn, Heinrich Himmler e Rudolf
Hess; quest'ultimo apparteneva anche all'Ordine Ermetico dell'Alba Dorata,
società d'ispirazione rosacrociana. Secondo alcuni storici, si recò in
Inghilterra nel 1941 per negoziare una pace separata con gli inglesi proprio a
causa della sua affiliazione a questa setta segreta la cui sede e i cui vertici
risiedevano in Gran Bretagna. Il Falangismo spagnolo di Francisco Franco fu
autenticamente cattolico e rigorosamente antimassonico. La Repubblica,
egemonizzata dalle sinistre anticlericali (socialisti, repubblicani, comunisti),
e sostenuta dall'esterno dagli anarchici e all'estero dal Messico di Cardenas,
dalla Francia del Fronte Popolare del marxista Lèon Blum e in maniera più decisa
e diretta dall'URSS di Stalin, cominciò ad innescare un clima di odio e di
violenza tale che soprattutto dal 1936 al 1939 raggiunse l'apice massimo. A
proposito del dittatore georgiano, urge una precisazione: la volta scorsa ho
scritto che non risulta affiliato; ebbene, un massone mi ha riferito invece che
Stalin era "fratello". La Massoneria lo ha screditato dopo la morte a causa
delle molte epurazioni da lui effettuate all'interno del Pcus. Il presidente
repubblicano Manuel Azaña, un massone fanatico, era deciso a portare la Spagna
sotto l'orbita sovietica, provocando e alimentando la violenza inaudita dei
rivoluzionari contro la Chiesa e tutti coloro che non si piegavano al terrore
rosso. Le persecuzioni furono terribili; gli orrori dei comunisti spagnoli
superavano in molti casi quelli dei giacobini durante la Rivoluzione francese.
Con la risoluta reazione dei nazionalisti di Franco, aiutati in maniera decisiva
dalla Germania ma soprattutto dall'Italia, la Repubblica filosovietica fu
abbattuta. Franco giunto al potere emanò il 1° marzo 1940 la legge per la
repressione della massoneria e del comunismo. Va aggiunto che molti massoni di
tutte le tendenze politiche antifasciste si arruolarono nelle Brigate
Internazionali, per andare in soccorso dei "fratelli" in pericolo. La vittoria
degli Alleati nella II guerra mondiale e la sconfitta dei grandi nazionalismi
italiano, tedesco e giapponese, implicò la divisione del mondo in due blocchi,
voluto a Yalta nel 1945 dai "fratelli" Roosevelt, Churchill e Stalin: a
occidente il predominio americano e a oriente quello sovietico. I due
mondialismi materialisti si spartivano il pianeta: da una parte il capitalismo
liberaldemocratico, agnostico e tollerante, dall'altro il comunismo ateo e
totalitario. Il nazionalismo doveva essere distrutto per far posto al
mondialismo, che avrebbe dovuto portare al compimento della Grande Opera, al
sogno della massoneria: la Repubblica Universale. I popoli dovevano scegliere.
L'Italia decideva il suo destino il 18 aprile 1948: dopo l'unità durante la
Resistenza, una parte della Massoneria sostenne i partiti laici minori, il PDA,
il PRI e il PLI, apertamente filoamericani, mentre l'altra il Fronte Popolare,
costituito da PCI e PSI, che invece erano filosovietici. Simbolo del FP era
un'immagine di Garibaldi. La grande vittoria della DC confermò l'Italia nel
campo americano, insieme agli altri paesi occidentali. In tutta l'Europa
orientale, la Massoneria spianò la strada ai socialcomunisti. La studiosa Angela
Pellicciari, tra le migliori esperte di storia del Risorgimento italiano, ha
giustamente notato che sull'emblema della DDR (la Germania Orientale comunista)
figurava un compasso; ricordiamo che il compasso, con la stella a 5 punte e la
squadra sono i principali simboli della massoneria. Un caso oscuro ed
emblematico di come i "fratelli" si vogliano bene tra loro riguarda la
Cecoslovacchia. Con il colpo di Stato del 1948, il radicale Jan Masaryk, già
Gran Maestro della Massoneria ceca al pari di suo padre Tomas e di Edvard Beneš,
persecutori e carnefici degli slovacchi cattolici, fu "suicidato" dagli stessi
"fratelli" comunisti che lui aveva favorito come alleati al governo (era l'unico
non marxista). La famiglia Masaryk fu protagonista di un vero e proprio dramma:
Tomas fece di tutto per "liberare" la Cecoslovacchia dall'Impero Asburgico,
mentre suo figlio Jan aveva consegnato il suo paese (rimettendoci la vita!)
negli artigli del bolscevismo internazionale. Lo stesso anno, il 14 maggio 1948
Ben Gurion fondava lo Stato d'Israele, dando vita al "Risorgimento ebraico" che
ha per base ideologica il Sionismo di Teodoro Herzl. Il sionismo predica il
ritorno in patria del popolo d'Israele, in base ad un messianismo laico e
terreno. Con l'arrivo dei coloni ebrei è iniziato un capitolo triste per la
sorte del popolo arabo-palestinese. Nel 1945 a S. Francisco era nata l'ONU, per
iniziativa delle potenze vincitrici, al posto della screditata Società delle
Nazioni. La sua sede è a New York, edificata in uno spazio donato dai
Rockefeller. Le stanze dell'ONU sono piene di simbologie massoniche. Le Nazioni
Unite sono una prefigurazione del futuro governo mondiale, controllate da
burocrati mediocri ma potenti, influenzati da un tipo di socialismo fabiano e
tecnocratico. Esse hanno silenziosamente e subdolamente incoraggiato la
decolonizzazione negli anni '40, '50 e '60 delle dipendenze oltre continente di
Inghilterra, Francia, Belgio, Portogallo e Olanda. Rozzi e violenti capipopolo
di sinistra come Sukarno in Indonesia, Lumumba nel Congo belga, Ho Chi Minh in
Vietnam, solo per fare qualche nome, ottennero l'indipendenza delle loro nazioni
per poi fare lucrosi affari sottobanco con i grandi capitalisti occidentali,
loro che avevano predicato la guerra rivoluzionaria ai bianchi "schiavisti" e
"sfruttatori". Lo stesso può dirsi per le rivoluzioni marxiste nei Paesi poveri,
la Cina di Mao (istigata dall'agente sovietico del Comintern, il rivoluzionario
massone Michail Borodin, detto Gurov) e la Cambogia dei khmer rossi, dove il
macellaio comunista Pol Pot ha eliminato 1 milione di persone nel giro di una
settimana, ma soprattutto nell'America Latina , guidate dai "fratelli" Castro e
Che Guevara a Cuba (entrambi 33° grado del Rsaa della Gran Loggia Cubana),
Romulo Betancourt in Venezuela, Jacobo Arbenz Guzmàn in Guatemala e Salvador
Allende in Cile (Venerabile della Loggia "Hiram n° 66 di Santiago). Una breve
digressione merita il "mitico 68". Esso fu preparato mediante un'efficace
suggestione culturale dalla Scuola di Francoforte, un gruppo di filosofi
marxisti "eretici", tra cui Theodor Adorno, Herbert Marcuse e Max Horkehimer.
Fondata dalla Fabian Society, la società semi-segreta inglese nata nel 1904,
fautrice dell'espansione del socialismo nel mondo, da cui sono usciti molti
politici laburisti come i premier Tony Blair e Gordon Brown, essa aveva lo scopo
di inquinare i costumi dell'Occidente con la mentalità libertaria e nichilista,
al fine di facilitare l'avvento della socialdemocrazia universale. Un altro
organismo mondialista che ci riguarda molto da vicino è l'Unione Europea (ex
Ceca-Euratom, Cee). Nonostante sia stata voluta anche da 3 cattolici ferventi
come De Gasperi, Schuman e Adenauer, l'Ue ha preso una piega sempre più
tecnocratica, centralista, socialista e laicista. Padri "spirituali" di questa
Europa debole e corrotta sono i massoni Blum, Spaak, Monnet, Spinelli, Brandt,
Giscard d'Estaing, Felipe Gonzalez, Cohn Bendhit, Mitterrand (che in occasione
del bicentenario della Rivoluzione francese ha riempito Parigi di simboli
esoterici) e Delors. Qualcuno non contento, vuole perfino far entrare la
Turchia, vista come l'ariete che potrà finalmente distruggere la nostra Civiltà.
Del resto è sotto gli occhi di tutti la politica anticristiana praticata dalle
istituzioni comunitarie. L'azione della massoneria in Italia nel dopoguerra si è
concentrata soprattutto sulla corruzione dei costumi e della famiglia. Forze
politiche anticlericali come il Pri, il Psi, il Pci, il Psdi, il Pli, guidate
dal Partito Radicale di Marco Pannella ed Emma Bonino, riuscirono a far
introdurre il divorzio nel 1970 e l'aborto nel 1978. Esso era stato legalizzato
prima nell'URSS e poi nel restante campo comunista, poi diveniva legge negli USA
il 22 gennaio 1973, quando la Corte Suprema, controllata dai Rockefeller, si
pronunciò a favore di tale provvedimento. Che l'applicazione dell'aborto su
scala mondiale sia frutto di una pianificazione a tavolino dei poteri massonici,
non c'è dubbio; diceva la femminista francese Edwige Prud'homme, Gran Maestra
della Loggia femminile di Francia, intervistata da Le Monde il 26 aprile 1975:
«È nelle nostre logge che furono prese, 15 anni fa le prime iniziative che
condussero alla legislazione sulla contraccezione, il familial planning e
l'aborto». Lo storico François Fejtö su "il Giornale" del 14 dicembre 1982:
«Sotto Giscard, il Gran Maestro della Gran Loggia di Francia, Pierre Simon,
svolse un ruolo preponderante nella preparazione delle leggi sulla
contraccezione e l'aborto». Perfino Giovanni Paolo II diceva che «sono grandi e
potenti le forze che oggi, apertamente od occultamente, dispiegano nel mondo la
cultura della morte». Molte agenzie dell'ONU e dell'Ue promuovono l'aborto su
scala planetaria, soprattutto nel Terzo mondo. L'aborto per i massoni, ha un
significato esoterico profondo: è il sacrificio cruento di sangue innocente
offerto al Principe di questo mondo, Satana, il vero dio della Massoneria,
qualificato come Gadu o Ente Supremo, per nascondere ai profani le vere finalità
della setta, come ebbe a sottolineare il grande giurista cattolico e
controrivoluzionario francese vissuto tra il '700 e l'800, il conte di
Anthenaire, e come confermano molti documenti riservati agli alti gradi, tra cui
quelli di Albert Pike, Sovrano Gran Commendatore del Supremo Consiglio del Rssa
della Giurisdizione del Sud degli Stati Uniti d'America, vissuto nell'800. Gli
anni '80 furono l'inizio del collasso sovietico: l'elezione al vertice del PCUS
dello pseudo innovatore Michail Gorbačev, tanto acclamato in Occidente, portò
alla fine del comunismo nell'Europa orientale nel 1989 e alla dissoluzione
dell'URSS nel 1991. La sua politica riformatrice e allo stesso tempo
fallimentare, era dettata dai poteri forti mondialisti, decisi a far crollare il
socialismo di Stato per proiettare l'economia russa verso il mercato globale;
gli stessi gruppi di potere che furono i burattinai dell'ottobre 1917, i
Rockefeller in testa. Non stupirà sapere che Gorbačev è massone e membro del
Lucis Trust, un club fondato dalla teosofa ed esoterista Alice Bailey, che si
batte per l'unificazione delle religioni; la congrega usa riunirsi spesso nella
cappella newyorkese presbiteriana di S.Giovanni il Divino. Esso è inoltre uno
degli sponsor più attivi per i meeting sul dialogo interreligioso promossi
dall'ONU. Prima del novembre 1989, Gorbačev tenne un incontro molto riservato a
Mosca con il Gran Maestro della Massoneria romena, Marcel Shapira, il quale gli
confidò con mesi d'anticipo che i capi comunisti di allora, i vari Ceausescu,
Husak, Honecker, ecc, sarebbero stati presto sostituiti con altri leaders. Ciò
la dice lunga sui profondi legami tra apparato comunista e massoneria
internazionale mondialista. Oggi l'ex dittatore sovietico è a capo della Green
Cross International, una grande associazione ecologista, ed è tra i firmatari
della Carta della Terra, che a suo avviso dovrebbe sostituire i 10 Comandamenti,
nonché sostenitore delle bizzarre previsioni sul clima di Al Gore. Nell' '89 il
comunismo, la peggiore forma di sfruttamento e di oppressione della storia,
crollava con un terrificante bilancio incalcolabile di morti e di danni
materiali e spirituali, con il solo risultato di aver devastato i popoli e di
aver paradossalmente lasciato al loro posto tutti grossi gruppi del grande
capitale internazionale. La fine del sistema comunista in Europa ha portato al
superamento dei blocchi e all'indiscussa supremazia USA. L'11 settembre 1991 il
presidente americano George Bush (33° grado Rsaa) annunciò dal suo studio ovale
di Washington che si era giunti all'alba di un "nuovo ordine mondiale". Cosa
intendeva? Quella che oggi è sotto gli occhi di tutti: la società multietnica e
multiculturale, che ci porterà alla Repubblica Universale massonica, che
annullerà tutte le culture e le fedi. Proprio a partire da quegli anni,
l'Europa, culla di Civiltà, è stata interessata dall'invasione di immigrati
provenienti dall'Est, dall'Africa, dall'America Latina e dall'Asia. La maggior
parte di questi nuovi arrivati è di fede musulmana. La religione di Maometto è
incompatibile con gli ordinamenti civili occidentali, crea incomprensioni e
problemi di convivenza, ma ai progressisti, custodi del politically correct e
proprietari dei mezzi di comunicazione, la cosa sembra non importare, anzi
auspicano uno "scontro creativo" tra civiltà, per cui nascerà un nuovo ordine
dal caos, come disse Edgar Morin, sociologo di sinistra ed ex consigliere di
Mitterrand. L'obiettivo dei grembiulini è devastare la radice e il tessuto
culturale e sociale con l'ausilio della religione islamica, che è in grande
espansione, contro un'Europa disarmata e in crisi d'identità. Ma la
globalizzazione era già stata preparata nei piani alti delle logge massoniche.
In piena Seconda guerra mondiale, John Foster Dulles, presidente della
Fondazione Rockefeller, così vedeva la "pace universale", sul "Times" del 16
marzo 1942: «Un Governo mondiale, la limitazione immediata delle sovranità
nazionali, il controllo internazionale di tutti gli eserciti e di tutte le
marine, un sistema monetario unico, la libertà di immigrazione nel mondo
intero». Oggi si parla tanto di pace, quanto è abusato questo termine! La "pax
mondana" è cosa ben diversa da quella "christiana", lo dice perfino Gesù nel
Vangelo, checché ne dica qualche parroco o vescovo progressista. Tutti noi
ricordiamo quando durante la guerra in Iraq, molti italiani esposero la bandiera
arcobaleno; ebbene quel vessillo è simbolo della Società Teosofica, fondata nel
1875 a New York da Anne Beasant, Helena Petrovna Blavatsky , Alice Bailey e
altri famosi occultisti, che indica la pace come sforzo umano e non come dono di
Dio. L'arcobaleno così inteso era presente già nella simbologia delle logge
massoniche del'700, figura sulla bandiera del Nicaragua (tuttora patria e
rifugio di comunisti, massoni, rivoluzionari, guerriglieri, narcotrafficanti e
terroristi di tutto il mondo) e nello stemma dell'Antico Rito Noachita. Inutile
dire quanto sia usato durante le manifestazioni omosessuali. Quindi l'arcobaleno
è il simbolo principale della Nuova Era dell'Acquario, che sarà pacifista,
multietnica, multiculturale, multisessuale, sincretista e politicamente
corretta. La moderna secolarizzazione ha colpito duramente anche la Chiesa. Una
crisi che è stata preparata da tempo dalle logge massoniche. Documenti riservati
dell'Alta massoneria risalenti a fine '800 – inizio '900 dichiaravano che
occorreva distruggere la Chiesa cattolica dal di dentro, puntando sulla
corruzione morale dei sacerdoti e dei credenti, al fine di screditarla. Il
periodico francese "Vers Demain" pubblicò un estratto del piano studiato dal
massone spretato Paul Roca: «Soppressione della veste talare, matrimonio dei
preti, revisione dei dogmi in funzione del progresso universale, sconvolgimento
della liturgia, l'Eucarestia ridotta a un semplice simbolo della comunione
universale ed il vecchio Papato ed il vecchio sacerdozio abdicanti di fronte ai
preti dell'avvenire». Da qui l'irrompere dell'eresia modernista, duramente
condannata da S. Pio X con il decreto Lamentabili e l'enciclica Pascendi del
1907. Ovunque la Massoneria è giunta al potere, ha sempre provveduto ad
infiltrare agenti e a sottomettere la Chiesa allo Stato, come è avvenuto in
Francia durante la Rivoluzione con la Costituzione Civile del Clero, così come
in Messico, in Russia, ecc, e come voleva fare in Italia contro papa Pio IX, che
non voleva «diventare il cappellano di Casa Savoia». Un grande santo come Padre
Pio da Pietrelcina definiva la massoneria «l'infame setta». Non esagerava, aveva
perfettamente ragione. Francesco Pio Meola
La massoneria cattiva che minaccia il
mondo, scrive Claudio Messora il 9 dicembre
2015. Gioele Magaldi vi racconta i disegni della massoneria neo-aristrocratica e
la battaglia in corso con quella progressista per il dominio sul mondo (la
prima) e per il ripristino delle libertà fondamentali dell’uomo (la seconda),
mostrando le connessioni con gli ultimi avvenimenti del contesto geopolitico.
Ho letto alcune tue interviste, in cui analizzi
i fatti di Parigi, e li leghi all’intreccio massonico. Confermi?
Fatti come quelli del 7 gennaio e del 13 novembre
sono già adombrati nel libro, specialmente nell’ultimo capitolo di “Massoni.
Società a responsabilità illimitata”, edito da Chiarelettere. L’ISIS è una
creatura non “occidentale”, così come spesso si dice in una banalizzazione delle
dinamiche del potere: è semmai una creazione sovranazionale, apolide. Ci sono
forze sovranazionali che operano. E lo fanno con uno spirito cosmopolita. C’era
per esempio, nell’Ottocento, una internazionale massonica progressista che
andava a fare le rivoluzioni ovunque vi fosse una tirannide. La patria era ogni
luogo ove si trattasse di aiutare delle persone ad auto-determinarsi, a darsi
Costituzioni, liberali e democratiche. Garibaldi è uno che ha combattuto
ovunque, insieme ai patrioti ungheresi, statunitensi, francesi. Sono venuti a
fare il Risorgimento in Italia e sono andati a farlo in Ungheria, e sono andati
in Francia, sono andati negli Stati Uniti. Ecco, invece oggi, da settant’anni a
questa parte, soprattutto nell’ultimo mezzo secolo, per la prima volta nella
storia nell’ambito della Massoneria sono arrivati all’egemonia dei gruppi
massonici, non più progressisti, ma io li definisco neo-aristocratici e
reazionari, con un’idea non più cosmopolita del loro potere e delle loro
battaglie, ma apolide, cioè indifferente, cinicamente indifferente al benessere
dei singoli popoli, e anche sopraelevati rispetto a qualunque controllo di tipo
territoriale, con la capacità di incidere, quindi, globali. Ecco! Nell’ambito di
questi circuiti c’è una super-loggia, la Hathor Pentalpha, che è a monte anche
degli eventi tragici dell’11 settembre. A un certo punto prorompe in un ambito
di altre super-logge neo-aristocratiche e, quasi come una super-loggia eretica
in negativo, immagina un mondo dove anche il terrorismo, su scala globale, abbia
un ruolo politico importante.
Un ruolo destabilizzatore?
Sì. Noi abbiamo già questa esperienza, per averla
vissuta in Italia ma anche in singole altre nazioni. L’esperienza di un
terrorismo degli anni Settanta e Ottanta che, molto spesso, è stato ambiguo ed
opaco, nel senso che è un terrorismo dove ci sono state infiltrazioni di manine
varie, cioè non c’era soltanto l’istanza, come dire, spontanea, autonoma e
autentica ancorché terribile, di gruppi coerenti con quell’aberrante idea di
trasformazione della società in modo violento, armato. No! C’era chi ha
accompagnato, infiltrato, eterodiretto. Immaginiamo allora che a un certo punto
qualcuno decide, in un mondo più globalizzato rispetto agli anni Settanta e
Ottanta (ricordiamoci che la globalizzazione in senso stretto arriva dopo
l’unificazione europea, la caduta del muro di Berlino e la caduta dell’Unione
Sovietica), in un nuovo contesto che è quello che si va a configurare all’inizio
del XXI° Secolo, che il terrorismo globale possa avere un ruolo importante per
ridefinire i rapporti sociali e politici. Non ci scordiamo che, dopo il 2001,
negli Stati Uniti e quindi nella prima democrazia al mondo, tutte le norme
legislative del Papework Act sono all’insegna di una violazione patente di quei
principi di democrazia e libertà su cui gli Stati Uniti e tutte le
democrazie moderne sono stati edificati. E oggi, in Italia, in Francia, in
Europa, dopo gli eventi francesi si inizia a pensare a misure legislative
illiberali come il Papework Actamericano.
Quando tu dici che c’è una super-loggia che
avrebbe interesse ad immaginare un ruolo politico per il terrorismo”, nella
sostanza, a chi ti riferisci?
La caratteristica delle super-logge massoniche è
quella di inglobare personaggi che provengono dall’establishment politico,
finanziario, militare, diplomatico, dall’intelligence… Cioè: la trasversalità
delle presenze è funzionale, perché c’è bisogno di una copertura mediatica. C’è
bisogno di omissioni mediatiche. C’è bisogno di connivenza industriale,
connivenza militare, connivenza politica. I personaggi sono i protagonisti
negativi dei primi anni duemila. Anche lì, attenzione! Certamente c’è dentro il
clan Bush, ma il clan Bush è soltanto la punta di un iceberg. Il Governo degli
Stati Uniti, gestito malamente nei due mandati di George W. Bush, in realtà è
stato uno strumento. Quando alimentiamo polemiche antiamericane, non ci rendiamo
conto che non esiste l’America in quanto tale. Gli Stati Uniti, come ogni grande
paese, sono attraversati da gruppi di potere che spesso sono in feroce lotta tra
di loro. Questi poteri apolidi di cui parlavo prima si servono anche del governo
degli Stati Uniti, quando possono, perché è un governo importante, che muove
risorse militari ed economiche importanti. Ma si tratta di un utilizzo fatto
dall’esterno, attraverso persone che, contingentemente, occupano dei posti. Mi
chiedono se no ho paura di morire. Intanto ci tengo a precisare che non sto
“sputtanando” la Massoneria: io sono un massone fiero di essere tale, e
lo rivendico con orgoglio. L’opinione pubblica italiana è paurosamente ignorante
su questo tema, a partire dai libri di scuola dove l’argomento massoneria viene
omesso. Nessuno ne parla, né nel bene né nel male. La massoneria è stata
centrale, a partire dal settecento e fino agli anni sessanta con la New
Frontiers, che è stata l’ultima istanza veramente progressista del novecento.
Kennedy non era massone, ma il suo ideologo di riferimento, Artur Meier
Schelesinger, era massone ed era anche Maestro Venerabile di una loggia
progressista molto importante: la Thomas Paine, alla quale ho avuto il
privilegio di essere iniziato. E poi va ricordato l’evento epocale che ha
mandato, per la prima volta, il primo Presidente cattolico alla guida degli
Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, e il primo Papa massone al Soglio
Pontificio, che fece il Concilio Vaticano II° e riconciliò la Chiesa con la
modernità. Una sorta di connubio, quindi, grazie a un’operazione voluta da
alcune logge di ambiente cattolicheggiante e non. Da questo partì anche, grazie
ad una serie di reti massoniche, la risoluzione della crisi missilistica di
Cuba. C’è questo tentativo che vedrà poi degli epigoni anche in una serie di
persone che verranno uccise, da Robert Kennedy a Martin Luther King. Robert
Kennedy stava per essere iniziato: non fece a tempo. Martin Luther King invece
era massone. E c’è un laboratorio, in quel momento, che tenta di proporre un
ampliamento dei diritti sociali ed economici: era la New Frontiers kennedyana,
che venne bloccato attraverso degli omicidi. Questi omicidi segnano
anche l’arrivo di una nuova egemonia, non più della massoneria progressista, che
appunto io rivendico con orgoglio e che dal settecento in avanti ha trasformato
il mondo portando la sovranità del popolo, la democrazia, la libertà, lo stato
di diritto, i diritti inalienabili degli uomini e dei cittadini – e questa cosa
avrebbe potuto proseguire, e forse oggi ci troveremmo in un mondo diversamente
globalizzato -, ma di una massoneria neo-aristocratica, che immagina
un’involuzione oligarchica e tecnocratica nella governance mondiale.
E ci riesce, fino ad adesso!
E ci riesce fino ad adesso! Naturalmente con delle
accelerazioni pericolose da apprendisti stregoni, che offrono il fianco ad una
reazione. Io, insieme ad altre persone in Italia e nel mondo, stiamo cercando di
“riavviare”, la forza comunque silente, intatta, dei circuiti massonici
progressisti che hanno sonnecchiato.
Per tornare alla domanda precedente, come
influiscono queste super logge nei fatti, nei flussi degli avvenimenti
terroristici?
Facciamo un esempio: il famoso Califfo
al-Baghdadi. Siamo al limite del paradosso: coloro che lo detengono come
pericoloso terrorista si vedono recapitare un ordine di scarceramento! Questo
signore è stato iniziato massone, è un uomo del tutto integrato nel sistema di
vita occidentale il quale, insieme agli altri suoi compari, da mesi fa una
sceneggiata hollywoodiana, perché tutte le decapitazioni in mondovisione,
tutto il sistema comunicativo dell’ISIS, è un sistema ben studiato.
Compresa Rita Katz che è l’unica…
Tutto quanto è ben studiato. Ci sono alcuni che
sono iniziati a queste logge “controiniziatiche”, che io definirei una
“massoneria maligna“, una pianta maligna che è fiorita dentro un corpo non solo
sano, ma benemerito. E poi ci sono naturalmente gli ignari. L’ISIS fa un salto
di qualità. Prima avevamo il terrorismo di al-Qaeda che era un terrorismo a
macchia di leopardo: non c’era uno Stato: c’era una base in Afganistan. Qui
invece c’è un catalizzatore potente anche ideologico, cioè l’ISIS, che è un
punto di richiamo per cellule sparse ovunque, ma ha che ha anche una sua forza
finanziaria, una capacità di espansione e di attrazione, antitetica anche alla
modernità. Diciamo la verità: sono state introdotte leggi liberticide con
il Patriot Actnegli Stati Uniti e anche altrove in Occidente, ma poi si era
spenta l’emergenza al terrorismo, perché era un’emergenza fasulla, farlocca,
così come è farlocco il pericolo dell’ISIS. Proseguendo nella direzione che
stiamo prendendo, ad un certo momento ci sarà un intervento militare del solito
tipo, cioè di tipo distruttivo. Ci andranno di mezzo popolazioni inermi, civili,
senza nessuna costruzione di infrastrutture materiali e immateriali della
democrazia e della libertà. A questo si arriverà titillando la paura, l’orrore.
Invece, diciamoci la verità, quello che bisognerebbe fare oggi è sì raderli al
suolo (io sono per l’intervento di terra, di aria, di tutto), ma la potenza
delle democrazie è talmente spropositata che, se volessero intervenire, in poco
tempo l’ISIS verrebbe raso al suolo. Ma poi occorrerebbe fare una cosa che non è
stata fatta in tutti questi decenni: cioè invece di proporre forme diverse e
sempre uguali di neocolonialismo, di sfruttamento del caos altrui per i propri
interessi, si tratterebbe di costruire, in quei Paesi, infrastrutture materiali
e immateriali di democrazia. Questo è lo spirito della Dichiarazione Universali
dei Diritti Umani che noi abbiamo approvato all’ONU, ma che è lettera morta!
Cioè pensare che fatte salve le specificità culturali, però ci voglia il
rispetto delle donne, il rispetto dei diversi, il rispetto dei dissenzienti, il
rispetto del fatto che gli esseri umani sono cittadini e non sudditi. Tutte cose
che io rivendico come portate dalla massoneria, la massoneria ha inventato il
concetto di esseri umani latori pro quota di sovranità e non sudditi. Guardate
che la consuetudine dei millenni di storia umana è quella di avere avuto
oligarchie, aristocrazie religiose o profane a governare su masse di straccioni
tenuti nell’ignoranza e nell’abbrutimento. La massoneria, gli avanguardisti
massoni, dal settecento in avanti hanno cambiato questo stato di cose. Adesso,
degli avanguardisti in negativo stanno cercando di introdurre un governo
mondiale di aristocratici dello spirito, sedicenti “illuminati”. Illuminati è un
aggettivo, non un sostantivo come alimenta un certo fiume carsico complottista.
Non esiste nessuna continuità storica tra illuminati di Baviera e presunti
illuminati che governerebbero il mondo, cosa che non significa nulla.
‘Illuminati’ è un aggettivo che può attribuirsi ad alcuni massoni aristocratici.
Ecco, costoro immaginano un mondo neo-feudale, (ndr: cfr. “Diego Fusaro: il
medioevo era meglio”) dove la democrazia – attenzione! -, non è affrontata in
termini perentori, come invce accadde in certi esperimenti liberticidi e
tirannici negli anni settanta. Cioè non si la si sostituisce con un regime
tirannico, in occidente. Pensiamo a quello che accadde in Grecia, con la
dittatura dei Colonnelli, a quello che accadde in Portogallo, a quello che
accadde in America Latina con l’operazione Condor, al Cile, all’Argentina,
a quello chesi tentò di fare in Italia con la P2 che doveva essere la base per
gestire in modo autoritario, stile Argentina, un paese nel cuore dell’occidente.
Oggi non si pensa più a questo perché il cittadino ormai è abituato ai riti
della democrazia, alla retorica della democrazia. Oggi piuttosto si pensa di
svuotarla di sostanza. Si abitua il cittadino a non eleggere più il Senato o le
province (ad esempio, per parlare dell’Italia). In Europa ci si è abituati a una
costruzione economicistica e tecnocratica: il Parlamento Europeo non è il luogo
della sovranità del popolo: non ha il potere di sfiduciare un esecutivo europeo.
Non abbiamo un dipartimento economico, quindi un primato della politica,
sovra-ordinato alla Banca Centrale. Il più grosso potere è un potere non
elettivo, tecnocratico. La Banca Centrale? Sì, c’è un diritto pubblico che la
regola, ma la proprietà e l’indirizzo sono di natura privatistica. Ecco: questa
Europa è figlia delle idee del comitato disposto da Coudenhove-Kalergi e Jean
Monnet, ex massone progressista (ndr: cfr. “Il piano Kalergi” e “La verità su
Kalergi e il suo piano”), passato poi ai circuiti neo-aristocratici. Sento
spesso dire: “Bisogna tornare allo spirito del discorso di Schuman dei padri
fondatori”, ma proprio quello spirito ha costruito questa Europa! Il discorso di
Robert Schuman del 1950 fu scritto da Jean Monnet!
La UE è una creatura massonica?
È una creatura massonica! io ne parlo nel secondo
capitolo nel libro “Massoni”. Io davvero rinvio il tuo pubblico alla lettura di
quel libro, perché gli ultimi settant’anni di storia vengono passati ai raggi-x
con nomi, cognomi e circostanze in termini estremamente minuziosi.
Cosa vuole dire UR-lodges?
La massoneria storicamente si articola in
Grandi Orienti o Gran Logge, cioè federazioni di logge su base nazionale, con
una certa difformità di rituali. La massoneria è un network internazionale,
tanto che c’è perfino unpassaporto massonico che consente di avere – diciamo –
rapporti diplomatici. Tuttavia, questa articolazione viene superata, nella
seconda metà dell’ottocento, dalla costruzione di super-logge sovra-nazionali,
che bypassano gli insediamenti nazionali e quindi la sovranità territoriale di
una giunta, di un Grande Oriente o di una Gran Loggia e si pongono in termini
globalizzanti. Spesso cooptano tra le proprie file sia profani, cioè persone mai
passate per iniziazione massonica ma eccellenti in vari ambiti, sia eminenze
della massoneria tradizionale. Quindi può capitare che un personaggio
importante, della United Lodges of England o della Gran loggia dello stato di
New York o del grande Oriente di Francia o del Grande Oriente d’Italia, poi
stia con un piede lì e un piede in una super-loggia, beneficiando di
una maggiore capacità di movimento. Le UR-Lodegesdanno anche vita a quei
soggetti che spesso sono immaginati illusoriamente come i protagonisti di certi
eventi contemporanei. Parlo del
Bildelberg Group, della Trilateral Commission, del Council on Foreign Relation,
del Royal Institute of International Affairs, del Bohemian Club.
Tutta questa pletora di entità, che non hanno alcuna vera
soggettività importante o capacità di incidere, sono associazioni
paramassoniche, dove si incontrano massoni e non massoni ma dove di solito sono
in pochi quelli appartenenti alle UR-Lodges, le super logge che le hanno
generate, ad avere il controllo. Per esempio Enrico Letta, che pure ha fatto e
fa parte di varie entità paramassoniche, non è mai stato iniziato in una qualche
UR-Lodges.
Mario Monti sì, però?
Mario Monti sì! E io ne ho parlato: sono stato
forse il primo a spiegare qual era il background di Mario Monti.
Monti, Napolitano, Draghi… non c’è bisogno che te
lo chieda. Ma la domanda era questa: le UR-Lodges hanno questo obiettivo di
neo-feudalizzare la società globale. Ma se è vero che ogni cosa che si fa deve
avere un obiettivo, un tornaconto, un interesse, qual è lo scopo finale? Forse
pensano che il mondo sarebbe meglio organizzato in un altro modo, oppure hanno
interessi economico-finanziari da difendere, o magari pensano di poter
amministrare meglio la loro attività. Cosa vorrebbero?
“I veri mandanti dell’Isis e la
Superloggia massonica Hathor-Pentalpha”, scrive
Carlo Tarallo il 20 novembre 2015 su “Italia Ora”.
Intervista esclusiva a Gioele Magaldi, Gran Maestro del Grande Oriente
Democratico (grandeoriente-democratico.com) e Presidente del Movimento Roosevelt
(movimentoroosevelt.com), autore del best-seller “MASSONI. Società a
responsabilità illimitata. La scoperta delle Ur-Lodges” (Chiarelettere, Milano
2014) primo volume di una trilogia, che sta anche per essere pubblicato in
lingua spagnola, francese e inglese.
D. Magaldi, lei afferma nel suo libro “Massoni”
che il nome “Isis” ha un significato legato a una superloggia massonica…
R. Come ho spiegato nel primo volume della serie
di Massoni. Società a responsabilità, Chiarelettere Editore, l’Isis e il
progetto politico-terroristico connesso sono una precisa e meditata creazione ad
opera della Ur-Lodge Hathor-Pentalpha, una superloggia sovranazionale
malignamente “eretica ed estremista” nei suoi fini e nei suoi mezzi, persino
rispetto agli ordinari circuiti massonici neoaristocratici e reazionari. Del
resto, Isis o Iside è la stessa divinità egizia che, in determinati contesti
mitologico-rituali, assume il nome di “Hathor… Tutto questo, comunque, viene
spiegato minuziosamente nel libro Massoni, cosi come vi vengono profetizzati-
con mesi e mesi di anticipo (il libro è uscito nel novembre 2014) - eventi quali
i tremendi attentati terroristici di Parigi del 7 gennaio (episodio di “Charlie
Hebdo”) e del 13 novembre 2015. Le superlogge “Hathor-Pentalpha”, “Amun”,
“Geburah”, “Der Ring” (alla guida di altre, loro satelliti) lucrarono enormi
profitti geopolitici ed economici dalle guerre “preventive” al terrorismo dei
primi anni ‘2000. Guerre che avrebbero avuto un senso solo se davvero fossero
state volte ad “esportare” democrazia, libertà, laicità, diritti universali e
infrastrutture materiali e immateriali in grado di garantire in Medio Oriente e
altrove non solo istituzioni fondate sulla sovranità popolare e il pluralismo
liberale, ma anche giustizia sociale e prosperità per tutti e per ciascuno. Cosi
non fu. Quelle guerre, scatenate con il pretesto di abbattere “regimi canaglia”
fiancheggiatori del terrorismo islamico, in realtà sono servite a scopi di
ampliamento del potere e della ricchezza di un ristretto numero di gruppi
massonici reazionari e neoaristocratici.
Cosa sono le superlogge massoniche?
Anzitutto occorre rammentare che il termine
tecnico per denominarle è “Ur-Lodges”. Si tratta di logge molto potenti e
speciali, di respiro e composizione sovranazionale, che cooptano tra i propri
membri eminenti personaggi (sia uomini che donne) appartenenti alle Comunioni
massoniche tradizionali (Gran Logge e Grandi Orienti) e anche profani e profane
di particolare spessore e prestigio politico-sociale, economico-finanziario,
mediatico, militare e culturale. E si tratta di contesti dove non ci si occupa
soltanto di gestire il potere ai suoi massimi livelli globali, ma anche di
cenacoli dove teorie e pratiche rituali ed esoteriche vengono coltivate con
grande assiduità e scrupolosità. In effetti, a partire da fine Ottocento
(momento di nascita delle prime, tra queste superlogge) e poi soprattutto nel
corso del Novecento e nel primo quarto del XXI secolo, l’egemonia massonica e
l’egemonia tout-court a livello planetario passa dalle tradizionali comunità
massoniche organizzate su base nazionale a queste superlogge sovranazionali.
Perché una superloggia dovrebbe scatenare il
terrore in Europa?
Da mesi, con la sceneggiata hollywoodiana
sull’Isis e i suoi tagliatori di teste trasmessa worldwide, si è dapprima
preparato il terreno. Poi è giunto il primo assaggio cruento nel cuore del
Vecchio continente (vedi attentato alla sede della rivista “Charlie Hebdo”),
quindi c’è stata una ulteriore escalation con l’episodio di venerdì 13 novembre
2015 e la strage di Parigi. Pur dissentendo da qualsivoglia paranoia
complottista sulle numerologie di certi eventi, occorre rammentare che da
quando, il venerdì 13 ottobre del 1307, il re di Francia Filippo il Bello diede
l’ordine di arresto dei Cavalieri Templari, “venerdì 13” è divenuto un
significante importante e famigerato negli ambienti esoterici e massonici e poi
anche nell’immaginario collettivo “profano”, tanto da dar vita, in tempi
recenti, ad alcune serie filmografiche sul tema. E’ in corso una lotta
fratricida tra ambienti massonici neoaristocratici, egemoni da mezzo secolo, e
la ripresa di attività dei circuiti latomistici progressisti, decisi ora ad
invertire il corso antidemocratico e tecnocratico tanto della globalizzazione
che della governance europea. Colpendo in un giorno molto preciso e particolare,
le manovalanze terroristiche eterodirette dagli ambienti della Ur-Lodge
Hathor-Pentalpha, intendevano conseguire due precisi obiettivi.
Uno: dare un segnale infra-massonico ai circuiti
liberomuratori progressisti e in particolare a una superloggia precisa, legata
alla tradizione dei Templari e operante con particolare attenzione in Francia,
in questi mesi… Dirò poi di che Ur-Lodge si tratti e che cosa stia cercando di
fare sul territorio francese.
Due: grazie allo shock provocato e allo
spauracchio della presunta impossibilità di garantire la sicurezza senza misure
emergenziali, determinare sia in Francia che altrove un maggiore controllo
politico, sociale e mediatico “autoritario”, mediante l’introduzione di
eventuali modifiche costituzionali (vedi gli annunci di Hollande in tal senso) e
di una sorta di “Patriot Act” europeo. In sostanza, dopo aver determinato una
cinesizzazione del popolo europeo sul piano dei rapporti sociali ed economici
(smantellamento del welfare, disoccupazione galoppante, crollo della domanda
aggregata e dei consumi e conseguente aumento di manodopera a buon prezzo e con
bassi salari) e dopo aver costruito una UE matrigna e antidemocratica (il
Parlamento europeo, luogo di rappresentanza della sovranità del Popolo europeo
non ha il potere di fiduciare e sfiduciare un esecutivo politico continentale
che sia sovraordinato alle strutture burocratiche comunitarie, invece di essere,
come effettivamente è, subordinato alla dittatura tecnocratica della Bce, vero
“dominus” non elettivo dell’attuale Europa), adesso si cerca di mortificare
ulteriormente la vita democratica del Vecchio continente, introducendo, per
mezzo della paura del terrorismo, leggi liberticide e autoritarie.
Il Procuratore nazionale Antimafia, Franco
Roberti, ha detto che “forse dobbiamo essere pronti a rinunciare ad alcune delle
nostre libertà personali, in particolare dal punto di vista della comunicazione”
a causa della necessità di combattere con ogni mezzo il terrorismo. Cosa ne
pensa?
Proprio il 14 novembre, sul sito ufficiale del
Movimento Roosevelt (movimentoroosevelt.com), poi rilanciato anche sul sito di
Grande Oriente Democratico (grandeoriente-democratico.com), è apparso un
importante intervento intitolato “Strage a Parigi del 13 novembre 2015: il
tragico avverarsi delle profezie di MASSONI e di Gioele Magaldi (risalenti al
2014) e un necessario impegno di tutti e di ciascuno per difendere democrazia e
libertà, contro qualsivoglia deriva autoritaria e illiberale in stile Patriot
Act sul suolo europeo e contro altre conseguenze strumentali e scellerate
auspicate dai mandanti degli attentati di ieri (13 novembre) e del 7 gennaio
2015 in Francia”, articolo pubblicato il 14 novembre 2015 sul sito MR, di cui
consiglio un’attenta lettura. Dopo qualche polemica iniziale, “a caldo”,
rispetto a quanto da lui affermato, ho avuto modo di informarmi meglio sulla
figura di Franco Roberti, procuratore antimafia e antiterrorismo, e in molti me
ne hanno parlato come di persona seria, competente e amante della libertà e
della democrazia. Credo, quindi, che quelle parole (anch’ esse dette “a caldo”,
sull’onda dei fatti terribili che ci hanno tutti indignato e scosso) sul fatto
di rinunciare alla libertà, specie di comunicazione, in favore della sicurezza,
siano state pronunciate in un momento di comprensibile e preponderante
preoccupazione di assicurare al popolo italiano il massimo di tutela da minacce
terroristiche. Ma sono altrettanto convinto che Franco Roberti e i suoi
collaboratori saranno in grado di lavorare alacremente sul lato della
prevenzione e del controllo sapiente del territorio e dei luoghi più esposti a
rischio, senza minimamente attentare alle libertà fondamentali dei cittadini.
Del resto, il massone progressista Benjamin Franklin, uno dei massimi padri
della nascita della prima Repubblica costituzionale e democratica al Mondo, gli
Stati Uniti d’America, soleva affermare: “Chi è pronto a dar via le proprie
libertà fondamentali per comprarsi briciole di temporanea sicurezza, non merita
né la libertà né la sicurezza”. A proposito dei fatti di Parigi di venerdì
scorso, vorrei aggiungere quello che mi hanno suggerito diversi amici fraterni
onesti e scrupolosi, tra i quadri e i dirigenti dei servizi d’intelligence (di
diverse nazioni) operanti in Francia, e in particolare a Parigi. E sa cosa mi
hanno detto? Che senza una falla grossa come una casa nell’operato degli stessi
servizi segreti occidentali e francesi (qualche agente infedele che,
evidentemente, ha “collaborato” con i terroristi, tradendo con infamia i propri
doveri e la propria dignità di uomo e di servitore dello Stato), quello che è
accaduto venerdì 13 novembre non sarebbe mai potuto accadere.
Ma stiamo scherzando? Terroristi che arrivano
indisturbati a pochi passi da dove si muove il Presidente della Repubblica e che
vanno a fare il più atroce attentato in un locale che avrebbe dovuto essere
scientificamente guardato a vista da servizi d’intelligence e sicurezza, in
quanto già attenzionato in precedenza per possibili atti di terrorismo e
violenza?
Senza la connivenza di apparati deviati
dell’intelligence militare e civile, tutto ciò non sarebbe stato assolutamente
possibile. Ecco, dunque ci si prodighi per evitare, in Italia, le falle
clamorose e inescusabili relative alla prevenzione degli attentati e al presidio
capillare dei luoghi più esposti a rischi. E da questo punto di vista, in molti
che lo conoscono bene, mi assicurano che Franco Roberti rappresenti una
garanzia- per competenza, intelligenza e desiderio sincero di proteggere la
popolazione esposta a minacce terroristiche- di prim’ordine.
Quando e come finirà, se finirà, questa
tragedia?
La tragedia non finirà da sola. La sua fine
dipende insieme dalle iniziative dei massoni progressisti nel contrastare i
progetti di involuzione neo-feudale su scala europea, occidentale e globale e
dal risveglio dell’orgoglio di tutti i cittadini comuni, latori pro-quota di
sovranità. In questa prospettiva è stato fondato il Movimento Roosevelt
(movimentoroosevelt.com), per unire in una alleanza comune élites progressiste e
popolo sovrano desideroso di difendere con le unghie e con i denti tre secoli di
conquiste democratiche e liberali.
Le sue verità sono sconvolgenti, lei vende
tantissimi libri e gira l’Italia a spiegarle a tutti. Ha mai avuto una querela?
Ho ricevuto querele (stralunate) per diffamazione,
in relazione alle attività del sito ufficiale di Grande Oriente Democratico
(grandeoriente-democratico.com), Movimento massonico d’opinione di cui mi onoro
di essere Gran Maestro. Ma non ho ricevuto alcuna querela per questioni
attinenti alla pubblicazione del libro Massoni. Società a responsabilità
illimitata. La scoperta delle Ur-Lodges.
Nella massoneria, adesso, pensa di avere più
amici o più nemici?
Ho sicuramente sia molti amici
che molti nemici, all’esterno del network specifico di GOD, parte del più ampio
campo di azione della Libera Muratoria progressista, di cui sono parte
integrante. Tuttavia, da qualche tempo a questa parte accadono cose un po’
strane… L’altro giorno, ad esempio, qualcuno mi ha iscritto ad un Gruppo
“Massoneria” su facebook e poi, su quello stesso Gruppo, ieri, mercoledì 18
novembre, sono stato oggetto di minacce di esplicita violenza fisica e anche di
morte, da alcuni massoni italiani, peraltro riconoscibili con nome e cognome.
Sarà naturalmente mia cura, nelle prossime ore, allertare della cosa in modo
adeguato sia le autorità giudiziarie competenti che l’opinione pubblica.
Bruxelles corrotta, Europa infetta.
Tangenti. Sprechi. Inefficienza. Istituzioni al
servizio di lobby potenti e occulte. Ecco tutti i pubblici vizi della capitale.
Che affossano la fiducia nell’Unione. Bandiere davanti alla Commissione Europea
a Bruxelles. È un tour tra gli edifici più importanti della città: dalla
residenza reale al museo di belle arti, dagli uffici ministeriali alle carceri,
dall’osservatorio astronomico al palazzo di giustizia. Sono maestosi, coperti di
marmi e statue a testimoniare la solidità della virtù pubblica. Eppure per dieci
anni a gestirli è stata una cricca: ogni appalto una mazzetta, altrimenti non si
lavorava. Tutti sapevano, nessuno ha mai denunciato la rete criminale che ha
trasformato il cuore del Paese in una vera Tangentopoli. Non stiamo parlando
delle gang romana di Mafia Capitale, questa è Bruxelles: due volte capitale, del
Belgio e dell’Europa. E due volte corrotta, nell’intreccio d’affari tra poteri
locali e autorità continentali. Qui non si decide soltanto la vita di una
nazione lacerata dalle tensioni tra valloni e fiamminghi, ma il destino di mezzo
miliardo di persone, cittadini di un’Unione che mai come in questo momento si
mostra debole e inconcludente. Dall’inizio del millennio la fiducia degli
italiani, come evidenzia il sondaggio Demopolis, è crollata e solo uno su
quattro crede ancora nell’Europa. Bruxelles però è anche il laboratorio in cui
la corruzione si sta evolvendo. La mutazione genetica delle vecchie bustarelle
in un virus capace di intaccare in profondità la reputazione delle istituzioni
europee, diffuso silenziosamente da quei soggetti chiamati lobby. Realtà
estranee alla tradizione democratica dei nostri Stati nazionali e molto diverse
dai modelli statunitensi, perché qui non ci sono leggi che le regolino, né
sanzioni che le spaventino: le lobby sono invisibili e allo stesso tempo
appaiono onnipotenti. Il simbolo è Place Poelaert, la grande piazza panoramica
affacciata sul centro storico di Bruxelles. Da un lato c’è il palazzo di
giustizia, con la cupola dorata che svetta sull’intera città: una muraglia di
impalcature lo imprigiona da cima a fondo, soffocando le colonne dietro un
gigantesco castello di assi che marciscono tristemente. Il cantiere dei restauri
è abbandonato da otto anni, da quando i titolari sono stati arrestati, assieme
ad altri 33 tra imprenditori e funzionari accusati di avere depredato l’intero
patrimonio immobiliare statale. Proprio di fronte al palazzo della giustizia
impacchettato c’è uno splendido complesso rinascimentale, con un giardino
impeccabile. È la sede del Cercle de Lorraine, “the business club”, come recita
la targa: l’associazione che raccoglie gli industriali più prestigiosi del
Paese, baroni e visconti da sempre padroni del vapore assieme ai manager
rampanti della new economy. Lì, tra sale affrescate e camerieri in livrea,
promuovono i loro interessi. Insomma, sono una lobby. Una delle oltre seimila
che presidiano la capitale europea, con più di 15 mila dipendenti censiti mentre
altrettanti si muovono nell’oscurità. A Bruxelles il colore degli affari
rispecchia il cielo perennemente coperto: si va dal grigio al nero. Non a caso,
la frase magica della cricca degli appalti era «bisogna che il sole splenda per
tutti». Oggi la città è tutta un cantiere. Sono centinaia. Dall’aeroporto al
quartiere generale della Nato, dalla periferia al centro storico si vedono
ovunque gru e ruspe all’opera. Per non essere da meno, anche il Parlamento
europeo vuole abbattere l’edificio dedicato a Paul-Henri Spaak, completato nel
1993 con un miliardo di spesa: il progetto prevede altri 750 uffici per i
deputati del presente e del futuro, rappresentanti delle nazioni che aderiranno
all’Unione negli anni a venire. Se però dal Palazzo di Giustizia si va verso il
Parlamento percorrendo la chaussée d’Ixelles, la frenesia cementizia si mostra
in una luce diversa. La lunga arteria è stata completamente rifatta nel 2013,
solo che al momento dell’inaugurazione c’è stata una sorpresa: i marciapiedi
erano troppo larghi e gli autobus finivano per incastrarsi l’un contro l’altro.
Hanno ricominciato da capo, di corsa. Appena riaperta al traffico, però, la
pavimentazione allargata non ha retto al peso dei pulmann e si è riempita di
buche, manco fosse Roma. E giù con la terza ondata di lavori: ora la strada
sembra una chilometrica sciarpa rattoppata. Ixelles è un comune autonomo, perché
Bruxelles in realtà è un insieme di diciannove piccoli municipi indipendenti,
ciascuno con il suo borgomastro. In questo periodo il meno sereno è il sindaco
di Uccle, che per undici anni è stato pure presidente del Senato belga. Come
avvocato ha difeso una masnada di magnati kazaki, ottenendone l’assoluzione. In
cambio ha ricevuto 800 mila euro. «Compensi professionali», ha spiegato Armand
De Decker. Il sospetto invece è che la scarcerazione degli oligarchi sia il
tassello di un intrigo internazionale: una clausola del patto segreto tra il
presidente kazako Nazarbayev e l’allora collega francese Sarkozy per la vendita
di elicotteri, in cui era previsto anche «di fare pressione sul senato di
Bruxelles». Un’accusa formulata dagli inquirenti parigini, perché le procure
locali si guardano bene dall’indagare. Gli investigatori belgi non hanno fama di
efficienza né di indipendenza. La storia recente del Paese è costellata di
scandali che si perdono nel nulla, tra trame occulte e massoneria: i
parallelismi con l’Italia sono forti e anche qui prospera una cultura del
sospetto, che porta i cittadini a diffidare della giustizia. L’inchiesta sulla
tangentopoli capitale è partita nel 2005, le sentenze di primo grado ci sono
state solo quattro mesi fa. I dieci dirigenti della Régie des Batiments, che per
un decennio hanno intascato almeno un milione e 700 mila euro, se la sono cavata
con condanne irrisorie. «I fatti sono gravi, ma ormai antichi», ha riconosciuto
la corte. Questa giustizia lenta e spesso inefficace è anche arbitro di parecchi
dei misfatti che avvengono nei palazzi della Ue. Sono le magistrature nazionali
a procedere penalmente contro i corrotti, perché le agenzie europee possono
minacciare soltanto sanzioni amministrative: la punizione massima è il
licenziamento, una rarità, mentre più frequenti sono le retrocessioni di grado e
soprattuto le lettere di richiamo. Di certo, non un grande deterrente per
rinsaldare la moralità dei commissari, dei 751 deputati e dei 43 mila funzionari
che gestiscono ogni anno oltre 140 miliardi di euro e scrivono leggi vincolanti
per 28 Paesi. Mentre anche dalla loro onestà dipende la credibilità di un
organismo sempre meno rispettato. L’istituto statistico più autorevole,
Eurobarometro, due anni fa ha lanciato l’allarme: il 70 per cento dei cittadini
ritiene che la corruzione sia entrata nelle istituzioni europee. Lo credono
27.786 persone, selezionate scientificamente per rappresentare l’intera
popolazione dell’Unione. È un dato choc. La Commissione ha reagito annunciato
una crociata contro le tangenti in tutto il Continente. Ovunque, tranne che nei
suoi uffici: nel 2014 il primo rapporto anti-corruzione nella storia della Ue ha
sezionato i vizi di ogni Paese, senza però fare cenno ai peccati dentro casa:
quella che la Corte dei Conti europea ha definito nero su bianco «un’infelice e
inspiegabile omissione». D’altronde la presidenza di Jean-Claude Juncker è
cominciata nel peggiore dei modi. Le rivelazioni di LuxLeaks - pubblicate in
Italia da “l’Espresso” - hanno messo a nudo il suo ruolo nel trasformare il
Lussemburgo nel Bengodi delle aziende in cerca di tasse irrisorie. Per
riscattarsi, Juncker ha promesso una sterzata contro l’iniquità fiscale
legalizzata. «Ma finora la Commissione è stata passiva su questa materia»,
sottolinea Eva Joly, per anni il giudice istruttore più famoso di Francia, che
ha portato alla sbarra i crimini delle grandi aziende, ed ora è eurodeputato
verde: «La follia è che abbiamo al vertice dell’Europa l’uomo che ha arricchito
il Lussemburgo grazie alle tasse rubate agli altri, con guadagni che continuano
a crescere. Nel Parlamento i verdi hanno imposto la creazione di un comitato
speciale: il primo rapporto sarà pronto tra un mese e sarà molto duro. Anche i
conservatori ora hanno capito e c’è la volontà di piegare i paradisi fiscali:
sono convinta che il Lussemburgo dovrà adeguarsi o uscire dall’Unione». Quello
che Juncker costruito in Lussemburgo, a Malta lo ha realizzato John Dalli, il
ministro che ha fatto dell’isoletta una piazzaforte finanziaria, graditissima
agli investitori italiani più spregiudicati e ai miliardi rapidi delle
scommesse. Poi nel 2010 Dalli è entrato nel governo dell’Unione: come
commissario per la salute ha avuto in mano dossier fondamentali, incluso il via
libera alle coltivazioni ogm. Finché la sua carriera non si è trasformata in
circo. Letteralmente. Il suo vecchio amico Silvio Zammit, pizzaiolo e impresario
circense part-time, è andato in giro chiedendo soldi per conto del «boss». Ha
prospettato a una holding svedese la possibilità di spalancare il mercato
europeo a un prodotto che piace molto agli scandinavi: lo snus, il tabacco da
masticare. Una passione da pirati e cowboy, finora proibita nel resto della Ue,
con potenzialità miliardarie: rimpiazza le sigarette anche dove il fumo è
vietato. In cambio Zammit ha chiesto una somma niente male: 60 milioni di euro,
poco meno della storica tangentona Enimont. La questione è arrivata sul tavolo
dei detective dell’Olaf, l’unità antifrode europea guidata dall’italiano
Giovanni Kessler. Con investigatori provenienti dalla Guardia di Finanza,
perquisendo di notte l’ufficio del commissario, sono stati trovati «indizi
plurimi» del coinvolgimento personale di Dalli. Nell’ottobre 2012 l’allora
presidente Barroso ha obbligato il maltese alle dimissioni, firmate molto
controvoglia. Tant’è che quando, dopo la sostituzione del capo della polizia,
l’indagine penale nell’isola è stata archiviata, Dalli ha cominciato a sparare
denunce dichiarandosi vittima di un’ingiustizia. E il parlamento ha criticato
l’azione dell’Olaf: «Dal rapporto dei supervisori emergono molti dubbi sui
metodi del nostro istituto antifrode più importante, che nei resoconti manipola
le statistiche per presentare risultati migliori del reale», sancisce
l’eurodeputato verde Bart Staes, membro di spicco del comitato che vigila sul
budget, altro caposaldo del sistema di controllo. L’Olaf si è trovata ai ferri
corti pure con la Corte dei conti, a cui ha contestato appalti oscuri. Che a sua
volta ha rimandato le accuse al mittente. Insomma, un tutti contro tutti, con
esiti abbastanza deprimenti per l’affidabilità dei custodi di Bruxelles. Oggi
l’Europa sembra avere tanti cani da guardia litigiosi. E tutti con la museruola:
abbaiano, ma non mordono. Il loro compito infatti si limita a suggerire
provvedimenti. Fuori dai palazzi della Commissione, non hanno poteri e devono
invocare l’aiuto delle polizie nazionali. Che - tra interessi patronali e
differenze normative - non sempre collaborano. I detective europei hanno bisogno
di un’autorizzazione pure per ascoltare i testimoni. All’Olaf ogni indagine è
affidata a una coppia di ispettori, senza assistenti: si fanno da soli pure le
fotocopie e passano più tempo a difendersi da tiro incrociato delle altre
autorità che non a investigare. Il feeling che si respira è negativo, come se la
lotta alla corruzione interna non fosse una priorità, anzi. Eppure i campanelli
d’allarme non mancano, anche in Parlamento. L’ultimo a essere condannato due
mesi fa è stato un ex deputato inglese, Ashley Mote, che ha rubato 355 mila euro
grazie a rimborsi gonfiati. È stato uno dei primi eletti del movimento
anti-europeo inglese: nei comizi urlava contro il malaffare di Bruxelles, poi
falsificava le note spese. Janice Atkinson, sempre dell’Ukip, a marzo si è fatta
triplicare la ricevuta dopo il cocktail con la moglie del leader Nigel Farage -
4350 euro invece di 1350 - mentre la sua assistente si vantava: «È un modo di
riportare a casa i nostri soldi». E quando nel 2011 un reporter del “Sunday
Times” si è finto lobbista, offrendo denaro in cambio di emendamenti a sostegno
della sua società, tre deputati hanno abboccato subito. Due - un austriaco e uno
sloveno - si sono dimessi e sono stati condannati in patria. Il terzo, l’ex
ministro degli Esteri romeno Severin, è ancora al suo posto mentre l’istruttoria
a Bucarest langue. Distinguere tra lobbisti veri e falsi non è facile. A
Bruxelles è stato istituito un registro per queste figure, senza vincoli né
sanzioni: chi vuole si accredita. L’attivissima sezione europea di Transparency
International un mese fa ha dimostrato che metà delle 7821 dichiarazioni
ufficiali delle lobby erano «incomplete o addirittura insensate». E in tanti si
sottraggono al censimento, a partire dagli studi legali: un’armata che esercita
un’influenza nascosta. La soluzione? «Rendere obbligatoria l’iscrizione al
registro», spiega Carl Dolan di Transparency. «E bisogna vietare ogni contatto
con chi non è iscritto», aggiunge Staes: «Devo ammettere però che in Parlamento
non esiste una maggioranza favorevole al registro obbligatorio. Noi verdi, come
i 5stelle italiani e alcuni esponenti socialdemocratici, ci stiamo battendo,
molti invece sono contrari». Tra i palazzi delle istituzioni e quelli dei
potentati economici ci sono tante porte girevoli. Si passa dagli uffici della
Commissione a quelli delle corporation e viceversa. Figure come Lord Jonathan
Hill, con trascorsi in società di lobby della City, imposto dal governo Cameron
al vertice della struttura Ue che si occupa di mercati finanziari. O il caso
sensazionale di Michele Petite, il direttore europeo degli affari legali che si
tramuta in consigliere della Philip Morris e poi rientra come presidente del
comitato etico che dirime i conflitti d’interesse nella Ue. Ma queste sono le
pedine sullo scacchiere di una partita più complessa. Le manovre dei lobbisti
intrecciano network che possono seguire la geopolitica dei governi, dei partiti
o semplici reti di conoscenze trasversali adeguatamente retribuite. Il terreno
di caccia favorito è la zona grigia in cui i grandi propositi dei legislatori
europei si trasformano in regolamenti, spesso modesti. Uno dei passaggi più
opachi avviene nei “gruppi di esperti” che studiano i dossier caldi. Una ong ha
appena svelato che il 70 per cento degli esperti incaricati di valutare la
questione del fracking, la discussa tecnica di estrazione petrolifera, hanno
relazioni con le compagnie del settore. Non si tratta di un’eccezione, ma di un
andazzo molto diffuso. L’Ombudsman europeo, l’autorità etica più piccola e
dinamica, apre un’istruttoria dietro l’altra. Senza spezzare la cortina di ferro
che protegge gli intrallazzi. «Bisogna incrementare al massimo la trasparenza,
deve esserci sempre una traccia scritta di chi interviene nelle discussioni
interne», sintetizza Carl Dolan. I conflitti di interessi pullulano: nel 2012
sono stati segnalati 1078 dipendenti europei con incarichi extra. Quelli
sanzionati sono una ventina, quasi sempre con reprimende scritte o verbali.
L’impunità è pressoché certa. Per anni il funzionario Karel Brus ha fatto sapere
in anticipo agli emissari di due colossi dei cereali, l’olandese Glencore e la
francese Univivo, i prezzi stabiliti dall’Europa per gli aiuti agricoli: notizie
d’oro, che permettevano di investire a colpo sicuro. In cambio si ipotizza che
abbia incassato almeno 700 mila euro. Prima della condanna penale però sono
passati dieci anni e il travet è sparito in Sudamerica. E per le due società c’è
stata solo una multa: mezzo milione, un’inezie rispetto ai profitti. La
Commissione ha in mano un’arma micidiale: può bandire le aziende corruttrici da
tutti i contratti europei. Misura applicata solo due volte negli ultimi anni.
Perché la volontà di fare pulizia sembra labile. Prendiamo il dieselgate di
Volskwagen: gli uffici tecnici dell’Unione avevano segnalato i trucchi della
casa tedesca da parecchi mesi, ma la denuncia è rimasta lettera morta fino
all’intervento delle autorità statunitensi. «Questa è la nuova corruzione. Ed è
il nuovo mondo, in cui si agisce tramite logaritmi che falsificano i dati dei
computer: la realtà si riduce a schermate digitali, mentre Volskwagen otteneva
fondi per produrre auto ecologiche e contribuiva ad aumentare l’inquinamento che
uccide migliaia di persone», tuona Eva Joly: «Ma la portata dello scandalo è
ancora più grave, perché dimostra che il rispetto delle regole non è più un
valore. La Germania, il Paese della legge e dell’ordine, ha ingannato tutti; la
loro azienda simbolo ha mentito per anni. Le nazioni che hanno costruito questa
Unione stanno perdendo credibilità e non capiscono quanto ciò peserà sul futuro
delle nostre istituzioni». In quello shoccante 70 per cento di cittadini che
percepisce un’Europa corrotta si proietta una sfiducia più vasta. «È un dato che
nasce dallo sconcerto per la debolezza della reazione davanti ai problemi: la
crisi economica, il tracollo greco e adesso l’esodo dei migranti», commenta Bart
Staes: «La gente sente i racconti sulle pressioni delle lobby, si diffonde il
sospetto che l’Unione serva più per tutelare gli interessi economici che i
cittadini. C’è la necessità di riforme profonde, che non sono nell’agenda di
Juncker. Ma soprattutto bisogna dare risposte concrete: fatti, non storytelling.
Partiamo dalla Volskwagen: quasi tutti i produttori di auto sfruttano i buchi
nella legislazione per alterare i test, noi verdi abbiamo proposto di cambiare
le regole e punire chi mente. Se agisci e la gente vede che i guasti vengono
risolti, allora avrà di nuovo fiducia». Un professore dal cognome altisonante,
David Engels, in un saggio ha paragonato il declino dell’Unione al crollo della
repubblica nella Roma antica. Oggi come allora, l’allargamento troppo rapido dei
confini, il confronto con un’economia globalizzata, la crisi dei modelli
religiosi - all’epoca i nuovi culti importati nell’Urbe, adesso l’Europa
cristiana alle prese con l’Islam - e il contrasto tra i privilegi dei patrizi e
l’impoverimento dei ceti popolari, logorano le istituzioni democratiche.
Un’analisi che riecheggia le parole scritte da Altiero Spinelli nel 1941, in
quel manifesto di Ventotene che ha partorito l’idea di Europa unita. «La
formazione di giganteschi complessi industriali e bancari... che premevano sul
governo per ottenere la politica più rispondente ai loro particolari interessi,
minacciava di dissolvere lo Stato stesso. Gli ordinamenti democratico liberali,
divenendo lo strumento di cui questi gruppi si valevano per meglio sfruttare
l’intera collettività, perdevano sempre più il loro prestigio, e così si
diffondeva la convinzione che solamente lo stato totalitario, potesse in qualche
modo risolvere i conflitti di interessi». Era la situazione che ha fatto
trionfare le dittature e spinto il continente nel baratro della guerra. L’Europa
unita è nata da questa lezione, che ora sta dimenticando.
"Noi detective facciamo il massimo".
Parla Giovanni Kessler, dal 2011 alla guida degli ispettori antifrode Ue
dell'Olaf. Giovanni Kessler
viene spesso indicato come l’italiano più potente negli uffici della Ue. In
patria la sua carriera si è alternata tra magistratura e politica: pubblico
ministero a Trento e Bolzano, con due anni da volontario a Caltanissetta per le
indagini sulle stragi di mafia. Poi è stato eletto nel 2001 deputato, diventando
poi uno dei costituenti del Pd e quindi presidente della provincia di Trento.
Dall’inizio del 2011 è alla guida dell’Olaf, i detective antifrode dell’Ue, che
vigilano sulla gestione dei fondi e sull’etica di tutta la vita comunitaria.
Kessler,
il 70 per cento dei cittadini europei crede che la corruzione sia entrata nelle
istituzioni Ue. Lei ritiene fondata questa percezione?
«Io credo che le
istituzioni europee abbiano un sistema di controllo più avanzato che altrove e
che funziona bene. Ci sono stati casi di frode e ce ne saranno altri che non
conosciamo: non esistono organismi immuni dalla corruzione. Ma se ci fossero
sacche profonde di malaffare lo sapremmo e non ci sono. Queste istituzioni sono
sane e hanno qualcosa che non esiste in nessuno degli stati membri: l’Olaf,
appunto. Siamo un servizio ispettivo indipendente: è questa la parola chiave,
che lo rende diverso dalle altre strutture esistenti nel mondo».
Ma voi
formalmente siete parte della Commissione, ossia del governo europeo.
«Noi
amministrativamente facciamo parte della Commissione, io ho la qualifica di
direttore generale, ma viene garantita l’indipendenza per tutto quello che
riguarda la nostra attività di investigatori. Possiamo indagare su tutti gli
organismi europei, incluso il parlamento. Non siamo generici ispettori:
riceviamo notizie o agiamo autonomamente. Le istituzioni hanno l’obbligo di
segnalarci sospetti di malversazione, ma anche i cittadini possono rivolgersi
direttamente a noi, pure in forma anonima».
E avete
poteri sufficienti?
«Il limite è che
facciamo indagini amministrative, non abbiamo strumenti come l’accesso ai conti
bancari per tracciare le transazioni sospette. Ma per quello che riguarda
inchieste interne abbiamo poteri significativi. Ad esempio i commissari non
hanno immunità nei nostri confronti: possiamo ottenere tutto quello che li
riguarda, biglietti aerei, note spese, documenti. Possiamo persino entrare nei
loro uffici, guardare nei cassetti e nei computer».
Le
statistiche indicano che in questi anni la vostra produttività è aumentata
considerevolmente.
«Nel 2012 abbiamo
rivisto la nostra organizzazione. Oggi il numero di inchieste è raddoppiato
mentre si sono ridotti i tempi medi. C’è stato un cambiamento di mentalità:
cerchiamo di essere più orientati ai risultati, sempre nel rispetto delle
procedure. Ossia alla conclusione dell’indagine, che porti all’archiviazione o a
una incriminazione».
Si è
parlato spesso di potenziare la vostra capacità operativa: un rapporto di
Transparency international giudica insufficiente le vostre risorse.
«Un dirigente dirà
sempre che vuole più risorse, infatti le ho chieste in tutte le sedi. Credo però
che quella che abbiamo raggiunto in questi anni sia la nostra “velocità di
crociera” e mi chiedo se può avere un senso aumentarla ancora. L’Olaf dispone di
circa 300 persone per l’attività investigativa, se anche avessi il doppio del
personale, sarebbe sempre una goccia rispetto alle dimensioni dell’Europa».
L’indagine sul commissario Dalli è stata la più importante. Però dopo questo
successo siete stati voi a finire sotto accusa. Alcuni deputati hanno chiesto
persino le sue dimissioni.
«Non mi aspettavo certo
una simile reazione. Il dibattito si è spostato dalle aule del tribunale al
parlamento, dove siamo stati contestati da alcuni settori. Immagino che possa
avere contribuito il rendersi conto per la prima volta che l’Olaf è realmente un
potere autonomo, che non si può imbavagliare in alcun modo e che può avere un
ruolo determinante nella lotta alla corruzione. Ma in questa vicenda ho notato
l’assenza di un’opinione pubblica europea che facesse sentire il suo peso. È
stato accertato che Dalli ha avuto incontri nascosti con i rappresentati dei
produttori di tabacco, vietati dai codici Ue».
Lobby e consulenze, il record europeo di
Soru. I numeri dell'Integrity Watch di Transparency
International fotografano lo stato del lobbismo in Europa. E nella lista nera
finisce l'ex presidente della regione Sardegna, continua “L’Espresso”.
E le aziende italiane come fanno lobby in Europa? L’unico modo per tentare una
radiografia sono i dati sugli incontri condotti dai lobbisti con commissari e
alti dirigenti della Ue, che vengono censiti dallo scorso dicembre. Il
monitoraggio è possibile grazie al sito Integrity Watch di Transparency
International. Che spiega come fino a luglio la più attiva sia stata
Confindustria, con 14 meeting nel carniere e 12 rappresentanti autorizzati a
entrare in Parlamento mentre i dipendenti schierati nella capitale sono solo 9.
Più tesserini che persone? Forse i badge sono stati richiesti per i vertici
italiani dell’associazione industriali o forse per consulenti tecnici. Nella hit
parade troviamo società di energia, acciaio e banche assieme a Mediaset. Fiat
Chrysler ha avuto solo due colloqui di alto livello europeo e schiera due
addetti a Bruxelles. Una pattuglia ridotta. Ma la compagnia di Sergio
Marchionne, che si presenta come registrata a Londra, ha un cuore che batte
negli Usa, nonostante solo due anni fa abbia ottenuto sei milioni dalla Ue per
un programma di ricerca. Tra gli europarlamentari, invece, lo stesso
osservatorio punta un faro su Renato
Soru, ex presidente sardo e fondatore di Tiscali, che è al quinto posto
assoluto per mole di incarichi esterni. È stato incluso in una lista nera di
nove deputati contestati per i rapporti economici con compagnie di pubbliche
relazioni o associazioni industriali. Il polacco Michal Boni per esempio ha
omesso di dichiarare le sue consulenze per il colosso della lobby dal nome
evocativo di Lewiatan. Ma chi tace non corre rischi. L’ex ministra francese
Rachida Dati viene attaccata per il silenzio sui nomi dei clienti che
arricchiscono il suo studio legale mentre siede in Parlamento. E uno degli
eletti in Belgio si è scordato di rendere nota la proprietà di stock option per
cinque milioni di euro: un vero sbadato.
Così l'Italia regala i fondi europei ai
big delle consulenze. Le multinazionali Ernst & Young
e PricewaterhouseCoopers fanno il pieno di fondi strutturali. Con risultati
spesso non all'altezza delle parcelle da record, scrive Stefano Vergine su
“L’Espresso”. L’Italia, si sa,
non è brava a spendere i fondi strutturali europei. È però bravissima a
utilizzarli per pagare consulenze, a volte con procedure che riducono al minimo
la concorrenza e fanno felici quasi sempre le stesse aziende. Due, per la
precisione: Ernst & Young e Pricewaterhouse Coopers.
I numeri aiutano a
comprendere il fenomeno. Di tutti i fondi
strutturali ricevuti dall’Unione europea per lo sviluppo del Mezzogiorno,
ne abbiamo spesi più in consulenze che per settori cruciali come il turismo e la
cultura. Il dato emerge dai documenti della Ragioneria dello Stato sui fondi
europei assegnati a Roma dal 2007 al 2013, l’unico periodo su cui finora sono
state pubblicate cifre definitive. Dei 31,4 miliardi da spendere in questi sette
anni con l’obiettivo ufficiale di sviluppare il Sud, il 3,3 per cento è andato a
quella che viene definita “assistenza tecnica”. Tradotto dal burocratese: la
consulenza è costata un miliardo di euro. Spesa che, in teoria, un senso ce
l’avrebbe. Per usare al meglio gli aiuti europei, regioni e ministeri si possono
infatti affidare a società esterne che hanno competenza in materia. Nella
pratica non funziona sempre così. Lo dicono i risultati ottenuti finora. E lo
fanno capire ancora meglio due bandi di gara recenti. Uno, pubblicato a maggio
dal ministero dell’Interno, cerca consulenti per migliorare il sistema di
accoglimento dei richiedenti asilo. Vale 13,4 milioni di euro, quasi
l’equivalente di quello che l’Unione europea spende in cinque mesi per
l’operazione di pattugliamento del Mediterraneo chiamata Triton. L’altro bando
per la consulenza, aperto a luglio dal ministero dell’Istruzione, promette 48
milioni di euro, che possono salire a 81,6 milioni senza ulteriore gara, per un
progetto di innovazione scolastica. Di strano c’è che nessuna delle due offerte
richiede esperienza specifica nella gestione del problema oggetto di gara.
Entrambi i bandi impongono però come condizione necessaria un “fatturato
specifico”. Cifre alte: nel primo caso dev’essere pari a quasi 10 milioni di
euro, nel secondo addirittura a 24 milioni. L’anomalia sta proprio qui.
Significa che può vincere la commessa solo chi ha già fatto soldi (e tanti) con
la consulenza sui programmi finanziati dall’Ue, e poco importa se quella
consulenza non aveva nulla a che fare con i migranti o la scuola. Una stranezza
italiana, dimostra uno studio della Confindustria: il fatturato specifico è
richiesto nel 90 per cento delle gare bandite da noi, mentre nel Vecchio
Continente la media è del 18 per cento. Il risultato è che i possibili vincitori
dei ricchi contratti appena offerti dai ministeri guidati da Angelino Alfano e
Stefania Giannini sono, appunto, due: Ernst & Young e PricewaterhouseCoopers. Si
tratta di colossi del settore, multinazionali con base a Londra e sedi in ogni
angolo del globo. L’alta probabilità che siano loro a vincere dipende dai
numeri. Solo queste due società possono infatti vantare fatturati specifici del
genere. Perché sono loro ad aver fatto finora la parte del leone nella
spartizione delle consulenze sui fondi europei destinati all’Italia. Lo dicono i
dati pubblicati dal governo sul sito opencoesione.gov.it. Si legge che
PricewaterhouseCoopers ha incassato dal 2007 al 2013 circa 42 milioni di euro,
Ernst & Young è arrivata a fatturare più di 44 milioni. Cifre enormi, rispetto a
quelle incamerate dai concorrenti (a cui non rimane che consorziarsi per cercare
di raggiungere le soglie di fatturato richieste). E il merito non è solo dei
concorsi tagliati su misura, a volte è anche dei continui rigonfiamenti dei
costi. Come nel caso di una gara bandita nel 2009 dal ministero dell’Istruzione,
il cui valore è passato in meno di tre anni da 26 a 47 milioni di euro.
Praticamente raddoppiato grazie ai ritocchi decisi da alcuni dirigenti di Stato.
Ad aggiudicarsi l’appalto, sul quale la Procura di Roma ha avviato un’indagine,
è stato un consorzio di cui fa parte Ernst & Young. Sulla vicenda dovranno fare
chiarezza i magistrati romani, ma di certo i dati dimostrano che in Italia vale
una regola particolare: consulente che vince non si cambia. Un sistema che
ostacola la concorrenza. E non aiuta a risparmiare fondi pubblici, né a usare
bene i pochi soldi che otteniamo dall’Europa per la crescita del malandato Sud.
LA MASSONERIA ED IL NAZI-FASCISMO-COMUNISMO.
Comunismo e Nazi-Fascismo figli degeneri del
Socialismo. Il comunismo, come ideologia, si prefigge l’estinzione delle classi
con il supporto della massoneria; il Nazi-Fascismo si prefigge l’eliminazione
delle razze con l’aiuto della massoneria.
La Mano Nascosta che ha Fatto Storia
(Hidden Hand), scrive The Vigilant Citizen. Traduzione
a cura di Anticorpi.info. I dipinti e le immagini dei grandi uomini del passato
rivelano un elemento che li accomuna. Può essere solo un caso il fatto che molti
di essi nascondessero una mano mentre posavano per i dipinti che li ritraevano?
Improbabile. In questo post esamineremo l'origine massonica della "mano
nascosta" (hidden hand) e i potenti personaggi che si fecero ritrarre nell'atto
di compiere tale segno. Ricordo quando la mia docente di storia cercava di
spiegarci come mai Napoleone fosse frequentemente raffigurato con una mano sotto
la camicia. Le motivazioni ufficiali sono elencate nelle seguenti righe:
"Sono state avanzate numerose teorie per spiegare
perché Napoleone sia stato tradizionalmente raffigurato con la mano nel
panciotto. Ad esempio: un'ulcera allo stomaco, la carica dell'orologio, una
malattia della pelle, il fatto che all'epoca fosse ritenuto scortese tenere le
mani in tasca, un cancro al petto, una mano deforme, una bustina profumata nel
panciotto, il fatto che i pittori non amino dipingere le mani." Tom Holmberg
A meno che tutti i personaggi citati in questo
articolo avessero una ulcera gastrica o una mano deformata, al gesto di
nascondere la mano si deve attribuire un significato specifico. Che in effetti
c'è. La maggior parte delle persone che usano questo segno sono membri della
massoneria. Considerando la grande importanza di tale gesto nei rituali
massonici e che tutte le elite facessero parte della massoneria o comunque
sapessero cosa fosse, è impossibile che la continua riproposizione di questo
gesto sia semplicemente il risultato di una coincidenza. La mano nascosta è
infatti un simbolo ricorrente nei rituali del grado massonico Royal Arch, ed i
leader mondiali se ne servono per comunicare agli altri iniziati dell'ordine:
"Questo è ciò a cui appartengo, ciò in cui credo e per il quale sto lavorando."
Il grado Royal Arch (13° grado del Rito Scozzese o 7° del Rito di York) è noto
anche come Mason of the Secret. Raggiunto questo grado, si dice che gli iniziati
ricevano le grandi verità massoniche.
"Fino al Royal Arch gli iniziati sono
familiarmente denominati confratelli, e mantenuti in uno stato di profonda
ignoranza. Dal Royal Arch in poi i membri sono denominati compagni, e hanno
diritto a una spiegazione esauriente sui misteri dell'ordine. Tale
differenziazione concorda con la nota abitudine di Pitagora di rubricare i
propri allievi praticamente alla stessa maniera. Dopo una sospensione
condizionale di cinque anni, gli allievi erano ammessi alla presenza del
precettore, il quale si rivolgeva a loro come "compagni" cui era consentito
conversare con lui liberamente. Prima di tale termine il maestro impartiva i
suoi insegnamenti da dietro uno schermo." John Fellows, Inchiesta su Origini,
Storia e Tenore della Massoneria
"Accedendo al Royal Arch si apprendono
meravigliose nozioni che non potrebbero essere eguagliate da qualsiasi
istituzione umana." George Oliver, Lezioni sulla Massoneria
È a questo punto che l'iniziato impara il sacro
nome di Dio.
"Un grado più augusto, sublime e importante di
quelli che lo precedono, che è, infatti, il culmine e la perfezione dell'antica
Massoneria. Esso lascia nella nostra mente la convinzione della esistenza di un
Dio senza inizio e senza fine - la grande e incomprensibile Alfa e Omega - e ci
ricorda la riverenza che dobbiamo al suo Santo nome." George Oliver, Monumenti
Storici
Tale Santo nome è Jahbulon, combinazione di parole
che significano "dio" in siriaco, caldeo ed egiziano.
"JEHOVAH. Tra le varie versioni di questo nome
sacro in uso tra le diverse nazioni della terra, tre in particolare meritano
l'attenzione dei massoni di grado Royal Arch:1. JAH, riscontrabile nel Salmo 68,
v. 4.2. BAAL o BEL. Questa parola indica un signore, padrone o possessore, ed è
stata applicata da molte nazioni d'oriente per indicare il Signore di tutte le
cose, il Maestro del mondo.3. ON. Era il nome con cui JEHOVAH veniva
venerato tra gli egiziani." Malcolm C. Duncan, Rituali Massonici
Il rito di iniziazione a tale grado rievoca il
ritorno a Gerusalemme dei tre più eccellenti massoni, dopo la prigionia in
Babilonia. Evitando di esaminare l'intera cerimonia e il relativo simbolismo, ad
un certo punto del rito viene chiesto all'iniziato di imparare una parola
segreta e un segno della mano che incarni il passaggio di un "velo." L'immagine
sulla destra raffigura il segno che simboleggia il passaggio al Secondo
Velo, come documentato nel libro Rituali Massonici di Duncan.
"Il Maestro del Secondo Velo: devi essere tre
eccellenti maestri, poiché più in là non puoi arrivare senza la mia parola,
segno, ed esortazione. Le mie parole sono Sem, Japhet, e Adoniram; il mio segno
è questo: (portando la mano al petto), esso imita ciò che Dio diede a Mosè,
quando Egli gli ordinò di spingere la mano in seno e poi, estraendola, la mano
divenne bianca e lebbrosa come la neve. La mia parola di esortazione è la
spiegazione di questo segno, e si trova negli scritti di Mosè, Quarto capitolo
dell'Esodo: “E il Signore disse a Mosè: Poni ora la tua mano in grembo. E lui
mise la mano in seno, e quando la tirò fuori, ecco che la sua mano era lebbrosa
come la neve." Malcolm C. Duncan, Rituali Massonici
Come detto, il gesto della mano è ispirato dal
verso 4:6 dell'Esodo. In questo passaggio biblico il cuore ("petto") rappresenta
ciò che siamo in base alle nostre azioni. Si può pertanto interpretarlo
come: sei ciò che fai. Il significato simbolico di questo gesto potrebbe
spiegare il motivo per cui è così largamente utilizzato dai più celebri massoni.
La mano nascosta consente agli altri iniziati di sapere che la persona
raffigurata fa parte della fratellanza segreta, e che le sue azioni sono
ispirate alla filosofia massonica. La mano che esegue le azioni è celata dietro
il bavero, il che simbolicamente si riferisce alla natura occulta delle azioni
massoniche. Ecco alcuni uomini celebri che utilizzarono il segno della mano
nascosta.
NAPOLEONE BONAPARTE.
Napoleone (1769-1821) fu un leader militare e politico francese,
dalle cui azioni scaturì la politica europea nel XIX secolo. Iniziato presso la
loggia dell'Army Philadelphe nel 1798. I suoi fratelli Giuseppe, Luciano, Luigi
e Girolamo, erano tutti e quattro massoni. Cinque dei sei membri del Gran
Consiglio dell'Impero erano massoni, come lo erano sei dei nove funzionari
imperiali e 22 dei 30 Marescialli di Francia. Lo studioso di cultura massonica
J.E.S. Tuckett affronta così la questione: "Strano che le prove riguardanti
l'appartenenza di Napoleone alla fratellanza massonica non siano mai state
esaminate in dettaglio, poiché la questione è di estremo interesse e - alla luce
del ruolo notevole che questo straordinario uomo ebbe negli affari del
continente europeo." Nel saggio su Napoleone e la Massoneria, Tuckett scrive:
"Ci sono prove inconfutabili secondo le quali Napoleone conoscesse la natura, la
finalità e la struttura della Massoneria; nozioni che approvava e praticava per
promuovere i propri scopi." J.E.S. Tuckett, Napoleone e la Massoneria (fonte) Si
dice anche che Napoleone facesse ricorso a poteri occulti. Quando nel 1813 fu
sconfitto a Leipzip, un ufficiale prussiano scoprì una "stanza dei segreti"
appartenente al condottiero corso, nella quale era custodito il libro del
Destino e degli Oracoli. In principio questo libro fu scoperto in una delle
tombe reali di Egitto nel corso di una spedizione militare francese del 1801.
L'imperatore ne commissionò la traduzione ad uno studioso e antiquario tedesco.
Da quel momento in poi, l'Oraculum diventò uno dei beni più preziosi di
Napoleone. Lo consultava in molte occasioni e si dice che abbia "costituito uno
stimolo per le sue imprese speculative di maggior successo."
KARL MARX. Karl
Marx è noto per aver fondato il comunismo moderno. Benché alcuni massoni neghino
questa possibilità,sembra che sia stato un massone di 32 grado della loggia del
Grande Oriente. Marx si fece portavoce del movimento ateo e socialista d'Europa.
Sosteneva il principio secondo cui la fase successiva alla sostituzione delle
monarchie con le repubbliche socialiste sarebbe dovuta essere la conversione
delle stesse in repubbliche comuniste.
GEORGE WASHINGTON.
George Washington fu uno dei Padri Fondatori degli Stati Uniti, ed è considerato
'il più importante massone americano.' Charles Willson scovò questo dipinto di
un Washington all'età di 52 anni. Notate la posizione dei piedi: essi formano
una piazza oblunga. La posizione dei piedi è molto importante nel simbolismo
massonico.
WOLFGANG AMADEUS MOZART.
Mozart è uno dei più prolifici e influenti compositori di
sempre. Fu massone, iniziato nella loggia austriaca Zur Zur Wohltätigkeit il 14
Dicembre 1784. Numerose sue opere contengono degli importanti elementi
massonici. Prima tra tutte Il Flauto Magico, del tutto basata su principi
massonici. Di seguito, alcune composizioni create da Mozart per le logge
massoniche:
Lied (canzone) "Gesellenreise, da utilizzare
durante l'assunzione di nuovi operai."
Cantata per tenore e coro maschile Die
Maurerfreude ("The Mason's Joy").
La funerea musica massonica (Maurerische
Trauermusik).
Due canzoni per celebrare l'apertura del "Zur
Hoffnung Neugekrönten":
Cantata per tenore e pianoforte, Die ihr die
Weltalls Schöpfer ehrt unermesslichen.
La piccola cantata massonica (Kleine
Freimaurer-Kantate).
IL MARCHESE DE LAFAYETTE.
De Lafayette fu massone di 33 grado. Secondo quanto sostenuto da Willam Denslow
nell'opera 10.000 Massoni Famosi, Lafayette era un ufficiale francese, che
partecipò come generale alle guerra di indipendenza americana e fu tra i leader
della Guardia Nazionale francese durante la sanguinosa rivoluzione. Fu anche
nominato Gran Commendatore onorario del Supremo Consiglio di New York. Più di 75
organismi massonici negli Stati Uniti portano il suo nome.
SALOMON ROTSCHILD.
Salomon Rothschild è stato il fondatore del ramo viennese della famiglia di
Mayer Amschel Rothschild. La famiglia più potente del mondo ha molto influenzato
le politiche di Germania, Francia, Italia e Austria. I Rothschild sono tra i
creatori del sionismo e dello Stato di Israele. Il loro potere si è propagato
ben oltre i confini della loggia massonica. Si dice facciano parte delle 13
linee di sangue degli "Illuminati." Il recente edificio della Corte suprema di
Israele - finanziato dai Rothschild - conferma il ricorso al simbolismo
massonico da parte di tale famiglia.
SIMON BOLIVAR.
Noto come El Libertador (il Liberatore), Simon Bolivar è considerato il George
Washington del Sud America. E' entrato in massoneria presso Cadice, in Spagna,
per poi essere iniziato al Rito Scozzese a Parigi ed essere nominato templare in
Francia nel 1807. Bolivar ha fondato e servito come comandante la loggia
Protectora de las Vertudes No.1 in Venezuela. Il paese della Bolivia porta il
suo nome. Bolivar fu anche presidente della Colombia, del Perù e della Bolivia
nel 1820. Apparteneva alla loggia Ordine e Libertà No. 2, in Perù. Notate
nell'immagine la posizione dei suoi piedi e lo schema a scacchiera del
pavimento, anch'esso massonico.
JOSEPH STALIN.
Il regno del terrore di Stalin in Unione Sovietica provocò la morte di milioni
di suoi connazionali. Spesso nelle foto si fece ritrarre facendo il gesto della
mano nascosta. Non esistono documenti ufficiali che dimostrino la iniziazione di
Stalin alla Massoneria. Naturalmente, i dittatori come Stalin riuscivano a
controllare tutte le informazioni circa se stessi ed i loro affari, rendendo
difficile provare alcunché in un senso o nell'altro. Il segnale della mano
nascosta però fornisce un indizio della sua appartenenza ad una fratellanza
occulta.
ALTRI PERSONAGGI: Mazzini, Cavour, Henry Varnum
Poor (Standard & Poor's), Franklyn Pierce.
Come si è visto, i leader con la "mano nascosta"
hanno avuto una grande influenza sulla storia del mondo ed è stato confermato
che molti fossero massoni. Questo gesto è un dettaglio ancora largamente
trascurato, che allude all'abbraccio della filosofia occulta da parte del
leader. Una volta compreso questo fatto e riconosciuta l'immensa influenza che
questi leader hanno avuto sul corso della storia, possiamo cominciare a
comprendere la forza nascosta che attualmente guida l'attuale mondo
internazionale. I membri di queste confraternite avranno anche mantenuto
opinioni diverse e aderito a fazioni differenti (comunismo contro capitalismo),
ma la filosofia di fondo, le convinzioni e gli scopi ultimi erano comuni:
l'avvento di una Età dell'illuminismo. Naturalmente, ogni ricercatore serio è
già a conoscenza del ruolo della massoneria nel dispiegarsi della storia
mondiale. Il segno della mano nascosta usato da numerosi personaggi storici è
semplicemente l'espressione di questa realtà poco nota. Come affermò
Confucio: "Il mondo è governato da segni e simboli, non da leggi e frasi."
Articolo in lingua inglese pubblicato sul sito The Vigilant Citizen
Lo scopo della massoneria è il trionfo
del Comunismo. Pubblicato da "Neovitruvian". Secondo
CG Rakovsky i massoni “devono morire per mano della rivoluzione, raggiunta
grazie alla loro cooperazione”. Fu uno dei fondatori dell’Internazionale
Comunista, ambasciatore sovietico a Parigi e Londra, e capo di Stato
dell’Ucraina. “Il vero segreto della massoneria è il suicidio della massoneria
come organizzazione, e il suicidio fisico di ogni importante massone.” Questa
rivelazione proviene da un interrogatorio della polizia stalinista nel 1938 dal
titolo “La Sinfonia rossa”, un documento non originariamente concepito per
il pubblico. By Henry Makow Ph.D.
(Trascrizione da Des Griffin, Fourth Reich of the Rich, p. 254, on-line)
Tradotto da “Neovitruvian” . “So tutto questo non
perche` sia un massone, ma poiché appartengo a Loro ‘” [gli Illuminati] dice
Rakovsky, un collega di Leon Trotsky arrestato per aver complottato contro
Stalin. L’obiettivo di Rakovsky è quello di convincere Stalin, un nazionalista,
a collaborare con l' “internazionale comunista-capitalista. La massoneria è la
più grande società segreta al mondo con oltre cinque milioni di membri, di cui
tre milioni negli Stati Uniti. E ‘strumentale nella cospirazione totalitaria.
Nei Protocolli dei Savi di Sion, l’autore (forse Lionel Rothschild, 1808-1879)
scrive: “La muratoria Gentile funge ciecamente da schermo per noi e per i nostri
obiettivi, ma il piano d’azione rimane per tutto il popolo un mistero
sconosciuto …. Chi e che cosa è in grado di rovesciare una forza invisibile?”
(Protocollo 4)”. Ancora egli scrive, «dovremo creare e moltiplicare le logge
massoniche … assorbire in loro tutti che sono di primo piano nella attività
pubblica e coloro che possono tornarci utili, perché in queste logge troveremo
il nostro centro per l’intelligence e le attività di influenza …. Le trame
politiche più segrete ci saranno note e cadranno sotto le nostre abili mani
manipolatorie… Noi sappiamo quale è la meta finale … mentre i goyim non
sanno nulla … “(protocollo 15) Nel suo interrogatorio, Rakovsky dice che milioni
affollano la Massoneria per ottenere un vantaggio. “I governanti di tutte le
nazioni alleate erano massoni, con pochissime eccezioni.” Tuttavia, il vero
obiettivo è “creare tutti i presupposti necessari per il trionfo della
rivoluzione comunista, questo è lo scopo evidente della massoneria, ma è chiaro
che tutto questo va fatto con vari pretesti, ma sempre attraverso i loro ben
noti slogan [Libertà, Uguaglianza, Fraternità]. Hai capito?” (254) I massoni
dovrebbero ricordare la lezione della Rivoluzione francese. Anche se “hanno
giocato un ruolo fondamentale nella rivoluzione, sono stati consumati da essa…”
Dal momento che la rivoluzione richiede lo sterminio della borghesia come
classe, [così tutta la ricchezza andrà dagli Illuminati nelle vesti dello Stato]
ne consegue che i massoni devono essere liquidati. Quando questo segreto viene
rivelato, Rakovsky immagina “l’espressione di stupidità sul volto di qualche
massone quando si rende conto che deve morire per mano dei rivoluzionari. Urlerà
e vorrà riconosciuti i suoi servizi nella rivoluzione! E ‘ uno spettacolo in cui
si può morire … ma di risate!” (254) Rakovsky si riferisce alla massoneria come
una bufala: “Un manicomio, ma in libertà” (254) In Russia nel 1929, ogni massone
che non era ebreo venne ucciso insieme alla sua famiglia, secondo Alexey Jefimow
(“Chi sono i governanti della Russia?» P.77) Come massoni, altri richiedenti per
l’ammissione nella “utopica masterclass umanista” (neocons, i liberali, i
sionisti, i gay e le attiviste femministe) potrebbero trovarsi in una brutta
sorpresa. Probabilmente infatti verranno messi da parte una volta che
adempiranno al loro scopo. Quando l’interrogatore fece pressioni su Rakovsky per
avere informazioni su importanti Illuminati che gli si sono avvicinati con una
iniziativa, Rakovsky era sicuro che almeno due di essi fossero morti: Walter
Rathenau il ministro degli Esteri del Wiemar, e Lionel Rothschild. Dice che
Trotsky era la sua fonte di informazione. Altre sono speculazioni: “Come
istituzione, la banca di Kuhn Loeb & Company di Wall Street: [e] le famiglie
Schiff, Warburg, Loeb e Kuhn, io dico le famiglie, al fine di sottolineare
diversi nomi dal momento che sono tutti collegati … attraverso matrimoni,
i Baruch, i Frankfurter, gli Altschul, i Cohen, i Benjamin, gli Strauss, i
Steinhardt, i Blom, i Rosenman, i Lippmann, i Lehman, i Dreyfus, i Lamont, i
Rothschild, i Lord, i Mandel, i Morganthau, gli Ezekiel, i Lasky.” (272)
Consentendo ai banchieri il privilegio di creare denaro, abbiamo creato un
vampiro insaziabile. Se si potesse produrre soldi, immaginate la tentazione di
possedere e controllare tutto, anche il pensiero! Questo è il senso ultimo del
comunismo. Rakovsky fa riferimento alla Grande Depressione del 1929 come ad una
“rivoluzione americana”. Essa è stata deliberatamente provocata dagli Illuminati
a scopo di lucro, per demolire lo “stereotipo americano” e conquistare il potere
politico. “L’uomo per mezzo del quale hanno fatto uso di tale potere fu Franklin
Roosevelt. Capisci? … In quell’anno, 1929, il primo anno della rivoluzione
americana, nel mese di febbraio, Trotsky lasciò la Russia, l’incidente
avvenne in ottobre… Il finanziamento ad Hitler fu concordato nel mese di luglio,
1929. Pensi che tutto questo sia una coincidenza? In questo momento si stavano
preparando per la presa del potere negli Stati Uniti e nell’Unione Sovietica: lì
tramite una rivoluzione finanziaria, e qui [in Russia] con l’aiuto della guerra
[Hitler, Seconda Guerra Mondiale] e la sconfitta che doveva seguire.” (273)
Rakovsky propose che Stalin collaborò con gli Illuminati, La prima condizione è
che si fermasse con le esecuzione dei seguaci di Trotzky. Poi saranno stabiliti
“diverse zone di influenza” dividendo “il Comunismo formale da quello reale.” Ci
saranno “concessioni reciproche di aiuto per un periodo, mentre il piano è in
corso di svolgimento … Appariranno persone influenti a tutti i livelli della
società, anche molto alti, che aiuteranno il Comunismo…” (276) Rakovsky delineò
il piano degli Illuminati di fondere il comunismo e il capitalismo. In ogni
caso, gli Illuminati controlleranno tutta la ricchezza e il potere. “A Mosca c’è
il Comunismo: A New York, il capitalismo, tesi e antitesi. Analizziamo entrambi.
A Mosca c’è un comunismo soggettivo ma [oggettivamente] un capitalismo di
Stato…a New York il capitalismo è soggettivo, ma oggettivamente si tratta di
comunismo. (276) Nel caso del comunismo, lo Stato possiede le corporazioni, i
banchieri e lo Stato. Nel caso del capitalismo, i banchieri controllano le
corporazioni, e le corporazioni controllano lo Stato. In ogni caso, in
Occidente, è necessario un capitalismo monopolistico, con crescente
controllo politico e culturale simile a quello della Russia sovietica. The Red
Symphony conferma che i nostri leader politici e culturali sono per lo più
creduloni o traditori. Il sovvertimento degli Stati Uniti fa parte di un piano
per la tirannia mondiale. Una cabala occulta di banchieri è dedita a
schiavizzare l’umanità. La maggior parte delle religioni e gruppi sono stati
sovvertiti dal piano degli Illuminati per dominare il mondo e usurpare tutta la
sua ricchezza, come indicato nei protocolli. Il denominatore comune è la
Massoneria. Una manifestazione dell’emergente tirannia luciferina Rothschild è
il design massonico del nuovo edificio della Corte Suprema israeliana, sopra. La
maggior parte dei massoni ed ebrei non sono a conoscenza di questo piano, si
sarebbero opposti, e sono essi stessi vittime. L’accusa di “antisemitismo” è
utilizzata per distrarci dal vero problema, la creazione di uno stato di polizia
globale dedicato alla proiezione della ricchezza, della perversità e della
potenza dei cabalisti in ogni sfera della vita. La “guerra al terrore” è utile
a questo controllo autoritario. Che cosa stanno progettando se l’obiettivo è uno
stato di polizia con tanto di confisca delle armi da fuoco? Un’altra Grande
Depressione? Una Guerra civile? Un gulag americano? Un attacco nucleare o
biologico “terrorista”? L’11 settembre dimostra che sono in grado di macellare
americani senza alcun rimorso. Siamo nati all’80esimo minuto di una partita di
calcio e la squadra di Dio non se la sta cavando bene. Gli Illuminati hanno
definito Dio in termini privi di senso e quindi lo hanno bandito dal nostro
universo. Dio è sinonimo di ideali spirituali. Invece di elevarci
spiritualmente, ci hanno degradato e trasformato in animali, per servire meglio
gli Illuminati.
Massoneria e Socialismo. Le radici
occulte del socialismo, scrive Jean Vandamme l'8-27
luglio 2010 su "Centro San Giorgio". Se la tesi di dottorato di Nicholas
Nicholas Goodrick-Clarke intitolata "The Occult Roots of Nazism: Secret Aryan
Cults and Their Influence on Nazi Ideology: The Ariosophists of Austria and
Germany, 1890-1935" (The Aquarian Press, Wellingborough 1985) mostra l'influenza
preponderante delle Logge nella genesi del nazionalsocialismo, lo stesso si può
dire per il comunismo, il quale è solamente una forma radicale dell'ideologia
socialista. Resta tuttavia da spiegare perché questi regimi totalitari si sono
liberati dalla tutela delle Logge per poi osteggiarle. Allo stesso modo, ci si
può legittimamente chiedere quale interesse abbia avuto la Massoneria a produrre
tali mostruosità. Questo articolo ci propone alcune risposte a partire da
citazioni estratte da testi massonici sull'argomento.
Gli iniziati dietro ogni ideologia
- Introduzione di VLR. È bene sapere che nazisti e massoni avevano qualcosa in
comune. Ecco nuova luce sulle ragioni della loro reciproca ostilità. Il fenomeno
dei rapporti delle Logge con l'estrema destra è cosa nota da molto tempo: già il
massone René Guénon (1886-1951) 2, nella sua lettera del 12 ottobre 1936 a R.
Schneider, affermò a proposito di Benito Mussolini (1883-1945): «D'altronde,
corrisponde a verità il fatto che (Mussolini) era massone, e - dettaglio
divertente - la camicia nera con cui fece il suo ingresso a Roma gli era stata
offerta dalle Logge di Bologna» 3. La questione merita di essere approfondita
ma, certamente, tutto accadde come se si fosse prodotto uno scisma all'interno
di ciò che può essere definita «la Chiesa Iniziatica»:
- da un lato, le obbedienze classiche, vicine
all'internazionalismo e all'egualitarismo;
- dall'altro, alcune Logge come la Società Thule,
l'Ordine del Nuovo Tempio, l'Ordo Templi Orientis (O.T.O.) 4, e altre
organizzazioni gnostiche, élitarie, spesso fondate su un'inasprita ideologia
razzista. L'opera di Nicholas Goodrick-Clarke ha l'immenso merito di rivelare
che dietro ai movimenti politici del XX secolo, si nascondevano spesso dei guru,
ossia degli Alti Iniziati. In definitiva, se si osservano gli avvenimenti
tenendo conto di questo fattore nascosto, ci si accorge che la Rivoluzione,
sotto le sue diverse maschere, non è nient'altro che una colossale manipolazione
dei popoli per mezzo delle ideologie. L'internazionalsocialismo è mostruoso
tanto quanto il nazionalsocialismo. Stalin (1878-1953), Mao (1893-1976) e Pol
Pot (1928-1998) non hanno nulla da invidiare ad Adolf Hitler (1889-1945). In ciò
non c'è niente di stupefacente: questi fratelli-nemici hanno le stesse origini
iniziatiche.
Le origini massoniche del socialismo.
Tutti coloro che dubitano di tale filiazione dovrebbero consultare il
Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie («Dizionario della Massoneria»), pubblicato
da Daniel Ligou (Parigi 1987). Quest'opera autorizzata è molto istruttiva. Da
essa, apprendiamo che tra i numerosi massoni, che furono gli apostoli del
socialismo, figurano:
- Il conte de Saint-Simon
(Claude-Henry di Rouvroy; 1760-1825). «Il fondatore
del sansimonismo era stato iniziato nel 1786 alla Loggia "L'Olympique de la
Parfaite estime", all'Oriente di Parigi e alla Società Olimpica» (pag. 1079);
- Pierre Leroux (1797-1871). «Filosofo,
giornalista e scrittore socialista, tipografo, membro della Costituente del 1848
poi della Legislativa. Membro della Loggia
"Les Droits de l'Homme", Oriente di Grasse» (pag. 695).
- Louis-Auguste Blanqui
(1805-1881). Secondo il Dictionnaire de la
Franc-Maçonnerie, il famoso teorico socialista fu «membro degli "Amis de la
Vérité" ("Amici della Verità") intorno al anni 1830, e del "Temple des Amis de
l’Honneur Français" ("Tempio degli Amici dell'Onore Francese") nel 1842» (pag.
141).
- Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865). Il padre del
socialismo francese, prima amico e poi avversario di Karl Marx (1818-1883),
venne iniziato «non senza avere esitato» per molto tempo «l'8 gennaio 1847, alla
Loggia di Besançon "Spucar", come riportato anche nell'opera "De la justice dans
la Révolution et dans l'Église" ("La giustizia nella Rivoluzione e nella
Chiesa"; 1858). La sua iniziazione è celebre soprattutto per il fatto che
Proudhon, alla terza domanda d'ordine, "Doveri dell'uomo verso Dio", rispose:
"La guerra"»! (pag. 967).
- Louis Blanc (1811-1882). «Militante
repubblicano, poi socialista, membro del Governo provvisorio del 1848, deputato
di Parigi nel 1871, poi senatore. Blanc venne iniziato in esilio, alla Loggia
"Les Sectateurs de Menés ("I Seguaci di Menés"), all'Oriente di Londra, prima
del 1854, data nella quale gli venne conferito il 93º Grado del Rito di Memphis
e Oratore del Supremo Consiglio di questo Grado» (pagg. 140-141).
- Mikhail Bakunin (1814-1876). «Il principe
Mikhail Bakunin, anarchico russo, nato l'8 maggio 1814 a Premoukhino (oggi
Kalinine), venne educato da un padre massone, un aristocratico liberale che
sosteneva di avere assistito alla presa della Bastiglia [...]. Divenuto massone
nel 1845 [...], Bakunin si era avvalso di questa qualità nel 1848, ma non si sa
molto sulla sua iniziazione [...]. Giunto a Parigi nel 1844, frequentò
Lamennais, George Sang, Michelet, Nicolas Herzon e il "Fratello" Louis Blanc»
(pag. 102).
- Lenin (Vladimir Ilyich Ulyanov; 1870-1924).
«Vladimir sarebbe stato iniziato alla Loggia "L'Union de Belleville",
all'Oriente di Parigi, prima della guerra del 1914. Ma essendo andati perduti
gli archivi di questa Loggia, non si possiedono tracce formali dell'appartenenza
di Lenin alla Massoneria. Tutto ciò che si sa con certezza è che Ulyanov fu
amico di "Montehus” (1872-1958), un cantante antimilitarista che, precisamente,
era membro della Loggia "L'Union de Belleville" nello stesso periodo» (pag.
693). Sapete a chi si deve L'lnternationale, questo canto rivoluzionario
diventato l'inno internazionale dei partiti socialisti e comunisti, e che fu
anche l'inno sovietico fino al 1936? Ce lo dice il Dictionnaire de la
Franc-Maçonnerie (pag. 954): ad un massone!
- Eugène Pottier (1816-1887), «anarchico francese,
nato nel 1816, partecipò alle Rivoluzioni del 1830, del 1848 e del 1871. Fu
sindaco del dipartimento dell'IIe sotto la Comune di Parigi. Condannato a morte,
si rifugiò in Belgio, in Inghilterra e in America dove venne iniziato nel 1875
alla Loggia "Les Égalitaires" ("Gli Egualitari"), fondata a New York dai
proscritti della Comune. Ritornato in Francia nel 1887, volle farsi
regolarizzare affiliandosi alla Loggia parigina "Le Libre Examen" ("Il Libero
Esame"), ma l'autore dell'Internazionale morì alcuni giorni dopo» (pag. 954). Di
fatto, è attestato storicamente che Pottier compose nel 1871 la poesia che fu
messa in musica da Pierre Degeyter (1848-1932) nel 1888 ed eseguita per la prima
volta lo stesso anno per la festa dei lavoratori di Lille.
Massoneria e comunismo.
Anche se, come abbiamo visto, non si può affermare con certezza
che Lenin fosse massone, una cosa è certa: tra la Massoneria e il socialismo
radicale - il comunismo - non c'è vera opposizione. L'incompatibilità proclamata
nel novembre 1922 al IV Congresso dell'Internazionale non deve ingannarci. In
Francia, ad esempio, numerosi fondatori del giovane Partito Comunista erano
massoni:
- Ludovic-Oscar Frossard (1889-1946), Segretario
generale del giovane Partito Comunista Francese, ma ostile alla
«bolscevizzazione» del Partito, sconfessato dall'Internazionale a causa del suo
atteggiamento al II Congresso del Partito Comunista Francese, e per il suo
rifiuto della 22ª condizione di Mosca (il Kominternl'humanité vietò
l'appartenenza alla Massoneria), si dimise il 1º gennaio 1923. Creò allora il
Partito Comunista Unitario (PCU, che nel 1924 divenne, dopo fusione con altri
gruppi dissidenti, l'Unione Socialista Comunista).
- André Morizet (1876-1942). Membro fondatore del
Partito Comunista, fu ostile alla 22ª condizione di Mosca, che vietava
l'appartenenza alla Massoneria di cui era membro (Grand'Oriente di Francia).
Escluso dal Komintern nel gennaio del 1923, con Ludovic-Oscar Frossard, per le
stesse ragioni, uscì dal Partito Comunista Francese ed entrò nell'l'Unione
Socialista Comunista rimanendovi fino al 1927.
- Antonio Coen (1885-1956). Iniziato alla Gran
Loggia, membro dell'ufficio del Partito Comunista, dal quale si staccò dopo il
IV Congresso dell'Internazionale. Alcuni anni più tardi, divenne Gran Maestro
della Gran Loggia di Francia.
- Zéphirin Camélinat (1840-1932). Tesoriere della
Section Française de l'Internationale Ouvrière («Sezione Francese
dell'Internazionale Operaia»; SFIO), si riunì ai maggioritari comunisti del
Congresso di Tours nel 1920, e favorì la nascita del comunismo in Francia. Nel
1921, egli vendette le azioni del giornale L'Humanité, (fondato da Jean Jaurès),
al Partito Comunista Francese. Nel 1924, fu candidato alle elezioni
presidenziali, ed ottenne ventun voti sull'insieme dei deputati e dei senatori.
Malgrado le condizioni di Mosca, fu la sola personalità del Partito Comunista
Francese ad essere al tempo stesso membro del Komintern e della Massoneria.
- Charles Lussy (1883-1967). Fin dalle elezioni
legislative del 1914, egli difese i colori della Section Française de
l'Internationale Ouvrière. Dopo la Grande Guerra, entrò nell'Humanité, poi seguì
la maggioranza del Partito di Jean Jaurès (1859-1914) nella sua adesione
all'Internazionale comunista. Rimase nel Partito Comunista per due anni.
All'inizio del 1923, Lussy lasciò il Partito Comunista Francese, e dopo una
breve parentesi con l'Unione Socialista Comunista, tornò al Partito Socialista.
- Marcel Cachin (1859-1958). Padre fondatore del
Partito Comunista, direttore del giornale L'Humanité, fu iniziato alla
Massoneria nella Loggia La Concorde Castillonnaise.
- Antoine Ker (1886-1923). Sostenitore della III
Internazionale, assistette, nel dicembre 1920, al Congresso di Tours e venne
eletto nel Comitato Direttivo del Partito Comunista. Collaborò all'Humanité e a
La Vie Ouvrière («La vita operaia»), e venne incaricato di curare i rapporti tra
il Partito Comunista Francese, il Partito Comunista Tedesco e l'Internazionale.
In questa cornice, andò a Mosca. Rimase in collegamento col Partito fino alla
sua morte, ma «si sarebbe dimesso» dalla Massoneria.
Ma ce ne sono tanti altri, come Ho Chi Min
(1890-1969), il liberatore-oppressore comunista del Vietnam. Nel n° 256 della
rivista L'Histoire, Jacques Dalloz - che ha dedicato un'opera a tale questione -
scrive: «Alcuni vietnamiti venuti in Francia, soprattutto per studiare, si
fecero iniziare a Parigi o nelle città universitarie del Sud. Tra essi, il
futuro Ho Chi Min. All'inizio dell'anno 1922, il giovane comunista si presentò
per l'iniziazione alla Loggia della capitale "La Fédération Universelle" ("La
Federazione Universale"), raccomandato dall'incisore Roger Boulanger […]. Nel
dicembre dello stesso anno, la IV Internationale condannò la Massoneria,
"un'istituzione segreta della borghesia radicale": un paradosso che non sembrò
disturbare affatto il futuro dirigente vietnamita […]. Nell'agosto 1945 […],
altri massoni andarono al potere, come Hoang Minh Giam, che i responsabili
francesi consideravano a quel tempo l'eminenza grigia di Ho Chi Min, e che
partecipò ai suoi governi per molti anni […]. La fine della guerra in Indocina
portò un nuovo colpo alla Massoneria locale. Già moribonda, la Fratellanza
tonchinese si spense col passaggio al comunismo del Nord Vietnam.
L'installazione del nuovo regime portò - come negli altri Paesi comunisti - alla
scomparsa della Massoneria. In questo caso, l'iniziazione di Ho Chi Min non fece
alcuna differenza» 5. Tutto porta dunque a pensare che tra comunismo e
Massoneria si è prodotto un movimento simile a quello che Goodrick-Clarke
constata tra il nazismo e le Logge: sia un affrancamento progressivo dalla loro
tutela, e in seguito un'ostilità, o addirittura una persecuzione di queste
società di pensiero, considerate - a buon diritto - come il fermento di altre
ideologie concorrenti. Ci si può chiedere, dunque, per quale motivo le Logge
abbiano suscitato ideologie contrapposte, col rischio, nelle loro forme
radicali, di una persecuzione degli stessi massoni. Tenteremo di dare una
spiegazione a questo dilemma alla luce di testi massonici sull'argomento.
L'unità fondamentale di tutti i
«Fratelli». Ma - diranno gli scettici - come spiegare
l'esistenza di certe obbedienze massoniche nei Paesi capitalisti che si sono
dichiarate più volte ostili al comunismo? Ciò dimostrerebbe che i massoni non
hanno una visione globale dell'avvenire dell'umanità. Ogni obbedienza
lavorerebbe unicamente per conseguire gli scopi della nazione alla quale
appartiene. Errore! Un testo fondante come le Costituzioni di Anderson (1723)
proclama che riunendo gli uomini di tutti gli orizzonti la Massoneria persegue
lo scopo di diventare «il centro d'unione e lo strumento per stringere
un'amicizia sincera tra gli uomini che altrimenti sarebbero rimasti
continuamente estranei». L'obiettivo è noto: l'instaurazione di un Governo
Mondiale. Ciò è rivelato da quell'altro testo fondamentale che è il Discorso di
Ramsay (1737): «I nostri antenati, i crociati (i Templari; N.d.R.), vollero
riunire in una sola fratellanza gli individui di tutte le Nazioni. Quale obbligo
abbiamo verso questi uomini superiori che hanno immaginato un'istituzione il cui
unico scopo è la riunione degli spiriti e dei cuori per renderli migliori e per
formare col passare del tempo una Nazione Spirituale in cui, senza derogare ai
diversi doveri che esige la diversità degli Stati, si creerà un Popolo nuovo
che, riunendo numerose nazioni, li cementerà attraverso i legami della virtù e
della scienza».
Ideologie «opposte» come strumenti di
«progresso». Importa poco se questi uomini, una volta
usciti dalle Logge, siano appartenuti a partiti politici o persino a Paesi
antagonisti. Una volta reclutati, avranno avuto in comune certi principî che
hanno fatto sì che, pur combattendosi tra loro, hanno collaborato alla Grande
Opera, vale a dire all'edificazione della civiltà massonica mondiale. Un simile
modo di procedere è efficace: si chiama dialettica. Non sono io a dirlo, ma
Oswald Wirth (1860-1943), uno dei teorici ufficiali della Massoneria: «Il due è
il numero del discernimento, che procede per analisi, stabilendo incessanti
distinzioni sulle quali nessuno potrebbe basarsi. Lo spirito che nega di
fermarsi in questa via si condanna alla sterilità del dubbio sistematico,
all'opposizione impotente, alla contestazione continua [...]. Il due rivela il
tre, e il Ternario non è che un aspetto più intelligibile dell'unità. La
Tri-unità di ogni cosa è il mistero fondamentale dell'iniziazione intellettuale.
Il massone, che orna la sua firma con tre punti in forma di Triangolo, lascia
intendere che sa riportare, attraverso il Ternario, il Binario all'unità. Si si
è realmente elevato all'altezza del punto che domina gli due altri, non si
perderà mai nelle vane discussioni, perché percepirà senza difficoltà la
soluzione che si sprigiona da un dibattito contraddittorio. Giudicando dall'alto
senza il minimo pregiudizio e in tutta libertà di spirito, otterrà la luce dallo
scontro dell'affermazione e della negazione». Ecco dunque chiarita la filosofia
massonica: di due tesi (o di due forze) opposte, si utilizza la risultante che
farà avanzare la causa. Avrete notato, en passant, l'analogia profonda con
l'ideologia marxista. Nel libro Idéalisme et matérialisme dans la conception de
l’Histoire («Idealismo e materialismo nella concezione della Storia»), il
socialista Jean Jaurès rivendica la filiazione del socialismo dai sistemi
filosofici massonici di Immanuel Kant (1724-1804) e di Georg Wilhelm Friedrich
Hegel (1770-1831), considerati come tali dai massoni:
- Per Kant, lo sapete tutti, il problema
filosofico consiste espressamente nel trovare la sintesi delle affermazioni
contraddittorie che si presentano allo spirito dell'uomo: l'Universo è limitato
o infinito? il tempo è limitato o infinito? La serie delle cause è limitata o
infinita? Tutto è sottomesso all'universale e inflessibile necessità, o c'è
spazio anche per la libertà delle azioni umane? Tante tesi e antitesi, negazioni
e affermazioni, tra i quali lo spirito esita. Lo sforzo del filosofia kantiana è
tutto nella soluzione di queste contraddizioni, di queste antinomie
fondamentali.
- Infine è Hegel ad enunciare la formula di questo
lungo lavoro, dicendo che la verità è nella contraddizione: coloro che affermano
una tesi senza opporgli una tesi opposta errano e sono schiavi di una logica
ristretta e illusoria.
Credo sia inutile ricordare agli adepti la
dottrina di Marx, il quale è stato un discepolo intellettuale di Hegel: lo
dichiara lui stesso, lo proclama nella sua introduzione al Capitale; sembra che
anche Friedrich Engels (1820-1895), per alcuni anni, a causa di quella tendenza
che porta l'uomo il capitale - das kapital che ha vissuto per molto tempo in un
luogo a ritornare verso le sue origini, si sia applicato nello studio
approfondito di Hegel. Una sorprendente applicazione di questa formula dei
contrari la si trova in Marx il quale constata «l'antagonismo delle classi, lo
stato di guerra economica, che oppone la classe capitalista alla classe
proletaria […]. Secondo la vecchia formula di Eraclito che Marx ama citare ("La
pace è solamente una forma, un aspetto della guerra; la guerra è solamente una
forma, un aspetto della pace"). Non bisogna opporre l'uno all'altro: ciò che
oggi è lotta, domani sarà l'inizio della riconciliazione. Il pensiero moderno
dell'identità dei contrari (che i massoni definiscono "coincidentia
oppositorum"; N.d.T.) si ritrova ancora in quest'altra concezione ammirevole del
marxismo: "L'umanità è stata condotta fin qui, per così dire, dalla forza
inconscia della Storia […]. Ebbene, quando sarà realizzata la rivoluzione
socialista, quando l'antagonismo delle classi sarà cessato, quando la comunità
umana sarà in possesso dei grande mezzi di produzione secondo i bisogni
conosciuti e constatati dagli uomini, allora l'umanità verrà stata strappata al
lungo periodo d'incoscienza in cui cammina dai secoli, spinta dalla forza cieca
degli avvenimenti, ed entrerà nella nuova era in cui l'uomo anziché essere
sottomesso alle cose regolerà l'andamento cose […]. Per Marx, questa vita
incosciente è la condizione stessa e la preparazione della vita cosciente di
domani, e così è ancora la Storia si incarica di risolvere una contraddizione
essenziale. Ebbene, mi chiedo se non si può, se non si deve, senza mancare allo
spirito stesso del marxismo, spingere oltre questo metodo di conciliazione dei
contrari, di sintesi dei contraddittori, e cercare la conciliazione fondamentale
del materialismo economico e dell'idealismo applicato allo sviluppo della
Storia». Dopo questa lettura, non ci si può trattenere dal pensare che il
socialismo si è adeguato alla dialettica massonica e l'ha sistematizzata ed
interpretata in modo particolare ed esclusivo. Notiamo, en passant, l'analogia
profonda del pensiero massonico e di quello socialista per via del loro
carattere messianico, prometeico e olista. Sottolineiamo anche il loro obiettivo
comune: l'unità e l'autonomia dell'umanità. Tuttavia, se, nelle righe
precedenti, Jaurès illustra il concetto di dialettica marxista, ignoriamo ancora
quello della dialettica massonica.
Ordo ab chao, o la finalità dello Stato
totalitario. Ed ecco un primo chiarimento. Commentando
il motto massonico Ordo ab Chao («L'ordine a partire dal caos»), l'illustre
massone René Guénon, rivela che, in realtà, le organizzazioni opposte vengono
utilizzate come la «materia» dagli «Alti Iniziati» per farle concorrere alla
Grande Opera: «Menzioneremo ancora, senza insistere oltremodo, un altro
significato di un carattere più particolare che del resto è legato abbastanza
direttamente a quello che abbiamo appena indicato, perché si riferisce tutto
sommato allo stesso campo: questo significato si rifà all'uso, per farli
concorrere alla realizzazione dello stesso piano d'insieme, di organizzazioni
esterne incoscienti di questo piano, e apparentemente contrapposte le une alle
altre, sotto un'unica direzione "invisibile" che è essa stessa al di là di tutte
le opposizioni. In sé stesse, le opposizioni, grazie all'azione disordinata che
producono, costituiscono certamente un tipo di "caos" meno apparente; ma si
tratta precisamente di usare questo stesso "caos" prendendolo in qualche modo
come la "materia" sulla quale si esercita l'azione dell0 "spirito" rappresentato
dalle organizzazioni iniziatiche di ordine l'elevato e più "interiore" alla
realizzazione dell'"ordine" generale, come, nell'insieme del "cosmo", tutte le
cose che sembrano opposte tra loro non sono realmente, in definitiva, che
elementi dell'ordine totale». Se le parole hanno un senso, questa si chiama
manipolazione su scala continentale. Il risultato di queste manovre,
accuratamente nascoste al profano, sarà, come si è visto, la creazione di un
Governo Mondiale. E questo Superstato sarà totalitario. Il motto Ordo ab Chao
non lascia su questo punto alcun dubbio: dopo il disordine (solve),
sapientemente provocato sul piano nazionale e internazionale - disordine
ottenuto adulando le passioni degli uomini e sviluppando ideologie contrapposte
- verrà l'«ordine» massonico (coagula) che sarà brutale. A quelli che vorrebbero
sapere ciò che gli Alti Iniziati pensano della Democrazia, consiglio la lettura
dell'opera del massone René Guénon più esplicita su questo argomento, vale a
dire La Crise du Monde Moderne («La Crisi del Mondo Moderno»), un libro
fondamentale presso gli iniziati di estrema destra.
Conclusione.
Forse qualcuno mi rimprovererà di aver fatto troppe citazioni. La natura stessa
del mio scritto mi ha obbligato a farlo. Per essere creduti, bisogna portare
delle prove, soprattutto in questo caso in cui la realtà sembra superare la
fantasia. Ancora una volta ci viene presentata questa verità, ossia che tutte le
ideologie sono figlie della Rivoluzione, e che tra esse e il cattolicesimo
l'incompatibilità è totale. Terminerò con una citazione presa dalla Bolla In
Eminenti, nella quale Papa Clemente XII (1652-1740) condannò, con estrema
chiaroveggenza, fin dal 1738, la Massoneria: «Già per la stessa pubblica fama Ci
è noto che si estendono in ogni direzione, e di giorno in giorno si avvalorano,
alcune società, unioni, riunioni, adunanze, conventicole o aggregazioni
comunemente chiamate dei "Liberi Muratori" o "des Francs Maçons", o con altre
denominazioni chiamate a seconda della varietà delle lingue, nelle quali con
stretta e segreta alleanza, secondo loro Leggi e Statuti, si uniscono tra di
loro uomini di qualunque religione e sètta, contenti di una certa affettata
apparenza di naturale onestà. Tali società, con stretto giuramento preso sulle
Sacre Scritture, e con esagerazione di gravi pene, sono obbligate a mantenere un
inviolabile silenzio intorno alle cose che esse compiono segretamente. Ma
essendo natura del delitto il manifestarsi da sé stesso e generare il rumore che
lo denuncia, ne deriva che le predette società o conventicole hanno prodotto
tale sospetto nelle menti dei fedeli, secondo il quale per gli uomini onesti e
prudenti l'iscriversi a quelle aggregazioni è lo stesso che macchiarsi
dell'infamia di malvagità e di perversione: se non operassero iniquamente, non
odierebbero tanto decisamente la luce».
Massoneria e Comunismo.
Il socialista Mussolini come vedeva nel 1919 il socialismo-comunismo: «Sulla
Rivoluzione russa mi domando se non è stata la vendetta dell'ebraismo contro
il Cristianesimo, visto che l'ottanta per cento dei dirigenti dei Soviet sono
ebrei... La finanza dei popoli è in mano agli ebrei, e chi possiede le
casseforti dei popoli dirige la loro politica.»
Il giornalista Mussolini e la finanza
internazionale. Articolo pubblicato su "Il Popolo d'Italia" del 4 giugno 1919.
"I COMPLICI. I proletari evoluti e coscienti che
gridano “Viva Lenin!” credendo di gridare “Viva il socialismo “, non sanno
certamente ch'essi gridano “Abbasso il socialismo! “I falsi pastori che
“mangiano e bevono” alle spalle delle masse sempre pronte a giurare, se non a
morire, per gli ideali nuovi e lontani, danno ad intendere che quel che si è
instaurato in Russia è socialismo. Colossale menzogna! In Russia si è stabilito
il governo di una frazione del Partito socialista. In Russia i proletari
lavorano come prima; sono sfruttati come prima perché devono mantenere una
burocrazia innumerevole e succhiona, secondo la testimonianza non sospetta del
capitano Sadoul; sono mitragliati come prima non appena osino insorgere contro
il regime che li condanna alla schiavitù e alla fame; invece di uno czar ce ne
sono, oggi, due, ma le forme e i metodi dell'autocrazia non sono affatto
cambiati. Si capisce perfettamente che alcuni scrittori venuti dagli ambienti
borghesi, abbiano delle simpatie per il bolscevismo. C'è in Russia uno Stato, un
Governo, un ordine, una burocrazia, una polizia, un militarismo, delle
gerarchie. Ma il socialismo non c'è. Non c'è nemmeno il cominciamento del
socialismo, non c'è niente che somigli ad un regime socialista. Il leninismo è
la negazione perfetta del socialismo. E' il governo di una nuova casta di
politicanti. Gli è per questo che è assai difficile trovare degli apologisti del
leninismo fra le teste pensanti del socialismo russo e del socialismo
occidentale. Le più stroncanti requisitorie contro il leninismo non sono venute
dai borghesi, ma da uomini che avevano lottato e sofferto per la redenzione
della massa operaia. Questi uomini si chiamano Piekanoff, il maestro dei
marxisti russi; si chiamano Kropotkin, l'apostolo dell'anarchia. La demolizione
dei metodi di governo leninista non è opera del "Times", ma di un Axelrod,
chiamato il decano dei socialisti russi; di un Souckhomline, collaboratore per
lungo tempo dell' "Avanti". Il manifesto del Partito operaio russo e dei
socialisti menscevichi, non sono stati stampati dal "Corriere della Sera", ma da
"Critica Sociale". Non sono state inventate da noi "rinnegati" - che in questo
caso (è strano ma vero!) difendiamo il socialismo!.- le pagine di Bernstein, di
Kautsky, di Eisner, di Troelstra, di Branting e di infiniti altri socialisti,
che si sono schierati contro la “caricatura del socialismo realizzatasi tra
Pietrogrado e Mosca”. Non siamo noi, ma un dott. Totomianz, veterano della
cooperazione russa che nell'ultimo numero della “Critica Sociale” di
FilippoTurati, stampa queste parole eloquentissime: "I bolscevichi hanno creato,
in fin dei conti, non già una vera democrazia bensì la denominazione della
plebaglia, una oclocrazia che non si arresta davanti a nessun mezzo terroristico
in una guerra di sterminio contro la borghesia e gli intellettuali." Infinite
volte, e specialmente dopo il congresso di Berna, noi abbiamo prodotto documenti
inconfutabili della vera natura del regime russo. Chi non ricorda la lettera di
Alexeyev e quella della vedova di Plekanoff ? Noi riaffermiamo che il leninismo
non ha niente di comune col socialismo, eppure i socialisti ufficiali italiani,
con clamori minacciosi, chiamano al soccorso per salvare la Russia. Ma la Russia
non ha bisogno di essere salvata, perché non corre pericolo alcuno. Chi sostiene
il bolscevismo - ficcatevelo bene in testa, miei cari proletari! - non è la
forza del popolo russo che subisce, dopo aver cercato di spezzarlo, quel regime
di barbarie contro il quale sono più volte insorti e anarchici e socialisti
rivoluzionari, con tentativi soffocati spietatamente nel sangue; chi sostiene il
bolscevismo non è il famoso esercito rosso che esiste nelle carte di Trotzky,
non nella realtà. Il giornale 'Humanité' del 30 maggio, reca la testimonianza
imparziale del signor Paolo Birukoff, il quale, a proposito dell'esercito rosso,
in cotal nonché significativa guisa si esprime: "Il popolo russo, così pacifico,
detesta la guerra oggi, come ieri, come sempre. Oppone una resistenza accanita
al reclutamento." Altro che entusiastica risposta agli ordini di mobilitazione,
secondo ci narravano gli imbonitori dei crani proletari d'Italia. Il signor
Birukoff dice qualche cosa di ancora più interessante: "Ci sono tanti disertori
nell'armata rossa, quanti ce ne erano nell'esercito dello zar. Accade che un
reggimento non arriva alla tappa designata perché tutti gli uomini si sono
sbandati strada facendo..." Ed è questo esercito di sbandati che ferma
Mannerheim e Kolcak? Mai più. Se Pietrogrado non cade, se Denikin segna il
passo, gli che è così vogliono i grandi banchieri ebraici di Londra e di New
York, legati da vincoli di razza cogli ebrei che a Mosca come a Budapest, si
prendono una rivincita contro la razza ariana che li ha condannati alla
dispersione per tanti secoli, In Russia l'80 per cento dei dirigenti dei
"Soviets" sono ebrei, a Budapest su 22 commissari del popolo ben 17 sono ebrei.
Il bolscevismo non sarebbe, per avventura, la vendetta dell'ebraismo contro il
cristianesimo? L'argomento si presta alla meditazione. E' possibile che il
bolscevismo affoghi nel sangue di un "progrom" di proporzioni catastrofiche. La
finanza mondiale è in mano degli ebrei. Chi possiede le casseforti dei popoli,
dirige la loro politica. Dietro ai fantocci di Parigi, sono i Rotschild, i
Warnberg, gli Schyff, i Guggheim, i quali hanno lo stesso sangue dei dominatori
di Pietrogrado e di Budapest. La razza non tradisce la razza. Cristo ha tradito
l'ebraismo, ma, opinava Nietzsche in una pagina meravigliosa di previsioni, per
meglio servire l'ebraismo rovesciando la tavole dei valori tradizionali della
civiltà elleno-latina. Il bolscevismo é difeso dalla plutocrazia internazionale.
Questa é la verità sostanziale. La plutocrazia internazionale dominata e
controllata dagli ebrei, ha un interesse supremo a che tutta la vita russa
acceleri sino al parossismo il suo processo di disintegrazione molecolare. Una
Russia paralizzata, disorganizzata, affamata, sarà domani il campo dove la
borghesia, si, la borghesia o signori proletari, celebrerà la sua spettacolosa
cuccagna. I re dell'oro pensano che il bolscevismo deve vivere ancora, per
meglio preparare il terreno alla nuova attività del capitalismo. Il capitalismo
americano ha già ottenuto in Russia una concessione grandiosa. Ma ci sono ancora
miniere, sorgenti, terre, officine che attendono di essere sfruttate dal
capitalismo internazionale. Non si salta, specialmente in Russia, questa tappa
fatale nella storia umana. E' inutile, assolutamente inutile, che i proletari
evoluti ed anche coscienti, si scaldino la testa per difendere la Russia dei
Soviets. Il destino del leninismo non dipende dai proletari di Russia o di
Francia e meno ancora da quelli d'Italia. Il leninismo vivrà finché lo vorranno
i re della finanza; morirà quando decideranno di farlo morire i medesimi re
della finanza. Gli eserciti antibolscevichi che di quando in quando sono colpiti
da misteriose paralisi, saranno semplicemente travolgenti ad un momento dato che
sarà scelto dai re della finanza. Gli ebrei dei Soviets precedono gli ebrei
delle banche. La sorte di Pietrogrado non si gioca nelle steppe gelide della
Finlandia; ma nelle banche di Londra, di New York e di Tokio. Dire che la
borghesia internazionale vuole oggi assassinare il regime dei Soviets è dire una
grossa menzogna. Se, domani, la borghesia plutocratica si decidesse a questo
assassinio, non incontrerebbe difficoltà di sorta poiché i suoi “complici”, i
leninisti, siedono già e lavorano per lei al Kremlino. MUSSOLINI".
Cospirazione ebrea in Russia.
Si legge su "Avventismo Profetico" «La realtà del bolscevismo stesso, il fatto
che tanti ebrei sono bolscevichi e che l'ideale del bolscevismo concorda su
molti punti con il più sublime ideale del giudaismo — di cui una parte almeno
forma la base dei migliori insegnamenti del fondatore del Cristianesimo — ha un
grande significato. Ogni ebreo cosciente e riflessivo dovrà esaminarlo con molta
attenzione». Il mondo ebreo, gennaio 1929
- La Massoneria è un’organizzazione capitalistica
o comunistica? Questi due termini per gli agenti del potere occulto non esistono
praticamente…Ebrei e massoni formano un tessuto compatto e potente: quindi per i
Massoni come per gli Ebrei, capitalismo e comunismo sono mezzi per il potere
pag. 153
- Massoneria e Comunismo: due aspetti della
stessa medaglia, cioè l’alto ebraismo occulto, 204
- Raggiungere un governo mondiale sotto la
maschera del socialismo, 16
- 1848: gli ebrei entrarono nell’ arena politica
direttamente ed assunsero un ruolo dominante… nei movimenti liberali. La
rivoluzione del 1848 finì per identificarsi con l’emancipazione ebraica, 25
- Con l’Internazionale e la Comune l’ebraismo uscì
allo scoperto: gli ebrei … parteciparono potentemente all’ organizzazione del
partito socialista, 26
- La rivoluzione proletaria comunarda risparmiò
scrupolosamente le proprietà degli ebrei, 26
- The American Hebrew, 10/09/1920: “la rivoluzione
bolscevica fu… opera del pensiero ebreo, del malcontento ebreo, dei piani ebrei,
lo scopo dei quali era di creare un nuovo ordine nel mondo”, 27
- “Non vi era una sola organizzazione politica
(rivoluzionaria) in questo vasto impero che non fosse influenzata da ebrei o
diretta da essi…Gli ebrei sono stati gli artefici della rivoluzione del 1917”,
29
- B.Lazare (ebreo, 1934): “L’ ebreo Karl Marx,
discendente da una serie di rabbini e di dottori, fu un talmudista lucido e
chiaro … fu un logico, un ribelle, un agitatore, un aspro polemista, che prese
il dono del sarcasmo e dell’invettiva dalle sorgenti ebraiche”, 27
- 1919: notizie di un’organizzazione segreta
ebraico-massonico, la Lega dei Fratelli Internazionali, fondata dall’ ebreo
tedesco Mordechai, cioè Karl Marx, 150
- L’ oro ebreo americano forgiò il bolscevismo e
consacrò la rivoluzione d’ ottobre alla causa egemonica d’ Israele, 36
- Chicago Tribune del 19/06/1920: “Trotzkij
(ebreo) conduce i rivoluzionari ebrei al potere mondiale – il bolscevismo non è
che un mezzo per i suoi fini”, 36
- (Oggi) il compito del comunismo è terminato
(caduto il 1989): lo scopo era quello di preparare la strada ad una
socialdemocrazia universale, 37
- La forza mondialista ebrea si manifesta nella
rivoluzione russa: Lenin (sposato ad un’ebrea) e Kerenskj (34), Stalin, Kaganov,
Beria, etc (segue lunghissima lista), 145
- Cronaca di Londra 1919: “moltissimi ebrei sono
bolscevichi e gli ideali del bolscevismo coincidono … con gli alti ideali del
giudaismo”, 38
- Il Comunista (aprile 1919): “la rivoluzione
russa è stata firmata soltanto da mani ebree”, 38
- Finanziamenti massonico-giudaici alla
rivoluzione d’ ottobre, 33
- Jakob Schiff, banchiere ebreo-americano, nell’
aprile 1918 ebbe a dichiarare pubblicamente che grazie al suo appoggio
finanziario la rivoluzione russa era riuscita. Tratto dal libro di Meurin "LA
SINAGOGA DI SATANA"
Il comunismo mascherato dall'assenza di classi
sociali è un piano per schiavizzare le masse sotto il pugno di ferro degli
elitari. La sua origine proviene dal Talmud ebraico. Gli obiettivi comunista
diretti dalla volontà dell'élite, è eliminare la classe media per mezzo di
assassini (guerre, fame ecc.) la confisca di tutti i loro beni e possedimenti,
permettendo così di restare solo due classi - l'élite e gli schiavi! Il
comunismo è la falsificazione finale di "umanità". E' il piano della salvezza -
- - ma SENZA Dio. Dio ha promesso nella Sua Parola che alla fine regnerà la
giustizia, che ci sarà pace nel Suo regno, e che tutte le persone sono uguali. I
comunisti, un gruppo dominato dagli ebrei sionisti, affermano che porteranno la
pace nel mondo. Ma la loro definizione di "pace" è l'eliminazione di ogni
resistenza alle loro politiche, con qualsiasi mezzo necessario. Quando i
comunisti si impadronirono del potere in Russia, dopo la sanguinosa guerra
civile che durò dal 1917 fino al 1922, crearono immediatamente un'organizzazione
Terroristica che utilizzarono contro il popolo della Russia. Primo si chiamò
"CHEKA" (1917-1922), sigle in russo che significano Commissione Straordinaria
Russa per combattere la Contro Rivoluzione e il Sabotaggio. Di seguito, il nome
si cambiò in "GPU", sigla in russo per Amministrazione Politica di Stato. Dal
1922 al 1934 si trasformò in "OGPU", sigla dell'Amministrazione Politica dello
Stato Unificata; posteriormente questi si sostituirono dal "lNKVD" -
Commissariato del Popolo per Temi Interni - fino al 1960. In quell'anno tornò a
cambiare nome, il quale si ricorda bene: "KGB", sigla di Comitato di Sicurezza
per lo Stato. Dalla caduta della Germania nazista nel 1945, si è indottrinata la
gente in tutto il mondo mediante libri, film e l'insegnamento nelle scuole,
sulle orribili condizioni esistenti in Germania durante il regime di Hitler; e
della maniera in cui le persone furono brutalmente arrestate, alcuni dopo essere
stati torturati, uccisi e altri inviati in campi di lavoro forzato e in quelli
di sterminio. Non metto in dubbio che successero cose orribili a molte persone,
tra cui la popolazione civile tedesca, il quale soffrì sotto l'oppressione della
Germania nazista. Tuttavia, quello che gli "educatori" in Occidente hanno omesso
di menzionare in maniera adeguata, sono le atrocità commesse dai governanti
comunisti nell'Unione Sovietica; che furono, nella maggioranza dei casi, molto
peggiore. Se i Nazisti versarono fiumi di sangue, i macellai comunisti sparsero
oceani di sangue. Perché ogni cristiano che vive in Occidente possa comprendere
la brutalità della CECA, lasci che la illustri di seguito: Immaginate qualsiasi
città degli Stati Uniti (o altrove), circondato da forze armate e tutte le
strade completamente disabilitati. Queste forze entrarono nella città,
catturando tutti quelli che lavorano per agenzie locali o federali. Senza alcuna
prova, condotti nei principali centri commerciali, dove furono uccisi davanti a
un pubblico inorridito. Tra queste persone ci sarebbero tutti i funzionari
responsabili dell'applicazione della legge, i lavoratori delle poste, gli
operatori di servizi sociali, ecc. Dopo l'obiettivo della CECA fu la scuola
pubblica. Lì si catturano tutti i migliori insegnanti e studenti, che furono
anche tutti fucilati. Poi fu il turno delle chiese, i pastori, diaconi,
insegnanti della scuola di Domenica, individuati tutti i responsabili, furono
uccisi senza processo. Dopo, tutti i professionisti, come medici, infermieri,
ingegneri, direttori di giornali e altri scrittori, uomini d'affari furono
catturati e fucilati nei parchi pubblici. Pertanto, tutte le persone considerate
di ceto superiore o della classe media (borghesia), furono catturati e fucilati.
La città non ebbe più alcun autorità e la Ceca mantenne lì una guarnigione, la
quale svuotò le carceri e i prigioni, collocando i detenuti in posti direzionali
per assicurarsi che il resto della popolazione avrebbe obbedito ai suoi nuovi
dirigenti. Immaginate che questo succeda in tutte le città del paese dove
vivete, senza che rimanga salva nemmeno la più piccola città o comunità. La
nazione sarebbe come una persona decapitata, giacendo solo il cadavere. Questo è
quello che l'Internazionale Comunista fece in Russia. Fu uno dei peggiori
genocidi nella storia dell'umanità. Il paese russo, e quello Ucraino, fu violato
e assassinato; e quelli che sopravvissero, lo fecero sotto le peggiori
condizioni di schiavismo che l'uomo abbia mai visto. Non appena si creò la
Ceca nel dicembre del 1917, la leadership comunista pubblicò una lista dei suoi
nemici, i quali dovevano essere eliminati, cioè, assassinati. In alto alla lista
c’erano i membri della nobiltà russa (anche donne e bambini), uomini d'affari,
tutti gli insegnanti, funzionari di polizia, tutte le persone appartenenti al
vecchio sistema giudiziario, tutti i membri delle organizzazioni della società
civile, funzionari delle Forze armate precedenti, tutti i chierici, includendo
sacerdoti ortodossi e pastori e dirigenti cristiani (battisti e pentecostali). I
maestri della Scuola di Domenica hanno considerato i comunisti come una minaccia
terribile. Furono obiettivi di sterminio anche gli studenti più in primo piano
nelle scuole che - secondo loro - sarebbero diventati potenziali leader di una
possibile insurrezione anticomunista. Quando l'inferno arrivò e le bande della
Ceca irruppero nelle città e villaggi, sequestrarono i bambini e li condussero
alla periferia delle città; lì furono brutalmente assassinati e sepolti nella
fossa comune - molti erano ancora in vita mentre furono seppelliti. Le Unità
della Ceca erano conformate da dirigenti comunisti ed ex detenuti delle prigioni
russe, i quali eseguirono i massacri. Man mano che i bolscevichi continuavano a
guadagnare più territorio, tutte le prigioni si andavano vuotando. La brutalità
del genocidio dei più illuminati del popolo russo, sarà presentato nel giorno
del Grande Giudizio, quando si mostrerà tutta la verità e sarà ristabilita la
giustizia da parte del RE dei re, Gesù Cristo (Apocalisse 20:10-15). Sono sicuro
che la maggioranza di quelli che stanno leggendo questi fatti le sarà difficile
comprendere questa brutalità, perché non ha una "mente criminale". Gli spietati
dirigenti comunisti avevano però l'obiettivo di schiacciare il popolo russo per
sempre e distruggere qualunque tipo di possibile opposizione contro gli invasori
comunisti. Quello che non vi hanno insegnato nella scuola, è che la rivoluzione
comunista fu un'invasione straniera da parte di una maggioranza
di EBREI RUSSI che furono allenati e formati in Germania, Svizzera, Inghilterra
e negli Stati Uniti. In questi momenti alcuni tra i lettori possono diventare
nervosi e pensare che quello che scriva è antisemita. Quella che racconto loro è
la verità, che è stata rimossa da oltre cento anni, nascosta sotto il coperchio
della "PAURA". Se si sforzano di comprovare i fatti storici reali, scopriranno
che quella che dichiaro è verità. Ora, lasciatemi citare una fonte che non può
essere smentita: il pastore rumeno Richard Wurmbrand, che ha sofferto molto per
la sua fede sotto il regime comunista in Romania (Wurmbrand è nato ebreo, ma è
diventato un cristiano - vedi Giovanni tre). Citerò i seguenti estratti da un
suo piccolo libro, dal titolo "Chi era KARL MARX?", pagine 51 e 52: "Per
completare il quadro, qualche parola in più su Moisés Hess, l'uomo che convertì
Marx ed Engels all'idea socialista. C'è una lapide in Israele iscritta con le
parole: "Moisés Hess, fondatore del Partito Tedesco Social-democratico". Nel
Catechismo Rosso per il Popolo Tedesco, Hess espone le sue credenze. "Chi è
nero"? Nero è il Clero... questi teologi sono i peggiori aristocratici... il
chierico insegna i principi per opprimere il popolo nel nome di Dio. In secondo
luogo, insegna al popolo a lasciarsi opprimere e sfruttare, nel nome di Dio. In
terzo luogo, il più importante, (il clero) provvede per se stesso, con l'aiuto
di Dio, una vita meravigliosa sulla terra, mentre consiglia al popolo di
aspettare il cielo... "La bandiera rossa simboleggia la rivoluzione permanente
fino alla vittoria completa delle classi lavoratrici in tutti i paesi
civilizzati: La Repubblica Rossa... la rivoluzione socialista è la mia
religione... gli operai, quando abbiano conquistato un paese, devono aiutare i
suoi fratelli nel resto del mondo."
Questa era la religione di Hess (Ebreo) quando
fece la prima stampa del Catechismo. Nella sua seconda edizione, aggiunse alcuni
capitoli. Questa volta la stessa religione, ossia, la rivoluzione socialista,
usa un linguaggio cristiano per accreditare se stessa tra i credenti
cristiani. Insieme con la propaganda della rivoluzione, si alternano alcune
parole circa il cristianesimo come religione di amore e di umanesimo. Il suo
messaggio, però, deve essere chiarito: l'inferno non può essere sulla terra e
nel cielo, nella vita ultraterrena. La società socialista è la realizzazione
vera del cristianesimo. Così, Satana si maschera da angelo di luce. Dopo che
Hess, ebbe convinto Marx ed Engels all'idea socialista, affermando anzitutto che
il suo scopo avrebbe "dato il calcio definitivo alla religione medievale" (il
suo amico Georg Jung disse più chiaramente: "Sicuramente Marx disperderà Dio dal
suo cielo "), un interessante sviluppo ebbe luogo nella vita di Hess, che aveva
fondato il socialismo moderno, creò anche un movimento completamente diverso,
una specifica forma di sionismo. Hess, il fondatore del socialismo moderno, il
cui obiettivo è cacciare Dio dal "cielo", fu anche il fondatore di un tipo
diabolico di Sionismo, quello che supponeva andava a distruggere il Sionismo
corretto, il Sionismo di amore, di comprensione e di pace. Egli, che insegnerà a
Marx l'importanza della lotta di classe, scrisse nel 1862 le sorprendenti
parole: "La lotta per la razza è primaria, lo scontro di classe è
secondario". Aveva infiammato l'animo della guerra di classe, fuoco mai estinto,
invece di insegnare alle genti a cooperare per il bene comune. Questo stesso
Hess, dunque, generò un Sionismo distorto, un Sionismo di lotta di razza, un
Sionismo imposto per forza contro gli uomini che non siano della razza ebrea.
Così come respingiamo il marxismo satanico, ogni ebreo o cristiano responsabile
deve respingere questa diabolica perversione del Sionismo. Hess reclama
Gerusalemme per gli ebrei, ma senza Gesù il Re degli Ebrei. Che necessità aveva
Hess di Gesù? Scrive: "Ogni ebreo può trasformarsi in un Messia, ogni donna
ebrea in una Madre Dolorosa". Allora, perché non fece dell'ebreo Marx un Messia,
un Unto di Dio, invece di un uomo pieno di odio, tentando di cacciare a Dio dal
cielo? Per Hess, Gesù è "un ebreo che i pagani divinizzarono come suo
Salvatore". "Né Hess né gli ebrei sembrano avere bisogno di Lui". Pag. 56:
Potrebbe aggiungersi che Hess non fu solamente la fonte originale del marxismo,
e l'uomo che cercò di creare un Sionismo anti-Dio (Anticristo), ma anche il
predecessore dell'attuale teologia del rivoluzionario Concilio Mondiale di
Chiese e delle nuove tendenze nel cattolicesimo che parlano di salvazione. "Uno
stesso uomo, quasi sconosciuto, è stato il portavoce di tre movimenti satanici:
il comunismo, il Sionismo razzista e pieno di odio, e la teologia della
rivoluzione”. Nella pagina 11 di questo libro, il Pastore Wurmbrand cita una
parte di un poema scritto da Karl Marx che s’intitola "il Violinista": " I
vapori infernali salgono e riempiono la mente. Fino a che impazzisco e il mio
cuore è completamente cambiato. Vedi questa spada? Il Principe delle Tenebre me
la vendé." Biografia breve di Moisés Hess. Il suo nome completo era
Moritz Moisés Hess, nato nel 1812 a Bonn, Germania, in una famiglia ebrea di
ricchi industriali. Moisés morì a Parigi nel 1875 e fu sepolto in Israele.
Fu cabalista e seguace di Jacob Frank. In "Judisches Lexicón", Berlino, 1928,
pagine 1577/78, fu catalogata come un rabbino comunista e il padre del
socialismo moderno. Hess lanciò nel 1841 il periodico "Rheinische Zeitung", e un
anno più tardi fece capo di redazione a Karl Marx, che allora aveva 24 anni di
età. Hess introdusse Marx in un ordine Massonico e lo convertì al socialismo e
dopo al comunismo. Nel 1844, Hess presentò Friedrich Engels a Karl Marx. Engels
era più giovane di Marx di due anni. Moisés Hess era anche membro degli
Illuminati, e nel 1847 introdusse Marx ed Engels in quest’ordine satanico. Il
ramo degli Illuminati al quale appartennero si chiamava "LEGA DEI GIUSTI" (più
tardi chiamata LEGA DEI COMUNISTI). Quando posteriormente Karl Marx si trasferì
a Londra con la sua famiglia, fu supportato, fino al momento della sua morte, da
Nathan Rothschild. Se qualcuno avesse profetizzato nell'anno 1850 che il lavoro
di questi tre Ebrei tedeschi qualche giorno condurrebbe alla formazione
dell'Unione Sovietica e alla propagazione del comunismo che abbracciò oltre alla
metà della popolazione mondiale nel suo momento culminante, nessuno lo avrebbe
creduto. La stessa cosa si può dire di Maometto, il fondatore dell'Islam, e di
tutti gli altri uomini indiavolati che hanno causato tanta morte e dolore nel
mondo attraverso i suoi scritti e malvagi complotti. Oggigiorno, i cristiani non
possono discernere le malvagità che questa gente demoniaca sta spargendo;
malvagità il cui obiettivo è spingere in questi giorni, l'arrivo dell'Anticristo
in questo mondo. Hess morì nel 1875; Marx, otto anni più tardi, nel 1883. Engels
visse 12 anni più che Marx, morendo nel 1895. Ebbero però discepoli poderosi che
si sarebbero convertiti in nomi importanti dopo la rivoluzione bolscevica del
1917. Ventitré anni dopo la morte di Engels, Vladimir Lenin, la cui madre era
ebrea, portò dalla Svizzera un gruppo di comunisti di diverse nazionalità.
Questo gruppo attraversò Germania, Svezia e Finlandia fino ad arrivare a San
Pietroburgo, in Russia. Con Lenin stava sua moglie ebrea Krupsakaya, la quale
svolse un ruolo importante nella rivoluzione. Da New York approdò l'ebreo russo
Lev Davidovich Trotzky (vero nome Lev Davidovich Bronstein) con 300 ebrei russi
- ben allenati - che si prepararono a New York per convertirsi in ufficiali del
futuro Esercito Rosso. A questi devono essere aggiunti altri 90.000 giovani
ebrei russi che si erano esiliati temporaneamente in Siberia, o che erano
fuggiti della Russia rifugiandosi in differenti paesi europei, allenandosi
nell'attesa del momento della presa di potere in Russia. In Russia si unirono al
giovane Stalin che era sposato con una donna ebrea. Non ho spazio per nominare
tutti gli ebrei sotto la leadership di Lenin (vero nome Vladimir Ilic Ulianov)
e, dopo, Stalin. Questi, tuttavia, sono i più importanti: Lenin formò una
"troica" (= trio), con Zinoview e Kamenev, entrambi ebrei. Nel 1922 il politburo
era formato da Lenin, Zinoviev, Kamenev, Trotzky, Bukharin, Tomsky e Stalin.
Quando Lenin morì nel 1924, Stalin si servirono di tutti loro fino a che
finalmente li assassinò mediante i suoi agenti. In quest’articolo però, voglio
concentrarmi nelle operazioni dell'intelligenza comunista. I seguenti uomini e
donne - tutti ebrei - furono leader della Ceca nel 1918, anno quando cominciò il
terrore: presidente, Félix Dzerzjinskij (Rufin), alias "L'Acciaio Félix".
Direttori aggiunti: Jakov Peters, Sjklovskij, Kneifis, Zeistin, Krenberg, María
Chaikina, Sachs, Leontevitj, Delafabr, Blumkin, Alexandrovitj, Zitkin, Zahlman,
Ryvkin, Reintenberg, Fines, Goldin, Gelperstein, Knigessen, Deibkin,
Schillenckus, E. Rozmirovithj, G. Sverdlov, Karlson, Deibol, Zakis, Janson,
Sjaumjan, Seizjan, Fogel, Antonov, Jakov Sorenseon. In solo un anno, 320.000
chierici russi furono assassinati da questa "macchina per uccidere". Secondo i
registri del KGB, che diventarono pubblici dopo il 1991, questa "macchina per
uccidere" della Ceca sterminò 10.180.000 persone tra il 1918 e il 1920. La
brutale guerra civile che l'ebreo Lenin scatenò per sottomettere la Russia,
causò altri quindici milioni di morti. Durante la fame nera "provocata" dal 1921
al 1922, morirono altri 5.053.000 russi. Durante i quattro primi anni che Lenin
stette nel potere, sterminò oltre trenta milioni di russi. Quando Stalin assunse
il potere in Russia, Lazar Kaganovitj si convertì nella sua mano destra. Lazar
nacque nel 1893, e alla precoce età di 21 anni si laureò nell'Accademia Ebrea
Superiore Talmudica; dopo, l'anno seguente, fu nominato "Gran Rabbino" della
Russia. Stalin aveva piena fiducia in Kaganovitj, il quale utilizzò la "macchina
per uccidere" dell’Intelligenza per continuare ad ammazzare il popolo russo. Fu
Kaganovitj quello che portò l'enorme fame nera del 1932-33, essendo le zone più
colpite dell'Ucraina e del Caucaso settentrionale. Tutti gli agricoltori
autonomi furono obbligati ad abbandonare le loro fattorie; alcuni di essi furono
costretti a fare parte dei "kibbutz" che si denominò "kolchos" in russo. Stalin
ordinò che la popolazione russa doveva diminuire; con questo poté vantarsi che
non c'era disoccupazione nell'Unione Sovietica, che fu presentata agli occhi
dell'Occidente come il "Paradiso" dei Lavoratori. Nel 1933, sei milioni di
persone, tra uomini, donne e bambini, morirono di fame. Durante la primavera del
1933, ogni giorno morivano circa 25.000 persone in Ucraina. I sovietici
provocarono quindici milioni di morti. Stalin incaricò di questo sterminio tre
ebrei comunisti; Lazar Kaganovitj, Jakov Jakovlev (Epstein) e G.
Kaminskij.Questi tre uomini decisero quanti agricoltori sarebbero rimasti
nell'Unione Sovietica, e quanti altri sarebbero morti di fame o sarebbero stati
avviati ai Gulag (campi di lavoro forzato). Lo Storico Valentyn Moroz
del dell'Institute for Historical Review ha scritto: - "Il villaggio ucraino era
stato a lungo riconosciuto come il baluardo delle tradizioni nazionali. I
bolscevichi hanno cercato di infliggere un colpo mortale alla struttura del
villaggio perché era la spinta vitale dello spirito nazionale ". La situazione
fu tanto grave in Ucraina che nel 1934 si generalizzasse il cannibalismo e i
bambini orfani furono condotti a centri specializzati, dove furono sacrificati e
i suoi corpi spezzati e venduti alla popolazione. È anche importante evidenziare
che Lev Trotsky guidò un'unità in Russia tra il 1929-1931, per pignorare le
fattorie dei contadini obbligarli a lavorare in fattorie collettive. Affinché i
lettori comprendano i danni causati al popolo russo, prestino bene attenzione in
queste cifre fornite. Inoltre le bande di assassini comunisti sacrificarono 17,7
milioni di cavalli, 29,8 milioni di teste di bestiame, 10 milioni di vacche
lattiere, 14,4 milioni di maiali e 93,9 milioni di pecore e capre. Il risultato
di questa distruzione generalizzata dell'agricoltura in Russia e del suo
bestiame per carne e latticini, fu che circa 15 milioni di russi morissero di
fame. Queste cifre sono state prese dagli archivi ufficiali del KGB, disponibili
dopo la caduta dell'Unione Sovietica nel 1991. Mentre scrivo queste linee, la
mia anima piange profondamente man mano che immagino la sofferenza e la
distruzione di tutta una nazione, e alle persone che persero perfino tutto
quello che avevano, le loro vite, nelle mani di "uomini satanici". I Gulag erano
campi di lavoro forzato, uguali o ancora peggiori, dei campi dei nazisti.
Esisterono circa 3000 campi di lavoro, sparsi da Murmansk, fino all'ovest della
Siberia. Secondo Alexander Solzhenitsyn, per il Gulag passarono tra quaranta e
cinquanta milioni di persone tra gli anni 1928 e 1953. Nonostante l'antica
Unione Sovietica si ruppe nel 1991, ancora esistono i Gulag. In ogni campo
c'erano da 2.000 a 10.000 prigionieri. Non tutti i carcerati, purtroppo,
arrivarono ai campi. Molte volte i treni si fermavano durante il tragitto, in
pieno inverno e si obbligava a tutti i carcerati di scendere. In quel luogo li
costringevano a svestirsi e li irrigavano con acqua gelata, mentre le guardie si
burlavano, ridendo e gridando: "Vanno in fumo caldo". Come dire che, con questo
tipo di trattamento, non potevano sopravvivere. Durante l'anno 1937, il Comitato
Centrale Comunista, decise che la popolazione russa doveva essere soppressa
ancora di più. Si ordinò al NKVD che sterminasse un numero di 268,950 persone. I
dirigenti allora conclusero che il ritmo del massacro era troppo lento; è
cosicché la quota di morti s’incrementò a 48.000 persone. Durante gli anni
1937-38 la NKVD fermò a sette milioni di carcerati politici, dei quali la cifra
di assassinati arrivava a 40.000 il mese. I detenuti non avevano commesso nessun
delitto. Le unità della NKVD circondavano quartieri e villaggi, e dopo, a caso,
caricavano gente come bestiame. Col fine di accelerare il massacro, le casse dei
camion che trasportano i carcerati erano ermeticamente chiuse, per permettere
che fossero ammazzati con il gas. Come vede, il procedimento di morte con il gas
era applicato ancora prima che lo usassero i nazisti. Vittime del comunismo
giudaico...
- URSS, 80 milioni di morti;
- Cina, 65 milioni di morti (oggi non si sa...);
- Vietnam, 1 milione di morti;
- Corea del Nord, 2 milioni di morti;
- Cambogia, 2 milioni di morti;
- Europa dell'est, 2 milioni di morti;
- America Latina, 150.000 morti;
- Africa, 1 milione e 700.000 morti;
- Afghanistan, 1 milione e 500.000 morti;
-movimento comunista internazionale e partiti
comunisti non al potere, circa 10.000 morti.
Il totale si avvicina ai 150 milioni di morti.
LA LISTA DELLE VITTIME E' STATA PRESA DA: Libro
nero del Comunismo di Stéphane Courtois.
Nel Luglio del 1938, Lavrentii Beria, nato da una
famiglia ebrea della Georgia nel 1899, fu nominato capo della NKVD. Beria si
trasformò in uno dei peggiori assassini di massa della storia. Inoltre, era
molto sadico e con orribili perversioni sessuali. Beria odiava i bambini, ed è
per ciò che voleva inviarne il maggiore numero possibile ai campi di lavori
forzati. Durante il mese di ottobre del 1940, la NKVD fermò attorno ad un
milione di bambini, di età comprese tra i 14 e 17 anni. In città e villaggi, le
unità del NKVD sequestravano semplicemente a caso i bambini, facendoli dopo
sparire. Nel 1943 sequestrarono ed inviarono ai gulag circa due milioni di
bambini. Secondo i registri ufficiali disponibili a Mosca, dopo la caduta del
comunismo, circa 20 milioni di russi furono liquidati dai sicari, assassini, di
Beria durante la guerra. I soldati e civili russi che erano stati catturati dai
tedeschi e, dopo il 1945, obbligati a ritornare in Russia dai soldati
nordamericani, furono trattati come nemici e posteriormente fucilati oppure
inviati ai campi di lavori forzati. A titolo individuale, Beria utilizzò il suo
potere affinché le sue pattuglie sequestrassero ragazze giovani e li
conducessero ai suoi quartieri, dove li violava. Dopo che Beria soddisfaceva le
sue perversioni sessuali, li assassinava. Ufficialmente Stalin si vantava
dicendo che "Beria è per me ciò che Heinrich Himmler era per Adolf Hitler." Nel
1949, Stalin era irritato con la maggioranza degli ebrei con posizioni di
leadership nell' Unione Sovietica. I leader ebrei avevano partecipato
attivamente alla formazione dello stato d'Israele, canalizzando armi ed ebrei
verso la Palestina. In un dibattito all'ONU nel 1948, furono congiuntamente
l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti che, contro i britannici ed i francesi,
forzarono la votazione affinché gli ebrei avessero un stato proprio:
Israele. Stalin utilizzò il suo potere per ordinare la detenzione e l'esecuzione
di centinaia di eminenti ebrei russi (una guerra tra ebrei). I leader comunisti
ebrei avevano sufficienza forza per deporre a Stalin del suo carico di
Segretario Generale del Partito comunista nel 1952. Stalin rispose fermando ad
un gruppo di medici ebrei, tacciandoli di assassinare ai comunisti. Di seguito,
attaccò tutti gli ebrei del politburo, come a tutti i membri che avevano mogli
ebree, arrestandoli. Beria agì, ed i suoi agenti modificarono la medicazione di
Stalin; e il 1° marzo del 1953, Stalin ricevé una dose letale di veleno che lo
provocò un attacco cardiaco. Stalin perse la parola e tre giorni più tardi morì.
Allora successe qualcosa di strano. Beria si trasformò nel capo dell'Unione
Sovietica; ed il 23 marzo di 1953, ordinò che circa un milione di carcerati
politici, rinchiusi nel GULAG, fossero messi in libertà. Il 27 maggio di 1953,
suggerì che i sovietici abbandonassero la Germania Orientale e che la Germania
potesse unificarsi. Volle anche consegnare i paesi baltici all'Occidente e
ristabilire le autorità locali nell'Unione Sovietica. Allo stesso tempo, Beria
cominciò a presentare relazioni pubbliche sui terribili assassini di massa
ordinati da Stalin ed a rivelare la verità sul "culto di Stalin." Allora,
Bulganin, Malenkov e Kruschev, attraverso un colpo di Stato, assunsero il potere
nell'Unione Sovietica e fermarono a Beria e sei dei suoi più vicini
collaboratori. Si celebrò un finto processo nel dicembre del 1953, nel quale
furono condannati a morte e fucilati. La persona più influente di Krusciov era
Lazar Kaganovitj, ma pochi anni dopo fu cacciato dal potere e mandato in esilio
negli Urali. Nel 1964 Krusciov fu costretto a ritirarsi. Questo ebreo russo
simbolizza tutta la malvagità che l'uomo può arrivare ad essere. Suona ironico
che, il 31 maggio del 1962, l'ufficiale nazi tedesco Adolf Eichmann sia stato
eseguito nella forca di una prigione israeliana, dopo che lo si trovasse
rifugiato in Argentina, passata la Seconda Guerra Mondiale. Agenti del Mossad
israeliano andarono in Argentina; lì lo sequestrarono, lo tirarono fuori
clandestinamente dal paese e lo portarono in Israele per giudicarlo per gli
assassini in massa di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Eichmann ammise
che era stato solo un amministratore del piano per la detenzione degli ebrei in
Germania e nei paesi occupati dai tedeschi; e di inviarli a campi di lavoro dove
la maggioranza di essi morì, ossia per malattia, per fame, per il duro lavoro, o
semplicemente assassinati in seguito cremati. Eichmann si difese aggiungendo che
eseguiva solo ordini, che era solo un ingranaggio nella catena di comando; che
egli non era personalmente responsabile. Legittimamente, fu dichiarato colpevole
dei crimini contro l'umanità fu impiccato e morì. Però, perché i dirigenti di
differenti paesi non hanno elevato il grido verso il cielo contro Iván Serov; e,
in particolare, perché la comunità ebrea non parla degli orrendi crimini di
Serov? Qui espongo brevemente quello che questo uomo fece mentre viveva: all'età
di 17 anni, Iván volle essere ufficiale dell'Esercito Rosso; ma dato che era
basso - misurava solo 1,60 metri - entrò nelle Forze Sovietiche dell'Interno,
dove realizzò funzioni di intelligenza. Siccome era astuto, divenne direttore
della polizia segreta in Ucraina, sotto il comando diretto di Nikita Kruschev
che a quei tempi era il segretario del partito Comunista in Ucraina. Iván Serov
fu l'addetto della detenzione, deportazione ed assassinio di contadini ucraini
durante i terribili anni di fame nera. Quando Stalin intervenne nella guerra
civile spagnola (1936-1939), inviò a Serov per lavori di spionaggio e sterminio.
Lavorò congiuntamente con individui che arrivarono ad essere comunisti famosi:
Goumulka in Polonia e Tito in Yugoslavia. Nel 1939, quando congiuntamente
Germania e l'Unione Sovietica attaccarono la Polonia, Serov fu inviato per
occuparsi delle deportazioni e le esecuzioni. Serov si cambiò temporaneamente il
nome con quello di "Generale Malinov". Un milione e mezzo di cittadini polacchi
furono assassinati o deportati. Ci furono assassini di massa nel bosco di Katyn,
nella periferia della città di Minsk; lì, 4,000 ufficiali polacchi furono
assassinati e sepolti in fosse comuni. L'obiettivo era distruggere l'esercito
polacco. Questo assassinio massiccio fu attribuito ai Nazisti, ma finalmente la
verità uscì alla luce e si conobbe che fu opera della NKVD. Nel 1940, quando i
paesi baltici furono occupati dall'esercito sovietico, Serov fu l'addetto della
deportazione e l'esecuzione di un milione di persone in quei paesi. Nel suo
infame ordine (001223) che è stato declassificato degli archivi di Mosca,
scrisse le seguenti direttive: "Tutte le detenzioni devono farsi all'alba. La
famiglia deve essere riunita in una sola stanza, vestita e con la cosa più
elementare in quanto a bagaglio. Nella stazione di ferrovia devono separare gli
uomini dalle sue mogli che non si vedranno mai più, spiegando loro che sarà
fatto una visita medica in luoghi diversi. Tutti i treni devono essere
fortemente custoditi. Dopo avere "tolto di mezzo a questi cittadini baltici",
Serov fu premiato dietro l'ordine di Lenin. Durante il collasso della Germania,
Serov fu inviato di nuovo in Polonia, dove, mediante inganno, potè "registrare"
a 200.000 dei combattenti che lottarono per la libertà contro i tedeschi.
Posteriormente furono fucilati o deportati nei Gulag. Sedici membri del governo
polacco esiliato a Londra che volarono a Varsavia, furono arrestati e mandati a
Mosca, e non furono mai più visti. Serov fu quindi inviato al Caucaso e in
Crimea, dove schiacciò le rivolte e diresse più deportazioni e uccisioni.
Successivamente, fu assegnato a Berlino Est, dove il suo dipartimento lavorò sul
rapimento di scienziati tedeschi, congiuntamente con gli arresti di persone
regolari da inviare al Gulag. Dopo la morte di Stalin, la cupola utilizzò a
Serov per uccidere Beria ed i suoi collaboratori. A quei tempi, tutti i rami di
intelligenza sovietica, eccetto il GRU, si fusero in una sola. Il suo primo
direttore fu Serov. Circa 64.000 agenti dell'anteriore NKVD di Beria furono
assassinati o deportati. Iván Serov Alexandrovitj fu il perfetto burocrate,
senza nessun scrupolo in favore del carattere sacro della vita umana. L'unica
ragione per la quale non è stato mai giudicato, fu perché ancora il regime al
quale servì stava al potere e lo protesse. Dall'Europa no al reato di
negazionismo per i crimini commessi dallo stalinismo. La Commissione Europea ha
respinto una richiesta avanzata dai governi di Lituania, Lettonia, Ungheria,
Romania, Bulgaria e Repubblica Ceca di proibire e perseguire in tutto il
territorio dell'Unione la negazione dei crimini staliniani esattamente come
avviene con la Shoah. Il problema è trovare un accordo sulle orrende violenze
che hanno insanguinato l'Europa orientale sotto il comunismo. La Russia si
oppone all'equiparazione tra i massacri staliniani e quelli hitleriani e anche
gli storici sono divisi. Un punto cruciale è la stessa definizione di genocidio,
che comprende i tentativi di eliminare gruppi etnici o religiosi, ma non classi
sociali. Fu già l'Urss di Stalin, nel 1948, ad opporsi all'introduzione di
questa categoria in sede ONU. Bruxelles non è quindi riuscita a trovare un
accordo nemmeno sulla natura delle deportazioni nei GULag. Dall'articolo
"L’AMERICA VINTA", della D.ssa Lasha Darkmoon si legge tra l'altro: "L’orgia di
morte, tortura e saccheggio che seguì il trionfo ebraico in Russia (dopo la
Rivoluzione Bolscevica del 1917) non fu mai uguagliata nella storia del mondo.
Gli Ebrei erano liberi di praticare le loro più fervide fantasie di omicidio di
massa su vittime indifese. I cattolici furono trascinati giù dai loro letti,
torturati e uccisi. Alcuni furono addirittura fatti a pezzi, un po’ alla volta,
mentre altri furono marcati con ferri roventi, strappati gli occhi con dolori
difficilmente immaginabili. Altri furono messi dentro a delle casse, all’interno
delle quali venivano introdotti ratti affamati che si accanivano sui corpi.
Alcuni furono inchiodati al soffitto per le mani o per i piedi e lasciati a
penzoloni fintanto che sopraggiungeva la morte per sfinimento. Altri furono
incatenati al pavimento e versato loro in bocca piombo bollente. Molti furono
legati a dei cavalli e trascinati per le strade della città mentre la folla si
accaniva su di loro con sassi e pedate fino alla morte. Le madri venivano
portate nella pubblica piazza dove venivano strappati dalle braccia i loro
bambini, i quali venivano buttai in aria per poi essere infilzati al volo sulla
punta della baionetta. Le donne cattoliche gravide venivano incatenate agli
alberi e i bambini strappati dal ventre materno. “Non dobbiamo mai dimenticare
cosa successe quando gli ebrei erano una élite nemica nell’Unione Sovietica,” fa
notare tristemente il Prof. Kevin MacDonald. “Il disgusto e il disprezzo per la
gente tradizionale e la cultura della Russia fu un importante fattore
nell’accanita partecipazione ebraica nei più grandi crimini del 20°
secolo.” MacDonald si riferisce al genocidio sistematico di oltre 50 milioni di
russi sotto il dominio di Lenin e Stalin: un periodo di assassinii di massa che
attraversò ben 36 anni (1917-1953). La nuova elite americana, come ho
evidenziato nella prima parte di questo articolo (L’America come Colonia
Israeliana), è un elite ebraica. Esattamente come l’elite della Russia
bolscevica e dell’Unione Sovietica stalinista. Ed è in sostanza un elite ostile
che “detesta la nazione che governa.” Dobbiamo quindi stare in guardia.
Putin al Museo Ebraico di Mosca: “Il primo governo
sovietico era perlopiù composto da ebrei guidati da false ideologie.
Putin: il primo governo sovietico era perlopiù
composto da ebrei. Parlando al Museo Ebraico di Mosca, il presidente russo ha
affermato che tali politici sono stati guidati da false ideologie.
Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che
almeno l’80 per cento dei membri del primo governo sovietico erano ebrei.
“Ho pensato a qualcosa solo ora: la decisione di
nazionalizzare questa biblioteca è stata fatta dal primo governo sovietico, la
cui composizione era perlopiù ebrea per l’80-85 per cento”, ha detto Putin lo
scorso 13 giugno nel corso di una visita al Museo Ebraico e al Centro di
Tolleranza di Mosca.
Putin si è riferito alla biblioteca del rabbino
Joseph I. Schneerson, l’ultimo leader del movimento Chabad-Lubavitch. I libri,
che vengono rivendicati dai rappresentanti Chabad negli Stati Uniti, sono stati
spostati al museo di Mosca da questo mese.
Secondo la trascrizione ufficiale del discorso al
museo, Putin ha continuato dicendo che i politici del primo governo sovietico a
prevalenza ebraica “sono stati guidati da false considerazioni ideologiche ed
hanno sostenuto l’arresto e la repressione di ebrei, cristiani ortodossi russi,
musulmani e membri di altre fedi. Tutti sono stati raggruppati nella stessa
categoria.
“Fortunatamente, tali visioni e percezioni
ideologiche sono crollate. Ed oggi, stiamo essenzialmente restituendo questi
libri alla comunità ebraica con un sorriso felice. “Ampiamente considerato come
il primo governo sovietico, il Consiglio dei Commissari del Popolo è stata
costituito nel 1917 ed era composto da 16 leader, tra cui il presidente Vladimir
Lenin, il capo degli affari esteri Leon Trotsky e Stalin, che era a capo del
Commissariato del Popolo delle nazionalità.
Il comunismo, mascherato dall'abolizione delle
classi, è un piano per schiavizzare le masse sotto il pugno di ferro dell'élite
ebrea. La sua origine è proprio uscita dal Talmud ebraico, e in sostanza tutti i
leader importanti della rivoluzione bolscevica comunista erano ebrei, reclutati
e finanziati dai banchieri sionisti ebrei di Wall Street a svolgere un ruolo
fondamentale nella rivoluzione russa. Karl Marx era un Ebreo. Vladimir Lenin
(vero nome Vladimir Ilic Ulianov) era un Ebreo, così come circa l'80% di tutti i
leader della rivoluzione bolscevica. «Sulla spada e il fuoco trionfò il
giudaismo con il nostro fratello Carlo Marx, l'ebreo che ha il compito di
realizzare quanto hanno ordinato i nostri Profeti, elaborando il piano
conveniente per mezzo delle rivendicazioni del proletariato». Chi scrisse queste
frasi? Un ebreo, naturalmente. Queste frasi possono, infatti, essere lette nel
giornale ebreo Haijut di Varsavia, del 3 agosto 1928. Ciò che i bolscevichi,
ebrei nella maggior parte, fanno oggi in Russia contro il Cristianesimo, non è
che una nuova edizione di quanto fecero i massoni durante la rivoluzione
francese. Gli esecutori sono diversi, ma la dottrina che li muove e li
autorizza, nonché la suprema direzione e guida, sono sempre le stesse».
Cardinale José Maria Caro, E., Arcivescovo di Santiago, Primate del Cile. El
Misterio de la masoneria. Diffusione Editoriale, pag. 258
"Non sussiste ormai alcun dubbio sul fatti che gli
ideatori del comunismo furono gli ebrei. Essi, infatti, sono stati non solo gli
inventori, ma anche gli autori della dottrina su cui poggia quel mostruoso
sistema che tiene aggiogato con potere assoluto la maggior parte dell'Europa e
dell'Asia, che sconvolge le nazioni americane e si diffonde progressivamente in
tutti i popoli, anche cristiani, del mondo. Il comunismo agisce come un cancro
letale, si spande come un tumore maligno nelle pieghe più recondite delle
nazioni libere. E sembra purtroppo che non esista un rimedio contro tanto male.
Non solo, ma risulta altrettanto chiaro che sono gli ebrei gli inventori ed i
dirigenti della pratica comunista, della sua efficiente tattica di
combattimento, della sua insensibile e spietata politica inumana messa in atto,
nonché della sua aggressiva strategia internazionale". Tratto da "Complotto
contro la chiesa".
Il mondo crede che gli EBREI hanno il monopolio
sul "Ricordo dell’Olocausto." Ma il presidente ucraino Viktor Yushchenko ha
gettato gli ebrei una curva dedicando il 2008 come "Anno della Memoria Ucraina
dell'Olocausto". Questo "ricordo dell'olocausto", ricorda l'omicidio per fame
forzata di 6 milioni di cristiani ucraini, uccisi dai bolscevichi ebrei. Gli
ucraini chiamano questo olocausto "Holodomor" che significa
"carestia-genocidio." Naturalmente gli ebrei sionisti lo negano. Proprio come
negano tutti i loro numerosi crimini contro l'umanità. Lo storico Valentyn Moroz
dell'Institute for Historical Review ha scritto: "Il villaggio ucraino era stato
a lungo riconosciuto come il baluardo delle tradizioni nazionali. I bolscevichi
hanno cercato di infliggere un colpo mortale alla struttura del villaggio perché
era la primavera dello spirito vitale nazionale ".
Massoneria e Fascismo.
Mussolini e la massoneria. Stemma della Repubblica Sociale Italiana. Rito
Simbolico Italiano, scrive Stefania Nicoletti. Il rapporto fra fascismo e
massoneria è a dir poco ambiguo e, al di là dei proclami propagandistici di
Mussolini, fu tutt’altro che conflittuale, a cominciare dal finanziamento
offerto da alcune logge milanesi alle squadre fasciste che si apprestavano a
marciare su Roma. Il programma del movimento, per la parte sociale, si poneva il
piano della massonica “democrazia del lavoro” e fu elaborato dal “fratello”
Alceste De Ambris. Impossibile elencare qui tutti i fascisti massoni: sono
davvero troppi, anche tra gli stessi fondatori dei Fasci di Combattimento nel
1919. Tra i più noti: Italo Balbo, Dino Grandi, Roberto Farinacci, Michele
Bianchi, Emilio De Bono, Giacomo Acerbo, Achille Starace. E Licio Gelli, la cui
ascesa iniziò proprio in seno al regime fascista. Nel dopoguerra, nel carcere
romano di Regina Cœli, il futuro fondatore della Loggia P2, che mai rinnegò il
suo profondo credo fascista, condivise la cella e strinse amicizia con il
principe Junio Valerio Borghese, l’autore del futuro tentato golpe del ’70. La
Massoneria di Piazza del Gesù (Gran Loggia Nazionale d’Italia, di rito scozzese,
separatasi dal Grande Oriente nel 1908), guidata in quegli anni da Raoul
Vittorio Palermi, appoggiò l’ascesa del fascismo. Ma anche l’allora Gran Maestro
del GOI Domizio Torrigiani augurò il successo al governo di Mussolini dopo la
Marcia su Roma. In seguito, Palermi continuò ad appoggiare il fascismo,
arrivando a conferire a Mussolini la sciarpa e il brevetto di 33esimo grado.
Palermi figurò anche tra gli informatori dell’OVRA[vi], la polizia politica
fascista. Torrigiani invece se ne discostò, pur continuando a mantenere presenze
massoniche del GOI nei gangli finanziari dello Stato (emblematico il caso del
massone Beneduce a capo dell’IRI). Se è vero ciò che diceva Antonio Gramsci, che
la Massoneria fu il vero e autentico partito della borghesia italiana, non si fa
fatica a capire come mai appoggiò l’ascesa al potere del fascismo. Il movimento
di Mussolini, infatti, si presentava sia come anticapitalista (pur ricevendo
finanziamenti dai più grandi gruppi industriali e bancari esteri, soprattutto
francesi, inglesi e americani; ma, si sa, pecunia non olet), sia come
antibolscevico, anticomunista e antiproletario. Mussolini, nei suoi discorsi
demagogici, attaccava sia i grandi industriali sia i proletari. Si presentava
quindi come il difensore della piccola e media borghesia, che fu infatti il
maggiore sostenitore del fascismo, vedendo in pericolo i propri interessi
economici dopo l’occupazione delle fabbriche nel cosiddetto “biennio rosso”. Si
unirono così gli industriali del Nord e i latifondisti del Sud, che minacciati
dalle lotte degli operai e dei braccianti, trovarono nel fascismo un naturale
alleato. Nel blocco confluirono elementi dell’esercito e della burocrazia:
quindi una parte non indifferente della base massonica italiana. Nel febbraio
del 1923, Mussolini dette però il via a una campagna antimassonica, impartendo
agli iscritti del Partito Fascista la direttiva di sciogliere ogni vincolo con
le logge. Nel 1925 presentò una legge contro le associazioni segrete, la
cosiddetta “Legge contro la massoneria”, che in realtà non cita mai
esplicitamente la massoneria, ma parla solo di “associazioni segrete ed operanti
anche solo in parte in modo clandestino od occulto e i cui soci sono comunque
vincolati da segreto”. Infatti Antonio Gramsci, che in quell’occasione tenne il
suo unico discorso alla Camera, ebbe a dire: «La realtà dunque è che la legge
contro la massoneria non è prevalentemente contro la massoneria; coi massoni il
fascismo arriverà facilmente ad un compromesso. […] Poiché la massoneria passerà
in massa al Partito Fascista e ne costituirà una tendenza.» Nel discorso alla
Camera del 16 maggio 1925, Mussolini affermava che la società italiana era
dominata da un manipolo di uomini mediocri, divenuti potenti solo perché
massoni[x]. Ma in un’intervista tessé le lodi della massoneria tedesca, inglese
e americana. Tre giorni dopo la legge fu approvata dalla Camera, con 289 sì e
solo 4 no. Fra gli assenti al voto, i massoni Aldo Finzi e Dino Grandi. Lo
stesso Dino Grandi che il 25 luglio 1943, spinto dai massoni americani (che
ebbero un ruolo fondamentale nello sbarco degli Alleati in Sicilia), orchestrò
la caduta di Mussolini presentando l’ordine del giorno che lo sfiduciò. E, a
proposito di Gran Consiglio del Fascismo, c’è da sottolineare che i quattro
quinti del Gran Consiglio che dichiarò fuori legge la massoneria erano formati
da massoni. Mussolini sembrava irriducibile nei confronti della libera
muratoria: era uno dei pochi socialisti a non aver indossato il grembiulino.
Tuttavia affidava i destini finanziari e industriali del Paese a figure come
Alberto Beneduce (suocero di Enrico Cuccia), socialista e massone, che il Duce
scelse per creare l’IRI, l’Istituto per la Ricostruzione Industriale, e in
seguito per riorganizzare la Banca d’Italia. Dopo la legge del ’25, oltre ai
massoni apertamente antifascisti, ci fu anche chi scelse la via della
moderazione e del tiepidismo, rinunciando a esprimere qualsiasi forma di
dissenso: così facendo, alcuni massoni continuarono a godere nella società
italiana di posizioni anche altamente prestigiose. Questo è il caso, per
esempio, oltre che del già citato Beneduce, anche del favorito di Giovanni
Agnelli: Vittorio Valletta, direttore generale e amministratore delegato della
Fiat dal 1929 al 1946, quando ne divenne presidente. Ma se il Duce, almeno a
parole e negli atti pubblici e ufficiali, si scagliava contro la massoneria, non
fu così duro nei confronti dei Rosa Croce. Una figura chiave nei rapporti tra
Rosa Croce e Mussolini fu Giuseppe Cambareri. Teosofo, rosacruciano ed
esoterista, si presentò quale antimassone, giacché i massoni erano ormai troppo
invischiati nella politica e quindi contro-iniziati. Fu lui a proporre a
Mussolini di utilizzare la “Fraternitas Rosicruciana Antiqua” quale strumento
per attenuare l’isolamento dell’Italia, o quantomeno aggirare l’ostacolo delle
sanzioni economiche deliberate dalla massonica Società delle Nazioni dopo
l’aggressione italiana all’Etiopia. L’Italia era accusata di aver bombardato
obiettivi civili, di aver fatto uso di gas asfissianti e di aver colpito
bersagli protetti dalla (massonica) Croce Rossa. Il tentativo andò avanti per
alcuni anni, almeno fino al 1938. Il 5 marzo 1937 Mussolini ricevette a Palazzo
Venezia 120 rosacroce statunitensi dell’AMORC di Harvey Spencer Lewis.
Attraverso la mediazione e l’attivismo di Cambareri molti antichi massoni
tornarono a ronzare attorno ai poteri forti. Un percorso culminato nella
massonica Conferenza di Monaco. Uno sguardo all’estero: il regime fascista di
Mussolini fu sostenuto dagli anglo-americani fino a quando l’Italia entrò in
guerra a fianco di Hitler (anch’egli finanziato da capitali esteri). Essere
sostenuto dagli anglo-americani significa sostanzialmente essere sostenuto dalla
massoneria anglo-americana, che è il vero governo-ombra. Solo per fare alcuni
esempi: si sa già tutto sull’ “intensa simpatia” che il massone Winston
Churchill nutriva nei confronti di Mussolini. Inoltre l’ambasciatore americano
in Italia, William Philips, disse che Mussolini aveva “portato ordine dove c’era
il caos”. Frase non casuale, dato che ricalca il motto massonico “ordo ab chao”
(=“ordine dal caos”). Infine, i simboli. Fondamentali per capire sia la
massoneria che il fascismo. Solo per fare un esempio, il sigillo del Rito
Simbolico Italiano (formatosi ufficialmente a Milano nel 1876), oltre a
contenere i soliti simboli massonici (stella, squadra, compasso), è costituito
da un aquila che sovrasta un fascio littorio. Molto simile allo stemma della
Repubblica Romana del 1848-49, e identico all’aquila con il fascio littorio che
si trova al centro della bandiera della Repubblica Sociale Italiana, lo Stato
fantoccio creato dai nazisti e da Mussolini a Salò, all’indomani dell’armistizio
dell’8 settembre 1943. Un caso? Tra l’altro: “Rito Simbolico Italiano” =RSI.
“Repubblica Sociale Italiana” =RSI. Ma questa sarà sicuramente una coincidenza…
Massoneria e Nazismo.
Gli Stati Uniti d'America ed il Regno Unito, come è noto, a
Norimberga, nel principale dei processi ai criminali dirigenti del nazismo,
assunsero una posizione diversa da quella della Francia e dell'Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche. Questi due paesi infatti rivendicavano che il
processo fosse esteso ai protettori e finanziatori del nazismo, ai grandi
banchieri ed industriali del nazismo, mentre la scelta dei giudici rimase legata
alla volontà degli anglosassoni di condannare solo i diretti responsabili. Nel
principale processo di Norimberga, ricordiamo, si ebbero 12 esecuzioni di
altrettante condanne a morte.
Le origini occulte ed esoteriche del nazismo,
scrive Pierluigi Tombetti. Il partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi
ha la sua origine in una delle tante associazioni, o bund, in cui il popolo
tedesco tendeva naturalmente a riunirsi: questa si chiamava “Germanenorden”
(Ordine dei Germani) e vide la luce il 12 marzo 1912 incorporando
l’Hammer–Gemeinden (Lega del Martello) ed altri gruppi antisemiti. Il
Germanenorden (GO) convocò nel maggio 1914 a congresso tutte le associazioni
nazionaliste germaniche con lo scopo di creare una loggia antisemita segreta da
contrapporre all’internazionale ebraica: in agosto i membri del “GO” erano già
migliaia con oltre cento logge in cui le idee di List e Lanz von Liebenfels
erano discusse ed apprezzate dai membri per il loro antisemitismo e per l’enfasi
posta sulla ricerca dell’antica sapienza aria. Sarà nel 1916 che il GO
acquisterà il suo elemento di spicco, Rudolf von Sebottendorff: giovane inquieto
ed avventuroso, dopo essersi iscritto al politecnico di Berlino si imbarca e
viaggia in tutto il mondo. Si ferma al Cairo dove si avvicina al misticismo e
all’insegnamento iniziatico dei dervisci Mevlevi (cfr HERA n°31 pag.48). Da
queste prime esperienze trae il nucleo dell’insegnamento iniziatico che
perfeziona negli anni successivi a Costantinopoli dove rimane al servizio di
Hussein Pasha come sovrintendente delle proprietà. Qui Sebottendorff frequenta
la famiglia degli ebrei Termudi, ricchi studiosi della Qabbala e proprietari di
una vasta biblioteca di testi alchemici e rosacrociani; entra a far parte della
loro loggia del rito di Memphis ed elabora un sistema di meditazione e
respirazione forzata con tecniche di posizionamento delle mani e del corpo che
descriverà in “Die Praxis der alten Turkischen Freimaurerei” (1924). Questa sua
attività spirituale si nutre anche della sapienza egizia poiché nel 1900 aveva
visitato la piramide di Cheope a Giza, studiandone il significato cosmologico e
numerologico, avvicinandosi così alla gnosi occulta delle teocrazie egiziane.
Poco a poco Sebottendorff si convince che rune e misticismo islamico hanno
un’origine comune e su questa idea continua i suoi studi elaborando una sorta di
yoga sillabico, in cui dopo aver assunto speciali posture ed attuato una
respirazione canalizzata e controllata, si ripetono alcune sillabe mistiche. Il
suo sistema si propone di accumulare il più possibile la forza cosmica
all’interno del corpo umano e indirizzarla in punti desiderati così da gustare
sapori ed odori sottili fino alla percezione dell’ “ombra nera” che segna
l’inizio di una nuova vita spirituale ed il discepolo riceve il nome di Loggia.
Il passo successivo porta a gradi superiori di meditazione, fino alla
visualizzazione interiore dei colori, qualcosa di simile agli esercizi
spirituali di Ignazio di Loyola, che fu uno dei direttori spirituali a cui
Heinrich Himmler attinse per le meditazioni SS a Wewelsburg. Le tecniche di
Sebottendorff avevano come scopo il miglioramento dell’individuo fino a farlo
divenire un essere spirituale completo secondo l’insegnamento della massoneria
turca. Una sorta di Pranayama massonico. Sebottendorff tornerà in Germania nel
1913 e si affilierà al “Germanenorden”, diventando il responsabile della sezione
bavarese. Con lui troviamo il giovane Walter Nauhaus, studioso di tradizioni
esoteriche e cultura nordica ed altri esponenti di quella cultura germanica che
mescola esoterismo e ricerca storica sulla scia di Guido von List che ricercano
nella cultura ariana una superiore saggezza da contrapporre al potere ebraico in
Germania. Se anche il GO era senza dubbio una loggia con intenti antisemiti e
politici, non possiamo non riconoscere che un uomo dell’esperienza di
Sebottendorff, con una fortissima base esoterica e sapienziale avrebbe apportato
nuova linfa spirituale alla loggia bavarese. Le direttive della loggia erano
chiare:
1) sarebbe entrato a farne parte solo chi poteva
dimostrare la purezza del sangue fino alla terza generazione;
2) Si sarebbe compiuta un’opera di propaganda
razziale con dimostrazione scientifica della decadenza dovuta a mescolanza con
razze inferiori.
Per ribadire il carattere religioso e massonico
dell’ordine, esaminiamo brevemente il rituale di iniziazione dell’ordine. La
serata di iniziazione era un evento da frac e ogni nuovo fratello si sarebbe
dovuto sottoporre ai controlli frenologici tramite il plastometro, uno strumento
inventato da un frenologo di Berlino che prendeva le misure del cranio per
verificare l’appartenenza alla pura razza ariana. Mentre i novizi attendevano
nella sala attigua, nella sala della Loggia prendevano posto il Maestro sul suo
scranno con baldacchino, protetto simbolicamente da due cavalieri in tunica
bianca e con elmo adorno di corna. Di fronte sedevano il tesoriere e il
segretario mentre l’araldo prendeva posto al centro della stanza. Dalla parte
opposta al Maestro, nella zona denominata “Bosco del Graal” era seduto il Bardo
e davanti a lui il Maestro di cerimonie in abito blu. Intorno sedevano i
fratelli mentre un armonium e un pianoforte suonavano accompagnando un piccolo
coro di “elfi della foresta”. Si cominciava con il Tannhaeuser di Wagner. A luce
di candela i fratelli si facevano il segno della swastika levogira ed il maestro
rispondeva allo stesso modo. I novizi venivano introdotti bendati mentre il
Maestro spiegava loro la visione del mondo ario–germanica dell’Ordine e si
accendeva la “sacra fiamma del bosco”. Il Maestro brandiva la lancia di Wotan e
i due cavalieri incrociavano le spade sopra di essa; aveva luogo poi una serie
di chiamate e risposte accompagnata dal Lohengrin e i novizi prestavano
giuramento. Seguivano altri rituali in cui venivano personificate figure divine
del pantheon germanico creando così un’atmosfera vicina sia al misticismo
ariosofico che al rituale massonico. In “Prima che Hitler venisse”,
Sebottendorff afferma che le opere di Guido von List e Lanz von Liebenfels
“erano un pregevole patrimonio di dati non certo trascurabili, nonostante la
mistica oltranzista” e dichiara che Philipp Stauff, noto per le sue ricerche
sulle case runiche, riunì nella Associazione dei seguaci di List i simpatizzanti
di quest’ultimo. La loggia berlinese della Società Guido von List si scisse e
nel 1912 Stauff e i suoi collaboratori entrarono a far parte del Germanenorden.
Abbiamo quindi tutti i motivi per affermare che il GO aveva al suo interno
elementi guida (Stauff, Nauhaus, Sebottendorff, e altri) che approvavano e
praticavano gli insegnamenti di Guido von List e Lanz von Liebenfels. Se
aggiungiamo a questo gli esercizi di yoga massonico e la preparazione iniziatica
di Sebottendorff che avrebbe influenzato poco a poco gli insegnamenti della
loggia bavarese, dobbiamo ammettere che il GO era intriso di una sapienza
esoterica che si esprimeva essotericamente con discorsi pubblici nazionalisti ed
antisemiti, e attraverso l’organo ufficiale della loggia, “Runen”, (il primo
numero uscì nel gennaio 1918) diretto da Sebottendorff che ne era il principale
finanziatore. Tra l’altro le cerimonie importanti venivano svolte durante i
giorni dei solstizi, come era costume tra gli antichi germani. Lo stemma della
società includeva una swastika, secondo gli insegnamenti solari degli ariosofi
che i membri sfoggiavano su una spilla. Gli aderenti al GO inoltre portavano un
anello con rune con intento apotropaico: lo stesso anello (ideato da Weisthor,
il consigliere – mago del Reichsfuehrer SS) che troveremo tra gli ufficiali
superiori SS con rune e teschio all’esterno e la firma di Himmler all’interno.
Sebotendorff era anche uno studioso di astrologia e preparava ponderosi oroscopi
allo scopo di evidenziare il futuro del GO e della Germania. Il 18 agosto 1918
la loggia bavarese del “GO” cambia ufficialmente nome in Thule come copertura
per le attività politiche. Thule Bund significa ritorno alla mitica età dell’oro
nella zona di origine della civiltà aria. Le cerimonie di iniziazione richiamano
alla mitica patria nordica e collegano il rituale massonico ad una religione
wotanica solare evidente nei simboli swastika e nell’immagine di Odino sui fogli
ufficiali della Loggia. Fra gli ospiti della Thule troviamo personaggi che
avrebbero rivestito ruoli chiave nel partito nazista come Alfred Rosenberg,
articolista del “Muenchener Beobachter” (il giornale della Thule che si sarebbe
trasformato in “Voelkischer Beobachter”, il quotidiano del partito
nazionalsocialista) il futuro ministro della cultura, Dietrich Eckart, il
maestro spirituale di Hitler e Karl Hausofer Membri invece ne furono Rudolf
Hess, occultista e studioso di esoterismo, grande amico di Hitler e Hans Frank,
futuro governatore di Polonia. Ma come si giunge dalla Thule al partito nazista?
Dopo il primo conflitto mondiale, Hitler, che aveva combattuto in trincea, tornò
a Monaco dove lavorò come spia per la polizia locale che voleva raccogliere
informazioni sui vari gruppi operanti in città. Nel settembre 1919 egli
frequentò una riunione del “Deutsche Arbeiterpartei” (DAP – Partito dei
Lavoratori Tedeschi) fondato all’interno del gruppo Thule il 5 gennaio 1919 dal
fabbro Anton Drexler in una birreria di Monaco. Hitler rimase colpito dalle idee
del nuovo partito che erano in perfetta sintonia con le sue e presentò ai suoi
superiori un rapporto favorevole. Fece visita di nuovo al gruppo e si iscrisse
con la tessera n° 7. Di lì a poco Hitler ne assunse la presidenza, il nome fu
modificato in Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi (NSDAP) e la
Thule seppe di aver trovato il proprio capo e il proprio destino politico. Nella
Thule Bund si instillava l’idea che le dottrine scientifiche dovessero piegarsi
a dimostrare la veracità della dottrina della Razza superiore germaniche con
studi ed esperimenti su animali e uomini: ritroviamo qui le idee degli ariosofi
che saranno poi realizzate con la tipica precisione tedesca nelle accademie
scientifiche SS durante il III Reich. La Thule aveva dunque come scopo la
purificazione eugenetica di una élite destinata ad occupare i posti chiave nella
guida di una nazione in cerca del sé; la stessa ideologia degli arconti, degli
iniziati o dei gerofanti che veniva diffusa dalla corrente teosofica e
ariosofica tra la seconda metà del XIX sec. e i primi anni del XX. Tuttavia alla
base vi è una nostalgia delle origini, il senso della caduta dalla purezza
originale al peccato (la commistione con razze inferiori) e la convinzione che
il popolo ebreo rappresentasse la più colpevole di queste razze. A questo punto
abbiamo gli elementi per affermare che la società Thule, da cui nasce il
nazionalsocialismo come braccio politico, catalizza una corrente di pensiero che
si origina da un’ansia religiosa, la Thule crea addirittura propri rituali
all’interno della Loggia degli iniziati. In pratica, come nel caso
dell’Ariosofia, stiamo assistendo alla nascita autonoma e spontanea di una nuova
religione. La società Thule verrà, però, lasciata a sé stessa in quanto Hitler
trovava insopportabile l’idea di una conventicola politica che non riusciva ad
andare oltre il concetto di società segreta. Decise di trasformare
l’Arbeiterpartei in un grande partito di massa mentre la Thule perderà
gradualmente di importanza di fronte al NSDAP che sembrava incarnarne meglio
l’ideologia. Quando Hitler si avvicinò al gruppo Thule, gravitavano intorno a
Sebottendorff personalità curiose che non cercavano solo una riscossa politica
tedesca ma approfondivano la cultura ariosofica e studiavano le teorie di
vittoria solare del germanesimo sulle razze inferiori; l’emblema della croce
uncinata teosofica con a fianco il dio Wotan/Odin delle pubblicazioni della
Thule evidenzia la visione pangermanica e pseudo-religiosa del gruppo. Ma per
confermare questo aspetto diamo una breve scorsa ai membri più famosi e
all’influenza che ebbero su Hitler: Dietrich Eckart. Hitler lo considerava il
suo mentore, il maestro a cui ricorrere per consigli e suggerimenti su qualsiasi
campo, ritenendolo un uomo dalla superiore conoscenza. Eckart, a sua volta, lo
introdusse nella società bene di Monaco che strinse rapporti di simpatia con il
Fuehrer, sostenendo finanziariamente il NSDAP. Eckart era anche uno studioso
dell’occulto, della magia tibetana e conosceva personalmente alcuni esponenti di
questa disciplina. Le lunghe conversazioni che aveva regolarmente con Hitler
avrebbero probabilmente fornito l’occasione per trasmettere questa conoscenza.
Egli era convinto che una misteriosa e superiore razza ariana ovunque nel mondo
e da millenni sarebbe in marcia dal nord al sud e sarebbe costantemente
impegnata nel combattimento contro le razze inferiori di sub–uomini
(untermenschen). Il destino escatologico del mondo si sarebbe realizzato
attraverso la vittoria della stirpe ariana, una salvezza spirituale. Nella Thule
Bund troviamo anche Karl Haushofer, che era stato addetto militare a Tokyo.
Sembra che negli anni 1903–1908 facesse frequenti visite a Gurdjieff in Asia
centrale, seguendone per un po’ gli insegnamenti, ma si tratta di voci non del
tutto confermate. Haushofer si dedicò ad uno studio personale sulle dottrine
teosofiche e si convinse che i popoli ariani avevano avuto un’origine comune in
Asia, forse proprio in Tibet. Qui e nel deserto di Gobi aveva cercato invano
l’entrata di Agarthi e aveva stabilito contatti con saggi tibetani che gli
avevano trasmesso conoscenze millenarie. Allo scoppio della prima guerra
mondiale tornò in Germania e aderì al GO. Al temine della guerra accettò
l’incarico di professore di geopolitica presso l’università di Monaco dove
approfondì il concetto di sangue e suolo secondo cui la sopravvivenza di una
razza dipende dalla conquista del lebensraum (spazio vitale) ottenuta
sottomettendo le razze inferiori. Il suo interesse per la scienza esoterica
incorporava anche l’astrologia di cui era appassionato cultore; tutti elementi
che ritroveremo nella persona di Hitler. Tra l’altro l’astrologia permeava anche
gli ambienti dello stato maggiore tedesco. Infatti il generale Ludendorff, che
era stato compagno di Hitler durante il tentativo di impadronirsi di Monaco con
la marcia del putsch dell’8 novembre 1923, condivideva, insieme al presidente
Hindenburg, una credenza che mescolava vari elementi esoterici ed astrologici.
Haushofer andava spesso a trovare Hitler durante il periodo di detenzione di
Landsberg, dove il Fuehrer fu rinchiuso per aver partecipato al putsch fallito.
Le loro lunghe conversazioni vertevano su geopolitica, teorie della razza e
origine della stirpe aria. È difficile credere che Haushofer non gli abbia
parlato di ciò che più gli stava a cuore e cioè della sua ricerca dell’Agartha e
della sapienza tibetana. Le missioni della sezione “SS Ahnenerbe” in Tibet e il
ritrovamento di cadaveri di monaci tibetani nel bunker di Berlino nel maggio del
’45 sembrano confermarlo. Ma a Landsberg c’era un altro personaggio che faceva
parte della Thule: Rudof Hess. Nato ad Alessandria il 26 aprile 1894 frequentò
scuole destinate ai fanciulli più benestanti e allo scoppio del conflitto si
arruolò nell’esercito tedesco come fante. Al temine della prima guerra mondiale
si iscrisse all’università di Monaco dove studiò economia, storia, geografia (fu
allievo di Haushofer) e scienze politiche. Hess incontrò Hitler a Monaco nel
1920, e ne fu affascinato. Si iscrisse al NSDAP con la tessera n° 16 e divenne
da subito il secondo di Hitler. Le testimonianze che abbiamo ci parlano di una
strettissima amicizia tra Hitler e Hess (l’unico a cui Hitler dava del tu e non
del voi) che scelse di internarsi volontariamente a Landsberg per stare vicino
al suo Fuehrer: in quei mesi di assidua frequentazione, Hess spiegò a Hitler le
teorie di Haushofer e gli parlò dei suoi interessi di occultismo ed esoterismo.
Hess era vegetariano, come Hitler, e faceva preparare i suoi cibi con
particolari procedimenti bio-dinamici, secondo i precetti della medicina
omeopatica. Hitler ed Hess nutrivano un altro interesse in comune: quello per le
culture dell’Asia orientale, e per l’astrologia. Hess aveva una cerchia di amici
particolari, tutti come lui affascinati dalla conoscenza segreta ariana, ed
approfondiva questi argomenti con studi appassionati nella sua biblioteca
personale. A Landsberg Hitler, Hess e Haushofer preparano a tre mani il “Mein
Kampf”, la dottrina politica espressa essotericamente di una ideologia che ha le
sue radici nel movimento teosofico ed ariosofico. In conclusione la nascita del
partito nazionalsocialista è legata al Germanenorden, che a sua volta cambiò
nome in Thule, la mitica patria degli iperborei (cfr HERA n°29 pag.46). Hitler
preferì sempre stendere un velo di segretezza sulle sue attività esoteriche, sul
fatto che si era nutrito delle ideologie di von Lanz, che si era fatto ordinare
da Lanz confratello dell’ONT e sulle dottrine segrete ariosofiche che
condivideva. L’effetto della generale destabilizzazione delle coscienze causato
dalla filosofia irrazionalista ed idealista e la spinta ariosofica e patriottica
dell’emozione voelkisch si risolse in una manifestazione violenta ed esplosiva
dell’archetipo Wotan/Odin. Questo fenomeno si tradusse in pratica durante il III
Reich con la dottrina ariana a cui Hitler donò il crisma della legalità in nome
della razza superiore. Tratto da: Informazione Consapevole.
Fascismo e comunismo: i figli (degeneri)
della guerra. Il Primo conflitto mondiale con i suoi
lutti diede vita a due movimenti opposti. Uno voleva il paradiso in terra e
scimmiottava le religioni, l'altro militarizzò la società per volontà di
potenza, scrive Marcello Veneziani, Domenica 07/12/2014 su "Il Giornale". La
prima guerra mondiale ebbe due figli, uno rosso come il sangue che versò la
rivoluzione, l'altro nero come i lutti che causò la guerra: il comunismo e il
fascismo. Il primo preesisteva come idea e come movimento. Il secondo aveva fra
i precursori il nazionalismo e l'interventismo. Ambedue venivano dal socialismo
ma divennero realtà, partito unico e regime sotto i colpi della guerra. Al di là
di quel che oggi si dice, a Mussolini gli italiani credettero davvero e non
smisero di credere nemmeno nel pieno della seconda guerra mondiale, come
documentano Mario Avagliano e Marco Palmieri in Vincere e vinceremo! (Il Mulino,
pagg. 376, euro 25). Come testimoniano le lettere dal fronte pubblicate dai due
storici, il consenso popolare all'entrata in guerra e anche oltre, fu sincero,
«vasto e diffuso» e la partecipazione al regime e all'impresa bellica fu «attiva
ed entusiasta». E ben superiore rispetto alla prima guerra mondiale. Per la
verità anche Stalin ebbe consenso popolare nel mondo, che in Russia si cementò
in chiave patriottica nella seconda guerra mondiale; ma i russi, a differenza
degli italiani sotto il fascismo, vivevano sotto il terrore e le sue vittime
furono milioni. Ma proviamo a leggere sotto un'altra luce la parabola del
comunismo e del fascismo. Una lettura transpolitica, oltre la storia e il
Novecento. Il comunismo fu il tentativo fallito di estendere l'ordine religioso
alla società e il fascismo fu il tentativo tragico di estendere l'ordine
militare alla nazione. Il primo infatti s'imperniò sulla rinuncia
all'individualità, sulla comunanza di ogni bene, sulla comune catechesi
ideologica e sull'attesa del paradiso, nonché sulla legge egualitaria, degna di
un convento, «ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi
bisogni». Ma passando da una comunità eletta di frati - che scelgono quel tipo
di vita e rinunciano ai beni terreni - all'intera società costretta a osservare
quelle norme, il paradiso trasloca in terra e diventa inferno. Gli angeli e i
diavoli vengono storicizzati e identificati rispettivamente nella classe operaia
e nei padroni, coi loro servi; l'eterno si risolve nel futuro, e dal processo
spirituale al processo economico-materiale la scelta totale si fa servitù
totalitaria, il convento si fa soviet e poi lager, la comunità si fa Partito e
poi Stato, soffocando nel sangue chi si oppone o solo dissente. È nel passaggio
dalla comunità al comunismo che la libera rinuncia ai beni terreni e individuali
di un ordine conventuale si fa costrizione, tirannia ed espropriazione. La
comunione dei beni su base volontaria è una grande conquista, il comunismo
egualitario per obbligo di Stato è una terribile condanna. Nel fascismo avviene
un processo analogo: i codici, i linguaggi, le divise, i valori eroici attinenti
a un ordine militare vengono estesi all'intera nazione, la milizia si trasforma
in mobilitazione di massa. La società viene organizzata come un immenso
esercito, in ogni ordine e grado, e relativa gerarchia, e viene resa coesa
dall'amor patrio e dalla percezione del nemico. I valori di un ordine militare,
come credere obbedire e combattere, vengono estesi all'intera nazione.
L'impianto del fascismo è tendenzialmente autoritario, perché attiene all'agire
e alla milizia, quello del comunismo è tendenzialmente totalitario perché
pervade ogni sfera, incluso il credere e il pensare. La guerra come proiezione
verso l'esterno e la militarizzazione come orizzonte interno rende il fascismo
un regime in assetto di guerra, animato da volontà di potenza e da una fede
assoluta nei confini, trasferita anche nei rapporti umani. L'ordine militare
come scelta volontaria attiene a un'aristocrazia, ma nel fascismo viene
nazionalizzato, si fa Stato-Popolo, coscrizione obbligatoria di massa, inclusi
donne e bambini. Il comunismo è la degradazione di un ordine religioso imposto a
un'intera società e il fascismo è l'imposizione di un ordine militare a
un'intera nazione. Entrambi sono risposte sacrali, idealiste e comunitarie alla
società secolarizzata, utilitaristica e individualista: il carattere sacrale del
comunismo è sostitutivo della religione, condannata dall'ateismo di Stato; il
carattere sacrale del fascismo è integrativo della religione, come una religione
epica e pagana della patria in cui sono ammessi più déi e ciascuno domina nel
suo regno, storico o celeste. L'archetipo del comunismo è di tipo escatologico,
l'archetipo del fascismo è di tipo eroico. La redenzione promessa dal comunismo
avviene tramite la rivoluzione dei rapporti di classe. La vittoria promessa dal
fascismo avviene tramite le armi. Infatti il fascismo, nato da una guerra, muore
in guerra, sconfitto sul campo di battaglia. Invece il comunismo, nato da una
rivoluzione, fallisce proprio sul terreno economico, sconfitto sul piano del
progresso e dell'emancipazione. Mussolini sta al socialismo come Napoleone sta
alla Rivoluzione francese: è il loro antefatto. Se il prototipo ideale del
comunismo è la rivoluzione francese, il modello storico del fascismo è il
bonapartismo, che su un'impresa militare fonda un nuovo ordine civile. Napoleone
da giacobino diventa generale e poi imperatore; il Duce, ex-socialista, segue
una parabola affine. Fascismo e comunismo sovietico nascono ambedue dal collasso
dell'Ordine preesistente, imperniato sugli Imperi Centrali. La caduta
dell'Impero zarista per la rivoluzione russa, la guerra irredentista contro
l'impero austroungarico per la rivoluzione fascista. La Madre di ambedue è la
Grande Guerra, col suo corredo di sangue e trincea, la leva obbligatoria e lo
sgretolarsi del Mondo di ieri sorretto da quell'Ordine. A complicare le cose
venne poi il terzo incomodo, nato anch'egli dalla Guerra ma a scoppio ritardato:
il Nazionalsocialismo tedesco, da cui scaturì la Seconda Guerra Mondiale, fatale
per l'Europa, letale per il fascismo. La storia avrebbe preso un'altra piega se
il patto Molotov-Ribbentrop tra Hitler e Stalin avesse retto alla prova del
conflitto e all'indole dei due dittatori. In quel caso, probabilmente, la
Seconda Guerra Mondiale avrebbe vendicato la Prima e ne avrebbe rovesciato
l'esito, seppure con soggetti mutati: l'Urss al posto della Russia, il Terzo
Reich al posto della Prussia e dell'Austria asburgica. Salvo una finale resa dei
conti tra il comunismo asiatico e il nazismo indoeuropeo. Resta il paradosso
della Prima Guerra Mondiale: fu la Grande Guerra a far nascere il fascismo e il
comunismo e a galvanizzarli, ma fu la stessa Guerra a decretare la vittoria sul
campo delle democrazie liberali e poi l'americanizzazione del mondo. L'ambigua
follia della guerra.
Lenin accese la scintilla. Stalin bruciò
ogni cosa. Togliatti raccolse le ceneri. Nuove carte
provano la continuità politica tra Mosca e il comunismo italiano. Stessa logica,
stessi tragici effetti, scrive Giampietro Berti, Martedì 8/04/2014" su "Il
Giornale". Sulla storia dei legami e dei contrasti fra il comunismo sovietico e
il comunismo italiano esiste una vasta e varia bibliografia, ma quest'ultimo
libro di Giancarlo Lehener (con Francesco Bigazzi), Lenin, Stalin, Togliatti. La
dissoluzione del socialismo italiano (Mondadori, pagg. 360, euro 19), è
particolarmente istruttivo perché mette in luce l'implacabile logica che
sottende l'intera vicenda; logica che trascende la volontà dei singoli uomini.
C'è infatti una linea di continuità politica che, senza alcuna degenerazione,
inesorabilmente da Lenin, attraverso Stalin, giunge a Togliatti. Essa porterà
nel secondo dopoguerra - data la preminenza dei comunisti sui socialisti - a
recidere le possibilità riformatrici, e concrete, del socialismo italiano. Il
libro prende le mosse dalle tappe fondamentali che portarono un piccolo gruppo
di rivoluzionari di professione - Lenin, Trotskij, Stalin e pochi altri - alla
fortunata conquista del potere con il golpe dell'ottobre 1917. Come è noto in
Russia esistevano allora circa 140 milioni di persone, ma il putsch bolscevico
che fece cadere Kerenskij - lo ha ripetutamente ammesso Trotskij - fu attuato da
25mila militanti. Ciò spiega perché fin da subito vennero poste in atto le
direttive criminali per annientare ogni forma di opposizione, di destra e di
sinistra: così nel 1918 con l'abolizione dell'Assemblea costituente; così nel
1921 a Krondstad, con i marinai insorti, decimati a centinaia su ordine di
Trotsky; così, nello stesso periodo, in Ucraina con il movimento contadino
machnovista. Scrive Lehener: «Dal 1918 al 1922 una statistica per difetto dà la
cifra di 250mila persone assassinate dai cekisti (la polizia segreta)». La
sistematica distruzione di ogni opposizione è la prova più evidente della scarsa
adesione al regime da parte della popolazione: infatti perché usare tanto
terrore, se vi fosse stato un vero consenso al comunismo? Non dimentichiamo che
fra il 1935 e il 1941, si deve registrare l'arresto di milioni di persone, di
cui almeno sette milioni uccise. Nella fase più acuta del Grande Terrore
(1937-1938) furono assassinate 690mila persone, mentre un milione 800mila
vennero deportate. Il mito della rivoluzione d'ottobre infiammò comunque fin
dall'inizio il movimento operaio e socialista europeo. In Italia diede il via
alla rottura fra la componente riformista e quella massimalista, culminata nella
drammatica scissione di Livorno del 1921, che portò alla nascita del partito
comunista. Come sottolinea Lehener, la conseguenza di questo «errore
irrecuperabile» fu l'indebolimento generale delle forze democratiche, e ciò,
ovviamente, favorì la vittoria del fascismo. Con l'adesione alla Terza
Internazionale, il cui ruolo consisterà nell'essere un mero organo esecutivo
delle decisioni prese dal Kremlino, i comunisti italiani, come del resto i
comunisti di qualsiasi altro Paese, vennero sottoposti ai diktat di Mosca.
L'ascesa di Stalin comportò l'abbandono definitivo di ogni progetto di
rivoluzione mondiale, sostituito con l'idea del «socialismo in un solo Paese».
Di qui l'ovvia sudditanza del partito all'Unione Sovietica, che generò un
contrasto inevitabile al proprio interno circa la linea da tenere di fronte alla
nuova situazione acuitasi con l'avvento al potere del dittatore georgiano;
contrasto mosso dalla logica dell'epurazione, come è confermato dal conflitto
fratricida scatenatosi fra i suoi maggiori esponenti, Gramsci, Togliatti,
Bordiga, Tasca, Grieco, Silone, Tresso, Leonetti, Secchia, Ravazzoli, Terracini
e altri (con reciproche accuse di tradimento e conseguenti isolamenti,
criminalizzazioni ed espulsioni). Inoltre i comunisti italiani, pervasi sempre
più dal loro settarismo, attivarono una cieca ostilità contro coloro che non si
piegavano alle direttive del Komintern, in modo particolare contro le forze
socialdemocratiche, i cui militanti, bollati come «socialfascisti» e
«socialtraditori», erano considerati i veri ostacoli della rivoluzione
proletaria e spesso ritenuti più pericolosi degli stessi nemici borghesi,
compresi i fascisti. La profonda convinzione, del tutto fantastica, del crollo
imminente del capitalismo, specialmente dopo il 1929, fu causa di ulteriori
settarismi, uniti a un senso di superiorità verso l'intero fronte progressista,
dovuta alla certezza di possedere - grazie all'infallibilità del
marxismo-leninismo - la conoscenza del processo storico. Dalla preziosa e
inedita documentazione raccolta da Francesco Bigazzi si evince l'impressionante
clima di terrore instaurato dallo stalinismo. Tutti coloro che si erano
rifugiati nell'Urss - gran parte furono uccisi o scomparvero nei Gulag -
finirono per spiarsi l'uno con l'altro, e con ciò diventarono zelanti esecutori
delle direttive staliniste, compresa la delazione di compagni, per non cadere
nelle sgrinfie della polizia politica. Una tragedia immane che non ha prodotto
nulla di buono.
GLI ACCORDI SEGRETI DEI GERARCHI.
Churchill-Mussolini. Ecco le (nuove)
prove del mitico carteggio. Le lettere tra un capo
partigiano e una spia confermano l'esistenza del compromettente documento,
scrive Matteo Sacchi, Mercoledì 15/01/2014, su "Il Giornale". Il carteggio
Churchill-Mussolini, uno dei documenti più misteriosi della storia contemporanea
italiana, torna di nuovo a far parlare di sé. La vicenda è abbastanza nota al
grande pubblico. Prima e durante la seconda guerra mondiale il duce del fascismo
e il primo ministro britannico intrattennero quasi sicuramente una
corrispondenza riservata. Mussolini aveva custodito gelosamente quelle carte,
soprattutto da quando le sorti dell'Asse si erano volte inesorabilmente alla
sconfitta. Cosa contenevano? Molto probabilmente aperture di Churchill verso il
più fragile dei suoi nemici - l'ex primo lord dell'ammiragliato considerava la
penisola italiana il ventre molle della «Fortezza europa» del nazifascismo. Il
contenuto esatto di quegli scritti non è noto, ma nel marzo del '45 Mussolini
confidò ad Alessandro Pavolini: «Questi documenti valgono per l'Italia più di
una guerra vinta... perché documentano la malafede inglese». Probabilmente
esagerava perché qualsiasi corrispondenza val ben poco a confronto con una
disfatta militare. Però di certo se le tenne ben strette durante la sua fuga
verso Dongo. Come ricostruito da alcuni storici, a esempio Luciano Garibaldi, il
27 aprile 1945, al momento della sua cattura, Benito Mussolini aveva con sé due
borse piene di documenti contenenti - secondo le testimonianze - parte della sua
corrispondenza con Churchill. Le due borse furono subito requisite dai
partigiani della 52ª Brigata Garibaldi Luigi Clerici. Da quel momento il destino
dei documenti diventa meno chiaro. Secondo alcuni testimoni, dopo la produzione
di alcune copie, il 4 maggio 1945, il materiale fu esaminato da una commissione
formata, tra gli altri, dal segretario della Federazione comunista locale, Dante
Gorreri, e dal nuovo prefetto di Como, Virginio Bertinelli. Era materiale
scottante, ma forse i partigiani non capirono quanto. Sta di fatto che poi
accadde l'incredibile: il 2 settembre 1945, a nemmeno due mesi dalla conclusione
della guerra, dopo aver perso le elezioni e non più primo ministro, Winston
Churchill si recò sul lago di Como, a trascorrere una breve vacanza nella Villa
Apraxin di Moltrasio, dietro falso nome. Forse si trattò di una missione di
recupero aiutata e gestita dai servizi segreti inglesi. Infatti dopo quel
momento del famoso carteggio non si ebbe più traccia. Ora a questo quadro si
aggiunge un nuovo tassello. In una ricostruzione dello storico Roberto
Festorazzi pubblicata sul nuovo numero di Oggi emerge che in questo intrigo
internazionale ebbe un ruolo rilevante anche un agente dei servizi segreti
italiani, Bruno Piero Puccioni (1903-1990). Puccioni era stato un fascista della
prima ora e già nella Repubblica sociale in qualità di agente aveva svolto il
ruoli di collegamento tra fascisti, partigiani e alleati (le parti si parlavano
molto più di quanto si creda). Da una villa del borgo di Damaso, non lontano da
Dongo, Puccioni era riuscito a stabilire buoni rapporti con i partigiani
moderati tra i quali il nobile fiorentino Pier Luigi Bellini delle Stelle,
comandante della 52ª Brigata. Puccioni cercò di elaborare un piano per salvare
Mussolini e consegnarlo agli americani. Il piano fallì e Mussolini venne
fucilato (non è qui il caso di riaprire la discussione annosa se per volontà
partigiana o con una spintarella degli agenti inglesi). Quel che è certo è però
che Puccioni e Bellini delle Stelle cercarono anche nel dopoguerra di rimettere
le mani sul carteggio. Festorazzi ha ritrovato alcune delle loro missive. Così
scrive, secondo Oggi e Festorazzi, Bellini delle Stelle a Puccioni il 7 maggio
del '49: «Il carteggio pare sia andato a chi già supponevamo, ma seguendo
tutt'altra via da quella che ho dapprima seguito... Pare però che seguendo
questa via si possa giungere ad entrare in possesso di una copia fotografica di
tutti i 63 fogli...». Il piano dei due ex nemici-amici evidentemente non andò a
buon fine. Secondo Festorazzi speravano con quelle carte di far tornare Trieste
all'Italia. Di certo questa è un'ulteriore conferma dell'esistenza del carteggio
e di quale strada probabilmente prese. Come spiega al Giornale Francesco
Perfetti, contemporaneista della LUISS Guido Carli di Roma: «Che il carteggio
sia esistito ormai è un fatto che negano soltanto alcuni storici inglesi, più
che altro per un non molto sensato amor di patria». E che potesse essere
compromettente? «All'epoca senz'altro, chiaro che potesse imbarazzare il primo
ministro inglese, anche se non va sopravvalutato. Non credo ci sia al suo
interno qualcosa che possa cambiare la Storia. Al massimo le prove di quella
Realpolitik che si pratica sempre in tempo di guerra e che era un tratto chiaro
e noto del modo di operare di Churchill. Quanto alla simpatia umana che molti
conservatori inglesi e Churchill provarono a lungo prima della guerra per
Mussolini è cosa nota anche quella».
Riemerge un dossier sulle lettere tra
Churchill e Mussolini, scrive Roberto Festorazzi il 13
giugno 2015 su "Avvenire". Winston Churchill nel settembre 1945 soggiornò tre
settimane sul lago di Como. Lo scopo della «strana vacanza» è oggetto di
discussioni da decenni. Non pare che lo statista sia venuto sul Lario solo per
dipingere e riposare... Lo dimostrano, tra l’altro, gli importanti colloqui che
ebbe nella villa di Moltrasio dov’era ospite. Il leader conservatore ricevette
pure il nunzio in Italia, monsignor Francesco Borgongini Duca, che gli avrebbe
riferito le preoccupazioni di Pio XII circa l’eventualità che l’Italia venisse
trattata con durezza ai tavoli della pace. L’incontro è confermato da un
documento degli archivi americani, pubblicato dallo storico Nicola Tranfaglia:
la relazione che il delegato apostolico in Gran Bretagna, monsignor William
Godfrey, redasse il 6 novembre 1945 dopo un colloquio con Churchill in cui il
premier sostenne che la Penisola, come nazione vinta, non poteva essere
interamente libera, ma doveva adeguarsi a una forma di tutela. Le discussioni
sul carteggio Churchill-Mussolini – la corrispondenza segreta intercorsa tra i
due uomini di Stato dalla metà degli anni Trenta almeno fino al 1940, se non
oltre – hanno ripreso vigore dopo la pubblicazione dell’ultimo libro di Mimmo
Franzinelli L’arma segreta del Duce. La vera storia del carteggio
Churchill-Mussolini(Rizzoli). Ai teoremi negazionisti dello storico bresciano
che, con toni polemici un po’ sopra le righe, esclude l’esistenza di un simile
epistolario, si possono tuttavia opporre molti dati di fatto che militano a
favore della tesi opposta. Qui proporremo un’inedita scoperta che consente di
aggiungere nuovo pepe alla pietanza. Qualche tempo fa, in una villa della
Brianza, è emerso un plico di documenti esplosivi, con l’intestazione «Carteggio
Churchill-Mussolini». Si tratta di un dossier appartenuto all’ex proprietario di
quella residenza, e incautamente dimenticato nel corso di un trasloco non troppo
accurato. Padrone della villa fu un agente segreto britannico, autore di
fortunosi recuperi dei dossier esteri che Mussolini portò con sé sul lago di
Como, nelle giornate di fine aprile del 1945. Si tratta di Malcom Hector Smith,
un personaggio di cui si sa molto poco, ma la cui figura è di grandissimo
interesse per penetrare a fondo i misteri del carteggio più controverso della
storia. Il maggiore Smith, nato a Palermo nel 1910 da genitori scozzesi e morto
a Como nel 1991, non soltanto fu al centro di molti intrighi, ma nel dopoguerra
venne incaricato dal governo britannico di restare a occuparsi, in Italia, dei
cascami di quei recuperi di «preda cartacea», come una sorta di agente
permanente degli interessi della Corona. Sotto l’incarico di copertura di
console del Sudafrica, Smith, tra una partita di golf e l’altra, agì così per
occultare le tracce di quelle lontane operazioni speciali svolte nella
primavera-estate del 1945. Il primo a sollevare il coperchio sui ruoli
dell’ufficiale scozzese fu Duilio Susmel, cacciatore di carte ducesche, il quale
sulla Domenica del Corriere nel gennaio 1967 scrisse a chiare lettere che
questi, nelle giornate di Ferragosto del ’45, aveva disseppellito i carteggi nel
giardino di Villa Mantero di Como, dove erano transitati Rachele Mussolini e i
suoi figli minori. A fornire indicazioni dettagliate sulla esatta localizzazione
dei preziosi fascicoli era stato l’industriale chimico Guido Donegani, padrone
della Montedison. Costui, arrestato e rinchiuso a San Vittore con l’accusa di
collaborazionismo, aveva barattato la scarcerazione con suggerimenti agli
inglesi atti a individuare i nascondigli delle carte. E non è privo di rilevanza
osservare che Churchill, durante la sua «strana vacanza» pittorica sul lago di
Como nel settembre 1945, soggiornasse proprio nella villa di Moltrasio
dell’industriale, recandosi poi in visita a Venegono, località varesina dove
Donegani si trovava sotto scorta militare britannica: praticamente «piantonato»!
Non è tutto: lo stesso Smith, il 22 maggio precedente, era riuscito a
intercettare altri segmenti della corrispondenza Duce-Churchill, occultati
nell’imbottitura di una cavallina della palestra Negretti, sempre nel capoluogo
lariano. A questo punto torna molto utile considerare il plico dei documenti
riemerso dalla ex-villa dell’agente segreto: carte che contribuiscono ad
avvalorare ulteriormente questa pista di indagine. Di che cosa si tratta? La
busta, oltre a copie di relazioni inedite e sensazionali che descrivono le
missioni svolte da Smith nelle settimane successive alla conclusione del
conflitto, contiene le trascrizioni in inglese sia dello scoop di Susmel,
apparso sulla Domenica del Corriere, sia delle polemiche che ne seguirono. Una
prima domanda sorge spontanea: per quale ragione Smith, che parlava
correntemente l’italiano, avvertì l’esigenza di tradurre quelle notizie di
stampa? Evidentemente qualcuno a Londra, nel governo o nella direzione dei
servizi segreti, gli aveva chiesto una relazione dettagliata sull’argomento.
Curiosamente, il servizio esclusivo della Domenica del Corriere, «lanciato» dal
rotocalco fin dalla copertina, provocò una serie di reazioni. Un ex agente
dell’Ovra (il braccio operativo della Polizia politica fascista) scrisse al
settimanale per attaccare Smith. Terzilio Borghesi – questo il suo nome –
lamentò di essere stato derubato, quando nel maggio del ’45 era stato arrestato
a San Maurizio di Brunate da agenti inglesi, tra cui il nostro. Smith replicò
alla lettera diffamatoria della spia dell’Ovra, ma – questo è il lato
interessante della vicenda – la sua rettifica non riguardava in nulla le notizie
sul suo ruolo nella vicenda del trafugamento del carteggio Churchill-Mussolini.
In tal modo è come se confermasse indirettamente lo scoop di Susmel. Soltanto
poco prima di morire, in un’intervista rilasciata allo storico Marino Viganò, il
maggiore Smith ammise ufficialmente di essere stato l’autore di quei recuperi
cartacei, chiarendo di aver incontrato lo stesso Winston Churchill durante il
soggiorno dello statista britannico sul Lario. Benché lo smentisse a Viganò,
l’ufficiale scozzese in privato ad amici e conoscenti rivelava inoltre di aver
avuto un ruolo anche nell’epilogo cruento di Mussolini: indiscrezioni di cui è
molto difficile valutare il reale fondamento. Le «carte della villa» contengono
anche appunti dattiloscritti di Smith, che danno consistenza al suo (finora)
evanescente profilo biografico. Egli infatti, trasferitosi in Scozia dopo
l’infanzia palermitana, era emigrato in Sudafrica nel 1923, rimanendovi fino
allo scoppio della Seconda guerra mondiale. Rientrato in Gran Bretagna, era
stato poi arruolato nel Field Security Service e nel luglio 1943 era sbarcato in
Sicilia con le truppe alleate. Durante la campagna d’Italia, aveva lavorato in
stretta collaborazione con il controspionaggio del Sim. In qualità di ufficiale
di collegamento britannico, operava alle dipendenze degli alti comandi della
sicurezza militare congiunta anglo-americana, cioè agli ordini del G-2 della 5ª
Armata americana. Nei suddetti appunti, si riporta, tra l’altro, una
dichiarazione del capo dell’808° Battaglione del controspionaggio italiano in
zona di operazioni, la quale attesta che «il maggiore Smith e la sua Sezione,
composta da 6 uomini più il comandante, aveva "compiti di ricerca delle spie
tedesche lasciate dietro le linee alleate"». Nel luglio 1945 Malcom Smith si unì
in matrimonio al soprano fiorentino Elda Ribetti. Come d’incanto il padre della
sposa, il fascistissimo colonnello di fanteria Alfredo Ribetti, che si trovava
agli arresti, venne scarcerato... Semplici coincidenze?
Il carteggio Churchill-Mussolini? Una
traccia nei Nationals Archives di Londra, scrivono il
2 settembre 2015 Dino Messina e Eugenio Di Rienzo su "Il Corriere della Sera".
La caccia al carteggio segreto tra Churchill e Mussolini, dove il premier
britannico, prima del 10 giugno 1940, invitava il capo del fascismo a far
entrare l’Italia in guerra a fianco della Germania per mitigare, in caso di
sconfitta del Regno Unito, le pretese di Hitler al tavolo delle trattative, ha
impegnato per quasi settanta anni, storici della domenica, inguaribili
nostalgici del Ventennio nero, giornalisti in cerca di scoop, spregiudicati
editori. Solo, nel marzo di quest’anno, come ha scritto Paolo Mieli sulle pagine
del «Corriere», questa caccia si è ufficialmente chiusa, definitivamente ci
auguriamo, grazie all’importante lavoro di Mimmo Franzinelli (“L’arma segreta
del Duce. La vera storia del carteggio Churchill-Mussolini”, Rizzoli). Nel suo
studio Franzinelli ci ha rivelato con meritoria pignoleria la lunga storia di
falsificazioni e di manipolazioni che si è sviluppata intorno al fantomatico
commercio epistolare. Inventato di sana pianta e costruita con molta rozzezza è,
infatti, lo schema di accordo dell’11 aprile con la quale l’inquilino di Downing
Street chiedeva all’ospite di Palazzo Venezia di catapultare il nostro Paese
nella tragedia del secondo conflitto mondiale, in modo da «aiutare la Gran
Bretagna nella futura conferenza di pace a frenare il militarismo tedesco e a
ottenere la vittoria finale contro di esso», promettendo l’intervento del
Governo di Sua Maestà per sostenere le rivendicazioni italiane verso la Francia
e per «ripristinare i diritti dell’Italia sul Mediterraneo». Egualmente
contraffatta, come numerose altre missive, era la risposta 4 maggio, dove il
Capo del Governo italiano informava Churchill di aver ottenuto il consenso di
Vittorio Emanuele a quell’accordo.
Tutto falso, tutto da buttare in quel carteggio?
Assolutamente sì. E, a titolo di direttore di una rivista storica, voglio qui
pubblicamente ringraziare Franzinelli, sicuro che, dopo il suo libro, la mia
redazione non sarò più invasa, come tante volte è accaduto, da clamorose
rivelazioni sulla diplomazia segreta di Mussolini, opera di pseudo-studiosi
dominati dalla teoria del complotto. Come analista del passato, devo però
rimproverare all’autore dell’Arma segreta del Duce un errore di metodo e
un’insufficienza nella ricerca archivistica che si collegano l’uno all’altra,
dando vita a un circolo vizioso storiografico. Per il primo punto devo dire che
l’aver dimostrato che lo scambio di missive tra Churchill e Mussolini della
primavera-estate del 1940, in nostro possesso, è un apocrifo non vuol dire che
non siano esistiti in quello stesso periodo, come Franzinelli presume, negoziati
o magari semplici pourparlers con l’Italia, attraverso i quali Francia e
Inghilterra cercarono di ottenere l’assicurazione che il Duce in una futura
conferenza di pace avrebbe speso la sua influenza a loro favore, in cambio di
una sostanziosa contropartita ma soprattutto al fine di arginare la
preponderanza del «Reich millenario». Per il secondo punto, mi spiace dover
osservare che quanto afferma l’autore dell’ “Arma segreta del Duce”, e cioè che
ogni rapporto tra il Mussolini e i leaders delle democrazie liberali si sarebbe
interrotto il 19 maggio, dopo il secco rifiuto di Palazzo Venezia a prendere in
considerazioni gli inviti di Churchill e Roosevelt a non seguire Hitler
nell’avventura bellica iniziata nel settembre 1939, costituisce una grave
imprecisione. Un’imprecisione che Franzinelli si sarebbe potuta facilmente
risparmiare con un più lungo e fruttuoso soggiorno di studio nei Nationals
Archives britannici o più semplicemente grazie a un’attenta lettura dell’ultimo
capitolo del lavoro di Emilio Gin, “L’ora segnata dal destino. Gli Alleati e
Mussolini da Monaco all’intervento. Settembre 1938 – Giugno 1940!”, pubblicato
da Nuova Cultura Editore nel 2012. Negli archivi di Londra, sono conservati,
sotto il titolo “Suggested Approach to Signor Mussolini”, i verbali della
riunione del War Cabinet del 26 maggio 1940. In quella data, previa intesa con
il governo di Parigi, l’esecutivo britannico decideva di inviare a Roosevelt una
bozza di accordo, che il Presidente degli Stati Uniti avrebbe dovuto sottoporre
all’attenzione di Mussolini. Nel testo, le Potenze occidentali, nel momento in
cui il fronte francese si era letteralmente sbriciolato sotto la spallata della
Blitzkrieg scatenata dall’esercito tedesco, chiedevano al Duce di offrire la sua
collaborazione nelle future trattative con la Germania per assicurare una
soluzione di tutte le questioni europee, da cui dipendeva «la sicurezza e
l’indipendenza degli Alleati» e la possibilità di garantire «una pace giusta e
duratura all’Europa». Qualora Mussolini avesse accettato questa proposta, Londra
e Parigi s’impegnavano a non aprire nessun negoziato con Hitler, se questi non
avesse consentito all’Italia di partecipare, nonostante il suo status di non
belligerante, alla conferenza di pace. Inoltre Churchill e il Primo ministro
francese, Paul Reynaud, promettevano formalmente, sotto la malleveria degli
Stati Uniti, di ricompensare il governo di Roma soddisfacendo «tutte le sue
legittime aspirazioni nel Mediterraneo» che all’epoca comprendevano, in primo
luogo, l’internazionalizzazione di Gibilterra e la partecipazione al controllo
del Canale di Suez, oltre importanti acquisti territoriali nell’Africa francese.
Il cammino per arrivare a questa iniziativa era stato difficile e contrastato.
Churchill aveva dovuto, infatti, superare le resistenze di Reynaud, che alla
fine si era arreso, contando sullo «sconforto che l’idea di un’Europa dominata
da Hitler doveva causare in Mussolini». Anche Roosevelt aveva recalcitrato
all’idea di un suo nuovo intervento su Palazzo Venezia, dopo la cattiva
accoglienza ricevuta da un suo precedente messaggio, che era stato definito dal
Duce un’indebita ingerenza nella politica italiana. Per vincere la ritrosia di
Washington, il premier britannico aveva incaricato il Segretario agli Esteri,
Halifax, di abboccarsi con l’ambasciatore italiano a Londra, Bastianini, per
sondare gli umori di Palazzo Venezia. L’incontro, svoltosi nel pomeriggio del 25
maggio, durante il quale Halifax aveva consegnato al nostro diplomatico la bozza
della lettera di Roosevelt, era stato positivo. Con tutte le cautele del caso,
Bastianini, che certo non parlava a titolo personale, informava Halifax che il
Presidente del Consiglio italiano non avrebbe opposto nessun pregiudiziale
rifiuto a partecipare a una «peace conference by the side of the belligerents».
Mussolini, aggiungeva Bastianini, era interessato a risolvere tutte le questioni
europee, e in particolare ad arrivare a un’equa sistemazione politica e
territoriale della Polonia, e aveva sempre pubblicamente manifestato il vivo
desiderio di costruire un «accordo generale sull’Europa» che non avrebbe dovuto
essere «un semplice armistizio» ma piuttosto un patto di sicurezza collettiva in
grado di «salvaguardare la pace del continente per almeno un secolo». Nella
mattinata del 27, l’ambasciatore americano Phillips, dopo aver appreso il
rifiuto di Mussolini di concedergli udienza, consegnava la lettera di Roosevelt
a Ciano, ribadendo che, in caso di risposta positiva, il Presidente degli Stati
Uniti sarebbe divenuto «personalmente responsabile per l’esecuzione, a guerra
finita, degli eventuali accordi». Con perfetto tempismo, in quella stessa
giornata, anche l’ambasciatore francese François-Poncet incontrava il nostro
ministro degli Esteri, annunciandogli che, con l’esclusione della Corsica, la
Francia era disposta a trattare «sulla Tunisia e forse anche sull’Algeria». La
replica di Ciano non lasciava, però, adito a nessuna speranza. La decisione di
entrare in guerra era stata ormai presa e se anche il Duce avesse potuto avere
pacificamente il doppio di quanto da lui reclamato, egli avrebbe rifiutato. Come
ha scritto Emilio Gin, la rinuncia di Mussolini a prendere in considerazione il
piano di Churchill obbediva a un calcolo razionale che poco aveva a che fare con
l’infatuazione bellicista che gran parte della storiografia italiana gli
attribuisce. Il Duce, infatti, non avrebbe potuto tollerare di partecipare ai
colloqui per la pace, accanto ad un Hitler trionfante, solo per gentile
concessione di Giorgio V e del suo fiacco alleato. In questo caso, la sua
posizione sarebbe stata debolissima, del tutto ininfluente, e il Führer,
divenuto padrone assoluto del gioco, avrebbe potuto imporre a tutta l’Europa il
Neue Ordnung nazionalsocialista, eliminando dalla scena politica Nazioni
Neutrali, Paesi occupati, Alleati e la stessa Italia. Solo dopo aver partecipato
al conflitto, al “modico” prezzo di «un pugno di morti» per sedersi al tavolo
delle trattative, Mussolini poteva dunque far sentire la sua voce con la fondata
speranza di essere ascoltato. Come, il 28 maggio, Ciano fece intendere al
ministro d’Inghilterra, Percy Lorraine, non esisteva altra via d’uscita dalla
guerra scatenata dal Reich se non la partecipazione italiana al conflitto. Si
trattava un messaggio cifrato, volutamente ambiguo, che pure fu perfettamente
inteso dalle Cancellerie alleate. Fu soprattutto Parigi a penetrare il senso di
quell’enigmatico avvertimento e comprendere che nei piani di Palazzo Venezia
l’intervento italiano doveva costituire il contrappeso necessario alla vittoria
di Hitler. Il 2 giugno, infatti, il Ministro francese della Difesa e degli
Esteri, Daladier, sosteneva che il governo di Roma intendeva iniziare una
«guerra a termine», che non aveva «precedenti nella storia diplomatica». Dopo
sei giorni, il Sottosegretario del Quai d’Orsay Baudouin manifestava al nostro
ambasciatore a Parigi, Guariglia, la speranza che Italiani e Francesi potesse
adoperarsi nel futuro per colmare l’abisso che attualmente li separava perché
alle due Nazioni latine non conveniva né una pax britannica né la vittoria
completa di Hitler. La risposta dell’italiano, sebbene fornita a titolo
strettamente personale, veniva incontro a quel desiderio. Guariglia replicava
che, considerando che il Duce aveva sempre avuto a cuore «la necessità della
ricostruzione europea», da raggiungere mediante «una giusta e intelligente
politica evolutiva», era forse possibile ipotizzare che egli, in questo triste
momento, pensasse di «arrivare agli stessi risultati attraverso la via della
guerra». La più forte conferma al fatto che, anche dopo il 10 giugno, Mussolini
non intendeva recidere il filo del colloquio con Parigi e Londra è, sempre
secondo Emilio Gin, nelle istruzioni impartite agli Stati Maggiori delle nostre
Forze Armate, poco prima dell’inizio delle ostilità. Se si eccettua l’offensiva
italiana sulle Alpi occidentali, iniziata con inspiegabile ritardo solo il 21
giugno, la guerra del Duce doveva essere, per sua stessa ammissione la replica
di quella «guerra seduta» (Sitzkrieg), che per quasi un anno aveva opposto,
senza grande spargimento di sangue, gli Alleati e i Tedeschi sul suolo francese.
All’Esercito, che con una manovra a tenaglia dalla Libia e dall’Etiopia, avrebbe
potuto seriamente minacciare l’Egitto, fu ingiunto di restare con l’arma al
piede senza prendere nessuna iniziativa. Alla Regia Marina, che era in
condizioni di disturbare efficacemente, se non addirittura di interrompere, i
movimenti dei convogli britannici nel Canale di Suez, si ordinò di aprire il
fuoco solo se attaccata. All’Aeronautica si diedero disposizioni di soprassedere
«fino a nuovo ordine a qualsiasi operazione offensiva» e di vietare ai propri
aerei di portarsi a più di dieci chilometri dal confine con la Francia. Furono,
inoltre, annullate le incursioni su Gibilterra e Alessandria d’Egitto, già da
tempo programmate e fu ridotto d’intensità il bombardamento di Malta dell’11
giugno. Fino a quando i raids effettuati da 36 velivoli della Raf, che nella
notte del 12 giugno colpirono Torino e Genova completamente illuminate, come in
tempo di pace, non provocarono una escalation militare italiana, era dunque
intenzione del Duce di limitarsi a una «guerra di parata», per non pregiudicare
il rapporto con Churchill nella futura conferenza di pace, dove sarebbe iniziata
la guerra vera, quella contro Hitler. Dopo questo lungo periplo, torno, ora, al
punto di partenza. A differenza di Franzinelli e di molti altri storici
mainstream, io concordo con Renzo de Felice nel ritenere che, con buona
verosimiglianza, la logora borsa di cuoio che Mussolini trascinò con sé nella
sua fuga da Milano doveva contenere materiale scottante. Forse non dei documenti
che potevano valere per l’Italia «più di una guerra vinta», come il Duce confidò
a Pavolini, ma certo delle testimonianze in grado di mettere in seria difficoltà
il governo britannico. Allo stesso tempo reputo però che, se questa
documentazione è esistita, sia del tutto inutile cercarla perché essa è stata
distrutta o sepolta in luogo inaccessibile, nei giorni immediatamente successivi
l’uccisione di Mussolini. Uccisione resa possibile, occorre ricordarlo, da un
colpo di mano organizzato, come i lavori di Mauro Canali e miei hanno
dimostrato, dallo Special Operations Executive, l’organizzazione terroristica
che, dall’inizio del conflitto, Churchill aveva posto sotto il suo comando
diretto.
Patto Molotov-Ribbentrop.
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Il patto Molotov-Ribbentrop, talvolta
chiamato patto Hitler-Stalin, fu un trattato di non aggressione fra la Germania
nazista e l'Unione Sovietica. Venne firmato a Mosca il 23 agosto 1939 dal
ministro degli Esteri sovietico Vjačeslav Molotov e dal ministro degli Esteri
tedesco Joachim von Ribbentrop. Si trattò di una conseguenza della decisione di
Stalin, dubbioso della reale volontà delle potenze europee occidentali di
opporsi all'espansionismo aggressivo della Germania nazista, di ricercare un
accordo con Hitler per contenerne la spinta verso est, per acquisire vasti
territori appartenuti all'impero zarista e per dirottare le mire tedesche verso
ovest, guadagnando tempo per rafforzare i suoi preparativi militari. Hitler
accolse prontamente la sorprendente disponibilità sovietica contando di
sfruttare l'accordo per concentrare le sue forze a ovest, senza temere minacce
alle spalle pur mantenendo le sue mire strategiche a lungo termine verso le
terre dell'est. L'accordo, considerato da alcuni storici uno dei fattori causali
determinanti dell'inizio della seconda guerra mondiale (1º settembre 1939),
definiva tra l'altro le sfere di influenza del Terzo Reich e dell'Unione
sovietica per le zone vicine ai confini dei due Stati. Le conseguenze immediate
più importanti del trattato furono la divisione del territorio polacco tra
sovietici e tedeschi e l'occupazione delle repubbliche baltiche da parte
dell'Armata Rossa. L'equilibrio di potere in Europa, durante la pausa successiva
alla prima guerra mondiale, veniva eroso un poco alla volta. Basti pensare alla
crisi causata dalla guerra d'Etiopia (1935-1936), che preludeva alla crisi
dell'unico organismo di pace internazionale, la Società delle Nazioni; oppure
all'accordo di Monaco (1938) che dava mano libera a Hitler nel suo intento di
estendere i propri territori (a costo di altri stati come la Cecoslovacchia). Le
potenze occidentali, perseguendo la politica chiamata dell'Appeasement, per
timore di scatenare un nuovo conflitto mondiale, decisero di consentire alle
continue pretese territoriali del Terzo Reich. Visto dalla prospettiva
sovietica, un patto con la Germania poteva essere una risposta necessaria al
deterioramento della situazione in Europa, a partire dalla seconda metà
degli anni trenta, quando la Germania nazista si allineò con l'Italia
fascista per formare il gruppo delle Potenze dell'Asse. Da una parte, un patto
avrebbe garantito una certa sicurezza all'URSS; dall'altra questa mirava, come
la Germania, a rovesciare l'ordine stabilito nel trattato di Versailles,
stipulato dopo la prima guerra mondiale dagli Alleati occidentali senza il
concorso dei diplomatici sovietici considerati rappresentanti di un'entità
politica non riconosciuta internazionalmente (la Russia bolscevica) e minacciosa
per l'ordine politico-sociale. Infatti la grande guerra era finita in maniera
svantaggiosa anche per i russi: le loro perdite territoriali erano la
conseguenza dello stato di debolezza in cui si trovava nel 1918 lo stato
sovietico, che allora era appena nato e reduce da sconvolgimenti come
la rivoluzione d'Ottobre del 1917 e la guerra civile russa. I territori ceduti
ad altri stati erano immensi. Poi si erano formati i nuovi paesi indipendenti
interamente sul territorio dell'ex-impero
russo: Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania; un simile discorso valeva per i
territori occupati dai polacchi nel 1920, a est della linea Curzon; inoltre,
l'Unione sovietica era interessata a riprendere il controllo sulla Bessarabia,
territorio abitato in larga maggioranza da moldavi, occupato dalla Romania nel
1918 nonostante le inutili proteste sovietiche. Tanto la Germania quanto
l'Unione Sovietica erano dunque interessate a sovvertire un ordine stabilito
senza che né l'una né l'altra potessero avere voce in capitolo. Il Regno Unito e
la Francia erano invece notori garanti dello status quo territoriale, e rimasero
in attesa fino alla distruzione della Cecoslovacchia da parte della Germania,
resa possibile dalla Conferenza di Monaco: quest'ultima era stata decisa in
comune accordo da Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Benito Mussolini ed Édouard
Daladier il 29 settembre 1938: in seguito all'accordo, il territorio
cecoslovacco andava a finire, più o meno direttamente, sotto il controllo di
Hitler. Da parte della Francia e del Regno Unito, era stata decisiva la tendenza
a cercare compromessi con la Germania allo scopo di evitare un confronto
militare: si trattava di quella che veniva chiamata politica dell'Appeasement,
una pacificazione ricercata quasi a tutti i costi: infatti, la decisione di
cedere alle richieste territoriali dei tedeschi era in contraddizione con
l'alleanza franco-cecoslovacca del 1924. Le decisioni prese erano comunque a
favore della politica hitleriana di quegli anni, atta a procurare al popolo
tedesco il cosiddetto "spazio vitale" in Europa dell'est (Lebensraum im Osten).
Nel frattempo, comunque, le due potenze occidentali si erano arrese all'evidenza
dei fatti, dato che le loro concessioni non avevano placato, ma anzi stimolato
le velleità di Hitler. La politica dell'Appeasement non poteva assolutamente più
essere perseguita, dunque l'espansione tedesca doveva assolutamente essere
fronteggiata. Così, inglesi e francesi si dichiararono disposti a garantire
l'integrità della Polonia già nel marzo del 1939, il che fornì alla Germania un
pretesto per disdire un patto di non aggressione stipulato con la Polonia sei
anni prima. Per gestire la situazione, i francesi e gli inglesi si sforzarono di
trovare un accordo con i sovietici, i quali tuttavia, nella primavera del 1939,
stavano negoziando anche con i nazisti e giocavano quindi contemporaneamente su
due tavoli. La politica franco-inglese era mal vista dai sovietici per diverse
ragioni: durante il 1938 il governo sovietico si era invano offerto di difendere
la Cecoslovacchia in caso di invasione tedesca, ma quest'ultima, così come altri
paesi dell'area, nutriva dubbi sulle reali intenzioni di Mosca ed aveva
preferito appoggiarsi alle potenze occidentali. Il primo Segretario
sovietico Stalin, che non era stato invitato alla conferenza di Monaco, cominciò
a credere che Francia e Gran Bretagna agissero in accordo con Hitler
nell'interesse di porre un freno al comunismo, o che addirittura volessero
aizzargli contro una Germania sempre più potente. Del resto, non si trattava di
un'impressione del tutto nuova: Stalin aveva già sospettato un certo
disinteresse da parte dell'occidente nei confronti di un fascismo in continua
avanzata, esemplificato dagli eventi della guerra civile spagnola. Le
negoziazioni della primavera del 1939 intraprese da Unione Sovietica e il
binomio Francia-Regno Unito per fronteggiare il pericolo tedesco si bloccarono:
la causa principale di questo fallimento furono i reciproci sospetti. L'Unione
Sovietica cercava garanzie contro l'aggressione tedesca e il riconoscimento del
diritto di interferire contro "un cambio di politica favorevole a
un'aggressione" nelle nazioni lungo il confine occidentale dell'URSS: anche se
nessuna delle nazioni coinvolte aveva formalmente richiesto la protezione
dell'Unione Sovietica (alcune nazioni come la Finlandia, la Romania, le
repubbliche baltiche e la Turchia consideravano l'Unione Sovietica più
pericolosa della stessa Germania), i sovietici annunciarono "garanzie per
l'indipendenza di Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Turchia
e Grecia". Dall'altra parte, i britannici e i francesi temevano non senza motivo
che ciò avrebbe consentito l'intervento sovietico negli affari interni delle
nazioni confinanti, anche in assenza di una immediata minaccia tedesca. Con la
Germania che chiedeva concessioni territoriali alla Polonia, e di fronte
all'opposizione polacca, la minaccia di una guerra era crescente. Ma anche se ci
fu uno scambio di telegrammi tra sovietici ed occidentali (non più tardi
dell'inizio di aprile) una missione militare inviata via nave dalle potenze
occidentali non arrivò a Mosca prima dell'11 agosto. Un punto spinoso era
senz'altro l'atteggiamento della Polonia, stato che aveva ripreso ad esistere
solo dopo la prima guerra mondiale e che ora si trovava a metà strada tra
Germania e Unione Sovietica: il governo polacco temeva giustamente che il
governo di Mosca cercasse l'annessione di regioni della Polonia orientale
rivendicate dall'Unione Sovietica. Si trattava dei territori ad est della linea
Curzon, incorporate nella Polonia nel 1920, considerati dai sovietici come
"irredente" (l'Ucraina occidentale e la Bielorussia occidentale). Le
rivendicazioni territoriali sovietiche erano fondate non tanto sulle aspirazioni
degli abitanti di questi territori ma sulla costatazione oggettiva che la
maggioranza della popolazione non era di lingua polacca; vi era piuttosto
corrispondenza etnica tra questi territori e quelli dell'Ucraina e della
Bielorussia. Dato che la Polonia si rifiutava non immotivatamente di permettere
all'esercito sovietico un intervento militare sul suo territorio in caso di
aggressione tedesca, la situazione pareva lasciare i sovietici senza nessuna
possibilità di contrastare i nazisti prima dell'invasione della Polonia. Questa,
dal canto suo si sentiva abbastanza forte grazie alle garanzie di protezione
pronunciate da inglesi e francesi; così, nella terza settimana di agosto i
negoziati si fermarono: ormai i sovietici sospettavano che sarebbero entrati in
un conflitto limitato a loro e ai tedeschi. Anche su questo fronte si
svilupparono febbrili reazioni, parallelamente a quanto facevano i sovietici con
francesi e britannici. Il Primo Segretario sovietico Stalin aveva aperto, già
nel mese di maggio, dei negoziati per un miglioramento delle relazioni con la
Germania sostituendo il Ministro degli Esteri Maxim Litvinov con Molotov.
L'ebraico e pro-occidentale Litvinov non si addiceva a guidare l'Unione
Sovietica verso un accordo con la Germania nazista, visto che era largamente
percepito come un sostenitore dell'alleanza con le potenze occidentali e contro
i poteri fascisti. La sua sostituzione non era altro che la conferma
dell'irrimediabile scetticismo sviluppato da Stalin nei confronti della Francia
ed il Regno Unito. Per il momento, Stalin aveva invece approvato il programma di
Molotov di provocare una guerra tra la Germania e le nazioni occidentali.
Infatti, un avvicinamento ai nazisti avrebbe concesso all'Armata Rossa il tempo
di cui aveva assolutamente bisogno per prepararsi a una forse inevitabile guerra
contro la Germania. L'esigenza di rimandare il più possibile il confronto era
dovuta al fatto che gli apparati governativi e l'Armata Rossa erano stati
indeboliti dai quattro processi indetti da Stalin negli ultimi tre anni per
eliminare le vecchie prominenze del comunismo sovietico (Grandi purghe). Per
quanto riguarda Hitler, questi era convinto che questo accordo avrebbe costretto
francesi e britannici a desistere dall'intento di difendere la Polonia. Il fin
troppo facile successo diplomatico raggiunto alla Conferenza di Monaco gli aveva
dato la falsa sicurezza che i suoi avversari fossero degli smidollati.
Spartizione territoriale tra Germania e Unione Sovietica che vede a sinistra la
suddivisione come sarebbe dovuta avvenire in base agli accordi, a destra la
spartizione effettivamente avvenuta; in blu il Reich tedesco; in celeste gli
obiettivi tedeschi, in arancione gli obiettivi sovietici; in rosso l'Unione
Sovietica: in realtà gli scopi militari di Hilter andavano ben oltre quelli
indicati dalle cartine, tanto che nel 1941 la Germania avrebbe aggredito
l'Unione Sovietica. Le negoziazioni riuscirono: concludendo un accordo
strategico tedesco-sovietico, Molotov, il 19 agosto propose anche un protocollo
aggiuntivo "che coprisse i punti sui quali i Partiti Contraenti erano
interessati, nel campo della politica estera". Il trattato veniva reso noto
all'opinione pubblica come un patto di non aggressione articolato in sette
articoli e della durata di dieci anni. Tuttavia, buona parte dell'Europa
orientale veniva segretamente divisa in due sfere d'influenza, una tedesca ed
una sovietica, come era previsto in un protocollo supplementare diviso in
quattro articoli:
Secondo il primo articolo il confine tra le due
sfere doveva coincidere con la frontiera settentrionale della Lituania, che
cadeva così nella zona di interesse tedesca. Questo significava
che Finlandia, Estonia e Lettonia, espressamente indicate nell'accordo, cadevano
nell'area sovietica.
Secondo il secondo articolo la Germania e l'Unione
Sovietica stabilivano le rispettive zone di interesse sul territorio della
Polonia nell'eventualità di un suo "riarrangiamento politico": le aree a est dei
fiumi Narew, Vistola e San rientravano nell'area di interesse sovietica, mentre
a quella tedesca spettava la parte ovest. Questa linea di confine si trovava
poco più ad ovest della linea Curzon. La questione se la sopravvivenza di uno
stato polacco fosse "desiderata" o meno veniva in teoria lasciata in sospeso:
secondo il testo, dovevano essere attesi gli sviluppi politici successivi.
Secondo il terzo articolo la Germania dichiarava
il suo disinteresse nei confronti della Bessarabia.
Secondo il quarto articolo le due potenze
promettevano la segretezza di questo documento aggiuntivo.
Dati gli enormi conflitti di potere tra sovietici
e tedeschi, era chiaro ad entrambe le parti che l'accordo stipulato non sarebbe
stato rispettato troppo a lungo. Basti pensare ai piani hitleriani di espansione
in Europa orientale, la sua teoria di unLebensraum (ossia la ricerca di uno
spazio vitale per il popolo che secondo Hitler era giudicato il più forte). Già
il 22 agosto, prima della conclusione del patto, Hitler aveva dichiarato: (DE)
« Ich brauche die Ukraine, damit man uns nicht wieder wie im letzten Krieg
aushungert. » (IT) «Ho bisogno dell'Ucraina, altrimenti ci faranno morire di
fame come durante la guerra passata. » (Adolf Hitler)
Il controllo dell'Ucraina, detta "granaio
d'Europa", avrebbe assicurato le risorse economiche nel confronto con qualsiasi
avversario. Mussolini, non ancora preparato al conflitto, tentò all'ultimo
momento di evitare un confronto immediato proponendo per la seconda volta una
conferenza a livello europeo, simile quella di Monaco. Stavolta, però, francesi
ed inglesi non reagirono concretamente all'iniziativa. Il Duce dichiarò a Hitler
che l'Italia sarebbe entrata in guerra soltanto in seguito; nonostante una certa
perplessità, quest'ultimo era deciso a procedere anche senza l'apporto italiano
per concludere le operazioni prima dei rigori invernali. Il mondo dei paesi
democratici reagì con sorpresa e disappunto alla notizia del patto giacché,
nonostante la segretezza dell'appendice, la pubblicazione del patto di non
aggressione fu interpretata con pessimismo: si prospettava un ridimensionamento
o una spartizione della Polonia, eventi che con tutta probabilità avrebbero
provocato una guerra. Il 1º settembre, solo una settimana dopo che il patto era
stato firmato, la divisione ebbe inizio con l'invasione tedesca, giustificata da
un pretesto (il cosiddetto incidente di Gleiwitz: una messa in scena posta in
essere da soldati tedeschi camuffati con un'uniforme polacca che attaccarono una
stazione radio in territorio tedesco). A sua volta, l'Unione Sovietica attaccò
da est il 17 settembre, senza prendere in considerazione il Patto di non
aggressione sovietico-polacco concluso sette anni prima. Dopo l'inizio delle
operazioni militari contro la Polonia, la costernazione non accennava a
diminuire, sia tra i governi che più di tutti avevano temuto un simile
risultato, sia tra i tanti sostenitori del comunismo, molti dei quali trovavano
incomprensibile che i sovietici fossero scesi a patti con il nemico ideologico
nazista. Una famosa vignetta di David Low apparsa sul London Evening
Standard del 20 settembre 1939 mostrava Hitler e Stalin scambiarsi un inchino
sopra il cadavere della Polonia, con Hitler che diceva: "La feccia della Terra,
suppongo?" mentre Stalin replicava "Il sanguinario assassino dei lavoratori,
presumo?". La stampa italiana, controllata dal regime, reagiva invece in maniera
positiva: Il Corriere della Sera del 24 agosto parlava di uno "splendido
successo" delle potenze dell'Asse, non mancando di attaccare la politica di
Regno Unito e Francia. Il 28 settembre 1939 i tre deboli Stati baltici non
ebbero altra scelta che firmare un cosiddetto patto di assistenza e mutua
difesa, che permetteva all'Unione Sovietica di far stazionare delle truppe
in Estonia, Lettonia e Lituania; lo stesso giorno un protocollo supplementare
tedesco-sovietico trasferiva gran parte della Lituania dalla prevista sfera
d'influenza tedesca a quella sovietica. La Finlandia resistette a simili pretese
(non volle accettare nemmeno uno scambio di territori con l'URSS a lei
favorevole in termini di estensione) e venne per questo attaccata dall'URSS il
30 novembre. Comunque, le truppe finlandesi, pur enormemente inferiori sul piano
numerico, erano molto motivate e perfettamente attrezzate per un confronto
militare durante la stagione invernale. Dopo più di tre mesi di aspri
combattimenti e pesanti perdite da parte sovietica nella seguente guerra
d'inverno, l'Unione Sovietica desistette dal suo intento di occupare ed
annettersi l'intera Finlandia, in cambio di circa il 10% del territorio
finlandese (la Carelia), gran parte del quale era ancora nelle mani
dell'esercito finnico (questa cessione sarebbe rimasta definitiva). Nel
giugno 1940 i tre stati baltici subirono l'occupazione e la successiva
annessione da parte dell'Unione Sovietica. Il 26 giugno 1940 i sovietici posero
un ultimatum alla Romania per la cessione della Bessarabia e della parte
settentrionale della Bucovina: la richiesta sovietica della Bucovina
Settentrionale, un territorio mai appartenuto alla Russia che i tedeschi
consideravano mitteleuropeo e che non era stato preso in considerazione nei
protocolli del patto di non aggressione, fu una sorpresa non solo per la
Romania, ma anche per il Terzo Reich. Senza l'appoggio dei suoi tradizionali
alleati, Regno Unito e Francia, Bucarest cedette i territori richiesti, ma da
parte sovietica vi fu il mancato rispetto dei patti: i militari rumeni in
ripiegamento verso il nuovo confine nei tempi e nei modi concordati furono
attaccati proditoriamente, anche con lancio di paracadutisti, dall'Armata Rossa.
I soldati sovietici aprirono il fuoco non solo contro i militari rumeni, ma
anche contro masse di civili in fuga verso la Romania (si ricordi in merito
il massacro di Fântâna Albă). Non paghe, le forze armate sovietiche invasero
anche il territorio di Herța, con una maggioranza di popolazione rumena pari a
circa il 95% del totale, che non era stato menzionato dall'ultimatum sovietico e
che apparteneva alla Romania in epoca anteriore allo scoppio della prima guerra
mondiale. Per ritornare alla Polonia, lo stato in fondo maggiormente citato
negli accordi segreti, la politica di occupazione tedesca era sin dall'inizio
orientata verso la creazione di uno spazio vitale per i tedeschi e lo sterminio
degli ebrei. Dato che la teoria nazista delle razze era difficile da estendere
ai popoli slavi, era intenzione di Hitler quella di mostrare la differenza tra
tedeschi e polacchi con particolare chiarezza, adottando speciali misure. Ad
esempio, una parte dei bambini polacchi era destinata alla deportazione nella
parte originaria dell'impero tedesco per svolgere le mansioni più umili. La
Polonia doveva invece essere germanizzata grazie a due provvedimenti: da una
parte era previsto l'insediamento di tedeschi fino ad allora residenti in
Germania e nei Paesi Baltici; dall'altra, la cultura polacca doveva essere
sostituita da quella germanica. Non diversamente i sovietici miravano a
cancellare il "mito" della nazione polacca e decidevano lo sterminio degli
ufficiali polacchi che si erano loro consegnati per sfuggire alla cattura da
parte dei nazisti: questa decisione era maturata nella consapevolezza che i
laureati polacchi al momento dell'arruolamento assumevano automaticamente il
grado di ufficiale. Per l'inizio del 1941, gli imperi di Germania e Unione
Sovietica condividevano un confine che passava attraverso le odierne Lituania e
Polonia. Subito dopo, le relazioni tedesco-sovietiche iniziarono a raffreddarsi
e lo scontro tra lo Stato nazista e quello comunista sembrò sempre più
inevitabile: esso si sarebbe poi concretizzato con l'inizio dell'operazione
Barbarossa (22 giugno 1941). La Germania ruppe il patto due anni dopo che era
stato stipulato invadendo l'Unione Sovietica il 22 giugno 1941: come anticipato
poc'anzi, quest'azione bellica venne chiamata "operazione Barbarossa". Nel giro
di settimane, l'aggressione tedesca venne imitata da una ripresa delle ostilità
da parte della Finlandia, il 26 giugno, che iniziava la cosiddetta guerra di
continuazione contro l'Unione Sovietica: se il paese scandinavo aveva riscosso
simpatie a livello mondiale per le operazioni militari dell'inverno 1939-40, la
decisione finlandese di riprendere le ostilità contro Stalin al fianco di Hitler
fu criticata dalle potenze occidentali che erano nel frattempo diventate alleate
dell'URSS. La Germania nazista trovava nella Finlandia, retta da un governo
democratico, un importante alleato per stabilizzare il fianco settentrionale del
suo schieramento e minacciare anche da nord Leningrado. La conseguenza più
immediata del patto fu senz'altro l'occupazione tedesca e sovietica della
Polonia (che quanto alla circostanza aveva affrontato precedenti storici
settecenteschi, vedi spartizione della Polonia). La divisione riguardava anche
i Paesi Baltici: questi ultimi, entrati alla fine nella sfera di potere
sovietica, non riuscirono più a ritrovare la loro indipendenza neppure a
conflitto terminato, dovendo invece attendere fino al 1991. Nonostante le
previsioni di Hitler, il fatto sigillò definitivamente la fine della politica
dell'Appeasement: Hitler dovette rendersi conto che le potenze occidentali non
erano più intenzionate ad assistere passivamente all'espansione del Terzo Reich.
Dopo l'occupazione della Polonia, Regno Unito e Francia erano ormai in guerra
contro la Germania per dare vita al conflitto che più tardi sarebbe stato
chiamato seconda guerra mondiale. Si trattava di un confronto drammatico, ma di
un evento dalla portata non ancora mondiale: per il momento le due potenze
vicine all'Europa, gli USA e l'URSS, ne rimanevano fuori. Era quella che Winston
Churchill chiamò twilight war (guerra del crepuscolo). Stalin trasse profitto
dal patto. Per lui veniva rimandata l'eventualità di ritrovarsi coinvolto in una
guerra su due fronti contro il Giappone e la Germania. Ottenne una "pausa di
respiro" di due anni per riorganizzare le strutture sovietiche in attesa del
confronto militare con la Germania, cui non era ancora preparato[10]. Peraltro
il tempo a disposizione, a causa della confusione e disorganizzazione
dell'Armata Rossa e di alcune scelte sbagliate dei dirigenti sovietici, non
produsse i risultati sperati e il 22 giugno 1941 l'Unione Sovietica venne colta
di sorpresa dall'attacco e subì una serie di pesanti disfatte. Inoltre
l'innaturale accordo con il nemico ideologico nazista e la passiva adesione agli
ordini di Stalin dei dirigenti sovietici e dei partiti comunisti europei diffuse
incertezza e inquietudine tra i militanti. Sempre a proposito dei vantaggi di
cui godette Stalin, va aggiunto che la sua sfera di interessi, dopo il confronto
militare con la Germania, non sarebbe più stata messa seriamente in discussione
(eccezion fatta per la Finlandia). Quindi, il paesi baltici e la parte orientale
dello stato polacco sarebbero stati inglobati nell'Unione
Sovietica. La Romania vedrà divisa una regione molto importante per la sua
storia come la Moldavia in due entità territoriali sotto due stati diversi
(quello orientale diventerà infatti sovietico). Questo darà inizio anche ad un
progressivo allontanamento culturale tra le genti delle due zone. Dal punto di
vista di Hitler l'accordo fu un successo: grazie alla sicurezza acquisita sulle
frontiere orientali, la Germania evitò momentaneamente una disastrosa guerra su
due fronti e poté schierare la massa delle sue forze all'ovest, guadagnando un
predominio decisivo in Europa. Ottenuti questi risultati, Hitler, pur avendo
ceduto temporaneamente ai sovietici importanti posizioni strategiche, poté nel
giugno 1941 riversare all'est tutto il peso della Wehrmacht, divenuta ora molto
più potente ed esperta del 1939, con il sostegno politico-economico di gran
parte dell'Europa, assoggettata o alleata con il Terzo Reich.
Peggio Stalin o Hitler?
Scrive Arrigo Petacco. L'anniversario della morte di Giuseppe Stalin — 50 anni
fa, il 5 marzo 1953, quando il dittatore aveva 73 anni — oltre a consentire ai
pochi e malinconici nostalgici del culto della personalità di levare suffragi
alla memoria del «grande e amato capo del popolo lavoratore» come lo definivano
con reverenza Togliatti e i suoi seguaci, ha anche riaperto il gioco della
comparazione. Chi era più criminale, chi ne ha ammazzati di più, chi si merita
di finire più in giù dell'altro nelle profondità dell'inferno: Hitler o Stalin?
Io me ne guarderò bene dal dare una risposta perché non sarà certo la cinica
conta dei milioni di cadaveri, a stabilire il primato fra i due principali
protagonisti negativi del secolo scorso. Non ho invece la minima esitazione a
indicare il più ipocrita: l'Oscar della doppiezza spetta a Giuseppe Stalin.
Hitler, a modo suo, era sincero. Non ha mai tenuto nascosta la sua volontà di
sopraffare, il suo razzismo sanguinario. Da quando pubblicò il Mein Kampf nel
1921, il futuro Fuhrer non ha mai fatto mistero dei suoi infernali progetti e
chi aderì al suo movimento sapeva di entrare a far parte di una congrega di
malfattori. Stalin invece ingannò per decenni il suo e altri popoli promettendo
il Paradiso in terra per i lavoratori di tutto il mondo e realizzando invece un
sistema infernale che dovunque è stato applicato ha prodotto soltanto miseria,
fame, ingiustizia e morte. Ancora oggi a 50 anni dalla morte di Stalin e a 10
dall'implosione epocale dell'Unione Sovietica, c'è qualcuno (soprattutto sui
libri di scuola, purtroppo) che si ostina a «salvare» la memoria di Stalin
ammettendo certi suoi errori più o meno gravi ma sottolineando che a lui si deve
l'industrializzazione dell'Unione Sovietica e soprattutto la vittoria delle
democrazie occidentali nella seconda guerra mondiale. Ora, a parte il fatto che
lo sviluppo industriale dell'Unione Sovietica costò un tale prezzo di sangue che
fa ancora inorridire, è sullo Stalin salvatore delle democrazie che vorrei
soffermarmi. Stalin infatti non salvò affatto le democrazie occidentali dalla
minaccia nazista ma al contrario ne fu salvato. Molti ancora oggi non sanno o
non amano ricordare che nei primi due anni del secondo conflitto mondiale
l'Unione Sovietica fu alleata e complice della Germania nazista. Dall'agosto del
1939, quando firmò il patto di amicizia con Hitler, al giugno del 1941 quando
con l'«operazione Barbarossa» le armate naziste aggredirono l'Unione Sovietica a
tradimento, Stalin aveva sempre aiutato l'«amico» di Berlino a realizzare i suoi
piani di conquista. Con Hitler Stalin si spartì la sventurata Polonia, d'accordo
con Hitler si impadronì della Bessarabia, dei tre paesi baltici (Estonia,
Lituania, Lettonia) e cercò infine di piegare la resistenza degli eroici
finlandesi. Non solo: anche quando la svastica sventolava ormai su tutte le
capitali europee e l'Inghilterra sembrava ridotta al lumicino, Stalin continuò
volenterosamente a rifornire di materie prime le industrie belliche tedesche e
continuò anche quando, alla vigilia dell'aggressione, la Germania aveva
improvvisamente congelato i propri rifornimenti verso l'Urss. Il 21 giugno 1941,
l'inizio di «Barbarossa» fu ritardato di alcune ore per consentire a un treno
sovietico carico di preziosa gomma, di oltrepassare il confine russo-tedesco.
Poi come è noto le divisioni corazzate germaniche penetrarono in Russia «come
una baionetta in un pane di burro». Se Hitler non avesse calcolato male i tempi
e se le democrazie occidentali e soprattutto gli Stati Uniti con i loro convogli
artici non avessero rimpinguato di armi e di mezzi l'esauste risorse sovietiche,
difficilmente l'Armata rossa avrebbe trovato la forza di reagire. L'imputazione
quasi giudiziaria che oggi grava su Stalin è quella della smisurata falcidia di
vite umane. In questo, milione più milione meno egli eguaglia certamente Hitler
ma con una differenza. Salvo il colonnello Roehm, che fece uccidere nella famosa
«notte dei lunghi coltelli» perché gli insidiava il potere, Hitler fu leale e
collaborativo con tutti i suoi principali gerarchi. Stalin invece, tutto
istinto, rozzezza, crudeltà, passionalità vendicativa, in nome di un idilliaco
paradiso socialista che non arrivava mai, portò milioni di individui a morte,
comprese schiere di comunisti sinceri che credevano ciecamente in lui. L'immane
carneficina cominciò subito dopo la sua conquista del potere. Liquidò per primi
gli altri membri della «cinquina» dei possibili eredi nominati nel famoso
testamento di Lenin fra i quali forse non a caso lui era collocato all'ultimo
posto (Trotzcky, Bucharin, Kamenev, Zinoviev e Stalin) poi liquidò il 95% dei
componenti del comitato centrale, quindi il 90% dello stato maggiore dell'Armata
rossa con in testa il famoso maresciallo Tukacewsky; e il tragico balletto delle
cifre potrebbe continuare a lungo. Ancora alla vigilia della sua morte, Stalin
aveva appena avviato «il caso dei medici» prologo di una nuova purga che puntava
a eliminare tutti i suoi possibili concorrenti e in particolare l'altro genio
del male Laurenti Beria il quale, secondo alcune ipotesi, avrebbe giocato
d'anticipo affrettando la fine del dittatore. Oggi il mito di Stalin è ancora
vivo e sopravviverà a lungo. Non c'è dubbio infatti che l'uomo ha lasciato una
profonda impronta nella storia del mondo. Ancora a lungo storici e studiosi si
affanneranno per studiare la complessa psiche di questo personaggio che fu
certamente l'uomo più amato e più odiato della storia. Continueranno anche a
cercare di individuare la molla segreta che fece scattare nel rozzo
ex-seminarista di Tbilisi la sua inarrestabile volontà di potenza. Fra le
ipotesi finora avanzate ne sono emerse anche di singolari. L'ultima, più
curiosa, addebita il temperamento di Stalin alla sua statura. Il «piccolo padre»
era infatti piccolo di nome e di fatto. Misurava appena un metro e
cinquantotto.
IN QUESTO MONDO DI LADRI.
In Questo Mondo Di Ladri di
Antonello Venditti.
Eh, in questo mondo di ladri
C' ancora un gruppo di amici
Che non si arrendono mai.
Eh, in questo mondo di santi
Il nostro cuore rapito
Da mille profeti e da quattro
cantanti.
Noi, noi stiamo bene tra noi
E ci fidiamo di noi.
In questo mondo di ladri,
In questo mondo di eroi,
Non siamo molto importanti
Ma puoi venire con noi.
Eh, in questo mondo di debiti
Viviamo solo di scandali
E ci sposiamo le vergini.
Eh, e disprezziamo i politici,
E ci arrabbiamo, preghiamo,
gridiamo,
Piangiamo e poi leggiamo gli
oroscopi.
Voi, vi divertite con noi
E vi rubate tra voi.
In questo mondo di ladri,
In questo mondo di eroi,
Voi siete molto importanti
Ma questa festa per noi.
Eh, ma questo mondo di santi
Se il nostro cuore rapito
Da mille profeti e da quattro
cantanti.
Noi, noi stiamo bene tra noi
E ci fidiamo di noi.
In questo mondo... in questo
mondo di ladri...
In questo mondo... in questo
mondo di ladri...
In questo mondo... in questo
mondo di ladri...
Le persone perbene non
riescono a fare carriera all’interno della pubblica amministrazione.
Un giudizio lapidario che viene dal presidente dell’Autorità nazionale
anticorruzione Raffaele Cantone, scrive “Blitz Quotidiano” il 28 ottobre 2015.
Un giudizio appena mitigato dai due minuti di spiegazione dell’affermazione:
Cantone spiega che, a volte, questo avviene anche per colpe dei diretti
interessati. “Spesso le persone perbene all’interno della pubblica
amministrazione sono quelle che hanno meno possibilità di fare – dice Cantone –
Spesso fanno meno carriera. Spesso sono meno responsabilizzati perché
considerati per bene”. Secondo Cantone è ora di recuperare parole che non si
usano nel nostro mondo del lavoro. Una è la parola “controllo”. E il presidente
dell’anticorruzione si riferisce a chi osserva i colleghi timbrare il cartellino
e poi lasciare il posto di lavoro senza denunciare nulla. Quello che serve,
secondo Cantone, è una “riscossa interna” e un recupero non imposto dall’alto di
moralità e cultura dello Stato, il terzo settore e di conseguenza il nostro
Paese si salveranno dalla mala gestione della cosa pubblica.
Commenti disabilitati su
Cantone: “Non sono tutti fannulloni ma nella Pubblica amministrazione, le
persone perbene hanno meno possibilità”,
scrive Antonio Menna il 28 ottobre 2015 su “Italia Ora”. “Non sono tutti
fannulloni nella Pubblica amministrazione. Meno che mai sono tutti corrotti. Ma
è vero che le persone perbene sono quelli che vengono meno coinvolti nelle
scelte, meno responsabilizzati. Sono quelli che hanno meno possibilità di fare
carriera”. Lo dice chiaro e tondo, Raffaele Cantone, magistrato anticamorra, e
presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione. Lo dice nel corso di una
intervista pubblica al Sermig di Torino e il segmento sulla corruzione nella
pubblica amministrazione (rilanciato da un video del Corriere della Sera) è
quello che impressiona di più. Quante volte lo abbiamo pensato che essere onesti
è una penalizzazione? Chi è onesto non va lontano. “A volte, però”, chiarisce
Cantone, “anche per sue responsabilità. Dobbiamo trovare il coraggio di
ripristinare alcune parole che nel nostro lessico si sono dimenticate: la parola
controllo, per esempio. Se il mio amico, vicino di stanza, usa il badge per
coprire i colleghi che magari sono in vacanza, devo stare zitto? Perché devo
stare zitto? Queste apparenti distrazioni sono complicità. La società dei
piccoli favori, magari banali, magari che non portano necessariamente alla
corruzione, ci abitua all’idea che ci sia uno spazio dove tutto si può
comprare.” “Il problema – conclude Cantone – non è solo la disonestà ma, a
volte, anche non capire con chi parlare. Ci sono cento centri di costo solo
nella città di Roma, cento uffici che fanno appalti e spesa. Come li controlli?
La deresponsabilizzazione la fa da padrona, ed è essa stessa una delle ragioni
che giustifica la corruzione.”
In Italia si fa carriera solo se si è ricattabili,
scrive il 5 giugno 2015 Claudio Rossi su "L'Uomo qualunque".
“Il nostro Paese sta sprofondando nel conformismo (…) siamo usciti da una
consultazione elettorale che ha dato il risultato a tutti noto, ma la cosa che
colpisce è questo saltare sul carro del vincitore. Tacito diceva che una delle
abitudini degli italiani è di ruere in servitium: pensate che immagine potente,
correre ad asservirsi al carro del vincitore. Noi tutti conosciamo persone
appartenenti al partito che ha vinto le elezioni che hanno opinioni diverse
rispetto ai vertici di questo partito. Ora non si tratta affatto di prendere
posizioni che distruggono l’unità del partito, ma di manifestare liberamente le
proprie opinioni senza incorrere nell’anatema dei vertici di questo partito (…)
Queste persone, dopo il risultato elettorale, hanno tirato i remi in barca e le
idee che avevano prima, oggi non le professano più. Danno prova di conformismo.
(…) La nostra rappresentanza politica è quella che è (…) La diffusione della
corruzione è diventata il vero humus della nostra vita politica, è diventata una
sorta di costituzione materiale. Qualcuno, il cui nome faccio solo in privato,
ha detto che nel nostro Paese si fa carriera in politica, nel mondo della
finanza e dell’impresa, solo se si è ricattabili (…) Questo meccanismo della
costituzione materiale, basato sulla corruzione, si fonda su uno scambio, un
sistema in cui i deboli, cioè quelli che hanno bisogno di lavoro e
protezione, gli umili della società, promettono fedeltà ai potenti in cambio di
protezione. È un meccanismo omnipervasivo che raggiunge il culmine nei casi
della criminalità organizzata mafiosa, ma che possiamo constatare nella nostra
vita quotidiana (…) Questo meccanismo funziona nelle società diseguali, in cui
c’è qualcuno che conta e che può, e qualcuno che non può e per avere qualcosa
deve vendere la sua fedeltà, l’unica cosa che può dare in cambio (…) Quando
Marco Travaglio racconta dei casi di pregiudicati o galeotti che ottengono 40
mila preferenze non è perché gli elettori sono stupidi: sanno perfettamente
quello che fanno, ma devono restituire fedeltà. Facciamoci un esame di coscienza
e chiediamoci se anche noi non ne siamo invischiati in qualche misura. (…)
Questo meccanismo fedeltà-protezione si basa sulla violazione della legge. Se
vivessimo in un Paese in cui i diritti venissero garantiti come diritti e non
come favori, saremmo un paese di uomini e donne liberi. Ecco libertà e onestà.
Ecco perché dobbiamo chiedere che i diritti siano garantiti dal diritto, e non
serva prostituirsi per ottenere un diritto, ottenendolo come favore. Veniamo
all’autocoscienza: siamo sicuri di essere immuni dalla tentazione di entrare in
questo circolo? (…) Qualche tempo fa mi ha telefonato un collega di Sassari che
mi ha detto: “C’è una commissione a Cagliari che deve attribuire un posto di
ricercatore e i candidati sono tutti raccomandati tranne mia figlia. Sono venuto
a sapere che in commissione c’è un professore di Libertà e Giustizia…”. Io ero
molto in difficoltà, ma capite la capacità diffusiva di questo sistema di
corruzione, perché lì si trattava di ristabilire la par condicio tra candidati.
Questo per dire quanto sia difficile sgretolare questo meccanismo, che si basa
sulla violazione della legge. Siamo sicuri di esserne immuni? Ad esempio,
immaginate di avere un figlio con una grave malattia e che debba sottoporsi a un
esame clinico, ma per ottenere una Tac deve aspettare sei mesi. Se conosceste il
primario del reparto, vi asterreste dal chiedergli il favore di far passare
vostro figlio davanti a un altro? Io per mia fortuna non mi sono mai trovato in
questa condizione, ma se mi ci trovassi? È piccola, ma è corruzione, perché se
la cartella clinica di vostro figlio viene messa in cima alla pila, qualcuno che
avrebbe avuto diritto viene posposto. Questo discorso si ricollega al problema
del buon funzionamento della Pubblica amministrazione: se i servizi
funzionassero bene non servirebbe adottare meccanismi di questo genere. Viviamo
in un Paese che non affronta il problema della disonestà e onestà in termini
morali. (…) Se non ci risolleviamo da questo, avremo un Paese sempre più
clientelarizzato, dove i talenti non emergeranno perché emergeranno i
raccomandati, e questo disgusterà sempre di più i nostri figli e nipoti che
vogliono fare ma trovano le porte sbarrate da chi ha gli appoggi migliori. È una
questione di sopravvivenza e di rinascita civile del nostro Paese. Ora,
continuiamo a farci questo esame di coscienza: non siamo forse noi, in qualche
misura, conniventi con questo sistema? Quante volte abbiamo visto vicino a noi
accadere cose che rientrano in questo meccanismo e abbiamo taciuto? Qualche
tempo fa, si sono aperti un trentina di procedimenti penali a carico di colleghi
universitari per manipolazione dei concorsi universitari (…) Noi non sapevamo,
noi non conoscevamo i singoli episodi (…) e per di più non siamo stati parte
attiva del meccanismo, ma dobbiamo riconoscere che abbiamo taciuto, dobbiamo
riconoscere la nostra correità. Proposta: Libertà
e Giustizia è una associazione policentrica che si basa su circoli, che
sono associazioni nella associazione, radicati sul territorio e collegati alla
vita politica. Non sarebbe il caso che i circoli si attrezzassero per monitorare
questi episodi, avendo come alleati la stampa libera e la magistratura autonoma?
Potrebbe essere questa una nuova sfida per Libertà e Giustizia, controllare la
diffusione di questa piovra che ci invischia tutti, cominciando dal basso,
perché dall’alto non ci verrà nulla di buono, perché in alto si procede con quel
meccanismo che dobbiamo combattere.”
Gustavo Zagrebelsky.
“I cittadini silenziosi possono essere dei perfetti sudditi per
un governo autoritario, ma sono un disastro per una democrazia”.
Robert Alan Dahl
Il volume più letto dai politici? Un
manuale per ottenere l'immunità.
Alle Biblioteca delle Nazioni Unite non hanno più nemmeno una
copia. Spiega i vari tipi di immunità e chi può usufruire, scrive Gabriele
Bertocchi Venerdì, 08/01/2016, su “Il Giornale”. Non è un semplice libro, è
il libro che ogni politico dovrebbe leggere. E infatti è cosi, tutto lo
vogliono. È diventato il libro più richiesto alla biblioteca delle Nazioni
Unite. Vi starete chiedendo che volume è: magari se è un'opera di letteratura
classica, oppure un trattato sulla politica internazionale. Nessuno di questi,
si chiama "Immunità di capi e funzionari di Stato per crimini internazionali", è
uno scritto da Ramona Pedretti, ex studentessa dell’Università di Lucerna. È una
tesi di dottorato, un vademecum che spiega e illustra che tipo di immunità
esistono per tali soggetti. "Più che un libro è una star" commenta Maria
Montagna sulle pagine de La Stampa, una delle addette alla gestione banca dati
di Dag Hammarskjold Library, libreria dedicata al'ex segretario generale, alle
Nazioni Unite. "È senza dubbio il libro più richiesto del 2015, anche più di
classici della letteratura Onu o grandi dossier" continua l'addetta. Il
successo lo si deve anche a Twitter, infatti la Dag Hammarskjold Library ha
pubblicato il "primato" del libro, creando così un vero e prioprio cult da
leggere. Ma all'interno cosa si può imparare, come scrive la Pedretti, autrice
del volume, si può scoprire che esistono due dtipi di immunità: quella ratione
personae che mette i capi di stato al riparo dalla giurisdizione penale
straniera, e quella ratione materiae che protegge atti ufficiali e
funzionari che agiscono per conto dello Stato dal giudizio di tribunali di altri
Paesi. La Montagna spiega che "ora però la platea di lettori si è allargata
vista la pubblicità dei social", ma prima era perlopiù composta da
funzionari degli uffici legali e storici Onu, interessati in particolare alle
conclusioni tratte da Pedretti. La tesi è che capi o alti esponenti di Stato in
carica non possono essere perseguiti da corti straniere, al contrario degli ex.
E intanto, come si legge su La Stampa, arriva la conferma da parte della
libreria: "Mi spiace, al momento non abbiamo neanche una copia disponibile".
Va a ruba all’Onu il libro che insegna ai
leader come avere l’immunità.
Esaurito in biblioteca.
Tesi di laurea. Il pamphlet è stato scritto da Ramona Pedretti ex studentessa
dell’Università di Lucerna, scrive Francesco Semprini su “La Stampa” l’8 gennaio
2016. Basta entrare nella biblioteca delle Nazioni Unite e menzionare il nome
del libro per capire che non stiamo parlando di un volume qualunque. Maria
Montagna, una delle addette alla gestione della banca data di Dag Hammarskjold
Library - la libreria dedicata all’ex segretario generale - guarda la collega
Ariel Lebowitz e sorride. «Più che un libro è una star - dice - aspetti qui,
controlliamo subito». L’opera in questione è «Immunità di capi e funzionari di
Stato per crimini internazionali», un pamphlet scritto da Ramona Pedretti, ex
studentessa oriunda dell’Università di Lucerna. È una tesi di dottorato, un
vademecum per capire che tipo di immunità esistono per tali soggetti. Ne
esistono due, come spiega Pedretti nel suo scritto, quella ratione personae che
mette i capi di stato al riparo dalla giurisdizione penale straniera, e quella
ratione materiae che protegge atti ufficiali e funzionari che agiscono per conto
dello Stato dal giudizio di tribunali di altri Paesi. «È senza dubbio il libro
più richiesto del 2015, anche più di classici della letteratura Onu o grandi
dossier», dice Maria. Twitter ha fatto il resto, visto che Dag Hammarskjold
Library ha rilanciato sul social network il «primato» del libro moltiplicandone
notorietà e richieste. Ma chi lo chiede in prestito? All’inizio erano
soprattutto funzionari degli uffici legali e storici Onu, interessati in
particolare alle conclusioni tratte da Pedretti. La tesi dell’autrice è che capi
o alti esponenti di Stato in carica non possono essere perseguiti da corti
straniere, al contrario degli ex. È questo il principio ad esempio che ha
portato all’arresto di Adolph Eichmann da parte di Israele e Augusto Pinochet
dalla Spagna. «Ora però la platea di lettori si è allargata vista la pubblicità
dei social», chiosa Maria. E arriva la conferma: «Mi spiace, al momento non
abbiamo neanche una copia disponibile».
Fondazioni, i soldi nascosti dei
politici. Finanziamenti milionari anonimi. Intrecci
con banchieri, costruttori e petrolieri. Società fantasma. Da Renzi a Gasparri,
da Alfano ad Alemanno, ecco cosa c'è nei conti delle fondazioni, scrivono Paolo
Biondani, Lorenzo Bagnoli e Gianluca De Feo il 7 gennaio 2016 su “L’Espresso”.
Finanziamenti milionari ma anonimi. Un intreccio tra ministri, petrolieri,
banchieri e imprenditori. Con una lunga inchiesta nel numero in edicola
“L'Espresso” ha esaminato i documenti ufficiali delle fondazioni che fanno capo
ai leader politici, da Renzi a Gasparri, da Alfano a Quagliarello, tutte
dominate dall'assenza di trasparenza. Nel consiglio direttivo di Open, il
pensatoio-cassaforte del premier, siedono l’amico che ne è presidente Alberto
Bianchi, ora consigliere dell’Enel, il sottosegretario Luca Lotti, il braccio
destro Marco Carrai e il ministro Maria Elena Boschi. Il sito pubblica centinaia
di nomi di finanziatori, ma omette «i dati delle persone fisiche che non lo
hanno autorizzato esplicitamente». Il patrimonio iniziale di 20 mila euro,
stanziato dai fondatori, si è moltiplicato di 140 volte con i contributi
successivi: in totale, 2 milioni e 803 mila euro. Sul sito compaiono solo tre
sostenitori sopra quota centomila: il finanziere Davide Serra (175), il defunto
imprenditore Guido Ghisolfi (125) e la British American Tobacco (100 mila).
Molto inferiori le somme versate da politici come Lotti (9.600), Boschi (8.800)
o il nuovo manager della Rai, Antonio Campo Dell’Orto (solo 250 euro). Ma un
terzo dei finanziatori sono anonimi per un importo di 934 mila euro. Ad Angelino
Alfano invece fa oggi capo la storica fondazione intitolata ad Alcide De
Gasperi, che ha «espresso il suo dissenso» alla richiesta ufficiale della
prefettura di far esaminare i bilanci: per una fondazione presieduta dal
ministro dell’Interno, la trasparenza non esiste. Nell’attuale direttivo
compaiono anche Fouad Makhzoumi, l’uomo più ricco del Libano, titolare del
colosso del gas Future Pipes Industries. Tra gli italiani, Vito Bonsignore, l’ex
politico che dopo una condanna per tangenti è diventato un ricco uomo d’affari;
il banchiere Giovanni Bazoli, il marchese Alvise Di Canossa, il manager Carlo
Secchi, l’ex dc Giuseppe Zamberletti, l’ex presidente della Compagnia delle
Opere Raffaello Vignali, l’avvocato Sergio Gemma e il professor Mauro Ronco. Ma
tutti i contributi alla causa di Alfano sono top secret. Invece la fondazione
Magna Carta è stata costituita dal suo presidente, Gaetano Quagliariello, da un
altro politico, Giuseppe Calderisi, e da un banchiere di Arezzo, Giuseppe
Morbidelli, ora numero uno della Cassa di risparmio di Firenze. Gli altri
fondatori sono tre società: l’assicurazione Sai-Fondiaria, impersonata da Fausto
Rapisarda che rappresenta Jonella Ligresti; la Erg Petroli dei fratelli Garrone;
e la cooperativa Nuova Editoriale di Enrico Luca Biagiotti, uomo d’affari legato
a Denis Verdini. Il capitale iniziale di 300 mila euro è stato interamente
«versato dalle tre società in quote uguali». I politici non ci hanno messo un
soldo, ma la dirigono insieme ai finanziatori. Nel 2013 i Ligresti escono dal
consiglio, dove intanto è entrata Gina Nieri, manager di Mediaset. L’ultimo
verbale (giugno 2015) riconferma l’attrazione verso le assicurazioni, con il
manager Fabio Cerchiai, e il petrolio, con Garrone e il nuovo consigliere
Gianmarco Moratti. La fondazione pubblica i bilanci, ma non rivela chi l’ha
sostenuta: in soli due anni, un milione di finanziamenti anonimi. La Nuova
Italia di Gianni Alemanno invece non esiste più. “L’Espresso” ha scoperto che il
23 novembre scorso la prefettura di Roma ne ha decretato lo scioglimento: «la
fondazione nell’ultimo anno non ha svolto alcuna attività», tanto che «le
raccomandate inviate dalla prefettura alla sede legale e all’indirizzo del
presidente sono tornate al mittente con la dicitura sconosciuto». Ai tempi d’oro
della destra romana sembrava un ascensore per il potere: dei 13 soci promotori,
tutti legati all’ex Msi o An, almeno nove hanno ottenuto incarichi dal ministero
dell’agricoltura o dal comune capitolino. All’inizio Gianni Alemanno e sua
moglie Isabella Rauti figurano solo nel listone dei 449 «aderenti» chiamati a
versare «contributi in denaro». I primi soci sborsano il capitale iniziale di
250 mila euro. Tra gli iscritti compaiono tutti i fedelissimi poi indagati o
arrestati, come Franco Panzironi, segretario e gestore, Riccardo Mancini,
Fabrizio Testa, Franco Fiorito e altri. La “Fondazione della libertà per il bene
comune” è stata creata dal senatore ed ex ministro Altero Matteoli assieme ad
altre dieci persone, tra cui politici di destra come Guglielmo Rositani (ex
parlamentare e consigliere Rai), Eugenio Minasso, Marco Martinelli e Marcello De
Angelis. A procurare i primi 120 mila euro, però, sono anche soci in teoria
estranei alla politica, come l’ex consigliere dell’Anas Giovan Battista Papello
(15 mila), il professor Roberto Serrentino (10 mila) e l'imprenditore, Erasmo
Cinque, che versa 20 mila euro come Matteoli. La fondazione, gestita dal
tesoriere Papello, pubblica i bilanci: tra il 2010 e il 2011, in particolare,
dichiara di aver incassato 374 mila euro dai «soci fondatori», altri 124 mila di
«contributi liberali» e solo duemila dalle proprie attività (convegni e
pubblicazioni). Gli atti della prefettura però non spiegano quali benefattori li
abbiano versati. Espressione di Massimo D'Alema, ItalianiEuropei nel 1999 è
stata una delle prime fondazioni. I fondatori sono l'ex premier Giuliano Amato,
il costruttore romano Alfio Marchini, il presidente della Lega Cooperative,
Ivano Barberini, e il finanziere esperto in derivati Leonello Clementi. Il
capitale iniziale è di un miliardo di lire (517 mila euro), quasi totalmente
versati da aziende o uomini d’affari: 600 milioni di lire da varie associazioni
di cooperative rosse, 50 ciascuno da multinazionali come Abb ed Ericsson, la
Pirelli di Tronchetti Provera, l’industriale farmaceutico Claudio Cavazza, oltre
che da Marchini (50) e Clementi (55). ItalianiEuropei deposita regolari bilanci
e ha autorizzato la prefettura di Roma a mostrarli. L’ultimo è del 2013. Gli
atti identificano solo i finanziatori iniziali del 1998. A quei 517 mila euro,
però, se ne sono aggiunti altri 649 mila sborsati da «nuovi soci», non
precisati. Nei bilanci inoltre compare una diversa categoria di «contributi alle
attività» o «per l’esercizio»: in totale in sei anni i finanziamenti ammontano a
un milione e 912 mila euro. Italia Protagonista nasce nel 2010 per volontà di
due leader della destra: Maurizio Gasparri, presidente, e Ignazio La Russa,
vicepresidente. Tra i fondatori, che versano 7 mila euro ciascuno, c’è un
ristretto gruppo di politici e collaboratori, ma anche un manager, Antonio
Giordano. Dopo la fine di An, però, La Russa e i suoi uomini escono e la
fondazione resta un feudo dell’ex ministro Gasparri. Come direttore compare un
missionario della confraternita che s’ispira al beato La Salle, Amilcare
Boccuccia, e come vice un suo confratello spagnolo. Tra i soci viene ammesso
anche Alvaro Rodriguez Echeverria, esperto e uditore del sinodo 2012 in
Vaticano, nonché fratello dell’ex presidente del Costarica. L’ultimo bilancio
riguarda il 2013, quando il capitale, dai 100 mila euro iniziali, è ormai salito
a 231 mila. Le donazioni di quell’anno, 56 mila euro, non sono bastate a coprire
le spese, con perdite finali per 63 mila, però in banca ci sono 156 mila euro di
liquidità. Ma sui nomi dei benefattori, zero informazioni. «Quello che è
assolutamente inaccettabile è l’assenza di una regolamentazione che quanto meno
adegui le fondazioni alle regole dei partiti politici», dichiara
Raffaele Cantone a “l'Espresso” :
«Fermo restando che la riforma Letta sulla pubblicità ai partiti si è rivelata
inadeguata, perché il sistema delle verifiche è assolutamente ridicolo, ma
almeno ha introdotto un meccanismo di controllo. Sulle fondazioni invece c’è
totale anarchia: non si possono conoscere entrate e uscite, non c’é trasparenza
sui finanziatori».
«Non si possono conoscere entrate e uscite, non
c’é trasparenza sui finanziatori. I conti delle fondazioni possono essere fatti
in modo semplicistico e semplificato, senza rendere noto come arrivano i soldi e
come vengono spesi», scrive Gianluca De Feo il 7 gennaio 2016 su "L'Espresso".
«È una situazione che ha raggiunto i limiti dell’indecenza». Un anno fa Raffaele
Cantone fu il primo a lanciare l’allarme sui fondi opachi trasferiti alla
politica attraverso le fondazioni. Con un’intervista a “l’Espresso” il
presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione sottolineò il problema della
carenza di controlli. Negli ultimi mesi le indagini hanno poi evidenziato altri
sospetti sui soldi passati attraverso questi canali per finanziare l’attività
dei partiti.
Raffaele Cantone, ma
da allora è cambiato qualcosa?
«Non è cambiato nulla. Ma questo più che un
finanziamento ai partiti è un modo di sovvenzionare gruppi interni ai partiti,
quelle che un tempo si chiamavano correnti. Nel tempo le correnti si sono
organizzate in realtà di tipo associativo: questa scelta potrebbe essere
positiva, perché in qualche modo dà una struttura evidente alle correnti. Quello
che è assolutamente inaccettabile è l’assenza di una regolamentazione che quanto
meno adegui le fondazioni alle regole dei partiti politici. Fermo restando che
la riforma Letta sulla pubblicità ai partiti si è rivelata inadeguata, perché il
sistema delle verifiche è assolutamente ridicolo, ma almeno ha introdotto un
meccanismo di controllo. Sulle fondazioni invece c’è totale anarchia. Viene
previsto solo il controllo formale e generico delle prefetture, che non hanno
capacità di incidere sui bilanci: non si possono conoscere entrate e uscite, non
c’é trasparenza sui finanziatori. I conti delle fondazioni possono essere fatti
in modo semplicistico e semplificato, senza rendere noto come arrivano i soldi e
come vengono spesi».
Molte di queste
fondazioni politiche sono semplici associazioni, che non depositano neppure una
minima documentazione.
«Bisogna tenere presente che nel nostro Paese per
ragioni culturali queste realtà sono state un momento significativo della
libertà di associazione. Nel diritto civile sono previste le associazioni non
riconosciute, tutelate perché si tutela la libertà di associazione, che devono
avere una loro possibilità di operare. Il problema è che in questi casi viene a
mancare persino quel minimo di controllo esercitato dalle prefetture: sono in
tutto uguali a una bocciofila. Non ci sono né regole, né rischi legali quando
vengono usate per incassare finanziamenti sospetti: possono solo incorrere in
verifiche fiscali della Guardia di Finanza se emergono pagamenti in nero. È una
carenza normativa che si fa sentire e più volte il Parlamento ha espresso
esigenza di intervenire. Sono stati presentati diversi disegni di legge, alcuni
dei quali validi, ma non sono mai andati in discussione».
Negli organi che
gestiscono le fondazioni politiche c’è poi una diffusa commistione tra centinaia
di imprenditori e di politici. È una confusione che può alimentare i conflitti
di interesse?
«In sé non è un aspetto deleterio. Che ci sia un
legame nelle attività delle fondazioni tra chi svolge politica attiva e chi si
occupa di attività economiche, imprenditoriali e professionali, non è un dato
atipico delle moderne democrazie. Anzi, avviene in tutte le democrazie
occidentali. Il problema è che i potenziali conflitti di interesse possono
essere contrastati o attenuati solo attraverso meccanismi di trasparenza. Se
l’imprenditore Tizio finanzia la fondazione del politico Caio e questo dato è
noto, come avviene ad esempio negli Usa, questo sterilizza il conflitto
d’interessi perché quando si discuterà di provvedimenti che riguardano
l’imprenditore Tizio, direttamente o indirettamente, tutti potranno rendersi
conto dei legami. Quello che è grave è l’assenza di pubblicità nel modo in cui
le due situazioni si interfacciano all’interno delle fondazioni».
Alfano nasconde i soldi perfino ai suoi
prefetti. La Fondazione
presieduta dal ministro non pubblica l'elenco dei finanziatori. E il dg Rai è
sponsor di Renzi, scrive Paolo Bracalini Sabato,
09/01/2016, su “Il Giornale”. Un investimento da appena 250 euro che ne
rende ogni anno 650mila (di stipendio), un posto di assoluto comando nella tv
pubblica e prima ancora il Cda di Poste italiane. In epoca di rendimenti bassi o
negativi, l'investimento di Antonio Campo Dall'Orto è da manuale di finanza. Il
nuovo direttore generale della Rai ha donato 250 euro alla Fondazione Open, la
cassaforte renziana, entrando così nel cerchio ristretto degli amici dell'ex
sindaco di Firenze, che poi da premier ha ricambiato quelli che aveva creduto in
lui nominandoli nelle partecipate pubbliche. Dall'Orto è uno dei molti
finanziatori «in chiaro» della fondazione guidata da Maria Elena Boschi, Luca
Lotti e Marco Carrai. I donatori, cioè, che hanno dato il consenso alla
pubblicazione dei propri nomi nell'elenco dei finanziatori del think tank legato
a Renzi.Ma c'è una zona grigia. Sui 2.803.953,49 euro raccolti dalla Open,
infatti, quasi un terzo (913mila euro) arriva da ignoti sostenitori del renzismo
che preferiscono restare anonimi. E nemmeno tirando in ballo le prefetture, che
per legge vigilano (poco) su enti di diritto privato come le fondazioni, si
riesce a sapere di più. Il test lo ha fatto l'Espresso, contattando via mail
sette prefetti di altrettanti città italiane (da Roma a Napoli) dove hanno sede
le associazioni politiche espressione di qualche leader o presunto tale. Ma
anche l'intervento dello Stato, nella figura del prefetto, non sembra illuminare
granché di quella zona d'ombra che nasconde le modalità di finanziamento delle
fondazioni. Il paradosso è che persino quella che fa capo ad Angelino Alfano,
ministro dell'Interno e dunque riferimento istituzionale dei prefetti, «esprime
dissenso» alla richiesta di fornire bilanci e informazioni sulla Fondazione De
Gasperi, presieduta appunto dal leader di Ncd e capo del Viminale. L'unico
patrimonio tracciabile risale all'eredità della vecchia Dc, 400 milioni di lire,
passati alla fondazione intitolata al grande statista democristiano. Il resto
dei finanziatori si può solo immaginare guardando i membri del consiglio di
amministrazione (Bazoli di Intesa San Paolo, il miliardario libanese Makhzoumi
Fouad...), visto che la fondazione del ministro non si rende trasparente ai
prefetti. E donatori ne servono, visto che anche il 5 per mille per
l'associazione di Alfano è andato molto male: l'ultima volta solo 59
contribuenti hanno espresso la preferenza nella dichiarazioni dei redditi, per
complessivi 6.700 euro. Spiccioli. Di fondazioni politiche ce n'è un centinaio,
ma le più importanti (e ricche) sono una ventina. Ricevono fondi ministeriali,
accedono al 5 per mille, hanno sgravi fiscali, a differenza dei partiti possono
ricevere donazioni da aziende pubbliche - munifici colossi come Eni,
Finmeccanica, Poste - e non devono rendere pubblici i bilanci. Tanti vantaggi
che ne spiegano la proliferazione. Una di quelle storiche è ItalianiEuropei di
Massimo D'Alema. Quando nasce, nel 1999, viene innaffiata di soldi da
cooperative rosse, grosse multinazionali, colossi della farmaceutica. La
fondazione dell'ex premier Ds ha autorizzato la prefettura a rendere pubblici i
suoi bilanci. Dai quali, però, non si ricavano le informazioni complete sui
finanziatori. In totale dai rendiconti fino al 2013 risultano quasi 2 milioni di
euro di donazioni, registrate genericamente come «contributi all'attività» da
«nuovi soci». Ma quali siano i loro nomi non è dato saperlo.
Figuraccia italiana nella visita a Riad: rissa per il Rolex regalato a Renzi &
C. I 50 membri della delegazione si sono azzuffati per i regali offerti dalla
famiglia reale. Il premier li fa sequestrare ma a Palazzo Chigi non sono ancora
arrivati,
scrive TGCOM il 9 gennaio 2016. Monta la polemica
per il viaggio diplomatico e commerciale compiuto da Matteo Renzi e una
delegazione politico-economica in Arabia Saudita l'8 novembre 2015. E non
c'entrano gli appalti miliardari o
la crisi internazionale con l'Iran a causa delle esecuzioni capitali compiute da
Riad. Il problema sono i Rolex, i regali che i ricchi sauditi avevano preparato
per alcuni membri della delegazione italiana ma che alla fine tutti avrebbero
preteso. Stando alle indiscrezioni di stampa questi Rolex non è chiaro che fine
abbiano fatto. E' il Fatto Quotidiano a ricostruire la vicenda: i 50 ospiti
arrivati da Roma (tra cui vertici di aziende statali e non come Finmeccanica,
Impregilo e Salini) sono a cena con la famiglia reale. Arrivano gli omaggi
preparati dagli sceicchi, pacchettini con nomi e cognomi, in italiano e arabo.
C'è il pacchettino di serie A, con il Rolex svizzero, e quello, diciamo, di
serie B con un cronografo prodotto a Dubai che vale "solo" 4mila euro. Il
fattaccio avviene quando un furbetto della delegazione italiana scambia il suo
cronografo arabo col pacchetto luccicante svizzero. Il "proprietario" del Rolex
se ne accorge e scoppia una quasi rissa. Tutti vogliono il Rolex, i reali
sauditi sarebbero anche pronti a cambiare tutti i regali pur di non vedersi di
fronte questa scena da mercato del pesce. Ma interviene la security di Renzi che
sequestra tutti i pacchetti. Ora,
denuncia il Fatto Quotidiano, di questi orologi si è persa traccia. Va ricordato
che il governo di Mario Monti varò una norma che impedisce ai dipendenti
pubblici di accettare omaggi del valore superiore a 150 euro. I Rolex e gli
altri cadeau avrebbero dovuto essere depositati nella stanza dei regali al terzo
piano di Palazzo Chigi. Ma qui non si trovano. Interpellata
sul caso, Ilva Saponara, padrona del cerimoniale di Palazzo Chigi, non risponde,
dice di avere la febbre e di non ricordare nemmeno il contenuto dei doni offerti
dai sauditi. Anche l’ambasciatore Armando Varricchio, consigliere per l'estero
di Renzi, non parla ma annuisce di fronte alla ricostruzione del caso. Non dice
che fine hanno fatto i Rolex ma rassicura: "I doni di rappresentanza ricevuti
dalla delegazione istituzionale italiana, in occasione della recente visita
italiana in Arabia Saudita, sono nella disponibilità della Presidenza del
Consiglio, secondo quello che prevedono le norme. Come sempre avviene in questi
casi, dello scambio dei doni se ne occupa il personale della presidenza del
Consiglio e non le cariche istituzionali". Se ne deduce che qualcuno ancora non
ha restituito il Rolex in questione. E chissà se mai lo farà.
Governo in visita in Arabia Saudita. La
missione finisce in rissa per i Rolex in regalo.
Durante la trasferta a Ryad dello scorso novembre, i delegati italiani si sono
accapigliati per dei cronografi da migliaia di euro, un omaggio dei sovrani
sauditi. Per questo la delegazione del premier li ha sequestrati. Nota di
Palazzo Chigi: "Sono nella nostra disponibilità", scrive Carlo Tecce l'8 gennaio
2016 su "Il Fatto Quotidiano". Parapiglia tra dirigenti del governo in viaggio
con Matteo Renziper i Rolex elargiti dagli amici di Ryad. Questo racconto,
descritto da testimoni oculari, proviene dall’Arabia Saudita. È una grossa
figuraccia internazionale per l’Italia. È ormai la notte tra domenica 8 e lunedì
9 novembre. Il palazzo reale di Ryad è una fonte di luce che illumina la
Capitale saudita ficcata nel deserto. La delegazione italiana, che accompagna
Matteo Renzi in visita ai signori del petrolio, è sfiancata dal fuso orario e
dal tasso d’umidità. La comitiva di governo è nei corridoi immensi con piante e
tende vistose, atmosfera ovattata, marmi e dipinti. Gli italiani vanno a
dormire. Così il cerimoniale di Palazzo Chigi, depositario degli elenchi e dei
protocolli di una trasferta di Stato, prima del riposo tenta di alleviare le
fatiche con l’inusuale distribuzione dei regali. Quelli che gli oltre 50 ospiti
di Roma – ci sono anche i vertici di alcune aziende statali (Finmeccanica) e
private (Salini Impregilo) – hanno adocchiato sui banchetti del salone per la
cena con la famiglia al trono: deliziose confezioni col fiocco, cognome scritto
in italiano e pure in arabo. Gli illustri dipendenti profanano la direttiva di
Mario Monti: gli impiegati pubblici di qualsiasi grado devono rifiutare
gli omaggi che superano il valore di 150 euro oppure consegnarli subito agli
uffici di competenza. Qui non si tratta di centinaia, ma di migliaia di euro.
Perché i sovrani sauditi preparano per gli italiani dei pacchetti con orologi
preziosi: avveniristici cronografi prodotti aDubai, con il prezzo che oscilla
dai 3.000 ai 4.000 euro e Rolex robusti, per polsi atletici, che sforano decine
di migliaia di euro, almeno un paio. A Renzi sarà recapitato anche un cassettone
imballato, trascinato con il carrello dagli inservienti. Il cerimoniale sta per
conferire i regali. Il momento è di gioia. Ma un furbastro lo rovina. Desidera
il Rolex. Scambia la sua scatoletta con il pacchiano cronografo con quella
dell’ambito orologio svizzero e provoca un diverbio che rimbomba nella residenza
di re Salman. Tutti reclamano il Rolex. Per sedare la rissa interviene la scorta
di Renzi: sequestra gli orologi e li custodisce fino al ritorno a Roma. La
compagine diplomatica, guidata dall’ambasciatore Armando Varricchio, inorridisce
di fronte a una scena da mercato di provincia per il chiasso che interrompe il
sonno dei sauditi. Anche perché i generosi arabi sono disposti a reperire presto
altri Rolex pur di calmare gli italiani. Non sarà un pezzo d’oro a sfaldare i
rapporti tra Ryad e Roma: ballano miliardi di euro di appalti, mica affinità
morali. Nonostante le decapitazioni di Capodanno, tra cui quella dell’imam
sciita che scatena la furia dell’Iran, per gli italiani Ryad resta una meta
esotica per laute commesse. E che sarà mai una vagonata di Rolex? Il guaio è che
degli orologi, almeno durante le vacanze natalizie, non c’era più traccia a
Palazzo Chigi. Non c’erano nella stanza dei regali al terzo piano. Chi avrà
infranto la regola Monti e chi l’avrà rispettata? E Renzi ce l’ha o non ce l’ha,
il Rolex? La dottoressa Ilva Sapora, la padrona del cerimoniale di Palazzo
Chigi, non rammenta il contenuto dei doni. Ha la febbre e poca forza per
rovistare nella memoria. Varricchio ascolta le domande e la ricostruzione dei
fatti di Ryad: annuisce, non replica. Varricchio è il consigliere per l’estero
di Renzi, nonché il prossimo ambasciatore italiano a Washington. Allora merita
un secondo contatto al telefono. Non svela il destino del Rolex che ha ricevuto,
ma si dimostra comprensivo: “I cittadini devono sapere. Queste vicende meritano
la massima attenzione. Le arriverà una nota di Palazzo Chigi. Che la voce sia
univoca”. Ecco la voce del governo, che non smentisce niente, che non assolve la
Sapora, ma precisa i ruoli: “I doni di rappresentanza ricevuti dalla delegazione
istituzionale italiana, in occasione della recente visita italiana in Arabia
Saudita, sono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio, secondo quello
che prevedono le norme. Come sempre avviene in questi casi, dello scambio dei
doni se ne occupa il personale della presidenza del Consiglio e non le cariche
istituzionali”. Il racconto non finisce. Cos’è accaduto dopo la notte di Ryad?
Chi non voleva restituire o non ha ancora restituito i Rolex? Da
il Fatto Quotidiano di venerdì 8 gennaio 2016.
Renzi, Caporale vs Fiano (Pd): “Ci fu
rissa tra dirigenti per Rolex regalati dai sauditi”. “Scena ignominiosa, ma per
me non c’è notizia”, continua "Il Fatto Quotidiano
tv". Polemica vivace tra Antonello
Caporale, inviato de Il
Fatto Quotidiano, e il deputato Pd
Emanuele Fiano, durante Omnibus,
su La7. Lo scontro è innescato dall’articolo
di Carlo Tecce,
pubblicato sul numero odierno del Fatto, circa il parapiglia esploso nello
scorso novembre tra i dirigenti del governo in viaggio con Matteo
Renzi in Arabia Saudita: la
rissa tra i dirigenti governativi della folta delegazione italiana è
stata scatenata dalla generosa
elargizione di circa 50 Rolex di varia fattura ad opera del re saudita.
Come spiega Caporale nella trasmissione, nella hall dell’hotel di Ryad alcuni
dirigenti italiani si sono ribellati perché avevano ricevuto l’orologio meno
lussuoso, peraltro in barba alla legge
Monti che impone di rifiutare doni oltre i 150 euro. Successivamente
la scorta di Renzi ha dovuto sequestrare gli orologi, tutti prodotti a Dubai e
dal valore oscillante tra3mila e 4mila euro. Caporale commenta:
“Temo che la mediocrità del gruppo
dirigente e di coloro che dovrebbero guidare l’Occidente a risolvere questa
crisi internazionale sia tale che anche i dettagli illustrino il pessimismo
generale. E questo episodio è un dettaglio significativo”. Il
giornalista definisce il caso dei Rolex d’oro donati dagli ‘amici di Ryad’ un
dettaglio di costume non certo folkloristico: “E’ indicatore della nostra
ambiguità che ovviamente non è solo italiana, e simboleggia la debolezza
dell’Occidente. Che non riesce non solo a porre un’idea generale cu come far
fronte a una guerra così asimmetrica, pericolosa, atipica, difficile da
condurre, ma nemmeno a misurare le forze per far fronte a cose più banali”.
Insorge Fiano, che ribadisce di aver letto l’articolo de Il Fatto Quotidiano
‘parola per parola': “Qui c’è
un grande titolo, ma di notizie certe non c’è nulla”. “E’
notizia certa che i Rolex siano stati dati”, replica Caporale.
“L’unica fonte che viene citata” – obietta il parlamentare Pd – “è un
consigliere diplomatico di Palazzo Chigi”. “C’è
la nota di Palazzo Chigi alla fine dell’articolo” –
ribatte la firma de Il Fatto – “lo legga tutto”. Ma il deputato Pd, pur
definendo “ignominiosa” la rissa descritta nell’articolo di Tecce, ripete che
non c’è notizia, né la nota di Palazzo. In realtà, la versione del governo c’è e
non smentisce nulla, ma precisa i ruoli: “I
doni di rappresentanza ricevuti dalla delegazione istituzionale italiana, in
occasione della recente visita italiana in Arabia Saudita, sono nella
disponibilità della Presidenza del Consiglio, secondo
quello che prevedono le norme. Come sempre avviene in questi casi,
dello scambio dei doni se ne occupa il
personale della presidenza del Consiglio e non le cariche istituzionali”.
Quei magistrati calabresi
iscritti alla massoneria.
Tre dossier che scottano per un unico filone investigativo. Al centro i rapporti
inconfessabili tra 'ndrangheta, politica e istituzioni all'ombra delle logge,
scrive il direttore Paolo Pollichieni su "Il Corriere della Calabria", sabato,
09 Gennaio 2016. Un filone investigativo che scotta quello che si ritrovano in
mano diversi magistrati calabresi: porta a rivisitare e riattualizzare i
rapporti tra l'élite della 'ndrangheta e pezzi importanti del mondo massonico.
Non bastasse, ecco ricomparire anche il nodo dell'appartenenza alla massoneria,
in maniera diretta o velata ("all'orecchio"), di magistrati con ruoli
particolarmente delicati dentro le strutture giudiziarie della Calabria e non
solo della Calabria. Singoli filoni che fin qui non hanno avuto una lettura
unitaria, tracce e piste seguite dalle inchieste condotte da Nicola Gratteri,
procuratore aggiunto della Dda reggina, da Giuseppe Lombardo, della stessa Dda
reggina, e da Pierpaolo Bruni, che invece lavora alla Dda di Catanzaro. Va
ribadito che affiliarsi alla massoneria non è reato, in quanto la massoneria non
è tra le "associazioni segrete" proibite dalla Costituzione italiana con
l'articolo 18 («Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere
militare»). Diverso è dimostrare che alcune logge massoniche, magari sfuggite al
controllo della fratellanza universale, fanno da punto di ritrovo per rapporti e
sinergie inconfessabili tra mafiosi, politici e rappresentanti delle
istituzioni. A questo lavorano le singole inchieste e su questo stanno tornando
a rendere dichiarazioni importanti faccendieri che hanno rappresentato la
cerniera tra nomine, affari, appalti e riciclaggio riconducibili al mondo
criminale. Ma quando ci si imbatte nel nome di magistrati affiliati alla
massoneria il discorso cambia, perché se pure non si può qualificare
l'affiliazione massonica come reato, c'è tuttavia quanto statuito dal Consiglio
superiore della magistratura che ha affermato con chiarezza «l'incompatibilità
fra affiliazione massonica e l'esercizio delle funzioni di magistrato», perché
le caratteristiche delle logge massoniche sono quelle di «un impegno solenne di
obbedienza, solidarietà, e soggezione a principi e a persone diverse dalla
legge» e determinano perciò «come conseguenza inevitabile una menomazione grave
dell'immagine e del prestigio del magistrato e dell'intero ordine giudiziario».
A dare manforte al Csm c'è anche una sentenza della Suprema corte: «Il giudice
massone può essere ricusato dall'imputato, in quanto l'appartenenza a logge
preclude "di per sé l'imparzialità" del magistrato» (la Cassazione, 5a sezione
penale numero 1563 / 98), in altre parole, perché – come ha detto il giudice
Alfonso Amatucci – «essere iscritti alla massoneria significa vincolarsi al bene
degli adepti, significa fare ad ogni costo un favore. E l'unico modo nel quale
un magistrato può fare un favore è piegandosi a interessi individuali
nell'emettere sentenze, ordinanze, avvisi di garanzia». Come regolarsi, dunque,
se nell'acquisizione di documenti o nella raccolta di deposizioni sotto
giuramento, arriva sul tavolo del magistrato inquirente il nome di un collega
indicato come affiliato alla massoneria? Se lo stanno chiedendo in queste ore
all'interno delle Procure calabresi più esposte sul fonte delle indagini sui
rapporti apicali tra 'ndrangheta, politica e affari. I dossier che scottano sono
sostanzialmente tre. Il primo trae origine dalle denunce incrociate tra il gran
maestro Gustavo Raffi e uno dei massimi esponenti storici della massoneria
calabrese, il gran maestro Amerigo Minnicelli. Quest'ultimo, in sostanza, ha
accusato pubblicamente il Grande Oriente di aver consentito una dilatazione
delle iscrizioni in Calabria al fine di condizionare l'esito dell'elezione del
nuovo gran maestro Stefano Bisi, giornalista e vicedirettore de Il Corriere di
Siena, scelto da Raffi e vittorioso grazie al fatto che attorno a lui si sono
schierate compatte le logge calabresi, forti di 2mila maestri votanti. I rivali
di Bisi non hanno apprezzato il sostegno plebiscitario di una regione, la
Calabria, che durante la gestione Raffi ha acquisito un peso elettorale e
politico pari a quello di Toscana e Piemonte, molto più popolate e di lunga
tradizione massonica, e molto superiore a regioni molto più estese come la
Sicilia o la Lombardia. Un contenzioso interno? Non più, dopo le feroci critiche
del fratello calabrese Amerigo Minnicelli, che ha denunciato brogli alle
elezioni precedenti ed è stato trascinato davanti al tribunale, prima massonico
poi ordinario. «Raffi ha ritenuto di ampliare la base», dice Minnicelli, «e
questo non è certo un delitto. Ma l'esplosione degli iscritti nella mia regione
fa riflettere. E l'operazione "Decollo money" che ha portato in carcere nel 2011
l'imprenditore Domenico Macrì, calabrese con residenza in Umbria e agganci in
banca a San Marino, amico personale di Raffi, lambisce la Gran maestranza».
Raffi ha risposto a modo suo. Ha sospeso Macrì ma ha espulso Minnicelli.
Illuminanti, invece, sono le parole di Pantaleone Mancuso (alias "Vetrinetta"),
mammasantissima del crimine calabrese, deceduto il 3 ottobre scorso, che ha
teorizzato la confluenza della 'ndrangheta nella massoneria. Una preziosa
intercettazione ambientale, infatti, ci consegna il boss mentre spiega che la
'ndrangheta «non esiste più», è roba da paese, la 'ndrangheta vera si è
trasferita all'interno della massoneria, anzi è «sotto la massoneria». Un poco
quanto va spiegando, e siamo al secondo filone investigativo, in queste ore ai
magistrati reggini un altro esponente di spicco della massoneria che ha ripreso
a collaborare con la magistratura. Spiega perché, negli anni, il potere in
Calabria si è concentrato sull'asse Reggio-Gioia Tauro-Vibo e nel farlo chiama
in causa anche magistrati che avrebbero agito a protezione del "sistema" ogni
qualvolta le inchieste si sono avvicinate pericolosamente a tale cabina di
comando criminale. Il terzo nasce dal materiale sequestrato dal pm Pierpaolo
Bruni in casa e nei locali che ospitano la loggia massonica fondata da Paolo
Coraci, originario di Messina e residente a Roma ma con amicizie salde nel
Vibonese e nel Reggino, tra queste quelle con alcuni magistrati calabresi.
Dall'archivio del gran maestro Coraci sono saltate fuori anche le schede di
valutazione e i curricula di adepti da segnalare per l'ingresso nei consigli
d'amministrazione di 15 enti pubblici. Non solo, anche tre Questure sarebbero
state elevate al livello di dirigenza generale attraverso un intreccio di
interessi tra la loggia, un sacerdote ed esponenti politici. L'intervento della
loggia massonica avrebbe riguardato due Questure del sud Italia e una in una
regione del Centro. Secondo la Dda di Catanzaro, la loggia massonica fondata da
Coraci aveva interesse a creare un intricato sistema di potere che portava anche
alla nomina di consiglieri d'amministrazione in enti pubblici. C'è quanto basta
a mettere in fibrillazione più di un "palazzo", più di una "loggia" e più di una
"cosca", specialmente alla vigilia di una serie di scelte importanti che proprio
il Consiglio superiore della magistratura è chiamato a compiere per via del
turnover ai vertici di uffici giudiziari delicatissimi, quali ad esempio le
procure di Catanzaro e Cosenza.
CHI FA LE LEGGI?
Chi fa le
leggi? Tante proposte ma poche tagliano il traguardo. E otto su dieci sono del
governo. Dati
Openpolis: nelle ultime due legislature la percentuale di successo delle
iniziative di Palazzo Chigi è stata 36 volte più alta di quelle parlamentari.
L'apice con Letta. I tempi: neanche due settimane per il trattato su risanamento
banche e bail in, quasi 800 giorni per Italicum, divorzio breve e
anti-corruzione, scrive Michela Scacchioli il 5 gennaio 2016 su “La Repubblica”.
Neanche due settimane per ratificare il trattato sul fondo di risoluzione unica,
quello - tanto discusso in questi giorni di proteste
dei risparmiatori - su risanamento
bancario e salvataggio
interno (bail in). Ben 871 giorni, invece, per licenziare il ddl
sull'agricoltura sociale che ha impiegato quasi due anni e mezzo per diventare
legge. Nel mezzo ci sono da un lato lo svuota-carceri, i decreti lavoro,
fallimenti, missione militare
Eunavfor Med, competitività e riforma della pubblica
amministrazione che hanno tagliato il traguardo con - al massimo - 44 giorni di
tempo. Dall'altro si piazzano Italicum,
divorzio breve, ecoreati, anti-corruzione e affido familiare che oscillano tra i
664 e i 796 giorni necessari al via libera finale. Leggi lepre. E leggi lumaca.
Per rimanere in tema: durante la consueta conferenza stampa di fine anno, il
premier Matteo Renzi ha
detto a proposito delle unioni civili che
sì, il tema divide, ma che "nel 2016 queste vanno" necessariamente "portate a
casa" perché "a differenza di quello che avrei voluto, non siamo riusciti ad
approvare nel 2015" il ddl Cirinnà presentato
in commissione a Palazzo Madama già a marzo del 2013 e successivamente
modificato. "Purtroppo - ha poi aggiunto Renzi - non siamo riusciti a tenere il
tempo. Da segretario del Pd farò di tutto perché il dibattito che si apre al
Senato" a fine gennaio "sia il più serio e franco possibile. Un provvedimento di
questo genere non è un provvedimento su cui il governo immagina di inserire
l'elemento della fiducia, bisognerà lasciare a tutti la possibilità di
esprimersi". In fatto di leggi, tuttavia, i numeri appaiono chiari. Sono 565 le
norme approvate nelle ultime due legislature su un totale di oltre 14mila
proposte. In percentuale, però, tra quelle che sono riuscite a completare
l'iter, otto su dieci sono state presentate dal governo e non dal parlamento
italiano nonostante - costituzionalmente - siano Camera e Senato a essere
titolari del potere legislativo. Vero è che nel corso degli anni, i governi,
detentori di quello esecutivo, hanno ampliato il proprio raggio d'azione. Tanto
che la percentuale di successo delle proposte avanzate da Palazzo Chigi è 36
volte più alta di quelle parlamentari. Le cifre sono
quelle analizzate (al 4 dicembre 2015) da Openpolis per
Repubblica.it. Secondo l'osservatorio civico, infatti, "ormai è diventata
una prassi che la stragrande maggioranza delle leggi approvate dal nostro
parlamento sia di iniziativa del governo". Nell'attuale legislatura, come nella
scorsa, circa l'80% delle norme approvate è stato proposto dai vari esecutivi
che si sono succeduti. Ma cosa trattavano le oltre 500 leggi votate nelle ultime
due legislature? E poi: nei pochi casi in cui l'iniziativa del parlamento è
andata a buon fine, quali gruppi si sono resi protagonisti? Con che
provvedimenti? Quanto ci vuole in media a dire sì a una legge?
Chi
arriva in fondo. Un’analisi
sulla produzione legislativa del nostro parlamento non può che partire dai
numeri. Dei circa 183 disegni di legge che vengono presentati ogni mese, solo
sei raggiungono la fine del percorso. Di questi sei, nell'80% dei casi si tratta
di proposte avanzate dal governo. E mentre le iniziative di deputati e senatori
diventano legge nello 0,87% delle volte, la percentuale sale al 32,02% quando si
tratta del governo. Delle oltre 565 leggi approvate nelle ultime due
legislature, ben 440 sono state presentate dai vari esecutivi che si sono
succeduti. Fra i governi presi in considerazione, l’apice è stato raggiunto con
il governo di Enrico Letta:
in quel periodo il parlamento ha presentato soltanto l’11% delle leggi poi
approvate.
I tempi. In
media, dal momento della presentazione a quello dell’approvazione finale
trascorrono 151 giorni se si tratta di una proposta del governo. Ne passano 375
se si tratta di un’iniziativa parlamentare. Non stupisce quindi che la top 10
delle 'leggi lumaca' sia composta per il 90% da ddl presentati da deputati e
senatori, e che nella top 10 delle 'leggi lepre' vi siano soltanto quelle
proposte del governo. Se in media l’esecutivo impiega 133 giorni a trasformare
una proposta in legge (poco più di 4 mesi), i membri del parlamento ne impiegano
408 (oltre 1 anno). Nell’attuale legislatura si evidenziano trend opposti:
mentre le proposte del governo sono più lente rispetto allo scorso quinquennato,
quelle del parlamento risultano più veloci.
Tante ratifiche di trattati. Un
altro elemento analizzato è il contenuto di questi testi. Delle 565 leggi
approvate nelle ultime due legislature, il 36,28% erano ratifiche di trattati
internazionali, il 26,55% conversione di decreti leggi. Questo vuol dire che 6
volte su 10 una legge approvata da Camera e Senato non nasce in seno al
parlamento ma viene sottoposta all’aula per eventuali modifiche o bocciature.
Cambi di gruppo e instabilità. Se
da un lato la XVII legislatura
ha confermato lo squilibrio fra governo e parlamento nella produzione
legislativa, dall'altro ha introdotto una forte instabilità nei rapporti fra
maggioranza e opposizione. Il continuo
valzer parlamentare dei cambi di gruppo, con la nascita di tanti nuovi
schieramenti (molti dei quali di 'trincea' fra maggioranza e opposizione) ha
fatto sì che l'opposizione reale, dati alla mano, fosse composta solamente da
tre gruppi: Fratelli d'Italia, Lega Nord e Movimento 5 Stelle. Soltanto questi
tre infatti, alla fine hanno votato nella maggior parte dei casi in contrasto
con il Partito democratico.
Pd in
testa. Dalle politiche
del 2013, sono 30 le proposte di deputati e senatori che hanno completato l’iter
parlamentare (su più di 5mila ddl di iniziativa parlamentare). Protagonista
assoluto è il Partito democratico, che ha presentato il 73,33% dei testi in
questione. A seguire Forza Italia (10%), e poi 5 gruppi a pari merito: Movimento
5 Stelle, Scelta Civica, Per le Autonomie-Psie-Maie, Misto e Lega Nord.
I decreti. A
seguire nell'analisi, con un’altra fetta importante della torta, le conversioni
in legge dei decreti emanati dai vari governi che si sono susseguiti. La
conversione in legge dei decreti è una delle attività principali del nostro
parlamento. Succede molto raramente che un testo deliberato dal Consiglio dei
ministri non venga poi approvato da Camera e Senato. Negli ultimi 4 governi, il
più 'efficiente' è stato è stato quello a guida Letta, con soltanto il 12% dei
decreti decaduti. I decreti deliberati dal Consiglio dei ministri devono essere
convertiti entro 60 giorni. Non sorprende quindi che il 90% delle leggi che
rientra nella top 10 delle più veloci sia conversione di decreti. Fra le 10 più
lente invece, tutte tranne una sono state proposte da membri del parlamento. La
legge di iniziativa governativa più lenta è stata l’Italicum, che ha impiegato
779 giorni dal momento della presentazione per completare il suo iter.
Le Regioni. Nelle
ultime due legislature le Regioni italiane hanno presentato 119 disegni di
legge. Di questi, solamente 5 hanno completato l’iter, e tutti nello scorso
quinquennato. Tre dei cinque erano modifiche agli statuti regionali (di Sicilia,
Friuli-Venezia Giulia e Sardegna), uno è stato approvato come testo unificato
(in materia di sicurezza stradale), mentre l’ultimo è stato assorbito nella
riforma del federalismo fiscale sotto il governo Berlusconi.
Come si vota. Un
altro elemento fondamentale nell'approvazione delle leggi è il voto.
Soffermandosi in particolare sull'attuale legislatura, l'analisi si è
concentrata su chi ha contribuito, e in che modo, all'approvazione finale di
questi provvedimenti. Dalla percentuale di posizioni favorevoli sui voti finali
dei singoli gruppi presenti in aula, alla consistenza della maggioranza nel
corso della legislatura, passando per il rapporto fra voti finali e questioni di
fiducia. Se si prende il Pd come punto di riferimento in qualità di principale
forza politica all'interno della coalizione di governo, si è ricostruita la
distanza (o vicinanza) dall’esecutivo degli altri gruppi parlamentari. Il primo
dato che emerge è che su 435 votazioni finali, in 104 occasioni (23,01%), tutti
i gruppi alla Camera e al Senato hanno votato con il Pd.
Le opposizioni. Il
comportamento delle opposizioni nei voti finali regala molti spunti
interessanti. Perché se su carta alcuni schieramenti nel corso dei mesi si sono
dichiarati in contrasto con gli esecutivi di Letta prima e Renzi poi, i dati
raccontano altro. Nei voti finali alla Camera, ad esempio, Sel, gruppo di
opposizione, ha votato il 52% delle volte in linea col Pd. Al Senato, ramo in
cui i numeri a favore dell’esecutivo sono più risicati, solamente due gruppi
(Lega Nord e Movimento 5 Stelle) hanno votato nelle maggior parte dei voti
finali (più del 50%) diversamente dal Pd.
Voto di
fiducia: chi l'ha usato di più. Per
completare il quadro sulle votazioni, non si poteva non affrontare il tema delle questioni
di fiducia sui progetti di legge. Due
gli aspetti analizzati: da un lato il rapporto tra blindatura e leggi approvate,
dall’altro le occasioni durante le quali lo strumento è stato utilizzato più di
due volte sullo stesso provvedimento. Non solo la maggior parte delle leggi
viene proposta dal governo, ma emerge pure che l'approvazione richiede un
utilizzo elevato delle questioni di fiducia. In media, nelle ultime due
legislatura, il 27% delle leggi approvate ha necessitato di un voto di fiducia,
con picchi massimi raggiunti dal governo Monti: il 45,13 per cento. Ma quali
sono stati i provvedimenti che hanno richiesto più voti di fiducia? Al primo
posto c'è la riforma del lavoro, governo Monti, che ha richiesto 8 voti di
fiducia. Cinque voti di fiducia per il ddl anti-corruzione (sempre governo
Monti) e ancora cinque per la Stabilità 2013. Quattro voti di fiducia per il
decreto sviluppo e la riforma fiscale (governo Monti), tre per la legge sviluppo
2008 (governo Berlusconi). Tre voti di fiducia per la Stabilità 2014 (governo
Letta), tre anche per Stabilità 2015, Italicum, Jobs Act e riforma Pa (governo
Renzi).
Voti finali alla Camera. Uno
dei modi per capire il reale posizionamento in aula dei gruppi parlamentari è
vedere se il loro comportamento durante i voti finali è in linea o meno con
quello del governo. Questo esercizio permette anche di osservare come è variato
il sostegno all’esecutivo con la staffetta Letta-Renzi. Se da un lato Forza
Italia durante il governo Letta votava l’86% delle volte con il Pd (al tempo in
maggioranza), con il governo Renzi - e il riposizionamento dei berlusconiani -
la percentuale è scesa al 64,57 per cento.
Voti finali al Senato. I
numeri del governo a Palazzo Madama sono molto più risicati rispetto a quelli di
Montecitorio. Non sorprende quindi che la maggior parte dei gruppi, per un
motivo o per l’altro, spesso e volentieri abbia votato con il Pd nei voti finali
dei provvedimenti discussi in aula. Da sottolineare come i fuoriusciti da Forza
Italia, sia
Conservatori e Riformisti (di Raffaele
Fitto) che Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (di Denis
Verdini), da quando sono nati hanno votato rispettivamente il 78,69% e
il 78,13% delle volte in linea con il governo nei voti finali.
Voti finali panpartisan. Nel
dibattito parlamentare può succedere che su determinati argomenti si arrivi ad
una votazione panpartisan. Sono i casi i cui tutti i gruppi che siedono in aula
votano a favore, con nessuno ad astenersi o votare contro. Su 435 voti finali
che si sono tenuti da inizio legislatura, è successo ben 104 volte (23,91%). Più
ricorrente al Senato (28,10%) che alla Camera (20%). Trattasi principalmente,
nel 74% dei casi, di ratifica di trattati internazionali.
LA MASSONERIA E PALAZZO GIUSTINIANI.
Palazzo Giustiniani era della massoneria.
«Sarà il nostro museo», scrive Francesco Straface il
21 settembre 2016 su "Il Dubbio". La richiesta del Grande Oriente. Il poncio di
Garibaldi e i testamenti di Totò, Carducci e Pascoli tra i cimeli che la loggia
vorrebbe esporre nei locali confiscati da Mussolini. Secondo un diffuso luogo
comune la Massoneria ha un potere occulto sui governi. Eppure, nel caso
di Palazzo Giustiniani, la politica l'ha letteralmente osteggiata. Il Grande
Oriente d'Italia, infatti, reclama invano il rispetto della transazione
stipulata nel 1991 con l'allora presidente del Senato Giovanni Spadolini e il
ministero delle Finanze. Un accordo in virtù del quale il Governo si impegnava a
concedere dei locali da 120 metri quadrati ad un affitto simbolico ventennale,
da rinnovare periodicamente. L'immobile era dal 1901 sede della Massoneria. Il
Gran Maestro Ettore Ferrari l'acquistò dieci anni dopo grazie alle
sottoscrizioni degli associati per poco più di un milione di lire. La proprietà
originaria contava ben 405 vani, distribuiti su sette piani. Espropriato da
Mussolini nel 1926, divenne la casa del Senato. Con un dossier documentario,
curato da Carlo Ricotti ed Elisabetta Cicciola, a 25 anni dall'intesa
sottoscritta, il Grande Oriente torna a chiedere con forza la restituzione dei
locali, che vorrebbe adibire a Museo Storico della Massoneria italiana. Il
patrimonio che è conservato nelle teche del Vascello, in via di San Pancrazio, è
oggettivamente di grande valore. Tra i cimeli storici in attesa di essere
esposti al Senato, il collare storico indossato dai Gran Maestri, che venne
nascosto nelle fasce di un neonato per sottrarlo ai fascisti, il poncio di
Giuseppe Garibaldi, autenticato da uno dei figli, e i testamenti spirituali
di Totò, Giosuè Carducci e Giovanni Pascoli, che sono stati tra i massoni più
illustri. Il Gran Maestro Stefano Bisi non nasconde la sua amarezza: «Da un
quarto di secolo attendiamo la consegna dei locali. Un'ingiustizia tutta
italiana. Forse non ci si indigna perchè a subire un torto è la Massoneria». A
nulla sono servite le richieste inoltrate al presidente del Senato Pietro
Grasso e al Segretario Generale Elisabetta Serafin. «Chiediamo un accordo
pacifico, che prenda atto delle precedenti convenzioni. Altrimenti dovremmo
avviare un nuovo iter giudiziario contro quelle stesse Istituzioni che
celebriamo regolarmente, con numerosi eventi su tutto il territorio italiano,
per i 70 anni della Repubblica». Il Grande Oriente vorrebbe esporre lettere,
documenti e simboli storici della Libera Muratoria e affidarne la gestione a
cooperative sociali di detenuti o diversamente abili. «Non siamo i soli a tenere
riservati i nomi di tutti gli associati. La nostra è una casa aperta ribadisce
Bisi Soltanto qualche giorno fa abbiamo conferito a Pietro Bartolo, il medico
di Lampedusa, l'onorificenza dedicata a Galileo Galilei, la massima
riconoscibile a un non massone». Il Grande Oriente si è impegnato a supportare
il suo laboratorio, fornendogli mezzi e aiuto logistico.
IL RITO DI INIZIAZIONE.
Nudo accanto allo scheletro: i riti della
massoneria "hard". Un pentito racconta l'iniziazione
da affrontare per entrare nella superloggia, scrive Gianfranco Turano il 21
settembre 2016 su “L’Espresso”. Finora l'ammissione in loggia era stata svelata
ai profani dal film “Un borghese piccolo piccolo” di Mario Monicelli con il
Venerabile Romolo Valli che accoglie fra le colonne di Jachin e Boaz un Alberto
Sordi voglioso di carriera. Ma il personaggio di Sordi è un semplice
apprendista. Il superpentito Cosimo Virgiglio ha raccontato ai magistrati
reggini un rito “molto duro”, chiamato “penta” perché riservato a cinque persone
e dedicato a un grado iniziatico superiore. Nel verbale del 29 aprile 2015,
ancora in larga parte riservato, Virgiglio parla di un personaggio, il cui nome
è coperto da omissis, che ha il compito di sovrintendere al cerimoniale segreto
e occupa le cariche di Gran maestro del Grande Oriente di San Marino e di
Venerabile della loggia Montecarlo, madre di tutte le logge coperte. I cinque
candidati pensano a una semplice formalità. È l’inizio di un’ordalia. «Vengono
arrestati», racconta il pentito, «all’ingresso della dogana, si chiama così.
Tutti belli pimpanti, ridono. Di colpo, pum, vengono bloccati e messi nel
furgone al buio». Il Venerabile «si permetteva il lusso di farli morire al mondo
profano perché il rito di iniziazione è molto duro. Lui si permetteva di farli
morire al mondo profano nella Rocca di San Leo, la Rocca di San Marino».
Virgiglio si riferisce alla Rocca o Forte di San Leo, antica capitale del ducato
di Montefeltro che si trova circa 5 chilometri a ovest del territorio del Titano
ma ancora in provincia di Rimini. La Rocca ha un particolare significato per il
rito massonico perché le sue segrete hanno ospitato Giuseppe Balsamo conte di
Cagliostro, frammassone e avventuriero settecentesco di fama internazionale. «Io
l’ho vissuto», continua Virgiglio parlando del penta, «Non lì. Io l’ho vissuto a
Vibo e ho fatto sette ore, seminudo con lo scheletro a fianco e una luce. Lì fai
testamento». Il pubblico ministero che interroga, Giuseppe Lombardo della
direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, chiede se si tratti di uno
scheletro vero. La risposta è affermativa. Come nel Borghese piccolo piccolo, la
commedia all’italiana lascia presto il posto al dramma. Nel racconto di
Virgiglio emergono i motivi che impongono ai livelli più riservati
dell’associazione segreta tali durezze con chi deve “morire al mondo profano”.
Virgiglio spiega al magistrato: «Per farle capire come materialmente è avvenuta
l’interrelazione tra la componente massonica e quella tipicamente criminale, il
varco, che nel gergo massonico è riferito alla breccia di Porta Pia, è
costituito da quella nuova figura criminale che è identificata con la Santa.
Attraverso quel varco, costituito dai santisti che sono rappresentati da
soggetti insospettabili, il mondo massonico entra nella ’ndrangheta e non
viceversa. Il ruolo di santista all’interno della ’ndrangheta non consente in
automatico il contatto con la massoneria. È necessario che si individuino
ulteriori soggetti-cerniera, in giacca, cravatta e laurea». Virgiglio delinea il
doppio scopo strategico della nuova formazione. «Il sistema allargato aveva come
obiettivo finale quello di garantire alla componente massonica, fortemente
politicizzata, la gestione dei flussi elettorali. La componente di ’ndrangheta
mirava al consolidamento dei capitali sporchi che andavano ricollocati sul
mercato anche estero mediante strumenti finanziari evoluti». Virgiglio descrive
per diretta conoscenza la struttura massonica calabrese grazie al «mio ruolo
qualificato all’interno della Loggia dei due mondi di Reggio di cui detenevo il
“maglietto pulito”; esiste il cosiddetto “maglietto sporco o occulto” che
costituisce quell’ambito riservato o invisibile della stessa componente
massonica; di tale contesto facevano parte numerosi soggetti collegati
all’ambiente criminale di tipo mafioso che per evidenti ragioni non potevano
essere inseriti nelle logge regolari ovvero nella parte visibile». Questi nomi
sono ancora segreti, tranne uno che non è più perseguibile. Appartiene
all’inventore della massoneria segreta italiana, morto a 96 anni nel suo letto
alla fine del 2015. Licio Gelli, chi altri?
ERO MASSONE.
Ero massone.
Storia di Maurice Caillet, l’ex
venerabile convertito al cattolicesimo grazie a Lourdes, scrive il 21
Novembre 2014 Pietro
Piccinini su “Tempi”.
«Dopo quindici anni di guanti e grembiuli posso testimoniare che per un
“fratello” l’uomo da abbattere è sempre il Papa».
Cari amici di Tempi,
recentemente sono incappato su Youtube in un’intervista a Maurice Caillet, ex
massone convertito. Una storia bellissima che mi ha fatto tornare in mente di
averla già letta sul vostro settimanale. Cercando nell’archivio, però, non sono
riuscito a trovarla. Potreste aiutarmi a recuperarla? Grazie.
Paco Minelli:
Gentile lettore, lei ha ragione. L’intervista apparsa su un numero del
settimanale nel giugno 2010 non era mai stata riportata on line. Eccola di
seguito:
Maurice Caillet. La formazione razionalista, le battaglie per il
controllo demografico, poi l’iniziazione. Così un medico francese in cerca di
Lumi si ritrovò immerso in una notte fatta di trame segrete, corruzione e
occultismo. Dove tutto è tollerato, tranne la Chiesa. Confessioni di un ex
Venerabile
Di Pietro Piccinini.
Maurice Caillet è stato massone. Anzi, massonissimo. Per la precisione, è
stato Maestro Venerabile di una delle più antiche e importanti logge del Grande
Oriente di Francia. Di più: iniziato alla libera muratoria nel 1970 nel Tempio
di Rennes, nei suoi quindici anni di fedele appartenenza il dottor Caillet,
medico specializzato in chirurgia ginecologica e urologia, ateo razionalista
quasi fin dentro il dna, è stato una specie di enfant prodige della massoneria,
guadagnandosi il privilegio di accedere agli Alti Gradi del Rito Scozzese Antico
Accettato (dei quali molti “fratelli” ignorano perfino l’esistenza), fino a
raggiungere il diciottesimo, quello di Cavaliere Rosacroce. Da membro storico
dell’Organizzazione per la Pianificazione Familiare, praticava la contraccezione
artificiale e la sterilizzazione prima ancora che fossero legalizzate, e dal
1975, dopo aver visto andare in porto il piano massonico per l’introduzione in
Francia di una legge sull’aborto, divenne il primo medico a esercitare le
interruzioni di gravidanza in Bretagna. Nel frattempo, nel 1973, era anche
diventato rappresentante locale del Partito socialista di François Mitterrand,
perciò quando, nel 1981, quest’ultimo fu eletto presidente della Repubblica e
nominò dodici ministri massoni, Caillet ebbe modo di valutare da vicino il
conseguente boom di domande di iniziazione, molte delle quali provenivano
naturalmente da politici in cerca di utili amicizie. Lo stesso Caillet, che pure
era entrato nella massoneria immaginandola come «un luogo dove scambiarsi le
idee all’insegna della laicità», in seguito non disdegnò di scambiarsi appoggi
di carriera e favori giudiziari coi fratelli. Tutto questo, completo di nomi e
cognomi, Maurice Caillet lo ha scritto in un libro, Ero
massone (Piemme), che da un paio di mesi è uscito anche in Italia.
Peccato che pochi se ne siano accorti. Peccato perché tra quelle pagine ci sono
cose che forse neanche Dan Brown avrebbe il cuore di attribuire alla più
fanatica delle sue sette inventate. A parte l’armamentario classico di compassi
e grembiuli, ci sono – raccontati nel dettaglio – formule e riti occulti con
tende nere, teschi e bare. C’è (prima dell’iniziazione) l’ispezione dei Maestri
in incognito a casa Caillet. Ci sono resoconti di riunioni segrete, mitologia,
ideologia, corruzione e trame di potere. Ma soprattutto ci sono l’isolamento, il
mobbing spietato e le minacce di morte di cui Caillet fu fatto oggetto a partire
dal momento in cui, nel 1984, decise di comunicare ai “fratelli” la sua
conversione al cattolicesimo. Sembra il romanzo di un incredibile complottone
della massoneria intergalattica. Invece è la storia vera di Maurice Caillet. Che
oggi vive in Spagna, sotto protezione.
Dottor Caillet, lei chiese di entrare nella massoneria da
convinto ateo razionalista. E in genere è così che ci si immagina i massoni.
Quella che lei racconta, però, è più che altro una strana forma di religione
misterica ultrafideista. Che logica ha questo tuffo dai Lumi all’occulto?
«C’è
qualche cosa di incomprensibile anche per me nell’essere passato dal
razionalismo e dallo scientismo all’accettazione di rituali di tipo animista
fondati su una mitologia discutibile e a una vera e propria negazione della
ragione. Il mio stesso raziocinio ne è rimasto chiaramente annebbiato. Anche
altre persone più qualificate di me hanno ceduto alla seduzione delle “sirene”
massoniche: curiosità, ricerca di saperi nascosti ai comuni mortali, ambizione
di entrare nell’élite. Questa irrazionalità contrasta effettivamente con le
filosofie cosiddette dei Lumi, che facevano l’apologia della ragione, spesso con
disprezzo per la fede».
Molti princìpi della massoneria non sono altro che una specie di
cristianesimo senza Cristo. La sua stessa conversione iniziò quando, durante una
Messa a Lourdes, lei scoprì che quel «chiedete e vi sarà dato, cercate e
troverete, bussate e vi sarà aperto» non era un motto massonico bensì la «parola
del Signore Gesù».
«Il
mio ultimo libro, Ero
massone, mostra bene, spero, che i princìpi massonici “Libertà,
Uguaglianza, Fraternità” sono effettivamente scimmiottature degli insegnamenti
di Gesù, perché deviati o proprio traditi nella pratica. Ma in quindici anni di
massoneria io non mi sono mai preoccupato dell’origine di quei princìpi e non ne
vedevo le contraddizioni, in particolare l’assenza di uguaglianza tra gli
iniziati e i profani e perfino tra i massoni stessi, suddivisi in 33 gradi ben
distinti».
Nella storia della sua conversione c’è anche «lo sguardo» del suo
padre spirituale Yves Boucher. Possibile che in un monaco ci sia più “umanesimo”
che in un libero muratore?
«Senza
alcun dubbio l’incontro con quel monaco benedettino ha rafforzato la mia
conversione: prima in modo intuitivo, poi in modo più cosciente nel corso degli
anni, ho avvertito la presenza dello Spirito Santo che animava quell’uomo
autentico e distaccato dai beni di questo mondo, presenza che io non avevo mai
percepito tra i miei “fratelli” massoni, guidati da ogni sorta di brama e di
sofisma. Il suo buonsenso mi ha convinto che la fede non esclude la ragione, ma
la eleva. Mi ha anche insegnato a lasciarmi trasformare dalla Grazia che dona la
vera gioia».
Dopo la folgorazione a Lourdes le capitarono alcuni fatti
inquietanti che lei attribuisce all’«azione del Maligno». Cosa c’entra il
diavolo con la massoneria?
«Per
me è evidente che il Maligno ci tiene a mantenerci sotto la sua dipendenza
attraverso l’influenza di false filosofie, il fascino di saperi sedicenti
occulti e quella cultura di morte alla quale io ho contribuito con la pratica
delle interruzioni di gravidanza. Questo ci svia da Gesù che è la verità e la
vita».
Nel suo libro lei cita diversi cattolici affiliati alla
massoneria che vivono questa “doppia appartenenza” come se non ci fosse alcun
problema. Secondo lei nella Chiesa la massoneria è sottovalutata?
«In
Francia c’è sempre stata una tradizione di gallicanesimo, vale a dire di
indipendenza nei confronti dell’autorità del magistero. È per questo che la
prima condanna dell’appartenenza alla massoneria di Clemente XII (1738), poi le
seguenti, non furono trascritte né applicate dai diversi regimi francesi, regno,
impero o repubblica. Molti tra i massoni giustificano la loro doppia
appartenenza col pretesto che il nuovo diritto canonico, uscito dal Vaticano II,
non condanna esplicitamente l’adesione alla massoneria e fingono di ignorare la
dichiarazione della Congregazione per la dottrina della fede del 26 novembre
1983, firmata da monsignor Ratzinger e approvata da Giovanni Paolo II, dunque
senza alcun equivoco possibile. Per di più, alcuni cattolici un po’ ingenui si
lasciano sedurre dai princìpi di tolleranza e di umanesimo esibiti dalla
massoneria, per la quale in realtà l’antidogmatismo è un vero dogma».
E gli altri la sottovalutano? Sa che nel Partito democratico
italiano è iniziato uno psicodramma quando è emerso che alcuni suoi esponenti
sono massoni?
«Non
conosco la situazione in Italia, ma nei paesi anglofoni, così come in Francia, è
normale per un uomo politico appartenere alla massoneria».
C’è chi entra in una qualche loggia «per progredire su una
qualche via iniziatica o spirituale» e chi invece lo fa «per ampliare la rubrica
dei contatti illustri». Dove si incrociano le due strade?
«Quando
ero Venerabile (o presidente) di loggia, avevo suddiviso i miei “fratelli” in
tre categorie: un terzo di idealisti che sperano di migliorare l’uomo e la
società (senza l’aiuto di Dio: si chiama pelagianesimo), un terzo di arrivisti
che contano sulle loro nuove relazioni per migliorare la loro posizione sociale,
un terzo di assistiti che hanno bisogno di una famiglia in cui sentirsi al
sicuro, alla maniera dei clientes delle famiglie influenti ai tempi della
società romana antica. Ma certamente non c’è una separazione ermetica fra queste
tre categorie».
Ma la smania di potere può portare un massone a sostenere
battaglie contrarie alle proprie convinzioni? Ha visto esempi di questo?
«Assolutamente
sì, e il migliore esempio che posso fare è quello dei parlamentari francesi di
destra, membri della massoneria, che hanno votato nel 1974 a favore della legge
Veil sulla liberalizzazione dell’aborto, mentre le loro convinzioni personali li
spingevano a non farlo. Ma due Gran Maestri erano stati scelti come consiglieri
del governo e avevano chiesto ai “fratelli” di sostenere quel progetto. La
stessa Madame Veil rimase stupita di avere così pochi oppositori».
Lei scrive che l’edonismo massonico «ha portato a preparare e
promuovere in Francia», oltre all’aborto, tutte le leggi che favoriscono la
cosiddetta secolarizzazione, dal libertinaggio sessuale alla manipolazione degli
embrioni. Quindi esiste veramente il famigerato complotto che decide l’agenda
della politica e dell’opinione pubblica? E come funziona?
«Per
prima cosa la massoneria recluta sempre negli ambienti influenti e in
particolare negli ambienti della politica e del giornalismo, dell’educazione
pubblica e delle professioni liberali. Non si può veramente parlare di
complotto, ma nel corso delle riunioni che si svolgono ogni quindici giorni si
produce una “unificazione” delle idee, un consenso, che porta i “fratelli” a
usare della loro influenza là dove si trovano, e in genere con grande
discrezione».
Aborto, legalizzazione delle droghe, eutanasia, divorzio… Come
mai il culto massonico della natura e dell’umanità finisce sempre per ritorcersi
contro l’uomo?
«Effettivamente
tutto l’umanesimo che esclude Dio si ritorce contro l’uomo: è così che il
comunismo, le cui intenzioni originali erano lodevoli, è sfociato in uno dei più
grandi genocidi della storia».
Lei parla esplicitamente del «maschilismo della massoneria». Ma
se la massoneria è maschilista, dovrebbe essere maschilista, per esempio, anche
la legge sull’aborto. E come la mettiamo con la storia della “liberazione della
donna”?
«Non
c’è tutta la contraddizione che si potrebbe credere tra il maschilismo delle
obbedienze massoniche maschili e la cosiddetta liberazione della donna. Il punto
che accomuna le due cose è la volontà di sbarazzarsi di tutti gli ostacoli alla
possibilità per l’uomo di approfittare delle grazie femminili senza alcun
vincolo. Le obbedienze femminili, minoritarie, hanno inseguito la libertà
sfrenata senza valutare le conseguenze per la loro femminilità e la loro reale
indipendenza».
Dice che non si può usare la parola “complotto”. Ma
l’«universalismo massonico» di cui scrive nel libro, che addirittura «aspira al
governo del mondo, progetto sostenuto in forma sotterranea da parecchie
organizzazioni internazionali pilotate da massoni: Trilaterale, Bilderberg,
B’nai B’rith» un po’ ci assomiglia. Cosa succede in quelle segrete stanze?
«Benché
sia chirurgo, i miei mezzi finanziari non mi hanno permesso di entrare negli
arcani della massoneria internazionale politica e finanziaria, riservata ai
grandi di questo mondo. Ma io so quel che si diceva all’interno delle logge su
questo argomento. A proposito, Monsieur Zapatero, che credo sia massone, ha
ricevuto pochi giorni fa i suoi amici del Bilderberg nei pressi di Barcellona».
Qualcuno vede spuntare grembiuli anche dietro le varie “campagne”
contro il Papa e la Chiesa. Perché la massoneria dovrebbe odiare Benedetto XVI?
«Per
aver partecipato alla massoneria per quindici anni, posso testimoniare che per i
massoni, i quali affermano continuamente la loro grande tolleranza, l’uomo da
abbattere è il Papa, che si tratti di Pio XII, di Giovanni Paolo II o di
Benedetto XVI. Mentre la famosa tolleranza è effettiva nei confronti delle
Chiese protestanti e ortodosse (Chiese divise), come nei confronti del giudaismo
e dell’islam, l’ostilità contro la Chiesa cattolica riguarda il fatto che essa è
centralizzata attorno al Santo Padre, il quale vigila sulla sana dottrina e
sostiene in particolare la conciliabilità tra la fede e la ragione».
Sulla rivista cattolica L’homme nouveau lei ha invocato
«una legge per la separazione dello Stato dalla massoneria». Era solo una
battuta?
«Certo,
era ironico quel che ho scritto, e cioè che bisognava ottenere la separazione
dello Stato francese dalla massoneria, così come la massoneria aveva ottenuto
all’inizio del XX secolo la separazione della Chiesa e dello Stato. Io però lo
penso sinceramente, pur non prevedendone la realizzazione prima di qualche
decennio. Ma i tempi di Dio non sono i nostri… e io prego per la conversione dei
massoni».
"PADRI DELLA PATRIA"
VITTIME E COMPLICI DELLA NOSTRA
ROVINA.
Lettera da Crispi a Garibaldi
- Caprera. Torino, 3 febbraio 1863.
Mio Generale!
Giunto da Palermo, dove stetti poco men che un
mese, credo mio dovere dirvi qualche cosa della povera isola che voi chiamaste a
libertà e che i vostri successori ricacciarono in una servitù peggiore di prima.
Dal nuovo regime quella popolazione nulla ha
ottenuto di che potesse esser lieta. Nissuna giustizia, nissuna sicurezza
personale, l'ipocrisia della libertà sotto un governo, il quale non ha
d'italiano che appena il nome. Ho visitate le carceri e le ho trovate piene
zeppe d'individui i quali ignorano il motivo per il quale sono prigionieri. Che
dirvi del loro trattamento? Dormono sul pavimento, senza lume la notte, sudici,
nutriti pessimamente, privi d'ogni conforto morale, senza una voce che li
consigli e li educhi onde fosser rilevati dalla colpa.
La popolazione in massa detesta il governo
d'Italia, che al paragone trova più tristo del Borbonico. Grande fortuna che non
siamo travolti in quell'odio noi, che fummo causa prima del mutato regime! Essa
ritien voi martire, noi tutti vittime della tirannide la quale viene da Torino e
quindi ci fa grazia della involontaria colpa. Se i consiglieri della Corona non
mutano regime, la Sicilia andrà incontro ad una catastrofe.
E' difficile misurarne le conseguenze, ma esse
potrebbero essere fatali alla patria nostra. L'opera nostra dovrebbe mirare ad
evitare cotesta catastrofe, affinchè non si sfasci il nucleo delle provincie
unite che al presente formano il regno di Italia. Con le forze di questo regno e
coi mezzi ch'esso ci offre, noi potremmo compiere la redenzione della penisola e
occupar Roma. Sciolto cotesto nucleo, è rimandata ad un lontano avvenire la
costituzione d'Italia. Della vostra salute,
alla quale tutti c'interessiamo, ho buone notizie, che spero sempre migliori. Di
Palermo tutti vi salutano come vi amano.
Abbiatevi i complimenti di mia moglie e voi continuatemi il vostro affetto e
credetemi. Vostro ora
e sempre. F. Crispi.
La verità è
rivoluzionaria. Gli oltraggi subiti dalle popolazioni meridionali sono
incommensurabili. Non credo di aver fatto del male. Nonostante ciò, non rifarei
oggi la via dell'Italia meridionale, temendo di essere preso a sassate,
essendosi colà cagionato solo squallore e suscitato solo odio. Giuseppe
Garibaldi (da una lettera scritta ad Adelaide Cairoli, 1868)
Cronologia
moderna delle azioni massoniche e mafiose.
27 marzo 1848 -
Nasce la Repubblica Siciliana. La Sicilia ritorna ad essere indipendente,
Ruggero Settimo è capo del governo, ritorna a sventolare l'antica bandiera
siciliana. Gli inglesi hanno numerosi interessi nell'Isola e consigliano al
Piemonte di annettersi la Sicilia. I Savoia preparano una spedizione da affidare
a Garibaldi. Cavour si oppone perchè considera quest'ultimo un avventuriero
senza scrupoli (ricordano impietositi i biografi che Garibaldi ladro di cavalli,
nell' America del sud, venne arrestato e gli venne tagliato l'orecchio destro.
Sarà, suo malgrado, capellone a vita per nascondere la mutilazione) [Secondo
altre fonti l’orecchio gli sarebbe stato staccato con un morso da una ragazza
che aveva cercato di violentare all’epoca della sua carriera di pirata,
stupratore, assassino in America Latina, NdT]. Il nome di Garibaldi, viene
abbinato altresì al traffico di schiavi dall'Africa all'America. Rifornito di
denaro inglese da i Savoia, Garibaldi parte per la Sicilia.
11 maggio 1860 -
Con la protezione delle navi inglesi Intrepid e H.M.S. Argus, Garibaldi sbarca a
Marsala. Scrive il memorialista garibaldino Giuseppe Bandi: I mille vengono
accolti dai marsalesi come cani in chiesa! La prima azione mafiosa è contro la
cassa comunale di Marsala. Il tesoriere dei mille, Ippolito Nievo lamenta che si
trovarono pochi spiccioli di rame. I siciliani allora erano meno fessi! E'
interessante la nota di Garibaldi sull'arruolamento: "Francesco Crispi arruola
chiunque: ladri, assassini, e criminali di ogni sorta".
15 maggio 1860 -
Battaglia di Calatafimi. Passata alla storia come una grande battaglia, fu
invece una modesta scaramuccia, si contarono 127 morti e 111 furono messi fuori
combattimento. I Borbone con minor perdite disertano il campo. Con un esercito
di 25.000 uomini e notevole artiglieria, i Borbone inviano contro Garibaldi
soltanto 2.500 uomini. E' degno di nota che il generale borbonico Landi, fu
comprato dagli inglesi con titoli di credito falsi e che l'esercito borbonico
ebbe l'ordine di non combattere. Le vittorie di Garibaldi sono tutte una
montatura.
27 maggio 1860 -
Garibaldi entra a Palermo da vincitore!....Ateo, massone, mangiapreti, celebra
con fasto la festa di santa Rosalia.
30 maggio 1860 -
Garibaldi dà carta bianca alle bande garibaldine; i villaggi sono saccheggiati
ed incendiati; i garibaldini uccidevano anche per un grappolo d'uva. Nino Bixio
uccide un contadino reo di aver preso le scarpe ad un cadavere. Per incutere
timore, le bande garibaldine, torturano e fucilano gli eroici siciliani.
31 maggio 1860 -
Il popolo catanese scaccia per sempre i Borbone. In quell'occasione brillò, per
un atto di impavido coraggio, la siciliana Giuseppina Bolognani di Barcellona
Pozzo di Gotto (ME). Issò sopra un carro un cannone strappato ai borbonici e
attese la carica avversaria; al momento opportuno, l'avversario a due passi,
diede fuoco alle polveri; il nemico, decimato, si diede alla fuga disordinata.
Si guadagnò il soprannome Peppa 'a cannunera (Peppa la cannoniera) e la medaglia
di bronzo al valor militare.
2 giugno 1860 -
Con un decreto, Garibaldi assegna le terre demaniali ai contadini; molti
abboccano alla promessa. Intanto nell'Isola divampava impetuosa la rivoluzione
che vedeva ancora una volta il Popolo Siciliano vittorioso. Fu lo stesso popolo
che unito e compatto costrinse i borbonici alla ritirata verso Milazzo.
17 luglio 1860 -
Battaglia di Milazzo. Il governo piemontese invia il Generale Medici con 21.000
uomini bene armati a bordo di 34 navi. La montatura garibaldina ha fine. I
contadini siciliani si ribellano, vogliono la terra promessagli. Garibaldi,
rivelandosi servo degli inglesi e degli agrari, invia loro Nino Bixio.
10 agosto 1860 -
Da un bordello di Corleone, Nino Bixio ordina il massacro di stampo mafioso di
Bronte. Vengono fucilati l'avvocato Nicolò Lombardo e tre contadini, tra i quali
un minorato! L'Italia mostra il suo vero volto.
21 ottobre 1860
- Plebiscito di annessione della Sicilia al Piemonte. I voti si depositano in
due urne: una per il "Sì" e l'altra per il "No". Intimorendo, come abitudine
mafiosa, ruffiani, sbirri e garibaldini controllano come si vota. Su una
popolazione di 2.400.000 abitanti, votarono solo 432.720 cittadini (il 18%). Si
ebbero 432.053 "Sì" e 667 "No". Giuseppe Mazzini e Massimo D'Azeglio furono
disgustati dalla modalità del plebiscito. Lo stesso ministro Eliot, ambasciatore
inglese a Napoli, dovette scrivere testualmente nel rapporto al suo Governo che:
"Moltissimi vogliono l'autonomia, nessuno l'annessione; ma i pochi che votano
sono costretti a votare per questa". E un altro ministro inglese, Lord John
Russel, mandò un dispaccio a Londra, cosí concepito: "I voti del suffragio in
questi regni non hanno il minimo valore".
1861 - L'Italia
impone enormi tasse e l'obbligo del servizio militare, ma per chi ha soldi e
paga, niente soldato. Intanto i militari italiani, da mafiosi, compiono atrocità
e massacri in tutta l'Isola. Il sarto Antonio Cappello, sordomuto, viene
torturato a morte perchè ritenuto un simulatore, il suo aguzzino, il colonnello
medico Restelli, riceverà la croce dei "S.S. Maurizio e Lazzaro". Napoleone III
scrive a Vittorio Emanuele: "I Borbone non commisero in cento anni, gli orrori e
gli errori che hanno commesso gli agenti di Sua Maestà in un anno”.
1863 - Primi
moti rivoluzionari antitaliani di pura marca indipendentista. Il governo
piemontese instaura il primo stato d'assedio. Viene inviato Bolis per massacrare
i patrioti siciliani. Si prepara un'altra azione mafiosa contro i Siciliani.
8 maggio 1863 -
Lord Henry Lennox denuncia alla camera dei Lords le infamie italiane e ricorda
che non Garibaldi ma l'Inghilterra ha fatto l'unità d'Italia.
15 agosto 1863 -
Secondo stato d'assedio. Si instaura il terrore. I Siciliani si rifiutano di
indossare la divisa italiana; fu una vera caccia all'uomo, le famiglie dei
renitenti furono torturate, fucilate e molti furono bruciati vivi. Guidava
l'operazione criminale e mafiosa il piemontese Generale Giuseppe Govone. (Nella
pacifica cittadina di Alba, in piazza Savona, nell'aprile 2004 è stato
inaugurato un monumento equestre a questo assassino. Ignoriamo per quali
meriti.)
1866 - In
Sicilia muoiono 52.990 persone a causa del colera. Ancora oggi, per tradizione
orale, c'è la certezza che a spargervi il colera nell'Isola siano state persone
legate al Governo italiano. Intanto tra tumulti, persecuzioni, stati d'assedio,
terrore, colera ecc. la Sicilia veniva continuamente depredata e avvilita; il
Governo italiano vendette perfino i beni demaniali ed ecclesiastici siciliani
per un valore di 250 milioni di lire. Furono, nel frattempo, svuotate le casse
della regione. Il settentrione diventava sempre più ricco, la Sicilia sempre più
povera.
1868 - Giuseppe
Garibaldi scrive ad Adelaide Cairoli:"Non rifarei la via del Sud, temendo di
essere preso a sassate!". Nessuna delle promesse che aveva fatto al Sud (come
quella del suo decreto emesso in Sicilia il 2 giugno 1860, che assegnava le
terre comunali ai contadini combattenti), era stata mantenuta.
1871 - Il
Governo, con un patto scellerato, fortifica la mafia con l'effettiva connivenza
della polizia. Il coraggioso magistrato Diego Tajani dimostrò e smascherò questa
alleanza tra mafia e polizia di stato e spiccò un mandato di cattura contro il
questore di Palermo Giuseppe Albanese e mise sotto inchiesta il prefetto, l'ex
garibaldino Gen. Medici. Ma il Governo italiano, con fare mafioso si schiera
contro il magistrato costringendolo a dimettersi.
1892 - Si
formano i "Fasci dei Lavoratori Siciliani". L'organizzazione era pacifica ed
aveva gli ideali del popolo, risolvere i problemi siciliani. Chiedeva,
l'organizzazione dei Fasci la partizione delle terre demaniali o incolte, la
diminuzione dei tassi di consumo regionale ecc.
4 gennaio 1894 -
La risposta mafiosa dello stato italiano non si fa attendere: STATO D'ASSEDIO.
Francesco Crispi, (definito da me traditore dei siciliani a perenne vergogna dei
riberesi) presidente del Consiglio, manda in Sicilia 40.000 soldati al comando
del criminale Generale Morra di Lavriano, per distruggere l'avanzata impetuosa
dei Fasci contadini. All'eroe della resistenza catanese Giuseppe De Felice
vengono inflitti 18 anni di carcere; fu poi amnistiato nel 1896, ricevendo
accoglienze trionfali nell'Isola.
Note di "Sciacca
Borbonica": Sono molti i paesi del mondo che dedicano vie, piazze e strade a
lestofanti e assassini. Ma pochi di questi paesi hanno fatto di un pirata
macellaio addirittura il proprio eroe nazionale. Il 27 luglio 1995 il
giornale spagnolo "El Pais", giustamente indignato per l’apologia di Garibaldi
fatta dall’allora presidente Scalfaro (quello che si prendeva 100 milioni al
mese in nero dal SISDE, senza che nessuno muovesse un dito) nel corso di una
visita in Spagna, così gli rispose a pag. 6: “Il presidente d'Italia è stato
nostro illustre visitante...... Disgraziatamente, in un momento della sua
visita, il presidente italiano si è riferito alla presenza di Garibaldi nel Rio
della Plata, in un momento molto speciale della storia delle nazioni di questa
parte del mondo. E, senza animo di riaprire vecchie polemiche e aspre
discussioni, diciamo al dott. Scalfaro che il suo compatriota [Garibaldi] non ha
lottato per la libertà di queste nazioni come egli afferma. Piuttosto il
contrario". Il 13 settembre 1860, mentre l'unificazione italiana era in pieno
svolgimento, il giornale torinese Piemonte riportava il seguente articolo.
(1): «Le imprese di Garibaldi nelle Due Sicilie parvero sin da allora così
strane che i suoi ammiratori ebbero a chiamarle prodigiose. Un pugno di giovani
guidati da un audacissimo generale sconfigge eserciti, piglia d'assalto le città
in poche settimane, si fa padrone di un reame di nove milioni di abitanti. E ciò
senza navigli e senz'armi... Altro che Veni, Vedi, Vici! Non c'è Cesare che
tenga al cospetto di Garibaldi. I miracoli però non li ha fatti lui ma li fecero
nell'ordine: 1°)-L'oro con il quale gli inglesi comprarono quasi tutti i
generali borbonici e col quale assoldarono 20.000 mercenari ungheresi e slavi e
pagarono il soldo ad altri 20.000 tra carabinieri e bersaglieri, opportunamente
congedati dall'esercito sardo-piemontese e mandati come "turisti" nel Sud, altro
che i 1000 scalcinati eroi...... 2°)-il generale Nunziante ed altri tra
ufficiali dell'esercito e della marina che, con infinito disonore, disertarono
la loro bandiera per correre sotto quella del nemico eccovi servito un piccolo
elenco di traditori al soldo degli anglo-piemontesi, oltre al
Nunziante: Generale Landi, Generale Cataldo, Generale Lanza, Generale Ghio,
Comandante Acton, Comandante Cossovich,ed altri ancora; 3°)-i miracoli li ha
fatti il Conte di Siracusa con la sua onorevolissima lettera al nipote Francesco
II° (lettera pubblicata in un post a parte); 4°)-li ha fatti la Guardia
Nazionale che, secondo il solito, voltò le armi contro il re che gliele avea
date poche ore prima; 5°)-)li ha fatti il Gabinetto di Liborio Romano il quale,
dopo aver genuflesso fino al giorno di ieri appié del trono di Francesco II, si
prostra ai piedi di Garibaldi; 6°)- La quasi totalità della nobiltà siciliana.
Beh, Con questi miracoli ancor io sarei capace di far la conquista, non dico
della Sicilia e del Reame di Napoli, ma dell'universo mondo. Dunque non state a
contare le prodezze di Sua Maestà Garibaldi I. Egli non è che il comodino della
rivoluzione. Le società segrete (la massoneria) che hanno le loro reti in tutto
il paese delle Due Sicilie, hanno di lunga mano preparato ogni cosa per la
rivoluzione. E quando fu tutto apparecchiato si chiamò Garibaldi ad eseguire i
piani [...]. Se non era Garibaldi sarebbe stato Mazzini, Kossuth, Orsini o Lucio
della Venaria: faceva lo stesso. Appiccare il fuoco ad una mina anche un bimbo
può farlo. Di fatto vedete che dappertutto dove giunge Garibaldi la rivoluzione
è organizzata issofatto, i proclami sono belli e fatti, anzi stampati. In questo
modo credo che Garibaldi può tranquillamente fare il giro del mondo a piantare
le bandiere tricolori del Piemonte. Dopo Napoli Roma, dopo Roma Venezia, dopo
Venezia la Dalmazia, dopo la Dalmazia l'Austria, caduta l'Austria il mondo è di
Garibaldi, cioé del Piemonte! Oh che cuccagna! Torino capitale dell'Europa, anzi
dell'orbe terracqueo. Ed i torinesi padroni del mondo!». Dai Savoia agli
Agnelli, da una famiglia di vampiri ad un altra.....per il Sud sempre lo stesso
destino.......dar loro anche l'ultima goccia di sangue. Comunque la Giustizia
Divina arriva sempre........i savoia son finiti nella merda e nel ludibrio, gli
Agnelli nella tomba e nella droga che certamente sarà il mezzo con quale ci
libereremo di questa gente maledetta.
Gli eurobond che fecero l'Unità d'Italia
quando il Regno di Napoli era come la Germania, scrive
Giuseppe
Chiellino il 30 giugno 2012 su “Il Sole 24 Ore”. Il vertice europeo di
fine giugno ha cancellato gli eurobond dall'agenda. Almeno per ora. Angela
Merkel è stata drastica: «Mai finchè sarò viva» aveva detto in pubblico qualche
giorno prima. Chissà se la cancelliera tedesca aveva avuto il tempo di leggere
lo studio di Stéphanie Collet, storica della finanza della Université Libre de
Bruxelles che è andata a spulciare negli archivi delle Borse di Parigi e Anversa
per studiare l'unico precedente assimilabile agli Eurobond: l'unificazione del
debito sovrano dei sette stati che 150 anni orsono, su iniziativa del Piemonte e
sotto tutela di Francia e Inghilterra, costituirono il Regno d'Italia. Nella
storia dello stato moderno è l'esperienza storicamente più vicina al
faticosissimo tentativo di dare maggiore consistenza politica all'Unione
europea, anche attraverso l'integrazione delle politiche economiche e fiscali,
compresi debiti sovrani dei 17 paesi dell'euro. Un precedente prezioso, secondo
la Collet, per cercare di capire – mutatis mutandis - come potrebbero
comportarsi i mercati finanziari di fronte all'unificazione del debito pubblico
dei paesi della zona euro. «Come l'Italia di allora, l'Europa oggi è fatta da
stati eterogenei, con economie di dimensioni e condizioni diverse, che parlano
lingue diverse e hanno sistemi di imposizione fiscale separati» ricorda la
studiosa. Grazie al fatto che anche dopo l'unificazione i titoli del Regno
d'Italia conservarono fino al 1876 l'indicazione della loro origine (per
esempio, ad Anversa le emissioni del Regno delle Due Sicilie erano indicate come
"Italy-Neapolitean") la Collet è riuscita a ricostruire le serie storiche dei
prezzi settimanali tra il 1847 e il 1873. Un lavoro certosino di raccolta
manuale dei dati dagli archivi e dai database originali per capire come si sono
mosse le quotazioni, prima e dopo l'unità, politica ed economica. 25 emissioni
suddivise in quattro gruppi: Regno di Piemonte e Sardegna, Lombardo-Veneto, Due
Sicilie e Stato Pontificio. La prima cosa che balza agli occhi è lo spread
(anche allora!) tra i rendimenti dei diversi gruppi di bond prima e dopo
l'Unità. Quelli del Regno delle Due Sicilie (che erano un quarto del totale)
prima del 1861 pagavano i tassi più bassi: 4,3%, 140 punti base in meno delle
emissioni papali e di quelle piemontesi (che rappresentavano rispettivamente il
29% e il 44% del debito unitario dopo la conversione) e 160 in meno rispetto a
quelle Lombardo-Venete (che però erano solo il 2%). Insomma, a voler utilizzare
le categorie di oggi, il Regno di Napoli economicamente era per l'Italia quello
che oggi la Germania è per l'Eurozona. «Come il Regno di Napoli prima
dell'integrazione del debito sovrano, la Germania di oggi è l'economia più forte
dell'eurozona e beneficia del costo del debito più basso in assoluto» scrive
Collet. Considerazioni, queste, che faranno storcere il naso a molti, ma
sicuramente non di parte. Del resto, come ricorda Collet, Napoli era di gran
lunga la città più importante del neonato Regno d'Italia. E le regioni del Sud
avevano una discreta struttura industriale, un'agricoltura fiorente sia pure
basata sul latifondismo, e importanti porti commerciali. Subito dopo il 1861,
però, lo scettiscismo dei mercati nel processo unitario italiano impose un "risk
premium" comune a tutti i bond degli stati preunitari, anche a quelli che fino a
quel momento avevano goduto di maggiore fiducia e dunque di rendimenti più
bassi. Proprio quello che oggi la Germania teme possa avvenire con gli eurobond:
l'anno successivo, infatti, i rendimenti dei titoli convertiti in "Regno
d'Italia" si allinearono ben al di sopra dei tassi precedenti, al 6,9%. Per gli
"Italy – Neapolitean" 260 punti base in più che diventarono 460 nel 1870, per
poi cominciare a ripiegare dopo il 1871, quando cioè l'annessione di Venezia e
di Roma e il trasferimento della capitale nella città del papato convinsero gli
investitori, e non solo, che l'Unità era ormai irreversibile. L"Italia" non era
più una mera "espressione geografica", come l'aveva definita Metternich nel
1847, ma dopo tre guerre d'indipendenza e più di vent'anni di manovre
diplomatiche era diventata uno stato unitario. «L'integrazione dei debiti
sovrani era stato uno strumento per portare avanti l'integrazione politica, come
sarebbe oggi per l'Europa» afferma Collet, ma nota anche che «un aumento del
premio di rischio aggraverebbe la crisi del debito che sta vivendo l'Europa
piuttosto che risolverla. Significherebbe che, se fossero introdotti gli
eurobond, la Germania perderebbe il suo rating elevato». Questo portava Collet a
definire, già nei mesi scorsi, «remote» le speranze di vedere nel breve termine
un mercato integrato dei titoli di debito dell'eurozona. Nel lungo termine,
invece, i risultati della ricerca sul caso italiano dimostrano che «nel tempo i
rendimenti dei titoli diminuirono». Alla luce di questo, oggi la domanda è:
quanto tempo ci vorrà perché anche l'Europa sia considerata come un blocco unico
e in grado di dotarsi di un vero e proprio piano di salvataggio per l'euro? Per
l'Italia ci volle all'incirca un decennio. Considerato che quella italiana fu
un'annessione anche militare e quella europea è un'integrazione consensuale, e
che i mercati dei capitali si muovono a ritmi diversi rispetto alla seconda metà
dell'800, anche Collet concorda che un aumento del costo del debito nel breve
termine sarebbe un prezzo che potremmo permetterci di pagare se avessimo la
certezza di avere, tra qualche anno, un'Europa più unita. Ma questa certezza
nessuna ricerca, per quanto accurata, potrà mai darla. Serve, forse, la capacità
di andare oltre il breve periodo, di guardare un po' più lontano rispetto alla
prossima scadenza elettorale, superando la "veduta corta" che per Tommaso Padoa
Schioppa è stata «la radice» della crisi.
P2 E DINTORNI. CHI ERA
LICIO GELLI?
Chi era Licio Gelli, l'ex
"venerabile" della P2. Il gran maestro della loggia massonica, morto ieri, è
stato protagonista di una lunga stagione di trame e misteri della storia
italiana, scrive "Panorama" il 16 dicembre 2015. Il "burattinaio", "Belfagor",
"il venerabile". Ovvero, Licio Gelli. L'ex gran maestro della loggia
massonica P2, che tante volte è tornato nella storia della prima e della seconda
Repubblica tra rapporti occulti con il potere, vicende giudiziarie, arresti,
fughe e guai col fisco, è morto a 96 anni nella sua dimora storica Villa Wanda,
alle porte di Arezzo.
La vita.
Nato a Pistoia il 21 aprile 1919, a 18 anni si arruolò come volontario nelle
camicie nere di Franco in Spagna. Fu fascista, "repubblichino" e poi
partigiano. Il 16 dicembre 1944 sposa Wanda Vannacci dalla quale ebbe quattro
figli. Dopo la guerra si trasferisce in Sardegna e in Argentina, dove si lega a
Peron e Lopez Rega. Tornato in Italia comincia a lavorare nella fabbrica di
materassi Permaflex e diventa direttore dello stabilimento di Frosinone. Poi
diventa socio dei fratelli Lebole e proprietario dello stabilimento Gio.Le di
Castiglion Fibocchi.
La massoneria.
Nel 1963 Gelli si iscrive alla massoneria. Nel 1966 il Gran maestro
Gamberini lo trasferisce alla loggia "Propaganda 2", nata a fine Ottocento per
permettere l'adesione riservata di personaggi pubblici. Nel 1975 si decide lo
scioglimento della P2, che però grazie a Gelli, che da segretario diviene gran
maestro, rinasce più forte e allarga i suoi tentacoli in ogni ramo del potere.
Quando, il 17 marzo 1981, i giudici milanesi Turone e Colombo, indagando sul
crack Sindona, arrivano alle liste, per il mondo politico italiano è un
terremoto. Negli elenchi ci sono quasi mille nomi tra cui ministri,
parlamentari, finanzieri come Michele Sindona e Roberto Calvi, editori,
giornalisti, militari, capi dei servizi segreti, prefetti, questori, magistrati.
C'è anche il nome di Berlusconi.
I guai con la giustizia.
La P2 risulta coinvolta direttamente o indirettamente in tutti i maggiori
scandali degli ultimi trent'anni della storia italiana: tentato golpe Borghese,
strategia della tensione, crack Sindona, caso Calvi, scalata ai grandi gruppi
editoriali, caso Moro, mafia, tangentopoli. Il 22 maggio 1981 scatta il primo
ordine di cattura, ma Gelli è irreperibile. Verrà arrestato a Ginevra il 13
settembre 1982. Rinchiuso nel carcere di Champ Dollon, evade il 10 agosto 1983.
Il 21 settembre 1987 si costituisce a Ginevra. Torna a Champ Dollon, che lascia
il 17 febbraio 1988 estradato in Italia.
La condanna.
L'11 aprile ottiene la libertà provvisoria per motivi di salute. Il 16 gennaio
1997 c'è un nuovo ordine di arresto, ma il ministero della Giustizia lo revoca:
il reato di procacciamento di notizie riservate non era tra quelli per cui era
stata concessa l'estradizione. Il 22 aprile 1998 la Cassazione conferma
la condanna a 12 anni per il Crack del Banco Ambrosiano. Il 4 maggio Gelli è di
nuovo irreperibile: la fuga dura più di quattro mesi. Gli vengono concessi i
domiciliari, che sconterà a Villa Wanda, la residenza dove è morto e che
nell'ottobre 2013 gli venne sequestrata a conclusione di una indagine per un
debito col fisco; la magione - nella quale tuttavia continuò a vivere - è
rientrata nella sua disponibilità pena nel gennaio scorso per la dichiarata
prescrizione dei reati fiscali. Nell'aprile 2013 i pm di Palermo dell'inchiesta
Stato-mafia lo hanno sentito per gli intrecci tra P2, servizi ed eversione.
(ANSA)
A 96 muore Licio Gelli. In
Italia non ha mai fatto un giorno di carcere.
Scompare l'ex venerabile della loggia P2. E' deceduto a Villa Wanda, ad Arezzo.
Condannato per depistaggio delle indagini sulla strage di Bologna, dopo essere
stato detenuto in Francia e Svizzera era tornato a vivere in Toscana, scrive
R.I. su "L'Espresso" il 16 dicembre 2015.
E' morto Licio Gelli, l'ex venerabile della loggia P2, coinvolto nei misteri più
oscuri dell'Italia del dopoguerra. Si è spento alle 23 del 15 dicembre a Villa
Wanda, la casa sulle colline di Arezzo. Nato a Pistoia il 21 aprile del 1919,
Gelli fu condannato per depistaggio delle indagini sulla strage di Bologna del
1980, dopo essere stato detenuto in Svizzera e Francia e coinvolto in varie
inchieste, era tornato a vivere a Villa Wanda. Gelli lascia la seconda moglie
Gabriela (la prima Wanda è scomparsa da tempo) e i tre figli Raffaello, Maurizio
e Maria Rosa, la quarta figlia Maria Grazia è morta nel 1988 in un incidente
stradale. I funerali sono previsti giovedì a Pistoia, mentre la camera ardente
potrebbe essere allestita nella chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Arezzo a
pochi metri da Villa Wanda. Il «burattinaio», «Belfagor», «il
venerabile». Ovvero, Licio Gelli. L'ex gran maestro della P2, che tante volte è
tornato nella storia della prima e della seconda Repubblica tra rapporti occulti
con il potere, vicende giudiziarie, arresti, fughe e guai col fisco, a 18 anni
si arruolò come volontario nelle «camicie nere» di Franco in Spagna. Fu
fascista, repubblichino e poi partigiano. Il 16 dicembre 1944 sposa Wanda
Vannacci dalla quale ebbe quattro figli. Dopo la guerra si trasferisce in
Sardegna e in Argentina, dove si lega a Peron e Lopez Rega. Tornato in Italia
comincia a lavorare nella fabbrica di materassi Permaflex e diventa direttore
dello stabilimento di Frosinone. Poi diventa socio dei fratelli Lebole e
proprietario dello stabilimento Gio.Le di Castiglion Fibocchi. Nel 1963
Gelli si iscrive alla massoneria. Nel 1966 il Gran maestro Gamberini lo
trasferisce alla loggia «Propaganda 2», nata a fine Ottocento per permettere
l'adesione riservata di personaggi pubblici. Nel 1975 si decide lo scioglimento
della P2, che però grazie a Gelli, che da segretario diviene gran maestro,
rinasce più forte e allarga i suoi tentacoli in ogni ramo del potere. Quando, il
17 marzo 1981, i giudici milanesi Turone e Colombo, indagando sul crack
Sindona, arrivano alle liste, per il mondo politico italiano è un
terremoto. Negli elenchi ci sono quasi mille nomi tra cui ministri,
parlamentari, finanzieri come Michele Sindona e Roberto Calvi, editori,
giornalisti, militari, capi dei servizi segreti, prefetti, questori, magistrati.
C'è anche il nome di Berlusconi. La P2 risulta coinvolta direttamente o
indirettamente in tutti i maggiori scandali degli ultimi trent'anni della storia
italiana: tentato golpe Borghese, strategia della tensione, crack Sindona, caso
Calvi, scalata ai grandi gruppi editoriali, caso Moro, mafia, tangentopoli. Il
22 maggio 1981 scatta il primo ordine di cattura, ma Gelli è irreperibile. Verrà
arrestato a Ginevra il 13 settembre 1982. Rinchiuso nel carcere di Champ
Dollon, evade il 10 agosto 1983. Il 21 settembre 1987 si costituisce a Ginevra.
Torna a Champ Dollon, che lascia il 17 febbraio 1988 estradato in Italia.
L'11aprile ottiene la libertà provvisoria per motivi di salute. Il 16 gennaio
1997 c'è un nuovo ordine di arresto, ma il ministero della Giustizia lo revoca:
il reato di procacciamento di notizie riservate non era tra quelli per cui era
stata concessa l'estradizione. Il 22 aprile 1998 la Cassazione conferma la
condanna a 12 anni per il Crack del Banco Ambrosiano. Il 4 maggio Gelli è di
nuovo irreperibile: la fuga dura più di quattro mesi. Gli vengono concessi i
domiciliari, che sconterà a Villa Wanda, la residenza dove è morto e che
nell'ottobre 2013 gli venne sequestrata a conclusione di una indagine per un
debito col fisco; la magione - nella quale tuttavia continuò a vivere - è
rientrata nella sua disponibilità pena nel gennaio scorso per la dichiarata
prescrizione dei reati fiscali. Nell'aprile 2013 i pm di Palermo dell'inchiesta
Stato-mafia lo hanno sentito per gli intrecci tra P2, servizi ed eversione. Con
la morte di Licio Gelli scompare uno dei protagonisti degli anni più bui della
storia d’Italia. L’ex venerabile porta con se nella tomba alcuni dei segreti,
destinati, salvo colpi di scena, a restare tali. A capo di una loggia massonica
P2 (Propaganda 2), sconfessata solo dopo lo scoppio dello scandalo dal Grande
Oriente, Gelli era riuscito a tessere una trama di relazioni internazionali e
nazionali che ne hanno fatto a lungo il burattinaio occulto del Paese. Gelli
aveva creato con la P2 nel corso degli anni ’70 un centro di potere di cui, si
scoprì, facevano parte alti vertici delle forze armate, dei servizi segreti,
politici, imprenditori e giornalisti. La P2 è stata chiamata in causa in tutti i
più grandi scandali della storia d’Italia, dal tentato golpe del principe
Borghese, il crack Sindona, il caso Calvi, il controllo del Corriere della Sera
(Bruno Tassan Din, direttore generale della Rizzoli aveva la tessera 534). Fu
condannato, tra l’altro, a 10 anni per depistaggio delle indagini della strage
di Bologna del 1980. Dopo essere stato detenuto in Svizzera e Francia, è vissuto
a Castiglion Fibocchi, a nord di Arezzo, a Villa Wanda, sequestrata il 10
ottobre 2013 dalla Guardia di Finanza per frode fiscale (17 milioni di euro).
Dopo varie aste andate deserte è stata affidata a Licio Gelli come custode
giudiziario. Qui dal 2001 Gelli viveva in detenzione domiciliare dove ha
scontato la pena di 12 anni per la bancarotta fraudolenta dell’Ambrosiano.
L’Italia scoprì l’esistenza di una sorta di Stato parallelo il 17 marzo 1981,
quando gli allora giudici istruttori Gherardo Colombo e Giuliano Turone,
nell’ambito di un’inchiesta sul finto rapimento del finanziere Michele Sindona,
fecero perquisire Villa Wanda e la fabbrica di sua proprietà - Giole - sempre a
Castiglion Fibocchi, subito a nord di Arezzo. Qui venne scoperta una lunga lista
di alti ufficiali delle forze armate e di ’grand commis’ aderenti alla P2 resa
pubblica dall’allora presidente del Consiglio Giovanni Spadolini il 21 maggio
1981. La lista includeva 962 nomi tra cui anche l’intero gruppo dirigente dei
servizi segreti italiani, 2 ministri (Gaetano Stammati e Paolo Foschi, entrambi
Dc), 44 parlamentari, 12 generali dei Carabinieri, 5 della Guardia di Finanza,
22 dell’Esercito, 4 dell’Aeronautica e 8 ammiragli. Imprenditori come Silvio
Berlusconi, giornalisti come Roberto Gervaso e Maurizio Costano e Vittorio
Emanuele di Savoia Nel maggio del 1981 Gelli è già irreperibile. Scappò in
Svizzera dove fu arrestato nel 1982 e rinchiuso nel carcere di Champ Dollon da
cui, nel suo stile, misteriosamente riuscì a scappare, l’anno dopo, ad agosto
del 1983. Trovò rifugio in Sudamerica dove resto a lungo tra Venezuela e
Argentina prima di costituirsi nel 1987, però sempre a Ginevra. Solo nel
febbraio del 1988 venne estradato in Italia ma resta in carcere pochi giorni: ad
aprile ottiene la libertà provvisoria per motivi di salute. Licio Gelli è stato
condannato, tra l’altro, a 12 anni per il crack del Banco Ambrosiano di Calvi;
calunnia nei confronti dei magistrati milanesi Colombo, Turone e Viola; calunnia
aggravata dalla finalità di terrorismo per aver tentato di depistare le indagini
sulla strage alla stazione di Bologna, vicenda per cui è stato condannato a 10
anni Nel corso della sua movimentata storia Gelli aveva coltivato buoni rapporti
con i militari golpisti argentini che nel 1976 avevano deposto Isabelita Peron:
il generale Roberto Eduardo Viola e l’ammiraglio Emilio Massera. Si è spesso
parlato di suoi legami con la Cia, mai provati, o quanto meno con personaggi
legati indirettamente a Langley come lo storico conservatore Michael Ledeen.
Cia, golpe, esercito e
crac: tutti i torbidi segreti che Licio Gelli si porta nella tomba,
scrive “Libero
Quotidiano” il 16 dicembre 2015. Con la morte di Licio Gelli scompare uno dei
protagonisti degli anni più bui della storia d’Italia. L’ex "venerabile "porta
con se nella tomba alcuni dei segreti più torbidi d’Italia, destinati, salvo
colpi di scena, a restare tali. A capo di una loggia massonica P2 (Propaganda
2), sconfessata solo dopo lo scoppio dello scandalo dal Grande Oriente, Gelli
era riuscito a tessere una trama di relazioni internazionali e nazionali che ne
hanno fatto a lungo il burattinaio occulto del Paese. Nato a Pistoia il 21
aprile del 1919, Gelli aveva creato con la P2 nel corso degli anni ’70 un centro
di potere di cui, si scoprì, facevano parte alti vertici delle forze armate, dei
servizi segreti, politici, imprenditori e giornalisti. La P2 è stata chiamata in
causa in tutti i più grandi scandali della storia d’Italia, dal tentato
golpe del principe Borghese, il crack Sindona, il caso Calvi, il controllo del Corriere
della Sera (Bruno Tassan Din, direttore generale della Rizzoli aveva la
tessera 534). Fu condannato, tra l’altro, a 10 anni per depistaggio delle
indagini della strage di Bologna del 1980. Dopo essere stato detenuto in
Svizzera e Francia, è vissuto a Castiglion Fibocchi, a nord di Arezzo, a Villa
Wanda, sequestrata il 10 ottobre 2013 dalla Guardia di Finanza per frode fiscale
(17 milioni di euro). Dopo varie aste andate deserte è stata affidata a Licio
Gelli come custode giudiziario. Qui dal 2001 Gelli viveva in detenzione
domiciliare dove ha scontato la pena di 12 anni per la bancarotta fraudolenta
dell’Ambrosiano. L’Italia scoprì l’esistenza di una sorta di Stato parallelo
allignato dentro e dietro quello ufficiale il 17 marzo 1981 quando gli allora
giudici istruttori Gherardo Colombo e Giuliano Turone, nell’ambito di
un’inchiesta sul finto rapimento del finanziere Michele Sindona, fecero
perquisire Villa Wanda e la fabbrica di sua proprietà - Giole - sempre a
Castiglion Fibocchi, subito a nord di Arezzo. Qui venne scoperta una lunga lista
di alti ufficiali delle forze armate e di "grand commis" aderenti alla P2 resa
pubblica dall’allora presidente del Consiglio Giovanni Spadolini il 21 maggio
1981. La lista includeva 962 nomi tra cui anche l’intero gruppo dirigente dei
servizi segreti italiani, 2 ministri (Gaetano Stammati e Paolo Foschi, entrambi
Dc), 44 parlamentari, 12 generali dei Carabinieri, 5 della Guardia di Finanza,
22 dell’Esercito, 4 dell’Aeronautica e 8 ammiragli. Imprenditori come Silvio
Berlusconi, giornalisti come Roberto Gervasoe Maurizio Costano e Vittorio
Emanuele di Savoia. Nel maggio del 1981 Gelli è già irreperibile. Scappò in
Svizzera dove fu arrestato nel 1982 e rinchiuso nel carcere di Champ Dollon da
cui, nel suo stile, misteriosamente riuscì a scappare, l’anno dopo, ad agosto
del 1983. Trovò rifugio in Sudamerica dove resto a lungo tra Venezuela e
Argentina prima di costituirsi nel 1987, però sempre a Ginevra. Solo nel
febbraio del 1988 venne estradato in Italia ma resta in carcere pochi giorni: ad
aprile ottiene la libertà provvisoria per motivi di salute. Licio Gelli è stato
condannato, tra l’altro, a 12 anni per il crac del Banco Ambrosiano di
Calvi; calunnia nei confronti dei magistrati milanesi Colombo, Turone e Viola;
calunnia aggravata dalla finalità di terrorismo per aver tentato di depistare le
indagini sulla strage alla stazione di Bologna, vicenda per cui è stato
condannato a 10 anni. Nel corso della sua movimentata storia Gelli aveva
coltivato buoni rapporti con i militari golpisti argentini che nel 1976 avevano
deposto Isabelita Peron: il generale Roberto Eduardo Viola e l’ammiraglio Emilio
Massera. Si è spesso parlato di suoi legami con la Cia, mai provati, o quanto
meno con personaggi legati indirettamente a Langley come lo storico conservatore
Michael Ledeen.
È morto Licio Gelli.
L'ex
venerabile della loggia P2, 96 anni, è deceduto nella sua dimora di Villa Wanda
a Arezzo, scrive Luca Romano Mercoledì 16/12/2015 su "Il Giornale". È
morto Licio Gelli. L'ex venerabile della loggia P2, 96 anni, è deceduto nella
sua dimora di Villa Wanda a Arezzo. Gelli era stato ricoverato recentemente in
ospedale. L'ex imprenditore divenuto famoso per la vicenda legata alla loggia
massonica P2 si è spento poco prima delle 23 di martedì a Villa Wanda dove
risiedeva da anni. Da due giorni le condizioni di salute di Licio Gelli, già
precarie, erano fortemente peggiorate tanto da indurre la moglie Gabriela Vasile
a ricoverarlo nella clinica pisana di San Rossore da dove era stato dimesso alla
fine della scorsa settimana perché giudicato ormai in fin di vita. Dopo un
rapido check up all'ospedale di Arezzo che aveva dato lo stesso esito, la
famiglia aveva deciso di riportarlo a Villa Wanda dove è spirato. Nato a Pistoia
il 21 aprile del 1919, Gelli è stato condannato per depistaggio delle indagini
sulla strage di Bologna del 1980, dopo essere stato detenuto in Svizzera e
Francia e coinvolto in varie inchieste, si era ritirato nella sua abitazione
sulle colline di Arezzo dove è morto. Gelli lascia la seconda moglie Gabriela
(la prima Wanda è scomparsa da tempo) e tre figli Raffaello, Maurizio e Maria
Rosa, la quarta figlia Maria Grazia è morta nel 1988 in un incidente stradale. I
funerali si svolgeranno probabilmente giovedì a Pistia, mentre la camera ardente
dovrebbe essere allestita nella chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Arezzo a
pochi metri da Villa Wanda.
Licio Gelli e la P2.
Le liste
segrete loggia P2 (Propaganda due) furono scoperte il 17 marzo 1981, continua
Luca Romano. Condannato per depistaggio delle indagini della strage di Bologna
del 1982, è stato l'uomo dietro ai grandi misteri d'Italia, il nome dell'ex
venerabile - gran maestro della loggia deviata - è legato a decine di inchieste
giudiziarie e a vari lati oscuri della storia dello scorso secolo: tentato golpe
Borghese, strategia della tensione (strage alla stazione di Bologna in testa),
crac Sindona, caso Calvi e Moro, mafia, tangentopoli. Classe 1919, si è spento
nella sua villa Wanda (ribattezzata in onore della prima moglie Wanda Vannacci)
sulle colline di Arezzo, dove era rientrato dopo un breve ricovero in ospedale.
Definito "il burattinaio d'Italia", faccendiere e imprenditore, fu fascista
durante il regime e la Repubblica di Salò e, poi, partigiano, quando la vittoria
della guerra cominciò a rivelarsi impossibile per i nazi-fascisti. Le liste
segrete loggia P2 (Propaganda due) furono scoperte il 17 marzo 1981. I giudici
istruttori Gherardo Colombo e Giuliano Turone, nell'ambito di un'inchiesta sul
finto rapimento del finanziere Michele Sindona (banchiere coinvolto nell'affare
Calvi e mandante dell'omicidio di Giorgio Ambrosoli), fecero perquisire la villa
di Gelli e la fabbrica di sua proprietà (la Giole di Castiglion Fibocchi,
Arezzo), che portò alla scoperta di una lunga lista di alti ufficiali delle
forze armate e di funzionari pubblici aderenti alla P2. La scoperta di un potere
parallelo, di un altro Stato che controllasse ogni intrigo di potere, fu un
terremoto politico, che travolse un pezzo della classe dirigente italiana. Tra
le 962 persone inserite nell'elenco vi erano i nomi di 44 parlamentari, 2
ministri dell'allora governo (Enrico Manca, Psi e Franco Foschi, Dc), un
segretario di partito, 12 generali dei carabinieri, 5 generali della guardia di
finanza, 22 generali dell'esercito italiano, 4 dell'aeronautica militare, 8
ammiragli, vari magistrati e funzionari pubblici, i direttori e molti funzionari
dei vari servizi segreti, diversi giornalisti ed imprenditori. Tra i nomi più
noti, oltre a Vittorio Emanuele di Savoia, anche il futuro premier Silvio
Berlusconi. Nel 2008, in un'intervista a Klaus Davi per Klauscondicio, l'ex
venerabile dichiarò: "Con la P2 avevamo l'Italia in mano. Con noi c'era
l'esercito, la guardia di finanza, la Polizia, tutte nettamente comandate da
appartenenti alla Loggia". Il presidente del Consiglio Arnaldo Forlani attese il
21 maggio 1981, prima di rendere pubblica la lista degli appartenenti alla P2.
Fu istituita, per volontà della presidente della Camera Nilde Iotti, una
commissione parlamentare d'inchiesta, guidata dalla deputata democristiana Tina
Anselmi, ex partigiana e prima donna a diventare ministro. La commissione
affrontò un lungo lavoro di analisi venendo a scoprire come la P2 fu anche un
punto di riferimento in Italia per ambienti dei servizi segreti americani,
intenzionati a tenere sotto controllo la vita politica italiana fino al punto,
se necessario, di promuovere riforme costituzionali apposite o di organizzare un
colpo di Stato. La commissione denunciò la loggia come una vera e propria
organizzazione criminale ed eversiva. Fu sciolta con un'apposita legge, la
numero 17 del 25 gennaio 1982.
Gelli e i misteri d'Italia.
Oltre che
alla vicenda della loggia P2 il nome di Licio Gelli, l'ex venerabile della
loggia P2 è legato a decine di inchieste giudiziarie e a vari lati oscuri della
storia recente d' Italia, conclude Luca Romano. Oltre che alla vicenda della
loggia P2 il nome di Licio Gelli, l'ex venerabile della loggia P2 scomparso
nella serata di martedì 15 a 96 anni nella sua casa di Arezzo, è legato a decine
di inchieste giudiziarie e a vari lati oscuri della storia recente d' Italia:
dal tentato golpe Borghese a tangentopoli, dalla scalata a gruppi editoriali al
caso Moro.
Questo un elenco dei
principali fatti che lo hanno visto coinvolto e indagato negli ultimi anni.
- STRAGE DI BOLOGNA (2 agosto
1980 - 85 morti e 200 feriti): assolto definitivamente dall' accusa di
associazione eversiva Gelli nel 1994 è stato condannato per calunnia (10 anni)
al processo d'appello-bis. Nell'ambito del processo l' ex "venerabile" fu
protagonista anche della misteriosa rinuncia all'incarico da parte di uno dei
legali di parte civile Roberto Montorzi che abbandonò il collegio dopo due
incontri con Gelli a villa Wanda.
- BANCO AMBROSIANO: al
processo di primo grado a Milano, Gelli è stato condannato a 18 anni di
reclusione per il ruolo avuto nella bancarotta dall'istituto di Calvi (che aveva
la tessera n.519 della P2). Il suo nome è da sempre anche al centro delle
indagini sulla morte del "banchiere di Dio". Nel processo di secondo grado la
pena venne ridotta a 12 anni. Il 6 maggio 1998 Gelli, che doveva scontare la
condanna divenuta definitiva, fugge da villa Wanda e si rende irreperibile. Il
10 settembre viene fermato e arrestato a Cannes. Gelli entrò anche
nell'inchiesta sull'omicidio del banchiere, ma il procedimento venne archiviato
il 30 maggio 2009.
- CONTO "PROTEZIONE": il 29
luglio 1994 Gelli è stato condannato a Milano a sei anni e mezzo, in primo
grado, per la vicenda del conto 633369 di Silvano Larini all'Ubs di Lugano, del
quale fu trovata traccia nel 1981 a Castiglion Fibocchi con riferimenti a soldi
destinati al Psi di Craxi e Martelli. La pena fu ridotta a 5 anni e 9 mesi in
appello. La Cassazione decise l'annullamento della condanna per Gelli per
improcedibilità dell'azione penale, essendo stata la sua posizione definita nel
processo per il crac del Banco Ambrosiano.
- ATTENTATI AI TRENI IN
TOSCANA: accusato di aver finanziato le organizzazioni eversive "nere" per gli
attentati degli anni Settanta, Gelli è stato prima condannato a 8 anni e poi
dichiarato non processabile.
- MAFIA-POLITICA-AFFARI: Gelli
era uno dei 126 imputati al processo a Palmi sui presunti collegamenti tra mondo
politico ed imprenditoriale e organizzazioni mafiose. Secondo l'accusa, si
sarebbe adoperato per "aggiustare" un processo in Cassazione a due presunti
mafiosi di Taranto. Venne assolto il 3 marzo 1995 dall' accusa di concorso
esterno in associazione mafiosa. Nel 1998 è chiamato in causa dal procuratore
capo di Palermo Giancarlo Caselli nell'inchiesta Sistemi criminali poi
archiviata nel 2000.
- INCHIESTA OPERAZIONI
FINANZIARIE: tra il 1993 ed il 1994, Gelli è stato al centro dell'attenzione dei
magistrati di Arezzo e Roma per una serie di operazioni finanziarie miliardarie
che avrebbe disposto in varie banche. Le indagini sono legate in particolare al
fallimento della holding Cgf del gruppo Cerruti. Un ruolo di primo piano nelle
vicende è rivestito dall'ex vicepresidente del Csm Ugo Zilletti.
- LEGAMI CON LA CAMORRA: la
Dda di Napoli ha indagato sui rapporti tra Gelli ed alcuni esponenti della
camorra.
- INCHIESTA CHEQUE TO CHEQUE:
Gelli venne iscritto nel registro degli indagati, insieme al figlio Maurizio,
nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla procura di Torre Annunziata (Napoli)
in relazione ad un presunto traffico internazionale di armi e valuta. Una
trentina le persone arrestate. L'inchiesta venne poi trasferita a Milano.
- CASO BRENNEKE: le presunte
rivelazioni fatte al Tg1 dal sedicente ex agente della Cia Richard Brenneke sui
rapporti tra servizi segreti Usa e P2, duramente smentite da Gelli, estate del
1990 provocarono tensioni e polemiche, anche per il coinvolgimento dell'allora
presidente della Repubblica Francesco Cossiga.
- FALLIMENTO DI NEPI: Il 10
giugno 1997 la procura di Roma emette 9 ordini di arresto per il fallimento
della holding Di Nepi e di numerose società legate al gruppo. Per Gelli scatta
l'obbligo di dimora a Arezzo. Il 18 aprile 2005 venne condannato a 2 anni e 3
mesi di reclusione per associazione a delinquere e bancarotta insieme ad altre 9
persone.
Licio Gelli, quel
megalomane di provincia diventato potente per caso.
Un uomo bugiardo. Che solo le circostanze, la guerra fredda, l'essere l'Italia
un paese di frontiera tra l'Ovest e l'Est, in un brulichio di spie, affaristi e
politicanti, avevano potuto trasformare in un uomo capace di infilarsi ovunque,
dai partiti ai servizi segreti. E all'ombra delle grandi stragi di questo Paese,
scrive Marco Damilano il 16 dicembre 2015 su “L’Espresso”.
Gli ho parlato una sola volta, al
telefono, più di dieci anni fa. Chiamai il numero della casa ad Arezzo per
un'intervista, l'apparecchio suonò un paio di volte, poi qualcuno rispose.
«Pronto, vorrei parlare con Licio Gelli», dissi. Dall'altra parte un lungo
silenzio, poi quella voce: «Non è in casa». Io, stupito: «Ma scusi, Gelli è lei,
la riconosco!». E lui: «No, guardi, non sono io». E mise giù. A me venne in
mente che l'attore Alighiero Noschese, il primo imitatore della tv italiana, era
stato affratellato alla loggia P2, si diceva che falsificasse le voci nelle
telefonate del Venerabile, fingeva di essere un ministro o il presidente del
Consiglio. E anche lui all'epoca si era inventato un'altra identità, al telefono
si faceva chiamare dottor Luciani, per paura delle intercettazioni. E
pensai che questo era, prima di tutto, Licio Gelli. Un bugiardo. Un
megalomane di provincia che solo le circostanze - la guerra fredda, l'essere
l'Italia un paese di frontiera tra l'Ovest e l'Est, in un brulichio di spie,
affaristi e politicanti - avevano potuto trasformare in un uomo potente. In
vecchiaia si era messo a scrivere versi di dubbio valore letterario ma di sicuro
impatto per le cronache: ««Passano gli anni e il tempo affresca le rughe, /
scalfisce i segreti remoti che durano nel cuore…». Untuoso, anzi viscido, ogni
parola un soffio di ricatto. «Sono il confessore di questa Repubblica», amava
vantarsi ai tempi della sua ascesa. Quando arrivava all'hotel Excelsior in via
Veneto, si rinchiudeva nelle sue tre stanze, dalla 127 alla 129, e riceveva. I
suoi seguaci. I candidati alla loggia. «Il braccio sinistro appoggiato su una
scrivania con molti cassetti. Ogni tanto ne apriva uno e tirava fuori qualche
fascicolo ben conservato in copertine di cartoncino rosa. Era il suo archivio.
Lo faceva intravedere, ora ammiccante ora minaccioso, ai suoi ospiti costretti a
sedersi su una poltrona più bassa, tanto per far notare la differenza. Quasi
sempre, dopo ogni visita, le cartelline rosa si arricchivano di altri fogli,
nuovi segreti», scrivevano Maurizio De Luca e Pino Buongiorno, due giornalisti
che non ci sono più, nell'instant-book a più mani "L'Italia della P2" uscito
subito dopo la pubblicazione degli elenchi della loggia nel maggio 1981, a
tutt'oggi il libro più bello su Gelli e i suoi cari. Generali, ammiragli,
direttori di giornale, ministri, segretari di partito. Piccoli
uomini, ridicoli e sinistri. Questa era la loggia massonica P2. Nella
lista ritrovata a Castiglion Fibocchi erano 962, sfilarono uno a uno a palazzo
San Macuto, davanti alla commissione parlamentare di inchiesta presieduta da
Tina Anselmi. Nei diari della parlamentare democristiana ci sono gli appunti di
quelle audizioni, dove tutti negavano e insieme confermavano. «Enrico Manca: nel
1980 il 4 aprile entro come ministro del Commercio estero nel governo
Cossiga. A fine aprile conosco Gelli a un ricevimento all'ambasciata
argentina. Visita di Maurizio Costanzo, che disse di essere massone, e a nome di
Gelli mi chiese se ero disponibile a aderire alla massoneria. Quando mi vidi
negli elenchi di Gelli telefonai a Costanzo, ma questi mi confermò di aver
telefonato a Gelli la non disponibilità...».
La carriera di Gelli era cominciata nel biennio 1943-45, nel passaggio di
regime, al trapasso del fascismo, con la penisola occupata da eserciti
stranieri, l'ideale per cominciare una lunga trafila di doppiogiochista. Il
giovane repubblichino resta in forza alle SS ma traffica con i partigiani, è un
fascista che trama con gli antifascisti, per lui a guerra finita garantisce il
presidente comunista del Cln di Pistoia Italo Carobbi: «Il Gelli Licio di
Ettore, pur essendo stato al servizio dei fascisti e dei tedeschi, si è reso
utile alla causa dei patrioti». Due righe che valgono un'intera biografia,
ricordate dallo storico Luciano Mecacci nel volume-inchiesta sull'assassinio di
Giovanni Gentile, intitolato "La ghirlanda fiorentina". Quella pianta
intrecciata di fiori secchi, appassiti, putridi che soffoca ogni raggio di luce.
La Ghirlanda massonica e piduista cresce negli anni della democrazia,
come una radice marcia di un albero rigoglioso, una cellula malata in un corpo
sano, nell'oscurità. Gelli entra nella segreteria di un deputato democristiano,
diventa dirigente di una nota ditta di materassi, la Permaflex, e in questa
veste accoglierà Giulio Andreotti all'inaugurazione dello stabilimento di
Frosinone (il Divo lo ricorderà sempre così: «Era uno che vendeva materassi», e
via sminuzzando),
giura fedeltà alla massoneria, il Grande Oriente.
Prospera negli anni Settanta dei misteri e delle stragi, si infila
dappertutto: nei partiti, al Quirinale, a Palazzo Chigi, a Montecitorio, tra gli
alti gradi delle forze armate, al comando dei servizi segreti. Controlla le
scalate bancarie più prodigiose, da quella di Michele
Sindona a quella di Roberto Calvi, destinati a morti tragiche e mai
chiarite. È un'ombra
nelle più grandi tragedie italiane: la strage della stazione di Bologna
del 2 agosto 1980, il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro. Si allarga al Sud
America, nell'Argentina di Peron e dei generali golpisti. Sogna di riscrivere la
Costituzione: il piano di rinascita democratica, i partiti da chiudere, la tv
privata da diffondere, lo statuto dei lavoratori da stracciare, la separazione
delle carriere dei magistrati, «l'obbligo di attuare i turni di festività per
sorteggio, per evitare la sindrome estiva che blocca le attività produttive».
Cede alla vanità e si fa intervistare dal "Corriere della Sera" di cui alla fine
degli anni Settanta ha il pieno controllo. Il verbo gelliano va nella
prestigiosa terza pagina del quotidiano di via Solferino domenica 5 ottobre
1980. Titolo in ginocchio: «Parla, per la prima volta, il signor P2 Licio
Gelli». Incipit genuflesso: «Capo indiscusso della più segreta e potente loggia
massonica, ha accettato di sottoporsi a un'intervista esponendo anche il suo
punto di vista...», scrive felice l'intervistatore Maurizio Costanzo, iniziato
alla loggia due anni prima. «Una brodaglia disgustosa, con il burattinaio che
(tronfio, allusivo, arrogante, ricattatorio) pontifica su tutto e tutti,
dispensando ridicole ricette economiche dietro le quali s'intravedono speranze
di nuovi affari», scrive Giampaolo Pansa.
Silvio Berlusconi giurò da fratello il 26 gennaio 1978 nella sede romana
della P2 in via Condotti, con il grado di apprendista, tessera numero 1816. E in
quel sodalizio tra il Gran Maestro e il Cavaliere c'era un'intuizione potente:
che per attuare il piano di rinascita e conquistare l'Italia non servivano le
bombe sui treni ma il Mundialito, il mini-mondiale di calcio in Uruguay
strappato alla Rai dalla tv del Biscione grazie alla mediazione di Gelli. Non ci
voleva il colpo di Stato, bastava "Colpo grosso". Tra i due personaggi distanti
in tutto, uno dedito ai segreti, l'altro all'immagine, c'è in realtà la stessa
concezione del mondo. In cui le relazioni valgono più delle regole, le lobby
occulte e trasversali contano di più delle appartenenze visibili, la fedeltà
alle istituzioni va scavalcata da doppie, triple fedeltà non dichiarate. Gelli
se ne va e a leggere le cronache di questi giorni si direbbe che abbia vinto
lui. Le vicende bancarie di questi giorni, con la ghirlanda di relazioni
intrecciata attorno alla Banca Etruria, fiore all'occhiello di Arezzo, la città
del Venerabile. Lo scandalo vaticano di ricatti incrociati e millanterie. Il
ritrovato attivismo di Luigi Bisignani, il più giovane tra i nomi comparsi nella
lista dei piduisti (lui ha sempre negato, naturalmente: «Non avevo neppure l'età
per iscrivermi»). La P3, la P4, numerate con scarsa fantasia, per certificare il
marchio di origine, il logo di successo. Quante volte, in questi ultimi anni, in
questi ultimi mesi, ci siamo sorpresi ad avvertire in alcune carriere improvvise
l'inconfondibile odore della P2, gli stessi metodi, a volte le stesse persone. I
burattinai o presunti tali si sono moltiplicati nei palazzi, solo che la posta
in gioco è più meschina, non c'è il grande gioco della guerra fredda che serviva
a nascondere i piccoli affari. E ancora più avvilenti sono i protagonisti:
banchieri di provincia, monsignori allupati, ragazze esibizioniste, faccendieri
invecchiati... «Se la loggia P2 è stata politica sommersa, essa è contro tutti
noi che sediamo in questo emiciclo. Questo è il sistema democratico che in
questi quaranta anni abbiamo voluto e costruito con il nostro quotidiano
impegno: non può esservi posto per nicchie nascoste o burattinai di sorta». Con
queste parole, il 9 gennaio 1986, Tina Anselmi presentava nell'aula della Camera
le conclusioni della commissione parlamentare di inchiesta sulla P2 da lei
presieduta. Trent'anni dopo Gelli se ne va. Ma ancora c'è tanto da fare per
custodire la Repubblica e le sue istituzioni, la trasparenza della democrazia,
dai suoi eredi, i suoi imitatori, i suoi fratelli. I tanti Gelli d'Italia che si
aggirano tra di noi.
Quando Licio
bocciò Silvio,
scrive Gianfrancesco Turano il
16 dicembre 2015 su "L'Espresso".
È morto Licio
Gelli, 96 anni, fascista vertical che
passerà alla storia per avere legittimato in quasi un secolo di vita il sistema
del potere oligarchico attraverso l'associazionismo segreto. Che si chiamasse loggia
P2 o altrimenti, per l'Aretino non faceva grande differenza purché
depotenziasse la democrazia nell'unico modo ammesso dai sistemi politici
dell'Occidente: l'oligarchia,
appunto. L'unica cosa che Gelli non poteva tollerare, da ex fautore del sistema
autocratico, erano le imitazioni. Per questo, cinque anni fa, sconfessò il suo
ex iscritto e Nostro Caro Leader Silvio
Berlusconi in un'intervista all'Espresso. La malattia e una sua certa
vicinanza, puramente territoriale, con elementi del governo in carica hanno
forse impedito al Venerabile
Maestro di esprimersi compiutamente sulla squadra di Matteo Renzi. In
modo alquanto compassato, Gelli ha criticato come goffe le riforme, poco più di
un anno fa, e ha usato il termine "bambinone" per il primo ministro senza
chiarire chi siano i genitori dell'infante.
Il paleocraxiano Rino Formica, felice inventore dell'espressione
"sinistra ferroviaria", ha attribuito la paternità del renzismo proprio a Gelli
e al suo Piano
Rinascita in un'interemerata risalente al marzo 2014. Esagerato? Di certo
l'Istituzione, cioè la massoneria, ha continuato fino a oggi ad avere un
rapporto contrastato amore-odio verso il "fratello che sbaglia" Licio. La sua
influenza reale è però stata continua, costante, a dispetto dei proclamati
rinnovamenti di grembiuli e cappucci. La morte di Gelli arriva quasi
contemporanea alla dipartita verso l'Oriente Eterno di Armando
Cossutta e della Popolare
dell'Etruria e del Lazio. Il primo ha rappresentato per anni l'Urss
all'interno del Pci. La seconda è la banca aretina appena fallita dopo decenni
di gestione del massonissimo Elio Faralli, scomparso a 91 anni nell'aprile 2013.
La morte è trasversale. Una specie di massoneria. Il Raguno invernale è
intitolato, ovviamente, al Venerabile. Si invitano i partecipanti a vestirsi in
modo adeguato. In attesa di comunicare gli indirizzi delle migliori boutique di fashion massonica,
vorrei pregare GLU di
interrompere i servizi di Discovery Channel che ama accompagnare all'iniziativa.
La scelta del luogo è di pertinenza del Venerabile
BM, clonato e seviziato dalle suore nel Raguno Gaetano di semifausta
memoria. Propenderei per Roma dove si trovano i migliori grembiuli in pelle
d'agnello. Se no Abruzzo, dove abbondano i suscuoiati agnelli. PS Mi sono appena
accorto che questo è il post numero 333 di RdC.
Ça ne s'invente pas.
Gelli: "Sono le mie brutte
copie". "Il
governo Berlusconi si è abbeverato al mio Piano di Rinascita nazionale. Ma il
premier non è in grado di realizzarlo". Parla l'ex capo della Loggia P2, scrive Gianfrancesco
Turano il 20 giugno 2010 su “L’Espresso”.
"La democrazia è
una brutta malattia, una ruggine che corrode. Guardi quello che accade in
Grecia, in Spagna, in Portogallo: anarchia completa". In partenza, Licio Gelli è
coerente con il credo di una vita giunta al traguardo dei 91 anni: ordine e
disciplina. Eppure no. Il Venerabile della poco disciolta loggia P2 non può
godere appieno del successo della sua creatura, quel Piano di Rinascita che per
Antonio Di Pietro e molti altri oppositori è la stella polare dell'esecutivo. "È
vero", sostiene Gelli: "Gli uomini al governo si sono abbeverati al mio Piano di
Rinascita, ma l'hanno preso a pezzetti. Io l'ho concepito perché ci fosse un
solo responsabile, dalle forze armate fino a quell'inutile Csm. Invece oggi vedo
un'applicazione deformata".
Non è contento dell'esecutivo?
"Ho grandi
riserve. Ci sono gli stessi uomini di vent'anni fa e non valgono nulla. Sanno
solo insultarsi e non capiscono di economia. Tremonti è un tramonto. Il
Parlamento è pieno di massaggiatrici, di attacchini di manifesti e di indagati.
Chi è sotto inchiesta deve essere cacciato all'istante, al minimo sospetto".
Almeno il suo ex iscritto Silvio Berlusconi ha la sua
benedizione?
"Io sono un
laico. Non do benedizioni ma certamente non condivido ciò che accade per sua
volontà. Anche certe questioni private si risolvono in famiglia. Deve essere
meno goliardico".
Vede in lui il realizzatore del Piano Rinascita?
"Non è adatto.
Inoltre, non ha molti collaboratori di valore".
Pensa che sia vittima della pressione leghista?
"La Lega per me
è un pericolo. Sta espropriando la sostanza economica dell'Italia. Le bizzarrie
di Umberto Bossi hanno già diviso il Paese. Bisogna dire basta".
Altri segnali di crisi?
"I partiti non
esistono più e i leader attuali passano il Rubicone con tre tessere in tasca.
Non bisogna riformare solo la giustizia, ma prima di tutto l'economia e la
sanità".
Ci tranquillizzi, dottor Gelli. Lei non sta diventando di
sinistra?
"Io sono per il
buon senso. Sono per il benessere al popolo che oggi patisce, non arriva al 20
del mese. Qui siamo oltre i margini della rivolta. Siamo alla Bastiglia".
Filippo Facci il 17 luglio
2014 su “Libero Quotidiano”: "Aveva ragione Gelli". Se Hitler era vegetariano
(che poi non lo era) non è che allora ci strafoghiamo di carne. Del resto Hitler
fece la prima campagna antifumo: non è che allora ci ammazziamo di canne. A
Stalin piaceva Mozart: non è che allora ascoltiamo tutti Peppino di Capri.
Eccetera. Il discorso è demenziale ma serve a dire che persino Licio
Gelli poteva aver ragione in alcune cose: non perché fosse un genio visionario,
ma perché il suo Piano di Rinascita democratica sosteneva anche dei progetti in
parte banali e in parte condivisi da democrazie di tutto il mondo. Ecco perché
esorcizzare i tentativi di riforma paragonandoli a quanto scriveva Gelli nel
1976 - vedi Il Fatto di martedì - resta di un livello intellettuale
annichilente, minestra riscaldata persino per un pubblico para-grillino. Un
Parlamento semplificato, un Senato regionale, un premier eletto dalla Camera, i
decreti legge non emendabili, dei limiti all'ostruzionismo, l'abolizione delle
province, riduzione dei parlamentari: la verità è che certi propositi piduisti
erano di assoluta usualità; oppure, come nel caso dell'Italicum, erano delle
oasi di democrazia se paragonati alle liste bloccate che ci vanno cucinando.
Altre proposte di Gelli, poi, non sono né banali né moderate: sono dei sogni.
Tipo "dissolvere la Rai in nome della libertà di antenna" o ancora la chimera
della "responsabilità civile dei magistrati": quella vera, non l'inapplicabile
legge Vassalli o il consommè che il ministro Andrea Orlando va preparando.
Licio Gelli al Fatto: “Il
bambinone Renzi e gli ex lacchè di Berlusconi”.
Il Venerabile della Loggia P2 dice la sua sulle ultime mosse del governo: "Le
riforme sono goffe". E sull'Italia di oggi: "Sono felice che vengano a galla le
responsabilità della cattiva politica", scrive di Marco Dolcetta il 23 maggio
2014 su “Il Fatto Quotidiano”. Di questi tempi sia la schiena che il cuore
stanno dando qualche problema a Licio Gelli. Il 96enne Venerabile della Loggia
P2, nonostante la voce affaticata, mantiene una certa energia verbale: “Lei deve
sapere che sono entrato nei Servizi di intelligence dello Stato italiano dopo un
incontro con Mussolini che voleva conoscermi. Io, il volontario ‘Licio Gommina’
della guerra civile di Spagna, nella quale aveva perso la vita mio fratello. Il
Duce mi chiese quale poteva essere la ricompensa che lo Stato italiano poteva
dare alla mia famiglia. In quella occasione, gli dissi che senz’altro mi sarebbe
interessato conoscere il mondo dei Servizi segreti… Da allora non ne sono più
uscito”.
Ma che ne pensa
dell’attualità italiana e di Renzi?
Renzi è un bambinone, visto il
suo comportamento che è pieno di parole e molto ridotto nei fatti: non è
destinato a durare a lungo… Comunque, non è mai stato (né lui né i suoi
familiari) nella massoneria. Vedo che nel suo governo ci sono molte giovani
donne che io personalmente vedrei molto meglio a occuparsi d’altro…”.
E le riforme del premier?
Quelle di Renzi, per la legge
elettorale e il Senato, sono goffe. Per quanto riguarda Palazzo Madama, mi fa
piacere pensare che, nonostante tutti mi abbiano vituperato, sotto sotto mi
considerano un lungimirante propositore di leggi; una quarantina di anni fa, con
Rodolfo Pacciardi, scrivemmo, su invito dell’allora presidente Giovanni Leone,
il cosiddetto Piano R., di Rinascita nazionale. Prevedeva una serie di norme e
riforme che avrebbero potuto creare i fondamenti per uno Stato più efficace.
Leone fu eletto presidente della Repubblica grazie ai voti della massoneria: lui
mi ringraziò e poi mi chiese questo contributo. Così gli facemmo avere il testo
del Piano R., cui lui non diede mai alcun riscontro e, anzi, da allora evitò di
incontrarmi… Riguardo al Piano di Rinascita democratica, sfogliando le pagine di
quel testo, si ritrova – nella parte riguardante le riforme istituzionali – una
quasi totale abolizione del Senato. Riducendone drasticamente il numero dei
membri, aumentando la quota di quelli scelti dal presidente della Repubblica e
attribuendo al Senato una competenza limitata alle sole materie di natura
economica e finanziaria, con l’esclusione di ogni altro atto di natura politica.
L’intento era ed è ancora oggi chiaro. Dare un taglio effettivo a un ramo del
Parlamento che, storicamente, ha maggiore saggezza e cultura non solo politica,
a favore di una maggiore velocità nel fare leggi e riforme. Ricordo di averne
parlato in seguito, quando veniva a trovarmi ad Arezzo, anche con la mia amica
Camilla Cederna”.
In tema di amici, che ne
pensa della carriera letteraria di Luigi Bisignani?
Più che mio amico, Luigi è mio
figlioccio. Quando era ancora giovane, dopo la scomparsa di suo padre, sia io
che Gaetano Stammati ci prendemmo cura di lui. Avevo e ho sempre avuto una
grande stima di Luigi. Tanto che, quando nacque il progetto dell’Organizzazione
Mondiale del Pensiero e dell’Assistenza Massonica, a Roma, il 1 gennaio 1975,
decidemmo di affidargli l’incarico di addetto stampa, perché eravamo certi di
poter fare pieno assegnamento sulla sua preziosa collaborazione…”.
Lei con la Svizzera ha un
rapporto particolare, conosce bene le galere ma anche le banche di quel Paese…
Sì, soprattutto quando mi sono
stati sottratti dai giudici milanesi diversi milioni di franchi che risultavano
il frutto lecito di mia mediazione internazionale e che furono destinati a
risarcire piccoli azionisti del Banco Ambrosiano dopo le note vicende che mi
videro ingiustamente coinvolto. Ma nonostante tutto, ho accettato questo
risarcimento forzato. La cosa più sorprendente, però, è che quei soldi non sono
stati mai destinati a piccoli azionisti, tanto che da tempo io, assieme al loro
legale, l’avvocato Gianfranco Lenzini di Milano, ho presentato richiesta di
chiarimenti in tutte le sedi, ma senza alcun risultato”.
Come spiega il caso Renzi,
la sua veloce ascesa, e cosa prevede per il futuro?
Beh, Renzi è un fenomeno
parzialmente italiano, e mi risulta che fra i suoi mentori politici ci siano
persone che vivono a Washington. È circondato, però, da mezze tacche: gli ex
lacchè di Berlusconi. Fini, che ho conosciuto bene, quando faceva l’attendente
ossequioso di Giorgio Almirante cui prestavo denari per il Msi. Soldi sempre
resi… quello sì che era uomo di parola. E poi Schifani, Alfano: personaggi non
certo di livello. Berlusconi ha sbagliato con le giovani donne, ma soprattutto
circondandosi di personaggi di bassa levatura… Penso a Verdini, un mediocre uomo
di finanza; è un massone… credo, ma non della nostra squadra. Il più alto
livello di maturità politica in Italia c’è stato con Cossiga e Andreotti che
avevano entrambi dei sistemi di controllo politico, uno con ‘Gladio’ e l’altro
con Anello, cosa che Berlusconi non è mai riuscito a ripetere. E si sono visti i
risultati di questa sua incapacità…”.
Per concludere, che ne
pensa dell’Italia, e del suo futuro?
Non le nascondo che vedo, con
una certa soddisfazione, il popolo soffrire. Non mi fraintenda: non sono felice
di questa situazione. Sono felice, invece, che vengano sempre più a galla le
responsabilità della cattiva politica. Perché, probabilmente, solo un tributo di
sangue potrà dare una svolta, diciamo pure rivoluzionaria, a questa povera
Italia”. Da Il Fatto Quotidiano del 23 maggio 2014
A SINISTRA SI E’ PIU’ INTELLIGENTI?
Le persone di sinistra sono più
intelligenti? Si Chiede su “La mente è Meravigliosa”.
“Tutti i giorni la gente si sistema i capelli, perché non il cuore?” Vi sembra
una frase intelligente? Queste parole sono state formulate dalla mente di
Ernesto Che Guevara, il famoso rivoluzionario. Ci sono molte altre citazioni
epiche di questo mito che sono sopravvissute fino ai giorni d’oggi. Ciò ha forse
a che vedere con la sua ideologia di sinistra? Uno studio della Brock
University sostiene di sì. Lo studio della Brock University nell’Ontario,
Canada. Secondo i risultati ottenuti dai ricercatori della Brock University,
nell’Ontario, Canada, coloro che sono meno intelligenti già durante l’infanzia
sviluppano un’ideologia di destra e tendenze razziste e omofobe, rispetto alle
ideologie di sinistra, che sono più aperte e comprensive.
Per giungere a questa conclusione, i ricercatori si sono basati su
studi condotti negli anni 1958 e 1970 nel Regno Unito. Questi studi analizzarono
il livello d’intelligenza di migliaia di bambini tra i 10 e gli 11 anni, che poi
risposero a domande di politica una volta raggiunta l’età di Cristo, 33 anni.
Tra le domande poste ai bambini ormai adulti, c’erano questioni riguardo
i pregiudizi di vivere affianco a vicini di una razza diversa o sulle
preoccupazioni che sorgono quando bisogna lavorare con qualcun altro. Altre
domande alle quali dovettero rispondere i soggetti riguardavano l’ideologia
politica conservatrice, come rendere più severe le pene dei criminali o mostrare
ai bambini la necessità di ubbidire all’autorità. Le persone di sinistra sono
davvero più intelligenti? Alcune delle conclusioni a cui sono giunti i
ricercatori della Brock University sostengono che i politici conservatori
facilitano la nascita di pregiudizi. Basandosi sui risultati delle ricerche
inglesi, i ricercatori sostengono che le persone meno intelligenti si
localizzano nello spettro della destra politica, perché qui si sentono più
sicuri. Secondo i creatori di questo studio, è l’intelligenza innata a
determinare il livello di razzismo di una persona, molto più dell’educazione e
dell’istruzione. Nemmeno lo status sociale ha un ruolo importante a proposito.
Semplicemente affermano che l’ideologia conservatrice è la via giusta per
trasformare bambini che hanno difficoltà a ragionare in persone razziste. Le
capacità cognitive sono fondamentali per avere una mente aperta. Ciò significa
che coloro che hanno capacità cognitive ridotte o molto ridotte tendono ad
adottare ideologie conservatrici per la sensazione di ordine che implicano.
Questa è un’altra delle conclusioni dello studio. Intelligenza innata. Secondo
le ricerche condotte dalla Brock University, tutto ciò significa che
l’intelligenza innata ha un ruolo determinante nell’ideologia ultima adottata da
un individuo. Questo significa che essere di destra è sinonimo di stupidità?
Assolutamente no. Oggigiorno, in tutto il mondo le ideologie politiche sono un
po’ ingarbugliate. Niente è più ciò che sembra. Possiamo definire un regime
comunista come quello imposto in Corea del Nord di sinistra? Qui, i cittadini si
sono abituati a vivere sotto gli ordini di un dittatore che si definisce
d’ideologia progressista, ma che manipola i destini di milioni di persone con un
pugno di ferro. Esistono altri esempi di paesi in cui si è tentato di stabilire
un regime di sinistra e comunista, ma senza successo. Russia o Cuba, per
esempio, hanno sofferto terribili repressioni popolari durante la fase della
dittatura del proletariato, che alla fine si è trasformata nel mandato di un
singolo leader come Stalin o Castro, con accesso limitato alla libertà o al
pensiero. Ciò significa che, tra i partiti della sinistra mondiale, c’è gente
camuffata che in realtà è di destra? È possibile che nell’ideologia progressista
si siano infilate persone poco intelligenti che in realtà sono conservatori? Non
esiste una risposta chiara a questo tipo di domande, poiché le ideologie hanno
sempre meno peso in un mondo mosso meramente da interessi economici e dei
partiti. In realtà, ciò che importa è avere una mente aperta e curiosa. Imparate
da tutti coloro che hanno qualcosa da apportarvi nella vita. Se non avete
un’intelligenza innata che apra la vostra mente, almeno stimolate la
vostra intelligenza emotiva. Siate sensibili a qualsiasi tipo di tendenze e modi
di essere e adottate una vita piena e felice. Come diceva Ernesto Che
Guevara, se siete in grado di avere capelli splendenti, siete anche capaci di
avere un cuore nobile e buono.
BRUNO TINTI E IL MALVEZZO DI SCRIVERE ARTICOLI PER NULLA CALZANTI,
scrive Francesco Maria
Toscano su “Il Moralista”.
Il magistrato Bruno Tinti, blogger in forza al Fatto Quotidiano,
ha oggi scritto un pezzo, pubblicato nella versione cartacea del giornale
diretto da Padellaro, per criticare la sempiterna “mania di complottismo” ora
sublimata dall’uscita del libro “Massoni” scritto da Gioele Magaldi per
Chiarelettere. Al netto di qualche divagazione storica non sempre pertinente,
Tinti non riesce però a contestare nel merito alcunché. La prima cosa da fare
per valutare bene la qualità di un testo dovrebbe essere quella di leggerlo con
attenzione. O perlomeno di leggerlo e basta. Non so se Tinti abbia studiato in
profondità le questioni poste da Magaldi con prosa asciutta ed invidiabile
acribia. A leggere il suo articolo si direbbe però di no, contenendo perlopiù
raffronti raffazzonati e per nulla calzanti che tentano maldestramente di
bollare l’opera del Gran Maestro del Grande Oriente Democratico con il marchio
del complottismo spiccio. Quindi, tralasciando una serie di considerazioni
preliminari avulse dal contesto e messe in fila a casaccio, dalle scie
chimiche al ruolo delle multinazionali, dal caso Ferraro alla
banda Baader-Meinhof, per finire con l’immancabile Licio Gelli, andrei
subito al punto. E’ chiaro infatti il tentativo di Tinti di mischiare un lavoro
puntuale e scrupoloso, quello di Magaldi per l’appunto, con teorie strampalate e
improbabili nella speranza di costringere il lettore a non poter più distinguere
le cose serie da quelle ridicole. Si tratta di una tecnica narrativa ampiamente
conosciuta, questa sì suggestiva e di tipo sensazionalistico, in genere nemica
del ragionamento socratico, pacato e razionale. A cosa serve infatti tirare in
ballo la storia di un magistrato dichiarato affetto da disturbi mentali se non a
lasciar surrettiziamente intendere che anche Magaldi, forse, è un po’ pazzo?
Allo stesso modo, a cosa serve riesumare per l’occasione la vecchia vicenda
di Igor Marini se non ad insinuare il dubbio volto a fare credere che, in fin
dei conti, anche questo Magaldi è potenzialmente un calunniatore provetto? Trovo
poco nobile questo modo di recensire un libro che sta riscuotendo un grande
successo. Non mi pare poi che né l’ex magistrato Ferraro né il sedicente
conte Igor Marini siano mai stati autori di Chiarelettere, onde per cui
l’editore Lorenzo Fazio dovrebbe forse spendere qualche parola a tutela della
serietà e della credibilità della casa editrice che con passione guida. A questo
punto, finita la lunga ma necessaria premessa, andiamo al sodo. Cosa lamenta
Tinti? Lamenta principalmente la mancanza di documenti a supporto delle tesi
articolate dal Magaldi, non accontentandosi della spiegazione che giudica
sconveniente l’appesantimento di un’opera, corposa ma scorrevole e avvincente,
per il tramite di mille documenti dal taglio spiccatamente burocratico. Ribalto
l’impostazione. Magaldi ha detto chiaramente di essere pronto a fornire le prove
in caso di specifiche e plateali contestazioni da parte dei diretti interessati.
Cosa aspettano quindi i vari Napolitano, Draghi, Merkel e Monti, tutta gente caruccia
e a modo a voler dare retta all’affresco proposto da Tinti, a sbugiardare la
ricostruzione del Magaldi? Perché, ad esempio, l’ufficio stampa del Quirinale,
con esplicito riferimento al libro “Massoni, società a responsabilità
illimitata” (Chiarelettere editore), non dirama una bella nota ufficiale per
dire che il Presidente della Repubblica non è mai stato iniziato nelle loggia “Three
Eyes”? Forse per le stesse ragioni per le quali nessuno mai si sognò di
smentire o di approfondire le rivelazioni dell’ex ministro del Tesoro
americano Tim Geithner, buone per smascherare le trame messe in campo da alcuni
“alti dignitari europei” che vollero e ottennero l’arrivo al potere in
Italia dell’irreprensibile Mario Monti? Chi lo sa, magari pure Geithner,
al pari di tanti altri, crede alle scie chimiche e agli omini verdi. Anziché
difendere acriticamente l’operato di un banchiere centrale come Draghi,
unanimemente ritenuto fra i massimi responsabili della crisi in atto, il
magistrato Tinti dovrebbe forse invitare molti potenti a smentire o, semmai,
a querelare. Questo sarebbe l’unico modo per ottenere quelle “pezze
d’appoggio” che in tanti sperano legittimamente di poter prima o poi
visionare. Se però nessuno dice niente mentre tutti gli alti
papaveri citati scelgono la via dell’imbarazzato silenzio, un motivo magari ci
sarà. E un magistrato come Bruno Tinti dovrebbe probabilmente chiedersi quale.
Tortura per chiunque osi ribellarsi,
Genova fu solo l’inizio, scrive “Libreidee”. La folla che riempie lo stadio di
La Spezia, un silenzio livido e uno spettro sul palco, Bob Dylan, alle prese con
uno strano concerto segnato dal lutto per la morte di Carlo Giuliani poche ore
prima, a una manciata di chilometri di distanza, in mezzo alla follia criminale
esplosa a Genova dopo un’accurata preparazione logistica e militare. Lo ha detto
un ex dirigente della Nsa, Wayne Madsen, intervistato da Franco Fracassi nel
libro “G8 Gate”: i colossi finanziari e le multinazionali che avevano portato
Bush al potere temevano i No-Global più di ogni altra cosa, inclusa Al-Qaeda.
Per questo furono ben 1.500 gli agenti della National Security Agency impegnati
nell’operazione-Genova, insieme a 700 operatori dell’Fbi. Missione: organizzare
(e far eseguire alla polizia italiana) la più feroce punizione collettiva della
storia occidentale contemporanea. Lo conferma il
generale Fabio Mini, già comandante della missione Nato in Kosovo: esistono
“strutture” abilitate a smistare falsi militanti, facendoli passare indenni
attraverso più frontiere. Loro, i black bloc, incaricati di devastare Genova in
modo da creare un alibi per la repressione indiscriminata dei manifestanti
pacifici. Fino al reato di tortura, ora contestato all’Italia, 14 anni dopo.
A Genova nel 2001 accadde qualcosa di irreparabile e sinistramente profetico,
scrive “Come Don Chisciotte”: «Nell’arco di una manciata di giornate ci
accorgemmo di essere stati proiettati e letteralmente catapultati nel nuovo
millennio». Di colpo, ci siamo scoperti «ingenui figli di un tempo già antico,
quel ventesimo secolo che, nonostante l’atomica e i lager, non aveva
completamente scalfito le speranze in un mondo migliore». Il funerale delle
illusioni: «La nostra Italietta – così piccola e così gracile – sarà pure stata
anche la Repubblica delle stragi impunite, delle molte mafie e della corruzione
dilagante, ma, ai nostri occhi, rimaneva l’imperfetta democrazia che i padri
costituenti ci avevano consegnato per attuare concretamente i principi di
uguaglianza e libertà. Invece – scrive “HS” – quello che accadde superò la
nostra immaginazione». Sepolta, a Genova, anche l’ingenuità fisiologica del
movimentismo, che in fondo «non abbandona l’illusione che si possa dialogare con
l’avversario per riformare il sistema in senso migliorativo». Il movimento
No-Global bisognava «domarlo, criminalizzarlo e reprimerlo in nome del
neoliberismo “neomercantile”», togliendo ai giovani l’arma della politica
e della giustizia. Hanno vinto loro, conclude
il blog: i ragazzi di oggi non hanno idea di cosa accadde davvero a Genova,
perché ormai «appartengono a un altro mondo», nel senso che «sono cresciuti in
un contesto in cui la digitalizzazione dei segni, dei simboli e pure dei
comportamenti ha quasi oscurato il senso concreto e tangibile delle cose», con
la sua spietata durezza. All’epoca della mattanza genovese, Google e YouTube
«appartenevano ancora al regno del “futuribile” e del realizzabile». Ora, il
paesaggio antropologico è irriconoscibile: «In un certo qual modo smartphone,
blueberry, iPod, Whatsapp, Twitter, Facebook e compagnia cantante sono diventati
parte integrante delle nostre vite, e per i nostri figli o nipoti non è quasi
concepibile un mondo senza la tecnologie digitali. Nel nostro nuovo mondo
postmoderno digitalizzato e “virtualizzato” il tempo scorre via veloce come lo
scoccare di una scintilla nel buio, si scompone in fantastiliardi di
millisecondi, frazionati e separati, insinuando un senso di comprensibile vuoto
e di assenza di memoria». Oggi la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo condanna
l’Italia per gli atti di tortura inflitti ai manifestanti dalle forze
dell’ordine nell’Istituto Pascoli? Confinare le giornate di Genova in quelle
aule, dove raggiunse il culmine l’ultimo atto di feroce violenza repressiva,
«significa smarrire il senso di quelle ore». Perché nel capoluogo ligure «era
accaduto qualcosa di definitivo e irreparabile, qualcosa che non avrebbe potuto
essere cancellato lavando quei muri imbrattati di sangue». In realtà, continua
il blog, «non abbiamo mai compreso fino in fondo quanto possano contare le
parole e i consigli degli “ingegneri sociali”, degli esperti di sociologia,
psicologia, antropologia, di questioni militari, geopolitiche, strategiche, di
sicurezza e ordine pubblico», perché in fondo siamo rimasti «ragionevoli uomini
democratici e perbene». Per questo non ci siamo accorti di essere diventati
«altro che le cavie di uno dei più arditi esperimenti mai tentati fino ad allora
in un paese dell’Occidente civile e avanzato». Come se in quella torrida estate
del 2001 il capoluogo ligure «si fosse trasformato in un enorme laboratorio per
applicare i nuovi modelli militarizzati e tecnologicamente avanzati di gestione
dell’ordine pubblico». Di lì a poco, «Ground Zero avrebbe cancellato tutte le
residue speranze per un “altro mondo possibile”, e dalla guerriglia e
controguerriglia urbane artificiosamente costruite, si passava alla guerra
permanente e globale», con tanti saluti alle belle speranze del movimento
No-Global, che pretendeva pari opportunità e diritti per l’intera umanità. Nel
suo libro “Massoni”, Gioele Magaldi illumina le pagine più oscure e confuse
della nostra storia recente, rivelando il ruolo spesso decisivo delle
“Ur-Lodges”, le superlogge latomistiche dell’élite cosmopolita che sovrintende
alle grandi decisioni, anche attraverso istituzioni transnazionali e
“paramassoniche” come la Commissione Trilaterale, il Bilderberg, i grandi
think-tank che orientano la dirigenza finanziaria, industriale, bancaria,
editoriale, culturale, politica, giornalistica. Magaldi, a sua volta massone e
associato alla prestigiosa superloggia “Thomas Paine”, nonché animatore del
“Movimento Roosevelt” che si propone di scuotere la politica italiana ed europea
liberandola dal dogma neoliberista che impone il taglio dello Stato, accusa
anche l’ambiente massonico internazionale più progressista, colpevole di aver
aderito a cuor leggero già nel 1981 allo storico patto “United Freemasons for
Globalization”. Una stretta di mano con i più pericolosi oligarchi che, di lì a
poco, avrebbero precipitato il pianeta nella privatizzazione universale.
Genocidio di popoli, guerre, rapina delle risorse, delocalizzazioni criminose e
scomparsa del lavoro e dei diritti sindacali, fino all’agonia inconcepibile del
sistema industriale più evoluto del mondo, l’Europa, messa in ginocchio
dall’austerity finanziaria pianificata a tavolino dai supremi globalizzatori.
Paolo Franceschetti, ex avvocato e indagatore di strani delitti rituali, riletti
come cerimonie del massimo potere oligarchico, si sforza di vedere il bicchiere
mezzo pieno: la storia dell’umanità è lastricata di abusi abominevoli, se oggi
li si denuncia significa che sta crescendo una consapevolezza diffusa che, prima
o poi, cambierà l’orizzonte. Inutile stupirsi della ferocia del supremo potere:
lo sostengono voci diversissime tra loro, per formazione e provenienza. Per
esempio Paolo Ferraro, prestigioso magistrato allontanato dalla magistratura. O
un ex dirigente dei servizi segreti come Fausto Carotenuto. O Paolo Barnard, il
primo a denunciare la brutale restaurazione europea, col saggio “Il più grande
crimine”. O, ancora, un massone come Gianfranco Carpeoro, allievo di Francesco
Saba Sardi e grande studioso del linguaggio simbolico. Dal canto suo, Magaldi
esprime un’indignazione lucida e pacata: lo Stato laico, moderno e democratico,
fatto di cittadini e non più di sudditi, «non è stato un regalo della cicogna»,
ma dall’intellighenzia massonica occidentale, impegnata in una lotta
plurisecolare contro l’oscurantismo e l’assolutismo. Per questo, insiste, è
necessario che insorga il vertice massonico progressista, il solo in grado di
contrastare – a livello elitario – la deriva neo-feudale del nuovo potere che,
col pretesto di una crisi artificiale costruita a tavolino, sta smantellando la
democrazia in tutto l’Occidente. I ragazzi di Genova, che nel 2001 volevano
diritti estesi a tutti i popoli del mondo, mai si sarebbero aspettati che
quegli stessi diritti considerati inviolabili – a
cominciare dall’accesso al lavoro – sarebbero stati presto perduti anche qui,
nel cuore di un’Europa devastata dalle leggi speciali imposte dall’élite
tecnocratica attraverso il braccio secolare di una moneta unica non sovrana. La
scomparsa dell’orizzonte cominciò proprio nelle piazze genovesi trasformate in
campo di battaglia: «Genova per noi è stato solo il primo dei tanti esperimenti
di ingegneria sociale volti a spezzare qualsiasi volontà di resistenza nei
confronti di un sistema iniquo e ingiusto», osserva “Come Don Chisciotte”.
«Deposte l’immaginazione e la volontà di cambiamento siamo solo diventati più
gretti, cinici ed egoisti». Per questo, i globalizzatori dell’abuso «hanno vinto
su tutta la linea». De Gennaro resta al suo posto, alla presidenza di
Finmeccanica? Ovvio. Lo difende Renzi, l’uomo che in nome delle riforme
strutturali dettate dalla Troika e da Wall Street abolisce Senato e Province,
introduce il licenziamento facile con il Jobs Act e costruisce una legge
elettorale monarchica. La differenza, rispetto al 2001, è che nessuno scende più
in piazza. Pochi si accorgono di quello che sta realmente accadendo,
nell’area-test chiamata Europa. Al pessimismo
universale dei blogger si oppone la voce di Magaldi: insieme alla Francia,
sostiene, l’Italia è il solo paese in cui è possibile far partire qualcosa che
assomigli a un risveglio. Non a caso, la “punizione” dell’infame G8 del 2001 fu
progettata proprio in Italia. Ed era solo l’inizio: la “tortura” continua:
Genova era solo l’inizio.
L'UGUAGLIANZA E L’INVIDIA SOCIALE.
Frasi, citazioni e aforismi
sull’uguaglianza. Pubblicato da Fabrizio Caramagna.
Nasciamo uguali, ma l’uguaglianza cessa dopo
cinque minuti: dipende dalla ruvidezza del panno in cui siamo avvolti, dal
colore della stanza in cui ci mettono, dalla qualità del latte che beviamo e
dalla gentilezza della donna che ci prende in braccio. (Joseph Mankiewicz)
Tutti gli uomini nascono uguali, però è l’ultima
volta in cui lo sono. (Abraham Lincoln)
Ognuno è impastato nella stessa pasta ma non cotto
nello stesso forno. (Proverbio Yiddish)
Dovunque sono uomini, sono diversità di opinioni,
disparità di sentimenti, differenza di umori, tali e tante variazioni temporanee
o permanenti, che il consenso perfetto è impossibile, non dico fra tutti o fra
molti, ma fra pochi, fra due. (Federico De Roberto)
Equa distribuzione della ricchezza non significa
che tutti noi dovremmo essere milionari – significa solo che nessuno dovrebbe
morire di fame. (Dodinsky)
L’uguaglianza sarà forse un diritto, ma nessuna
potenza umana saprà convertirlo in un fatto. (Honoré de Balzac)
È falso che l’uguaglianza sia una legge di natura:
la natura non ha fatto nulla di eguale. La sua legge sovrana è la subordinazione
e la dipendenza. (Marchese di Vauvenargues)
L’uguaglianza consiste nel ritenerci uguali a
coloro che stanno al di sopra di noi, e superiori a coloro che stanno al di
sotto. (Adrien Decourcelle)
Egalitarista. Il genere di riformatore politico e
sociale interessato a fare scendere gli altri al proprio livello più che a
sollevarsi a quello degli altri. (Ambrose Bierce)
In America tutti sono dell’opinione che non ci
sono classi sociali superiori, dal momento che tutti gli uomini sono uguali, ma
nessuno accetta che non ci siano classi sociali inferiori, perché, dai tempi di
Jefferson in poi, la dottrina che tutti gli uomini sono uguali vale solo verso
l’alto, non verso il basso. (Bertrand Russell)
Ci sono due dichiarazioni sugli esseri umani che
sono vere: che tutti gli esseri umani sono uguali, e che tutti sono differenti.
Su questi due fatti è fondata l’intera saggezza umana. (Mark Van Doren)
Davanti a Dio siamo tutti ugualmente saggi… e
ugualmente sciocchi. (Albert Einstein)
Perché noi non siamo né al di sopra né al di sotto
del resto: tutto quello che è sotto il cielo è sottoposto a una stessa legge e a
una stessa sorte… Le anime degli imperatori e dei ciabattini sono fatte su uno
stesso stampo. (Michel De Montaigne)
L’uguaglianza deve essere quella delle
opportunità, non può essere ovviamente quella dei risultati. (John Dryden)
Ho letto tempo fa che nel futuro gli uomini
saranno tutti uguali. Ugualmente ricchi o ugualmente poveri? (Zarko Petan)
Gli uomini sono nati uguali ma sono anche nati
diversi. (Erich Fromm)
La figlia del re, giocando con una delle sue
cameriere, le guardò la mano, e dopo avervi contato le dita esclamò: “Come!
Anche voi avete cinque dita come me?!”. E le ricontò per sincerarsene. (Nicolas
Chamfort)
Noi sosteniamo che queste verità sono per sé
evidenti: che tutti gli uomini sono creati uguali; che sono dotati dal Creatore
di certi diritti inalienabili, tra i quali sono la vita, la libertà e la ricerca
della felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini i
governi, che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che, ogni
qualvolta una forma di governo diventi perniciosa a questi fini, è nel diritto
del popolo di modificarla o di abolirla. (Thomas Jefferson, Dichiarazione
d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America)
“Libertè, Egalitè, Fraternitè”. (Dichiarazione dei
diritti dell’uomo e del cittadino”, 1795)
Tutta la società diventerà un unico ufficio e
un’unica fabbrica con uguale lavoro e paga uguale. (Vladimir Lenin)
Il vizio inerente al capitalismo è la divisione
ineguale dei beni; la virtù inerente al socialismo è l’uguale condivisione della
miseria. (Sir Winston Churchill)
Allo stato naturale… tutti gli uomini nascono
uguali, ma non possono continuare in questa uguaglianza. La società gliela fa
perdere, ed essi la recuperano solo con la protezione della legge. (Montesquieu)
La prima uguaglianza è l’equità. (Victor Hugo)
L’uguaglianza ha un organo: l’istruzione gratuita
e obbligatoria. (Victor Hugo)
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
(Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 3, 1947)
Nessuno vi può dare la libertà. Nessuno vi può
dare l’uguaglianza o la giustizia. Se siete uomini, prendetevela. (Malcolm X).
Finché c’è una classe inferiore io vi appartengo,
finché c’è una classe criminale io vi appartengo, finché c’è un’anima in
prigione io non sono libero. (Eugene V. Debs)
Le lacrime di un uomo rosso, giallo, nero, marrone
o bianco sono tutti uguali. (Martin H. Fischer)
C’è qualcosa di sbagliato quando l’onestà porta
uno straccio, e la furfanteria una veste; quando il debole mangia una crosta,
mentre l’infame pasteggia nei banchetti. (Robert Ingersoll)
L’uguaglianza non esiste fin a quando ciascuno non
produce secondo le sue forze e consuma secondo i suoi bisogno. (Louis Blanc)
Amici miei, vi dico che, anche se dovrete
affrontare le asperità di oggi e di domani, io ho sempre davanti a me un sogno.
E’ un sogno profondamente radicato nel sogno americano, che un giorno questa
nazione si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni:
noi riteniamo ovvia questa verità, che tutti gli uomini sono creati uguali.
(Martin Luther King)
Vivere nel mondo di oggi ed essere contro
l’uguaglianza per motivi di razza o colore è come vivere in Alaska ed essere
contro la neve. (William Faulkner)
Fino a quando la giustizia non sarà cieca al
colore, fino a quando l’istruzione non sarà inconsapevole della razza, fino a
quando l’opportunità non sarà indifferente al colore della pelle degli uomini,
l’emancipazione sarà un proclama ma non un fatto. (Lyndon B. Johnson)
Un uomo non può tenere un altro uomo nel fango
senza restare nel fango con lui. (Booker T. Washington)
Viviamo in un sistema che sposa il merito,
l’uguaglianza e la parità di condizioni, ma esalta quelli con la ricchezza, il
potere, e la celebrità, in qualunque modo l’abbiano guadagnato. (Derrick A.
Bell)
Se le malattie e le sofferenze non fanno
distinzione tra ricchi e poveri, perché dovremmo farlo noi? (Sathya Sai Baba)
Se ci pungete non diamo sangue, noi? Se ci fate il
solletico, non ridiamo? Se ci avvelenate non moriamo? (William Shakespeare)
Guardo i volti delle persone che lottano per la
propria vita, e non vedo estranei. (Robert Brault)
Qualunque certezza tu abbia stai sicuro di questo:
che tu sei terribilmente come gli altri. (James Russell Lowell)
Lo stesso Dio che ha creato Rembrandt ha creato
te, ed agli occhi di Dio tu sei prezioso come Rembrandt o come chiunque altro.”
(Zig Ziglar)
È bello quando due esseri uguali si uniscono, ma
che un uomo grande innalzi a sé chi è inferiore a lui, è divino. (Friedrich
Hölderlin)
Se ti sedessi su una nuvola non vedresti la linea
di confine tra una nazione e l’altra, né la linea di divisione tra una fattoria
e l’altra. Peccato che tu non possa sedere su una nuvola. (Khalil Gibran)
Il sole splende per tutti. (Proverbio latino)
La pioggia non cade su un tetto solo. (Proverbio
africano)
In quanto uomini, siamo tutti uguali di fronte
alla morte. (Publilio Siro)
La morte è questo: la completa uguaglianza degli
ineguali. (Vladimir Jankélévitch)
Nella vita si prova a insegnare che siamo tutti
uguali, ma solo la morte riesce ad insegnarlo davvero. (Anonimo)
Nella democrazia dei morti tutti gli uomini sono
finalmente uguali. Non vi è né rango né posizione né prerogativa nella
repubblica della tomba. (John James Ingalls).
Finito il gioco, il re e il pedone tornano nella
stessa scatola. (Proverbio Italiano).
L’uguale distribuzione della ricchezza dovrebbe
consistere nel fatto che nessun cittadino sia tanto ricco da poter comprare un
altro, e nessuno tanto povero che abbia necessità di vendersi. (Armand
Trousseau)
L’amore, è l’ideale dell’uguaglianza. (George
Sand)
L’amore pretende di parificare, ma il denaro
riesce a differenziare. (Aldo Busi)
Noi che siamo liberali e progressisti sappiamo che
i poveri sono uguali a noi in tutti i sensi, tranne quello di essere uguali a
noi. (Lionel Trilling)
La saggezza dell’uomo non ha ancora escogitato un
sistema di tassazione che possa operare con perfetta uguaglianza. (Andrew
Jackson)
Nessun uomo è al di sopra della legge, e nessuno è
al di sotto di esso. (Theodore Roosevelt)
Siamo tutti uguali davanti alla legge, ma non
davanti a coloro che devono applicarla. (Stanislaw Jerzy Lec)
La maestosa uguaglianza delle leggi proibisce ai
ricchi come ai poveri di dormire sotto i ponti, di mendicare per strada e di
rubare il pane. (Anatole France)
Perché in Italia la stupenda frase “La Giustizia è
uguale per tutti” è scritta alle spalle dei magistrati? (Giulio Andreotti)
La scuola dava peso a chi non ne aveva, faceva
uguaglianza. Non aboliva la miseria, però tra le sue mura permetteva il pari. Il
dispari cominciava fuori. (Erri De Luca)
Qui vige l’eguaglianza. Non conta un cazzo
nessuno!” (Dal film Full metal jacket)
Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più
uguali degli altri. (George Orwell)
Per realizzare una democrazia compiuta occorre
avere il coraggio di rimettere in discussione il diritto di voto. Non posso
guidare un aeroplano appellandomi al principio di uguaglianza: devo prima
superare un esame di volo. Perché quindi il voto, attività non meno affascinante
e pericolosa, dovrebbe essere sottratta a un esame preventivo di educazione
civica e di conoscenza minima della Costituzione? (Massimo Gramellini)
La via dell’uguaglianza si percorre solo in
discesa: all’altezza dei somari è facilissimo instaurarla. (Conte di Rivarol)
La parità e l’uguaglianza non esistono né possono
esistere. E’ una menzogna che possiamo essere tutti uguali; si deve dare a
ognuno il posto che gli compete. (Pancho Villa)
Fu un uomo saggio colui che disse che non vi è più
grande ineguaglianza di un uguale trattamento di diseguali. (Felix Frankfurter)
Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far
parti uguali fra disuguali. (Lorenzo Milani)
Quella secondo la quale tutti gli uomini sono
eguali è un’affermazione alla quale, in tempi ordinari, nessun essere umano sano
di mente ha mai dato il suo assenso. (Aldous Huxley)
L’uguaglianza è una regola che non ha che delle
eccezioni. (Ernest Jaubert)
Nell’incredibile moltitudine che potrebbe venir
fuori da una sola coppia umana, che disuguaglianze e varietà! Vi si trovano
grandi e piccoli, biondi e bruni, belli e brutti, deboli e forti. Tutto vi
figura: il peggiore e l’eccellente, la tara e il genio, la mostruosità in alto e
quella in basso. Dall’unione di due individui, tutto può nascere. Punto di
congiunzione da cui non si deve sperare tutto e temere tutto. La coppia più
banale è gravida di tutta l’umanità. (Jean Rostand)
Anche tra egualitari fanatici il più breve
incontro ristabilisce le disuguaglianze umane. (Nicolás Gómez Dávila)
Io non ho rispetto per la passione
dell’uguaglianza, che a me sembra una semplice invidia idealizzata. (Oliver
Wendell Holmes Jr)
Il significato della parola uguaglianza non deve
essere “omologazione”. (Anonimo)
Sì, c’è qualcosa in cui noi ci assomigliamo: tu e
io ci crediamo differenti in modo uguale. (Jordi Doce)
Le donne che cercano di essere uguali agli uomini
mancano di ambizione. (Timothy Leary)
Assistere l’autodeterminazione del popolo sulla
base della massima uguaglianza possibile e mantenere la libertà, senza la minima
interferenza di qualsivoglia potere, neppure provvisorio. (Michail Bakunin)
L’uguaglianza non può regnare che livellando le
libertà, diseguali per natura. (Charles Maurras)
I legislatori o rivoluzionari che promettono
insieme uguaglianza e libertà sono o esaltati o ciarlatani. (Goethe)
Quando sicurezza e uguaglianza sono in conflitto,
non bisogna esitare un momento: l’uguaglianza va sacrificata. (Jeremy Bentham)
Una società che mette l’uguaglianza davanti
libertà otterrà né l’una né l’altra. Una società che mette la libertà davanti
all’uguaglianza avrà un buon livello di entrambe. (Milton Friedman)
Libertà, Uguaglianza, Fraternità – come arrivare
ai verbi? (Stanislaw Jerzy Lec)
“Libertà, Fraternità, Uguaglianza”, d’accordo. Ma
perchè non aggiungervi “Tolleranza, Intelligenza, Conoscenza?” (Laurent Gouze)
Dicesi problema sociale la necessità di trovare un
equilibrio tra l’evidente uguaglianza degli uomini e la loro evidente
disuguaglianza. (Nicolás Gómez Dávila)
Credo nell’uguaglianza. Gli uomini calvi
dovrebbero sposare donne calve. (Fiona Pitt-Kethley)
Nel mondo contemporaneo l’unico posto dove si
realizza la perfetta uguaglianza è nel traffico. (Fragmentarius)
Nella troppa disuguaglianza delle fortune,
egualmente che nella perfetta eguaglianza, l’annua riproduzione si restringe al
puro necessario, e l’industria s’annienta, poiché il popolo cade nel letargo.
(Pietro Verri)
Se ciò che io dico risuona in te, è semplicemente
perché siamo entrambi rami di uno stesso albero. (William Butler Yeats)
Chiunque può fuggire nel sonno, siamo tutti geni
quando sogniamo, il macellaio e il poeta sono uguali là. (EM Cioran)
Io amo la notte perché di notte tutti i colori
sono uguali e io sono uguale agli altri…(Bob Marley)
Il mio diritto di uomo è anche il diritto di un
altro; ed è mio dovere garantire che lo eserciti. (Thomas Paine)
Chi vede tutti gli esseri nel suo stesso Sé, ed il
suo Sé in tutti gli esseri, perde ogni paura. (Isa Upanishad)
«Fu il
sangue mio d’invidia sì riarso
che se
veduto avesse uomo farsi lieto,
visto
m’avresti di livore sparso.
(Dante Alighieri, Purgatorio,
XIV, vv.82-84)
L’invidia sociale,
scrive
Francesco Colonna,
su ”Facci un salto”. Si sono impiegati molti decenni per sradicare il tratto
fondamentale del marxismo, cioè la
lotta di classe. Gli argomenti contrari a quel principio si
riassumono in un concetto semplice: la collaborazione
è più efficace della lotta. Permette di costruire di più, di
fare più cose, di redistribuire meglio non solo i soldi, ma le competenze e la
giustizia. Gli argomenti a favore invece erano e sono quella di una divergenza
di interessi che si
concilia male con l’idea di giustizia sociale. Non importa qui dibattere il
tema. Quel che conta è quell’idea non circola più, e infatti nessuno ne parla e
nessuno la usa per sostenere le proprie tesi. Di conseguenza, la logica sarebbe
questa, tutto dovrebbe essere più tranquillo, una società più conciliante, meno
aggressiva, più disposta alla collaborazione, nella quale i problemi si
risolvono in modo pacifico e ragionato.
E invece a quella ideologia (giusta o sbagliata che fosse non importa) si è
sostituito non un pensiero o una filosofia nuovi ma un sentimento: l’invidia,
alla quale si può aggiungere l’aggettivo “sociale”.
L’invidia nelle sue forme più comuni si riferisce alla cose, invidia per ciò che
non ho e altri hanno. Invece nella nostra società fatta di immagine e
comunicazione (parole che sembrano sempre sottintendere una falsità o almeno una
irrealtà) l’invidia è rivolta all’essere, ai modelli
di successo, di fama o di notorietà. E questa invidia prende
tante forme: dalla
ostilità alla
imitazione. E, per capire bene cosa significhi e comporti, basta
guardare alla etimologia:
invidere in latino vuol
dire guardare
storto, guardare in modo non corretto. Cioè l’invidia impedisce
di vedere giusto e quindi di capire. Ed è trasversale,
colpisce ovunque. Mentre la lotta di classe comunque dava una identità, una
appartenenza, l’invidia sociale disgrega, atomizza la lotta,
relegandola nell’intimo, pur esibendosi poi come ricerca di giustizia sociale.
Difficile che in questa luce si possa trovare una strada comune, al massimo si
cercano nemici,
veri o presunti. Una caccia nella quale brillano il sospetto, la vendetta, il
complotto, il pregiudizio. E con questo carico sulla coscienza diviene difficile
ragionare e scegliere bene il tipo di società nel quale vivere.
Monti, Bersani, Vendola e Cgil: il club
della patrimoniale. La tentazione di patrimoniale è
sempre più forte: Bersani ne vuole una light, Vendola punta alle rendite
finanziarie, la Cgil sogna una stangata da 40 miliardi, scrive
Andrea Indini su
“Il Giornale”.
E, adesso, patrimoniale.
La spinta è forte. In piena campagna elettorale, la tentazione di fare una
tentazione extra sui grandi patrimoni sembra impossessarsi trasversalmente sui
leader di molti partiti. Il primo a proporla è stata Mario
Monti che, nella sua agenda,
l'ha inserita (senza farsi troppi problemi) per riuscire a ridurre la pressione
fiscale, a
partire dal "carico
fiscale gravante su lavoro e impresa". In men che non si dica, una
schiera di amanti delle tasse hanno subito fatto propria la smania di andare a
mettere le mani sui risparmi degli
italiani. "I ricchi devono andare all'inferno". Sebbene si
riferisse al Gerard Depardieu che, per l'eccessiva tassazione, ha deciso di
lasciare la Francia e accogliere il passaporto russo offertogli da Vladimir
Putin, l'imprecazione lanciata da Nichi
Vendola dà una chiara idea
della crociata che, in caso di vittoria alle politiche, la sinistra condurrà
contro i beni degli italiani. Dove potrà, razzolerà per far cassa e appianare i
debiti di una macchina statale che fagocita tutti i soldi che vengono versati
nell'erario pubblico. Nel giorni scorsi, in una intervista a Radio24, il leader
del Sel aveva poi spiegato che, quando sarà al governo, andrà a "stanare" la
ricchezza che deriva dalle rendite finanziarie. "Se
si immagina che quella finanziaria del Paese è stimata in 4mila miliardi di euro
e che viceversa meno di mille persone dichiarano nella denuncia dei redditi più
di un milione di euro all'anno di reddito, siamo di fronte a una ricchezza
largamente imboscata - ha spiegato Vendola - la tassazione alle transazioni
finanziarie e sugli attivi finanziari non è una proposta bolscevica".
Nascondendosi dietro alla ragione economica tesa alla ricostruzione del Paese,
il governatore della Puglia sembra muoversi solo per una ragione di invidia
sociale. Il primo a parlare di patrimoniale è stato, però, il
Professore. Nell'agenda
presentata a dicembre, Monti ha spiegato che è possibile tagliare le tasse a
scapito di altri cespiti: "Il
carico corrispondente va trasferito su grandi patrimoni e sui consumi che non
impattano sui più deboli e sul ceto medio".
Si legga: patrimoniale e appesantimento dell’Iva sui beni di lusso. Insomma, al
premier uscente sembra non bastare l'aver introdotto l'Imu che, è già di per sé,
una patrimoniale sull'abitazione. E, su questo punto, si trova in perfetta
sintonia con Pierluigi Bersani che
ieri sera, negli studi di Ballarò,
ha spiegato chiaramente che l’imu non è una patrimoniale "abbastanza
progressiva" per i suoi gusti. "Nel
prossimo anno non saremo in condizione di ridurre le entrate dell’imu ma
potremmo fare un riequilibrio caricando sui possessori di grandi patrimoni
immobiliari - ha spiegato il segretario del Partito democratico - a fronte di
una detrazione del 5% dobbiamo caricare con un’imposta personale sui detentori
di grandi patrimoni immobiliari dal valore catastale di 1,5 milioni di euro". La
segreteria di via del Nazareno, modificando leggermente i propositi iniziali
vagamente massimalisti, ha fatto balenare una patrimoniale light da
applicare agli immobili
oltre il milione e mezzo di valore catastale. Lo staff di Bersani ha, invece,
specificato che si tratterebbe di circa tre milioni a prezzi reali. Al
suo fianco si è subito schierato anche Antonio Ingroia che ha già annunciato di
voler togliere l'Imu perché la ritiene "un
peso insopportabile e intollerabile". Il
progetto del leader di Rivoluzione civile è rendere "il
sistema economico più equo" mettendo "una
patrimoniale sui redditi più alti e sui patrimoni più consistenti".
Il sindacato di Susanna
Camusso, che
garantisce un’area elettorale decisiva per il Pd, ha preparato una piano fiscale
che presenterà a Roma il 25 e 26 gennaio. Piano che fa impallidire gli slogan
anti ricchi di Vendola: la Cgil punta, infatti, a reperire 40 miliardi di euro
all'anno dalla patrimoniale, 20 miliardi dalla "ristrutturazione della spesa
pubblica", 10 miliardi dal riordino dei finanziamenti alle imprese e 10 miliardi
dai fondi dell'Unione europea. Gli 80 miliardi rastrellati verrebbero destinati,
ogni anno, al lavoro (creazione di nuovi posti, sostegno dell’occupazione e
nuova riforma del mercato del lavoro), al welfare e alla "restituzione fiscale"
attraverso il taglio della prima aliquota dal 23 al 20% e della terza dal 38 al
36%. Progetto che senza la patrimoniale da 40 miliardi non sta in piedi.
Ci volevate
uguali? Ora sim tutti poveri, scrive Mimmo Dato su "L'Intraprendente".
In questo nostro bel paese, mio caro Mictel o come ti chiami, abbiamo avuto
imponenti correnti d’ispirazione populista, con orientamenti internazionali con
sguardo alla sovietizzazione ed al marxismo, forse un po’ radicalizzanti ma
certo, a loro dire, pacifisti. Insomma tutta gente all’opposizione che ha
vissuto una vita a gridare quanto fosse giusto eliminare le diseguaglianze
economiche e ridistribuire le ricchezze, per ovvio sempre prodotte dagli altri e
mai da loro; che bisognava aumentare le spese dello Stato per attuare queste
pseudo misure egualitarie. Insomma tutti questi contro tutti quelli che non
ponevano quale obiettivo principe la massimizzazione dell’uguaglianza. Poi il
sogno in Italia si avvera e i governi a marchio populista, pacifista,
egualitario si succedono a raffica pur senza che nessuno li elegga ma la
Costituzione non viene infranta per questo, per i comunisti il voto non serve,
ed eccoci all’oggi, tutti poveri uguale. Tutte le decisioni per la sopravvivenza
del paese sono state omesse come qualunque sistema libero e democratico farebbe,
tasse da record mondiale, caccia alle streghe, si è omesso di rafforzare le
forze di difesa e di cercare le alleanze a garanzia internazionale. Quindi tutte
le decisioni sono tendenti alla massimizzazione dell’uguaglianza in povertà
contro quelle tese a garantire l’indipendenza e la sopravvivenza del sistema
economico e democratico, si legga la nuova legge elettorale che dovrebbe esser
varata. Ma allora, caro Mictel, ti chiederai chi erano e chi sono i veri
potenti? Forse i ceti abbienti che sostenevano gruppi di maggioranza senza aver
avuto, per loro frazionamento ed opportunismo, la capacità di arrestare forme
populiste egualitarie o questi ultimi che hanno preso il potere da anni e stanno
perseguendo opzioni politiche da disastro, spesa pubblica e disoccupazione al
cielo? Vedi Mictel se tu mi fai la domanda, e non me la fai, su come la penso
credo che oggi esistano due gruppi di pensatori, quelli che non vogliono
l’uguaglianza nemmeno come valore e quelli che pensano che sia comunque
impossibile. A questo punto, inutili e terra di conquista, che ci compri la
Russia o la Cina. Eppoi il tuo nome sembra americano e mi dici esser cinese.
Come ho fatto a non capirlo quando sei sceso da quel macchinone di lusso?
Altro che tutti uguali. Meglio tutti più
ricchi. Frankfurt:
ridurre le differenze di reddito non è un ideale morale. Il problema è invece
che troppi sono poveri, scrive Harry G. Frankfurt Martedì 27/10/2015 su "Il
Giornale". In un recente discorso sullo stato dell'Unione, il presidente Barack
Obama ha dichiarato che la disuguaglianza di reddito è «la sfida che definisce
la nostra epoca». A me sembra, invece, che la sfida fondamentale per noi non sia
costituita dal fatto che i redditi degli americani sono ampiamente disuguali, ma
dal fatto che troppe persone sono povere. Dopo tutto, la disuguaglianza di
reddito potrebbe essere drasticamente eliminata stabilendo semplicemente che
tutti i redditi devono essere ugualmente al di sotto della soglia di povertà.
Inutile dire che un simile modo di ottenere l'uguaglianza dei redditi - rendendo
tutti ugualmente poveri - presenta ben poche attrattive. Eliminare le
disuguaglianze di reddito non può quindi costituire, di per sé, il nostro
obiettivo fondamentale. Accanto alla diffusione della povertà, un altro aspetto
dell'attuale malessere economico è il fatto che, mentre molte persone hanno
troppo poco, ce ne sono altre che hanno troppo. È incontestabile che i molto
ricchi abbiano ben più di ciò di cui hanno bisogno per condurre una vita attiva,
produttiva e confortevole. Prelevando dalla ricchezza economica della nazione
più di quanto occorra loro per vivere bene, le persone eccessivamente ricche
peccano di una sorta d'ingordigia economica, che ricorda la voracità di chi
trangugia più cibo di quanto richiesto sia dal suo benessere nutrizionale sia da
un livello soddisfacente di godimento gastronomico. Tralasciando gli effetti
psicologicamente e moralmente nocivi sulle vite degli stessi golosi,
l'ingordigia economica offre uno spettacolo ridicolo e disgustoso. Se lo
accostiamo allo spettacolo opposto di una ragguardevole classe di persone che
vivono in condizioni di grande povertà economica, e che perciò sono più o meno
impotenti, l'impressione generale prodotta dal nostro assetto economico risulta
insieme ripugnante e moralmente offensiva. Concentrarsi sulla disuguaglianza,
che in sé non è riprovevole, significa fraintendere la sfida reale che abbiamo
davanti. Il nostro focus di fondo dovrebbe essere quello di ridurre sia la
povertà sia l'eccessiva ricchezza. Questo, naturalmente, può benissimo
comportare una riduzione della disuguaglianza, ma di per sé la riduzione della
disuguaglianza non può costituire la nostra ambizione primaria. L'uguaglianza
economica non è un ideale moralmente prioritario. Il principale obiettivo dei
nostri sforzi deve essere quello di rimediare ai difetti di una società in cui
molti hanno troppo poco, mentre altri hanno le comodità e il potere che si
accompagnano al possedere più del necessario. Coloro che si trovano in una
condizione molto privilegiata godono di un vantaggio enorme rispetto ai meno
abbienti, un vantaggio che possono avere la tendenza a sfruttare per esercitare
un'indebita influenza sui processi elettorali o normativi. Gli effetti
potenzialmente antidemocratici di questo vantaggio vanno di conseguenza
affrontati attraverso leggi e regolamenti finalizzati a proteggere tali processi
da distorsioni e abusi. L'egualitarismo economico, secondo la mia
interpretazione, è la dottrina per cui è desiderabile che tutti abbiano le
stesse quantità di reddito e di ricchezza (in breve, di «denaro»). Quasi nessuno
negherebbe che ci sono situazioni in cui ha senso discostarsi da questo criterio
generale: per esempio, quando bisogna offrire la possibilità di guadagnare
compensi eccezionali per assumere lavoratori con capacità estremamente richieste
ma rare. Tuttavia, molte persone, pur essendo pronte a riconoscere che qualche
disuguaglianza è lecita, credono che l'uguaglianza economica abbia in sé un
importante valore morale e affermano che i tentativi di avvicinarsi all'ideale
egualitario dovrebbero godere di una netta priorità. Secondo me, si tratta di un
errore. L'uguaglianza economica non è di per sé moralmente importante e, allo
stesso modo, la disuguaglianza economica non è in sé moralmente riprovevole. Da
un punto di vista morale, non è importante che tutti abbiano lo stesso, ma che
ciascuno abbia abbastanza. Se tutti avessero abbastanza denaro, non dovrebbe
suscitare alcuna particolare preoccupazione o curiosità che certe persone
abbiano più denaro di altri. Chiamerò questa alternativa all'egualitarismo
«dottrina della sufficienza», vale a dire la dottrina secondo cui ciò che è
moralmente importante, con riferimento al denaro, è che ciascuno ne abbia
abbastanza. Naturalmente, il fatto che l'uguaglianza economica non sia di per sé
un ideale sociale moralmente cogente non è una ragione per considerarla un
obiettivo insignificante o inopportuno in qualsiasi contesto. L'uguaglianza
economica può avere infatti un importante valore politico e sociale e possono
esserci ottime ragioni per affrontare i problemi legati alla distribuzione del
denaro secondo uno standard egualitario. Perciò, a volte, può avere senso
concentrarsi direttamente sul tentativo di aumentare l'ampiezza dell'uguaglianza
economica piuttosto che sul tentativo di controllare fino a che punto ognuno
abbia abbastanza denaro. Anche se l'uguaglianza economica, in sé e per sé, non è
importante, impegnarsi ad attuare una politica economica egualitaria potrebbe
rivelarsi indispensabile per promuovere la realizzazione di vari obiettivi
auspicabili in ambito sociale e politico. Potrebbe inoltre risultare che
l'approccio più praticabile per raggiungere la sufficienza economica universale
consista, in effetti, nel perseguire l'uguaglianza. E ovviamente, il fatto che
l'uguaglianza economica non sia un bene in sé lascia comunque aperta la
possibilità che abbia un valore strumentale come condizione necessaria per
ottenere beni che posseggono, questi sì, un valore intrinseco. Pertanto, una
distribuzione di denaro più egualitaria non sarebbe sicuramente criticabile.
Tuttavia, l'errore assai diffuso di credere che esistano potenti ragioni morali
per preoccuparsi dell'uguaglianza economica in quanto tale è tutt'altro che
innocuo. Anzi, a dir la verità, tende a essere una credenza piuttosto dannosa.
(2015 Princeton University Press2015 Ugo Guanda Editore Srl)
GLI INTOCCABILI E LA SOCIETA’ DELLE CASTE.
Gli intoccabili. Il caso Saguto e la
società delle caste, scrive Pino Maniaci su "Telejato"
il 26 ottobre 2015. IL CASO SAGUTO E LA
SOCIETÀ DELLE CASTE: L’ANTIMAFIA, I GIUDICI, I BUROCRATI, I POLITICI. E POI LA
PLEBE. Di fronte a tutto quello che abbiamo visto, letto e ascoltato in
questi ultimi tempi sul caso della gestione personalizzata dei beni sequestrati
da parte di un nutrito numero di magistrati, componenti del CSM, cancellieri,
funzionari della DIA, personale giudiziario e amministratori giudiziari,
sappiamo solo che il CSM ascolterà nei prossimi giorni i giudici coinvolti (ce
ne sono altri 4 che continuano ad operare a Palermo). Ci chiediamo, anche a
tutela dell’immagine di migliaia di magistrati onesti: Se
a un comune mortale cittadino italiano fossero stati contestati la metà dei
fatti addebitati alla Saguto non sarebbe stato sottoposto agli arresti
domiciliari? Se fossero stati contestati a Renzi, piuttosto che a Crocetta o a
Marino non si sarebbero dimessi? Invece nel suo caso si parla di
trasferimento ad altra sede. Ci chiediamo ancora una volta, fermo restando la
presunzione d’innocenza fino all’ultimo grado di giudizio, ma
è opportuno che a “Zà Silvana” indossi ancora la toga? È
opportuno che tutte le persone coinvolte in favoritismi, raccomandazioni e
assunzioni ad amici e parenti restino ancora al loro posto? È opportuno che
funzionari della DIA al servizio di questo sistema continuino a svolgere ancora
funzioni pubbliche? Non comprendiamo quale sia la differenza tra questi
soggetti e chi incassa una tangente. Entrambi utilizzano i propri ruoli
istituzionali per rubare soldi pubblici. La giustizia è davvero uguale per
tutti? Non ci soddisfano più le assicurazioni che tutto sarà chiarito. Sarà
chiarito da chi? Quando e davanti a chi? Tutti invece devono essere
immediatamente rimossi dai loro pubblici incarichi, in modo trasparente perché
come cittadini abbiamo concesso credito a giudici che abbiamo ritenuto
credibili, che abbiamo rispettato per la loro vita blindata, giudici che abbiamo
ascoltato e dei quali abbiamo rispettato il lavoro senza alcuna delegittimazione
preventiva. Vengano rimossi senza stipendio per rispetto verso tutti quei
magistrati che hanno onorato e onorano i valori di autonomia e indipendenza,
assicurando credibilità alla Giustizia con i comportamenti di tutti i giorni.
Vengano rimossi per rispetto a tutti quei servitori dello Stato caduti
nell’adempimento del dovere. Vengano rimossi e gli vengano sequestrati i beni
per rispetto a tutti coloro che chiamati a collaborare con l’autorità
giudiziaria con compiti delicatissimi e complessi lo fanno con coraggio. Pochi
giorni fa i deputati della nostra regione hanno approvato in Commissione in
tempo record il ddl salva burocrati e nominati. La finanziaria del 2012 ed un
parere del Cga del 2014 hanno stabilito la gratuità degli incarichi nelle
società partecipate dalla Regione e vietato le superindennità aggiuntive agli
alti dirigenti. Fatto questo che avrebbe comportato anche la restituzione delle
somme. Ebbene la stessa Ars che fa le pulci ai gettoni di presenza ai
consiglieri comunali per cifre irrisorie ha varato un ddl in 10 minuti per
salvare i maxicompensi aggiuntivi agli alti burocrati e ai blindati. Il
presidente della lotta alla manciugghia, Crocettino, è diventato il Santo
protettore della casta. Ricordiamo che negli anni ’80, ’90, il sogno di tanti
giovani era quello di una società nella quale se
sei bravo e se ti impegni, farai strada. Adesso se nasci parìa crepi
parìa. Tra una casta e l’altra ci sono muraglie cinesi. Non esiste più la media
borghesia e neanche la piccola. Ci sono le caste e poi la plebe, il volgo. Hanno
fatto quadrato tra di loro. Le caste hanno fatto rete, si coalizzano tra loro.
La casta degli antimafia,
come se l’antimafia fosse una categoria dello spirito, gli intoccabili ed unti
dal Signore per antonomasia si è coalizzata con quella dei politici e spesso con
quella dei burocrati. Ovunque ti giri ci sono i privilegiati che si fanno beffe
di chi è dall’altra parte dello steccato. Ogni loro gesto è uno sputo in faccia
a chi fatica onestamente, a chi si suda lo stipendio, a chi pur sudando non avrà
mai un diritto. Le caste sono intoccabili. E in quanto tali trattano gli altri
con arroganza e sfacciataggine. Ci sentiamo come si sentivano i poveracci alla
vigilia della Rivoluzione francese, anzi peggio, perché adesso ti prendono in
giro con l’ipocrisia della democrazia e l’illusione della libertà. Nella Francia
della Rivoluzione c’era Maria Antonietta che ha detto “Se
non c’è pane non possono mangiare grissini?”. Adesso abbiamo a “Zà
Silvana” che dall’alto della casta dice: “18
mila euro di spesa non pagata al supermercato? Che sbadata. Mica faccio io la
spesa”. È la Rivoluzione Francese ai tempi da “Zà Silvana”. Un ultimo
e accorato appello a tutte le Associazioni Antiracket e Antimafia che non
sentono la necessità di proferire parola neanche davanti a delle gravissime
minacce ricevute dal Direttore di Telejato, Pino Maniaci, da parte della Saguto
(a “Zà Silvana”) e del Prefetto Cannizzo, che parlando tra di loro hanno
affermato: “Pino
Maniaci ha le ore contate”. E ai ragazzi di Addiopizzo. Forza ragazzi
fate sentire la vostra variopinta presenza e alzate in coro la voce organizzando
graziosi sit-in di protesta nelle pubbliche piazze e davanti al Tribunale di
Palermo, datevi da fare ad appendere sui pali e le vetrine di Palermo la
scritta: “Un
Magistrato e un Prefetto che usano il loro potere per fini personali sono
persone senza dignità”.
Il caso Saguto e la società delle caste:
l'antimafia, i giudici, i burocrati, i politici. E poi la plebe.
L'inchiesta che riguarda il giudice Saguto, insieme ad una serie di altri fatti
di cronaca mi hanno convinta che viviamo in una società divisa in caste. Da un
lato gli intoccabili, i privilegiati, dall'altro la plebe. Ai tempi di Maria
Antonietta lei diceva "mangiate biscotti se non avete pane", oggi c'è un giudice
che non si accorge di 18 mila euro di conto non pagato al supermercato...,
scrive domenica 25 Ottobre 2015 Rosaria Brancato su “Tempo Stretto”. Il caso
Saguto non mi ha fatto dormire la notte. Per 10 giorni ho avuto il panico
temendo quale cosa raccapricciante avrei letto il giorno dopo a proposito
dell’inchiesta su Silvana
Saguto, ormai ex presidente della sezione misure preventive del Tribunale
di Palermo. L’indagine su quel che accadeva nella gestione dei beni confiscati
alla mafia (che in Sicilia rappresentano il 43% del totale) sta facendo emergere
di tutto. La Saguto spaziava dalle nomine di amministratori giudiziari nelle
società confiscate in cambio di incarichi
per il marito, i parenti e gli amici, all’utilizzo
dell’auto blindata come taxi per prelevare la nuora e accompagnarla nella
villa al mare, o delle sue ospiti per non incappare nel traffico palermitano,
oppure dal farsi recapitare a casa per le cene 6 chili tonno fresco,
lamponi, (di provenienza da aziende sotto sequestro) al conto da quasi 20
mila euro non pagato al supermercato confiscato (“una dimenticanza, non
sono io quella che va a fare la spesa..”). La “zarina” delle misure preventive
si è data da fare per la laurea
del figlio ottenuta grazie all’aiuto del docente della Kore di Enna,
Carmelo Provenzano che in cambio veniva nominato consulente. Il giovane
laureato, stando alle intercettazioni, la festa proprio non la voleva “questa
laurea è una farsa, gli altri sgobbano per averla” ma il giudice non sentì
ragioni e affidò l’organizzazione proprio al professore Provenzano che oltre a
scrivere la tesi ha provveduto al menù, così come avverrà per la successiva
festa di compleanno della Saguto. Gli agenti della scorta infine venivano
utilizzati per andare in profumeria a fare acquisti. Ciliegina sulla torta del
dichiarazioni del giudice antimafia a proposito dei figli di Paolo Borsellino,
Manfredi e Anna. Il 19 luglio, anniversario dell’assassinio di Borsellino,
Silvana Saguto partecipa come madrina alla manifestazione Le vele della
legalità, fa il suo bel discorso antimafia, poi sale a bordo dell’auto blindata
ed al telefono dice ad un’amica: “Poi Manfredi che si commuove, ma perché
minc...a ti commuovi a 43 anni per un padre che è morto 23 anni fa? Che figura
fai? Ma che... dov'è uno... le palle ci vogliono. Parlava di sua sorella e si
commuoveva, ma vaff....o". Di fronte a tutto questo sappiamo solo che il CSM
ascolterà nei prossimi giorni i giudici coinvolti (ce ne sono altri 4 che
continuano ad operare a Palermo). Mi chiedo, anche a tutela
dell’immagine di migliaia di magistrati onesti ma se a Donna
Sarina fossero stati contestati la metà dei fatti addebitati alla Saguto
non sarebbe stata agli arresti domiciliari? Se fossero stati contestati a Renzi,
piuttosto che a Crocetta o a Marino non si sarebbero dimessi? Invece nel suo
caso si parla di trasferimento ad altra sede. Mi chiedo, fermo restando la
presunzione d’innocenza fino all’ultimo grado di giudizio, ma è opportuno che
indossi ancora la toga? La giustizia è davvero uguale per tutti? Leggo anche
dell’arresto per corruzione dell’ex direttrice
del carcere di Caltanissetta Alfonsa Miccichè. La signora affidava
progetti con somme inferiori ai 40 mila euro (quindi non soggetti ad evidenza
pubblica) a società che in cambio assegnavano incarichi alla figlia ed al
genero. Sempre in questi giorni scopro che al Comune di Sanremo
il 75% dei dipendenti è assenteista e c’è chi è stato filmato mentre
timbrava il cartellino in mutande e poi tornava a letto o lo faceva timbrare da
moglie e figli. Il sindaco di Sanremo dichiara: “sto valutando i provvedimenti
da prendere. Forse ANCHE il licenziamento”. A prescindere dal fatto che se
licenzi questi ladri
di lavoro almeno puoi assumere qualcuno onesto che ti fa funzionare il
Comune e adesso è disoccupato, mi chiedo signor sindaco: che significa ANCHE il
licenziamento? Che vorresti fare? Premiarli? Che differenza c’è tra questi
assenteisti e l’impiegato che incassa la tangente?
Entrambi rubano soldi
pubblici. Torniamo in Sicilia dove pochi giorni fa i deputati hanno
approvato in Commissione intempo
record il ddl salva burocrati e nominati. La finanziaria del 2012 ed un
parere del Cga del 2014 hanno stabilito la gratuità degli incarichi nelle
partecipate e vietato le superindennità aggiuntive agli alti dirigenti. Fatto
questo che avrebbe comportato anche la restituzione delle somme. Ebbene la
stessa Ars che fa le
pulci ai gettoni di presenza ai consiglieri comunali per cifre irrisorie
ha varato un ddl in 10 minuti per salvare i
maxi compensi aggiuntivi agli alti burocrati e ai blindati. Il presidente
della lotta alla manciugghia è diventato il Santo protettore della casta. A Roma
mentre la sottosegretaria alla cultura Francesca
Barracciu viene rinviata a giudizio per peculato per rimborsi da 81
mila euro il presidente del Consiglio Renzi annuncia
di voler togliere l’Ici sulla prima casa a TUTTI, sia che abbiamo un castello
che un tugurio. E si definisce di sinistra….Ricordo negli anni ’80, ’90, il
sogno della Milano da bere era quello di una società nella quale se sei bravo,
se ti impegni, farai strada. Adesso se nasci
parìa crepi parìa. Tra una casta e l’altra ci sono muraglie cinesi. Non
esiste più la media borghesia e neanche la piccola. Ci
sono le caste e poi la plebe, il volgo. Hanno fatto quadrato tra di loro.
Le caste hanno fatto
rete, si coalizzano tra loro. La casta degli “antimafia”, gli intoccabili
ed unti dal Signore per antonomasia si è coalizzata con quella dei politici e
spesso con quella dei burocrati. Ovunque ti giri ci sono i privilegiati che si
fanno beffe di chi è dall’altra parte dello steccato. Ogni loro gesto è uno
sputo in faccia a chi fatica onestamente, a chi si suda lo stipendio, a chi pur
sudando non avrà mai un diritto. Le
caste sono intoccabili. La Barracciu era la candidata che Renzi voleva ad
ogni costo per la presidenza della Regione Sardegna. A causa dello scandalo, ha
ripiegato per un posto di sottosegretario. La
Barracciu, la Saguto, le leggi ad personam mentre la Sicilia muore di fame.
E’ la sfacciataggine degli intoccabili. Mi sento come si sentivano i
poveracci alla vigilia della Rivoluzione
francese, anzi peggio, perché adesso ti prendono in giro con l’ipocrisia
della democrazia e l’illusione della libertà. Nella Francia della Rivoluzione
c’era Maria Antonietta
che dice “ma se non c’è pane non possono mangiare grissini?”. Adesso
abbiamo il giudice antimafia Silvana
Saguto che dall’alto della casta dice: “18 mila euro di spesa non pagata
al supermercato? Che sbadata. Mica faccio io la spesa”. E’ la Rivoluzione
Francese ai tempi della Saguto. Rosaria Brancato.
Cultura antimafia con pregi e difetti,
scrive Lionello Mancini su “Il Sole 24 ore” del 26 Ottobre 2015. I fatti e le
parole sconvolgenti attribuiti alla presidente della sezione misure di
prevenzione di Palermo, Silvana Saguto, rimandano ancora una volta ai limiti con
cui ciclicamente deve confrontarsi la cultura della legalità, nei diversi ambiti
– istituzionali, imprenditoriali, professionali e associativi – in cui si
esplica. Saguto, per anni nota e stimata esponente delle toghe antimafia, a suo
tempo oggetto di minacce direttamente per bocca di Salvatore Riina, dirigeva
fino a pochi giorni fa la sezione di Tribunale preposta al sequestro di beni ai
mafiosi. Un incarico delicato, specie sull’isola di Cosa nostra e, per molti
aspetti, pionieristico. Quantità, casistica e tipologia dei sequestri si sono
ampliate e complicate giorno dopo giorno. I beni vanno gestiti e valorizzati
fino alla confisca definitiva. Per questo i giudici delle misure di prevenzione
di tutta Italia si consultano in continuazione, propongono modifiche alle leggi,
creano una loro associazione per condividere le esperienze. Un lavoro meritorio
e quasi sconosciuto. Nei mesi scorsi nascono a Palermo voci sui criteri e
sull’accentramento delle deleghe su pochi nomi, seguono inchieste
giornalistiche, la Procura di Caltanissetta apre un fascicolo. Emerge così una
storia di favoritismi sfacciati, di gestione familistica della sezione, di
ingenti debiti personali della presidente, di favori e regali scambiati o
promessi, fino all’accusa di corruzione e alle dimissioni dalla funzione (non
dalla magistratura). Fino alle intercettazioni ambientali che raccolgono insulti
feroci alla famiglia Borsellino. Meglio non rifugiarsi nella tesi della “mela
marcia”. Solo per restare in tema e agli ultimi anni, è già accaduto con
Vincenzo Giglio, il presidente dell’omologa sezione di Reggio Calabria, appena
condannato in via definitiva per corruzione e rapporti con i clan; e con Maria
Rosaria Grosso, giudice della sezione fallimentare di Milano, indagata per
tentata concussione e abuso d’ufficio. Certo, esiste un problema di qualità dei
singoli cui viene conferito l’enorme potere decisionale ed economico della
giurisdizione. Ma accade che i vertici palermitani debbano ammettere di non
essere in grado di fornire una mappa degli incarichi agli amministratori
giudiziari; accade che nessun collega della stessa sezione, o del Tribunale,
abbia notato o segnalato alcuna anomalia in certe scelte, amicizie, parentele;
che un magistrato ottimamente retribuito si indebiti fino alla disperazione
senza che nessuno se ne accorga e anche per questo – sostiene Saguto – sfrutti
il proprio ruolo per restare a galla. Al di là degli individui, tutto ciò
significa che in ampie zone della magistratura, perno istituzionale dell’azione
antimafia e ordine autogovernato come solo il Parlamento, non vige alcun tipo di
verifica e di controllo. Solo malasorte? No. Esistono uffici giudiziari – anche
molto meno esposti di Palermo – che ormai controllano i flussi di lavoro, gli
incarichi, gli ammontari, popolando banche dati dalle quali estraggono
informazioni in tempo reale; ci sono Tribunali, Procure e Corti d’appello che
redigono il bilancio sociale per avere «una struttura organizzativa più
efficiente, per migliorare la capacità di comunicazione con i cittadini,
aumentando la trasparenza dell’azione svolta» (testuale dal sito del ministero)
ed è certo che in questi uffici il livello di controllo è di ben altra
efficacia. Non è impossibile, a volerlo fare. Ma bisognerebbe sentirsi meno
casta intoccabile e un po’ più reparto pregiato dello schieramento che comprende
commercianti iscritti alla Federazione antiracket, imprenditori con il rating di
legalità, giovani delle associazioni, sacerdoti e sindaci coraggiosi, pubblici
dipendenti che non prendono mazzette. Ognuno di questi protagonisti mostra pregi
da emulare e difetti da correggere, ma premessa per avanzare è prendere
onestamente atto dei propri limiti. Altrimenti si arretra a forza di indicare le
responsabilità altrui, lasciando che la bufera mediatica e giudiziaria si
plachi, per riprendere a sbagliare dal punto in cui si era stati interrotti.
QUESTIONI DI FAMIGLIA.
I fatal mariti,
scrive Sabato 19 Settembre 2015 Accursio Sabella su
“Live Sicilia”. Silvana Saguto è costretta a lasciare il suo incarico a causa di
una indagine che riguarda presunti favori al marito. La corsa di Anna
Finocchiaro verso il Quirinale è stata frenata anche dal caso del Pta di Giarre
che coinvolse il coniuge. E non sono gli unici casi, dalla consulenza del
"signor Chinnici" al ritardo di "mister Monterosso".
La moglie di Cesare deve apparire più onesta dell'imperatore. L'immagine è
rievocata a ogni scandalicchio e parentopolina. Qualcuno, però, in questi anni
ha forse dimenticato i mariti delle imperatrici. Fatal mariti, in molti casi. È
il caso di Silvana Saguto, ma non solo il suo. Perché i coniugi delle donne di
potere, in qualche caso, hanno finito per frenare e troncare carriere. O, in
qualche caso, per trascinare nella centrifuga di polemiche più o meno sensate,
le mogli. Ne sa qualcosa, come abbiamo già detto, Silvana Saguto, che ha
lasciato l'incarico di presidente della Sezione misure di prevenzione. È
indagata per corruzione e abuso d'ufficio. E la questione riguarda anche il
marito, appunto. L'accusa al magistrato infatti è relativa ai rapporti con
Gaetano Cappellano Seminara, il più noto degli amministratori giudiziari. A lui
sono giunti diversi incarichi di gestione di beni confiscati alla mafia. Una
fiducia ripagata – questa l'accusa, tutta da dimostrare – tramite consulenze che
lo stesso Cappellano Seminara avrebbe assicurato a Lorenzo Caramma, marito della
Saguto. Quanto basta, ovviamente, per fare da miccia a un'esplosione di veleni e
accuse incrociate che pare ancora all'inizio. E ha già portato all'estensione
dell'indagine ad altri tre magistrati. Intanto, la Saguto ha fatto le tende.
Attenderà un altro incarico. Ma il “colpo” alla carriera del magistrato è stato
durissimo. Marito, fatal marito. Che a pensarci bene, un'altra storia di coniuge
“scomodo” potrebbe aver contribuito a chiudere le porte del Quirinale a una
donna siciliana. È il caso di Anna Finocchiaro e soprattutto del fatal marito,
Melchiorre Fidelbo. Quest'ultimo è infatti finito dentro una inchiesta su un
maxi appalto dell'Asp di Catania destinato all'apertura del “Pta” di Giarre: una
struttura sanitaria “intermedia” che avrebbero dovuto alleggerire il peso dei
grossi ospedali. Fidelbo nell'ottobre del 2012 è stato anche rinviato a giudizio
per abuso di ufficio e truffa: è accusato di aver fatto pressioni indebite sui
dirigenti dell'Azienda sanitaria con lo scopo di ottenere l'affidamento. Una
vicenda ovviamente tirata fuori dai detrattori della Finocchiaro, nei giorni
caldi che hanno portato alla scelta del nuovo Capo dello Stato. Siciliano, ma
uomo. Nonostante la Finocchiaro pare piacesse molto anche a Forza Italia. Ma
quella storia... Chissà cosa si saranno detti, invece, Patrizia Monterosso e
Claudio Alongi, suo marito. E no, non c'entrano nulla i potenziali conflitti di
interesse tra un Segretario generale che contribuisce a scrivere le norme sui
dipendenti regionali e il commissario dell'Aran che – visto il ruolo – con i
dipendenti regionali deve discutere le norme che li riguardano. No, la storia è
un'altra. Ed è, in fondo, sempre la stessa. Quella per la quale la
plenipotenziaria di Palazzo d'Orleans è stata condannata dalla Corte dei conti a
oltre un milione di risarcimento per la vicenda degli extrabudget nella
Formazione professionale. Una condanna giunta nonostante l'appassionata difesa
del marito-avvocato Claudio Alongi. Anzi, “tecnicamente” proprio a causa
dell'avvocato-consorte. Perché il ricorso della Monterosso, al di là delle
questioni di merito che, stando ai giudici sarebbero rimaste tutte in piedi, è
stato respinto per un ritardo nella presentazione di alcuni documenti. Ritardo
dei legali, appunto. Marito compreso. Paradossi delle vite coniugali che si
intrecciano con le vite pubbliche. Ne sa qualcosa Caterina Chinnici. Fu lei la
massima sostenitrice di una legge sulla trasparenza che finalmente poneva dei
paletti (in questi anni a dire il vero, serenamente ignorati) riguardo alla
pubblicazione degli atti, degli stipendi e degli incarichi pubblici. Il caso,
però, ha voluto che a ignorare quelle disposizioni fosse anche un consulente
dell'Asp di Siracusa, Manlio Averna. Marito di Caterina Chinnici. Un caso che
creò anche tensioni all'interno della giunta di Raffaele Lombardo, con Massimo
Russo, ad esempio, molto critico sulla “dimenticanza” dell'Azienda siracusana.
"Non si può addebitare alla sottoscritta – replicò Caterina Chinnici -
l'eventuale inadempienza di coloro che dovrebbero controllare”. Polemiche,
ovviamente, poco più. Nulla a che vedere col “caso Saguto”, se non il ricorrere
di questi “incroci pericolosi” tra il divano di casa e le scrivanie del sistema
pubblico. Fastidi, o poco più, in cui il marito non sarà stato “fatale” per la
carriera, ma che certamente ha regalato alla consorte qualche minuto o qualche
giorno di tensione. Avvenne anche a Vania Contrafatto, attuale assessore
all'Energia. E il casus belli fu addirittura una cena, organizzata da Sandro
Leonardi, candidato dell'Idv al Consiglio comunale e marito della Contrafatto.
All'appuntamento c'erano, tra gli altri, il procuratore Francesco Messineo e gli
aggiunti Leonardo Agueci e Maurizio Scalia. Quest'ultimo era il magistrato che
coordinava l'indagine sui brogli alle primarie del centrosinistra. Una
rivelazione, quella, lanciata ironicamente nel corso di una conferenza stampa da
Antonello Cracolici: “Per sapere qualcosa sui presunti brogli alle primarie -
disse il capogruppo del Pd all'Ars - forse avremmo dovuto essere a una cena
elettorale che si è tenuta sabato a Mondello alla quale hanno partecipato, oltre
al candidato sindaco Leoluca Orlando, alcuni pm di Palermo che seguono le
indagini sulla vicenda". Orlando aveva denunciato brogli a quelle consultazioni
accusando il vincitore di quelle primarie, Fabrizio Ferrandelli. Tutto si
sgonfiò presto, con una nota del pm Scalia con la quale il magistrato spiegò di
aver preso parte “a un ricevimento in una casa privata di una collega e amica
per festeggiarne l'inaugurazione”. Vania Contrafatto, appunto. Una delle cene
probabilmente più indigeste per quello che sarebbe diventato il futuro assessore
all'Energia. E un marito può essere fatale persino “a costo zero”. Chiedete a
Valeria Grasso, nominata da Crocetta Soprintendente della Fondazione orchestra
sinfonica. Tra i consulenti, ecco spuntare il marito Maurizio Orlando: “Ma è qui
a titolo gratuito”, provò a spiegare l'imprenditrice antiracket. Pochi mesi
dopo, Crocetta l'avrebbe rimossa dalla guida della Foss.
Una cosa è certa, però. Per
i poveri cristi vale “Colpevole fino a prova contraria”. Per gli intoccabili
vale "Innocente fino a prova contraria o fino all’archiviazione o alla
prescrizione".
Nel "palazzo dello
scandalo". Un giorno con i giudici indagati,
scrive Riccardo Lo Verso Mercoledì 23 Settembre 2015 su “Live Sicilia”. Da
Silvana Saguto a Tommaso Virga, passando per Lorenzo Chiaromonte e Dario
Scaletta. Alcuni hanno cambiato incarico, altri hanno rinunciato a parte dei
loro compiti, ma è negli uffici giudiziari palermitani che attenderanno il
giudizio del Cms sulla loro eventuale incompatibilità ambientale. Tommaso Virga
è nella sua stanza al primo piano del nuovo Palazzo di giustizia di Palermo. Due
rampe di scale lo separano dalla sezione Misure di prevenzione finita sotto
inchiesta. Siede alla scrivania dopo avere appeso la toga e tolto la pettorina,
il bavaglino bianco che un regio decreto del 1865 impone di indossare ai giudici
in udienza. Questioni di forma e decoro. Virga parla con i cancellieri e prepara
il calendario delle udienze della quarta sezione penale. Fa tutto ciò che deve
fare un presidente che si è appena insediato. Archiviata l'esperienza di
consigliere togato al Consiglio superiore della magistratura aspettava che si
liberasse una sezione a Palermo. Un incrocio, quanto meno insolito, ha fatto sì
che andasse a prendere il posto di Mario Fontana, chiamato a sostituire Silvana
Saguto, l'ex presidente delle Misure di prevenzione travolta dall'indagine in
cui è coinvolto lo stesso Virga. Che si mostra disponibile con il cronista che
bussa alla sua porta. “Nel rispetto del ruolo che ricopro non ho mai fatto
dichiarazioni”, dice il presidente chiarendo subito la sua intenzione di non
cambiare idea proprio adesso. Inutile chiedergli dell'indagine che lo coinvolge,
della credibilità della magistratura che vacilla, della perplessità legittima di
chi si chiede se questa storia possa intaccare la serenità necessaria per chi
deve amministrare la giustizia al di là di ogni ragionevole dubbio,
dell'opportunità di continuare a fare il giudice a Palermo. Perché tutti i
magistrati coinvolti nell'indagine sono e resteranno a Palermo. Alcuni hanno
cambiato incarico, altri hanno rinunciato a parte dei loro compiti, ma è negli
uffici giudiziari palermitani, nei luoghi dello scandalo, che attenderanno il
giudizio del Csm sulla loro eventuale incompatibilità ambientale. Virga è tanto
garbato quanto ermetico. Si limita a fare registrare un dato incontrovertibile:
“Sono al mio posto, a lavorare”. I suoi gesti e il tono della voce sembrano
rispondere alla domanda sulla serenità. Qualcuno degli addetti alla cancelleria
si spinge oltre le impressioni con una frase asciutta: “L'autorevolezza del
presidente Virga è fuori discussione”. Già, l'autorevolezza, al centro delle
discussioni che impegnano gli addetti ai lavori nell'apparente normalità di una
mattinata al Palazzo di giustizia. Apparente perché è profondo il solco
tracciato dalla domanda che anima ogni capannello che si forma nei corridoi o
davanti alle aule: può essere credibile una magistratura segnata da un'indagine,
fastidiosa oltre che grave visti i reati ipotizzati? Nello scandalo dei beni
confiscati sono coinvolti quattro magistrati. Uno è Tommaso Virga, gli altri
sono Silvana Saguto e Lorenzo Chiaramonte (vecchi componenti della sezione
Misure di prevenzione, azzerata con l'arrivo di Fontana) e il pubblico ministero
Dario Scaletta. Hanno ruoli diversi nella vicenda. Per tutti vale il principio
della presunzione di non colpevolezza su cui si basa il nostro stato di diritto.
La Saguto sarebbe il vertice del presunto sistema affaristico - i pubblici
ministeri di Caltanissetta ipotizzano i reati di corruzione, induzione alla
concussione e abuso d'ufficio - creato attorno alla gestione dei beni
sequestrati e confiscati alla mafia. Un sistema che avrebbe finito per favorire
alcuni amministratori giudiziari piuttosto di altri. Fra i “favoriti” ci
sarebbero Gaetano Cappellano Seminara, il principe degli amministratori, e il
giovane Walter Virga, figlio del Tommaso di cui sopra. A detta dei pm nisseni,
il primo sarebbe stato nominato in cambio di consulenze assegnate al marito
della Saguto e il secondo per "ringraziare" Virga padre che, quando era
consigliere del Csm, avrebbe calmato le acque che si agitavano sull'operato
della Saguto. Un aiuto smentito nei giorni scorsi da Virga, tramite il suo
legale, l'avvocato Enrico Sorgi: “Durante il proprio mandato al Csm non
risultano essere stati avviati procedimenti disciplinari a carico della Saguto.
I fatti che formano oggetto della notizia diffusa sono del tutto privi di
potenziale fondamento”. Chiaramonte, invece, è indagato per abuso d'ufficio
perché non si sarebbe astenuto quando ha firmato l'incarico di amministratrice
giudiziaria a una persona di sua conoscenza. Infine c'è Dario Scaletta, pm della
Direzione distrettuale antimafia e rappresentante dell'accusa nei processi in
fase di misure di prevenzione. Scaletta avrebbe fatto sapere alla Saguto che era
stata trasferita da Palermo a Caltanissetta l'inchiesta su Walter Virga e cioè
il fascicolo da cui è partito il terremoto giudiziario. Il pubblico ministero ha
chiesto di non occuparsi più di indagini su Cosa nostra e di misure di
prevenzione. Tutti i magistrati, coinvolti nell'indagine a vario titolo e con
profili diversi, restano a Palermo. Silvana Saguto, appena avrà recuperato da un
infortunio fisico, andrà a presiedere la terza sezione della Corte d'assise.
Chiaramonte, ultimate le ferie, prenderà servizio all'ufficio del Giudice per le
indagini preliminari. Sarà il Csm a decidere se e quando trasferirli. Sul caso è
stato aperto un fascicolo, di cui si occuperà la Prima Commissione, competente
sui trasferimenti per incompatibilità ambientale e funzionale dei giudici. Il
Consiglio superiore della magistratura per tradizione non spicca in velocità. In
una giustizia spesso lumaca non fa eccezione il procedimento davanti
all'organismo di autogoverno della magistratura che somiglia molto, nel suo
svolgimento, ad un processo ordinario. A meno che non venga preso un
provvedimento cautelare urgente ci vorrà tempo prima di conoscere il destino dei
magistrati, forse più di quanto ne servirà ai pubblici ministeri di
Caltanissetta per chiudere le indagini o agli stessi indagati per chiarire la
loro posizione. Il “forse” è dovuto al fatto che le indagini affidate ai
finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Palermo sembrano essere appena
all'inizio e i pm non hanno alcuna intenzione, al momento, di sentire i
magistrati che avevano chiesto di essere interrogati. Oggi, però, son arrivate
le parole del vicepresidente del Csm Giovanni Legnini durante il plenum. "Oggi
parlerò con il presidente della Repubblica", ha detto ribadendo la volontà di
"procedere con la massima tempestività e rigore".
Lo scandalo dei beni sequestrati alla
mafia e il ruolo della Massoneria, scrive Riccardo
Gueci su "La Voce di New York" dekl 29 ottobre 2015. Tutti sapevano come veniva
gestita la Sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. Ma
nessuno parlava. E il motivo è semplice: perché dietro questo grande affare c’è
la Massoneria. I grandi 'numeri' della holding di don Ciotti, Libera: chi
guadagna sulle lucrose vendite dei prodotti agricoli di questa associazione
antimafia? Sull’indegna questione che ha investito la Sezione misure di
prevenzione del Tribunale di Palermo vanno in scena le sceneggiate di tanti
protagonisti. Il primo è un esponente del mondo politico. A recitarla è
l'onorevole Claudio Fava, membro autorevole della Commissione parlamentare
Antimafia. Salvo Vitale - come riportato nella pagina Facebook di Riccardo
Compagnino - riprende una dichiarazione del deputato di Sinistra Ecologia e
Libertà nella quale si legge: “C'è un punto di cui nessuno ci ha mai parlato,
ovvero che il marito della presidente della Sezione Misure di Prevenzione del
Tribunale di Palermo, Silvana Saguto, avesse una preziosa consulenza con lo
studio del commercialista che si occupa della gran parte dei beni sequestrati”.
A questa dichiarazione, Salvo Vitale, con la serenità di chi sa il fatto suo,
ribatte: “A parte il fatto che Cappellano Seminara è un avvocato e non un
commercialista, non è giusto, né corretto che tu faccia questa affermazione”. E,
nel far trasparire che egli con quel deputato ha avuto una qualche
frequentazione, continua: “Già un anno fa, quando è esploso il problema, ti sei
schierato a fianco della Bindi (presidente della Commissione Antimafia, ndr) per
'tutelare' l'immagine di un settore della Procura di Palermo di cui da tempo
avevamo denunciato le malefatte e lo strano modo di procedere. Le denunce del
Prefetto Caruso sono state pressoché ignorate e tutto è stato lasciato al suo
posto. Anche quando sei venuto a farci visita ti abbiamo informato su quello che
c'era sotto, hai abbassato il capo, dicendo che bisognava intervenire, ma forse
eri distratto”. Vitale prosegue nella sua replica affrontando un aspetto che,
con tutta probabilità, è quello di maggiore rilevanza economica e sociale di
questo andazzo affaristico-massonico: il fallimento di aziende, anche quelle
sequestrate a gente che è risultata estranea agli affari di mafia. Questa serie
di fallimenti ha concorso a determinare l'impoverimento dell'economia di Palermo
e della sua provincia, che già di suo non è mai stata prosperosa. “Invece di
lasciarsi prendere dalla paura di una destabilizzazione della magistratura -
aggiunge Vitale - cosa peraltro ripetuta dal giudice Morosini - sarebbe stato
più utile per la storia che ti porti appresso chiedere di far pulizia
all'interno di essa, anche perché la fiducia dei cittadini non si conquista
facendo credere che tutto è a posto, anche se tutto va male, ma intervenendo per
far pulizia e mettere davvero tutto a posto, quando bisogna far pulizia in casa.
Bastava guardare a Villa Teresa (Villa Santa Teresa, clinica privata confiscata
all’ingegnere Michele Aiello ndr) - dove la scandalosa amministrazione del
pupillo di Cappellano Seminara, Andrea Dara, che gli ha regalato un milione di
euro per una consulenza, ha prodotto danni economici e gestionali incalcolabili
- per renderti conto che la signora Saguto Silvana, il signor Caramma Elio, suo
figlio, e il signor Caramma Lorenzo, suo marito, hanno effettuato radiografie,
risonanze magnetiche, cervicale, dorsale, spalla, ginocchio senza che il loro
nome risulti sulla lista dei pagamenti. Bastava chiedere alla signora Saguto una
motivazione sul perché tanti incarichi nelle mani di poche persone e sul perché
si sono emessi decreti di confisca quando la magistratura penale aveva escluso
la provenienza mafiosa del bene. Bastava. E, invece, non si è fatto niente. E'
facile dire che non sapevamo...è difficile crederci”. In sostanza, il deputato
di Sel e vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia ha recitato la
sua sceneggiata e Vitale con dovizia di particolari e di argomenti l'ha
recensita a dovere. Fin qui l'arringa di Vitale. Ma c'è un'altra fonte di
notizie che va tenuta in debita considerazione ed è quella di Pino Maniaci,
direttore di TeleJato, la testata che per prima ha sollevato il caso. Maniaci è
stato intervistato dal nostro Giulio Ambrosetti “per conoscere qualche dettaglio
in più e le sue valutazioni sul caso” ed ha avuto modo di annotare alcune sue
valutazioni assai interessanti. In particolare su quanto riportato in un
articolo del Giornale di Sicilia che rende noti alcuni stralci delle
intercettazioni telefoniche tra la dottoressa Silvana Saguto e l'avvocato
Gaetano Cappellano Seminara, dove si fa riferimento all'impresa Calcestruzzi.
Pino Maniaci, saggiamente, precisa: “Quando si parla di Calcestruzzi a chi si fa
riferimento? Ricordo che Grimaldi, il figlio di un cancelliere (del Tribunale di
Palermo ndr) amministra almeno dodici aziende di calcestruzzo”. Quindi
l’affondo: “La dottoressa Saguto ha tirato in ballo Libera. Addiopizzo e il
presidente del Tribunale di Palermo, Leonardo Guarnotta. A suo dire le
associazioni antimafia e antiracket segnalavano i nomi degli amministratori
giudiziari. Tutto questo a me sembra incredibile”. Ad una seconda domanda
generica sulle associazioni antimafia, “parliamo un po' di Libera e di
Addiopizzo”, Pino Maniaci puntualmente fa rilevare che “sia Libera, sia
Addiopizzo sono partite da zero. Oggi sono delle holding. Ciò posto, il ruolo
che hanno svolto è positivo. Su Libera mi sono posto e continuo a pormi qualche
domanda. Per esempio: perché i prodotti di Libera debbono costare tanto? Un
pacco di pasta 5/6 euro, un vasetto di caponata 5 euro. Sono prezzi proibitivi.
Sarebbe auspicabile che tali prodotti diventino accessibili a tutte le tasche.
Sull'argomento ho chiesto un parere a don Ciotti. Ma non ho avuto risposte”. Le
tirate moralistiche di don Luigi Ciotti le dobbiamo considerare anch'esse
sceneggiate? “Poi c'è la questione legata ai sequestri. Mi riferisco alla
proposta di legge, che il Parlamento deve ancora iniziare a discutere, sulla
gestione dei beni sequestrati. Questa proposta di legge - relatore il
parlamentare Davide Matello, del PD, da sempre vicino a Libera - prevede di
assegnare alle associazioni antimafia, in via provvisoria, i beni e le aziende
sequestrate alla mafia. A me questa proposta sembra sbagliata. Ricordiamoci che
un bene sequestrato può tornare al suo legittimo proprietario, là dove non
dovessero emergere problemi”. E sempre a questo proposito, che risulta essere
uno dei temi più delicati del sistema delle confische, Maniaci prosegue nel
ricordare come in alcune vicende che hanno visto tante imprese avere avuto
riconsegnate le loro aziende dopo il sequestro, svuotate di ogni attività, al
limite del fallimento. Con questa procedura “è stata distrutta buona parte
dell'economia di Palermo e della sua provincia”. Ed aggiunge “sarebbe
interessante ascoltare le testimonianze degli imprenditori che hanno subito
queste ingiustizie”. E ricorda la vicenda dell'impresa Niceta che con tutta
probabilità chiuderà i battenti: “Della vicenda Niceta abbiamo le carte. Gli
amministratori giudiziari hanno licenziato circa 50 dipendenti e ne hanno
assunti 24. Alcuni di questi nuovi assunti sono amici del solito giro. L'ho
detto e lo ribadisco: in questa vicenda tagliare le teste lasciando il corpo non
serve a nulla. A che serve mandare via Virga se poi i coadiutori, nominati dallo
stesso Virga, restano?”. E continua: “Dietro la gestione dei beni sequestrati e
confiscati alla mafia ci sono interessi enormi. Vi siete chiesti perché la
dottoressa Saguto non è stata toccata? Ve lo dico io: perché tiene in pugno
personaggi importanti”. Fin qui l'intervista a Pino Maniaci. C'è poi un'altra
sceneggiata, che sa di paradosso. Stavolta la limitiamo al massimo. La
dottoressa Saguto, poverina, a causa del magro stipendio che le passa lo Stato
per il suo lavoro di magistrato, si era ridotta a contrarre un debito con il
supermercato - sequestrato alla mafia - dove faceva la spesa per sfamare la
famiglia. Ed addirittura secondo un articolo apparso sul Giornale di Sicilia, la
poverina non aveva i soldi per pagare la bolletta della luce. Le cronache ci
consegnano questo quadro, al netto delle intercettazioni telefoniche che
riguardano giudizi del tutto gratuiti sui figli di Paolo Borsellino, il
magistrato fatto saltare con la sua scorta in via D'Amelio nel 1992, delle quali
ci intratterremo in seguito. Queste cronache ci inducono a sottolinearne alcuni
aspetti. Il primo riguarda il sistema gerarchico del Tribunale di Palermo. Se la
Sezione Misure di prevenzione procede al sequestro di beni per i quali la stessa
‘macchina’ della Giustizia ha escluso la provenienza mafiosa, non c'è in quel
sistema gerarchico qualcuno che faccia presente che quel sequestro è
illegittimo? La ragione di questa 'assenza' è dovuta ad un potere occulto, che
anche i ciechi e i sordi sanno fare capo alla Massoneria. Infatti, tutti gli
uffici del Tribunale, specialmente Civile e in parte del Lavoro, sono largamente
infiltrati dal potere massonico. Lo sanno tutti, ma nessuno parla. Nel giro è
compresa larga parte dell'avvocatura. La cosa non è nuova, basta ricordare
quello che è accaduto al dottor Alberto Di Pisa quando, sull'argomento, si
'permise' di esprimere qualche opinione. Ricordate la vicenda del “corvo”? Da
allora non è cambiato nulla. Anzi! Non va trascurato il fatto che molto spesso
tra la Massoneria e la mafia è esistita una intesa molto stretta. Infatti, tra
sette segrete ci si intende più facilmente e si possono curare affari molto
lucrosi se si opera di comune accordo. Intanto quelle aziende, affidate alle
'cure' di amministratori di fiducia vengono distrutte e, talora, riconsegnate ai
legittimi proprietari semi fallite e con le maestranze licenziate. Con il bel
risultato di avere provocato sia un danno all'economia, sia un contributo in più
alla disoccupazione. Il secondo fa riferimento alle perplessità manifestate da
Pino Maniaci a proposito di Libera, l'associazione creata dal don Luigi Ciotti
per amministrare, attraverso un sistema di cooperative, i beni immobili,
specialmente terreni agricoli confiscati alla mafia. Maniaci fa riferimento ai
prezzi proibitivi dei prodotti agricoli di queste cooperative e di averne
chiesto inutilmente le motivazioni a don Ciotti. E rileva che ormai Libera è una
vera e propria holding. A proposito di tale questione va ricordato che le
cooperative agricole, promosse da Libera, che gestiscono i terreni agricoli
confiscati alla mafia sono finanziate con le risorse finanziarie europei dei
PON, cioè dei Piani Operativi Nazionali, sezione fondi strutturali europei per
la sicurezza. In definitiva quelle cooperative hanno i costi di gestione coperti
dai fondi europei e, spesso, utilizzano locali di vendita dei loro prodotti
anch'essi confiscati alla mafia. Non solo. Per l'uso dei terreni agricoli non
pagano nulla, ancorché in affidamento. Il capitale investito dai loro soci è di
entità simbolica. In sostanza, gestiscono soltanto utili. In presenza di queste
condizioni irripetibili in nessuna parte del mondo, non si capisce la ragione
economica del perché i loro prodotti abbiano questi prezzi proibitivi destinati
al consumatore di reddito medio alto. A chi vanno questi ragguardevoli profitti?
Un’indagine su costi, ricavi e investimenti delle cooperative di Libera non
sarebbe del tutto fuori luogo. Il terzo riguarda il Consiglio Superiore della
Magistratura (CSM). Secondo quanto riferito dalla dottoressa Silvana Saguto,
l'organo di autogoverno dei magistrati ha invitato tutti coloro che sono
implicati nelle vergognose vicende ricordate in precedenza a chiedere il
trasferimento. Questo è un punto delicato per la credibilità della Magistratura
che rischia di farla apparire una corporazione al di sopra e al di fuori della
legge che vale per tutti gli altri cittadini italiani. La questione, invece, è
molto semplice: la dottoressa Saguto, nell'ambito dei suoi compiti d'istituto,
ha compiuto quegli atti che le vengono addebitati? Allora: se quegli atti si
configurano non conformi alla deontologia professionale o, addirittura, come
reati, la dottoressa Saguto e i suoi complici vanno licenziati in tronco alla
stregua di qualsiasi altro lavoratore che non svolga i compiti che gli sono
assegnati con la dovuta correttezza. In questo caso nella condizione del
licenziamento dovrebbe figurare pure il divieto perenne ad entrare in un'aula di
qualsiasi Tribunale italiano, neanche come avvocato. Il congresso del sindacato
italiano dei magistrati, ove volesse darsi un minimo di dignità, dovrebbe
discutere di deontologia e di valori etici nell'esercizio della professione per
dare più forza e credibilità alla funzione del magistrato.
*Riccardo Gueci è un dirigente pubblico in pensione. Cresciuto nel vecchio Pci,
non ha mai dimenticato la lezione di Enrico Berlinguer. Per lui la politica non
può essere vista al di fuori della morale (Berlinguer, grande leader del Pci, a
proposito della gestione del potere in Italia, parlava infatti di "Questione
morale"). Per noi Gueci commenta i fatti legati alla politica estera e
all'economia. Oggi affronta il tema delle polemiche che stanno accompagnando la
gestione della Sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Palermo.
Tema che affronta da una particolare angolazione: quella economica, per
l'appunto. Sottolineando il ruolo che nell'economia siciliana - spesso in modo
occulto - viene svolto dalla Massoneria.
Quello che gli altri non
dicono.
Omicidio Mauro Rostagno, le
motivazioni: “Logge e 007, ma ad ammazzarlo fu Cosa nostra”,
scrive Giuseppe Pipitone il 29 luglio 2015 su “Il Fatto Quotidiano”. Depositate
le tremila pagine di motivazione della sentenza di condanna all'ergastolo per
Vincenzo Virga e Vito Mazzarra, mandante ed esecutore dell'omicidio del
sociologo e giornalista. "La torsione nelle finalità istituzionali degli
apparati di intelligence che si consuma proprio in quegli anni crea un terreno
propizio all’instaurazione di sordidi legami tra alcuni esponenti dei Servizi e
ambienti della criminalità organizzata". Di sicuro c’è solo che ad ammazzarlo fu
la mano di Cosa nostra. Sullo sfondo, invece, rimangono ancora troppi i moventi,
all’interno di un contesto difficilissimo da ricostruire tra depistaggi,
interessi incrociati, relazioni pericolose e prove scomparse. Ventisette anni
dopo, occorrono più di tremila pagine per spiegare chi e perché uccise Mauro
Rostagno, sociologo e giornalista, militante arancione e leader di Lotta
continua, fondatore della comunità terapeutica Saman e testimone della svolta
nera di Cosa nostra a Trapani, tra logge massoniche e attività coperte dei
servizi d’intelligence. Si era trasferito in Sicilia già da alcuni anni
Rostagno, quando il 26 settembre del 1988, viene freddato a colpi di fucile in
contrada Lenzi, a pochi passi dalla comunità che aveva creato insieme a Ciccio
Cardella, conosciuto in India negli anni ’70, poi coinvolto in uno dei tanti
rivoli investigativi sul mai del tutto risolto omicidio del sociologo torinese.
Quasi trent’anni dopo, però, la corte d’assise del comune trapanese ha trovato
autori e mandanti di quel delitto: sono, nell’ordine, il killer Vito Mazzara e
il boss di Cosa nostra Vincenzo Virga, condannati all’ergastolo il 16 maggio del
2014. Ci sono voluti altri quattordici mesi perché il giudice Angelo Pellino
depositasse le tremila pagine con le quali motiva quelle condanne. Un documento
storico – giudiziario importante quello di Pellino, perché ricostruisce il
contesto trapanese degli anni ’80, all’interno del quale matura l’omicidio
Rostagno. “La torsione nelle finalità istituzionali degli apparati di
intelligence che si consuma proprio in quegli anni e che ha a Trapani, con la
costituzione dell’ultimo Cas nella storia di Gladio, un suo epicentro, crea un
terreno propizio all’instaurazione di sordidi legami tra alcuni esponenti dei
Servizi e ambienti della criminalità organizzata locale”, scrive il presidente
della corte d’assise nelle motivazioni della sentenza. La Trapani degli anni
’80, infatti, è una città borderline, cerniera di rapporti tra 007 coperti,
massoni, boss di Cosa nostra, all’ombra dell’ultimo centro d’addestramento di
Gladio, la struttura paramilitare segreta nata come costola di Stay Behind, che
stabilisce nella città delle saline una delle cinque basi coperte della VII
divisione del Sismi: la stessa che nascondeva gli Ossi, gli operatori speciali
Stato Italiano, che per l’ambasciatore Francesco Paolo Fulci, erano legati alla
Falange Armata. “Ne scaturisce – continua Pellino – una rete di relazioni
pericolose, fatte di intese e scambi di favori reciproci e protezioni.
Un’organizzazione criminale che detiene un controllo capillare del territorio
può essere fonte della merce più preziosa per un apparato di intelligence, le
informazioni; ma può servire anche per operazioni coperte, ovvero per offrire
copertura a traffici indicibili da tenere al riparo da sguardi indiscreti.
Traffici che coinvolgono pezzi di apparati militari e di sicurezza dello Stato,
all’insaputa dei vertici militari e istituzionali o dei responsabili politici”.
Ed è in questo contesto che Rostagno comincia a fare il giornalista a Trapani,
seguendo per primoil processo per l’omicidio Vito Lipari, sindaco della
Castelvetrano dei Messina Denaro, e avviando una serie d’inchieste sul
territorio “Su questo versante – continua la motivazione della sentenza –
Rostagno poteva essere una minaccia, dopo che aveva scoperto gli strani traffici
che avvenivano a ridosso della pista di un vecchio aeroporto militare
ufficialmente in disuso alle porte di Trapani”. Tra i lavori svolti dal reporter
Rostagno, una nota a parte meritano per i giudici le “autonome
inchieste inchieste giornalistiche che miravano a varcare la soglia di autentici
santuari del potere locale come era all’epoca la rete di circuiti massonici che
faceva capo al Centro studi Antonio Scontrino a Trapani”. È un centro
importante quello di via Carreca, un posto dove non vanno in onda solo aperitivi
e iniziative culturali: è l’11 aprile del 1986, due anni prima dell’omicidio
Rostagno, quando la polizia fa irruzione e scopre che Scontrino è il paravento
di sei logge massoniche, Iside, Iside 2, Osiride, Ciullo d’Alcamo, Hiram e
Cafiero. Dopo che venne alla luce l’esistenza delle logge, Paolo Scontrino,
si giustifica parlando delle conferenze pubbliche organizzate dal circolo :
“Ricordo che in qualche riunione, anzi in una riunione fu presente l’Onorevole
Sergio Mattarella, un’altra volta il Sindaco di Trapani, ma anche alcuni lama
tibetani e fra gli altri che ricordo, tale padre Antonj, di religione indù, la
signora Dacia Maraini, il capo della comunità israelitica di Roma padre Toaf,
padre Evloghi, della Chiesa ortodossa ed altri”. Ad interrogare Scontrino il 28
ottobre del 1986 fu il maresciallo dei carabinieri Beniamino Cannas, uno dei
testi per i quali la Corte d’Assise ha chiesto oggi la trasmissione degli atti
in procura. Il presidente della Repubblica Mattarella, che all’epoca dei fatti
era un deputato della Dc, oggi invece smentisce di essere stato un
“frequentatore” delle iniziative del circolo Scontrino. “La sola volta in cui è
venuto a conoscenza dell’esistenza di questo circolo – fanno sapere dal
Quirinale – è stata, nei primi anni Ottanta, in occasione della conferenza,
sulla giustizia tributaria, di un suo collega, che Mattarella è andato ad
ascoltare apprendendo in quella sede che la conferenza era promossa da un
circolo denominato Scontrino a lui del tutto sconosciuto e con il quale non ha
mai avuto, né prima né dopo, alcuna relazione o contatto di qualsivoglia
genere”. Il paravento del circolo Scontrino è comunque crocevia d’interessi e
rapporti ad alto rischio. E per questo motivo che i giudici sottolineano come i
“sordidi legami” tra pezzi della massoneria e agenti dei servizi “per quanto non
direttamente afferenti al movente del delitto, abbiano avuto l’effetto di
incoraggiare i vertici dell’organizzazione mafiosa ad agire, nella ragionevole
convinzione di poter contare, una volta commesso il delitto, su una rete di
protezioni e connivenze pronta a scattare in caso di necessità: come alcune
sconcertanti emergenze di questo processo fanno paventare sia accaduto”. Come
dire che la mano che ha sparato a Rostagno è targata Cosa nostra, ma per
proteggerla si sono mossi poteri differenti da quelli mafiosi. È per questo
motivo che oggi rimangono ancora parecchi i buchi neri irrisolti. A cominciare
dai pezzi mancanti dell’indagine: le lettere che Rostagno si scambiava con il
fondatore delle Brigate Rosse Renato Curcio, la videocassetta in cui il
giornalista aveva registrato le riprese del presunto traffico d’armi scoperto
nei pressi della pista d’atterraggio di Kinisia, il memoriale sull’omicidio del
commissario Luigi Calabresi, fino alla partizione del proiettile calibro 38
estratto dal corpo del sociologo durante l’autopsia. Poi c’è la relazione
elaborata dagli 007 del centro Scorpione su Saman: svanita nel nulla come tutti
gli altri pezzi di puzzle. Nonostante le numerosi tesi investigative, la
presenza intorno alla matrice del delitto di personaggi che anche durante il
processo sono rimasti sullo sfondo, per Pellino l’unica pista provata
sull’omicidio Rostagno è quella mafiosa. “L’indagine sul movente dell’omicidio
che ha impegnato larga parte dell’istruzione dibattimentale – spiega il giudice
– ha consentito di misurare tutta l’inconsistenza delle piste alternative a
quella mafiosa, che pure sono state esplorate, senza preconcetti. Di contro, a
partire proprio da una ricognizione dei contenuti salienti del lavoro
giornalistico della vittima, di talune sue inchieste in particolare, ma del suo
stesso modo di concepire e soprattutto di praticare il giornalismo e
l’informazione come terreno di elezione di una ritrovata passione per l’impegno
civile, è emerso come Cosa Nostra avesse più di un motivo, e uno più valido
dell’altro, dal suo punto di vista, per volere la morte di Rostagno. E il
bisogno di mettere a tacere per sempre quella voce che come un tarlo insidiava e
minava la sicurezza degli affari (illeciti) e le trame collusive delle cosche
mafiose”. Nella città dei misteri, dove 007 si danno appuntamento con mafiosi e
massoni, Rostagno inizia a dare fastidio, inizia ad essere una “camurria” per i
boss di Cosa nostra. “Il suo sforzo – continua Pellino – di ridisegnare la mappa
degli organigrammi del potere mafioso e di individuare le figure emergenti che
potevano avere preso il posto degli esponenti della vecchia guardia di Cosa
Nostra, decimati da arresti ma ancora di più dai colpi messi a segno dalle
cosche antagoniste che nuovo slancio traevano dalla loro capacità di inserirsi
nella gestione del narcotraffico o in altre redditizie attività”. È per questo
motivo che alla fine, Pellino spiega come “le dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia, dopo una doverosa scrematura di quelli meno affidabili, convergono su
una duplice indicazione: l’omicidio fu deciso dai vertici di Cosa Nostra
trapanese o comunque con il loro assenso e dopo che fu vanamente esperito il
tentativo di indurre il giornalista a più miti consigli con pressioni e minacce
per interposta persona”. Sul terreno oltre al cadavere del giornalista, rimane
un processo che dopo 27 anni è arrivato solo al primo grado di giudizio, due
colpevoli condannati e gli artefici di insabbiamenti in serie mai individuati.
NO DAI, ABBIAMO PURE UN
PRESIDENTE MASSONE? (NON SAREBBE IL PRIMO) – SERGIO MATTARELLA TENNE CONFERENZE
AL CENTRO CULTURALE “SCONTRINO” DI TRAPANI, PARAVENTO DI LOGGE MASSONICHE
INFILTRATE DA MAFIOSI – DEL CENTRO SI ERA OCCUPATO ROSTAGNO PRIMA DI ESSERE
AMMAZZATO.
Al processo Rostagno la “gola
profonda” Paolo Scontrino ha spiegato che il Gran Maestro Giovanni Grimaudo, che
mandava avanti il centro, era notoriamente un Venerabile e che i personaggi che
accettavano di andare a tenere conferenze sapevano di avvicinarsi ad ambienti
massonici…scrive Sandra Rizza per il “Fatto Quotidiano” il 29 luglio 2015 pag. 1
e 2. C’erano Calogero Mannino e Carlo Vizzini, ma anche il capo dello Stato
Sergio Mattarella (all’epoca deputato Dc) tra i frequentatori delle iniziative
pubbliche del circolo “Scontrino”, il centro di cultura ospitato in un palazzo
barocco, che negli anni ‘80 nascondeva un vero e proprio tempio massonico e che
ora la Corte d’Assise di Trapani, nelle motivazioni della sentenza Rostagno,
definisce un paravento di logge infestate da elementi mafiosi del calibro di
Gioacchino Calabrò, l’artificiere della strage di Pizzolungo. Quando, l’11
aprile 1986, la polizia perquisì il circolo di via Carreca, nel centro storico
trapanese, saltarono fuori sei logge: Iside, Iside 2, Osiride, Ciullo d’Alcamo,
Hiram e Cafiero, ma anche una copiosa documentazione di agende e rubriche fitte
di numeri di telefono di esponenti politici locali e nazionali. I loro nomi, ora
scolpiti nero su bianco nel verdetto su Rostagno, li aveva già elencati in aula
il generale Nazareno Montanti, ex dirigente dei carabinieri di Trapani: “Sergio
Mattarella e Francesco Canino, entrambi Dc, Carlo Vizzini del Psdi, e l’ex
sindaco di Trapani Erasmo Garuccio”. Informazione confermata da Paolo Scontrino,
una delle fonti più introdotte nel circolo, che nel suo verbale reso alla
Criminalpol il 28 ottobre nel 1986, raccontò come il centro Scontrino
organizzasse “conferenze alle quali mi risulta abbiano partecipato l’on. Sergio
Mattarella, l’on. Vincenzino Culicchia (oggi Pdr), l’on. Francesco Canino (morto
nel 2014)” ma anche “il rabbino Toaf” e ancora “lama tibetani, tale padre Antonj
di religione Indù, Dacia Maraini… e altri’’. Nella perquisizione si trovò anche
una lettera di Mannino, datata 24 ottobre 1984, e indirizzata al Gran Maestro
Giovanni Grimaudo, nella quale il politico informava che era stato concesso al
centro Scontrino “un contributo in denaro”. Poco prima di essere ucciso,
Rostagno indagava proprio sul mondo delle logge. L’avvocato Antonio Marino, ex
segretario del Pci a Trapani, ha rivelato che sulla scoperta della loggia
segreta Iside 2, alla quale erano iscritti “soggetti importanti” (oltre a
Calabrò, il mafioso Natale L’Ala e il principe Gianfranco Alliata di Montereale,
coinvolto e poi prosciolto dall’indagine sul golpe Borghese), si era confrontato
con Mauro più di una volta. L’avvocato racconta che il primo editoriale sul caso
Scontrino firmato da Rostagno, il 22 febbraio del 1988, fu connotato da una
“plateale banalizzazione della vicenda”: fino ad insinuare che fosse tutta “una
montatura di Sergio Mattarella per colpire l’avversario Canino”. In realtà, ha
raccontato Marino: “Mauro mi disse: faccio finta di non aver capito, perché è
una cosa grossa e voglio indagare ancora”. Il legale racconta anche che Rostagno
volle incontrare il giudice istruttore Nunzio Trovato, per riferirgli che si era
recato al circolo Scontrino, scoprendo che Licio Gelli per due volte era stato a
Trapani, proprio nel periodo della costituzione di Iside 2, anche se Grimaudo ha
sempre smentito. Professore di filosofia, l’organizzatore delle iniziative
culturali del circolo Scontrino era proprio il Gran Maestro, che esibiva le sue
conoscenze con i politici, mentre teneva riservate le amicizie con l’avvocato
catanese Michele Papa, che vantava precedenti per banda armata, e con Pino
Mandalari, il commercialista di Totò Riina. Parlando delle relazioni altolocate
di Grimaudo, però, la “gola profonda” Paolo Scontrino ha spiegato che era così
notorio il suo ruolo di Venerabile, da presumere “che i personaggi invitati alle
conferenze sapessero di avvicinarsi ad ambienti massonici”. È stato il
maresciallo dei carabinieri Beniamino Cannas, uno dei testi per i quali la Corte
d’Assise ha chiesto la trasmissione degli atti in Procura, ad interrogare Paolo
Scontrino: non provò neppure, rilevano i giudici, ad “approfondire il
coinvolgimento del circolo in traffici d’armi o tresche con i servizi”. Né si
scomodò a passare il verbale ai pm del delitto Rostagno: “sebbene contenesse
spunti investigativi quanto meno rilevanti”.
In riferimento all’articolo
pubblicato il 29 luglio a pagina 1 e 2 da il Fatto Quotidiano con il titolo
“Mattarella ospite del circolo della loggia massonica deviata” a firma di Sandra
Rizza, l’Ufficio Stampa del Quirinale precisa quanto segue: Sergio Mattarella
non ha mai tenuto alcuna conferenza al circolo “Scontrino”, di cui non è stato
affatto “frequentatore” delle iniziative. La sola volta in cui è venuto a
conoscenza dell’esistenza di questo circolo è stata, nei primi anni Ottanta, in
occasione della conferenza, sulla giustizia tributaria, di un suo collega
professore della Facoltà di Giurisprudenza di Palermo che lo ha invitato ad
assistervi. Sergio Mattarella si è recato ad ascoltarlo, apprendendo in quella
sede che la conferenza era promossa da un circolo denominato “Scontrino”, a lui
del tutto sconosciuto e con il quale non ha mai avuto, né prima né dopo, alcuna
relazione o contatto di qualsivoglia genere.
Il punto: Mattarella ospite
della massoneria deviata.
Il nome del presidente spunta fuori dalle motivazioni della
sentenza sul caso Rostagno, scrive Domenico Camodeca su “L’Indro”. Le carte del
processo Rostagno, chiuso a Trapani nel 2014, descrivono l’attuale inquilino del
Colle nella veste di inconsapevole conferenziere al centro culturale
"Scontrino", secondo i giudici copertura legale di logge massoniche deviate. Il
giornalista Mauro Rostagno aveva scoperto tutto e, forse per questo, venne
ammazzato dalla mafia nel 1988. Se Mattarella sa qualcosa, parli. Ma, intanto, i
mass media di Regime mettono il silenziatore alla notizia. Il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella partecipò più volte, durante gli anni ’80 quando
era deputato DC, alle iniziative del circolo culturale "Scontrino" di Trapani.
Insieme a lui anche altri politici di moda a quei tempi come Calogero Mannino e
Carlo Vizzini. In realtà, il simposio trapanese avrebbe avuto la funzione di
‘paravento’ per gli affari occulti di logge massoniche in cui coesistevano
pacificamente mafiosi, uomini dei Servizi e altri pezzi dello Stato. Questa
notizia bomba non è un’ipotesi investigativa, ma parte del contenuto scritto
nero su bianco delle 3000 pagine delle motivazioni della sentenza del 16 maggio
2014 sul caso Rostagno, da poco depositate. La verità processuale finora emersa
ci dice che Mauro Rostagno era il giornalista-sociologo ucciso dalla mafia il 26
settembre 1988 allo scopo di impedirgli, così la pensano i giudici, di rivelare
quanto aveva scoperto sui torbidi rapporti intrecciati nell’Isola da massoneria,
Cosa Nostra, pezzi dello Stato e gli immancabili Servizi deviati. E allora? Cosa
ci stava a fare in quel covo di presunti massoni corrotti il fratello di
Piersanti, presidente della Regione Sicilia, ucciso nel 1980 e divenuto per
questo emblema dell’antimafia? Fino a prova contraria niente di male, perché il
discusso centro ‘Scontrino’ organizzava conferenze partecipate anche da
personaggi noti come il rabbino Elio Toaff e Dacia Maraini. Ma, ad inquietare, è
la curiosa coincidenza che il fondatore della comunità Saman stava indagando
proprio sul caso Scontrino, aveva capito che sotto la cenere covava qualcosa di
grosso e, per non agitare le acque, aveva sparso in giro la voce che il
polverone alzato dalle indagini sull’associazione cripto massonica fosse una
«montatura di Sergio Mattarella per colpire l’avversario Francesco Canino
(onorevole DC morto nel 2014 ndr)». In realtà, Rostagno era anche venuto a
conoscenza dell’arrivo per due volte a Trapani di Licio Gelli, il Venerabile
Maestro della Loggia P2. Ed è a questo punto che si interrompe tragicamente la
vita del coraggioso giornalista, lasciando ancora aperti molti interrogativi
sulla Verità di una vicenda a cui il silenzioso presidente della Repubblica
potrebbe fornire un valido contributo con la sua testimonianza.
IL BALLO DEL MASSONE –
STATERA: C’ERANO ALMENO 13 GREMBIULINI IN GARA PER IL QUIRINALE – E COME TUTTI I
“FRATELLI” CHE CONTANO, NON MILITANO NELLE RISSOSE LOGGETTE NAZIONALI, MA NELLE
BLINDATISSIME FRATELLANZE INTERNAZIONALI.
Il mitico Rino Formica: “Oggi
c’è un proliferare di pseudo-massonerie che dà luogo a una totale confusione tra
metodo massonico e istituzioni. In fondo, è il metodo di Renzi, che, se lo
lasciamo fare metterà al Quirinale un vigile urbano”..., scrive Alberto Statera
per “la Repubblica”. Tutti ci pensano, ma pochi osano nominare pubblicamente la
muta presenza minacciosa della massoneria nel torneo del Quirinale. Il Convitato
di pietra, tuttavia, è tradizionalmente vigile e solerte quando si tratta di
scegliere le alte cariche dello Stato, figurarsi quando si seleziona la più
alta. Ma se chiedi al nuovo Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia Stefano
Bisi, toscano come Matteo Renzi e come il plenipotenziario berlusconiano Denis
Verdini, per chi tra i candidati sta lavorando la più grande e importante
obbedienza italiana ti senti rispondere che «il GOI non tratta questioni di
politica, l’elezione del presidente della Repubblica non rientra tra i compiti
del Gran Maestro, che si occupa della gloria del Grande Architetto dell’Universo
e in questi giorni di molte installazioni di Maestri Venerabili in ogni parte
d’Italia. Ogni parola in più sul Quirinale verrebbe strumentalizzata». Per cui
non ce la dice, nonostante il fatto che degli almeno 48 nomi di quirinabili che
fin qui si sono fatti (escluso per pudore Giancarlo Magalli), almeno tredici
sono considerati in odore di massoneria. Per la verità, da quando ha contratto
il Patto del Nazareno con il piduista Silvio Berlusconi (noto appassionato di
simboli esoterici) un certo effluvio insegue lo stesso Matteo Renzi, suo padre
Tiziano e alcuni fiduciari del giglio magico fiorentino. Il presidente del
Consiglio ha tuttavia garantito: «Non sono massone, la mia è una famiglia di boy
scout», ignorando probabilmente che il fondatore britannico dello scoutismo
Robert Baden Powell era un autorevole massone. Per carità, non è una prova, come
mai furono provati i sospetti di affiliazioni massoniche di precedenti
presidenti della Repubblica, come Einaudi, Saragat, Ciampi (che ha smentito con
forza il professor Aldo Mola, storico della massoneria) e persino Pertini.
Percentuale peraltro eventualmente non solo aleatoria, ma comunque esigua, se è
vero quanto andava dicendo Francesco Cossiga: dei 48 presidenti americani solo
tre non sono stati massoni e due dei tre sono stati ammazzati. Già nella sua
fase pre-picconatoria, Cossiga rivendicava con fierezza e con chiunque
l’appartenenza a una famiglia di massoni e la sua con il grado di “33” a una
misteriosa Loggia internazionale. Vedeva massoni dappertutto e si considerava un
esperto della materia, come di aggeggi elettronici e spionistici: «Gelli — disse
in un’intervista pubblicata nel libro “Fratelli d’Italia” — è stato sostenitore
della candidatura di Pertini. Nelle ultime votazioni per l’elezione del
presidente della Repubblica arrivò ai massoni, deputati e senatori, una
circolare di Gelli perché votassero Pertini, il quale era circondato di massoni:
il suo grande elettore Teardo, socialista, presidente della regione Liguria era
piduista». In effetti, nel discorso di fine d’anno del 1981, il presidente più
amato affrontò lo scandalo della P2 rassicurando sulla lealtà delle istituzioni,
con queste parole: «Poi si è aggiunta a tutte queste preoccupazioni, italiane e
italiani, la questione della P2. Mi si intenda bene, perché non voglio che
ancora una volta il mio pensiero sia travisato. Quando io parlo della P2 non
intendo coinvolgere la massoneria propriamente detta, con la sua tradizione
storica. Per me almeno, una cosa è la massoneria, che non è in discussione,
un’altra cosa è la P2, questa P2 che ha turbato, inquinato la nostra vita».
Anche Giorgio Napolitano, figlio dell’avvocato Giovanni che fu un alto grado
della massoneria napoletana, ha subìto il venticello. Il 13 giugno 2010 nella
trasmissione televisiva “In mezz’ora” Lucia Annunziata chiese se il presidente
della Repubblica potesse essere un massone sotto il profilo dei valori
all’allora Gran Maestro del Grande Oriente Gustavo Raffi. Il quale rispose
appassionatamente: «A mio avviso sì, per umanità, distacco, intelligenza, per
avere levigato la pietra, per averla sgrezzata, lo dico in linguaggio muratorio,
in questo senso sì». Anche per Ciampi, in un’altra occasione, usò il linguaggio
«muratorio»: «Se devo ragionare sotto il profilo del weltanschauung lo considero
un fratello», pur smentendo l’appartenenza del presidente al Goi. Certo, fin dai
tempi di re Vittorio Emanuele e di Umberto I, la massoneria, se non al vertice,
non è mai mancata nell’alta burocrazia quirinalizia, come in tutte le alte
burocrazie più “nobili” dello Stato. Ma è ancora kingmaker presidenziale? Non vi
faremo i nomi degli almeno tredici possibili candidati considerati massoni o
amici della massoneria. Sia perché non c’è modo di provarlo, dal momento che,
nonostante i numerosi annunci contrari, le liste degli affiliati restano
riservate. Sia perché le personalità molto importanti fin dai tempi dello
scandalo P2 non sono iscritte a logge nazionali, ma a super-logge sovranazionali
assai esclusive dette Ur-Lodges. Almeno così sostiene Gioele Magaldi,
scissionista del Grande Oriente che ha fondato il Grande Oriente Democratico e
che in un suo monumentale libro ne cita diverse: dalla Three Eyes alla Pan
Europe, dalla Edmund Burke alla Leviathan e alla Thomas Paine. Se uno aspira al
Quirinale, insomma, non milita nelle rissose loggette italiane, ma naviga nel
vasto mondo di potenti planetari, dove le relazioni sono alte e la riservatezza
blindata. La tesi di Rino Formica, ex ministro socialista che di elezioni
presidenziali ne ha viste tante, è che in realtà l’unica elezione al Quirinale
condizionata effettivamente dalla massoneria italiana fu quella del paglietta
napoletano Giovanni Leone, perché fu messo a disposizione della risicata
maggioranza un piccolo ed essenziale pacchetto di voti di parlamentari massoni,
su richiesta di Ugo La Malfa per sbarrare la strada a Pietro Nenni. Lucidissimo
e ironico a 84 anni, Formica sghignazza sul fatto che le massonerie italiane
sono ormai fatte di «quattro sfessati». Secondo lui, «di fronte ai nuovi
intrecci dei grandi poteri occulti, in Italia c’è stata una proliferazione di
pseudo-massonerie dai comportamenti deviati, che hanno trasferito il metodo
massonico in consorterie di potere e affari. Ciò che prima era incardinato in un
mondo esoterico, politico alto, civile e riservato, ora dà luogo a una totale
confusione tra metodo massonico e istituzioni. In fondo, è il metodo di Renzi,
che, se lo lasciamo fare metterà al Quirinale un vigile urbano», dopo aver
trattato per mesi la prima poltrona della Repubblica con il piduista
pregiudicato Berlusconi e il suo attendente pluri-inquisito Verdini. Niente di
nuovo in fondo, se all’inizio del 1900 Ernesto Nathan, Gran Maestro del Grande
Oriente d’Italia e sindaco di Roma diceva di molti suoi fratelli in massoneria:
«Più che del bene altrui troppi ve ne sono preoccupati dei vantaggi che la loro
qualità può portare; nella vita politica essi hanno recato un elemento
dissolutore: il reciproco appoggio per fini disinteressati ha finito per
diventare mutua assistenza per interessi che giova far prevalere».
E’ ufficiale: siamo
governati dalla massoneria. “Le alte cariche dello stato? Tutti massoni!”.
Scrive Alessandro Raffa per nocensura.com. Magaldi più volte ha parlato
dell’affiliazione massonica di importanti personalità, senza essere mai
smentito, e ha affermato di essere pronto ad esibire le prove di quanto da lui
dichiarato, se gli sarà chiesto da un giudice. Nell’ambito di un servizio
dedicato a “Politica e massoneria” de La Gabbia dove l’inviato domanda a diversi
politici “se sono massoni” o se “conoscono politici massoni”, viene
intervistato Gioele Magaldi, leader della loggia massonica “Grande Oriente
Democratico”, che in passato ha rivelato l’affiliazione di Mario Monti a ben due
logge, (circostanza ribadita anche in questa occasione), rivelando che il suo
governo era composto da molti “grembiulini”. Il servizio risale al Gennaio 2014,
tuttavia, visto che molti italiani credono che queste storie siano barzellette,
bufale, minchiate, alias “gombloddismo!1!1!” come dicono ironicamente i
deficienti, coloro che pendono dalle labbra dei conduttori televisivi, coloro
che si bevono qualsiasi cosa sia propinata loro dal tubo catodico, quelli del
“lo ha detto la televisione” come se ciò fosse prova di autorevolezza, e si
permettono di sputare sentenze sulla base non di informazioni, ma della loro
presunzione personale, convinzioni plasmate dai media frutto di pensieri e
valutazioni fatte da persone che prima di farsi un’idea e ritenerla valida, non
si sono informate minimamente, o al massimo in modo più che superficiale. Queste
sono questioni che richiedono profondi studi per essere analizzate, studi che
richiedono anni e non poche ore. Ovviamente è la propaganda del sistema a
forgiare queste mentalità. Magaldi più volte ha parlato dell’affiliazione
massonica di importanti personalità, senza essere mai smentito, e ha affermato
di essere pronto ad esibire le prove di quanto da lui dichiarato, se gli sarà
chiesto da un giudice. Magaldi sostiene che le prime tre cariche dello Stato
– Presidente della Repubblica, della Camera e del Senato – sono affiliati alla
massoneria. A domanda Magaldi risponde che buona parte dei Presidenti della
Repubblica che si sono avvicendati in questi anni erano affiliati alla
massoneria: “compreso l’attuale inquilino”, Giorgio Napolitano. Poi rivela
che Piero Grasso “è stato iniziato molti anni fa” (quando era in magistratura
quindi?) e secondo Magaldi, persino Laura Boldrini “nell’ambito delle sue
esperienze internazionali ha avuto un’affiliazione massonica”. Nonostante siano
passati anni dalla divulgazione del servizio, vi risulta che qualcuno di questi
abbia smentito?!? A me no! Tra i politici intervistati, nessuno sembra sapere
niente, nessuno vuole parlare; tra questi Giulio Tremonti, che risponde
cortesemente di non voler parlare; eppure lui probabilmente di cose da dirne ne
avrebbe, visto che in più occasioni ha parlato di “illuminati”. L’unico tra i
politici a rispondere in modo “dignitoso”, seppur molto, molto, molto cauto, è
l’ex Ministro Sacconi; alla domanda “molti suoi colleghi sono massoni?” Sacconi
annuisce e risponde “presumo, può darsi”, per poi rilasciare, sempre in modo
molto cauto, la seguente dichiarazione: “Io penso che molti gruppi di pressione
guardino all’Italia come un paese insieme importante e fragile, e questo tenti
molti dal manipolare il corso democratico”. Una risposta che per chi sa “leggere
tra le righe”, esprime più di quanto sembra…
Il complottismo del “Fatto”
sul libro di Magaldi che sostiene come tutti i potenti siano massoni, scrive
Andrea Mollica sul blog di Gad Lerner. Gioele Magaldi è un massone di cultura
progressista, Gran Maestro del Grande Oriente Democratico, che ha appena
pubblicato un libro, “Massoni società a responsabilità illimitata”, di cui si è
innamorato il “Fatto Quotidiano”. Dopo una lunga, ed entusiasta, presentazione
scritta da Gianni Barbacetto e Fabrizio D’Esposito, oggi il quotidiano diretto
da Padellaro e Travaglio intervista l’autore del libro sulla “grande scoperta”
di questo volume, le Ur-Logdes, le superlogge massoniche che dominerebbero il
mondo. La tesi del libro di Magaldi è la seguente: tutti i grandi della Terra
appartengono a network massonici che decidono tutto quanto succede nelle nostre
società, più o meno. Una chicca svelata da Magaldi al sito Affaritaliani.it
chiarisce l’impianto del suo libro: Abu Bakr al-Baghadi, il califfo guida
dell’Isis, sarebbe uscito dalla prigione irachena in cui era tenuto prigioniero
dagli statunitensi dopo che si è affiliato a una Ur-Logdes. L’Isis sarebbe di
conseguenza un progetto massonico per scatenare nuove guerre. Le Ur-Lodges a
livello mondiale sarebbero 36, divise tra conservatrici e progressiste, e
praticamente ogni leader, politico oppure economico, vi sarebbe affiliato.
Matteo Renzi sarebbe l’unico presidente del Consiglio italiano non ancora
fratello massone, anche se tra poco lo diventerà. I suoi predecessori, Letta,
Monti, così come D’Alema o Berlusconi, militano in queste Ur-Lodges. Il leader
di Forza Italia è iscritto alla superloggia Three Eyes nel 1978, anche se ora ne
ha fondata una personale, la Loggia del Drago. In quell’anno Berlusconi entrò
nell’organizzazione che aveva tra i suoi fratelli anche il futuro presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano. Matteo Renzi aspirerebbe a entrare in
questa superloggia, ma al momento la sua richiesta di affiliazione viene frenata
perchè gli altri potenti iscritti, come Merkel o Weidmann, si fidano poco di
lui. Il massone italiano più influente, ça va sans dire, è Mario Draghi. Il
presidente della Bce apparterebbe a ben cinque Ur-Lodges, tra cui la Three Eyes.
Magaldi spiega nell’intervista concessa al “Fatto Quotidiano” di giovedì 20
novembre 2011 come sia riuscito a ricomporre tutti gli schemi che hanno dettato
la storia dell’ultimo secolo, più o meno. Le tesi di Magaldi appaiono un poco,
giusto un attimo, esagerate nel loro complottismo sfrenato, dove l’intera storia
dell’ultimo secolo sarebbe stata decisa dagli esperimenti di poche logge
massoniche. Il libro esce per i tipo di Chiarelettere, società editrice del
“Fatto”, e chissà che ne pensano le Ur-Lodges di questo legame.
Tutte le
super-logge della massoneria che governano l’Italia e il mondo. Il libro di
Gioele Magaldi che si ripromette di svelare l’album segreto dei massoni (e i
politici italiani sono molti),
scrivono Gianni
Barbacetto e Fabrizio d’Esposito su il Fatto Quotidiano, mercoledì 19 novembre
2014. Esistono i massoni e i supermassoni, le logge e le superlogge. Gioele
Magaldi, quarantenne libero muratore di matrice progressista, ha consegnato
all’editore Chiarelettere (che figura tra gli azionisti di questo giornale) un
manoscritto sconcertante e che sarà presentato domani sera alle 21 a Roma,
a Fandango Incontro. Il libro, anticipato ieri dal sito affaritaliani.it,
è intitolato Massoni società a responsabilità illimitata, ma è nel sottotitolo
la chiave di tutto: La scoperta delle Ur-Lodges. Magaldi, che anni fa ha fondato
in Italia il Grande Oriente Democratico, in polemica con il Grande Oriente
d’Italia, la più grande obbedienza massonica del nostro Paese, in 656 pagine
apre ai profani un mondo segreto e invisibile: tutto quello che accade di
importante e decisivo nel potere è da ricondurre a una cupola di superlogge
sovranazionali, le Ur-Lodges, appunto, che vantano l’affiliazione di presidenti,
banchieri, industriali. Non sfugge nessuno a questi cenacoli. Le Ur-Lodges
citate sono 36 e si dividono tra progressiste e conservatrici e da loro
dipendono le associazioni paramassoniche tipo la Trilateral Commission o il
Bilderberg Group. Altra cosa infine sono le varie gran logge nazionali, ma
queste nel racconto del libro occupano un ruolo marginalissimo. Tranne in un
caso, quello della P2 del Venerabile Licio Gelli. I documenti che mancano sono a
Londra, Parigi e New York. Prima però di addentrarci nelle rivelazioni clamorose
di Massoni è d’obbligo precisare, come fa Laura Maragnani, giornalista di
Panorama che ha collaborato con Magaldi e ha scritto una lunga prefazione, che
l’autore non inserisce alcuna prova o documento a sostegno del suo libro, frutto
di un lavoro durato quattro anni, nei quali ha consultato gli archivi di varie
Ur-Lodges. Tuttavia, come scrive l’editore nella nota iniziale, in caso di
“contestazioni” Magaldi si impegna a rendere pubblici gli atti segreti
depositati in studi legali a Londra, Parigi e New York. Detto questo, andiamo al
dunque non senza aver specificato che tra le superlogge progressiste la più
antica e prestigiosa è la Thomas Paine (cui è stato iniziato lo stesso Magaldi)
mentre tra le neoaristocratiche e oligarchiche, vero fulcro del volume, si
segnalano la Edmund Burke, la Compass Star-Rose, la Leviathan, la Three Eyes, la
White Eagle, la Hathor Pentalpha. Tutto il potere del mondo sarebbe contenuto in
queste Ur-Lodges e finanche i vertici della fu Unione Sovietica, a partire da
Lenin per terminare a Breznev, sarebbero stati superfratelli di una loggia
conservatrice, la Joseph de Maistre, creata in Svizzera proprio da Lenin. Può
sembrare una contraddizione, un paradosso, ma nella commedia delle apparenze e
dei doppi e tripli giochi dei grembiulini può finire che il più grande
rivoluzionario comunista della storia fondi un cenacolo in onore di un caposaldo
del pensiero reazionario. In questo filone, secondo Magaldi, s’inserisce pure
l’iniziazione alla Three Eyes, a lungo la più potente Ur-Lodges conservatrice,
di Giorgio Napolitano, attuale presidente della Repubblica e per mezzo secolo
esponente di punta della destra del Pci: “Tale affiliazione avvenne nello stesso
anno il 1978, nel quale divenne apprendista muratore Silvio Berlusconi. E mentre
Berlusconi venne iniziato a Roma in seno alla P2 guidata da Licio Gelli nel
gennaio, Napolitano fu cooptato dalla prestigiosa Ur-Lodge sovranazionale
denominata Three Architects o Three Eyes appunto nell’aprile del 1978, nel corso
del suo primo viaggio negli Stati Uniti”. Altri affiliati: Papa Giovanni XXIII,
Bin Laden e l’Isis, Martin Luther King e i Kennedy. C’è da aggiungere, dettaglio
fondamentale, che nel libro di Magaldi la P2 gelliana è figlia dei progetti
della stessa Three Eyes, quando dopo il ‘68 e il doppio assassinio di Martin
Luther King e Robert Kennedy, le superlogge conservatrici vanno all’attacco con
una strategia universale di destabilizzazione per favorire svolte autoritarie e
un controllo più generale delle democrazie. “Il vero potere è massone”. E
descritto nelle pagine di Magaldi spaventa e fa rizzare i capelli in testa.
Dal fascismo al nazismo, dai colonnelli in Grecia alla tecnocrazia dell’Ue,
tutto sarebbe venuto fuori dagli esperimenti di questi superlaboratori
massonici, persino Giovanni XXIII (“il primo papa massone”), Osama bin Laden e
il più recente fenomeno dell’Isis. In Italia, se abbiamo evitato tre colpi di
Stato avallati da Kissinger lo dobbiamo a Schlesinger jr., massone progressista.
L’elenco di tutti gli italiani attuali spiccano D’Alema, Passera e Padoan. Il
capitolo finale è un colloquio tra Magaldi e altri confratelli collaboratori con
quattro supermassoni delle Ur-Lodges. Racconta uno di loro, a proposito del
patto unitario tra grembiulini per la globalizzazione: “Ma per far inghiottire
simili riforme idiote e antipopolari alla cittadinanza, la devi spaventare come
si fa con i bambini. Altrimenti gli italiani, se non fossero stati dei bambinoni
deficienti, non avrebbero accolto con le fanfare i tre commissari dissimulati
che abbiamo inviato loro in successione: il fratello Mario Monti, il
parafratello Enrico Letta, l’aspirante fratello Matteo Renzi”. Per non parlare
del “venerabilissimo” Mario Draghi, governatore della Bce, affiliato a ben
cinque superlogge. Ecco l’elenco degli italiani nelle Ur-Lodges: Mario Draghi,
Giorgio Napolitano, Mario Monti, Fabrizio Saccomanni, Pier Carlo Padoan,
Massimo D’Alema, Gianfelice Rocca, Domenico Siniscalco, Giuseppe Recchi,
Marta Dassù, Corrado Passera, Ignazio Visco, Enrico Tommaso Cucchiani,
Alfredo Ambrosetti, Carlo Secchi, Emma Marcegaglia, Matteo Arpe,
Vittorio Grilli, Giampaolo Di Paola, Federica Guidi. Berlusconi, invece, avrebbe
creato una Ur-Lodge personale, la Loggia del Drago. Bisognerà aspettare le
“contestazioni”, per vedere le carte di Magaldi.
Mafia e massoneria per
aggiustare processi, il racconto del pentito, scrive “Oltre lo Stretto”. “Cosa
Nostra all’interno di ogni loggia massonica deve avere due uomini d’onore. Ci
sono province impregnate di questa cosa, come Trapani. Bontade per esempio era
sia uomo d’onore, sia massone. Dicevano che anche Madonia era massone. Nella
massoneria c’è un potere alternativo al nostro, dove si racchiude il vero
potere, politica, economia, magistrati, onorevoli”. Lo ha rivelato il
collaboratore di giustizia Leonardo Messina, parlando dei rapporti esterni
alla mafia, interrogato dal pubblico ministero al processo di Firenze sulla
strage del treno Rapido 904 il 23 dicembre 1984. Messina ha anche distinto i
ruoli di mafia e massoneria: “La massoneria è un’amministrazione del potere
differente, intelligente: un dottore non va a sparare per strada, un avvocato,
un magistrato, non lo fanno, mentre il potere nostro, quello di mafiosi è il
potere della paura, la gente ci rispetta per questo. In Sicilia specie negli
anni ’70 non c’era quasi controllo e la gente ci temeva”. Sempre Messina ha
detto che i rapporti della mafia con la massoneria in Sicilia servivano ad
“aggiustare i processi”. Alla richiesta di raccontare un fatto specifico,
Messina ha detto che ”nel mio caso, per un mio processo, mi sono rivolto a un
massone che ha parlato con il giudice e si è rivolto anche a un
giudice popolare, qualcuno è andato a parlare con loro e sono stato assolto”.
Due uomini d’onore
all’interno di ogni loggia: così Cosa Nostra e la massoneria hanno unito le
rispettive forze nella medesima strategia criminale,
scrive Giuseppe Pipitone su "L'Ora Quotidiano". A raccontarlo il collaboratore
di giustizia Leonardo Messina, boss di San Cataldo, ex braccio destro di Piddu
Madonia, già autore di alcune rivelazioni inedite. Era stato Messina il primo a
raccontare dei summit nei dintorni di Enna, alla fine del 1991, per mettere a
punto la strategia stragista della primavera successiva. Oggi il pentito ha
deposto al processo per la strage del Rapido 904, in corso davanti alla corte
d’assise di Firenze che sta processando Totò Riina, accusato di essere il
mandante dell’eccidio che il 23 dicembre 1984 fece 17 vittime. Durante la sua
deposizione, Messina ha descritto nel dettaglio il rapporto tra la mafia e le
logge massoniche. “Cosa Nostra – ha detto il pentito – all’interno di ogni
loggia massonica deve avere due uomini di onore. Ci sono province impregnate di
questa cosa, come Trapani. Bontade per esempio era sia uomo d’onore, sia
massone. Dicevano che anche Madonia era massone. Nella massoneria c’è un potere
alternativo al nostro, dove si racchiude il vero potere, politica, economia,
magistrati, onorevoli”. Un rapporto, quello tra Cosa Nostra e la massoneria,
ancora attualissimo. Il boss di Castelvetrano. Matteo Messina Denaro starebbe
puntando sulla creazione di nuove logge nella zona di Mazara del Vallo: un
escamotage per stringere nuovamente alleanze con professionisti e imprenditori.
La nuova strategia di Messina Denaro è descritta nella relazione consegnata dal
procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato al presidente della corte
d’appello in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Un report,
quello di Scarpinato, che s’incrocia con e indagini della procura di Palermo:
Messina Denaro, stando ad un’intercettazione telefonica, “si è rifatto tutte
cose”, e cioè si sarebbe sottoposto ad un intervento di chirurgia estetica per
alterare i suoi connotati. Un interrogativo che da qualche mese impegna gli
inquirenti. Quel che è certo, però, è che l’ultima primula rossa di Cosa Nostra
sta cercando di inserire uomini a lui fidati nelle logge del trapanese. “I
metodi della mafia e della massoneria – ha detto Messina – erano molto simili.
La massoneria è un’amministrazione del potere intelligente: un dottore non va a
sparare per strada, un avvocato, un magistrato, non lo fanno. Il mafioso invece
è il vero potere, é il potere della paura, la gente ci rispettava. In Sicilia
specie negli anni ’70 non c’era quasi controllo e la gente ci temeva”. Un
elemento importante del rapporto tra Cosa Nostra e la massoneria era quello
relativo alle inchieste della magistratura. “Serviva ad aggiustare i processi –
ha spiegato il pentito – nel mio caso, per un mio processo, mi sono rivolto a un
massone che ha parlato con il giudice e si é rivolto anche a un giudice
popolare, qualcuno é andato a parlare con loro. Sono stato assolto. Se ero
colpevole? Si, ma loro non avevano le prove”.
Mafia, il pentito Messina:
“Volevamo uccidere Bossi per attacchi ai meridionali”,
scrive Giuseppe Pipitone su “Il Fatto Quotidiano”. E' quanto rivelato dal
pentito di Cosa Nostra Leonardo Messina, spietato uomo d'onore di Caltanissetta
e fedelissimo del boss Piddu Madonia. Umberto Bossi ha rischiato di finire nella
lista nera di Cosa Nostra: troppo pesanti le sue posizioni contro il Meridione…
Talmente pesanti che avevano infastidito Leonardo Messina, all’epoca spietato
uomo d’onore di Caltanissetta e fedelissimo del boss Piddu Madonia. Era il 1991,
Tangentopoli e le stragi dovevano ancora fare capolino nella storia italiana, e
Messina aveva pensato di assassinare il leader della Lega Nord. “Un giorno c’era
Bossi a Catania e io dissi a Borino Micciché: questo ce l’ha con i meridionali:
vado e l’ammazzo” ha raccontato l’ex uomo d’onore, oggi collaboratore di
giustizia, deponendo come teste al processo sulla Trattativa tra pezzi dello
Stato e Cosa Nostra, in corso all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo.
L’idea di assassinare Bossi, però, venne bloccata immediatamente dallo stesso
Micciché, all’epoca capomafia di Enna. “Mi disse di fermarmi: questo è solo un
pupo, disse. L’uomo forte della Lega è Miglio che è in mano ad Andreotti.
Insomma, si sarebbe creata una Lega del Sud e la mafia si sarebbe fatta Stato”
ha detto Messina, aggiungendo che “in Cosa nostra si diceva che Andreotti era
uomo d’onore, che era punciuto (punto, ovvero affiliato formalmente, ndr) e che
ci avrebbe garantito al maxiprocesso: si riteneva che sarebbe finito in
barzelletta. Poi quando si seppe che invece a presiedere il collegio giudicante
che avrebbe celebrato il maxi sarebbe stato un altro (e non il giudice Corrado
Carnevale ndr) si capì che i politici si erano allontanati”. Secondo la
ricostruzione dell’accusa, la data che cambia per sempre la storia d’Italia è il
30 gennaio del 1992, quando la Corte di Cassazione mette il bollo sulle condanne
del Maxi Processo: è in quel momento che Riina decide di eliminare i politici
che non avevano mantenuto i patti e dichiarare quindi guerra allo Stato. Un
passaggio cruciale, che Messina aveva già svelato anni fa, quando molte sue
dichiarazioni erano finite nel fascicolo sui Sistemi Criminali, l’inchiesta
della procura di Palermo sulle strategie eversive di Cosa Nostra e di altre
associazioni criminali, poi archiviata nel 2001. “All’inizio degli anni ’90 Cosa
nostra era pronta ad acquistare dalla ‘ndrangheta una grossissima partita di
armi investendo circa 2 miliardi di lire” ha raccontato Messina. Le sue
dichiarazioni sulle spinte eversive della mafia, fanno il paio con quelle dello
stesso Gianfranco Miglio, che in un’intervista a Il Giornale, teorizzò la
“legalizzazione” di Cosa Nostra. “C’è anche un clientelismo buono che determina
crescita economica“ disse l’ideologo della Lega - Insomma, bisogna partire dal
concetto che alcune manifestazioni tipiche del Sud hanno bisogno di essere
costituzionalizzate”. E’ per questo motivo che tra il 1992 e il 1993 nascono in
tutto il Sud movimenti indipendentisti, omologhi meridionali della Lega Nord. A
spingere per le stragi e per un impegno diretto in politica delle associazioni
criminali, non è soltanto Cosa Nostra. “Mi venne detto chiaramente, tra la fine
del 1991 e l’inizio del 1992, che c’era una commissione nazionale che deliberava
tutte le decisioni più importanti. Una commissione in cui sedevano i
rappresentanti di altre organizzazioni criminali”. Sullo sfondo dell’eversione
targata Cosa Nostra, spunta anche l’ombra della massoneria. “Tutti i capi di
Cosa nostra facevano parte della massoneria” ha spiegato Messina, che decise di
diventare collaboratore di giustizia nel giugno del 1992. Il primo pm a cui
affida i suoi segreti è Paolo Borsellino, che lo interroga per l’ultima volta il
17 luglio del 1992. “Quel giorno racconta Messina il dottore Borsellino era
molto nervoso, accese un’altra sigaretta e prima di andare via mi disse: signor
Messina, è arrivata la mia ora. Non c’è più tempo, la saluto. E non l’ho più
visto”. In quel momento l’autobomba da piazzare in via d’Amelio era quasi
pronta.
Trattativa Stato-mafia,
Leonardo
Messina: “Borsellino mi disse che era arrivata la sua ora”, scrive Lorenzo
Baldo su Antimafia duemila. In udienza il collaboratore di giustizia parla anche
di Giulio Andreotti definendolo “punciutu”. “La mia crisi è anche di tipo morale
nonostante già mio nonno e molti parenti fossero uomini d’onore non mi riconosco
più nell’organizzazione e quando ho sentito in televisione la vedova dell’agente
di scorta, Vito Schifani, parlare e pregare gli uomini della mafia, le sue
parole mi hanno colpito come macigni e ho deciso di uscire da questa
organizzazione nell’unico modo che è possibile, cioè collaborando con la
giustizia”. Era il 30 giugno 1992 quando Leonardo Messina rilasciava queste
dichiarazioni ai pm di Palermo che lo stavano interrogando. Nei giorni
successivi lo stesso Messina aveva chiesto di essere sentito direttamente da
Paolo Borsellino. E così era stato. “Borsellino mi disse: a noi serve solo la
verità, non le congetture o i pensieri. E così ho iniziato a collaborare
parlando per ore mentre lui mi stava ad ascoltare”. Ed è esattamente ricordando
quell’ultimo interrogatorio del 17 luglio 1992, appena due giorni prima della
strage di via D’Amelio, che lo stesso “Narduzzo” ha fatto rivivere in aula la
tensione del giudice dei giorni prima della strage. “Quel giorno – ha raccontato
il collaboratore durante l’udienza al processo sulla trattativa – il dottore
Borsellino era molto nervoso, fumava in continuazione. Accese un’altra sigaretta
e prima di andare via mi disse: ‘signor Messina, non ci vediamo più, è arrivata
la mia ora. Non c’è più tempo, la saluto’. Sapeva di morire…”. Seduto tra i
banchi c’era anche il fratello del giudice, Salvatore Borsellino. Nel sentire
quelle parole è rimasto assorto nei suoi pensieri. L’immagine di Paolo
Borsellino che, con piena consapevolezza, affronta la morte ha preso forma. La
deposizione di Leonardo Messina si è protratta attraverso un excursus storico
che ha aperto uno spaccato importantissimo sulla potenza della mafia del
nisseno. “Sono uomo d’onore che ha giurato due volte, la prima da uomo d’onore
riservato con Luigi Calì, successivamente c’è stata una guerra di mafia, mi
hanno richiamato e ho dovuto giurare pubblicamente con la famiglia San Cataldo
nel 1982”. “Dall’82 fino a quando ho collaborato con la giustizia ho rivestito
degli incarichi in Cosa Nostra a Caltanissetta. Nel 1985 fui nominato sotto
capo”, sottolinea ulteriormente. Nel suo racconto c’è pure un aspetto legato
alla sua prima relazione sentimentale. “Sono nato e cresciuto nell’ambiente di
Cosa Nostra, in particolare con gli uomini d’onore di Caltanissetta. Quando mi
sono sposato nel 1978 abbiamo fatto con mia moglie un giuramento in chiesa,
davanti a Dio, in cui abbiamo giurato di onorare la mafia tutta la vita”.
Proseguendo nella sua deposizione l’ex boss ha ricordato di aver vissuto “il
trapasso tra la vecchia Cosa Nostra e quella voluta dai corleonesi. Ho assistito
al cambiamento – ha specificato – e alla distruzione di Cosa Nostra”. Nel
racconto del collaboratore di giustizia è stata ulteriormente approfondita la
reazione dei boss mafiosi in merito alla Corte di Cassazione che doveva
occuparsi del Maxi processo. “In Cosa Nostra – ha sottolineato Messina –,
durante il Maxi processo veniva detto che tutto si sarebbe ridotto in una bolla
di sapone. Non ci sarebbero state grandi condanne e tutto sarebbe andato bene”.
“Ci veniva detto – ha proseguito – che in Cassazione avrebbero buttato tutto
giù. Si riteneva che sarebbe finito in barzelletta. Lillo Rinaldi, che
frequentava Piddu Madonia, disse che Andreotti era ‘punciutu’ (punto, cioè
affiliato formalmente, ndr), mentre c’era chi diceva che Andreotti fosse il
figlio di un Papa”. “Salvo Lima e Andreotti – ha quindi ribadito il
collaboratore – erano i politici che dovevano garantire tutto questo e che poi
il maxi processo sarebbe stato assegnato al giudice Carnevale in Cassazione e
non ci sarebbero stati problemi”. “L’ottimismo cessa quando i politici si
allontanano e non riescono a far assegnare il processo al giudice Carnevale – ha
spiegato successivamente Messina –. Iniziano le recriminazioni di Cosa Nostra
nei confronti del vertice politico nazionale. C’è stato un momento in cui in
Cosa Nostra fu deciso di non votare per la Democrazia cristiana ma per i
socialisti”. “Io – ha aggiunto – ho ricevuto l’ordine preciso di votare e far
votare per i socialisti. L’onorevole Martelli quando è arrivato al potere,
scavalcando l’ala craxiana, non ha mantenuto i patti. Io non partecipavo alle
riunioni ma venivo messo a conoscenza delle decisioni prese”, ha quindi
evidenziato. “Io ero con Borino Miccichè – ha proseguito Messina – e altri
uomini d’onore e mi è stato detto chiaramente, tra la fine del 1991 e l’inizio
del 1992, che c’era una commissione nazionale che deliberava tutte le decisioni
più importanti. Una commissione in cui sedevano i rappresentanti di altre
organizzazioni criminali e il cui capo era Totò Riina”. “Un giorno c’era Umberto
Bossi a Catania. Dissi a Borino Miccichè: ‘questo ce l’ha con i meridionali,
vado e l’ammazzo’. Mi disse di fermarmi: ‘questo è solo un pupo. L’uomo forte
della Lega è Miglio (Gianfranco, ndr) che è in mano ad Andreotti’. Si sarebbe
creata una Lega del Sud e la mafia si sarebbe fatta Stato”. Di tutto ciò
Leonardo Messina aveva già parlato ai magistrati in quella famosa inchiesta
denominata “Sistemi criminali”, successivamente archiviata, i cui fascicoli sono
stati acquisiti al processo sulla trattativa Stato-mafia. Nei faldoni del 2001
c’erano già le sue dichiarazioni nelle quali l’ex uomo d’onore di San Cataldo
aveva fatto riferimento a svariate riunioni tra i capi dell’organizzazione,
tenutesi tra il ’91 ed il 92, nel corso delle quali discutevano proprio di un
“progetto politico finalizzato alla creazione di uno Stato indipendente del Sud,
all’interno di una separazione dell’Italia in tre Stati. In tal modo Cosa Nostra
si sarebbe fatta Stato. Il progetto era stato concepito dalla massoneria. Lo
stesso Messina aveva parlato anche di una “Lega Sud”, che sarebbe stata risposta
naturale alla Lega Nord. Quest’ultima avrebbe visto proprio Gianfranco Miglio
quale suo vero artefice. Dietro di lui spuntavano le ombre di Gelli e Andreotti.
E proprio Miglio avrebbe poi raccontato, nel ’99, di essersi trovato a Villa
Madama, a trattare di nascosto con Andreotti. Da evidenziare che molte
dichiarazioni rilasciate da esponenti di diverse organizzazioni criminali, oltre
Cosa Nostra, quali ‘Ndrangheta e Sacra Corona Unita convergono proprio su questi
punti. Di fatto Cosa Nostra sembrava a tutti gli effetti intenzionata a
sfruttare il successo politico della Lega Nord in modo da favorire la secessione
della Sicilia e delle regioni meridionali in genere, con lo scopo di gestire con
maggior facilità, a livello politico, gli interessi illeciti della criminalità.
“Molti degli uomini d’onore, cioè quelli che riescono a diventare dei capi,
appartengono alla massoneria. Questo non deve sfuggire alla Commissione, perché
è nella massoneria che si possono avere i contatti totali con gli imprenditori,
con le istituzioni, con gli uomini che amministrano il potere diverso da quello
punitivo che ha Cosa Nostra”. Era il 14 dicembre 1992 quando Leonardo Messina
rendeva queste dichiarazioni davanti alla Commissione Parlamentare Antimafia. A
distanza di 21 anni quelle parole sono tornate ad echeggiare in un’aula di
giustizia. Parlando della forza della mafia l’ex boss Messina ha specificato che
non ha eguali in quanto detiene “potere economico e potere punitivo”. Sugli
spalti ad ascoltare attentamente erano presenti diversi studenti palermitani,
alcuni dei quali del Liceo Classico Umberto I; alcuni esponenti delle Agende
Rosse (anche da altre parti d’Italia) e dell’associazione studentesca
ContrariaMente. Decisamente molto interessante è stato il riferimento del
collaboratore di giustizia all’avvocato Raffaele Bevilacqua. Immediatamente è
tornata alla memoria la recente inchiesta giudiziaria (successivamente
archiviata nel 2004) sull’ex vicepresidente diessino dell’ARS, Vladimiro
Crisafulli, sorpreso da un’intercettazione ambientale a parlare di politica e
affari proprio con l’avvocato Bevilacqua, già rappresentante di Cosa Nostra
nell’ennese, nonché ex consigliere provinciale DC. L’ennesima dimostrazione
dello strettissimo connubio Mafia e politica. Del tutto inquietante l’accenno
alla “nave piena di armi” nella disponibilità di Cosa Nostra, armi che servivano
ad “un sistema” per “fare la guerra”. Ed è proprio nei confronti di quel
“sistema criminale” che si continuerà a cercare di fare luce. Le prossime
udienze dei giorni 11, 12 e 13 dicembre saranno dedicate all’audizione di
Giovanni Brusca in trasferta a Milano.
Messina Denaro, politici e
massoni. Un pentito fa tremare mezza Sicilia,
scrive Riccardo Lo Verso su “Live Sicilia”. L'architetto Giuseppe Tuzzolino da
mesi collabora con i magistrati e tira in ballo politici, magistrati e
superburocrati regionali. Parla degli intrecci fra mafia e massoneria. E
sostiene di avere notizie su "Diabolik". In tanti ritengono "fantasiose" le sue
dichiarazioni. C'è, però, chi ritiene di dovere andare avanti per non lasciare
nulla al caso. Fra questi il procuratore aggiunto Teresa Principato che coordina
la caccia al super latitante. Alza il tiro. E di
parecchio. L'architetto Giuseppe Tuzzolino, che da alcuni mesi collabora con i
magistrati di mezza Sicilia, tira in ballo politici, magistrati e superburocrati
regionali. Parla degli intrecci fra la mafia e la massoneria. E sostiene
di avere notizie su Matteo Messina Denaro. E così c'è un gran viavai al Palazzo
di giustizia di Palermo. Il suo nome finì coinvolto in un'inchiesta giudiziaria
nel 2013. Tuzzolino era al centro del malaffare che ruotava attorno al rilascio
di una sfilza di concessioni edilizie nel comune di Palma di Montechiaro. Dopo
il carcere, l'architetto trentacinquenne patteggiò una condanna e iniziò a
parlare con i pubblici ministeri agrigentini. I suoi
racconti, però, hanno finito per sconfinare dalla città dei templi ed è
stato necessario attivare i magistrati della Direzione distrettuale antimafia
palermitana che si occupano delle indagini sulle cosche di Palermo, Trapani e
Agrigento. Ma pure dai pm di Caltanissetta competenti quando si tratta di
indagare su vicende che riguardano i colleghi palermitani. Il nodo della
questione è la credibilità di Tuzzolino. In tanti ritengono "fantasiose" le sue
dichiarazioni. C'è, però, chi ritiene di dovere andare avanti per non lasciare
nulla al caso. Fra questi il procuratore aggiunto Teresa Principato che coordina
la caccia al super latitante di Castelvetrano. La
vicenda Tuzzolino è stata oggetto di confronto anche nelle recenti riunioni
della Dda. E' proprio sul padrino trapanese che l'architetto ha fornito
le ultime indicazioni. Dice di averlo visto alcuni anni fa seduto al tavolo di
un ristorante di Castelevetrano. Tuzzolino saprebbe dei contatti fra Messina
Denaro e la massoneria. Circostanza non nuova, per la verità. Indica in un
palazzo nel centro di Trapani il cuore di una importante loggia di cui ha
indicato il simbolo. Un simbolo che è stato trovato anche nella memoria del
telefonino di uno dei Guttadauro, parenti di Messina Denaro e arrestati per
mafia. Sul capitolo massoneria ha fatto i cognomi di alcuni pezzi grossi della
burocrazia siciliana e persino di alcuni magistrati palermitani, raccontando di
un vorticoso intreccio di rapporti illeciti. Un
groviglio di interessi, favori e intrighi di potere. Chi è davvero
Tuzzolino e sono attendibili i suoi racconti? Fino a quando le sue dichiarazioni
si sono concentrate su realtà locali agrigentine è stato accertato che
l'architetto ha detto la verità. La sua credibilità, però, ha vacillato quando è
diventato un fiume in piena. Si è pure beccato una denuncia per calunnia che ha
in mano il procuratore aggiunto Maurizio Scalia con tanto di registrazione che
farebbe emergere il suo intento di utilizzare le sue dichiarazioni per togliersi
qualche sassolino dalle scarpe. Solo che adesso non si parla più di sassolini.
Più si va avanti e più Tuzzolino alza il tiro. E in Procura c'è chi, anche se
solo in parte, lo prende sul serio e chiede di mantenere il massimo riserbo
sulle sue dichiarazioni.
Il neo pentito, Giuseppe
Tuzzolino, lancia pesanti dichiarazioni sconquassando la Sicilia, scrive
“Palermomania”. Parla a ruota libera l'architetto Tuzzolino, coinvolgendo
svariate sfere della società siciliana, dalla politica, alla magistratura ad
"importanti burocrati", tocca il tema delle connivenze tra queste sub strutture
e la mafia e ancora tra la stessa mafia e la massoneria, senza lesinare notizie
in merito all'argomento centrale della latitanza mafiosa siciliana, la
localizzazione del boss Matteo Messina Denaro. Tuzzolino, era finito nei
registri degli inquirenti nel 2013, durante un'inchiesta riguardante il rilascio
di concessioni edilizie nel comune di Palma di Montechiaro, inchiesta in cui
venne condannato al carcere per poi patteggiare una riduzione della pena e
divenire collaboratore di giustizia verso i pm di Agrigento. Attualmente, il
tribunale interessato alle dichiarazioni del trentacinquenne Tuzzolino è il
Palazzo di Giustizia di Palermo, dato che le ultime informazioni, da lui
rilasciate, atterrebbero a movimenti non localizzati nel solo agrigentino ma
variegati, spazianti da Palermo, a Trapani e Caltanissetta. Il procuratore
aggiunto, Teresa Principato, occupantesi della ricerca del boss latitante,
Messina Denaro, sembra voler seguire le tracce indicate dal Tuzzolino, ma gran
parte della magistratura interessata, e non solo, si chiede quanto possano
essere attendibili le dichiarazioni del neo pentito, affermazioni già definite
"fantasiose". In merito alla figura di Messina Denaro, sembrerebbe aver indicato
un ristorante di Castelvetrano, dove alcuni anni fa avrebbe scorto il boss. Dei
contatti tra il super latitante e la massoneria, già si avevano delle
conoscenze, notizie che lo stesso Tuzzolino avrebbe confermato indicando un
palazzo, situato nel centro di Trapani, sede di un'imponente loggia e il simbolo
stesso della loggia, simbolo che venne riscontrato anche nel cellulare di un
membro della famiglia Guttadauro arrestato per mafia, parente del boss. Sempre
in ambito massoneria avrebbe narrato di intrecci particolarmente tortuosi, e
illeciti, che vedrebbero coinvolti magistrati, politici, e "importanti
burocrati" siciliani. Il problema dell'attendibilità di Tuzzolino si è aperto
nel momento in cui le dichiarazioni sono tracimate, ampliando confini e
contenuti, lasciando temere un tentativo di "vendetta" più che una reale
presenza di informazioni. Tracimazione che ha già comportato una denuncia per
calunnia. Bisogna però dire, che le dichiarazioni dell'architetto, quelle legate
all'ambito agrigentino, riguardanti festini con "cocaina e escort", appalti
truccati, tangenti e killer, sono risultate esatte, da ciò l'importanza della
richiesta di riserbo, da parte delle autorità, e di ulteriori, approfondite
indagini su quanto Tuzzolino ha e avrà da dichiarare.
Intervista
all'avv. Giuseppe Arnone da parte di iena giudiziaria Marco Benanti su "Le Iene
Sicule".
Avv Arnone
ci spiega cos'è accaduto in occasione dell'ultima sua clamorosa iniziativa?
“Io dispongo di un balcone,
nel mio nuovo studio, che sta proprio di fronte al Palazzo di Giustizia, tra il
cancello di accesso al Tribunale e il mio balcone vi è una distanza esattamente
di 12 metri. Si scende dal marciapiede, si attraversa la carreggiata di vai
Mazzini e siamo innanzi al cancello del Tribunale. Volendo col Dott. Ignazio
Fonzo potremmo, dai rispettivi studi, prenderci a pietrate con una fionda. Ma
ormai, poiché credo fermamente che la legge è uguale per tutti, i colpi di
fionda oggi sono formali ed istituzionali. Dal mio balcone ho collocato il primo
manifesto che sollecita l’allontanamento nei tempi più rapidi di Fonzo e dei
suoi partners in Procura dalla realtà agrigentina. Io prevedo la cacciata dalla
Magistratura e processi penali a non finire, per Fonzo e i correi. E più avanti
mi soffermerò sui procedimenti che sono già avviati con le indagini a carico di
Fonzo e del PM Maggioni, il suo braccio destro. Torniamo alla mattina di martedì
10 marzo. Ho collocato lo striscione da stadio, delle dimensioni di 6 metri per
un metro e mezzo. Dopo un po’ è arrivata la Digos in forze, chiedendomi di
rimuovere lo striscione. Ho risposto che non se ne parlava nemmeno,
sollecitandoli a fare la relazione di servizio inviandola al Ministero e al CSM.
Alle loro insistenze verbali, con un ampio sorriso, li ho invitati a tornare con
un provvedimento scritto, magari frutto della sapienza giuridica degli
scienziati del diritto Fonzo e del procuratore capo Di Natale. Ed ho aggiunto
che la mia sapienza giuridica mi consentiva di dire che la Carta Costituzionale
tutela quello striscione. Lo striscione è rimasto esposto. Lo toglierò domani
mattina."
Avvocato
ci può illustrare fatti e situazioni del processo cosiddetto delle tangenti al
comune di Agrigento?
"Lo striscione, come si può
agevolmente leggere, fa riferimento al “babbìo” con il quale Fonzo ha affrontato
la importantissima indagine sulle tangenti all’ufficio urbanistica del Comune di
Agrigento. Dai rapporti della Polizia, in primo luogo Digos, e dalle
intercettazioni telefoniche e dalle testimonianze dell’ing. Morreale, tutti
elementi acquisiti cinque anni fa o giù di li, a processo dovevano andare
innanzitutto il sindaco Zambuto e il suocero on. La Russa, da me definiti il
pupo e il puparo. Invece, come si suol dire, sono volati gli stracci, solo i
funzionari del Comune, di cui uno – il principale imputato – assolutamente
marginale, e pure gravemente malato da tempo. Sembrerebbe che il marciume al
Comune di Agrigento fosse rappresentato da un architetto di secondo ordine, che
prendeva tangenti di qualche centinaio di euro. Nelle telefonate degli indagati
intercettati si faceva riferimento alla mia persona con questi termini: “quel
cornuto di Arnone…..quel gran cornuto, quel cornuto che si fa….il cappotto di
legno di Arnone”. A fronte di queste telefonate e di decine di mie denunzie nei
confronti del capo dell’ufficio urbanistica Di Francesco, oggi pure imputato,
io non sono mai stato sentito come testimone, né nell’indagine preliminare, né
innanzi al Tribunale."
Quali
distorsioni giudiziarie ha lei denunciato questa volta?
"Proseguo il ragionamento e
completo la risposta. La mia deduzione è che la mia testimonianza avrebbe dovuto
comportare processo e probabilmente manette – come avvenuto per altri imputati
in questa vicenda – per il sindaco Zambuto e il puparo suocero La Russa.
Aggiungo che il testo di questa intervista verrà inviato al Procuratore Generale
Scarpinato: è il caso che Scarpinato affitti una suite nella Valle dei Templi
perché quello che sta combinando qui Fonzo e i suoi partners non ha eguali credo
in Europa. Adesso Fonzo è andato a sequestrare di persona gli atti del PRG di
Zambuto, sulla base delle informative della Digos di 5 anni addietro. I testi
delle informative e queste notizie sono diffuse dal giornale Grandangolo che
svolge il ruolo di sostanziale addetto stampa o di gazzetta ufficiale della
Procura di Agrigento. La domanda è semplice: perché quelle carte della Digos che
andavano dritto dritto ad incastrare il Sindaco Zambuto sono state insabbiate
per 5 anni? Ed ancora all’ufficio urbanistica avviene quello che adesso
descriverò. Per tre anni vi è uno scontro durissimo tra me da un lato contro Di
Francesco e il sindaco Zambuto e il puparo La Russa dall’altro. Zambuto mantiene
a capo dell’urbanistica, con un rapporto fiduciario, l’ing. Di Francesco, in
perfetta continuità con la precedente amministrazione berlusconiana. Io insisto
perché venga rimosso in quanto dedito all’illecito. Ricevo pressioni soprattutto
da La Russa per “riappacificarmi” con Di Francesco. Mando suocero e sindaco a
farsi benedire e alla fine ottengo la nomina del vincitore di concorso, ing.
Calogero Morreale e la rimozione di Di Francesco. Incredibile ma vero, dopo sei
mesi Zambuto licenzia l’ing. Morreale. Sostiene che non era in grado di far
funzionare gli uffici. In effetti il modo di gestire gli uffici tra la persona
per bene Morreale e Di Francesco, oggi sotto processo per associazione per
delinquere e tangenti, è diversissimo. Ma quello che è incredibile che la
Procura di Agrigento innanzi al licenziamento di Morreale sta a guardare: in un
altro posto, ove la Giustizia viene amministrata con criterio, sarebbero
scattate le manette per sindaco e suocero. Sulla base delle informative della
Digos insabbiate e sulla base della testimonianza di Morreale. Aggiungo che vi
era pure la testimonianza di un imprenditore del settore delle cooperative che
affermava, a verbale, innanzi alla Digos, di aver ricevuto richieste di tangenti
anche a nome del puparo La Russa. Ne vogliamo ancora? E ripeto: perché io non
sono stato sentito? Malgrado le mie denunzie? Malgrado fossi il più profondo
conoscitore di questi fatti?"
Al di là
del merito della contrapposizione sua con il pm Fonzo, questa vicenda è
emblematica di una condizione generale della giustizia oppure è un fatto
sporadico?
"Preannunzio che questo è il
primo striscione. Dal mio balcone ne caleranno altri. Ne ho in mente uno
bellissimo, di rilievo turistico. Lo striscione riporterà questo messaggio: “Indicazione
turistica di grande rilevanza. Visitate il Palazzo di Giustizia di Agrigento,
l’unico d’Italia ove non vige l’obbligatorietà dell’azione penale. Ingresso
gratuito. Accesso consentito dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Visite guidate previo appuntamento.
Chiedere del dott. Ignazio Fonzo”. Un altro
striscione proporrà un paragone tra il già presidente della Provincia Eugenio
D’Orsi, l’imputato per cui Fonzo ha chiesto 6 anni di carcere e l’interdizione
dai pubblici uffici, e lo stesso indagato Ignazio Fonzo. Ricostruirò,
comparandole, le azioni che Fonzo, da PM, ha contestato all’imputato D’Orsi,
chiedendo appunto ben 6 anni di carcere e l’interdizione dai pubblici uffici, e
le azioni illecite commesse da Fonzo e da Maggioni, da me denunziate, e per cui
i due magistrati sono oggi indagati a Caltanissetta, con una ordinanza che
dispone fior di investigazioni emessa a loro carico, su mia richiesta, dal GIP
dott. Testaquadra. Realizzerò un video, in contraddittorio con i giornalisti
interessati, e la gente potrà valutare quanti anni di galera meritano Fonzo e
Maggioni se D’Orsi ne merita 6. Se il criterio è questo – le accuse a D’Orsi
sono bazzecole, spesso ridicole – a Fonzo dovremmo dare 60 anni di carcere, ed
interdizione perpetua per 5 o 6 vite. La risposta quindi è netta. Fonzo e Di
Natale hanno abrogato ad Agrigento l’obbligo dell’azione penale. Soprattutto per
i potenti. L’ex vice ministro Capodicasa, per coincidenza grande amico di Anna
Finocchiaro, per coincidenza a sua volta grande amica del magistrato Giuseppe
Gennaro, per coincidenza a sua volta grande amico di Ignazio Fonzo ha costruito
una splendida villa moltiplicando per 4 volte i volumi in modo illegale e
commettendo un mare di reati. Il tutto nell’area super vincolata vicina al
Teatro Greco di Eraclea Minoa, sulla fascia costiera. Ho denunziato questi fatti
due anni e mezzo addietro, Capodicasa ha denunziato me per calunnia. Non abbiamo
notizie. Tutto sotto una tonnellata di sabbia. Nel frattempo però hanno trovato
il tempo per mandarmi a processo in una quarantina di procedimenti. Tutti per
cose poco serie. Specifico che non voglio dire che Fonzo ha recepito
raccomandazioni. Semplicemente che Fonzo, anzi, la Procura e Di Natale, sono
molto ma molto attenti alle vicende che riguardano personaggi potentissimi, con
amicizie o parentele potenti. Non intendo, cioè, sostenere che sia intervenuta
Anna Finocchiaro per raccomandare Capodicasa, mi limito ad evidenziare una serie
di fatti, la cui entità merita ancor più riflessione se consideriamo ciò che
dice il collega di Fonzo, PM Fornasier, in ordine ai legami fortissimi costruiti
da Fonzo. E più avanti spiegherò cosa si intende. Mi soffermo su Di Natale:
suggerisco a qualche docente universitario di diritto penale di disporre una
tesi sull’archiviazione dell’inchiesta per associazione mafiosa a beneficio di
Mirello Crisafulli. Se Di Natale avesse fatto quell’indagine, in quel modo, su
Dell’Utri o su Cuffaro, i giustizialisti di sinistra lo avrebbero messo al rogo.
E’ l’archiviazione più scandalosa che si sia mai vista. Di Natale e Fonzo ne
hanno fatta una simile per un dirigente medico di vertice dell’ASP che assieme
agli altri due massimi vertici firma la delibera di un’affidamento di un appalto
che la Procura ritiene truccato. Per gli altri due la Procura chiede l’arresto
dei firmatari. Per il terzo non fa nulla. Il GIP rigetta la richiesta di arresto
dei due osservando che non si capisce perché si fa questa differenza di
trattamento – del tutto priva di motivazione – tra i tre firmatari. Il GIP si è
posto una domanda sacrosanta e ha deciso secondo legge. Adesso gli forniamo la
probabile risposta. Il terzo firmatario è uno stretto congiunto, uno zio del
vice premier Alfano. Conosco bene Alfano e sono disposto a giocarmi le mani che
non si è mai mosso per effettuare alcuna raccomandazione alla Procura.
Conoscendolo sono certo che ignora la vicenda. Ma il dato è evidentissimo.
Quando la Giustizia non funziona ed è interessata a compiacere i potenti, il
timore reverenziale si attiva senza che nessuno lo solleciti. Automaticamente.
Ma voglio aggiungere qualcosa di clamoroso. Io dispongo di una registrazione ove
il PM anziano di Agrigento, Santo Fornasier, prima mi sollecita ad accordarmi
con Fonzo e a rinunziare alle denunzie contro di Fonzo, poi, di fronte alla mia
risposta negativa, mi minaccia, riporto testualmente, di
“brutte mazzate” attraverso gli strumenti “infidi
ed invasivi” di cui dispone la Procura, quindi esalta Fonzo dicendo
che è un personaggio “potentissimo, fortissimo, per
i legami che ha” e conclude con una ammissione che lascia senza
parole “Fonzo le ha fatto lo schieramento alle
spalle, questo è successo, questo è successo”.
Cosa
sarebbe questo schieramento alle spalle? Esistono fatti che possono far ritenere
effettivamente realizzato lo schieramento alle spalle ai suoi danni?
"Sì è pacifico che Fonzo e Di
Natale hanno posto in essere quello schieramento alle spalle ai miei danni di
cui ha parlato il PM Santo Fornasier ignorando di essere audio registrato. Lo
schieramento alle spalle lo sintetizzo in poche battute, andando ai fatti più
rilevanti. Hanno chiesto in quattro mesi e in quattro processi 9 anni di carcere
per me. Hanno preso tutti i processi. Tutti. Sempre assolto. Mi hanno
intercettato per 3 mesi, mi hanno pedinato, fotografato, mi hanno mandato un
plotone di Carabinieri a perquisire alle 4 di notte la mia villa, la mia
abitazione invernale, il mio studio professionale. Hanno sequestrato tutti i
computers di casa mia, non solo i miei, ma anche quelli professionali di mia
moglie medico e di mio figlio universitario. Mi hanno fatto fare da una
neurologa – si da una neurologa, concittadina di Di Natale – una perizia
psichiatrica che mi ha qualificato come malato di mente, affetto da un grave
disturbo paranoico. Ognuno comprende l’anomalia di far fare una perizia
psichiatrica ad una neurologa – democristiana come Di Natale, nissena come Di
Natale -, neurologa esperta in tossico dipendenze, invece che ad uno psichiatra.
A proposito, la perquisizione alle 4 di notte e il sequestro dei computers è
avvenuto sulla baase di telefonate intercettate – incredibile ma vero – ove una
mia carissima amica mi chiedeva un prestito di 50 euro per portare la figlia,
gravemente malata, da un otorino. Tutto questo è consacrato nelle bobine audio.
Poi Fonzo e Maggioni hanno nascosto la principale delle telefonate intercettate,
quella che sbriciolava le loro teorie accusatorie. Quella telefonata, di ben 15
minuti, aveva lo stesso valore della telefonate dell’esempio che illustro. Io
sono indagato per aver ucciso e occultato il cadavere di mio zio Nino. Mi
mettono il telefono sotto controllo e intercettano la telefonata dello zio Nino
che mi chiama da Cuba per invitarmi a raggiungerlo per divertirci assieme. Sulla
base di quella telefonata l’inchiesta è finita. Se nascondiamo la telefonata
possiamo continuare ad intercettare. E le intercettazioni sono come una rete per
la pesca a strascico. Parti per scoprire il reato di corruzione di una testimone
– pagando la visita medica della figlia malata – e poi magari scopri che
l’indagato fa uso di eroina, procura prostitute agli amici, commette qualche
leggerezza professionale. Purtroppo per Fonzo, nei tre mesi di intercettazioni è
venuto fuori che Peppe Arnone merita solo complimenti e suscita invidie. E
adesso sono Fonzo e Maggioni, i magistrati che hanno gestito le intercettazioni
ad essere indagati. Dico pure i numeri dei processi: Procura di Caltanissetta,
procedimenti n.175 e 178 del 2014, GIP dott. Testaquadra, magistrato molto serio
e perbene."
Come ha
visto reagire la stampa ad Agrigento? C'è stata qualche anomalia?
"Ad Agrigento la istituzione
peggiore, di gran lunga peggiore rispetto a tutte è l’informazione. Il sistema
informativo presenta livelli di degrado e di condizionamento che non hanno
eguali in Italia. Ed infatti nessun giornale online ha pubblicato la foto dello
striscione davanti al Tribunale e tre emittenti su quattro hanno censurato la
notizia. I giornali online, con l’esclusione di uno appena nato, hanno ritenuto
di non informare totalmente i lettori. In questo momento ho tra le mani una nota
di quello che è il maestro di questo tipo di giornalismo, Franco Castaldo. In
questa nota Castaldo scrive – rispondendo ad una mia contestazione sulle loro
censure – “che non è (ovvero sarà) l’Arnone a dettare i tempi e i modi
dell’informazione”. In questa frase vi è tutto: cosa sarebbero i tempi
dell’informazione? Il cittadino dovrebbe avere il diritto di essere informato.
Non dovrebbero esistere i tempi dell’informazione. Il cittadino dovrebbe avere
la notizia in tempo reale, quando il giornalista ne viene in possesso. Ad
Agrigento invece le notizie si censurano, si cancellano oppure al contrario, si
amplificano. Fonzo è indagato per aver preteso dal giornalista Lelio Castaldo
che non andasse in onda una trasmissione di un’ora, programmata da tempo, ed
annunciata con quasi un mese di spot – oltre cento spot - , trasmissione che
consisteva in una mia intervista relativa ad un’inchiesta a mio carico. Il
giornalista Lelio Castaldo la cancella e mi dice testualmente che lui non farà
più quella trasmissione su esplicita richiesta di Fonzo. Questo avviene a
febbraio del 2012. Sei mesi dopo siamo a luglio, il giornalista Lelio Castaldo –
che io assistevo gratuitamente – pubblica un mio comunicato molto ironico sulla
partecipazione di Fonzo ad un’udienza contro di me. Il comunicato parlava di
Fonzo “descamisados”, perché era sceso dal suo ufficio in udienza in fretta e in
furia, in maniche di camicia, per dare man forte al PM d’udienza. Il comunicato
compare e dopo poche ore scompare, sradicato pure dall’archivio del giornale.
Esattamente come avveniva con lo stalinismo, quando si modificavano le
fotografie per cancellare chi era caduto in disgrazia. Come si può comprendere
da queste due vicende, il condizionamento che viene operato dalla Procura di
Agrigento appare essere pesantissimo. Ovviamente questi cosiddetti giornali
censurano pure le notizie delle indagini a carico di Fonzo e del PM Maggioni a
Caltanissetta. Questo è il livello della disinformazione ad Agrigento. Possiamo
definirla mafia dei colletti bianchi questa gestione del sistema informativo che
priva il cittadino di un diritto costituzionalmente garantito? E non parlo delle
aggressioni che questa stampa conduce. Sempre il giornale del Franco Castaldo –
i Castaldo sono due fratelli, Franco e Lelio, Lelio è quello coinvolto
direttamente nei procedimenti a carico di Fonzo – riesce a violare regole
deontologiche minimali con comportamenti francamente inediti: le mie
collaboratrici vengono definite sul suo giornale “troie,
asine e giovenche”, dedite alla monta, io vengo paragonato a Rocco
Siffredi o John Holmes. Mi viene augurato di morire di AIDS. Vengo definito in
continuazione come iettatore. Ogni settimana abbiamo tre o quattro articoli con
firma apocrifa (Attila, Genserico e similari) grondanti di insulti contro di me.
Questo è il giornalismo agrigentino. Ma è un giornalismo o qualcosa di diverso?
Ecco perché Agrigento è la realtà più degradata della Sicilia e probabilmente
d’Italia, quantomeno per quanto riguarda istituzioni formali."
Lei
spesso è criticato perchè secondo taluni dietro le sue clamorose azioni talora
ci sarebbero aspirazioni politiche o altro, cosa risponde?
"La
mia aspirazione è certamente politica, ma nel senso letterale del termine,
migliorare la qualità della vita pubblica, della vita associata nella mia città.
Adesso la mia vita, nel senso della mia esistenza, è raccontata da ben tre
pentiti, due sono esponenti di primissimo piano di Cosa Nostra, il terzo è una
sorta di pentito colletto bianco, che si è pure mosso ai margini di Cosa Nostra.
E il racconto che ne viene fuori del ventennio 1990-2010, è semplicemente
bellissimo. Per vent’anni Cosa Nostra ha avuto il dubbio se era meglio uccidermi
o lasciarmi vivo. Si riunivano frequentemente per parlare di me e del mio
omicidio. Ora chi ha questa storia ha l’ambizione di migliorare la propria
terra, non ha paura né di Fonzi, né di Di Natali, né di Castaldi. I pentiti
raccontano che Cosa Nostra si impegnò con ogni energia per impedire la mia
elezione a sindaco nel ’93 e la mia elezione a deputato nel ’94. Persi le due
elezioni per poche centinaia di voti. E il super pentito Di Gati racconta che
era già stato deciso il mio omicidio, se avessi vinto le elezioni a sindaco del
’93. Il sindaco Arnone suscitava enormi preoccupazioni in Cosa Nostra. Il
racconto dei pentiti – si chiamano Maurizio Di Gati, Luigi Putrone e Giuseppe
Tuzzolino – riguarda il mio impegno per la legalità e contro gli appalti
truccati e gli imprenditori collusi con Cosa Nostra. Adesso è chiaro che non vi
è da parte mia un’aspirazione di campagna elettorale, se per politica intendiamo
questo, mentre vi è un’aspirazione di altro tipo, ovvero ottenere che le regole
dello Stato Italiano valgano anche ad Agrigento. E sino ad ora, con evidenza,
non è stato così."
Ad
oggi chi ha risposto ai suoi numerosi appelli sulla giustizia?
"Sino
ad’ora io non ho puntato ad avere risposte, cioè ad ottenere interventi. Ritengo
di essere il più esperto ed autorevole “guerriero” che si muova in terra
siciliana. I pentiti raccontano ciò che ho saputo fare contro Cosa Nostra. Ma vi
sono poi gli armadi del Consiglio Superiore della Magistratura, che documentano
le mie vittorie nelle battaglie contro magistrati molto molto molto discutibili.
Sono stato io che nel ’91 ottenni l’allontanamento del Procuratore capo Giuseppe
Vaiola, votato all’unanimità. Ho vinto cause contro il pretore e poi senatore
Melchiorre Cirami – sì proprio lui, quello della legge Cirami per Berlusconi - ,
ho vinto fior di cause contro Stefano Dambruoso, sì proprio lui, l’attuale
parlamentare che prende a schiaffi le deputate grilline. Ho provocato
l’allontanamento con addebiti pesantissimi del PM di Agrigento Giuseppe Miceli,
quello che mi voleva arrestare. Ho pure vinto la battaglia per la nomina a
Procuratore capo di Catania di Giovanni Salvi: credo proprio che senza i
documenti che io ho inviato al CSM, nell’imminenza della votazione, oggi il
Procuratore capo di Catania sarebbe Giuseppe Gennaro. Ho fatto questa premessa
perché so come si combattono le battaglie contro poteri di questo livello.
Bisogna prima avere tutte le carte in regola, essere inattaccabili. Io amo le
metafore storiche. Gli alleati impiegarono molto tempo a preparare lo sbarco in
Normandia, ma quando sbarcarono, l’unico dubbio era se Hitler sarebbe stato
fucilato o se si suicidava anticipando tutti. Così oggi la battaglia contro ciò
che ha rappresentato Fonzo ad Agrigento, è una battaglia vinta. Siamo come gli
alleati che sbarcati in Normandia, stanno riconquistando la Francia per arrivare
a Berlino. Ed adesso possiamo attivare il sistema mediatico nazionale,
certamente interessato a sentire le intercettazioni telefoniche sui prestiti per
la visita medica, scambiati come fatti di corruzione che giustificavano
perquisizioni alle 4 di notte, e ancor di più, l’ammissione del PM Fornasier che
il suo collega Fonzo realizzava schieramenti alle mie spalle. L’Italia è una
Democrazia, con tante contraddizioni, ma alla fine se hai ragione e le palle per
batterti, se non ti fai intimorire, vinci. Il destino di questi è segnato."
Ci può
anticipare sviluppi -se ci saranno- di queste vicende?
"Gli
sviluppi sono facili da prevedersi. Penso che appena l’onda mediatica nazionale
si occuperà delle cose che ho illustrato, non appena una delle trasmissioni
nazionali farà sentire la voce del PM Fornasier che ammette gli schieramenti
alle spalle di Fonzo, racconta come Fonzo ha strumentalizzato il suo ruolo per
costruire legami fortissimi, e addirittura minaccia le brutte mazzate,
interverranno di corsa ad Agrigento ispettori ministeriali e del CSM. E ancora,
io voglio far sentire la voce della signora che chiede in prestito 50 euro per
la visita medica della figlia o 20 euro per ordinare libri di scuola, e tutto
questo viene a giustificare processi per corruzione e perquisizioni alle 4 di
notte. Siccome siamo in un paese democratico e Arnone è comunque una personalità
che sa farsi valere, non invidio affatto Fonzo, Di Natale, Maggioni e compagnia
cantando. Tutti questi magistrati avranno per i prossimi anni problemi
gravissimi. E lo ritengo una vittoria della gente per bene. Io adesso non sto
punendo costoro solo per i torti che hanno fatto a me, ma soprattutto perché se
quello che ho subito io lo avesse subito un cittadino comune, sarebbe stato
travolto e distrutto. Fonzo e compagnia bella sono come il branco di iene che ha
assalito il rinoceronte. Stavano per farlo fuori, ma il rinoceronte è una bestia
molto solida, ha saputo reagire e adesso è lui che sta pestando le iene. Ma se
queste iene avessero assaltato una zebra o una gazzella o un’antilope,
l’avrebbero distrutta e sbranata senza pietà. Il rinoceronte oggi sta
realizzando il diritto di tutti al rispetto della giustizia e delle leggi dello
Stato. Gli sviluppi quindi saranno per tutti costoro pesantissimi. A
Caltanissetta, per tentare di salvare Fonzo e Maggioni, vi è stata pure la
sfilata di testi mendaci, ad esempio il teste Lelio Castaldo ha messo nero su
bianco una serie di bugie ridicole, proprio risibili. Ha raccontato che il
comunicato di Fonzo “descamisados” sia era cancellato per un guasto al sistema
informatico, il Gip ha disposto una perizia su quel sistema informatico. Sempre
Lelio Castaldo ha dichiarato al PM di aver cancellato la trasmissione su
consiglio del suo avvocato. Peccato che la trasmissione non era stata ancora
registrata e l’avvocato non aveva la materia su cui dare pareri giuridici. Se la
trasmissione fosse stata già registrata, l’avvocato avrebbe potuto dire: “non la
mandare in onda perché questa e quell’altra frase sono diffamatorie”. Non
esistendo la trasmissione, questo avvocato su cosa doveva dare il suo parere
legale? Tutto ciò viene a rappresentare ulteriormente il quadro di degrado e di
inquinamento che ruota attorno a costoro nella realtà agrigentina."
MASSONERIA NELLE
ISTITUZIONI.
Autorità criminali e culti misterici, scrive Antonella Randazzo.
Si parla spesso di “bizzarrie” che appaiono su Internet, ovvero di argomenti su
cui aleggia lo spettro della bufala o del contenuto che attrae ma è irreale,
singolare o stravagante. Il problema è che a volte si cerca di far rientrare in
questa categoria anche argomenti molto importanti per capire il sistema in cui
oggi ci troviamo. Un esempio di ciò è l’argomento “culti misterici”. Un culto
misterico è un culto riservato a pochi, che prevede riti di iniziazione e di
passaggio da un livello più basso ad uno più alto, il più totale segreto
relativo al culto, alle cerimonie, e l’idea che il gruppo fornirà conoscenze
esoteriche importanti. Non necessariamente i culti misterici sono religioni
misteriche, talvolta, come nel caso delle società segrete, si tratta di gruppi
che non dichiarano esplicitamente di adorare una precisa divinità. Tuttavia,
l’idea che vengano svelate cose “misteriose” che sono appannaggio di pochi,
suggerisce l’esistenza di “venerandi”, ovvero di una fonte da cui proverrà la
conoscenza esoterica. Nonostante su Internet esistano molte fonti che parlano di
sette esoteriche, di massoneria e di gruppi di potere occulti, non bisogna fare
l’errore di dare per scontato questi argomenti, sottovalutandoli o scambiandoli
per argomenti “sui generis”. Ci sono innumerevoli prove, talvolta date dagli
stessi interessati, che gli attuali personaggi al potere si valgono di
associazioni o culti misterici per alimentare il loro potere e per scongiurare
il pericolo che salgano al potere personaggi non controllabili.
Dunque, studiare con serietà un tale argomento può aggiungere nuove conoscenze
su come agiscono i personaggi che oggi esercitano potere sui popoli, su come
essi formano il ceto dirigente e come cercano in tutti i modi di tenerlo
soggiogato per potersi garantire il dominio sui popoli. Da molti elementi si
inferisce che è proprio attraverso le logge, i culti segreti e la mafia che
queste persone continuano a tenere sotto controllo le autorità, curandosi di
formarle e di obbligarle al segreto circa aspetti del sistema evidentemente
inconfessabili. L’uso di queste formazioni conferma, se ce ne fosse bisogno, la
natura criminale del sistema, che ha bisogno di manipolare e controllare per
continuare ad esistere. I gruppi segreti di natura massonica servirebbero a
controllare mentalmente chi è destinato a ricoprire cariche di potere. E’ come
se alcune persone dovessero essere “formate” in modo tale da commettere le più
gravi cattiverie senza avere scrupoli di coscienza, e magari motivandole
truffaldinamente per renderle “legittime”. In effetti, organizzare guerre,
uccidere o torturare persone inermi significa distruggere il sentimento umano
naturale di empatia con i propri simili, e dunque non sembrerebbe possibile
farlo senza un’accurata “formazione”. Per questo motivo sembrerebbe necessario
far praticare a chi ricoprirà ruoli importantissimi, culti che disumanizzano,
che stimolano gli aspetti più negativi e distruttivi dell’uomo, o che inducono a
credere che possano esistere principi, “valori” o ideologie che giustificano i
crimini più terribili contro l’umanità. Esisterebbero due tipi principali di
culti misterici:
1) quelli che prevedono
l’affiliazione di un numero relativamente ampio di adepti, che per la maggior
parte ricoprirà livelli bassi, e dunque non raggiungerà mai determinate
conoscenze, appannaggio dei pochi che raggiungeranno gli alti livelli;
2) quelli che appaiono come
sette vere a proprie, poiché sono destinate soltanto ai rampolli delle grandi
famiglie miliardarie o a personaggi “scelti”. In tal caso il personaggio sarà
chiamato ad aderirvi come fosse un “eletto”, ad esempio ricevendo una lettera da
chi ha creato la setta.
In quest’ultimo caso, i riti
talvolta sarebbero agghiaccianti, simili a quelli satanici. Ad esempio, nel
gruppo chiamato Skull & Bones gli iniziati dovrebbero masturbarsi nudi in una
bara, e successivamente subirebbero anche violenze verbali e fisiche, dovendo
lottare nel fango e a subire violenze con altri adepti fino allo sfinimento. Si
tratterebbe di tecniche elaborate dalla Cia al fine di indebolire il soggetto
attraverso una serie di atti che lo piegheranno fisicamente e mentalmente. Agli
adepti verrebbe anche inculcata l’idea di essere superiori e di avere la
“missione” di dominare sugli altri. Essi subirebbero dunque umiliazioni
sessuali, ma al contempo verrebbero abituati ad esaltare il proprio ego
umiliato, per sopperire alla bassa autostima stimolata dalle umiliazioni. Questi
rituali non sarebbero casuali, ma creati per influenzare gli adepti in un
determinato modo. L’obiettivo sarebbe quello di far emergere aspetti del sé
distruttivo, in modo tale che emozionalmente e mentalmente la persona possa
diventare più incline a mentire, ad ingannare e a commettere azioni criminali.
E’ come “programmare la mente” ai crimini che dovranno commettere quando
saliranno al potere. Essi dovranno commetterli non soltanto senza alcun rimorso
ma addirittura credendo che ciò sia giusto, e per poter raggiungere questo
livello di mistificazione occorre una sorta di percorso “esoterico” atto a
manipolare la mente a tal punto da produrre questo effetto. I riti praticati in
questi gruppi misterici sono traumatizzanti e violenti, e addirittura per essere
resi più agghiaccianti sarebbero utilizzate urla di sottofondo. Questi riti
sarebbero collegati a simbologie di vario genere, e servirebbero anche a creare
affiliazione a realtà false, per disorientare l’esistenza. Nelle società segrete
massoniche viene anche creato un clima di unità e “fratellanza” molto forte,
come se gli adepti fossero legati da qualcosa di importante e fondamentale per
la loro esistenza. La stessa cosa avviene nella mafia. Sembrano cose talmente
assurde da non poter essere vere, ma le prove e le testimonianze a sostegno di
ciò sono ormai così numerose che ignorarle significherebbe agire come i
personaggi di regime, che vedono soltanto quello che viene detto loro di vedere.
Storici come Paolo Mieli direbbero che tutto è casuale, che è casuale che quasi
tutte le più importanti autorità inglesi e statunitensi siano membri di alto
grado della massoneria, o che addirittura nel 2004, entrambi i candidati alla
presidenza degli Stati Uniti appartenessero alla società segreta Skull & Bones
(teschio e ossa – detta anche “Fratellanza della morte”). La Skull & Bones fu
fondata per “formare” l’èlite di potere statunitense, all’Università di Yale nel
1832, ad opera di William Huntinton Russell, che era colui che all’epoca si
occupava della produzione e del commercio di oppio. Questa setta, a detta di
molti, praticherebbe rituali simili a quelli praticati nel satanismo. La
giornalista Alexandra Robbins è riuscita ad intervistare diversi adepti,
ricavando un’immagine della setta a dir poco sconcertante. Gli adepti si
riunirebbero in un luogo chiamato “the Tomb” (la Tomba), luogo in cui si
svolgerebbero i riti. Il marchio della setta appare in molti oggetti posseduti
da coloro che l’hanno creata o che vi appartenevano (o vi appartengono), come
John Pierpont Morgan, David Rockefeller, Henry Stimson, Averell Harriman, i Bush,
i Taft, ecc. All’interno della setta viene presentata una realtà gravemente
squilibrata, eppure i suoi adepti diventano importanti industriali, dirigenti di
grandi banche o altre organizzazioni importanti, o addirittura presidenti o
consiglieri di presidenti. I membri della setta sono soltanto poche centinaia,
reclutati fra le più importanti famiglie miliardarie statunitensi. La Robbins,
nel libro “Secrets of the Tomb” descrive alcuni riti che appaiono come un
incrocio fra il carnevalesco e il paradossale, che meriterebbero una grossa
risata, se non ci fossero risvolti tremendamente seri. Ad esempio, il giovane
Bush, nel rito di iniziazione, sarebbe stato incappucciato e condotto da 11
patriarchi della confraternita travestiti come fosse carnevale: uno da Elihu
Yale (fondatore dell’Università), uno da Papa, uno da diavolo, ecc. In questo
clima farsesco l’iniziato doveva raccontare la propria “storia sessuale”,
dopodichè sarebbe dovuto entrare nudo in una bara per masturbarsi. Il tutto
veniva abbeverato da quantità esorbitanti di alcolici. Ma secondo la Robbins
tutto questo fare settario e bizzarro sarebbe “normale” negli ambienti dei
miliardari statunitensi. Ella dichiara: “I più ricchi americani si comportano
allo stesso modo quando partecipano a raduni esclusivi come quello che si tiene
ogni anno a Sun Valley in Idaho”. Considerato che si tratta di persone che hanno
nelle loro mani il destino di milioni di persone, c’è proprio da stare
tranquilli…Sia Kerry che Bush, candidati alla presidenza nel 2004, appartenevano
alla setta Skull & Bones, e risposero imbarazzati quando un giornalista chiese
loro se appartenevano alla setta e quali fossero i principi del gruppo. Bush
ammise di appartenere alla setta e alle ulteriori domande rispose: “è così
segreto che non possiamo parlarne”. Kerry rispose in modo analogo, ammettendo la
sua affiliazione: “non (posso dire) molto perché è un segreto”. Due persone che
aspirano a ricoprire una carica politica importantissima che confessano di avere
“segreti” da rispettare, che non sono cose che riguardano fatti privati, ma
un’affiliazione occulta. Giurare di non rivelare qualcosa all’interno di una
setta abitua ad un comportamento poco trasparente, assai pericoloso quando si
tratta di ricoprire cariche di potere. La loro fedeltà alla setta avrebbe
sovrastato la necessità di agire per il bene del popolo, ponendo il proprio
giuramento massonico al di sopra della fedeltà alla nazione. Come diceva Joseph
Pulitzer: «Non esiste delitto, inganno, trucco, imbroglio e vizio che non vivano
della loro segretezza”. Queste sette impongono il giuramento di “obbedienza
totale” e segretezza, assoggettando così la persona al gruppo. Come nel caso
della mafia, non si può disobbedire, svelare segreti o uscire dalla setta senza
pagare un prezzo molto alto. Le persone che fuoriescono dal controllo saranno
giudicate da appositi tribunali che prevedono anche la pena di morte. Oltre al
gruppo Skull & Bones ci sarebbero molte altre sette di tipo analogo, come la
cosiddetta “Società Boema” che si riunirebbe in California nelle ultime due
settimane di luglio, praticando riti satanici che prevedono un’invocazione fatta
ad una statua che rappresenta un gufo alto circa 7 metri. Parteciperebbero al
rito parecchie importanti autorità, capi di Stato, industriali, ex presidenti
statunitensi, ecc. Queste persone vestirebbero con una tunica con relativo
cappuccio, ovvero la stessa veste indossata dagli adepti del Ku Klux Klan. Di
fatto, negli Usa quasi tutti i presidenti e i vicepresidenti, molti senatori e
deputati, giudici e governatori sono massoni. Questo può essere considerato come
casuale da persone dotate di razionalità? E’ massone di alto livello l’ex capo
di governo inglese Tony Blair, egli è membro della Loggia massonica di Studholme
(Londra). La stessa regina sarebbe la “Patrona della massoneria Internazionale”,
come un capo su tutti i massoni di alto livello. Di tanto in tanto riunirebbe
tali personaggi a Drewery Lane (Londra). Altri membri della Corona inglese, come
il Duca di Edimburgo, sono membri di alto grado della massoneria. Il deputato
inglese Chris Mullins, attraverso un comitato d’inchiesta scoprì che molte
autorità in seno alle forze dell’ordine e alla giustizia erano affiliate a sette
segrete. L’agente dell’Fbi ora in pensione, Ted Gunderson, che si occupava di
investigare su culti e sette sataniche, scoprì attraverso varie fonti che molti
giudici, avvocati, attori, sportivi, medici, deputati e senatori, erano affilati
a sette di tipo massonico-satanico. Anche importanti capi di governo del
passato, come Winston Churchill, erano massoni di alto grado. I gradi più alti
sono di solito raggiunti soltanto da persone di sangue aristocratico o da alti
ufficiali delle forze armate. Le persone che appartengono alle sette destinate
soltanto a persone di “alto rango” vengono incoraggiate a sposarsi fra loro, per
creare maggiore coesione tra i gruppi e per evitare che queste persone entrino a
contatto con altre realtà che le “risveglino” e facciano scegliere loro altri
percorsi più “normali”. Tutto questo serve anche ad escludere gli “intrusi” dal
potere, creando in tal modo un sistema controllato dall’alto e prevedibile. Gli
ambienti settari degli stegocrati sono intrisi di un’alta valenza emotiva, che è
un misto fra onnipotenza, sete di potere, avidità e paura. Si crea una
rappresentazione della realtà alterata che può confondere fra ciò che è vero e
ciò che è soltanto finzione. Si crea uno stato emotivo talmente alterato da non
permettere alle vittime di avere una vita emotiva indipendente, o di uscire dal
giro senza pagare un prezzo molto alto. Molte di queste persone vivranno per
tutta la vita esistenze emotivamente alterate, passeranno fra una festa, un rito
e un impegno politico ( finanziario o economico) esibendo sorrisi stereotipati o
falsi entusiasmi. Racconteranno cose assurde sul “nemico terrorista”, sulla
“lotta del bene sul male”, o sul fatto che gli Usa sarebbero “una grande
democrazia”. Il gruppo di stegocrati sa che l’unico modo per continuare ad avere
potere è quello di controllare la mente di chi avrà ruoli di potere, e un modo
efficace, evidentemente, è quello di controllarli attraverso gruppi massonici e
satanici. Si tratterebbe dunque di utilizzare tali gruppi come uno strumento di
potere sulle menti degli adepti. I capi massonici vengono chiamati “maestri
occulti” o “sovrani”. Spiega Jordan Maxwell: “Gli ordini pre-massonici europei
sostenevano che ci fosse una piccola teoria, una piccola entità spirituale che
forniva una conoscenza per quello che i massoni chiamavano “i nostri maestri
occulti”… si riferivano a chi guidava la massoneria mondiale… loro non sanno chi
siano. Nessun massone sa realmente chi realmente guida l’organizzazione
mondiale. Li chiamano “i nostri maestri occulti”. Molti studiosi ritengono che i
riti satanici e massonici siano molto più simili di quello che si crede. Secondo
queste persone il Dio dei Massoni avrebbe un nome impronunciabile, ovvero
sarebbe lo stesso Dio dei satanisti. La maggior parte dei massoni smentisce
questo, ma alcuni, come Albert Pike, lo hanno ammesso. Da laici sarebbe
legittimo pensare che i “demoni” da loro adorati non sono altro che aspetti del
sé inquietanti, ovvero la cosiddetta “Ombra” descritta da Jung. Tali riti
potrebbero dunque avere lo scopo di alimentare questi aspetti per renderli più
forti o più presenti, allo scopo di far diventare le persone capaci di
comportamenti che altrimenti non avrebbero. In altre parole, si tratta di
rafforzare i potenziali criminali al fine di forgiare persone che si comportino
in modo utile al sistema, agendo sulla loro mente e instillando convinzioni
mistiche o esoteriche che condizioneranno le loro scelte e il loro
comportamento. Per questo di solito i riti posseggono un certo livello di
violenza, e abituano a calpestare la dignità umana. Qui non si vuole certo
sottovalutare il potere del pensiero. Come i fisici più all’avanguardia ci
insegnano, il pensiero è energia che può creare demoni e qualsivoglia realtà,
rafforzando alcuni aspetti della psiche e indebolendone altri.
I Fratelli d’Italia
chiamati a fregare l’Italia.
La Massoneria propriamente detta, ovvero quella che permette anche a decine di
migliaia di persone di aderire, dal punto di vista ideologico appare come un
calderone in cui c’è tutto e il contrario di tutto: si propone come “tollerante”
ma di fatto rappresenta un modo efficace per controllare le menti; si presenta
come “umanistica” ma risulta soprattutto un modo per spogliare gli umani della
loro umanità. Le logge massoniche servono, nonostante il volto rispettabile che
può essere dato, non solo a controllare le persone, ma anche ad organizzare e ad
attuare una serie di crimini di vario genere: corruzione di funzionari,
attentati terroristici, colpi di Stato, eliminazione di personaggi scomodi,
ecc.. Anche se le società segrete possono acquisire nomi diversi, esse sono
controllate da un unico centro di potere, che fa capo agli stegocrati, ovvero a
coloro che hanno nelle loro mani il potere finanziario, economico, politico e
mediatico. Credere che queste associazioni possano avere scopi positivi sarebbe
come credere che le banche operano per il bene dei popoli. Come tutte le
creazioni dell’attuale gruppo di potere, la natura evidente della massoneria
risulta l’opposto rispetto alla sua verità, ma la maggior parte degli adepti non
se ne accorge, ignorando ciò che avviene ai livelli più elevati. Certamente
esistono adepti che non sono affatto criminali, e che, anzi, sono persone per
bene che credono con sincerità ad un presunto scopo positivo dell’associazione.
Ma non dobbiamo dimenticare che se oggi ci troviamo nella situazione in cui
siamo è per la credulità e l’ignoranza (intesa come non conoscenza del vero
sistema attuale) di molte persone. Non essere capaci di riconoscere i tanti
tranelli messi in atto dal gruppo dominante costa caro a tutti. La maggior parte
delle persone che aderiscono alla massoneria crede che i precetti della
massoneria siano quelli che vengono loro insegnati, e alcuni ignorano persino
che esistano alti livelli in cui i principi propagandati si ribaltano. Quasi
tutti gli adepti non vanno oltre il terzo o quarto livello. Evidentemente, c’è
una doppia faccia nella massoneria: per la maggior parte è un’associazione
storica con principi “liberali” e “umanistici”, ma per chi la crea e la manovra
è soltanto una fonte per controllare, formare e dirigere coloro che potranno
avere ruoli importanti nei settori chiave del potere. Ad oggi, la massoneria è
un argomento poco trattato, che viene ammantato di mistero, come se non fosse
possibile capire che molte autorità e personaggi che ricoprono ruoli finanziari,
economici, mediatici e politici importanti sono quasi sempre massoni di grado
elevato. Anche la mafia è stata per molto tempo ammantata da un alone di
mistero, anche quando sapevano tutti che esisteva e quale ruolo avesse. Esiste
un forte legame fra mafia e massoneria. I vertici mafiosi, per poter meglio
coordinare alcune operazioni, sono strettamente collegati ai servizi segreti
come la Cia e l’MI6, e alle logge massoniche. L’Italia è stata messa sotto il
controllo della massoneria sin dall’Unità, attraverso personaggi come Garibaldi,
che era un noto massone di alto livello. Garibaldi ebbe il 33° grado della
massoneria, che gli inglesi concedevano ai dittatori Sud Americani o a coloro
che si mettevano completamente ai loro servigi. La spedizione dei Mille fu
finanziata dalla massoneria inglese con somme enormi, parecchi milioni di
dollari attuali. In realtà la Corona inglese ha utilizzato la massoneria, non
per unire l’Italia, come è stato detto, ma per imporre a tutti gli italiani il
potere (controllato) dei “Fratelli d’Italia”. Lo storico Salvatore Lupo scrisse
che “durante la cospirazione risorgimentale esisteva una rete clandestina
ispirata alla massoneria”. Il pentito Antonino Calderone raccontò anche che la
massoneria fungeva da canale per stabilire i contatti fra funzionari statali e
mafiosi. Secondo il giudice Agostino Cordova la massoneria è da ritenere “‘il
tessuto connettivo della gestione del potere”. All’interno di essa si trovano i
personaggi più disonesti e corrotti. Negli anni Novanta, in Italia, c’erano 146
massoni indagati per mafia e reati politici, 83 dei quali accusati di
riciclaggio di titoli rubati. Fra gli iscritti alle logge figuravano anche
diversi poliziotti e carabinieri, accusati da Cordova di “impedire le indagini”.
Secondo il pentito Leonardo Messina, la collaborazione fra mafiosi e massoneria
non è affatto rara, al contrario, quasi tutti i capimafia frequentano
assiduamente le logge massoniche, e l’intero vertice di Cosa Nostra è affiliato
alla massoneria. Mutolo parlò delle logge come di “un punto d’incontro per
tutti”. Ciò fa emergere la consonanza di interessi, di ruoli e di metodi. La
stessa strategia di mascherare, occultare o nascondere appartiene sia alla mafia
che ai servizi segreti e alle logge massoniche. Si parla di “servizi deviati” o
di massoneria “deviata” per proteggere un presunto ruolo corretto di queste
organizzazioni, ma in realtà esse sono per loro natura inclini al segreto e al
controllo. Se operano per nascondere significa che hanno qualcosa da nascondere.
Pur dovendo constatare gli stretti legami fra massoneria e mafia, occorre fare
alcune distinzioni. La mafia, avendo come scopo anche quello di soggiogare la
popolazione, non può essere completamente occulta, al contrario, essa deve dare
chiari segnali alla popolazione della sua esistenza. Tutti sanno chi sono i
mafiosi e dove abitano, e molti sono costretti a prendere atto degli omicidi
commessi dalle cosche. I mafiosi continuano ad abitare nelle zone di origine,
anche quando ormai sono assai noti, gli unici a non sapere chi sono e dove
abitano sono le istituzioni, dato che non li fanno arrestare. Molte famiglie
mafiose, come ad esempio quella dei Corleonesi, erano state identificate già
negli anni Cinquanta, ma soltanto nel periodo del pool si ebbe una vera
strategia per abbattere il loro potere. E’ vero che per molti anni le autorità
hanno cercato di negare l’esistenza della mafia, ma nel sud le persone sapevano
benissimo che c’era, e dovevano saperlo per esserne soggiogati, o perché erano
costrette a pagare il pizzo. Persone come Falcone e Borsellino avevano capito i
legami fra mafia e massoneria, e per questo sono state condannate a morte. Più
recentemente, anche magistrati come De Magistris e Woodcock hanno scoperto
stretti legami fra politici, mafiosi e massoni. Talvolta un personaggio può
appartenere a tutte e tre le categorie. Esistono reti di grave corruzione
scoperte da De Magistris, che per questo è stato messo nelle condizioni di non
poter continuare le sue indagini. La massoneria italiana raccoglie molti
personaggi del panorama finanziario, economico, mediatico e politico italiano,
in totale segreto, anche se per le nostre leggi è illegale creare associazioni
segrete. Come molti sanno, in Italia è stato realizzato il piano della
cosiddetta Loggia Propaganda 2, per evitare che gli italiani pretendessero una
maggiore apertura democratica. La Legge n.17 del 25 gennaio 1982 (detta Legge
Anselmi), fu approvata in seguito allo scandalo della Loggia Propaganda Due, con
lo scopo di sciogliere la P2 e rendere illegali tutte le associazioni segrete
con obiettivi analoghi. La legge ribadiva un principio presente nella
Costituzione Italiana, al secondo comma dell’articolo 18, che considera illegali
le associazioni segrete con scopi politici e a carattere militare. Questo faceva
apparire il pericolo come scampato e dava l’idea che ormai appartenesse al
passato. Di fatto però non si fece nulla per impedire che salissero al potere i
personaggi che agivano per realizzare il piano della P2. Il sistema agì come un
prestigiatore: mostrava una realtà che non esisteva, mentre ne realizzava
un’altra, proprio quella che faceva apparire come smascherata e distrutta. Sotto
i nostri occhi ci è stata data la fregatura. Secondo la giornalista Concita De
Gregorio, che ha intervistato Licio Gelli, la “strana” attività di questo
inquietante personaggio non appartiene certo al passato. Spiega la De Gregorio:
“(Gelli) è un uomo… (che) lavora a pieno ritmo, ha vari uffici in cui riceve
ospiti ogni giorno… ha un’agenda fittissima e una serie di segretarie che
lavorano per lui a tempo pieno. Io l’ho incontrato a villa Wanda, ad Arezzo,
nella sua abitazione… è in grande attività, riceve personalità straniere,
politici, imprenditori… per la gran parte italiani, ed è un uomo… che ha come un
crocevia di affari internazionali… stupisce questo disinteresse che c’è attorno
alla figura di Gelli, che è come se appartenesse al passato, in realtà
appartiene al presente, è lì e lavora… il suo piano si è realizzato,
nell’intervista… ha parlato di uomini politici attualmente in carica, fa dei
nomi che sono ancora quelli, la classe politica di allora è la stessa di oggi, è
difficile immaginare che anche i progetti, i programmi siano cambiati… alla fine
il progetto realizzato è quello di Gelli”. Non è difficile immaginare di che
“lavoro” si tratti, visti i precedenti, e nemmeno i personaggi che chiedono le
sue “consulenze”. Del resto, lo stesso Gelli non nega il potere che la loggia
che egli “dirigeva” ha avuto nel creare, com’era nei piani, un sistema
dittatoriale dotato di parvenza democratica. Dunque, non c’è dubbio che anche in
Italia i gruppi massonici hanno esercitato ed esercitano un potere
antidemocratico, attraverso la creazione di una vasta rete sotterranea che
riunisce i personaggi più importanti in molti settori, per “affiliarli” e
controllarli. Chi è fedele all’affiliazione è colui che ha più probabilità di
avere fama, soldi e potere. Chi è affiliato è una pedina (più o meno importante)
controllabile, fedele e manovrabile. Il principio di segretezza della massoneria
permette di agire in modo illegale e criminale senza essere perseguiti, e spesso
senza far capire chi sono i responsabili e come abbiano agito. Come denunciò
John Kennedy poco tempo prima di essere ucciso: “La parola ‘segretezza’ è
ripugnante in una società aperta e libera, e noi come popolo ci siamo opposti,
intrinsecamente e storicamente, alle società segrete, ai giuramenti segreti, e
alle riunioni segrete. Siamo di fronte, in tutto il mondo, ad una cospirazione
monolitica e spietata, basata soprattutto su mezzi segreti per espandere la sua
sfera d’influenza”. La segretezza protegge le attività criminali delle autorità,
e dunque conferisce un potere assoluto ad alcune persone, che potranno
commettere qualsiasi crimine senza essere perseguite. Quando viene sollevato
seriamente il problema della massoneria e della segretezza, alcune autorità
intervistate ci scherzano sopra come a prendere in giro e ad additare come
bizzarre tutte le persone che si accorgono di queste realtà. Deridere,
etichettare come “cospirazionisti” e “paranoici” o trattare come persone strane
e sospettose, sono metodi per far cadere nel vuoto le accuse di chi si accorge
che c’è un gruppo di potere che utilizza metodi criminali per continuare a
dominare. Cercando di screditare coloro che sollevano il problema cercano anche
di evitare di fare la dovuta chiarezza. Anche le autorità vaticane si valgono di
un’organizzazione che ricalca la struttura e le funzioni tipiche di
un’organizzazione massonica, ovvero l’Opus Dei. Per molti autori si tratta di un
centro potentissimo, che, insieme alla Curia Romana si occuperebbe di proteggere
ed estendere il potere e gli affari del Vaticano, anche attraverso mezzi di
arricchimento finanziario ed eliminando tutto ciò che potrebbe intralciare.
L’Opus Dei è diffusa in molti paesi del mondo, e si occuperebbe anche di
controllare le cariche ecclesiali di alto grado. Secondo alcuni antropologi i
culti misterici contengono ideologie che mirano al potere assoggettando persone
che poi saranno utilizzate per i propri scopi. Il satanismo appartiene a questa
categoria, come anche le sette segrete che professano altre finalità. Ogni tanto
alcuni personaggi, come l’ex Gran Maestro Giuliano di Bernardo, denunciano
aspetti strani della massoneria, ma queste persone parlano di “massoneria
deviata”, facendo credere che la massoneria in quanto tale sarebbe
un’organizzazione accettabile. Si trascura di parlare degli aspetti perlomeno
strani di questa organizzazione. Non si spiega il persistere di
un’organizzazione segreta che nel passato dichiarava di avere motivazioni
“cospirative” contro i regimi dittatoriali e assolutistici dell’epoca. Oggi, che
ci dicono di essere in una democrazia, quali scopi avrebbe la segretezza? Quale
scopo avrebbe la ritualistica, se non si tratta di una religione? Perché gli
alti gradi vengono tenuti nascosti alla maggior parte degli stessi adepti?
Perché aderiscono alla massoneria generali, giudici, alte cariche dell’esercito,
finanzieri, imprenditori e politici fra i più importanti? Quale sarebbe lo scopo
di ciò all’interno di una presunta “democrazia”? E perché la maggior parte di
essi nasconde di essere massone, specie se si tratta di persone influenti?
Esistono, com’è noto, segni e simboli che svelano l’appartenenza alla
massoneria, alcuni dei quali sono riconosciuti soltanto dagli stessi massoni, e
fungono da segnali segreti per ricondurre persone di diversa nazionalità o
sconosciute fra loro ad uno stesso “territorio”. Esistono segnali scambiati
mentre si porge la mano, speciali saluti, oppure piccoli oggetti (anelli,
spillette, ecc.) che possono essere posseduti soltanto da massoni. La dottoressa
antropologa Cecilia Gatto Trocchi scoprì come personaggi che utilizzavano
diverse ideologie poi convergevano con disinvoltura nella massoneria o nei culti
esoterici: “Ho scoperto tutta una lunga corrente di persone che sono passate dal
marxismo all’esoterismo… nelle logge si legge l’inno a Satana di Carducci… è una
visione spiritualista che si contrappone a quella cristiana”. Intervista alla
Prof.ssa Cecilia Gatto Trocchi prima che venisse trovata morta “suicida”. Questo
proverebbe la funzione manipolatrice delle ideologie dominanti, al pari con i
culti misterici di natura massonica. Che razza di persone sono quelle che si
mettono nude in una bara, che fanno pratiche sessuali davanti al gruppo o si
fanno umiliare sessualmente? Che promettono segretezza e si fanno manipolare
mentalmente da un presunto “maestro occulto”? Cosa penseremmo comunemente di
persone che si comportano così? Come minimo che hanno qualcosa che non quadra e
che dovrebbero farsi seguire da qualcuno, eppure queste persone non soltanto
passano per essere “normali”, ma addirittura ricoprono cariche importantissime.
Le domande sono: possiamo continuare ad accettare che questo genere di persone
governi il mondo? Perché mai dovremmo accettare che persone così squilibrate
esercitino un potere enorme sui popoli del mondo? Ci si augura che molte persone
non cedano all’inganno di credere che queste cose non siano vere o che chi le
solleva è solo un “paranoico complottista”. Non è chi denuncia tutto questo ad
essere squilibrato, ma chi lo crea e lo pratica. Per quanto queste cose appaiano
assurde e incredibili, purtroppo sono vere: siamo imprigionati in un sistema
guidato da persone mentalmente compromesse, che si spacciano per autorevoli
personaggi, e le nostre autorità, essendo loro complici, ce le presentano come
tali. Chi volesse approfondire l’argomento troverà molti libri di notevole
qualità, che chissà perché non vengono mai discussi nei salotti televisivi.
L’unica strada percorribile è quella di divenire coscienti della vera realtà, e
rigettare completamente tutti gli attuali criminali al potere. Conoscere la
natura dell’attuale potere criminale è il solo modo per poter diventare
consapevoli e poterlo distruggere. Come qualcuno ha detto, non c’è libertà
finché si è soggetti all’inganno.
Perchè leggere Antonio
Giangrande?
Ognuno di noi è segnato nella sua esistenza da un
evento importante. Chi ha visto il film si chiede: perché la scena finale de
“L’attimo fuggente” , ogni volta, provoca commozione? Il professor John Keating
(Robin Williams), cacciato dalla scuola, lascia l’aula per l’ultima volta. I
suoi ragazzi, riabilitati da lui dalla corruzione culturale del sistema, non ci
stanno, gli rendono omaggio. Uno dopo l’altro, salgono in piedi sul banco ed
esclamano: «Capitano, mio capitano!». Perché quella scena è così potente ed
incisiva? Quella scena ci colpisce perché tutti sentiamo d’aver bisogno di
qualcuno che ci insegni a guardare la realtà senza filtri. Desideriamo, magari
senza rendercene conto, una guida che indichi la strada: per di là. Senza
spingerci: basta l’impulso e l’incoraggiamento. Il pensiero va a quella poesia
che il vate americano Walt Whitman scrisse dopo l'assassinio del presidente
Abramo Lincoln, e a lui dedicata. Gli stessi versi possiamo dedicare a tutti
coloro che, da diversi nell'omologazione, la loro vita l’hanno dedicata per
traghettare i loro simili verso un mondo migliore di quello rispetto al loro
vivere contemporaneo. Il Merito: Valore disconosciuto ed osteggiato in vita,
onorato ed osannato in morte.
Robin Williams è il professor Keating nel film
L'attimo fuggente (1989)
Oh! Capitano, mio Capitano, il tremendo viaggio
è compiuto,
La nostra nave ha resistito ogni tempesta:
abbiamo conseguito il premio desiderato.
Il porto è prossimo; odo le campane, il popolo
tutto esulta.
Mentre gli occhi seguono la salda carena,
la nave austera e ardita.
Ma o cuore, cuore, cuore,
O stillanti gocce rosse
Dove sul ponte giace il mio Capitano.
Caduto freddo e morto.
O Capitano, mio Capitano, levati e ascolta le
campane.
Levati, per te la bandiera sventola, squilla
per te la tromba;
Per te mazzi e corone e nastri; per te le
sponde si affollano;
Te acclamano le folle ondeggianti, volgendo i
Walt Whitman (1819-1892) cupidi volti.
Qui Capitano, caro padre,
Questo mio braccio sotto la tua testa;
È un sogno che qui sopra il ponte
Tu giaccia freddo e morto.
Il mio Capitano tace: le sue labbra sono
pallide e serrate;
Il mio padre non sente il mio braccio,
Non ha polso, né volontà;
La nave è ancorata sicura e ferma ed il ciclo
del viaggio è compiuto.
Dal tremendo viaggio la nave vincitrice arriva
col compito esaurito,
Esultino le sponde e suonino le campane!
Ma io con passo dolorante
Passeggio sul ponte, ove giace il mio Capitano
caduto freddo e morto.
Antonio Giangrande. Un capitano necessario. Perché
in Italia non si conosce la verità. Gli italiani si scannano per la politica,
per il calcio, ma non sprecano un minuto per conoscere la verità. Interi
reportage che raccontano l’Italia di oggi “salendo sulla cattedra” come avrebbe
detto il professore Keating dell’attimo fuggente e come ha cercato di fare lo
scrittore avetranese Antonio Giangrande.
Chi sa: scrive, fa, insegna.
Chi non sa: parla e decide.
Chissà perché la tv ed i giornali gossippari e
colpevolisti si tengono lontani da Antonio Giangrande. Da quale pulpito vien la
predica, dott. Antonio Giangrande?
Noi siamo quel che facciamo: quello che diciamo
agli altri è tacciato di mitomania o pazzia. Quello che di noi gli altri dicono
sono parole al vento, perche son denigratorie. Colpire la libertà o l’altrui
reputazione inficia gli affetti e fa morir l’anima.
La calunnia è un venticello
un’auretta assai gentile
che insensibile sottile
leggermente dolcemente
incomincia a sussurrar.
Piano piano terra terra
sotto voce sibillando
va scorrendo, va ronzando,
nelle orecchie della gente
s’introduce destramente,
e le teste ed i cervelli
fa stordire e fa gonfiar.
Dalla bocca fuori uscendo
lo schiamazzo va crescendo:
prende forza a poco a poco,
scorre già di loco in loco,
sembra il tuono, la tempesta
che nel sen della foresta,
va fischiando, brontolando,
e ti fa d’orror gelar.
Alla fin trabocca, e scoppia,
si propaga si raddoppia
e produce un’esplosione
come un colpo di cannone,
un tremuoto, un temporale,
un tumulto generale
che fa l’aria rimbombar.
E il meschino calunniato
avvilito, calpestato
sotto il pubblico flagello
per gran sorte va a crepar.
E’ senza dubbio una delle arie più famose (Atto I)
dell’opera lirica Il Barbiere di Siviglia del 1816 di Gioacchino
Rossini (musica) e di Cesare Sterbini (testo e libretto). E’ l’episodio in cui
Don Basilio, losco maestro di musica di Rosina (protagonista femminile
dell’opera e innamorata del Conte d’Almaviva), suggerisce a Don Bartolo (tutore
innamorato della stessa Rosina) di screditare e di calunniare il Conte,
infamandolo agli occhi dell’opinione pubblica. Il brano “La calunnia è un
venticello…” è assolutamente attuale ed evidenzia molto bene ciò che avviene (si
spera solo a volte) nella quotidianità di tutti noi: politica, lavoro, rapporti
sociali, etc.
Alla fine di noi rimane il nostro operato, checché
gli altri ne dicano. E quello bisogna giudicare. Nasco da una famiglia umile e
povera. Una di quelle famiglie dove la sfortuna è di casa. Non puoi permetterti
di studiare, né avere amici che contano. Per questo il povero è destinato a fare
il manovale o il contadino. Mi sono ribellato e contro la sorte ho voluto
studiare, per salire nel mondo non mio. Per 17 anni ho cercato di abilitarmi
nell’avvocatura. Non mi hanno voluto. Il mondo di sotto mi tiene per i piedi; il
mondo di sopra mi calca la testa. In un esame truccato come truccati sono tutti
i concorsi pubblici in Italia: ti abilitano se non rompi le palle. Tutti uguali
nella mediocrità. Dal 1998 ho partecipato all’esame forense annuale. Sempre
bocciato. Ho rinunciato a proseguire nel 2014 con la commissione presieduta
dall’avv. Francesco De Jaco. L’avvocato di Cosima Serrano condannata con la
figlia Sabrina Misseri per il delitto di Sarah Scazzi avvenuto ad Avetrana.
Tutte mie compaesane. La Commissione d’esame di avvocato di Lecce 2014. La più
serena che io abbia trovato in tutti questi anni. Ho chiesto invano a De Jaco di
tutelare me, dagli abusi in quell’esame, come tutti quelli come me che non hanno
voce. Se per lui Cosima è innocente contro il sentire comune, indotti a pensarla
così dai media e dai magistrati, perché non vale per me la verità che sia
vittima di un sistema che mi vuol punire per essermi ribellato? Si nega
l’evidenza. 1, 2, 3 anni, passi. 17 anni son troppi anche per il più deficiente
dei candidati. Ma gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. Compiti non
corretti, ma ritenuti tali in tempi insufficienti e senza motivazione e con
quote prestabilite di abilitati. Così per me, così per tutti. Gli avvocati
abilitati negano l’evidenza. Logico: chi passa, non controlla. Ma 17 anni son
troppi per credere alla casualità di essere uno sfigato, specialmente perché i
nemici son noti, specie se sono nelle commissioni d’esame. In carcere o
disoccupato. Tu puoi gridare a squarciagola le ingiustizie, ma nessuno ti
ascolta, in un mondo di sordi. Nessuno ti crede. Fino a che non capiti a loro. E
in questa Italia capita, eccome se capita! La tua verità contro la verità del
potere. Un esempio da raccontare. Ai figli non bisogna chiedere cosa vogliono
fare da grandi. Bisogna dir loro la verità. Chiedergli cosa vorrebbero che gli
permettessero di fare da grandi. Sono nato in quelle famiglie che, se ti capita
di incappare nelle maglie della giustizia, la galera te la fai, anche da
innocente. A me non è successo di andare in galera, pur con reiterati tentativi
vani da parte della magistratura di Taranto, ma sin dal caso Tortora ho capito
che in questa Italia in fatto di giustizia qualcosa non va. Pensavo di essere di
sinistra, perché la sinistra è garantismo, ma non mi ritrovo in un’area dove si
tollerano gli abusi dei magistrati per garantirsi potere ed impunità. E di tutto
questo bisogna tacere. A Taranto, tra i tanti processi farsa per tacitarmi sulle
malefatte dei magistrati, uno si è chiuso, con sentenza del Tribunale n.
147/2014, con l’assoluzione perché il fatto non sussiste e per non doversi
procedere. Bene: per lo stesso fatto si è riaperto un nuovo procedimento ed è
stato emesso un decreto penale di condanna con decreto del Gip. n. 1090/2014:
ossia una condanna senza processo. Tentativo stoppato dall’opposizione.
Zittirmi sia mai. Pur isolato e perseguitato. Gli
italiani son questi. Ognuno dia la sua definizione. Certo è che gli italiani non
mi leggono, mi leggono i forestieri. Mi leggeranno i posteri. Tutto regolare: lo
ha detto la tv, lo dicono i giudici. Per me, invece, è tutto un trucco. In un
mondo di ladri nessuno vien da Marte. Tutti uguali: giudicanti e giudicati.
E’ da decenni che studio il sistema Italia, a carattere locale come a livello
nazionale. Da queste indagini ne sono scaturiti decine di saggi, raccolti in una
collana editoriale "L'Italia del Trucco, l'Italia che siamo", letti in tutto il
mondo, ma che mi sono valsi l’ostruzionismo dei media nazionali. Pennivendoli
venduti ai magistrati, all’economia ed alla politica, ma che non impediscono il
fatto che di me si parli su 200.000 siti web, come accertato dai motori di
ricerca. Book ed E-Book che si possono trovare su Amazon.it, Lulu.com.
CreateSpace.com e Google Libri, oltre che in forma di lettura gratuita e free
vision video su
www.controtuttelemafie.it , mentre la promozione
del territorio è su
www.telewebitalia.eu.
Ha la preparazione professionale per poter dire la
sua in questioni di giustizia?
Non sono un giornalista, ma a quanto pare sono
l’unico a raccontare tutti i fatti. Non sono un avvocato ma mi diletto ad
evidenziare le manchevolezze di un sistema giudiziario a se stante. La mia
emigrazione in piena adolescenza in Germania a 16 anni per lavorare; la mia
laurea quadriennale in Giurisprudenza presa in soli due anni all’Università
Statale di Milano, lavorando di notte e con moglie e due figli da mantenere,
dopo aver conseguito il diploma da ragioniere in un solo anno da privatista
presso un Istituto tecnico Statale e non privato, per non sminuirne
l’importanza, portando tutti i 5 anni di corso; tutto ciò mi ha reso immune da
ogni condizionamento culturale od ambientale. I miei 6 anni di esercizio del
patrocinio legale mi hanno fatto conoscere le macagne di un sistema che non è
riuscito a corrompermi. Per questo dal 1998 al 2014 non mi hanno abilitato alla
professione di avvocato in un esame di Stato, che come tutti i concorsi pubblici
ho provato, con le mie ricerche ed i miei libri, essere tutti truccati. Non mi
abilitano. Perché non sono uguale agli altri, non perché son meno capace. Non mi
abilitano perché vedo, sento e parlo. Ecco perché posso parlare di cose
giuridiche in modo di assoluta libertà, senza condizionamento corporativistico,
anche a certezza di ritorsione. E’ tutta questione di coscienza.
E’ TUTTA QUESTIONE DI COSCIENZA.
A’ Cuscienza di Antonio de Curtis-Totò
La coscienza
Volevo sapere che cos'è questa coscienza
che spesso ho sentito nominare.
Voglio esserne a conoscenza,
spiegatemi, che cosa significa.
Ho chiesto ad un professore dell'università
il quale mi ha detto: Figlio mio, questa parola si
usava, si,
ma tanto tempo fa.
Ora la coscienza si è disintegrata,
pochi sono rimasti quelli, che a questa parola
erano attaccati,
vivendo con onore e dignità.
Adesso c'è l'assegno a vuoto, il peculato, la
cambiale, queste cose qua.
Ladri, ce ne sono molti di tutti i tipi, il
piccolo, il grande,
il gigante, quelli che sanno rubare.
Chi li denuncia a questi ?!? Chi si immischia in
questa faccenda ?!?
Sono pezzi grossi, chi te lo fa fare.
L'olio lo fanno con il sapone di piazza, il burro
fa rimettere,
la pasta, il pane, la carne, cose da pazzi, Si è
aumentata la mortalità.
Le medicine poi, hanno ubriacato anche quelle,
se solo compri uno sciroppo, sei fortunato se
continui a vivere.
E che vi posso dire di certe famiglie, che la
pelle fanno accapponare,
mariti, mamme, sorelle, figlie fatemi stare zitto,
non fatemi parlare.
Perciò questo maestro di scuola mi ha detto,
questa conoscenza (della coscienza)
perchè la vuoi fare, nessuno la usa più questa
parola,
adesso arrivi tu e la vuoi ripristinare.
Insomma tu vuoi andare contro corrente, ma questa
pensata chi te l'ha fatta fare,
la gente di adesso solo così è contenta, senza
coscienza,
vuole stentare a vivere. (Vol tirà a campà)
SE NASCI IN ITALIA…
Quando si nasce nel posto sbagliato e si continua
a far finta di niente.
Steve Jobs è cresciuto a Mountain View, nella
contea di Santa Clara, in California. Qui, con il suo amico Steve Wozniak,
fonda la Apple Computer, il primo aprile del 1976. Per finanziarsi, Jobs vende
il suo pulmino Volkswagen, e Wozniak la propria calcolatrice. La prima sede
della nuova società fu il garage dei genitori: qui lavorarono al loro primo
computer, l’Apple I. Ne vendono qualcuno, sulla carta, solo sulla base
dell’idea, ai membri dell’Homebrew Computer Club. Con l’impegno d’acquisto,
ottengono credito dai fornitori e assemblano i computer, che consegnano in
tempo. Successivamente portano l’idea ad un industriale, Mike Markkula, che
versa, senza garanzie, nelle casse della società la somma di 250.000 dollari,
ottenendo in cambio un terzo di Apple. Con quei soldi Jobs e Wozniak lanciano il
prodotto. Le vendite toccano il milione di dollari. Quattro anni dopo, la Apple
si quota in Borsa.
Io sono Antonio Giangrande, noto autore di saggi
pubblicati su Amazon, che raccontano questa Italia alla rovescia. A tal fine tra
le tante opere da me scritte vi è “Italiopolitania. Italiopoli degli italioti”.
Di questo, sicuramente, non gliene fregherà niente a nessuno. Fatto sta che io
non faccio la cronaca, ma di essa faccio storia, perché la quotidianità la
faccio raccontare ai testimoni del loro tempo. Certo che anche di questo non
gliene può fregar di meno a tutti. Ma una storiella raccontata da Antonio Menna
che spiega perché, tu italiano, devi darti alla fuga dall’Italia, bisogna
proprio leggerla. Mettiamo che Steve Jobs sia nato in Italia. Si chiama Stefano
Lavori. Non va all’università, è uno smanettone. Ha un amico che si chiama
Stefano Vozzini. Sono due appassionati di tecnologia, qualcuno li chiama
ricchioni perchè stanno sempre insieme. I due hanno una idea. Un computer
innovativo. Ma non hanno i soldi per comprare i pezzi e assemblarlo. Si mettono
nel garage e pensano a come fare. Stefano Lavori dice: proviamo a venderli senza
averli ancora prodotti. Con quegli ordini compriamo i pezzi. Mettono un
annuncio, attaccano i volantini, cercano acquirenti. Nessuno si fa vivo. Bussano
alle imprese: “volete sperimentare un nuovo computer?”. Qualcuno è interessato:
“portamelo, ti pago a novanta giorni”. “Veramente non ce l’abbiamo ancora,
avremmo bisogno di un vostro ordine scritto”. Gli fanno un ordine su carta non
intestata. Non si può mai sapere. Con quell’ordine, i due vanno a comprare i
pezzi, voglio darli come garanzia per avere credito. I negozianti li buttano
fuori. “Senza soldi non si cantano messe”. Che fare? Vendiamoci il motorino. Con
quei soldi riescono ad assemblare il primo computer, fanno una sola consegna,
guadagnano qualcosa. Ne fanno un altro. La cosa sembra andare. Ma per decollare
ci vuole un capitale maggiore. “Chiediamo un prestito”. Vanno in banca.
“Mandatemi i vostri genitori, non facciamo credito a chi non ha niente”, gli
dice il direttore della filiale. I due tornano nel garage. Come fare? Mentre ci
pensano bussano alla porta. Sono i vigili urbani. “Ci hanno detto che qui state
facendo un’attività commerciale. Possiamo vedere i documenti?”. “Che documenti?
Stiamo solo sperimentando”. “Ci risulta che avete venduto dei computer”. I
vigili sono stati chiamati da un negozio che sta di fronte. I ragazzi non hanno
documenti, il garage non è a norma, non c’è impianto elettrico salvavita, non ci
sono bagni, l’attività non ha partita Iva. Il verbale è salato. Ma se tirano
fuori qualche soldo di mazzetta, si appara tutto. Gli danno il primo guadagno e
apparano. Ma il giorno dopo arriva la Finanza. Devono apparare pure la Finanza.
E poi l’ispettorato del Lavoro. E l’ufficio Igiene. Il gruzzolo iniziale è
volato via. Se ne sono andati i primi guadagni. Intanto l’idea sta lì. I primi
acquirenti chiamano entusiasti, il computer va alla grande. Bisogna farne altri,
a qualunque costo. Ma dove prendere i soldi? Ci sono i fondi europei, gli
incentivi all’autoimpresa. C’è un commercialista che sa fare benissimo queste
pratiche. “State a posto, avete una idea bellissima. Sicuro possiamo avere un
finanziamento a fondo perduto almeno di 100mila euro”. I due ragazzi pensano che
è fatta. “Ma i soldi vi arrivano a rendicontazione, dovete prima sostenere le
spese. Attrezzate il laboratorio, partire con le attività, e poi avrete i
rimborsi. E comunque solo per fare la domanda dobbiamo aprire la partita Iva,
registrare lo statuto dal notaio, aprire le posizioni previdenziali, aprire una
pratica dal fiscalista, i libri contabili da vidimare, un conto corrente
bancario, che a voi non aprono, lo dovete intestare a un vostro genitore.
Mettetelo in società con voi. Poi qualcosa per la pratica, il mio onorario. E
poi ci vuole qualcosa di soldi per oliare il meccanismo alla regione. C’è un
amico a cui dobbiamo fare un regalo sennò il finanziamento ve lo scordate”. “Ma
noi questi soldi non ce li abbiamo”. “Nemmeno qualcosa per la pratica? E dove vi
avviate?”. I due ragazzi decidono di chiedere aiuto ai genitori. Vendono l’altro
motorino, una collezione di fumetti. Mettono insieme qualcosa. Fanno i
documenti, hanno partita iva, posizione Inps, libri contabili, conto corrente
bancario. Sono una società. Hanno costi fissi. Il commercialista da pagare. La
sede sociale è nel garage, non è a norma, se arrivano di nuovo i vigili, o la
finanza, o l’Inps, o l’ispettorato del lavoro, o l’ufficio tecnico del Comune, o
i vigili sanitari, sono altri soldi. Evitano di mettere l’insegna fuori della
porta per non dare nell’occhio. All’interno del garage lavorano duro: assemblano
i computer con pezzi di fortuna, un po’ comprati usati un po’ a credito. Fanno
dieci computer nuovi, riescono a venderli. La cosa sembra poter andare. Ma un
giorno bussano al garage. E’ la camorra. Sappiamo che state guadagnando, dovete
fare un regalo ai ragazzi che stanno in galera. “Come sarebbe?”. “Pagate, è
meglio per voi”. Se pagano, finiscono i soldi e chiudono. Se non pagano, gli
fanno saltare in aria il garage. Se vanno alla polizia e li denunciano, se ne
devono solo andare perchè hanno finito di campare. Se non li denunciano e
scoprono la cosa, vanno in galera pure loro. Pagano. Ma non hanno più i soldi
per continuare le attività. Il finanziamento dalla Regione non arriva, i libri
contabili costano, bisogna versare l’Iva, pagare le tasse su quello che hanno
venduto, il commercialista preme, i pezzi sono finiti, assemblare computer in
questo modo diventa impossibile, il padre di Stefano Lavori lo prende da parte e
gli dice “guagliò, libera questo garage, ci fittiamo i posti auto, che è
meglio”. I due ragazzi si guardano e decidono di chiudere il loro sogno nel
cassetto. Diventano garagisti. La Apple in Italia non sarebbe nata, perchè
saremo pure affamati e folli, ma se nasci nel posto sbagliato rimani con la fame
e la pazzia, e niente più.
AVVOCATI. ABILITATI COL TRUCCO
Facile dire: sono avvocato. In Italia dove impera
la corruzione e la mafiosità, quale costo intrinseco può avere un appalto
truccato, un incarico pubblico taroccato, od una falsificata abilitazione ad una
professione?
Ecco perché dico: italiani, popolo di corrotti!
Ipocriti che si scandalizzano della corruttela altrui.
Io sono Antonio Giangrande, noto autore di saggi
pubblicati su Amazon, che raccontano questa Italia alla rovescia. A tal fine tra
le tante opere da me scritte vi è “Concorsopoli ed esamopoli” che tratta degli
esami e dei concorsi pubblici in generale. Tutti truccati o truccabili. Nessuno
si salva. Inoltre, nel particolare, nel libro “Esame di avvocato, lobby forense,
abilitazione truccata”, racconto, anche per esperienza diretta, quello che
succede all’esame di avvocato. Di questo, sicuramente, non gliene fregherà
niente a nessuno, neanche ai silurati a quest’esame farsa: la fiera delle vanità
fasulle. Fatto sta che io non faccio la cronaca, ma di essa faccio storia,
perché la quotidianità la faccio raccontare ai testimoni del loro tempo. Certo
che anche di questo non gliene può fregar di meno a tutti. Ma la cronistoria di
questi anni la si deve proprio leggere, affinchè, tu italiano che meriti, devi
darti alla fuga dall’Italia, per poter avere una possibilità di successo.
Anche perché i furbetti sanno come cavarsela. Francesco Speroni
principe del foro di Bruxelles.
Il leghista Francesco Speroni, collega di partito dell’ing. Roberto Castelli che
da Ministro della Giustizia ha inventato la pseudo riforma dei compiti
itineranti, a sfregio delle commissioni meridionali, a suo dire troppo
permissive all’accesso della professione forense. È l’ultima roboante voce del
curriculum dell’eurodeputato leghista, nonché suocero del capogruppo alla Camera
Marco Reguzzoni, laureato nel 1999 a
Milano e dopo 12 anni abilitato a Bruxelles. Speroni ha avuto un
problema nel processo di Verona sulle camicie verdi, ma poi si è salvato grazie
all’immunità parlamentare. Anche lui era con Borghezio a sventolare bandiere
verdi e a insultare l’Italia durante il discorso di Ciampi qualche anno fa,
quando gli italiani hanno bocciato, col referendum confermativo, la
controriforma costituzionale della
devolution. E così commentò: “Gli italiani fanno schifo,
l’Italia fa schifo perché non vuole essere moderna!”. Ecco, l’onorevole padano a
maggio 2011 ha ottenuto l’abilitazione alla professione forense in
Belgio (non come il ministro Gelmini che da Brescia ha
scelto Reggio Calabria)
dopo ben 12 anni dalla laurea conseguita a Milano. Speroni dunque potrà
difendere “occasionalmente in tutta Europa” spiega lo stesso neoavvocato
raggiunto telefonicamente da Elisabetta Reguitti de “Il Fatto quotidiano”.
Perché
Bruxelles?
Perché in Italia è molto più difficile mentre in
Belgio l’esame, non dico sia all’acqua di rose, ma insomma è certamente più
facile. Non conosco le statistiche, ma qui le bocciature sono molte meno
rispetto a quelle dell’esame di abilitazione in Italia”.
In quei mesi di tormenti a cavallo tra il 2000 e
il 2001 Mariastelalla Gelmini si trova dunque a scegliere tra fare l’esame a
Brescia o scendere giù in Calabria, spiegherà a Flavia Amabile: «La mia famiglia
non poteva permettersi di mantenermi troppo a lungo agli studi, mio padre era un
agricoltore. Dovevo iniziare a lavorare e quindi dovevo superare l'esame per
ottenere l'abilitazione alla professione». Quindi? «La sensazione era che
esistesse un tetto del 30% che comprendeva i figli di avvocati e altri pochi
fortunati che riuscivano ogni anno a superare l'esame. Per gli altri, nulla.
C'era una logica di casta, per fortuna poi modificata perché il sistema è stato
completamente rivisto». E così, «insieme con altri 30-40 amici molto demotivati
da questa situazione, abbiamo deciso di andare a fare l'esame a Reggio
Calabria». I risultati della sessione del 2000, del resto, erano incoraggianti.
Nonostante lo scoppio dello scandalo, nel capoluogo calabrese c'era stato il
primato italiano di ammessi agli orali: 93,4%. Il triplo che nella Brescia della
Gelmini (31,7) o a Milano (28,1), il quadruplo che ad Ancona. Idonei finali: 87%
degli iscritti iniziali. Contro il 28% di Brescia, il 23,1% di Milano, il 17% di
Firenze. Totale: 806 idonei. Cinque volte e mezzo quelli di Brescia: 144. Quanti
Marche, Umbria, Basilicata, Trentino, Abruzzo, Sardegna e Friuli Venezia Giulia
messi insieme. Insomma, la tentazione era forte. Spiega il ministro
dell'Istruzione: «Molti ragazzi andavano lì e abbiamo deciso di farlo anche
noi». Del resto, aggiunge, lei ha «una lunga consuetudine con il Sud. Una parte
della mia famiglia ha parenti in Cilento». Certo, è a quasi cinquecento
chilometri da Reggio. Ma sempre Mezzogiorno è. E l'esame? Com'è stato l'esame?
«Assolutamente regolare». Non severissimo, diciamo, neppure in quella sessione.
Quasi 57% di ammessi agli orali. Il doppio che a Roma o a Milano. Quasi il
triplo che a Brescia. Dietro soltanto la solita Catanzaro, Caltanissetta,
Salerno. Così facevan tutti, dice Mariastella Gelmini.
La Calabria è bella perchè c’è sempre il sole,
scrive Antonello Caporale su “La Repubblica”. Milano invece spesso è velata
dalla nebbia. E’ bella la Calabria anche, per esempio, perchè il concorso per
l’abilitazione alla professione di avvocato sembra più a misura d’uomo. Non c’è
il caos di Milano, diciamolo. E in una delle dure prove che la vita ci pone
resiste quel minimo di comprensione, quell’alito di compassione… In Calabria
c’è il sole, e l’abbiamo detto. Ma vuoi mettere il mare? ”Avevo bisogno di un
luogo tranquillo, dove poter concentrarmi senza le distrazioni della mia città.
Studiare e affrontare con serenità l’esame”. Ecco, questo bisogno ha portato
Antonino jr. Giovanni Geronimo La Russa, il figlio di Ignazio, anch’egli
avvocato ma soprattutto ministro della Difesa, a trasferirsi dalla Lombardia in
Calabria. Laureato a pieni voti all’università Carlo Cattaneo, Geronimo si è
abilitato con soddisfazione a Catanzaro a soli ventisei anni. Due anni ha
risieduto a Crotone. Dal 25 luglio 2005, in piazza De Gasperi, nella casa di
Pasquale Senatore, l’ex sindaco missino. E’ rimasto nella città di Pitagora
fino al 18 gennaio 2007. E si è rigenerato. Un po’ come capitò a Mariastella
Gelmini, anche lei col bisogno di esercitare al meglio la professione di
avvocato prima di darsi alla politica, e anche lei scesa in Calabria per
affrontare con ottimismo l’esame. La scelta meridionale si è rivelata azzeccata
per lei e per lui. Il piccolo La Russa è tornato in Lombardia con la forza di un
leone. E dopo la pratica nello studio Libonati-Jager, nemmeno trentenne è
divenuto titolare dello studio di famiglia. Quattordici avvocati a corso di
porta Vittoria. Bellissimo. “Ma è tutto merito mio. Mi scoccia di passare per
figlio di papà”. Geronimo è amante delle auto d’epoca, ha partecipato a due
storiche millemiglia. E infatti è anche vicepresidente dell’Aci di Milano. “Sono
stato eletto, e allora?”. Nutre rispetto per il mattone. Siede nel consiglio di
amministrazione della Premafin, holding di Ligresti, anche della Finadin, della
International Strategy. altri gioiellini del del costruttore. Geronimo è
socio dell’immobiliare di famiglia, la Metropol srl. Detiene la nuda proprietà
dei cespiti che per parte di mamma ha nel centro di Riccione. Studioso e s’è
visto. Ricco si è anche capito. Generoso, pure. Promuove infatti insieme a
Barbara Berlusconi, Paolo Ligresti, Giulia Zoppas e tanti altri nomi glamour
Milano Young, onlus benefica. Per tanti cervelli che fuggono all’estero, eccone
uno che resta.
Geronimo, figlio di cotanto padre tutore di lobby
e caste, che sa trovare le soluzioni ai suoi problemi.
Vittoria delle lobby di avvocati e
commercialisti: riforma cancellata, scrive Lucia Palmerini.
“…il governo formulerà alle categorie proposte di riforma.” con
questa frase è stata annullata e cancellata la proposta di abolizione degli
ordini professionali. Il Consiglio Nazionale Forense ha fatto appello ai
deputati-avvocati per modificare la norma del disegno di legge del Ministero
dell’Economia che prevedeva non solo l’eliminazione delle restrizioni
all’accesso, ma la possibilità di diventare avvocato o commercialista dopo un
praticantato di 2 anni nel primo caso e 3 nel secondo, l’abolizione delle
tariffe minime ed il divieto assoluto alla limitazione dello svolgimento della
professione da parte degli ordini. La presa di posizione degli avvocati del PdL
ha rischiato di portare alla bocciatura la manovra economica al cui interno era
inserita la norma su avvocati e commercialisti. Tra questi, Raffaello Masci,
deputato-avvocato che ha preso in mano le redini della protesta, ha ottenuto
l’appoggio del Ministro La Russa e del Presidente del Senato Schifani, tutti
accomunati dalla professione di avvocato. La norma, apparsa per la prima volta
ai primi di giugno, successivamente cancellata e nuovamente inserita nei giorni
scorsi è stata definitivamente cancellata; il nuovo testo quanto mai inutile
recita: “Il governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma
in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche si legge
nel testo, e inoltre – trascorso il termine di 8 mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà
espressamente regolamentato sarà libero.” La situazione non cambia e
l’Ordine degli avvocati può dormire sogni tranquilli. Ancora una volta gli
interessi ed i privilegi di una casta non sono stati minimamente scalfiti o
messi in discussione.
GLI ANNI PASSANO, NULLA CAMBIA ED E’ TUTTO
TEMPO PERSO.
Devo dire, per onestà, che il mio calvario è
iniziato nel momento in cui ho incominciato la mia pratica forense. A tal
proposito, assistendo alle udienze durante la mia pratica assidua e veritiera,
mi accorgevo che il numero dei Praticanti Avvocato presenti in aula non
corrispondeva alla loro reale entità numerica, riportata presso il registro
tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto. Mi accorsi, anche,
che i praticanti, per l’opera prestata a favore del dominus, non ricevevano
remunerazione, o ciò avveniva in nero, né per loro si pagavano i contributi.
Chiesi conto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto. Mi dissero
“Fatti i fatti tuoi. Intanto facci vedere il libretto di pratica, che poi
vediamo se diventi avvocato”. Controllarono il libretto, contestando la
veridicità delle annotazioni e delle firme di controllo. Non basta. Nonostante
il regolare pagamento dei bollettini di versamento di iscrizione, a mio carico
venne attivata procedura di riscossione coattiva con cartella di pagamento,
contro la quale ho presentato opposizione, poi vinta. Di fatto: con lor signori
in Commissione di esame forense, non sono più diventato avvocato. A dar loro
manforte, sempre nelle commissioni d’esame, vi erano e vi sono i magistrati che
io ho denunciato per le loro malefatte.
Sessione d’esame d’avvocato 1998-1999.
Presidente di Commissione, Avv. Antonio De Giorgi, Presidente Consiglio Ordine
degli Avvocati di Lecce. Sono stato bocciato. A Lecce mi accorgo di alcune
anomalie di legalità, tra cui il fatto che 6 Avetranesi su 6 vengono bocciati,
me compreso, e che molti Commissari suggerivano ai candidati incapaci quanto
scrivere nell’elaborato. Chi non suggeriva non impediva che gli altri lo
facessero. Strano era, che compiti simili, copiati pedissequamente, erano
valutati in modo difforme.
Sessione d’esame d’avvocato 1999-2000.
Presidente di Commissione, Avv. Gaetano De Mauro, Principe del Foro di Lecce.
Sono stato bocciato. A Lecce le anomalie aumentano. Sul Quotidiano di Lecce il
Presidente della stessa Commissione d’esame dice che: “il numero degli avvocati
è elevato e questa massa di avvocati è incompatibile con la realtà socio
economica del Salento. Così nasce la concorrenza esasperata”. L’Avv. Pasquale
Corleto nello stesso articolo aggiunge: “non basta studiare e qualificarsi,
bisogna avere la fortuna di entrare in determinati circuiti, che per molti non
sono accessibili”. L’abuso del potere della Lobby forense è confermato
dall’Antitrust, che con provvedimento n. 5400, il 3 ottobre 1997 afferma: “ E'
indubbio che, nel controllo dell'esercizio della professione, si sia pertanto
venuto a determinare uno sbilanciamento tra lo Stato e gli Ordini e che ciò
abbia potuto favorire la difesa di posizioni di rendita acquisite dai
professionisti già presenti sul mercato.”
Sessione d’esame d’avvocato 2000-2001.
Presidente di Commissione, Avv. Antonio De Giorgi, Presidente Consiglio Ordine
degli Avvocati di Lecce. Sono stato bocciato. A Lecce le anomalie aumentano. La
percentuale di idonei si diversifica: 1998, 60 %, 1999, 25 %, 2000, 49 %, 2001,
36 %. Mi accorgo che paga essere candidato proveniente dalla sede di esame,
perché, raffrontando i dati per le province del distretto della Corte D’Appello,
si denota altra anomalia: Lecce, sede d’esame, 187 idonei; Taranto 140 idonei;
Brindisi 59 idonei. Non basta, le percentuali di idonei per ogni Corte D’Appello
nazionale variano dal 10% del Centro-Nord al 99% di Catanzaro. L’esistenza degli
abusi è nel difetto e nell’eccesso della percentuale. Il TAR Lombardia, con
ordinanza n.617/00, applicabile per i compiti corretti da tutte le Commissioni
d’esame, rileva che i compiti non si correggono per mancanza di tempo. Dai
verbali risultano corretti in 3 minuti. Con esperimento giudiziale si accerta
che occorrono 6 minuti solo per leggere l’elaborato. Il TAR di Lecce,
eccezionalmente contro i suoi precedenti, ma conforme a pronunzie di altri TAR,
con ordinanza 1394/00, su ricorso n. 200001275 di Stefania Maritati, decreta la
sospensiva e accerta che i compiti non si correggono, perché sono mancanti di
glosse o correzioni, e le valutazioni sono nulle, perché non motivate. In sede
di esame si disattende la Direttiva CEE 48/89, recepita con D.Lgs.115/92, che
obbliga ad accertare le conoscenze deontologiche e di valutare le attitudini e
le capacità di esercizio della professione del candidato, garantendo così
l'interesse pubblico con equità e giustizia. Stante questo sistema di
favoritismi, la Corte Costituzionale afferma, con sentenza n. 5 del 1999: "Il
legislatore può stabilire che in taluni casi si prescinda dall'esame di Stato,
quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità tecnica e sussistano
apprezzabili ragioni che giustifichino l'eccezione". In quella situazione,
presento denuncia penale contro la Commissione d’esame presso la Procura di Bari
e alla Procura di Lecce, che la invia a Potenza. Inaspettatamente, pur con prove
mastodontiche, le Procure di Potenza e Bari archiviano, senza perseguirmi per
calunnia. Addirittura la Procura di Potenza non si è degnata di sentirmi.
Sessione d’esame d’avvocato 2001-2002.
Presidente di Commissione, Avv. Antonio De Giorgi, Presidente Consiglio Ordine
degli Avvocati di Lecce. Sono stato bocciato. A Lecce le anomalie aumentano.
L’on. Luca Volontè, alla Camera, il 5 luglio 2001, presenta un progetto di
legge, il n. 1202, in cui si dichiara formalmente che in Italia gli esami per
diventare avvocato sono truccati. Secondo la sua relazione diventano avvocati
non i capaci e i meritevoli, ma i raccomandati e i fortunati. Tutto mira alla
limitazione della concorrenza a favore della Lobby. Addirittura c’è chi va in
Spagna per diventare avvocato, per poi esercitare in Italia senza fare l’esame.
A questo punto, presso la Procura di Taranto, presento denuncia penale contro la
Commissione d’esame di Lecce con accluse varie fonti di prova. Così fanno altri
candidati con decine di testimoni a dichiarare che i Commissari suggeriscono.
Tutto lettera morta.
Sessione d’esame d’avvocato 2002-2003.
Presidente di Commissione, Avv. Luigi Rella, Principe del Foro di Lecce.
Ispettore Ministeriale, Giorgino. Sono stato bocciato. A Lecce le anomalie
aumentano. Lo stesso Ministero della Giustizia, che indice gli esami di
Avvocato, mi conferma che in Italia gli esami sono truccati. Non basta, il
Ministro della Giustizia, Roberto Castelli, propone il decreto legge di modifica
degli esami, attuando pedissequamente la volontà del Consiglio Nazionale Forense
che, di fatto, sfiducia le Commissioni d’esame di tutta Italia. Gli Avvocati
dubitano del loro stesso grado di correttezza, probità e legalità. In data
03/05/03, ad Arezzo si riunisce il Consiglio Nazionale Forense con i
rappresentanti dei Consigli dell’Ordine locali e i rappresentanti delle
associazioni Forensi. Decidono di cambiare perché si accorgono che in Italia i
Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati abusano del loro potere per essere
rieletti, chiedendo conto delle raccomandazioni elargite, e da qui la loro
incompatibilità con la qualità di Commissario d’esame. In data 16/05/03, in
Consiglio dei Ministri viene accolta la proposta di Castelli, che adotta la
decisione del Consiglio Nazionale Forense. Ma in quella sede si decide, anche,
di sbugiardare i Magistrati e i Professori Universitari, in qualità di
Commissari d’esame, prevedendo l’incompatibilità della correzione del compito
fatta dalla stessa Commissione d’esame. Con D.L. 112/03 si stabilisce che il
compito verrà corretto da Commissione territorialmente diversa e i Consiglieri
dell’Ordine degli Avvocati non possono essere più Commissari. In Parlamento, in
sede di conversione del D.L., si attua un dibattito acceso, riscontrabile negli
atti parlamentari, dal quale scaturisce l’esistenza di un sistema concorsuale
marcio ed illegale di accesso all’avvocatura. Il D.L. 112/03 è convertito nella
Legge 180/03. I nuovi criteri prevedono l’esclusione punitiva dei Consiglieri
dell’Ordine degli Avvocati dalle Commissioni d’esame e la sfiducia nei
Magistrati e i Professori Universitari per la correzione dei compiti. Però,
acclamata istituzionalmente l’illegalità, si omette di perseguire per abuso
d’ufficio tutti i Commissari d’esame. Non solo. Ad oggi continuano ad essere
Commissari d’esame gli stessi Magistrati e i Professori Universitari, ma è
allucinante che, nelle nuove Commissioni d’esame, fanno parte ex Consiglieri
dell’Ordine degli Avvocati, già collusi in questo stato di cose quando erano in
carica. Se tutto questo non basta a dichiarare truccato l’esame dell’Avvocatura,
il proseguo fa scadere il tutto in una illegale “farsa”. Il Ministero, alla
prova di scritto di diritto penale, alla traccia n. 1, erroneamente chiede ai
candidati cosa succede al Sindaco, che prima nega e poi rilascia una concessione
edilizia ad un suo amico, sotto mentite spoglie di un’ordinanza. In tale sede i
Commissari penalisti impreparati suggerivano in modo sbagliato. Solo io rilevavo
che la traccia era errata, in quanto riferita a sentenze della Cassazione
riconducibili a violazioni di legge non più in vigore. Si palesava l’ignoranza
dell’art.107, D.Lgs. 267/00, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, in
cui si dispongono le funzioni dei dirigenti, e l’ignoranza del D.P.R. 380/01,
Testo Unico in materia edilizia. Da molti anni, con le varie Bassanini, sono
entrate in vigore norme, in cui si prevede che è competente il Dirigente
dell’Ufficio Tecnico del Comune a rilasciare o a negare le concessioni edilizie.
Rilevavo che il Sindaco era incompetente. Rilevavo altresì che il Ministero dava
per scontato il comportamento dei Pubblici Ufficiali omertosi, che lavorando con
il Sindaco e conoscendo i fatti penalmente rilevanti, non li denunciavano alla
Magistratura. Per non aver seguito i loro suggerimenti, i Commissari mi danno 15
(il minimo) al compito esatto, 30 (il massimo) agli altri 2 compiti. I candidati
che hanno scritto i suggerimenti sbagliati, sono divenuti idonei. Durante la
trasmissione “Diritto e Famiglia” di Studio 100, lo stesso Presidente
dell’Ordine di Taranto, Egidio Albanese, ebbe a dire: “l’esame è blando,
l’Avvocatura è un parcheggio per chi vuol far altro, diventa avvocato il
fortunato, perché la fortuna aiuta gli audaci”. Si chiede copia del compito con
la valutazione contestata. Si ottiene, dopo esborso di ingente denaro, per
vederlo immacolato. Non contiene una correzione, né una motivazione alla
valutazione data. Intanto, il Consiglio di Stato, VI sezione, con sentenza
n.2331/03, non giustifica più l’abuso, indicando l’obbligatorietà della
motivazione. Su queste basi di fatto e di diritto si presenta il ricorso al TAR.
Il TAR, mi dice: “ dato che si disconosce il tutto, si rigetta l’istanza di
sospensiva. Su queste basi vuole che si vada nel merito, per poi decidere sulle
spese di giudizio?”
Sessione d’esame d’avvocato 2003-2004.
Presidente di Commissione, Avv. Francesco Galluccio Mezio, Principe del Foro di
Lecce. Sono stato bocciato. A Lecce le anomalie aumentano. I candidati
continuano a copiare dai testi, dai telefonini, dai palmari, dai compiti passati
dai Commissari. I candidati continuano ad essere aiutati dai suggerimenti dei
Commissari. I nomi degli idonei circolano mesi prima dei risultati. I candidati
leccesi, divenuti idonei, come sempre, sono la stragrande maggioranza rispetto
ai brindisini e ai tarantini. Alla richiesta di visionare i compiti, senza
estrarre copia, in segreteria, per ostacolarmi, non gli basta l’istanza orale,
ma mi impongono la tangente della richiesta formale con perdita di tempo e
onerose spese accessorie. Arrivano a minacciare la chiamata dei Carabinieri se
non si fa come impongono loro, o si va via. Le anomalie di regolarità del
Concorso Forense, avendo carattere generale, sono state oggetto della denuncia
formale presentata presso le Procure Antimafia e presso tutti i Procuratori
Generali delle Corti d’Appello e tutti i Procuratori Capo della Repubblica
presso i Tribunali di tutta Italia. Si presenta l’esposto al Presidente del
Consiglio e al Ministro della Giustizia, al Presidente della Commissione
Parlamentare Antimafia e Giustizia del Senato. La Gazzetta del Mezzogiorno, in
data 25/05/04, pubblica la notizia che altri esposti sono stati presentati
contro la Commissione d’esame di Lecce (vedi Michele D’Eredità). Tutto lettera
morta.
Sessione d’esame d’avvocato 2004-2005.
Tutto come prima. Presidente di Commissione, Avv. Marcello Marcuccio, Principe
del Foro di Lecce. Sono stato bocciato. Durante le prove d’esame ci sono gli
stessi suggerimenti e le stesse copiature. I pareri motivati della prova scritta
avvenuta presso una Commissione d’esame vengono corretti da altre Commissioni.
Quelli di Lecce sono corretti dalla Commissione d’esame di Torino, che da anni
attua un maggiore sbarramento d’idoneità. Ergo: i candidati sanno in anticipo
che saranno bocciati in numero maggiore a causa dell’illegale limitazione della
concorrenza professionale. Presento l’ennesima denuncia presso la Procura di
Potenza, la Procura di Bari, la Procura di Torino e la Procura di Milano, e
presso i Procuratori Generali e Procuratori Capo di Lecce, Bari, Potenza e
Taranto, perché tra le altre cose, mi accorgo che tutti i candidati provenienti
da paesi amministrati da una parte politica, o aventi Parlamentari dello stesso
colore, sono idonei in percentuale molto maggiore. Tutto lettera morta.
Sessione d’esame d’avvocato 2005-2006.
Tutto come prima. Presidente di Commissione, Avv. Raffaele Dell’Anna. Principe
del Foro di Lecce. Sono stato bocciato. Addirittura i Commissari dettavano gli
elaborati ai candidati. Gente che copiava dai testi. Gente che copiava dai
palmari. Le valutazioni delle 7 Sottocommissioni veneziane non sono state
omogenee, se non addirittura contrastanti nei giudizi. Il Tar di Salerno,
Ordinanza n.1474/2006, conforme al Tar di Lecce, Milano e Firenze, dice che
l’esame forense è truccato. I Tar stabiliscono che i compiti non sono corretti
perché non vi è stato tempo sufficiente, perché non vi sono correzioni, perché
mancano le motivazioni ai giudizi, perché i giudizi sono contrastanti, anche in
presenza di compiti copiati e non annullati. Si è presentata l’ulteriore
denuncia a Trento e a Potenza. Tutto lettera morta.
Sessione d’esame d’avvocato 2006-2007.
Tutto come prima. Presidente di Commissione, Avv. Giangaetano Caiaffa. Principe
del Foro di Lecce. Presente l’Ispettore Ministeriale Vito Nanna. I posti a
sedere, negli anni precedenti assegnati in ordine alfabetico, in tale sessione
non lo sono più, tant’è che si sono predisposti illecitamente gruppi di ricerca
collettiva. Nei giorni 12,13,14 dicembre, a dispetto dell’orario di convocazione
delle ore 07.30, si sono letti i compiti rispettivamente alle ore 11.45, 10.45,
11.10. Molte ore dopo rispetto alle ore 09.00 delle altre Commissioni d’esame.
Troppo tardi, giusto per agevolare la dettatura dei compiti tramite cellulari,
in virtù della conoscenza sul web delle risposte ai quesiti posti. Commissione
di correzione degli scritti è Palermo. Per ritorsione conseguente alle mie lotte
contro i concorsi forensi truccati e lo sfruttamento dei praticanti, con
omissione di retribuzione ed evasione fiscale e contributiva, dopo 9 anni di
bocciature ritorsive all’esame forense e ottimi pareri resi, quest’anno mi danno
15, 15, 18 per i rispettivi elaborati, senza correzioni e motivazioni: è il
minimo. Da dare solo a compiti nulli. La maggior parte degli idonei è leccese,
in concomitanza con le elezioni amministrative, rispetto ai tarantini ed ai
brindisini. Tramite le televisioni e i media nazionali si promuove un ricorso
collettivo da presentare ai Tar di tutta Italia contro la oggettiva invalidità
del sistema giudiziale rispetto alla totalità degli elaborati nel loro
complesso: per mancanza, nelle Sottocommissioni di esame, di tutte le componenti
professionali necessarie e, addirittura, del Presidente nominato dal Ministero
della Giustizia; per giudizio con motivazione mancante, o illogica rispetto al
quesito, o infondata per mancanza di glosse o correzioni, o incomprensibile al
fine del rimedio alla reiterazione degli errori; giudizio contrastante a quello
reso per elaborati simili; giudizio non conforme ai principi di correzione;
giudizio eccessivamente severo; tempo di correzione insufficiente. Si presenta
esposto penale contro le commissioni di Palermo, Lecce, Bari, Venezia, presso
le Procure di Taranto, Lecce, Potenza, Palermo, Caltanissetta, Bari, Venezia,
Trento. Il Pubblico Ministero di Palermo archivia immediatamente, iscrivendo il
procedimento a carico di ignoti, pur essendoci chiaramente indicati i 5 nomi dei
Commissari d’esame denunciati. I candidati di Lecce disertano in modo assoluto
l’iniziativa del ricorso al Tar. Al contrario, in altre Corti di Appello vi è
stata ampia adesione, che ha portato a verificare, comparando, modi e tempi del
sistema di correzione. Il tutto a confermare le illegalità perpetrate, che
rimangono impunite.
Sessione d’esame d’avvocato 2007-2008.
Tutto come prima. Presidente di Commissione Avv. Massimo Fasano, Principe del
Foro di Lecce. Addirittura uno scandalo nazionale ha sconvolto le prove scritte:
le tracce degli elaborati erano sul web giorni prima rispetto alla loro lettura
in sede di esame. Le risposte erano dettate da amici e parenti sul cellulare e
sui palmari dei candidati. Circostanza da sempre esistita e denunciata dal
sottoscritto nell’indifferenza generale. Questa volta non sono solo. Anche il
Sottosegretario del Ministero dell’Interno, On. Alfredo Mantovano, ha presentato
denuncia penale e una interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia,
chiedendo la nullità della prova, così come è successo per fatto analogo a Bari,
per i test di accesso alla Facoltà di Medicina. Anche per lui stesso risultato:
insabbiamento dell’inchiesta.
Sessione d’esame d’avvocato 2008-2009.
Tutto come prima. Presidente di Commissione Avv. Pietro Nicolardi, Principe del
Foro di Lecce. E’ la undicesima volta che mi presento a rendere dei pareri
legali. Pareri legali dettati ai candidati dagli stessi commissari o dai
genitori sui palmari. Pareri resi su tracce già conosciute perché pubblicate su
internet o perché le buste sono aperte ore dopo rispetto ad altre sedi, dando il
tempo ai candidati di farsi passare il parere sui cellulari. Pareri di 5 o 6
pagine non letti e corretti, ma dichiarati tali in soli 3 minuti, nonostante vi
fosse l’onere dell’apertura di 2 buste, della lettura, della correzione, del
giudizio, della motivazione e della verbalizzazione. Il tutto fatto da
commissioni illegittime, perché mancanti dei componenti necessari e da giudizi
nulli, perché mancanti di glosse, correzioni e motivazioni. Il tutto fatto da
commissioni che limitano l’accesso e da commissari abilitati alla professione
con lo stesso sistema truccato. Da quanto emerge dal sistema concorsuale
forense, vi è una certa similitudine con il sistema concorsuale notarile e
quello giudiziario e quello accademico, così come le cronache del 2008 ci hanno
informato. Certo è che se nulla hanno smosso le denunce del Ministro
dell’Istruzione, Gelmini, lei di Brescia costretta a fare gli esami a Reggio
Calabria, e del Sottosegretario al Ministero degli Interni, Mantovano, le
denunce insabbiate dal sottoscritto contro i concorsi truccati, mi porteranno,
per ritorsione, ad affrontare l’anno prossimo per la dodicesima volta l’esame
forense, questa volta con mio figlio Mirko. Dopo essere stato bocciato allo
scritto dell’esame forense per ben 11 volte, che ha causato la mia indigenza ho
provato a visionare i compiti, per sapere quanto fossi inetto. Con mia
meraviglia ho scoperto che il marcio non era in me. La commissione esaminatrice
di Reggio Calabria era nulla, in quanto mancante di una componente necessaria.
Erano 4 avvocati e un magistrato. Mancava la figura del professore
universitario. Inoltre i 3 temi, perfetti in ortografia, sintassi e grammatica,
risultavano visionati e corretti in soli 5 minuti, compresi i periodi di
apertura di 6 buste e il tempo della consultazione, valutazione ed estensione
del giudizio. Tempo ritenuto insufficiente da molti Tar. Per questi motivi,
senza entrare nelle tante eccezioni da contestare nel giudizio, compresa la
comparazione di compiti identici, valutati in modo difforme, si appalesava la
nullità assoluta della decisione della commissione, già acclarata da precedenti
giurisprudenziali. Per farmi patrocinare, ho provato a rivolgermi ad un principe
del foro amministrativo di Lecce. Dal noto esponente politico non ho meritato
risposta. Si è di sinistra solo se si deve avere, mai se si deve dare. L’istanza
di accesso al gratuito patrocinio presentata personalmente, dopo settimane,
viene rigettata. Per la Commissione di Lecce c’è indigenza, ma non c’è motivo
per il ricorso!!! Nel processo amministrativo si rigettano le istanze di
ammissione al gratuito patrocinio per il ricorso al Tar per mancanza di “fumus”:
la commissione formata ai sensi della finanziaria 2007 (Governo Prodi) da 2
magistrati del Tar e da un avvocato, entra nel merito, adottando una sentenza
preventiva senza contraddittorio, riservandosi termini che rasentano la
decadenza per il ricorso al Tar.
Sessione d’esame d’avvocato 2009-2010.
Tutto come prima. Presidente di Commissione Avv. Angelo Pallara, Principe del
Foro di Lecce. Nella sua sessione, nonostante i candidati fossero meno della
metà degli altri anni, non ci fu notifica postale dell’ammissione agli esami. E’
la dodicesima volta che mi presento. Questa volta con mio figlio Mirko.
Quantunque nelle sessioni precedenti i miei compiti non fossero stati corretti e
comunque giudicate da commissioni illegittime, contro le quali mi è stato
impedito il ricorso al Tar. Le mie denunce penali presentate a Lecce, Potenza,
Catanzaro, Reggio Calabria, e i miei esposti ministeriali: tutto lettera morta.
Alle mie sollecitazioni il Governo mi ha risposto: hai ragione, provvederemo. Il
provvedimento non è mai arrivato. Intanto il Ministro della Giustizia nomina
ispettore ministeriale nazionale per questa sessione, come negli anni
precedenti, l’avv. Antonio De Giorgi, già Presidente di commissione di esame di
Lecce, per gli anni 1998-99, 2000-01, 2001-02, e ricoprente l’incarico di
presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce. Insomma è tutta
una presa in giro: costui con la riforma del 2003 è incompatibile a ricoprire
l’incarico di presidente di sottocommissione, mentre, addirittura, viene
nominato ispettore su un concorso che, quando lui era presidente, veniva
considerato irregolare. Comunque è di Avetrana (TA) l’avvocato più giovane
d’Italia. Il primato è stabilito sul regime dell’obbligo della doppia laurea. 25
anni. Mirko Giangrande, classe 1985. Carriera scolastica iniziata direttamente
con la seconda elementare; con voto 10 a tutte le materie al quarto superiore
salta il quinto ed affronta direttamente la maturità. Carriera universitaria nei
tempi regolamentari: 3 anni per la laurea in scienze giuridiche; 2 anni per la
laurea magistrale in giurisprudenza. Praticantato di due anni e superamento
dell’esame scritto ed orale di abilitazione al primo colpo, senza l’ausilio
degli inutili ed onerosi corsi pre esame organizzati dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati. Et Voilà, l’avvocato più giovane d’Italia. Cosa straordinaria:
non tanto per la giovane età, ma per il fatto che sia avvenuta contro ogni
previsione, tenuto conto che Mirko è figlio di Antonio Giangrande, noto
antagonista della lobby forense e della casta giudiziaria ed accademica. Ma
nulla si può contro gli abusi e le ritorsioni, nonostante che ogni anno in sede
di esame tutti coloro che gli siedono vicino si abilitano con i suoi
suggerimenti. Volontariato da educatore presso l’oratorio della parrocchia di
Avetrana, e volontariato da assistente e consulente legale presso l’Associazione
Contro Tutte le Mafie, con sede nazionale proprio ad Avetrana, fanno di Mirko
Giangrande un esempio per tanti giovani, non solo avetranesi. Questo
giustappunto per evidenziare una notizia positiva attinente Avetrana, in
alternativa a quelle sottaciute ed alle tante negative collegate al caso di
Sarah Scazzi. L’iscrizione all’Albo compiuta a novembre nonostante
l’abilitazione sia avvenuta a settembre, alla cui domanda con allegati l’ufficio
non rilascia mai ricevuta, è costata in tutto la bellezza di 650 euro tra
versamenti e bolli. Ingenti spese ingiustificate a favore di caste-azienda, a
cui non corrispondono degni ed utili servizi alle migliaia di iscritti.
Oltretutto oneri non indifferenti per tutti i neo avvocati, che non hanno mai
lavorato e hanno sopportato con sacrifici e privazioni ingenti spese per anni di
studio. Consiglio dell’Ordine di Taranto che, come riportato dalla stampa sul
caso Sarah Scazzi, apre un procedimento contro i suoi iscritti per
sovraesposizione mediatica, accaparramento illecito di cliente e compravendita
di atti ed interviste (Galoppa, Russo e Velletri) e nulla dice, invece, contro
chi, avvocati e consulenti, si è macchiato delle stesse violazioni, ma che,
venuto da lontano, pensa che Taranto e provincia sia terra di conquista
professionale e tutto possa essere permesso. Figlio di famiglia indigente ed
oppressa: il padre, Antonio Giangrande, perseguitato (abilitazione forense
impedita da 12 anni; processi, senza condanna, di diffamazione a mezzo stampa
per articoli mai scritti e di calunnia per denunce mai presentate in quanto
proprio le denunce presentate sono regolarmente insabbiate; dibattimenti in cui
il giudice è sempre ricusato per grave inimicizia perché denunciato).
Perseguitato perché noto antagonista del sistema giudiziario e forense
tarantino, in quanto combatte e rende note le ingiustizie e gli abusi in quel
che viene definito “Il Foro dell’Ingiustizia”. (insabbiamenti; errori giudiziari
noti: Morrone, Pedone, Sebai; magistrati inquisiti e arrestati). Perseguitato
perché scrive e dice tutto quello che si tace.
Sessione d’esame d’avvocato 2010-2011.
Tutto come prima. Presidente di Commissione, Avv. Maurizio Villani, Principe del
Foro di Lecce. Compresa la transumanza di candidati da un'aula all'altra per
fare gruppo. Presente anche il Presidente della Commissione Centrale Avv.
Antonio De Giorgi, contestualmente componente del Consiglio Nazionale Forense,
in rappresentanza istituzionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del
distretto della Corte di Appello di Lecce. Tutto verificabile dai siti web di
riferimento. Dubbi e critica sui modi inopportuni di nomina. Testo del
Decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina
degli esami di abilitazione alla professione forense, è convertito in legge con
le modificazioni coordinate con la legge di conversione 18 Luglio 2003, n. 180:
“Art. 1-bis: ….5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per
ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti
avvocati. I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in
sostituzione di qualsiasi membro effettivo. 6. Gli avvocati componenti della
commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale
forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto,
assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno
un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere
designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine…”. Antonio De
Giorgi è un simbolo del vecchio sistema ante riforma, ampiamente criticato tanto
da riformarlo a causa della “Mala Gestio” dei Consiglieri dell’Ordine in ambito
della loro attività come Commissari d’esame. Infatti Antonio De Giorgi è stato a
fasi alterne fino al 2003 Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Lecce e contestualmente Presidente di sottocommissioni di esame di quel
Distretto. Oggi ci ritroviamo ancora Antonio De Giorgi, non più come Presidente
di sottocommissione, ma addirittura come presidente della Commissione centrale.
La norma prevede, come membro di commissione e sottocommissione, la nomina di
avvocati, ma non di consiglieri dell’Ordine. Come intendere la carica di
consigliere nazionale forense indicato dal Consiglio dell’Ordine di Lecce, se
non la sua estensione istituzionale e, quindi, la sua incompatibilità alla
nomina di Commissario d’esame. E quantunque ciò non sia vietato dalla legge, per
la ratio della norma e per il buon senso sembra inopportuno che, come presidente
di Commissione centrale e/o sottocommissione periferica d’esame, sia nominato
dal Ministro della Giustizia non un avvocato designato dal Consiglio Nazionale
Forense su proposta dei Consigli dell'Ordine, ma addirittura un membro dello
stesso Consiglio Nazionale Forense che li designa. Come è inopportuno che sia
nominato chi sia l’espressione del Consiglio di appartenenza e comunque che sia
l’eredità di un sistema osteggiato. Insomma, qui ci stanno prendendo in giro: si
esce dalla porta e si entra dalla finestra. Cosa può pensare un candidato che si
sente dire dai presidenti Villani e De Giorgi, siamo 240 mila e ci sono
quest’anno 23 mila domande, quindi ci dobbiamo regolare? Cosa può pensare
Antonio Giangrande, il quale ha denunciato negli anni le sottocommissioni
comprese quelle presiedute da Antonio De Giorgi (sottocommissioni a cui ha
partecipato come candidato per ben 13 anni e che lo hanno bocciato in modo
strumentale), e poi si accorge che il De Giorgi, dopo la riforma è stato
designato ispettore ministeriale, e poi, addirittura, è diventato presidente
della Commissione centrale? Cosa può pensare Antonio Giangrande, quando verifica
che Antonio De Giorgi, presidente anche delle sottocommissioni denunciate,
successivamente ha avuto rapporti istituzionali con tutte le commissioni d’esame
sorteggiate, competenti a correggere i compiti di Lecce e quindi anche del
Giangrande? "A pensare male, spesso si azzecca..." disse Giulio Andreotti. Nel
procedimento 1240/2011, in cui si sono presentati ben 8 motivi di nullità dei
giudizi (come in allegato), il TAR rigetta il ricorso del presente istante,
riferendosi alla sentenza della Corte Costituzionale, oltre ad addurre,
pretestuosamente, motivazioni estranee ai punti contestati (come si riscontra
nella comparazione tra le conclusioni e il dispositivo in allegato). Lo stesso
TAR, invece, ha disposto la misura cautelare per un ricorso di altro candidato
che contestava un solo motivo, (procedimento 746/2009). Addirittura con
ordinanza 990/2010 accoglieva l’istanza cautelare entrando nel merito
dell’elaborato. Ordinanza annullata dal Consiglio di Stato, sez. IV, 22 febbraio
2011, n. 595. TENUTO CONTO CHE IN ITALIA NON VI E' GIUSTIZIA SI E' PRESENTATO
RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI. Qui si rileva che la Corte di
Cassazione, nonostante la fondatezza della pretesa, non ha disposto per motivi
di Giustizia e di opportunità la rimessione dei processi dell’istante ai sensi
dell’art. 45 ss. c.p.p.. Altresì qui si rileva che la Corte di Cassazione,
sistematicamente, rigetta ogni istanza di rimessione da chiunque sia presentata
e qualunque ne sia la motivazione. Inoltre qui si rileva che la Corte
Costituzionale legittima per tutti i concorsi pubblici la violazione del
principio della trasparenza. Trasparenza, da cui dedurre l’inosservanza delle
norme sulla legalità, imparzialità ed efficienza.
Sessione d’esame d’avvocato 2011-2012.
Tutto come prima. Spero che sia l'ultima volta. Presidente di Commissione, Avv.
Nicola Stefanizzo, Principe del Foro di Lecce. Foro competente alla correzione:
Salerno. Dal sito web della Corte d’Appello di Lecce si vengono a sapere le
statistiche dell'anno 2011: Totale Candidati iscritti 1277 di cui Maschi 533
Femmine 744. Invece le statistiche dell'anno 2010: Totale Candidati inscritti
1161 di cui Maschi 471 Femmine 690. Ammessi all'orale 304; non Ammessi dalla
Commissione di Palermo 857 (74%). Si è presentata denuncia penale a tutte le
procure presso le Corti d'Appello contro le anomalie di nomina della Commissione
centrale d'esame, oltre che contro la Commissione di Palermo, in quanto questa
ha dichiarato falsamente come corretti i compiti del Dr Antonio Giangrande,
dando un 25 senza motivazione agli elaborati non corretti. Contestualmente si è
denunciato il Tar di Lecce che ha rigettato il ricorso indicanti molteplici
punti di nullità al giudizio dato ai medesimi compiti. Oltretutto motivi
sostenuti da corposa giurisprudenza. Invece lo stesso Tar ha ritenuto
ammissibili le istanze di altri ricorsi analoghi, per giunta valutando il merito
degli stessi elaborati. Antonio Giangrande, l’alfiere contro i concorsi
truccati, che per gli ipocriti è un mitomane sfigato, presenta il conto. Anzi il
rendiconto di un'Italia da schifo dove tutti si ergono a benpensanti e poi sono
i primi a fottere la legge ed i loro conterranei. Un giudizio sull’operato di un
certo giornalismo lo debbo proprio dare, tenuto conto che è noto il mio giudizio
su un sistema di potere che tutela se stesso, indifferente ai cambiamenti
sociali ed insofferente nei confronti di chi si ribella. Da anni sui miei siti
web fornisco le prove su come si trucca un concorso pubblico, nella fattispecie
quello di avvocato, e su come si paga dazio nel dimostrarlo. Nel tempo la
tecnica truffaldina, di un concorso basato su regole di un millennio fa, si è
affinata trovando sponda istituzionale. La Corte Costituzionale il 7 giugno
2011, con sentenza n. 175, dice: è ammesso il giudizio non motivato, basta il
voto. Alla faccia della trasparenza e del buon andamento e della legalità.
Insomma dove prima era possibile contestare ora non lo è più. D'altronde la
Cassazione ammette: le commissioni sbagliano ed il Tar può sindacare i loro
giudizi. Ad affermare l’importante principio di diritto sono le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione con sentenza n. 8412, depositata il 28 maggio 2012.
L’essere omertosi sulla cooptazione abilitativa di una professione od incarico,
mafiosamente conforme al sistema, significa essere complici e quindi poco
credibili agli occhi dei lettori e telespettatori, che, come dalla politica, si
allontana sempre più da un certo modo di fare informazione. Il fatto che io non
trovi solidarietà e sostegno in chi dovrebbe raccontare i fatti, mi lascia
indifferente, ma non silente sul malaffare che si perpetra intorno a me ed è
taciuto da chi dovrebbe raccontarlo. Premiale è il fatto che i miei scritti sono
letti in tutto il mondo, così come i miei video, in centinaia di migliaia di
volte al dì, a differenza di chi e censorio. Per questo è ignorato dal cittadino
che ormai, in video o in testi, non trova nei suoi servizi giornalistici la
verità, se non quella prona al potere. Dopo 15 anni, dal 1998 ancora una volta
bocciato all’esame di avvocato ed ancora una volta a voler trovare sponda per
denunciare una persecuzione. Non perché voglia solo denunciare l’esame truccato
per l’abilitazione in avvocatura, di cui sono vittima, ma perché lo stesso esame
sia uguale a quello della magistratura (con i codici commentati vietati, ma
permessi ad alcuni), del notariato (tracce già svolte), dell’insegnamento
accademico (cattedra da padre in figlio) e di tanti grandi e piccoli concorsi
nazionali o locali. Tutti concorsi taroccati, così raccontati dalla cronaca
divenuta storia. Per ultimo si è parlato del concorso dell’Agenzia delle Entrate
(inizio dell’esame con ore di ritardo e con il compito già svolto) e del
concorso dell’Avvocatura dello Stato (con i codici commentati vietati, ma
permessi ad alcuni). A quest’ultimi candidati è andata anche peggio rispetto a
me: violenza delle Forze dell’Ordine sui candidati che denunciavano l’imbroglio.
Non che sia utile trovare una sponda che denunci quanto io sostengo con prove,
tanto i miei rumors fanno boato a sè, ma si appalesa il fatto che vi è una certa
disaffezione per quelle categorie che giornalmente ci offrono con la cronaca il
peggio di sé: censura ed omertà. Per qualcuno forse è meglio che a me non sia
permesso di diventare avvocato a cause delle mie denunce presentate a chi,
magistrato, oltre che omissivo ad intervenire, è attivo nel procrastinare i
concorsi truccati in qualità di commissari. Sia chiaro a tutti: essere uno dei
10mila magistrati, uno dei 200mila avvocati, uno dei mille parlamentari, uno dei
tanti professori o giornalisti, non mi interessa più, per quello che è il loro
valore reale, ma continuerò a partecipare al concorso forense per dimostrare
dall’interno quanto sia insano. Chi mi vuol male, per ritorsione alle mie lotte,
non mi fa diventare avvocato, ma vorrebbe portarmi all’insana esasperazione di
Giovanni Vantaggiato, autore della bomba a Brindisi. Invece, questi mi hanno
fatto diventare l’Antonio Giangrande: fiero di essere diverso! Antonio
Giangrande che con le sue deflagrazioni di verità, rompe l’omertà mafiosa.
L’appoggio per una denuncia pubblica non lo chiedo per me, che non ne ho
bisogno, ma una certa corrente di pensiero bisogna pur attivarla, affinché
l’esasperazione della gente non travolga i giornalisti, come sedicenti operatori
dell’informazione, così come già avvenuto in altri campi. E gli operatori
dell’informazione se non se ne sono accorti, i ragazzi di Brindisi sono stati lì
a ricordarglielo. Si è visto la mafia dove non c’è e non la si indica dove è
chiaro che si annida. Tutti gli altri intendono “Tutte le Mafie” come un
insieme orizzontale di entità patologiche criminali territoriali (Cosa Nostra,
‘Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita, ecc.). Io intendo “Tutte le Mafie”
come un ordinamento criminale verticale di entità fisiologiche nazionali
composte, partendo dal basso: dalle mafie (la manovalanza), dalle Lobbies, dalle
Caste e dalle Massonerie (le menti). La Legalità è il comportamento umano
conforme al dettato della legge nel compimento di un atto o di un fatto. Se
l'abito non fa il monaco, e la cronaca ce lo insegna, nè toghe, nè divise, nè
poteri istituzionali o mediatici hanno la legittimazione a dare insegnamenti e/o
patenti di legalità. Lor signori non si devono permettere di selezionare secondo
loro discrezione la società civile in buoni e cattivi ed ovviamente si devono
astenere dall'inserirsi loro stessi tra i buoni. Perchè secondo questa cernita
il cattivo è sempre il povero cittadino, che oltretutto con le esose tasse li
mantiene. Non dimentichiamoci che non ci sono dio in terra e fino a quando
saremo in democrazia, il potere è solo prerogativa del popolo. Quindi abolizione
dei concorsi truccati e liberalizzazione delle professioni. Che sia il libero
mercato a decidere chi merita di esercitare la professione in base alle capacità
e non in virtù della paternità o delle amicizie. Un modo per poter vincere la
nostra battaglia ed abolire ogni esame truccato di abilitazione, c'è! Essere in
tanti a testimoniare il proprio dissenso. Ognuno di noi, facente parte dei
perdenti, inviti altri ad aderire ad un movimento di protesta, affinchè possiamo
essere migliaia e contare politicamente per affermare la nostra idea.
Generalmente si è depressi e poco coraggiosi nell'affrontare l'esito negativo di
un concorso pubblico. Se già sappiamo che è truccato, vuol dire che la
bocciatura non è a noi addebitale. Cambiamo le cose, aggreghiamoci, contiamoci
attraverso facebook. Se siamo in tanti saremo appetibili e qualcuno ci
rappresenterà in Parlamento. Altrimenti ci rappresenteremo da soli. Facciamo
diventare questo dissenso forte di migliaia di adesioni. Poi faremo dei convegni
e poi delle manifestazioni. L'importante far sapere che il candidato perdente
non sarà mai solo e potremo aspirare ad avere una nuova classe dirigente capace
e competente.
Sessione d’esame d’avvocato 2012-2013.
Tutto come prima. Presidente di Commissione, Avv. Francesco Flascassovitti,
Principe del Foro di Lecce, il quale ha evitato la transumanza di candidati da
un'aula all'altra per fare gruppo con una semplice soluzione: il posto
assegnato. Ma ciò non ha evitato l’espulsione di chi è stato scoperto a copiare
da fonti non autorizzate o da compiti stilati forse da qualche commissario,
oppure smascherato perché scriveva il tema sotto dettatura da cellulare munito
di auricolare. Peccato per loro che si son fatti beccare. Tutti copiavano, così
come hanno fatto al loro esame gli stessi commissari che li hanno cacciati. Ed è
inutile ogni tentativo di apparir puliti. Quattromila aspiranti avvocati si sono
presentati alla Nuova Fiera di Roma per le prove scritte dell'esame di
abilitazione forense 2012. I candidati si sono presentati all'ingresso del
secondo padiglione della Fiera sin dalle prime ore del mattino, perchè a Roma
c'è l'obbligo di consegnare i testi il giorno prima, per consentire alla
commissione di controllare che nessuno nasconda appunti all'interno. A Lecce
sono 1.341 i giovani (e non più giovani come me) laureati in Giurisprudenza.
Foro competente alla correzione: Catania. Un esame di Stato che è diventato un
concorso pubblico, dove chi vince, vince un bel niente. Intanto il mio ricorso,
n. 1240/2011 presentato al Tar di Lecce il 25 luglio 2011 contro la valutazione
insufficiente data alle prove scritte della sessione del 2010 adducente
innumerevoli nullità, contenente, altresì, domanda di fissazione dell’udienza di
trattazione, non ha prodotto alcun giudizio, tanto da farmi partecipare, nelle
more ed in pendenza dell’esito del ricorso, a ben altre due sessioni successive,
il cui esito è identico ai 15 anni precedenti: compiti puliti e senza
motivazione, voti identici e procedura di correzione nulla in più punti. Per
l’inerzia del Tar è stati costretti di presentare istanza di prelievo il
09/07/2012. Dall’udienza fissata e tenuta del 7 novembre 2012 non vi è stata
alcuna notizia dell’esito dell’istanza, nonostante altri ricorsi analoghi
presentati un anno dopo hanno avuto celere ed immediato esito positivo di
accoglimento. Ormai l’esame lo si affronta non tanto per superarlo, in quanto
dopo 15 anni non vi è più soddisfazione, dopo una vita rovinata non dai singoli
commissari, avvocati o magistrati o professori universitari, che magari sono
anche ignari su come funziona il sistema, ma dopo una vita rovinata da un intero
sistema mafioso, che si dipinge invece, falsamente, probo e corretto, ma lo si
affronta per rendere una testimonianza ai posteri ed al mondo. Per raccontare,
insomma, una realtà sottaciuta ed impunita. A Lecce sarebbero solo 440 su 1258 i
compiti ritenuti validi. Questo il responso della Commissione di Catania,
presieduta dall’Avvocato Antonio Vitale, addetta alla correzione degli
elaborati. Più di cento scritti finiscono sul tavolo della Procura della
Repubblica con l’accusa di plagio, per poi, magari, scoprire che è tutta una
bufala. Copioni a parte, sarebbe, comunque, il 65% a non superare l’esame:
troppi per definirli asini, tenuto conto che, per esperienza personale, so che
alla fase di correzione non si dedicano oltre i 5 minuti, rispetto ai 15/20
minuti occorrenti. Troppo pochi per esprimere giudizi fondati. Da 20 anni
denuncio che in Italia agli esami tutti si copia ed adesso scoprono l’acqua
calda. E copiano tutti. Si ricordi il “Vergogna, Vergogna” all’esame per
magistrato o il “Buffoni, Buffoni” all’esame di notaio, o le intemperanze agli
esami per l’avvocatura di Stato o la prova annullata per l’esame di notaio nel
2010 o di magistrato nel 1992. Sarebbe il colmo dei paradossi se tra quei 100 ci
fosse il mio nome. A parlar di sé e delle proprie disgrazie in prima persona,
oltre a non destare l’interesse di alcuno pur nelle tue stesse condizioni, può
farti passare per mitomane o pazzo. Non sto qui a promuovermi, tanto chi mi
conosce sa cosa faccio anche per l’Italia e per la sua città. Non si può, però,
tacere la verità storica che ci circonda, stravolta da verità menzognere
mediatiche e giudiziarie. Ad ogni elezione legislativa ci troviamo a dover
scegliere tra: il partito dei condoni; il partito della CGIL; il partito dei
giudici. Io da anni non vado a votare perché non mi rappresentano i nominati in
Parlamento. A questo punto mi devono spiegare cosa centra, per esempio, la
siciliana Anna Finocchiaro con la Puglia e con Taranto in particolare.
Oltretutto mi disgustano le malefatte dei nominati. Un esempio per tutti, anche
se i media lo hanno sottaciuto. La riforma forense, approvata con Legge 31
dicembre 2012, n. 247, tra gli ultimi interventi legislativi consegnatici
frettolosamente dal Parlamento prima di cessare di fare danni. I nonni avvocati
in Parlamento (compresi i comunisti) hanno partorito, in previsione di un loro
roseo futuro, una contro riforma fatta a posta contro i giovani. Ai fascisti che
hanno dato vita al primo Ordinamento forense (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 -
Ordinamento della professione di avvocato e di procuratore convertito con la
legge 22 gennaio 1934 n.36) questa contro riforma reazionaria gli fa un baffo.
Trattasi di una “riforma”, scritta come al solito negligentemente, che non viene
in alcun modo incontro ed anzi penalizza in modo significativo i giovani. Da
venti anni inascoltato denuncio il malaffare di avvocati e magistrati ed il loro
malsano accesso alla professione. Cosa ho ottenuto a denunciare i trucchi per
superare l’esame? Insabbiamento delle denunce e attivazione di processi per
diffamazione e calunnia, chiusi, però, con assoluzione piena. Intanto ti
intimoriscono. Ed anche la giustizia amministrativa si adegua. A parlar delle
loro malefatte i giudici amministrativi te la fanno pagare. Presento l’oneroso
ricorso al Tar di Lecce (ma poteva essere qualsiasi altro Tribunale
Amministrativo Regionale) per contestare l’esito negativo dei miei compiti
all’esame di avvocato: COMMISSIONE NAZIONALE D'ESAME PRESIEDUTA DA CHI NON
POTEVA RICOPRIRE L'INCARICO, COMMISSARI (COMMISSIONE COMPOSTA DA MAGISTRATI,
AVVOCATI E PROFESSORI UNIVERSITARI) DENUNCIATI CHE GIUDICANO IL DENUNCIANTE E
TEMI SCRITTI NON CORRETTI, MA DA 15 ANNI SONO DICHIARATI TALI. Ricorso, n.
1240/2011 presentato al Tar di Lecce il 25 luglio 2011 contro il voto numerico
insufficiente (25,25,25) dato alle prove scritte di oltre 4 pagine cadaune della
sessione del 2010 adducente innumerevoli nullità, contenente, altresì, domanda
di fissazione dell’udienza di trattazione. Tale ricorso non ha prodotto alcun
giudizio nei tempi stabiliti, salvo se non il diniego immediato ad una istanza
cautelare di sospensione, tanto da farmi partecipare, nelle more ed in pendenza
dell’esito definitivo del ricorso, a ben altre due sessioni successive, i cui
risultati sono stati identici ai temi dei 15 anni precedenti (25,25,25): compiti
puliti e senza motivazione, voti identici e procedura di correzione nulla in più
punti. Per l’inerzia del Tar si è stati costretti a presentare istanza di
prelievo il 09/07/2012. Inspiegabilmente nei mesi successivi all’udienza fissata
e tenuta del 7 novembre 2012 non vi è stata alcuna notizia dell’esito
dell’istanza, nonostante altri ricorsi analoghi presentati un anno dopo hanno
avuto celere ed immediato esito positivo di accoglimento. Eccetto qualcuno che
non poteva essere accolto, tra i quali i ricorsi dell'avv. Carlo Panzuti e
dell'avv. Angelo Vantaggiato in cui si contestava il giudizio negativo reso ad
un elaborato striminzito di appena una pagina e mezza. Solo in data 7 febbraio
2013 si depositava sentenza per una decisione presa già in camera di consiglio
della stessa udienza del 7 novembre 2012. Una sentenza già scritta, però, ben
prima delle date indicate, in quanto in tale camera di consiglio (dopo aver
tenuto anche regolare udienza pubblica con decine di istanze) i magistrati
avrebbero letto e corretto (a loro dire) i 3 compiti allegati (più di 4 pagine
per tema), valutato e studiato le molteplici questioni giuridiche presentate a
supporto del ricorso. I magistrati amministrativi potranno dire che a loro
insindacabile giudizio il mio ricorso va rigettato, ma devono spiegare non a me,
ma a chi in loro pone fiducia, perché un ricorso presentato il 25 luglio 2011,
deciso il 7 novembre 2012, viene notificato il 7 febbraio 2013? Un'attenzione
non indifferente e particolare e con un risultato certo e prevedibile, se si
tiene conto che proprio il presidente del Tar era da considerare incompatibile
perchè è stato denunciato dal sottoscritto e perché le sue azioni erano oggetto
di inchiesta video e testuale da parte dello stesso ricorrente? Le gesta del
presidente del Tar sono state riportate da Antonio Giangrande, con citazione
della fonte, nella pagina d'inchiesta attinente la città di Lecce. Come per
dire: chi la fa, l'aspetti? QUANTO SONO ATTENDIBILI LE COMMISSIONI D’ESAME?
Ogni anno a dicembre c’è un evento che stravolge la vita di molte persone.
Il Natale? No! L’esame di avvocato che si svolge presso ogni Corte di Appello ed
affrontato da decine di migliaia di candidati illusi. La domanda sorge
spontanea: c’è da fidarsi delle commissioni dei concorsi pubblici o degli esami
di Stato? «Dai dati emersi da uno studio effettuato: per nulla!». Così opina
Antonio Giangrande, lo scrittore, saggista e sociologo storico, che sul tema ha
scritto un libro “CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI. L’Italia dei concorsi e degli esami
pubblici truccati” tratto dalla collana editoriale “L’ITALIA DEL TRUCCO,
L’ITALIA CHE SIAMO”. E proprio dalle tracce delle prove di esame che si inizia.
Appunto. Sbagliano anche le tracce della Maturità. “Le parole sono importanti”,
urlava Nanni Moretti nel film Palombella Rossa alla giornalista che,
senza successo, provava a intervistarlo. E’ proprio dalla commissione dell’esame
di giornalismo partiamo e dalle tracce da queste predisposte. Giusto per
saggiare la sua preparazione. La commissione è quella ad avere elaborato le
tracce d’esame. In particolare due magistrati (scelti dalla corte d’appello di
Roma) e cinque giornalisti professionisti. Ne dà conto il sito de l’Espresso,
che pubblica sia i documenti originali consegnati ai candidati, sia la versione
degli stessi per come appare sul sito dell’Ordine, cioè con le correzioni (a
penna) degli errori. Ossia: “Il pubblico ministero deciderà se convalidare o
meno il fermo”. Uno strafalcione: compito che spetta al giudice delle indagini
preliminari. Seguono altre inesattezze come il cognome del pm (che passa da
Galese a Galesi) e una citazione del regista Carlo Lizzani, in cui “stacco la
chiave” diventa “stacco la spina”. Sarà per questo che Indro Montanelli decise
di non affrontare l’esame e Milena Gabanelli di non riaffrontarlo? Sarà per
questo che Paolo Mieli è stato bocciato? E che dire di Aldo Busi il cui compito
respinto era considerato un capolavoro e ricercato a suon di moneta? È in buona
compagnia la signora Gabanelli & Company. Infatti si racconta che anche Alberto
Moravia fu bocciato all’esame da giornalista professionista. Poco male. Sono le
eccezioni che confermano la regola. Non sono gli esami giudicate da siffatte
commissioni che possono attribuire patenti di eccellenza. Se non è la
meritocrazia ha fare leva in Italia, sono i mediocri allora a giudicare. Ed a un
lettore poco importa sapere se chi scrive ha superato o meno l'esame di
giornalismo. Peccato che per esercitare una professione bisogna abilitarsi ed
anche se eccelsi non è facile che i mediocri intendano l'eccellenza.
L’esperienza e il buon senso, come sempre, sono le qualità fondamentali che
nessuno (pochi) può trasmettere o sa insegnare. Del resto, si dice che anche
Giuseppe Verdi fu bocciato al Conservatorio e che Benedetto Croce e Gabriele
D’Annunzio non si erano mai laureati. Che dire delle Commissioni di esame di
avvocato. Parliamo della sessione 2012. Potremmo parlarne per le sessioni
passate, ma anche per quelle future: tanto in questa Italia le cose nefaste sono
destinate a durare in eterno. A Lecce sarebbero solo 440 su 1258 i compiti
ritenuti validi. Questo il responso della Commissione di Catania, presieduta
dall’Avvocato Antonio Vitale, addetta alla correzione degli elaborati. Più di
cento scritti finiscono sul tavolo della Procura della Repubblica con l’accusa
di plagio, per poi, magari, scoprire che è tutta una bufala. Copioni a parte,
sarebbe, comunque, il 65% a non superare l’esame: troppi per definirli asini,
tenuto conto che, per esperienza personale, so che alla fase di correzione non
si dedicano oltre i 5 minuti, rispetto ai 15/20 minuti occorrenti. Troppo pochi
per esprimere giudizi fondati. Oltretutto l’arbitrio non si motiva nemmeno
rilasciando i compiti corretti immacolati. Prescindendo dalla caccia mirata alle
streghe, c’è forse di più? Eppure c’è chi queste commissioni li sputtana. TAR
Lecce: esame forense, parti estratte da un sito? Legittimo se presenti in un
codice commentato. È illegittimo l’annullamento dell’elaborato dell’esame di
abilitazione forense per essere alcune parti estratte da un sito, se tali parti
sono presenti all’interno di un codice commentato. (Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima, Ordinanza 19 settembre 2013, n.
465). E’ lo stesso Tar Catania che bacchetta la Commissione d’esame di Avvocato
della stessa città Esame di avvocato...Copiare non sempre fa rima con annullare
- TAR CATANIA ordinanza n. 1300/2010. Esame avvocato: Qualora in sede di
correzione dell'elaborato si accerta che il lavoro sia in tutto o in parte
copiato da altro elaborato o da qualche manuale, per condurre all’annullamento
della prova, deve essere esatto e rigoroso. Tale principio di diritto è
desumibile dall’ordinanza in rassegna n. 1300/2010 del TAR Catania che ha
accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale avanzata avverso la
mancata ammissione del ricorrente alla prova orale dell’esame di avvocato. In
particolare, per il Tar etneo “il ricorso appare fondato, in quanto la
Commissione si è limitata ad affermare apoditticamente che il compito di diritto
penale della ricorrente conteneva “ampi passi del tutto identici all’elaborato
di penale contenuto” in altra busta recante il n. 459 senza alcuna
specificazione, anche sul compito, che consenta di appurare che questa presunta
“identità” vada oltre la semplice preparazione sui medesimi testi, o la
consultazione dei medesimi codici”. Per il TAR siciliano, inoltre, “l’elaborato
di penale del candidato contraddistinto dal n. 459 era stato corretto da una
diversa sottocommissione durante la seduta del 19 marzo 2010, e tale elaborato
non risulta essere stato parimenti annullato”. E a sua volta è la stessa
Commissione d’esame di Avvocato di Lecce ad essere sgamata. Esami di avvocato.
Il Tar di Salerno accoglie i ricorsi dei bocciati. I ricorsi accolti sono già
decine, più di trenta soltanto nella seduta di giovedì 24 ottobre 2013,
presentati da aspiranti avvocati bocciati alle ultime prove scritte da un
giudizio che il Tar ha ritenuto illegittimo in quanto non indica i criteri sui
cui si è fondato. Il Tribunale amministrativo sta quindi accogliendo le domande
cautelari, rinviando al maggio del 2014 il giudizio di merito ma indicando, per
sanare il vizio, una nuova procedura da affidare a una commissione diversa da
quella di Lecce che ha deciso le bocciature. Il numero dei bocciati, reso noto
lo scorso giugno 2013, fu altissimo. Soltanto 366 candidati, su un totale di
1.125, passarono le forche caudine dello scritto e furono ammessi alle prove
orali. Una percentuale del 32,53: quasi 17 punti in meno del 49,16 registrato
alla sessione dell’anno precedente. Numeri, questi ultimi, in linea con una
media che, poco più o poco meno, si è attestata negli ultimi anni
sull’ammissione della metà dei partecipanti. Nel 2012, invece, la ghigliottina è
caduta sul 64,09 per cento degli esaminandi. In numeri assoluti i bocciati
furono 721, a cui vanno aggiunti i 38 compiti (3,38 per cento) annullati per
irregolarità come il rinvenimento di svolgimenti uguali. Adesso una parte di
quelle persone ha visto accogliere dal Tar i propri ricorsi. I criteri usati dai
commissari per l’attribuzione del punteggio, hanno spiegato i giudici, «non si
rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle
ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della
Sottocommissione locale». La valutazione, quindi, «deve ritenersi
l'illegittima». Che ne sarà di tutti coloro che quel ricorso non lo hanno
presentato. Riproveranno l’esame e, forse, saranno più fortunati. Anche perché
vatti a fidare dei Tar. Ci si deve chiedere: se il sistema permette da sempre
questo stato di cose con il libero arbitrio in tema di stroncature dei
candidati, come mai solo il Tar di Salerno, su decine di istituzioni simili, vi
ha posto rimedio? Esami di Stato: forche caudine, giochi di prestigio o giochi
di azzardo? Certo non attestazione di merito. Sicuramente nell’affrontare
l’esame di Stato di giornalismo sarei stato bocciato per aver, questo articolo,
superato le 45 righe da 60 caratteri, ciascuna per un totale di 2.700 battute,
compresi gli spazi. Così come previsto dalle norme. Certamente, però, si leggerà
qualcosa che proprio i giornalisti professionisti preferiscono non dire: tutte
le commissioni di esame sono inaffidabili, proprio perché sono i mediocri a
giudicare, in quanto in Italia sono i mediocri a vincere ed a fare carriera!
Sessione d’esame d’avvocato 2013-2014.
Tutto come prima. Presidente di Commissione, Avv.
Luigi Covella, Principe del Foro di Lecce. Presidente coscienzioso e preparato.
Compiti come sempre uguali perché la soluzione la forniva il commissario, il
compagno di banco od i testi non autorizzati. Naturalmente anche in questa
sessione un altro tassello si aggiunge ad inficiare la credibilità dell’esame
forense. "La S.V. ha superato le prove scritte e dovrà sostenere le prove orali
dinanzi alla Sottocommissione". "Rileviamo che sono state erroneamente immesse
nel sistema le comunicazioni relative all’esito delle prove scritte e le
convocazioni per le prove orali". Due documenti, il secondo contraddice e
annulla il primo (che è stato un errore), sono stati inviati dalla Corte di
Appello di Lecce ad alcuni partecipanti alla prova d’esame per diventare
avvocato della tornata 2013, sostenuta nel dicembre scorso. Agli esami di
avvocato della Corte di Appello di Lecce hanno partecipato circa mille
praticanti avvocati e gli elaborati sono stati inviati per la correzione alla
Corte di Appello di Palermo. (commissari da me denunciati per concorsi truccati
già in precedente sessione). L’errore ha provocato polemiche e critiche sul web
da parte dei candidati. La vicenda sembra avere il sapore di una beffa
travestita da caos burocratico, ma non solo. Che in mezzo agli idonei ci siano
coloro che non debbano passare e al contrario tra gli scartati ci siano quelli
da far passare? E lì vi è un dubbio che assale i malpensanti. Alle 17 del 19
giugno nella posta di alcuni candidati (nell’Intranet della Corte di Appello) è
arrivata una comunicazione su carta intestata della stessa Corte di Appello,
firmata dal presidente della commissione, avvocato Luigi Covella, con la quale
si informava di aver superato "le prove scritte" fissando anche le date nelle
quali sostenere le prove orali, con la prima e la seconda convocazione. Tre ore
dopo, sul sito ufficiale corteappellolecce.it, la smentita con una breve nota.
"Rileviamo – è scritto – che sono state erroneamente immesse nel sistema le
comunicazioni relative all’esito delle prove scritte e le convocazioni per le
prove orali. Le predette comunicazioni e convocazioni non hanno valore legale in
quanto gli esiti delle prove scritte non sono stati ancora pubblicati in forma
ufficiale. Gli esiti ufficiali saranno resi pubblici a conclusione delle
operazioni di inserimento dei dati nel sistema, attualmente ancora in corso".
Sui forum animati dai candidati sul web è scoppiata la protesta e in tanti si
sono indignati. "Vergogna", scrive Rosella su mininterno.net. "Quello che sta
accadendo non ha precedenti. Mi manca soltanto sapere di essere stato vittima di
uno scherzo!", puntualizza Pier. Un candidato che si firma Sicomor: "un classico
in Italia... divertirsi sulla sorte della povera gente! poveri noi!". Un altro
utente attacca: "Si parano il c... da cosa? L’anno scorso i risultati uscirono
il venerdì sera sul profilo personale e poi il sabato mattina col file pdf sul
sito pubblico della Corte! La verità è che navighiamo in un mare di poca
professionalità e con serietà pari a zero!". Frank aggiunge: "Ma come è
possibile una cosa simile stiamo parlando di un concorso!". Il pomeriggio di
lunedì 23 giugno 2014 sono stati pubblicati i nomi degli idonei all’orale.
Quelli “giusti”, questa volta. E dire che trattasi della Commissione d’esame di
Palermo da me denunciata e della commissione di Lecce, da me denunciata. Che
consorteria tra toghe forensi e giudiziarie. Sono 465 i candidati ammessi alla
prova orale presso la Corte di Appello di Lecce. E' quanto si apprende dalla
comunicazione 21 giugno 2013 pubblicata sul sito della Corte di Appello
di Lecce. Il totale dei partecipanti era di 1.258 unità: la percentuale degli
ammessi risulta pertanto pari al 36,96%. Una percentuale da impedimento
all’accesso. Percentuale propria delle commissioni d’esame di avvocato nordiste
e non dell’insulare Palermo. Proprio Palermo. Il
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Termini Imerese, in primo
grado fu condannato a 10 mesi. L’accusa: truccò il concorso per avvocati. Non fu
sospeso. Da “La
Repubblica” di Palermo del 10/01/2001: Parla il giovane aspirante avvocato, che
ha portato con sé una piccola telecamera per filmare “palesi irregolarità”. «Ho
le prove nel mio video del concorso truccato. Ho un’altra cassetta con sette
minuti di immagini, che parlano da sole. Oggi sarò sentito dal magistrato. A lui
racconterò tutto ciò che ho visto. La giornata di un concorsista, aspirante
avvocato, comincia alle quattro e mezza del mattino. Alle sei devi esser in
prima fila. Ed è quello il momento in cui capisci come vanno le cose. Tutti lo
sanno, ma nessuno ne parla». I.D.B., 38 anni, ha voluto rompere il silenzio. Nei
giorni dell’esame scritto per l’abilitazione forense si è portato dietro una
piccola telecamera e ha documentato quelle che lui chiama “palesi irregolarità”.
E’ stato bloccato dai commissari e la cassetta con le immagini è stata
sequestrata. Ma lui non si perde d’animo: «in fondo io cerco solo la verità».
Intanto, I.D.B. rompe il silenzio con “La Repubblica” perché dice «è importante
cercare un movimento d’opinione attorno a questa vicenda ». E ha già ricevuto la
solidarietà dell’associazione Nazionale Praticanti ed avvocati. «Vorrei dire –
racconta – delle sensazioni che ho provato tutte le volte che ho fatto questo
esame. Sensazioni di impotenza per quello che senti intorno. Ed è il segreto di
Pulcinella. Eccone uno: basta comunicare la prima frase del compito a chi di
dovere. Io ho chiesto i temi che avevo fatto nelle sessioni precedenti: non
c’era una correzione, una motivazione, solo un voto». Il primo giorno degli
esami scritti il giovane si è guardato intorno. L’indomani era già dietro la
telecamera: «Ho filmato circa sette minuti, in lungo ed in largo nel padiglione
20 della Fiera del Mediterraneo, dove c’erano più di novecento candidati. A casa
ho rivisto più volte il filmato e ho deciso che avrei dovuto documentare ancora.
Così è stato. Il secondo filmato, quello sequestrato, dura più del primo. A un
certo punto una collega si è accorta di me e ha chiamato uno dei commissari. Non
ho avuto alcun problema, ho consegnato la cassetta. E sin dal primo momento ho
detto: Mi sono accorto di alcune irregolarità e ho documentato. Allora mi hanno
fatto accomodare in una stanza. E insistevano: perché l’ha fatto?. Tornavo a
parlare delle irregolarità. Poi mi chiedevano chi le avesse fatte. Lo avrei
detto al presidente della commissione, in disparte. Davanti a tutti, no!» Il
giovane si dice stupito per il clamore suscitato dal suo gesto: «Non dovrebbe
essere questo a sorprendere, ho avuto solo un po’ più di coraggio degli altri».
Ma cosa c’è in quelle videocassette? L’aspirante avvocato non vuole dire di più,
fa cenno ad un commissario sorpreso in atteggiamenti confidenziali con alcuni
candidati: «Francamente non capisco perché non siano stati presi provvedimenti
per il concorso. Quei capannelli che ho ripreso sono davvero troppo da
tollerare. Altro che piccoli suggerimenti!».
Sessione d’esame d’avvocato 2014-2015.
Tutto come prima. Presidente di Commissione, Avv.
Francesco De Jaco, Principe del Foro di Lecce. Presidente coscienzioso e
preparato. Compiti come sempre uguali perché la soluzione la forniva il
commissario, il compagno di banco od i testi non autorizzati. Sede di Corte
d’appello sorteggiata per la correzione è Brescia. Mi tocca, non come il
ministro Gelmini che da Brescia ha scelto
Reggio Calabria, dopo ben 12 anni dalla laurea conseguita a
Milano. In quei mesi di tormenti a cavallo tra il 2000 e il 2001 Mariastella
Gelmini si trova dunque a scegliere tra fare l’esame a Brescia o scendere giù in
Calabria, spiegherà a Flavia Amabile: «La mia famiglia non poteva permettersi di
mantenermi troppo a lungo agli studi, mio padre era un agricoltore. Dovevo
iniziare a lavorare e quindi dovevo superare l'esame per ottenere l'abilitazione
alla professione». Quindi? «La sensazione era che esistesse un tetto del 30% che
comprendeva i figli di avvocati e altri pochi fortunati che riuscivano ogni anno
a superare l'esame. Per gli altri, nulla. C'era una logica di casta, per fortuna
poi modificata perché il sistema è stato completamente rivisto». E così,
«insieme con altri 30-40 amici molto demotivati da questa situazione, abbiamo
deciso di andare a fare l'esame a Reggio Calabria». I risultati della sessione
del 2000, del resto, erano incoraggianti. Nonostante lo scoppio dello scandalo,
nel capoluogo calabrese c'era stato il primato italiano di ammessi agli orali:
93,4%. Il triplo che nella Brescia della Gelmini (31,7) o a Milano (28,1), il
quadruplo che ad Ancona. Idonei finali: 87% degli iscritti iniziali. Contro il
28% di Brescia, il 23,1% di Milano, il 17% di Firenze. Totale: 806 idonei.
Cinque volte e mezzo quelli di Brescia: 144. Quanti Marche, Umbria, Basilicata,
Trentino, Abruzzo, Sardegna e Friuli Venezia Giulia messi insieme. Insomma, la
tentazione era forte. Spiega il ministro dell'Istruzione: «Molti ragazzi
andavano lì e abbiamo deciso di farlo anche noi». Del resto, aggiunge, lei ha
«una lunga consuetudine con il Sud. Una parte della mia famiglia ha parenti in
Cilento». Certo, è a quasi cinquecento chilometri da Reggio. Ma sempre
Mezzogiorno è. E l'esame? Com'è stato l'esame? «Assolutamente regolare». Non
severissimo, diciamo, neppure in quella sessione. Quasi 57% di ammessi agli
orali. Il doppio che a Roma o a Milano. Quasi il triplo che a Brescia. Dietro
soltanto la solita Catanzaro, Caltanissetta, Salerno. Così facevan tutti, dice
Mariastella Gelmini. Io dal 1998 ho partecipato all’esame forense annuale.
Sempre bocciato. Ho rinunciato a proseguire nel 2014 con la commissione
presieduta dall’avv. Francesco De Jaco. L’avvocato di Cosima Serrano condannata
con la figlia Sabrina Misseri per il delitto di Sarah Scazzi. Tutte mie
compaesane. La Commissione d’esame di avvocato di Lecce 2014. La più serena che
io abbia trovato in tutti questi anni. Ho chiesto invano a lui di tutelare me,
dagli abusi in quell’esame, come tutti quelli come me che non hanno voce. Se per
lui Cosima è innocente contro il sentire comune, indotti a pensarla così dai
media e dai magistrati, perché non vale per me la verità che sia vittima di un
sistema che mi vuol punire per essermi ribellato? Si nega l’evidenza. 1, 2, 3
anni, passi. 17 anni son troppi anche per il più deficiente dei candidati. Ma
gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. Compiti non corretti, ma ritenuti
tali in tempi insufficienti e senza motivazione e con quote prestabilite di
abilitati. Così per me, così per tutti. Gli avvocati abilitati negano
l’evidenza. Logico: chi passa, non controlla. Ma 17 anni son troppi per credere
alla casualità di essere uno sfigato, specialmente perché i nemici son noti,
specie se sono nelle commissioni d’esame. A Bari avrebbero tentato di agevolare
la prova d'esame di cinque aspiranti avvocati ma sono stati bloccati e
denunciati dai Carabinieri, scrive “La Gazzetta del Mezzogiorno”. È accaduto
nella Fiera del Levante di Bari dove è in corso da tre giorni l'esame di
abilitazione professionale degli avvocati baresi. In circa 1500 hanno sostenuto
le prove scritte in questi giorni ma oggi, ultimo giorno degli scritti, i
Carabinieri sono intervenuti intercettando una busta contenente i compiti
diretti a cinque candidati. Un dipendente della Corte di Appello, con il compito
di sorvegliante nei tre giorni di prova, avrebbe consegnato ad una funzionaria
dell'Università la busta con le tracce. Lei, dopo alcune ore, gli avrebbe
restituito la busta con all'interno i compiti corretti e un biglietto con i
cinque nomi a cui consegnare i temi. Proprio nel momento del passaggio sono
intervenuti i Carabinieri, che pedinavano la donna fin dal primo giorno, dopo
aver ricevuto una segnalazione. Sequestrata la busta i militari hanno condotto i
due in caserma per interrogarli. Al momento sono indagati a piede libero per la
violazione della legge n. 475 del 1925 sugli esami di abilitazione
professionali, che prevede la condanna da tre mesi a un anno di reclusione per
chi copia. Le indagini dei Carabinieri, coordinate dal pm Eugenia Pontassuglia,
verificheranno nei prossimi giorni la posizione dei cinque aspiranti avvocati
destinatari delle tracce e quella di altre persone eventualmente coinvolte nella
vicenda. Inoltre tre aspiranti avvocatesse (una è figlia di due magistrati),
sono entrate nell’aula tirandosi dietro il telefono cellulare che durante la
prova hanno cercato di utilizzare dopo essersi rifugiate in bagno. Quando si
sono rese conto che sarebbero state scoperte, sono tornate in aula. Pochi minuti
dopo il presidente della commissione d’esame ha comunicato il ritrovamento in
bagno dei due apparecchi ma solo una delle due candidate si è fatta avanti,
subito espulsa. L’altra è rimasta in silenzio ma è stata identifica. Esame
per avvocati, la banda della truffa: coinvolti tre legali e due dirigenti
pubblici. Blitz dei carabinieri nella sede della Finanza. E la potente
funzionaria di Giurisprudenza sviene, scrive Gabriella De Matteis e Giuliana
Foschini su “La Repubblica”. Un ponte telefonico con l'esterno. Tre avvocati
pronti a scrivere i compiti. Un gancio per portare il tutto all'interno. Sei
candidati pronti a consegnare. Era tutto pronto. Anzi era tutto fatto. Ma
qualcosa è andato storto: quando la banda dell'"esame da avvocato" credeva che
tutto fosse andato per il verso giusto, sono arrivati i carabinieri del reparto
investigativo a fare saltare il banco. E a regalare l'ennesimo scandalo
concorsuale a Bari. E' successo tutto mercoledì 17 dicembre 2014 pomeriggio
all'esterno dei padiglioni della Guardia di finanza dove stava andando in scena
la prova scritta per l'esame da avvocato. Mille e cinquecento all'incirca i
partecipanti, divisi in ordine alfabetico. Commissione e steward per evitare
passaggi di compiti o copiature varie. Apparentemente nulla di strano.
Apparentemente appunto. Perché non appena vengono aperte le buste e lette le
tracce si comincia a muovere il Sistema scoperto dai carabinieri. Qualcuno
dall'interno le comunica a Tina Laquale, potente dirigente amministrativo della
facoltà di Giurisprudenza di Bari. E' lei a girarle, almeno questo hanno
ricostruito i Carabinieri, a tre avvocati che avevano il compito di redigere il
parere di civile e di penale e di scrivere l'atto. Con i compiti in mano la
Laquale si è presentata all'esterno dei padiglioni. All'interno c'era un altro
componente del gruppo, Giacomo Santamaria, cancelliere della Corte d'Appello che
aveva il compito di fare arrivare i compiti ai sei candidati che all'interno li
aspettavano. Compiti che sarebbero poi stati consegnati alla commissione e via.
Ma qui qualcosa è andato storto. Sono arrivati infatti i carabinieri che hanno
bloccato tutto. Laquale è svenuta, mentre a lei e a tutte quante le altre
persone venivano sequestrati documenti e soprattutto supporti informatici,
telefoni in primis, che verranno analizzati in queste ore. Gli investigatori
devono infatti verificare se, come sembra, il sistema fosse da tempo organizzato
e rodato, se ci fosse un corrispettivo di denaro e la vastità del fenomeno. Ieri
si è tenuta la convalida del sequestro davanti al sostituto procuratore, Eugenia
Pontassuglia. Ma com'è chiaro l'indagine è appena cominciata. Per il momento
viene contestata la truffa e la violazione di una vecchia legge del 1925 secondo
la cui "chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o
pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o
titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed
all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti,
presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e,
in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre
mesi ad un anno. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi
qualora l'intento sia conseguito". È molto probabile infatti che l'esame venga
invalidato per tutti. Certo è facile prendersela con i poveri cristi. Le macagne
nelle segrete stanze delle commissioni di esame, in cui ci sono i magistrati,
nessuno va ad indagare: perché per i concorsi truccati nessuno va in galera.
Concorsi, i figli di papà vincono facile: "E noi, figli di nessuno, restiamo
fuori". L’inchiesta sul dottorato vinto dal figlio del rettore della
Sapienza nonostante l'uso del bianchetto ha raccolto centinaia di commenti e
condivisioni. E ora siamo noi a chiedervi di raccontarci la vostra storia di
candidati meritevoli ma senza parenti eccellenti. Ecco le prime due lettere
arrivate, scrive Emiliano Fittipaldi su “L’Espresso”. A chi figli, e a chi
figliastri: è questa la legge morale che impera in Italia, il Paese della
discriminazione e delle corporazioni. Dove va avanti chi nasce privilegiato,
mentre chi non vanta conoscenze e relazioni rischia, quasi sempre, di arrivare
ultimo. Alla Sapienza di Roma l’assioma è spesso confermato: sono decine i
parenti di professori eminenti assunti nei dipartimenti, con intere famiglie (su
tutte quella dell’ex rettore Luigi Frati) salite in cattedra. A volte con
merito, altre meno. La nostra inchiesta sullo strano concorso di dottorato vinto
dal rampollo del nuovo magnifico Eugenio Gaudio, al tempo preside di Medicina,
ha fatto scalpore: la storia del compito “sbianchettato” (qualsiasi segno di
riconoscimento è vietato) e la notizia del singolare intervento dei legali
dell’università (hanno chiesto un parere all’Avvocatura dello Stato, che ha
invitato la Sapienza a “perdonare” il candidato ) hanno fatto il giro del web.
Il pezzo è stato condiviso decine di migliaia di volte, con centinaia di
commenti (piuttosto severi) di ex studenti e docenti dell’ateneo romano. Tra le
decine di lettere arrivate in redazione, due sono metafora perfetta di come la
sorte possa essere diversa a seconda del cognome che si porta. Livia Pancotto,
28 anni, laureata in Economia con 110 e lode, spiega che la storia del pargolo
di Gaudio le ha fatto «montare dentro una rabbia tale da farmi scrivere» poche,
infuriate righe. «Nel 2012, dopo la laurea, decisi di partecipare al concorso
per il dottorato in Management, Banking and Commodity Sciences, sempre alla
Sapienza», scrive in una lettera a “l’Espresso”. «Dopo aver superato sia l’esame
scritto che l’orale ricevetti la buona notizia: ero stata ammessa, sia pure
senza borsa». Dopo un mese, però, la mazzata. «Vengo a sapere dal professore che
il mio concorso è stato annullato, visto che durante lo scritto ho utilizzato il
bianchetto. Come nel caso del figlio del rettore Gaudio, nessuno aveva
specificato, prima dell’inizio del compito, che il bando prevedesse che si
potesse usare solo una penna nera». Se per il rampollo dell’amico che prenderà
il suo posto il rettore Frati mobiliterà i suoi uffici legali, la Pancotto viene
silurata subito, senza pietà. Oggi la giovane economista vive in Galles, dove ha
vinto un dottorato con borsa all’università di Bangor. Anche la vicenda di
Federico Conte, ora tesoriere dell’Ordine degli psicologi del Lazio, è
paradossale. Dopo aver completato in un solo anno gli esami della laurea
specialistica nel 2009, la Sapienza tentò di impedire la discussione della sua
tesi. «Mi arrivò un telegramma a firma di Frati, dove mi veniva comunicato
l’avvio di una “procedura annullamento esami”: il magnifico non era d’accordo
nel farmi laureare in anticipo, ed era intenzionato a farmi sostenere gli esami
una seconda volta». Conte domandò all’ateneo di chiedere un parere
all’Avvocatura, ma senza successo. Il giovane psicologo fu costretto a ricorrere
al Tar, che gli diede ragione permettendogli di laurearsi. «Leggendo la vostra
inchiesta ho la percezione di un’evidente diversità di trattamento rispetto al
figlio del rettore. Provo un certo disgusto nel constatare come le nostre
istituzioni siano così attente e garantiste con chi sbianchetta, mentre si
accaniscano su chi fa il proprio dovere». Magari pure più velocemente degli
altri. Ma tant’è. Nel paese dove i figli “so’ piezz’ e core”, la meritocrazia e
l’uguaglianza restano una chimera. Anche nelle università, luogo dove - per
antonomasia - l’eccellenza e il rigore dovrebbero essere di casa. Se poi l’Esame
di Avvocato lo passi, ti obbligano a lasciare. Giovani avvocati contro la Cassa
Forense. Con la campagna "'Io non pago e non mi cancello". I giuristi più
giovani in rivolta sui social network per la regola dei minimi obbligatori, che
impone contributi previdenziali intorno ai 4 mila euro annui alla cassa
indipendentemente dal reddito. Così c'è chi paga più di quello che guadagna. E
chi non paga si deve cancellare dall'Albo, venendo escluso dalla categoria,
scrive Antonio Sciotto su “L’Espresso”. Chi pensa ancora che la professione di
avvocato sia garantita e ben retribuita dia in questi giorni uno sguardo attento
ai social network. Twitter e Facebook da qualche giorno sono inondati da
'selfie' che raccontano tutta un'altra storia. "Io non pago e io non mi
cancello" è lo slogan scelto dai giovani legali per la loro rivolta contro i
colleghi più anziani e in particolare contro la regola dei "minimi obbligatori",
che impone di pagare i contributi previdenziali alla Cassa forense in modo del
tutto slegato dal reddito. Molti spiegano che la cifra minima richiesta –
intorno ai 4 mila euro annui - è pari o a volte anche superiore ai propri
redditi. E visto che se non riesci a saldare, devi cancellarti non solo dalla
Cassa, ma anche dall'albo professionale. Il risultato è che ad esercitare alla
fine restano tendenzialmente i più ricchi, mentre chi fa fatica ad arrivare a
fine mese viene di fatto espulso dalla categoria. E' vero che per i primi 8 anni
è prevista una buona agevolazione per chi guadagna sotto i 10 mila euro l'anno,
ma al pari le prestazioni vengono drasticamente ridotte. Per capirci: è come se
l'Inps chiedesse a un operaio e a un dirigente una stessa soglia minima di
contributi annui, non calcolata in percentuale ai loro redditi. Mettiamo 5 mila
euro uguali per tutti: salvo poi imporre la cancellazione dall'ente a chi non
riesce a saldare. "Dovrei salassarmi oggi per ricevere un'elemosina domani –
protesta Antonio Maria - mentre i vecchi tromboni ottantenni si godono le loro
pensioni d'oro, non pagate, conquistate avendo versato tutta la vita lavorativa
(ed erano altri tempi) il 10 per cento ed imponendo a me di pagare il 14 per
cento". "Il regime dei cosiddetti minimi è vergognoso – aggiunge Rosario -
Pretendere che si paghi 'a prescindere' del proprio reddito è una bestemmia
giuridica. Basta furti generazionali. Basta falsità". Uno dei selfie addirittura
viene da un reparto di emodialisi, a testimoniare la scarsa copertura sanitaria
assicurata ai giovani professionisti. La protesta si è diffusa a partire dal
blog dell'Mga - Mobilitazione generale avvocati , ha un gruppo facebook
pubblico dove è possibile postare i selfie, mentre su Twitter naviga sull'onda
dell'hashtag #iononmicancello. La battaglia contro le casse previdenziali
non è nuova, se consideriamo gli avvocati una parte del più vasto mondo delle
partite Iva e degli autonomi: già da tempo Acta, associazione dei freelance, ha
lanciato la campagna #dicano33, contro il progressivo aumento dei contributi
Inps dal 27 per cento al 33 per cento, imposto dalla legge per portarli al
livello dei lavoratori dipendenti. Il regime dei minimi obbligatori della Cassa
forense non solo darebbe luogo a una vera e propria "discriminazione
generazionale", ma secondo molti giovani avvocati sarebbe anche
incostituzionale, come spiega efficacemente Davide Mura nel suo blog: "E'
palesemente in contrasto con l'articolo 53 della Costituzione, che sancisce il
principio della progressività contributiva. Ma si viola anche l'articolo 3,
quello sull'uguaglianza davanti alla legge, perché le condizioni cambiano a
seconda se stai sopra o sotto i 10 mila euro di reddito annui". La soluzione?
Secondo l'Mga sarebbe quella di eliminare l'obbligo dei minimi e passare al
sistema contributivo, come è per tutti gli altri lavoratori. Vietando
possibilmente agli avvocati già in pensione di poter continuare a esercitare. Un
modo insomma per far sì che i "tromboni" lascino spazio ai più giovani.
I MEDIA ED I LORO PECCATI: DISINFORMAZIONE,
CALUNNIA, DIFFAMAZIONE.
Per il pontefice “il clima mediatico ha le sue
forme di inquinamento, i suoi veleni. La gente lo sa, se ne accorge, ma poi
purtroppo si abitua a respirare dalla radio e dalla televisione un’aria sporca,
che non fa bene. C’è bisogno di far circolare aria pulita. Per me i peccati dei
media più grossi sono quelli che vanno sulla strada della bugia e della
menzogna, e sono tre: la disinformazione, la calunnia e la diffamazione. Dare
attenzione a tematiche importanti per la vita delle persone, delle famiglie,
della società, e trattare questi argomenti non in maniera sensazionalistica, ma
responsabile, con sincera passione per il bene comune e per la verità. Spesso
nelle grandi emittenti questi temi sono affrontati senza il dovuto rispetto per
le persone e per i valori in causa, in modo spettacolare. Invece è essenziale
che nelle vostre trasmissioni si percepisca questo rispetto, che le storie umane
non vanno mai strumentalizzate”. Infatti nessuno delle tv ed i giornali ne
hanno parlato di questo intervento.
"Evitare i tre peccati dei media: la
disinformazione, la calunnia e la diffamazione". E' l'esortazione che rivolge al
mondo dell'informazione e della comunicazione Papa Francesco, cogliendo
l'occasione dell'udienza del 15 dicembre 2014 in Aula Paolo VI dei dirigenti,
dipendenti e operatori di Tv2000, la televisione della Chiesa italiana. «Di
questi tre peccati, la calunnia sembra il più grave perché colpisce le persone
con giudizi non veri. Ma in realtà il più grave e pericoloso è la
disinformazione, perché ti porta all'errore, ti porta a credere solo a una parte
della verità. La disinformazione, in particolare spinge a dire la metà delle
cose e questo porta a non potersi fare un giudizio preciso sulla realtà. Una
comunicazione autentica non è preoccupata di colpire: l'alternanza tra
allarmismo catastrofico e disimpegno consolatorio, due estremi che continuamente
vediamo riproposti nella comunicazione odierna, non è un buon servizio che i
media possono offrire alle persone. Occorre parlare alle persone “intere”, alla
loro mente e al loro cuore, perché sappiano vedere oltre l'immediato, oltre un
presente che rischia di essere smemorato e timoroso del futuro. I media
cattolici hanno una missione molto impegnativa nei confronti della comunicazione
sociale cercare di preservarla da tutto ciò che la stravolge e la piega ad altri
fini. Spesso la comunicazione è stata sottomessa alla propaganda, alle
ideologie, a fini politici o di controllo dell'economia e della tecnica. Ciò che
fa bene alla comunicazione è in primo luogo la “parresia”, cioè il coraggio di
parlare con franchezza e libertà. Se siamo veramente convinti di ciò che abbiamo
da dire, le parole vengono. Se invece siamo preoccupati di aspetti tattici, il
nostro parlare sarà artefatto e poco comunicativo, insipido. La libertà è anche
quella rispetto alle mode, ai luoghi comuni, alle formule preconfezionate, che
alla fine annullano la capacità di comunicare. Risvegliare le parole: ecco il
primo compito del comunicatore. La buona comunicazione in particolare evita sia
di "riempire" che di "chiudere". Si riempie quando si tende a saturare la
nostra percezione con un eccesso di slogan che, invece di mettere in moto il
pensiero, lo annullano. Si chiude quando alla via lunga della comprensione
si preferisce quella breve di presentare singole persone come se fossero in
grado di risolvere tutti i problemi, o al contrario come capri espiatori, su cui
scaricare ogni responsabilità. Correre subito alla soluzione, senza concedersi
la fatica di rappresentare la complessità della vita reale è un errore frequente
dentro una comunicazione sempre più veloce e poco riflessiva. La libertà è anche
quella rispetto alle mode, ai luoghi comuni, alle formule preconfezionate, che
alla fine annullano la capacità di comunicare».
Questa sub cultura artefatta dai media crea una
massa indistinta ed omologata. Un gregge di pecore. A questo punto vien meno il
concetto di democrazia e prende forma l’esigenza di un uomo forte alla giuda del
gregge che sappia prendersi la responsabilità del necessario cambiamento
nell’afasia e nell’apatia totale. Sembra necessario il concetto che è meglio far
decidere al buon e capace pastore dove far andare il gregge che far decidere
alle pecore il loro destino rivolto all’inevitabile dispersione.
Francesco di Sales, appena ordinato sacerdote, nel
1593, lo mandarono nel Chablais, che poi sarebbe il Chiablese, dato che sta
nell’Alta Savoia, ma l’avevano invaso gli Svizzeri e tutti si erano convertiti
al calvinismo, scrive Lanfranco Caminiti su “Il Garantista”. Insomma, doveva
essere proprio tosto predicare il cattolicesimo lì. Però, lui aveva studiato dai
Gesuiti e poi si era laureato a Padova, perciò poteva con capacità
d’argomentazione affrontare qualunque disputa teologica. Era uno che lavorava di
fino, Francesco di Sales. Solo che tutto quello che diceva dal pulpito non
sortiva grande effetto in quei cuori e quelle menti montanare, e allora per
raggiungerli e scaldarli meglio con le sue parole gli venne l’idea di far
affiggere nei luoghi pubblici dei “manifesti”, composti con uno stile agile e di
grande efficacia, e di far infilare dei “volantini” sotto le porte. Il
risultato fu straordinario. È per questo che san Francesco di Sales è il santo
patrono dei giornalisti. Per lo stile e l’efficacia, per la capacità di
argomentare la verità. Almeno fino a ieri. Perché da ieri c’è un altro Francesco
che ha steso le sue mani benedette sul giornalismo, ed è papa Bergoglio.
«Evitare i tre peccati dei media: la disinformazione, la calunnia e la
diffamazione». È l’esortazione che papa Francesco ha rivolto al mondo
dell’informazione e della comunicazione, cogliendo l’occasione dell’udienza in
Aula Paolo VI di dirigenti, dipendenti e operatori di Tv2000, la televisione
della Cei, conferenza episcopale italiana. In realtà, ne aveva già parlato il 22
marzo, incontrando nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, i
membri dell’Associazione ”Corallo”, network di emittenti locali di ispirazione
cattolica presenti in tutte le regioni italiane. Ora c’è tornato sopra, ora ci
batte il chiodo. Si vede che gli sta a cuore la cosa, e come dargli torto.
Evidentemente non parlava solo ai giornalisti cattolici, papa Francesco, e
quindi siamo tutti chiamati in causa. «Di questi tre peccati, la calunnia – ha
continuato Francesco – sembra il più grave perché colpisce le persone con
giudizi non veri. Ma in realtà il più grave e pericoloso è la disinformazione,
perché ti porta all’errore, ti porta a credere solo a una parte della verità».
Era stato anche più dettagliato nell’argomentazione il 22 marzo: «La calunnia è
peccato mortale, ma si può chiarire e arrivare a conoscere che quella è una
calunnia. La diffamazione è peccato mortale, ma si può arrivare a dire: questa è
un’ingiustizia, perché questa persona ha fatto quella cosa in quel tempo, poi si
è pentita, ha cambiato vita. Ma la disinformazione è dire la metà delle cose,
quelle che sono per me più convenienti, e non dire l’altra metà. E così, quello
che vede la tv o quello che sente la radio non può fare un giudizio perfetto,
perché non ha gli elementi e non glieli danno».
Sono i falsari dell’informazione, i peccatori più
gravi.
«E io a lui: “Chi son li due tapini
che fumman come man bagnate ’l verno,
giacendo stretti a’ tuoi destri confini?”.
L’una è la falsa ch’accusò Gioseppo;
l’altr’è ’l falso Sinon greco di Troia:
per febbre aguta gittan tanto leppo».
Così Dante descrive nel Canto XXX dell’Inferno la
sorte di due “falsari”, la moglie di Putifarre e Sinone. Sinone è quello che
convinse i Troiani raccontando un sacco di panzane che quelli si bevvero come
acqua fresca e fecero entrare il cavallo di legno, dentro cui si erano nascosti
gli Achei che così presero la città. La moglie di Putifarre, ricco signore
d’Egitto – così si racconta nella Genesi –, invece, s’era incapricciata del
giovane schiavo Giuseppe, cercando di sedurlo. Solo che Giuseppe non ci sentiva
da quell’orecchio. Offesa dal rifiuto del giovane, la donna si vendicò
accusandolo di aver tentato di farle violenza. Per questa falsa accusa Giuseppe
fu gettato nelle prigioni del Faraone. Eccolo, il “leppo” dantesco, che è un
fumo puzzolente. E fumo puzzolente si leva dalle pagine dei giornali di
disinformacija all’italiana.
Durante la Guerra fredda i russi si erano
specializzati nel diffondere informazioni false e mezze verità: raccontavano un
sacco di balle sui propri progressi, o magnificavano le sorti delle nazioni che
erano sotto l’orbita del comunismo, e nello stesso tempo imbrogliavano le carte
su quello che succedeva nell’Occidente maledettamente capitalistico. Pure gli
americani avevano la loro disinformacija. Le loro porcherie diventavano
battaglie di libertà e le puttanate che compivano erano gesti necessari per
difendere la democrazia dall’orso russo e dai cavalli cosacchi. Fare
disinformaciija non è banale, non è che ti metti a strillare le stronzate, è un
lavoro sottile. Quel cervellone di Chomsky – e ne capisce della questione, visto
che è un linguista – riferendosi alle falsificazioni delle prove e delle fonti
l’ha definita “ingegneria storica”. Devi orientare l’opinione pubblica,
mescolando verità e menzogna; devi sminuire l’importanza e l’attenzione su un
evento dandogli una scarsa visibilità e, all’opposto, ingigantire gli spazi
informativi su questioni di secondaria importanza; devi negare l’evidenza
inducendo al dubbio e all’incredulità. Insomma, è un lavoraccio, che presuppone
una vera e propria “macchina disinformativa”. Cioè, i giornali. «Ciò che fa bene
alla comunicazione è in primo luogo la parresia, cioè il coraggio di parlare con
franchezza e libertà», ha aggiunto papa Francesco. Ha ragione papa Francesco,
ragione da vendere. Qualunque direttore di giornale, qualunque editore,
qualunque comitato di redazione, qualunque corso dell’ordine dei giornalisti, ti
dirà che questi, della franchezza e della libertà, sono i cardini del lavoro
dell’informazione. Ma sono chiacchiere. Francesco, invece, non fa chiacchiere. E
magari succede che domani troveremo in qualche piazza dei dazebao o dei
volantini sotto le nostre porte con la sua firma.
Dalla prova scientifica a quella dichiarativa,
passando per il legame tra magistratura e giornalismo. Il dibattito sul processo
penale organizzato il 12 dicembre 2014 a Palmi, in provincia di Reggio Calabria,
nell’auditorium della Casa della Cultura intitolata a Leonida Repaci dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati con la collaborazione del Comune e della
Camera penale, è stato molto più di un semplice dibattito, andato oltre gli
aspetti prettamente giuridici, scrive Viviana Minasi su “Il Garantista”. Si è
infatti parlato a lungo del legame che esiste tra la magistratura e il
giornalismo, quel giornalismo che molto spesso trasforma in veri e propri eventi
mediatici alcuni processi penali o fatti di cronaca nera. Se ne è parlato con il
direttore de Il Garantista Piero Sansonetti, il Procuratore di Palmi Emanuele
Crescenti, il presidente del Tribunale di Palmi Maria Grazia Arena, l’onorevole
Armando Veneto, presidente della Camera penale di Palmi e con il presidente del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Francesco Napoli. Tanti gli ospiti presenti
in questa due giorni dedicata al processo penale. Al direttore Sansonetti il
compito di entrare nel vivo del dibattito, puntando quindi l’attenzione su
quella sorta di “alleanza” tra magistratura e giornalismo, a volte tacita. «Mi
piacerebbe apportare una correzione alla locandina di questo evento, ha detto
ironicamente Sansonetti – scrivendo “Giornalismo è giustizia”, invece che
“Giornalismo e giustizia”. Perché? Perché molto spesso, soprattutto negli ultimi
decenni, è successo che i processi li ha fatti il giornalismo, li abbiamo fatti
noi insieme ai magistrati». Fatti di cronaca quali il disastro della Concordia,
Cogne, andando indietro negli anni anche Tangentopoli, fino a giungere
all’evento che ha catalizzato l’attenzione dei media nazionali negli ultimi
giorni, l’inchiesta su Mafia Capitale, sono stati portati alla ribalta dal
giornalismo, magari a danno di altri eventi altrettanto importanti che però
quasi cadono nell’oblio. «Ci sono eventi di cronaca che diventano spettacolo –
ha proseguito il direttore Sansonetti – e questo accade quando alla stampa un
fatto interessa, quando noi giornalisti fiutiamo “l’affare”». Sansonetti ha poi
parlato di un principio importante tutelato dall’articolo 111 della
Costituzione, l’articolo che parla del cosiddetto “giusto processo”, che in
Italia sarebbe sempre meno applicato, soprattutto nella parte in cui si parla
dell’informazione di reato a carico di un indagato. «Sempre più spesso accade
che l’indagato scopre di essere indagato leggendo un giornale, o ascoltando un
servizio in televisione, e non da un magistrato». Su Mafia Capitale, Sansonetti
ha lanciato una frecciata al Procuratore capo di Roma Pignatone, definendo un
«autointralcio alla giustizia» la comunicazione data in conferenza stampa,
relativa a possibili altri blitz delle forze dell’ordine, a carico di altri
soggetti che farebbero parte della “cupola”. Suggestivo anche l’intervento di
Giuseppe Sartori, ordinario di neuropsicologia forense all’università di Padova,
che ha relazionato su “tecniche di analisi scientifica del testimone”. Secondo
quanto affermato da Sartori, le testimonianze nei processi, ma non solo, sono
quasi sempre inattendibili. Il punto di partenza di questa affermazione è uno
studio scientifico condotto su circa 1500 persone, che ha dimostrato come la
testimonianza è deviata e deviabile, sia dal ricordo sia dalle domande che
vengono poste al testimone. Un caso che si sarebbe evidenziato soprattutto nelle
vicende che riguardano le molestie sessuali, nelle quali il ricordo è fortemente
suggestionabile dal modo in cui vengono poste le domande. Il convegno era stato
introdotto dall’ex sottosegretario del primo governo Prodi ed ex
europarlamentare Armando Veneto, figura di primo piano della Camera penale di
Palmi. L’associazione dei penalisti da anni è in prima linea per
controbilanciare il “potere” (secondo gli avvocati) che la magistratura
inquirente avrebbe nel distretto giudiziario di Reggio Calabria e il peso
preponderante di cui la pubblica accusa godrebbe nelle aule di giustizia. Le
posizione espresse da Veneto, anche all’interno della camera penale di Palmi,
sono ormai state recepite da due generazioni di avvocati penalisti.
Purtroppo, però, in Italia non cambierà mai nulla.
Mamma l’italiani, canzone del 2010 di Après La
Class
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani
mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani
mancu li ca
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani
mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani
mancu li ca
nei secoli dei secoli girando per il mondo
nella pizzeria con il Vesuvio come sfondo
non viene dalla Cina non è neppure americano
se vedi uno spaccone è solamente un italiano
l'italiano fuori si distingue dalla massa
sporco di farina o di sangue di carcassa
passa incontrollato lui conosce tutti
fa la bella faccia fa e poi la mette in culo a
tutti
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani
mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani
mancu li ca
a suon di mandolino nascondeva illegalmente
whisky e sigarette chiaramente per la mente
oggi è un po' cambiato ma è sempre lo stesso
non smercia sigarette ma giochetti per il sesso
l'italiano è sempre stato un popolo emigrato
che guardava avanti con la mente nel passato
chi non lo capiva lui lo rispiegava
chi gli andava contro è saltato pure in a...
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani
mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani
mancu li ca
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani
mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani
mancu li ca
l'Italia agli italiani e alla sua gente
è lo stile che fa la differenza chiaramente
genialità questa è la regola
con le idee che hanno cambiato tutto il corso
della storia
l'Italia e la sua nomina e un alta carica
un eredità scomoda
oggi la visione italica è che
viaggiamo tatuati con la firma della mafia
mafia mafia mafia
non mi appartiene none no questo marchio di
fabbrica
aria aria aria
la gente è troppo stanca è ora di cambiare aria
mafia mafia mafia
non mi appartiene none no questo marchio di
fabbrica
aria aria aria
la gente è troppo stanca è ora di cambiare aria
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani
mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani
mancu li ca
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani
mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani
mancu li ca
vacanze di piacere per giovani settantenni
all'anagrafe italiani ma in Brasile diciottenni
pagano pesante ragazze intraprendenti
se questa compagnia viene presa con i denti
l'italiano è sempre stato un popolo emigrato
che guardava avanti con la mente nel passato
chi non lo capiva lui lo rispiegava
chi gli andava contro è saltato pure in a...
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani
mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani
mancu li ca
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani
mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani
mancu li ca
spara la famiglia del pentito che ha cantato
lui che viene stipendiato il 27 dallo Stato
nominato e condannato nel suo nome hanno sparato
e ricontare le sue anime non si può più
risponde la famiglia del pentito che ha cantato
difendendosi compare tutti giorni più incazzato
sarà guerra tra famiglie
sangue e rabbia tra le griglie
con la fama come foglie che ti tradirà
mafia mafia mafia
non mi appartiene none no questo marchio di
fabbrica
aria aria aria
la gente è troppo stanca è ora di cambiare aria
mafia mafia mafia
non mi appartiene none no questo marchio di
fabbrica
aria aria aria
la gente è troppo stanca è ora di cambiare aria
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani
mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani
mancu li ca
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani
mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani
mancu li ca
SE IL NEMICO NON LO PUOI BATTERE, FATTELO
AMICO!
Per non farsi stritolare dai poteri forti la
soluzione migliore è entrare a farne parte.
Istruzioni per entrare nella massoneria, scrive
“L’Inkiesta”. Vi siete stancati di subire le decisioni dei poteri forti?
Cambiate tutto ed entrate anche voi nei poteri forti. Se volete partecipare alle
macchinazioni che stabiliscono le sorti del mondo (come impoverire Paesi
all’improvviso, creare scandali, simulare crisi economiche, intrecciare
complotti e affari), allora dovete entrare nella massoneria. Scoprirete forse
che non funziona proprio così, ma almeno vi farete un nuovo giro di amici, che
non fa mai male. Come si fa a diventare massone? Non è semplice. Prima di tutto
bisogna scegliere la loggia che si preferisce. Esistono Riti diversi (scozzese
antico e accettato, di York, di Memphis, etc.), organizzazioni varie, Grandi
Orienti. Sceglietene uno a vostro piacimento. In genere è meglio scegliere
qualcosa vicino a casa, anche solo per motivi pratici. A differenza di altre
organizzazioni, non ci sono tessere né moduli (ma ci sono quote, anche alte, di
iscrizione), anche perché non vengono accettate tutte le persone che vorrebbero
entrare. C’è una selezione all’ingresso. Come spiega il Gran Maestro del Grande
Oriente Italiano, «il percorso che porta all’iniziazione può durare mesi e
anni». Per cominciare, però, pare che basti mandare una mail. Poi verranno loro
a controllare la vostra moralità, verificare se siete interessati davvero (e non
dei perditempo), verificare la vostra tenuta morale e spirituale. Subito dopo,
presentare un certificato con i carichi pendenti e il casellario giudiziale.
Devono essere puliti. Il nome viene sottoposto al giudizio degli altri membri,
che dovranno giudicare sull’ammissione. Una pallina bianca equivale a un sì, una
pallina nera equivale al no. Chi vota no poi deve spiegare i motivi del suo
rifiuto. Se ci sono più di una pallina nera, la richiesta viene sospesa o
addirittura rifiutata. Come vi dicevamo, non è così semplice. La massoneria, a
parte le teorie e i complottismi, avrebbe come scopo “il perfezionamento
dell’uomo”. Gli incontri sarebbero finalizzati a discutere delle tematiche più
importanti per l’umanità, da un punto di vista particolare. Quando arriverà il
momento dell’iniziazione, ci saranno rituali diversi: di sicuro ci sarà un breve
periodo di isolamento, nel quale si riflette sul passo che sta per compiersi.
Poi, arriverà il momento della proclamazione. Lasciamo qui, per descriverlo,
spazio a un grande autore come Lev Tolstoj, che racconta l’iniziazione di Pierre
Bezuchov in Guerra e Pace: Poco dopo avanzò nella stanza buia, non più il retore
di prima, ma il suo mallevadore Willarski, che Pierre riconobbe dalla voce. A
nuove domande circa la fermezza del suo proposito Pierre rispose: «Sì, sì, sono
d'accordo.» E con un sorriso raggiante infantile, con il grasso petto scoperto,
procedendo a passi timidi e ineguali con un piede scalzo e l'altro calzato, si
avvicinò alla spada di Willarski puntata contro il suo petto nudo. Dalla stanza
lo condussero lungo certi corridoi, facendogli fare varie giravolte avanti e
indietro, e infine lo accompagnarono alla porta della loggia. Willarski
tossicchiò e gli venne risposto con i colpi massonici di martello. La porta si
aprì davanti a loro. Una voce di basso (gli occhi di Pierre erano sempre
bendati) gli fece varie domande: chi fosse, dove e quando fosse nato eccetera.
Poi loguidarono in qualche altro posto senza levargli la benda dagli occhi e,
mentre Pierre camminava, gli parlarono sotto forma allegorica delle fatiche del
suo viaggio, della santa amicizia, dell'Eterno Architetto dell'universo, del
coraggio col quale avrebbe dovuto sopportare fatiche e pericoli. Durante questa
peregrinazione Pierre notò che a volte lo chiamavano il cercatore, a volte il
sofferente, a volte il postulante, e nel far questo battevano in modo diverso
con i martelli e con le spade. Mentre lo guidavano verso un punto ignoto, si
accorse che fra le sue guide si era prodotto un certo turbamento, una certa
confusione. Sentì che sottovoce si accendeva tra loro una discussione, e che uno
di essi insisteva affinché egli venisse fatto passare su un tappeto. Dopo di che
gli presero la mano destra, la posarono su qualcosa e gli ordinarono di
appoggiare con la sinistra un compasso sul capezzolo sinistro; infine Pierre
dovette pronunciare il giuramento di fedeltà alle leggi dell'ordine, ripetendo
le parole che qualcuno leggeva. Poi le candele vennero spente, fu acceso
dell'alcool - come Pierre poté indovinare dall'odore - e i massoni dissero che
avrebbe visto la piccola luce. Tolsero la benda a Pierre, e questi, come in
sogno, alla debole luce della fiamma dell'alcool vide alcuni uomini che, in
piedi davanti a lui, indossavano grembiuli simili a quelli del retore e tenevano
delle spade puntate contro il suo petto. Fra loro ce n'era uno con la camicia
bianca insanguinata. Pierre, a quella vista, si protese in avanti col petto
verso le spade, affinché queste lo ferissero. Ma le spade si scostarono da lui e
quasi subito la benda gli venne rimessa sugli occhi. «Adesso hai visto la
piccola luce,» disse una voce. Poi le candele furono di nuovo accese e i massoni
dissero che ora Pierre doveva vedere la luce piena; cosicché ancora la benda gli
venne levata, mentre all'improvviso più di dieci voci esclamavano: sic transit
gloria mundi. A poco a poco Pierre tornava in sé. Cominciò ad osservare la
stanza nella quale si trovava e le persone che gli stavano davanti. Intorno a
una lunga tavola, ricoperta da qualcosa di nero, sedevano una dozzina di
persone, tutte abbigliate come quelle che aveva visto poco prima. Pierre ne
riconobbe alcune appartenenti alla buona società di Pietroburgo. Al posto
presidenziale era seduto un giovane a lui sconosciuto, con una strana croce sul
petto. Alla sua destra sedeva l'abate italiano che Pierre aveva incontrato due
anni prima in casa di Anna Pavlovna. C'erano anche un altissimo dignitario e un
precettore svizzero che un tempo era stato dai Kuragin. Tutti tacevano in modo
solenne, ascoltando le parole del presidente che reggeva nelle mani il martello.
Nel muro era incastrata una stella fiammeggiante; da una parte della tavola si
vedeva un piccolo arazzo con varie figure; dall'altra, una specie di altare con
un Vangelo e un teschio. Intorno alla tavola, poi, c'erano sette grandi
candelabri simili a quelli delle chiese. Due fratelli condussero Pierre fino
all'altare, gli disposero i piedi ad angolo retto e gli ordinarono di coricarsi,
dicendo che egli doveva prosternarsi alle soglie del tempio. «Prima deve
ricevere la cazzuola,» sussurrò uno dei fratelli. «Ah, basta, per piacere,»
disse un altro. Senza obbedire, Pierre si guardò attorno, smarrito, con i suoi
occhi da miope. A un tratto lo colse un dubbio: «Dove sono? Che cosa faccio? Mi
stanno forse prendendo in giro?» Ma questo dubbio durò solo un istante. Egli si
volse a guardare i volti austeri delle persone che lo circondavano, si ricordò
di tutto ciò per cui era passato fino a quel momento, e comprese che non poteva
fermarsi a metà strada. Spaventato dal suo stesso dubbio, cercò di risuscitare
in sé il sentimento di commozione che aveva provato prima, e si prosternò alle
porte del tempio. In effetti quel sentimento di commozione lo assalì con
intensità più forte di prima. Quando ormai era a giacere da qualche tempo, gli
fu ordinato di alzarsi e gli fecero indossare un grembiule bianco eguale a
quello che portavano gli altri; poi gli posero nelle mani una cazzuola e tre
paia di guanti, e a questo punto il grande maestro gli rivolse la parola. Gli
disse che doveva sforzarsi di non macchiare in alcun modo il biancore di quel
grembiule, simbolo della forza e dell'innocenza; poi, a proposito di
quell'inspiegabile cazzuola, disse che egli doveva servirsene per purificare il
proprio cuore dai vizi e per lisciare con indulgenza il cuore del suo prossimo.
Indi, dei primi guanti, di foggia maschile, disse che Pierre ancora non poteva
conoscerne il significato, ma doveva tuttavia conservarli; degli altri, pure
maschili, dichiarò che avrebbe dovuto indossarli alle adunanze; infine, a
proposito dei terzi guanti, femminili, disse: «Amato fratello, anche questi
guanti femminili sono a voi destinati. Consegnateli alla donna che stimerete più
di ogni altra. Con questo dono convincerete della purezza del vostro cuore colei
che eleggerete a degna compagna nell'ordine dei liberi muratori.» Dopo una breve
pausa il gran maestro aggiunse: «Ma procura, amato fratello, che codesti guanti
non adornino mani impure.» Mentre il gran maestro pronunciava queste ultime
parole, parve a Pierre che il presidente si turbasse. Pierre si turbò ancor più,
si fece rosso fino al limite delle lacrime, come arrossiscono i bambini, e
cominciò a guardarsi attorno con aria inquieta. Ci fu un silenzio imbarazzato,
rotto alla fine da uno dei fratelli che, conducendo Pierre presso l'arazzo,
cominciò a leggere da un quaderno la spiegazione delle figure che vi apparivano:
il sole, la luna, il martello, l'archipendolo, la cazzuola, una pietra grezza,
un'altra squadrata a cubo, una colonna, tre finestre eccetera. Poi assegnarono a
Pierre il suo posto, gli mostrarono i segni della loggia, gli rivelarono la
parola d'ordine per poter entrare, e finalmente gli concessero di sedersi. Il
gran maestro prese a leggere lo statuto. Questo statuto era molto lungo e
Pierre, per i diversi sentimenti di gioia, di emozione e di vergogna, non era in
grado di capire ciò che veniva letto. Pose mente soltanto alle ultime parole
dello statuto, che gli restarono impresse nella memoria. «Nei nostri templi non
conosciamo altri ranghi,» leggeva il gran maestro, «se non quelli dati dalla
virtù e dal vizio. Guardati dall'operare qualsiasi differenza che possa violare
l'eguaglianza. Vola in aiuto del fratello, chiunque egli sia; ammaestra chi
sbaglia; risolleva chi cade e non nutrire mai ira o inimicizia contro il
fratello. Sii affabile e ospitale. Desta in tutti i cuori il fuoco della virtù.
Condividi la felicità del prossimo tuo e mai l'invidia offuschi questa pura
gioia. Perdona il tuo nemico, non vendicarti di lui se non, forse, facendogli
del bene. Adempiendo in tal modo alla legge suprema, tu ritroverai le tracce
della grandezza antica da te perduta,» concluse. Poi si alzò in piedi, abbracciò
Pierre e lo baciò. Pierre si guardava attorno con gli occhi colmi di lacrime di
gioia e non sapeva con quali parole rispondere alle congratulazioni e alle
proteste di antica conoscenza di chi lo circondava. Egli non ammetteva nessuna
vecchia conoscenza; in tutte quelle persone ravvisava soltanto dei fratelli coi
quali ardeva dall'impazienza di mettersi all'opera. Il gran maestro batté un
colpo di martello; tutti sedettero ai loro posti, e uno lesse un sermone sulla
necessità di essere umili.
I massoni scendono in campo: pronto il
partito dei Maestri, scrive “Libero Quotidiano”. Si
prepara a scendere in campo il partito
dei Massoni. L'annuncio è arrivato a Milano, in occasione della
presentazione del libro Massoni, di
Gioele Magaldi, Gran Maestro
del movimento massonico "Grande Oriente Democratico" (God) . Una presentazione
affollata, quella alla Casa della cultura del capoluogo meneghino, nel corso
della quale Magaldi ha annunciato la volontà di varare una rete di "massoni
progressisti" pronti a scendere in campo con quello che verrà chiamato
Movimento Roosvelt. L'obiettivo
programmatico è la difesa dei valori storici delle grandi rivoluzioni, francese
ed americana. Si tratterà, spiega sempre Magaldi, di una rete "a difesa di
un'Italia lontana dalle tecnocrazie europee e che esalterà il ruolo degli
individui e della società civile e della pubblica opinione". Rispondendo al
direttore di Affaritaliani.it, Magaldi ha rimarcato: "Sto fondando un
movimento meta-partitico ma che è anche politico. L'obiettivo non è creare
ulteriori divisioni ma riunire ciò che è sparso. E se riusciamo a migliorare i
partiti esistenti bene, altrimenti se ciò non accade nel giro di 2, 3 o 4 anni
non escludo di trasformare questa cosa in
un vero soggetto politico". Un
progetto a medio-lungo termine, dunque, al termine del quale la massoneria
potrebbe scendere in campo con il suo partito. Il Gran Maestro aggiunge: "Non ho
l'urgenza di fare un partito politico, ma l'orizzonte medio dei partiti attuali
è quello di coltivare piccole ambizioni personali, mentre
la nostra ambizione è quella
collettiva di tante persone. C'è anche una certa spavalderia garibaldina che fa
bene, d'altronde - sottolinea - i
garibaldini sono stati tutti eroi. Il mio sogno - conclude - è
quello di concorrere a declinare in modo globale i diritti universali e quello
di promuovere una democrazia sostanziale in Italia, in Europa e nel mondo". Nel
corso della presentazione milanese del libro, Magaldi, sollecitato dalle domande
dei relatori e del pubblico, ha riletto
la storia della Massoneria a
partire dal '700 e dalla Rivoluzione francese. Nel suo discorso, ha snocciolato
una serie di nomi definiti inaspettatamente "fratelli": tra questi
Papa Giovanni e Mario Draghi,
ma anche Giorgio Napolitano e Barack
Obama. E ancora Vladimir Putin e Margaret Thatcher, Angela
Merkel e il califfo del terrore, Abu
Bakr Al-Baghdadi, Francois Hollande, Christine Lagarde e
addirittura Gandhi e Martin Luther King.
Massoneria, il libro choc di Gioele
Magaldi: "Società a responsabilità illimitata", scrive
“Libero Quotidiano”. Sarà presentato domani a Roma il libro, anticipato ieri dal
sito affaritaliani.it, "Massoni società a responsabilità illimitata" a cura di
Gioele Magaldi.
L'opera, che ha tutte le carte in regola per figurare come il manoscritto più
sconcertante, inaspettato e comunque disorientate dell'anno, esce con il
seguente sottotitolo: "La scoperta delle Ur-Lodges", come recita il font bianco
su copertina violacea edita da Chiarelettere Editore. Ma cosa sono le Ur-lodges? "Superlogge sovranazionali che vantano
l'affiliazione di presidenti, banchieri, industriali" in cui "nessuno sfugge a
questi cenacoli" a dirla con Il Fatto quotidiano di oggi che, proprio
sul cartaceo di questa mattina, mercoledì 19 novembre, analizza l'opera di
Magaldi, presentato dal quotidiano di Antonio Padellaro come "libero muratore di
matrice progressista". Ad essere particolarmente interessante è proprio il
capitolo finale del libro in cui è presente un colloquio tra Magaldi e altri
confratelli collaboratori con quattro supermassoni di queste fantomatiche
"Ur-Lodges". Uno di loro, racconta: "Per far inghiottire simili
riforme idiote e
antipopolari alla cittadinanza,
la devi spaventare come si fa con i bambini. Altrimenti gli
italiani, se non fossero stati dei
bambinoni deficienti, non
avrebbero accolto con le fanfare i tre commissari dissimulati che abbiamo
inviato loro in successione: il fratello
Mario Monti, il
parafratello Enrico Letta,
l’aspirante fratello Matteo Renzi".
Mario Draghi,
governatore della Bce, sarebbe, a sentire quel che dice Magaldi "affiliato
a ben cinque superlogge."
Poi nella parte finale del manoscritto, l'autore snocciola, l'elenco degli
italiani inseriti nelle Ur-Lodges, in cui, oltre al già citato Mario Draghi,
figurerebbero "Giorgio Napolitano, Mario
Monti, Fabrizio
Saccomanni, Pier Carlo
Padoan, Massimo
D’Alema, Gianfelice Rocca,
Domenico Siniscalco, Giuseppe Recchi, Marta Dassù, Corrado
Passera, Ignazio Visco, Enrico
Tommaso Cucchiani, Alfredo Ambrosetti, Carlo Secchi, Emma
Marcegaglia, Matteo Arpe,
Vittorio Grilli, Giampaolo Di Paola, Federica Guidi. Berlusconi, invece, avrebbe
creato una Ur-Lodge personale, la Loggia del Drago".
Massoneria, libro shock del gran maestro
Magaldi: “Ecco i potenti nelle logge”. Centinaia di
nomi, tra cui Napolitano, Obama, Draghi, Bin Laden e Papa Giovanni XXIII. Tutti
"fratelli" secondo l'autore del volume presentato domani a Roma. Che però dice:
"Le prove le esibiscono soltanto se me le chiede il giudice", scrivono Gianni
Barbacetto e Fabrizio DEsposito su “Il Fatto Quotidiano”. Esistono i massoni e i
supermassoni, le logge e le superlogge. Gioele Magaldi, quarantenne libero
muratore di matrice progressista, ha consegnato all’editore Chiarelettere (che
figura tra gli azionisti di questo giornale) un manoscritto sconcertante e che
sarà presentato domani sera alle 21 a Roma, a Fandango Incontro. Il libro,
anticipato ieri dal sito affaritaliani.it, è intitolato Massoni
società a responsabilità illimitata, ma è nel sottotitolo la chiave di
tutto: La scoperta delle Ur-Lodges. Magaldi, che anni fa ha fondato in
Italia il Grande Oriente Democratico, in polemica con il Grande Oriente
d’Italia, la più grande obbedienza massonica del nostro Paese, in 656 pagine
apre ai profani un mondo segreto e invisibile: tutto quello che accade di
importante e decisivo nel potere è da ricondurre a una cupola di superlogge
sovranazionali, le Ur-Lodges, appunto, che vantano l’affiliazione di presidenti,
banchieri, industriali. Non sfugge nessuno a questi cenacoli. Le Ur-Lodges
citate sono 36 e si dividono tra progressiste e conservatrici e da loro
dipendono le associazioni paramassoniche tipo la Trilateral Commission o il
Bilderberg Group. Altra cosa infine sono le varie gran logge nazionali, ma
queste nel racconto del libro occupano un ruolo marginalissimo. Tranne in un
caso, quello della P2 del Venerabile Licio Gelli. I documenti che mancano sono a
Londra, Parigi e New York. Prima però di addentrarci nelle rivelazioni clamorose
di Massoni è d’obbligo precisare, come fa Laura Maragnani, giornalista di
Panorama che ha collaborato con Magaldi e ha scritto una lunga prefazione,
che l’autore non inserisce alcuna prova o documento a sostegno del suo libro,
frutto di un lavoro durato quattro anni, nei quali ha consultato gli archivi di
varie Ur-Lodges. Tuttavia, come scrive l’editore nella nota iniziale, in caso di
“contestazioni” Magaldi si impegna a rendere pubblici gli atti segreti
depositati in studi legali a Londra, Parigi e New York. Detto questo, andiamo al
dunque non senza aver specificato che tra le superlogge progressiste la più
antica e prestigiosa è la Thomas Paine (cui è stato iniziato lo stesso Magaldi)
mentre tra le neoaristocratiche e oligarchiche, vero fulcro del volume, si
segnalano la Edmund Burke, la Compass Star-Rose, la Leviathan, la Three Eyes, la
White Eagle, la Hathor Pentalpha. Tutto il potere del mondo sarebbe contenuto in
queste Ur-Lodges e finanche i vertici della fu Unione Sovietica, a partire da
Lenin per terminare a Breznev, sarebbero stati superfratelli di una loggia
conservatrice, la Joseph de Maistre, creata in Svizzera proprio da Lenin. Può
sembrare una contraddizione, un paradosso, ma nella commedia delle apparenze e
dei doppi e tripli giochi dei grembiulini può finire che il più grande
rivoluzionario comunista della storia fondi un cenacolo in onore di un caposaldo
del pensiero reazionario. In questo filone, secondo Magaldi, s’inserisce pure
l’iniziazione alla Three Eyes, a lungo la più potente Ur-Lodges conservatrice,
di Giorgio Napolitano, attuale presidente della Repubblica e per mezzo secolo
esponente di punta della destra del Pci: “Tale affiliazione avvenne nello stesso
anno il 1978, nel quale divenne apprendista muratore Silvio Berlusconi. E mentre
Berlusconi venne iniziato a Roma in seno alla P2 guidata da Licio Gelli nel
gennaio, Napolitano fu cooptato dalla prestigiosa Ur-Lodge sovranazionale
denominata Three Architects o Three Eyes appunto nell’aprile del 1978, nel corso
del suo primo viaggio negli Stati Uniti”. Altri affiliati: Papa Giovanni XXIII,
Bin Laden e l’Isis, Martin Luther King e i Kennedy. C’è da aggiungere, dettaglio
fondamentale, che nel libro di Magaldi la P2 gelliana è figlia dei progetti
della stessa Three Eyes, quando dopo il ‘68 e il doppio assassinio di Martin
Luther King e Robert Kennedy, le superlogge conservatrici vanno all’attacco con
una strategia universale di destabilizzazione per favorire svolte autoritarie e
un controllo più generale delle democrazie. “Il vero potere è massone”. E
descritto nelle pagine di Magaldi spaventa e fa rizzare i capelli in testa. Dal
fascismo al nazismo, dai colonnelli in Grecia alla tecnocrazia dell’Ue, tutto
sarebbe venuto fuori dagli esperimenti di questi superlaboratori massonici,
persino Giovanni XXIII (“il primo papa massone”), Osama bin Laden e il più
recente fenomeno dell’Isis. In Italia, se abbiamo evitato tre colpi di Stato
avallati da Kissinger lo dobbiamo a Schlesinger jr., massone progressista.
L’elenco di tutti gli italiani attuali spiccano D’Alema, Passera e Padoan. Il
capitolo finale è un colloquio tra Magaldi e altri confratelli collaboratori con
quattro supermassoni delle Ur-Lodges. Racconta uno di loro, a proposito del
patto unitario tra grembiulini per la globalizzazione: “Ma per far inghiottire
simili riforme idiote e antipopolari alla cittadinanza, la devi spaventare come
si fa con i bambini. Altrimenti gli italiani, se non fossero stati dei bambinoni
deficienti, non avrebbero accolto con le fanfare i tre commissari dissimulati
che abbiamo inviato loro in successione: il fratello Mario Monti, il
parafratello Enrico Letta, l’aspirante fratello Matteo Renzi”. Per non parlare
del “venerabilissimo” Mario Draghi, governatore della Bce, affiliato a ben
cinque superlogge. Ecco l’elenco degli italiani nelle Ur-Lodges: Mario Draghi,
Giorgio Napolitano, Mario Monti, Fabrizio Saccomanni, Pier Carlo Padoan, Massimo
D’Alema, Gianfelice Rocca, Domenico Siniscalco, Giuseppe Recchi, Marta Dassù,
Corrado Passera, Ignazio Visco, Enrico Tommaso Cucchiani, Alfredo Ambrosetti,
Carlo Secchi, Emma Marcegaglia, Matteo Arpe, Vittorio Grilli, Giampaolo Di
Paola, Federica Guidi. Berlusconi, invece, avrebbe creato una Ur-Lodge
personale, la Loggia del Drago. Bisognerà aspettare le “contestazioni”, per
vedere le carte di Magaldi.
Ida Magli: "L'Europa è un continente
inventato, è il trionfo della massoneria", scrive
“Libero Quotidiano”. Nel 2015 compirà 90 anni, gli ultimi 20 passati ad
attaccare l'idea e la realizzazione dell'Europa unita. Lei è
Ida Magli, la celebre
antropologa che 17 anni fa, con il saggio Contro L'Europa, suscitò
parecchio scalpore. Ora torna a ribadire le sue accuse in una lunga intervista
concessa ad Italia Oggi. C'è chi considera la Maglia una Cassandra, chi
invece - per mutuare un termine renziano - una sorta di gufo. Di sicuro, lei,
le idee le ha chiare.
Tempo fa la Magli chiedeva a gran voce lo stop all'unificazione, ma "oggi -
spiega - è difficile. A causa dell'ignoranza tecnica dei politici che, mi creda,
è brutale". Secondo l'antropologa, infatti, "c'è un'indifferenza a qualsiasi
fatto che possa far ripensare a quello che hanno progettato. Sento citare di
nuovo Romano Prodi",
ossia "il responsabile del nostro ingresso nella moneta unica". E oggi,
continua, "con l'euro siamo tutti più poveri". La Magli, prima ancora che contro
la moneta unica, puntava il dito contro il concetto di Europa unita "perché era
un progetto sbagliato. L'Europa è giunta a essere quella che è per la storia
delle varie nazioni che la compongono". E ancora: "Il punto è che
non esiste un'idea di Europa.
Guardi, ho fatto tante ricerche ma non ho mai trovato il delinearsi di un popolo
europeo". L'unificazione, insomma, è stata un errore poiché "non era possibile farla se non
perdendo tutte le ricchezze europee". La Magli prosegue: "Si pensa di poter fare
l'unità così. Così come si è pensato di fare lo stesso con la moneta unica,
dimenticando che la moneta è lo strumento di un popolo e non la si può imporre
fuori dall'economia dei singoli Stati". La Magli, quindi, nell'intervista
ritorna su uno dei concetti che più le stanno a cuore, ossia l'idea che
l'Europa unita altro non si che un progetto massonico. "Certo - rincara - e ora
c'è un libro di un massone, Gioele
Magaldi, che lo conferma. L'ho letto e riletto". L'antropologa
spiega: "La tesi è la seguente: la massoneria ha vinto, tutti i suoi progetti
sono stati realizzati, ora esca allo
scoperto e lavori con trasparenza". Una massoneria che per la
Magli passa da Romano Prodi e fino ad arrivare a
Matteo Renzi e alle sue
riforme, imposte dall'Europa e che si rivelano un male per l'Italia: "Le faccio
un esempio, tratto dalla Legge di stabilità: la
depenalizzazione di alcuni reati". Per la Magli "si
vuole l'imbarbarimento degli italiani, dei belgi, degli inglesi". Nell'ultima
parte della lunga intervista, dopo l'esplicita stroncatura del premier Renzi,
l'antropologa anti-Europa unita dà le pagelle ai politici dell'Italia di oggi.
Si parte da Silvio Berlusconi,
che "vuole salvare se stesso e s'è messo a praticare le larghe intese, che sono
la fine della democrazia". Quindi Beppe
Grillo: "All'inizio ci contavo, e invece... Invece si barcamenta
pure lui: oggi dice una cosa, domani un'altra. Ecco su di lui mi sono
sbagliata". E Matteo Salvini? "Forse ha delle idee, forse. Ma ha anche una
presunzione tale che realizzarle sarà difficile". Del tipo? "La conquista del
Sud, l'uscita dall'euro. E poi di Salvini ho avuto la misura quando si è messo a
nudo...".
Stefano Bisi: «Massoni si nasce. Esserlo
è un pregio» In Italia «troppi pregiudizi» contro le
logge. Che sono invece «luoghi di incontro e dialogo». Il Gran Maestro Bisi a
L43: «Siamo un esempio di
trasparenza», scrive Giorgio Velardi su “Lettera 43”. Si intitola Massoni.
Società a responsabilità illimitata. È il libro con cui Gioele Magaldi,
Gran Maestro del Grande Oriente Democratico (God), sta scalando le classifiche
di vendita in Italia. Un testo corposo, oltre 600 pagine nella quali l’autore
bolla i personaggi più influenti della storia contemporanea (da Margareth
Tatcher ad Angela Merkel fino a Mario Draghi, Giorgio Napolitano, Osama Bin
Laden e Barack Obama) come massoni. Si tratta, come ha spiegato lo stesso
Magaldi, dell’inizio di una trilogia che promette altre «sconcertanti»
rivelazioni. Stando alle affermazioni del Gran Maestro del God, oggi «se non sei
massone non hai alcuna chance di arrivare al vero potere». Un’impostazione con
cui non è d’accordo Stefano Bisi, giornalista, eletto il 2 marzo 2014 scorso
Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia (la più numerosa comunione massonica
del nostro Paese) dopo i 15 anni di gran maestranza di Gustavo Raffi. «Quello
dei massoni è un potere spirituale che permette di stare insieme ad altri
fratelli favorendo la crescita interiore del singolo individuo», spiega Bisi a
Lettera43.it. «Magaldi tiri fuori le prove di quanto ha scritto»,
incalza. «I nomi che ha citato nel libro? Sicuramente non fanno parte del Grande
Oriente d’Italia».
DOMANDA. Ha letto
Massoni?
RISPOSTA.
No, non l’ho letto.
D. Lo farà?
R.
Penso di no.
D. Dal libro emerge un quadro nel quale il
governo del mondo sembra essere totalmente conteso dalle Ur-Lodges. È davvero
così come scrive Magaldi?
R.
Facendomi questa domanda lei hai avuto un moto di sorriso. Provo la sua stessa
sensazione…
D. Ancora oggi il termine «massoneria» è
legato a fatti o esperienze poco edificanti. Basta pensare alla P2, che si
trasformò in un’organizzazione criminale ed eversiva.
R.
Non so per quanto tempo ancora ci porteremo dietro la vicenda della P2, che
nacque come loggia massonica del Grande d’Oriente d’Italia deviando poi il suo
corso. Domando a chi ha questa opinione: cosa dovremmo fare per scrollarcela di
dosso?
D. La colpa non deriva dal fatto che,
troppo spesso, delle attività svolte dalle logge o dei nomi dei loro associati
non si sa nulla?
R.
Nel Grande Oriente d’Italia la trasparenza viene già attuata. Chiunque,
collegandosi al nostro sito internet, può reperire informazioni sulle attività
che svolgiamo quotidianamente in tutto il Paese.
D. Tutto alla luce del sole, quindi.
R.
Bisogna avvicinarsi alla libera muratoria del Grande Oriente d’Italia senza
pregiudizi: solo in questo modo si possono comprendere i suoi obiettivi.
D. Però i nomi degli iscritti alle logge,
compresa la sua, sono segreti.
R.
Come lo sono, giustamente, quelli degli aderenti a tutte le altre associazioni o
ai partiti. Ognuno ha diritto alla riservatezza. C’è comunque chi, a tutti i
costi, vorrebbe avere accesso ai nomi dei massoni.
D. In che modo?
R.
Una legge regionale toscana obbliga gli amministratori pubblici a rendere note
tutte le associazioni a cui appartengono. In passato il Friuli-Venezia Giulia
imponeva a chi era dipendente o amministratore pubblico di dichiarare la non
appartenenza alla Massoneria. Nonostante la condannata da parte della Corte
europea dei diritti dell’uomo, pochi giorni fa, nella stessa Regione, ai
candidati a far parte di una specifica commissione è stato domandato se
appartenessero o meno a società di carattere massonico. La trovo una
discriminazione notevole e palese.
D. Di cosa dibattete durante le vostre
riunioni?
R.
Pochi giorni fa ero a Bari, dove sono state innalzate le colonne di una nuova
loggia all’interno del Grande Oriente d’Italia. Si è parlato di armonia.
D. Armonia?
R. Il lavoro all’interno di una loggia è
educativo. In quelle del Grande Oriente d’Italia si parla uno alla volta, non
c’è mai una sovrapposizione delle voci. Non ha ragione chi urla di più, tutti
hanno un loro punto di vista e rispettano quello dell’altro. Il metodo educativo
delle logge dovrebbe essere applicato a tutti i consessi civili e umani.
D. Lei che, se non sbaglio, non proviene
da una famiglia di tradizioni massoniche, come e quando ha capito di voler
intraprendere questa esperienza?
R.
Nel 1977 lessi su l’Espresso i nomi dei Maestri venerabili delle logge
italiane. C’erano anche quelli dei quattro presenti nella mia città, Siena.
Persone fra le più brave che esistevano nel contesto cittadino. Questo
particolare mi incuriosì e da lì iniziai a leggere testi riguardanti la
massoneria.
D. Poi cos’è successo?
R. In
questo percorso di lettura incontrai un massone con il quale cominciai a
dialogare e il 24 settembre 1982 venni iniziato in una loggia massonica.
D. Il Grande Oriente d’Italia conta circa
22.500 iscritti. Qual è il profilo dei vostri aderenti?
R.
Sono rappresentate tutte le categorie sociali: professionisti, impiegati,
artigiani, commercianti… È una comunione composita.
D. Ci sono anche giovani?
R.
Sì, e il loro numero è in aumento.
D. Quali sono i motivi che oggi spingono
un giovane ad entrare a far parte della Massoneria?
R.
Nel mondo contemporaneo c’è molta confusione. I giovani vedono nelle logge
massoniche luoghi dove si può parlare avendo la sicurezza che chi ti ascolta non
ti giudicherà per quello che dici ma anzi sarà disponibile al confronto. Le
racconto un episodio.
D. Prego.
R.
Alla nostra storica celebrazione del 20 settembre era presente Ermete Realacci,
presidente della commissione Ambiente di Montecitorio, che non è iscritto alla
Massoneria. Al termine dell’incontro l’esponente Pd è stato inseguito da una
giornalista che gli ha chiesto il motivo della sua presenza in quella sede. Lui
ha risposto di essere venuto perché dialoga con tutti, aggiungendo di aver
sentito parlare di solidarietà e nuovi italiani. «Magari» ha concluso «i partiti
discutessero di questi argomenti».
D. Come funziona, tecnicamente, l’ingresso
in una loggia?
R.
Partiamo da un presupposto: massoni si nasce ma si può non diventare se non si
incontra lungo la strada qualcuno che, terminata la fase di osservazione da
parte di alcuni fratelli che già appartengono alla loggia, ti fa presentare la
domanda di ingresso.
D. Continui.
R.
Una volta concluso questo passaggio l’aspirante massone incontrerà più volte i
fratelli esperti, poi la loggia voterà per l’ammissione o la non ammissione. In
caso di esito positivo si svolgerà la cerimonia di iniziazione, che è ampiamente
spiegata nei libri che si sono occupati della massoneria. La mia tegolatura,
termine tecnico che indica questo arco temporale, è durata quattro anni. Il
primo grado è quello di «apprendista libero muratore».
D. Gli altri?
R. I
gradi sono tre: oltre a quello esposto poc’anzi ci sono «Compagno d’arte» e
«Maestro». Ogni loggia ha a capo il «Maestro venerabile». Inoltre, a livello
nazionale, ci sono il «Gran Maestro» e la giunta. A livello circoscrizionale,
infine, figurano i presidenti dei collegi circoscrizionali, cioè i coordinatori
delle attività delle logge a livello regionale.
D. Per i liberi muratori appartenere alla
Massoneria comporta dei costi?
R.
Sì, 180 euro all’anno più un contributo per l’uso della casa massonica che può
variare da città a città.
D. Il suo ruolo prevede un compenso?
R. Il
mio compenso è di 129 mila euro lordi.
D. «La Massoneria ha stima, rispetto e
considerazione per le donne» però «non le ammette nell’Ordine». Perché?
R.
Noi siamo i prosecutori dell’opera dei costruttori di cattedrali, fra i quali
non figuravano donne, e ancora oggi viaggiamo lungo questa tradizione storica.
Nel mondo la Massoneria considerata regolare è quella dove non sono presenti le
donne. Collegati al Grande Oriente d’Italia ci sono però i cosiddetti «capitoli
della stelle d’Oriente» di cui fanno parte mogli, figlie e fidanzate dei massoni
che svolgono soprattutto un’opera filantropica.
D. Ha parlato di «massoneria regolare». Ne
esiste anche una irregolare?
R.
Non lo so, ma periodicamente si leggono strani nomi di nuove logge massoniche.
Sul termine «Massoneria» non c’è un copyright, quindi ognuno può crearne di non
regolari.
D. Veniamo al rapporto con la politica.
Nel testo di Magaldi tutti gli uomini più importanti del pianeta, da Angela
Merkel a Mario Draghi, risultano iscritti alla Massoneria. Matteo Renzi è
definito un «aspirante massone»: il premier vorrebbe entrare a far parte della
Three Eyes, loggia di stampo conservatrice alla quale, sempre secondo l’autore,
appartengono anche il numero uno della Bce e Giorgio Napolitano. Le risulta?
R.
Non ho prove a riguardo. Se Magaldi le ha le tiri fuori. Ciò che posso dire con
certezza è che i nomi che mi ha citato non fanno parte del Grande Oriente
d’Italia.
D. Si vocifera che l’ex sindaco di Firenze
non piaccia troppo ai massoni…
R.
Non so chi abbia messo in giro questa voce. Rispondo dicendo che, positiva o
negativa che sia, ogni massone del Grande Oriente d’Italia è libero di avere una
sua opinione sul premier e di pensare ciò che vuole.
D. Qual è il suo giudizio sul presidente
del Consiglio?
R. Il
parere personale di Stefano Bisi su Matteo Renzi non interessa a nessuno, quello
di Stefano Bisi su Matteo Renzi in qualità di Gran Maestro del Grande Oriente
d’Italia verrebbe sicuramente strumentalizzato. Preferisco quindi astenermi dal
dare giudizi. Noi massoni rispettiamo le istituzioni e chi le governa, abbiamo a
cuore solo il bene dell’Italia.
D. Oggi essere un massone è un pregio o un
difetto?
R.
Personalmente lo ritengo un pregio. Però, purtroppo, nel caso del Friuli-Venezia
Giulia di cui ho parlato prima l’appartenenza a una loggia diventa un difetto e
crea un danno. È il segno che ancora oggi il pregiudizio è duro a morire.
A proposito degli avvocati, si
può dissertare o credere sulla irregolarità degli esami forensi, ma tutti gli
avvocati sanno, ed omertosamente tacciono, in che modo, loro, si sono abilitati
e ciò nonostante pongono barricate agli aspiranti della professione. Compiti
uguali, con contenuto dettato dai commissari d’esame o passato tra i candidati.
Compiti mai o mal corretti. Qual è la misura del merito e la differenza tra
idonei e non idonei? Tra iella e buona sorte?
Noi siamo animali. Siamo
diversi dalle altre specie solo perché siamo viziosi e ciò ci aguzza l’ingegno.
La Superbia-Vanità
(desiderio irrefrenabile di essere superiori, fino al disprezzo di ordini,
leggi, rispetto altrui);
L’Avarizia (scarsa
disponibilità a spendere e a donare ciò che si possiede);
La Lussuria (desiderio
irrefrenabile del piacere sessuale fine a sé stesso);
L’Invidia (tristezza
per il bene altrui, percepito come male proprio);
La Gola (meglio
conosciuta come ingordigia, abbandono ed esagerazione nei piaceri della tavola,
e non solo);
L’Ira (irrefrenabile
desiderio di vendicare violentemente un torto subito);
L’Accidia-Depressione
(torpore malinconico, inerzia nel vivere e nel compiere opere di bene).
Essendo viziosi ci scanneremmo
l’un l’altro per raggiungere i nostri scopi. E periodicamente lo facciamo.
Vari illuminati virtuosi,
chiamati profeti, ci hanno indicato invano la retta via. La via indicata sono i
precetti dettati dalle religioni nate da questi insegnamenti. Le confessioni
religiose da sempre hanno cercato di porre rimedio indicando un essere superiore
come castigatore dei peccati con punizioni postume ed eterne. Ecco perché i vizi
sono detti Capitali.
I vizi capitali sono un
elenco di inclinazioni profonde, morali e comportamentali, dell'anima umana,
spesso e impropriamente chiamati peccati capitali. Questo elenco di vizi
(dal latino vĭtĭum = mancanza, difetto, ma anche abitudine deviata,
storta, fuori dal retto sentiero) distruggerebbero l'anima umana,
contrapponendosi alle virtù, che invece ne promuovono la crescita. Sono ritenuti
"capitali" poiché più gravi, principali, riguardanti la profondità della natura
umana. Impropriamente chiamati "peccati", nella morale filosofica e cristiana i
vizi sarebbero già causa del peccato, che ne è invece il suo relativo effetto.
Una sommaria descrizione dei
vizi capitali comparve già in Aristotele, che li definì gli "abiti del male". Al
pari delle virtù, i vizi deriverebbero infatti dalla ripetizione di azioni, che
formano nel soggetto che le compie una sorta di "abito" che lo inclina in una
certa direzione o abitudine. Ma essendo vizi, e non virtù, tali abitudini
non promuovono la crescita interiore, nobile e spirituale, ma al contrario la
distruggono.
In questo mondo vizioso tutto
ha un prezzo e quasi tutti sono disposti a svendersi per ottenerlo e/ o a
dispensare torti ai propri simili. Ciclicamente i nomi degli aguzzini cambiano,
ma i peccati sono gli stessi.
In questa breve vita senza
giustizia, vissuta in un periodo indefinito, vincono loro: non hanno la ragione,
ma il potere. Questo, però, non impedirà di raccontare la verità contemporanea
nel tempo e nello spazio, affinché ai posteri sia delegata l’ardua sentenza
contro i protagonisti del tempo trattato, per gli altri ci sarà solo l’ignominia
senza fama né gloria o l’anonimato eterno.
“La superficie della Terra
non era ancora apparsa. V’erano solo il placido mare e la grande distesa di
Cielo... tutto era buio e silenzio". Così inizia il Popol Vuh, il libro sacro
dei Maya Quiché che narra degli albori dell’umanità. Il Popol Vuh descrive
questi primi esseri umani come davvero speciali: "Furono dotati di
intelligenza, potevano vedere lontano, riuscivano a sapere tutto quel che è nel
mondo. Quando guardavano, contemplavano ora l'arco del cielo ora la rotonda
faccia della Terra. Contrariamente ai loro predecessori, gli esseri umani
ringraziarono sentitamente gli dei per averli creati. Ma anche stavolta i
creatori si indispettirono. "Non è bene che le nostre creature sappiano tutto, e
vedano e comprendano le cose piccole e le cose grandi". Gli dei tennero dunque
consiglio: "Facciamo che la loro vista raggiunga solo quel che è vicino,
facciamo che vedano solo una piccola parte della Terra! Non sono forse per loro
natura semplici creature fatte da noi? Debbono forse anch'essi essere dei?
Debbono essere uguali a noi, che possiamo vedere e sapere tutto? Ostacoliamo
dunque i loro desideri... Così i creatori mutarono la natura delle loro
creature. Il Cuore del Cielo soffiò nebbia nei loro occhi, e la loro vista si
annebbiò, come quando si soffia su uno specchio. I loro occhi furono coperti, ed
essi poterono vedere solo quello che era vicino, solo quello che ad essi
appariva chiaro."
E’ comodo definirsi scrittori
da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere
“C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di
scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri
scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale.
Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima
non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli
altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi
non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei
miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Ha
mai pensato, per un momento, che c’è qualcuno che da anni lavora indefessamente
per farle sapere quello che non sa? E questo al di là della sua convinzione di
sapere già tutto dalle sue fonti? Provi a leggere un e-book o un book di Antonio
Giangrande. Scoprirà, cosa succede veramente nella sua regione o in riferimento
alla sua professione. Cose che nessuno le dirà mai. Non troverà le cose ovvie
contro la Mafia o Berlusconi o i complotti della domenica. Cose che servono solo
a bacare la mente. Troverà quello che tutti sanno, o che provano sulla loro
pelle, ma che nessuno ha il coraggio di raccontare. Può anche non leggere questi
libri, frutto di anni di ricerca, ma nell’ignoranza imperante che impedisce
l’evoluzione non potrà dire che la colpa è degli altri e che gli altri son tutti
uguali. “Pensino ora i miei venticinque lettori che impressione dovesse fare
sull'animo del poveretto, quello che s'è raccontato”. Citazione di Alessandro
Manzoni.
Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio
i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Antonio Giangrande, perché è
diverso dagli altri?
Perché lui spiega cosa è la
legalità, gli altri non ne parlano, ma ne sparlano.
La legalità è un comportamento
conforme alla legge ed ai regolamenti di attuazione e la sua applicazione
necessaria dovrebbe avvenire secondo la comune Prassi legale di riferimento.
Legge e Prassi sono le due
facce della stessa medaglia.
La Legge è votata ed emanata
in nome del popolo sovrano. I Regolamenti di applicazione sono predisposti dagli
alti Burocrati e già questo non va bene. La Prassi, poi, è l’applicazione della
Legge negli Uffici Pubblici, nei Tribunali, ecc., da parte di un Sistema di
Potere che tutela se stesso con usi e consuetudini consolidati. Sistema di
Potere composto da Caste, Lobbies, Mafie e Massonerie.
Ecco perché vige il detto: La
Legge si applica per i deboli e si interpreta per i forti.
La correlazione tra Legge e
Prassi e come quella che c’è tra il Dire ed il Fare: c’è di mezzo il mare.
Parlare di legge, bene o male,
ogni leguleio o azzeccagarbugli o burocrate o boiardo di Stato può farlo. Più
difficile per loro parlar di Prassi generale, conoscendo loro signori solo la
prassi particolare che loro coltivano per i propri interessi di privilegiati.
Prassi che, però, stanno attenti a non svelare.
Ed è proprio la Prassi che
fotte la Legge.
La giustizia che debba essere
uguale per tutti parrebbe essere un principio che oggi consideriamo
irrinunciabile, anche se non sempre pienamente concretizzabile nella pratica
quotidiana. Spesso assistiamo a fenomeni di corruzione, all’applicazione della
legge in modo diverso secondo i soggetti coinvolti. E l’la disfunzione è insita
nella predisposizione umana.
Essa vien da lontano.
E’ lo stesso Alessandro
Manzoni che parla di “Azzeccagarbugli” genuflessi ai mafiosi del tempo al
capitolo 3 dei “Promessi Sposi”. Ma non sarebbe stato il Manzoni a coniare
l’accoppiata tra il verbo “azzeccare” e il sostantivo “garbuglio” stante che
quando la parola entrò nei “Promessi Sposi”, aveva un’età superiore ai tre
secoli. Il primo ad usarla fu Niccolò Machiavelli che, in un passo delle
"Legazioni" (1510), scrive: “Voi sapete che i mercatanti vogliono fare le cose
loro chiare e non azzeccagarbugli”. Questa spiegazione si trova nel Dizionario
italiano ragionato e nel Dizionario etimologico di Cortelazzo-Zolli mentre gli
altri vocabolari si limitano a indicare soltanto la matrice manzoniana. È giusto
dare a Niccolò quello che è di Niccolò, ricordando inoltre che il Manzoni era un
conoscitore dell’opera di Machiavelli ed è probabile che sia stato ispirato dal
citato passo. Non si dimentichi, infatti, che nella prima stesura dei “Promessi
Sposi” il personaggio si chiamava “dotor Pe’ ttola” e non Azzeccagarbugli.
La legge non era uguale per
tutti anche nel Seicento, secolo di soprusi e di prepotenze da parte dei
potenti. Renzo cerca giustizia recandosi da un noto avvocato del tempo, ma,
allora come oggi, la giustizia non sta dalla parte degli oppressi, bensì da
quella degli oppressori.
Azzecca-garbugli è
un personaggio del romanzo storico ed è il soprannome di un avvocato di Lecco,
chiamato, nelle prime edizioni del romanzo, dottor Pettola e dottor Duplica
(nell'edizione definitiva il nome non viene mai detto, ma solo il soprannome).
Il nome costituisce un'italianizzazione del termine dialettale milanese zaccagarbùj che
il Cherubini traduce "attaccabrighe". Viene chiamato così dai popolani per la
sua capacità di sottrarre dai guai, non del tutto onestamente, le persone.
Spesso e volentieri aiuta i Bravi, poiché, come don Abbondio, preferisce stare
dalla parte del più forte, per evitare una brutta fine.
Renzo Tramaglino giunge da
lui, nel capitolo III, per chiedere se ci fosse una grida che avrebbe
condannato don Rodrigo, ma lui sentendo nominare il potente signore, respinge
Renzo perché non avrebbe potuto contrastare la sua potente autorità. Egli
rappresenta quindi un uomo la cui coscienza meschina è asservita agli interessi
dei potenti. Compare anche nel capitolo quinto quando fra Cristoforo va al
palazzotto di don Rodrigo e lo trova fra gli invitati al banchetto che si sta
tenendo a casa appunto di don Rodrigo.
Apparentemente, è un uomo di
legge molto erudito, e nel suo studio è presente una notevole quantità di libri,
il cui ruolo principale, però, è quello di elementi decorativi piuttosto che di
materiale di studio. Il suo tavolo invece è cosparso di fogli che impressionano
gli abitanti del paese che vi si recano. In realtà non consulta libri da molti
anni addietro, quando andava a Milano per qualche causa d'importanza.
Il suo nome Azzeccagarbugli è
dovuto dal fatto che Azzecca significa "indovinare" e garbugli "cose non
giuste", quindi: Indovinare cose non giuste.
Azzeccagarbugli è la figura
centrale del Capitolo 3°, è un avvocato venduto, è un miserabile e il Manzoni
pur non dicendolo apertamente ce lo fa capire descrivendocelo appunto negli
aspetti più negativi. Di questo personaggio emerge una grande miseria morale:
ciò che preme all'avvocato è di assicurarsi il favore di don Rodrigo anche se
per ottenere questo deve calpestare quella giustizia della quale dovrebbe essere
servitore. Il Dottor Azzeccagarbugli è una figurina vista di scorcio, ma pur
limpida e interessante. E' un leguleio da strapazzo, ma abile la sua parte a
ordire garbugli per imbrogliare le cose, come lui stesso confessa a Renzo. Ci
vuole la conoscenza del codice, è necessario saper interpretare le gride, ma per
lui valgono sopra tutto le arti per ingarbugliare i clienti. Tale è la morale di
questo tipo di trappolone addottorato, comunissimo in ogni società. Il Manzoni
lo ha ricreato di una specifica individualità esteriore, nell'eloquio profuso, a
volte enfatico e sentenzioso, a volte freddo e cavilloso, grave e serio nella
posa di uomo di alte cure, pieno di sussiego nella sua mimica istrionica. Don
Rodrigo lo ha caro, come complice connivente nei suoi delittuosi disegni, mentre
il dottore accattando protezione col servilismo e l'adulazione, scrocca lauti
pranzi. Alcuni osservano, e non a torto, che in questo personaggio il Manzoni
abbia voluto farsi beffe dei legulei dalla coscienza facile.
"«Non facciam niente, –
rispose il dottore, scotendo il capo, con un sorriso, tra malizioso e
impaziente. – Se non avete fede in me, non facciam niente. Chi dice le bugie al
dottore, vedete figliuolo, è uno sciocco che dirà la verità al giudice.
All’avvocato bisogna raccontar le cose chiare: a noi tocca poi a imbrogliarle.
Se volete ch’io v’aiuti, bisogna dirmi tutto, dall’a fino alla zeta, col cuore
in mano, come al confessore. Dovete nominarmi la persona da cui avete avuto il
mandato: sarà naturalmente persona di riguardo; e, in questo caso, io anderò da
lui, a fare un atto di dovere. Non gli dirò, vedete, ch’io sappia da voi, che
v’ha mandato lui: fidatevi. Gli dirò che vengo ad implorar la sua protezione,
per un povero giovine calunniato. E con lui prenderò i concerti opportuni, per
finir l’affare lodevolmente. Capite bene che, salvando sé, salverà anche voi. Se
poi la scappata fosse tutta vostra, via, non mi ritiro: ho cavato altri da
peggio imbrogli… Purché non abbiate offeso persona di riguardo, intendiamoci,
m’impegno a togliervi d’impiccio: con un po’ di spesa, intendiamoci. Dovete
dirmi chi sia l’offeso, come si dice: e, secondo la condizione, la qualità e
l’umore dell’amico, si vedrà se convenga più di tenerlo a segno con le
protezioni, o trovar qualche modo d’attaccarlo noi in criminale, e mettergli una
pulce nell’orecchio; perché, vedete, a saper ben maneggiare le gride, nessuno è
reo, e nessuno è innocente. In quanto al curato, se è persona di giudizio, se ne
starà zitto; se fosse una testolina, c’è rimedio anche per quelle. D’ogni
intrigo si può uscire; ma ci vuole un uomo: e il vostro caso è serio, vi dico,
serio: la grida canta chiaro; e se la cosa si deve decider tra la giustizia e
voi, così a quattr’occhi, state fresco. Io vi parlo da amico: le scappate
bisogna pagarle: se volete passarvela liscia, danari e sincerità, fidarvi di chi
vi vuol bene, ubbidire, far tutto quello che vi sarà suggerito.»
Mentre il dottore mandava
fuori tutte queste parole, Renzo lo stava guardando con un’attenzione estatica,
come un materialone sta sulla piazza guardando al giocator di bussolotti, che,
dopo essersi cacciata in bocca stoppa e stoppa e stoppa, ne cava nastro e nastro
e nastro, che non finisce mai. Quand’ebbe però capito bene cosa il dottore
volesse dire, e quale equivoco avesse preso, gli troncò il nastro in bocca,
dicendo: – oh! signor dottore, come l’ha intesa? l’è proprio tutta al rovescio.
Io non ho minacciato nessuno; io non fo di queste cose, io: e domandi pure a
tutto il mio comune, che sentirà che non ho mai avuto che fare con la giustizia.
La bricconeria l’hanno fatta a me; e vengo da lei per sapere come ho da fare per
ottener giustizia; e son ben contento d’aver visto quella grida.
- Diavolo! – esclamò il
dottore, spalancando gli occhi. – Che pasticci mi fate? Tant’è; siete tutti
così: possibile che non sappiate dirle chiare le cose?
- Ma mi scusi; lei non m’ha
dato tempo: ora le racconterò la cosa, com’è. Sappia dunque ch’io dovevo sposare
oggi, – e qui la voce di Renzo si commosse, – dovevo sposare oggi una giovine,
alla quale discorrevo, fin da quest’estate; e oggi, come le dico, era il giorno
stabilito col signor curato, e s’era disposto ogni cosa. Ecco che il signor
curato comincia a cavar fuori certe scuse… basta, per non tediarla, io l’ho
fatto parlar chiaro, com’era giusto; e lui m’ha confessato che gli era stato
proibito, pena la vita, di far questo matrimonio. Quel prepotente di don
Rodrigo…
- Eh via! – interruppe
subito il dottore, aggrottando le ciglia, aggrinzando il naso rosso, e storcendo
la bocca, – eh via! Che mi venite a rompere il capo con queste fandonie? Fate di
questi discorsi tra voi altri, che non sapete misurar le parole; e non venite a
farli con un galantuomo che sa quanto valgono. Andate, andate; non sapete quel
che vi dite: io non m’impiccio con ragazzi; non voglio sentir discorsi di questa
sorte, discorsi in aria.
- Le giuro…
- Andate, vi dico: che
volete ch’io faccia de’ vostri giuramenti? Io non c’entro: me ne lavo le mani -.
E se le andava stropicciando, come se le lavasse davvero. – Imparate a parlare:
non si viene a sorprender così un galantuomo.
- Ma senta, ma senta, –
ripeteva indarno Renzo: il dottore, sempre gridando, lo spingeva con le mani
verso l’uscio; e, quando ve l’ebbe cacciato, aprì, chiamò la serva, e le disse:
– restituite subito a quest’uomo quello che ha portato: io non voglio niente,
non voglio niente.
Quella donna non aveva mai,
in tutto il tempo ch’era stata in quella casa, eseguito un ordine simile: ma era
stato proferito con una tale risoluzione, che non esitò a ubbidire. Prese le
quattro povere bestie, e le diede a Renzo, con un’occhiata di compassione
sprezzante, che pareva volesse dire: bisogna che tu l’abbia fatta bella. Renzo
voleva far cerimonie; ma il dottore fu inespugnabile; e il giovine, più attonito
e più stizzito che mai, dovette riprendersi le vittime rifiutate, e tornar al
paese, a raccontar alle donne il bel costrutto della sua spedizione."
A Parlar di azzeccagarbugli
non vi pare che si parli dei nostri contemporanei legulei togati, siano essi
magistrati od avvocati?
Additare i difetti altrui è
cosa che tutti sanno fare, più improbabile è indicare e correggere i propri.
Non abbiamo bisogno di eroi,
né, tantomeno, di mistificatori con la tonaca (toga e divisa). L’abito non fa il
monaco. La legalità non va promossa solo nella forma, ma va coltivata anche
nella sostanza. E’ sbagliato ergersi senza meriti dalla parte dei giusti.
Se scrivi e dici la verità con
il coraggio che gli altri non hanno, il risultato non sarà il loro rinsavimento
ma l’essere tu additato come pazzo. Ti scontri sempre con la permalosità di
magistrati e giornalisti e la sornionità degli avvocati avvezzi solo ai loro
interessi. Categorie di saccenti che non ammettono critiche. Se scrivi e sei del
centro-nord Italia, i conterranei diranno: che bel libro, bravo, è uno di noi.
Se scrivi e sei del centro-sud Italia i conterranei diranno: quel libro l’avrei
scritto anch’io, anzi meglio, ma sono solo cazzate.
Chi siamo noi?
Siamo i “coglioni” che altri
volevano che fossimo o potessimo diventare.
Da bambini i genitori ci
educavano secondo i loro canoni, fino a che abbiamo scoperto che era solo il
canone di poveri ignoranti.
Da studenti i maestri ci
istruivano secondo il loro pensiero, fino a che abbiamo scoperto che era solo il
pensiero di comunisti arroganti. Prima dell’ABC ci insegnavano “Bella Ciao”.
Da credenti i ministri di
culto ci erudivano sulla confessione religiosa secondo il loro verbo, fino a che
abbiamo scoperto che era solo la parola di pedofili o terroristi.
Da lettori e telespettatori
l’informazione (la claque del potere) ci ammaestrava all’odio per il diverso ed
a credere di vivere in un paese democratico, civile ed avanzato, fino a che
abbiamo scoperto che si muore di fame o detenuti in canili umani.
Da elettori i legislatori ci
imponevano le leggi secondo il loro diritto, fino a che abbiamo scoperto che
erano solo corrotti, mafiosi e massoni.
Ecco, appunto: siamo i
“coglioni” che altri volevano che fossimo o potessimo diventare.
E se qualcuno non vuol essere
“coglione” e vuol cambiare le cose, ma non ci riesce, vuol dire che è “coglione”
lui e non lo sa, ovvero è circondato da amici e parenti “coglioni”.
Ho vissuto una breve vita
confrontandomi con una sequela di generazioni difettate condotte in un caos
organizzato. Uomini e donne senza ideali e senza valori succubi del flusso
culturale e politico del momento, scevri da ogni discernimento tra il bene ed il
male. L’Io è elevato all’ennesima potenza. La mia Collana editoriale “L’Italia
del Trucco, l’Italia che siamo” composta da decine di saggi, riporta ai posteri
una realtà attuale storica, per tema e per territorio, sconosciuta ai
contemporanei perché corrotta da verità mediatiche o giudiziarie.
Per la Conte dei Conti è
l’Italia delle truffe. È l'Italia degli sprechi e delle frodi fotografata in un
dossier messo a punto dalla procura generale della Corte dei Conti che ha messo
insieme le iniziative più rilevanti dei procuratori regionali. La Corte dei
Conti ha scandagliato l'attività condotta da tutte le procure regionali e ha
messo insieme «le fattispecie di particolare interesse, anche sociale, rilevanti
per il singolo contenuto e per il pregiudizio economico spesso ingente».
A parlar di sé e delle proprie
disgrazie in prima persona, oltre a non destare l’interesse di alcuno pur nelle
tue stesse condizioni, può farti passare per mitomane o pazzo. Non sto qui a
promuovermi. Non si può, però, tacere la verità storica che ci circonda,
stravolta da verità menzognere mediatiche e giudiziarie. Ad ogni elezione
legislativa ci troviamo a dover scegliere tra: il partito dei condoni; il
partito della CGIL; il partito dei giudici. Io da anni non vado a votare perché
non mi rappresentano i nominati in Parlamento. Oltretutto mi disgustano le
malefatte dei nominati. Un esempio per tutti, anche se i media lo hanno
sottaciuto. La riforma forense, approvata con Legge 31 dicembre 2012, n. 247,
tra gli ultimi interventi legislativi consegnatici frettolosamente dal
Parlamento prima di cessare di fare danni. I nonni avvocati in Parlamento
(compresi i comunisti) hanno partorito, in previsione di un loro roseo futuro,
una contro riforma fatta a posta contro i giovani. Ai fascisti che hanno dato
vita al primo Ordinamento forense (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 -
Ordinamento della professione di avvocato e di procuratore convertito con la
legge 22 gennaio 1934 n.36) questa contro riforma reazionaria gli fa un
baffo. Trattasi di una “riforma”, scritta come al solito negligentemente, che
non viene in alcun modo incontro ed anzi penalizza in modo significativo i
giovani. Da anni inascoltato denuncio il malaffare di avvocati e magistrati ed
il loro malsano accesso alla professione. Cosa ho ottenuto a denunciare i
trucchi per superare l’esame? Insabbiamento delle denunce e attivazione di
processi per diffamazione e calunnia, chiusi, però, con assoluzione piena.
Intanto ti intimoriscono. Ed anche la giustizia amministrativa si adegua.
La mafia cos'è? La risposta
in un aneddoto di Paolo Borsellino: "Sapete che cos'è la Mafia... faccia conto
che ci sia un posto libero in tribunale..... e che si presentino 3 magistrati...
il primo è bravissimo, il migliore, il più preparato.. un altro ha appoggi
formidabili dalla politica... e il terzo è un fesso... sapete chi vincerà??? Il
fesso. Ecco, mi disse il boss, questa è la MAFIA!"
"La vera mafia è lo
Stato, alcuni magistrati che lo rappresentano si comportano da mafiosi. Il
magistrato che mi racconta che Andreotti ha baciato Riina io lo voglio in galera".
Così Vittorio Sgarbi il 6 maggio 2013 ad “Un Giorno Da Pecora su Radio 2.
«Da noi -
ha dichiarato Silvio
Berlusconi ai cronisti di una televisione greca il 23 febbraio 2013 - la
magistratura è una mafia più pericolosa della mafia siciliana, e lo dico sapendo
di dire una cosa grossa». «In Italia regna una "magistocrazia". Nella
magistratura c'è una vera e propria associazione a delinquere» Lo ha detto
Silvio Berlusconi il 28 marzo 2013 durante la riunione del gruppo Pdl a
Montecitorio. Ed ancora Silvio Berlusconi all'attacco ai magistrati: «L'Anm è
come la P2, non dice chi sono i loro associati». Il riferimento dell'ex
premier è alle associazioni interne ai magistrati, come Magistratura
Democratica. Il Cavaliere è a Udine il 18 aprile 2013 per un comizio.
Abbiamo una Costituzione
catto-comunista predisposta e votata dagli apparati politici che rappresentavano
la metà degli italiani, ossia coloro che furono i vincitori della guerra civile
e che votarono per la Repubblica. Una Costituzione fondata sul lavoro (che oggi
non c’è e per questo ci rende schiavi) e non sulla libertà (che ci dovrebbe
sempre essere, ma oggi non c’è e per questo siamo schiavi). Un diritto
all’uguaglianza inapplicato in virtù del fatto che il potere, anziché essere
nelle mani del popolo che dovrebbe nominare i suoi rappresentanti politici,
amministrativi e giudiziari, è in mano a mafie, caste, lobbies e massonerie.
Siamo un popolo corrotto:
nella memoria, nell’analisi e nel processo mentale di discernimento. Ogni dato
virulento che il potere mediatico ci ha propinato, succube al potere politico,
economico e giudiziario, ha falsato il senso etico della ragione e logica del
popolo. Come il personal computer, giovani e vecchi, devono essere formattati.
Ossia, azzerare ogni cognizione e ripartire da zero all’acquisizione di
conoscenze scevre da influenze ideologiche, religiose ed etniche. Dobbiamo
essere consci del fatto che esistono diverse verità.
Ogni fatto è rappresentato
da una verità storica; da una verità mediatica e da una verità giudiziaria.
La verità storica è
conosciuta solo dai responsabili del fatto. La verità mediatica è quella
rappresentata dai media approssimativi che sono ignoranti in giurisprudenza e
poco esperti di frequentazioni di aule del tribunale, ma genuflessi e stanziali
negli uffici dei pm e periti delle convinzioni dell’accusa, mai dando spazio
alla difesa. La verità giudiziaria è quella che esce fuori da una corte, spesso
impreparata culturalmente, tecnicamente e psicologicamente (in virtù dei
concorsi pubblici truccati). Nelle aule spesso si lede il diritto di difesa,
finanche negando le più elementari fonti di prova, o addirittura, in caso di
imputati poveri, il diritto alla difesa. Il gratuita patrocinio è solo una
balla. Gli avvocati capaci non vi consentono, quindi ti ritrovi con un avvocato
d’ufficio che spesso si rimette alla volontà della corte, senza conoscere i
carteggi. La sentenza è sempre frutto della libera convinzione di una persona
(il giudice). Mi si chiede cosa fare. Bisogna, da privato, ripassare tutte le
fasi dell’indagine e carpire eventuali errori dei magistrati trascurati dalla
difesa (e sempre ve ne sono). Eventualmente svolgere un’indagine parallela.
Intanto aspettare che qualche pentito, delatore, o intercettazione, produca una
nuova prova che ribalti l’esito del processo. Quando poi questa emerge bisogna
sperare nella fortuna di trovare un magistrato coscienzioso (spesso non accade
per non rilevare l’errore dei colleghi), che possa aprire un processo di
revisione.
Ognuno di noi antropologicamente ha un limite, non
dovuto al sesso, od alla razza, od al credo religioso, ma bensì delimitato
dall’istruzione ricevuta ed all’educazione appresa dalla famiglia e dalla
società, esse stesse influenzate dall’ambiente, dalla cultura, dagli usi e dai
costumi territoriali. A differenza degli animali la maggior parte degli umani
non si cura del proprio limite e si avventura in atteggiamenti e giudizi non
consoni al loro stato. Quando a causa dei loro limiti non arrivano ad avere
ragione con il ragionamento, allora adottano la violenza (fisica o psicologica,
ideologica o religiosa) e spesso con la violenza ottengono un effimero ed
immeritato potere o risultato. I più intelligenti, conoscendo il proprio limite,
cercano di ampliarlo per risultati più duraturi e poteri meritati. Con nuove
conoscenze, con nuovi studi, con nuove esperienze arricchiscono il loro bagaglio
culturale ed aprono la loro mente, affinché questa accetti nuovi concetti e
nuovi orizzonti. Acquisizione impensabile in uno stato primordiale. In non
omologati hanno empatia per i conformati. Mentre gli omologati sono mossi da
viscerale egoismo dovuto all’istinto di sopravvivenza: voler essere ed avere più
di quanto effettivamente si possa meritare di essere od avere. Loro ed i loro
interessi come ombelico del mondo. Da qui la loro paura della morte e la ricerca
di un dio assoluto e personale, finanche cattivo: hanno paura di perdere il
niente che hanno e sono alla ricerca di un dio che dal niente che sono li elevi
ad entità. L'empatia designa un atteggiamento verso gli altri caratterizzato da
un impegno di comprensione dell'altro, escludendo ogni attitudine affettiva
personale (simpatia, antipatia) e ogni giudizio morale, perché mettersi nei
panni dell'altro per sapere cosa pensa e come reagirebbe costituisce un
importante fattore di sopravvivenza in un mondo in cui l'uomo è in continua
competizione con gli altri uomini. Fa niente se i dotti emancipati e non
omologati saranno additati in patria loro come Gesù nella sua Nazareth: semplici
figli di falegnami, perchè "non c'è nessun posto dove un profeta abbia meno
valore che non nella sua patria e nella sua casa". Non c'è bisogno di essere
cristiani per apprezzare Gesù Cristo: non per i suoi natali, ma per il suo
insegnamento e, cosa più importante, per il suo esempio. Fa capire che alla
fine è importante lasciar buona traccia di sè, allora sì che si diventa
immortali nella rimembranza altrui.
Tutti vogliono avere ragione e tutti pretendono di
imporre la loro verità agli altri. Chi impone ignora, millanta o manipola la
verità. L'ignoranza degli altri non può discernere la verità dalla menzogna. Il
saggio aspetta che la verità venga agli altri. La sapienza riconosce la verità e
spesso ciò fa ricredere e cambiare opinione. Solo gli sciocchi e gli ignoranti
non cambiano mai idea, per questo sono sempre sottomessi. La Verità rende
liberi, per questo è importante far di tutto per conoscerla.
Tutti gli altri intendono “Tutte le Mafie” come un
insieme orizzontale di entità patologiche criminali territoriali (Cosa Nostra,
‘Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita, ecc.).
Io intendo “Tutte le Mafie” come un ordinamento
criminale verticale di entità fisiologiche nazionali composte, partendo dal
basso: dalle mafie (la manovalanza), dalle Lobbies, dalle Caste e dalle
Massonerie (le menti).
La Legalità è il comportamento umano conforme al
dettato della legge nel compimento di un atto o di un fatto. Se l'abito non fa
il monaco, e la cronaca ce lo insegna, nè toghe, nè divise, nè poteri
istituzionali o mediatici hanno la legittimazione a dare insegnamenti e/o
patenti di legalità. Lor signori non si devono permettere di selezionare secondo
loro discrezione la società civile in buoni e cattivi ed ovviamente si devono
astenere dall'inserirsi loro stessi tra i buoni. Perchè secondo questa cernita
il cattivo è sempre il povero cittadino, che oltretutto con le esose tasse li
mantiene. Non dimentichiamoci che non ci sono dio in terra e fino a quando
saremo in democrazia, il potere è solo prerogativa del popolo.
Non sono conformato ed omologato, per questo son
fiero ed orgoglioso di essere diverso.
PER UNA LETTURA UTILE E
CONSAPEVOLE CONTRO L’ITALIA DEI GATTOPARDI.
Recensione di un’opera
editoriale osteggiata dalla destra e dalla sinistra. Perle di saggezza destinate
al porcilaio.
I giornalisti della tv e
stampa, sia quotidiana, sia periodica, da sempre sono tacciati di faziosità e
mediocrità. Si dice che siano prezzolati e manipolati dal potere e che esprimano
solo opinioni personali, non raccontando i fatti. Lo dice Beppe Grillo e forse
ha ragione. Ma tra di loro vi sono anche eccellenze di gran valore. Questo vale
per le maggiori testate progressiste (Il Corriere della Sera, L’Espresso, La
Repubblica, Il Fatto Quotidiano), ma anche per le testate liberali (Panorama,
Oggi, Il Giornale, Libero Quotidiano). In una Italia, laddove alcuni magistrati
tacitano con violenza le contro voci, questi eccelsi giornalisti, attraverso le
loro coraggiose inchieste, sono fonte di prova incontestabile per raccontare
l’Italia vera, ma sconosciuta. L’Italia dei gattopardi e dell’ipocrisia.
L’Italia dell’illegalità e dell’utopia. Tramite loro, citando gli stessi e le
loro inchieste scottanti, Antonio Giangrande ha raccolto in venti anni tutto
quanto era utile per dimostrare che la mafia vien dall’alto. Pochi lupi e tante
pecore. Una selezione di nomi e fatti articolati per argomento e per territorio.
L’intento di Giangrande è rappresentare la realtà contemporanea, rapportandola
al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Questa è sociologia storica, di cui il Giangrande
è il massimo cultore. Questa è la collana editoriale “L’Italia del Trucco,
l’Italia che siamo” pubblicata su
www.controtuttelemafie.it ed altri
canali web, su Amazon in E-Book e su Lulu in cartaceo. 40 libri scritti da
Antonio Giangrande, presidente della “Associazione Contro Tutte le Mafie” e
scrittore-editore dissidente. Saggi pertinenti questioni che nessuno osa
affrontare. Opere che i media si astengono a dare loro la dovuta visibilità e le
rassegne culturali ad ignorare. In occasione delle festività ed in concomitanza
con le nuove elezioni legislative sarebbe cosa buona e utile presentare ai
lettori una lettura alternativa che possa rendere più consapevole l’opinione dei
cittadini. Un’idea regalo gratuita o con modica spesa, sicuramente gradita da
chi la riceve. Non è pubblicità gratuita che si cerca per fini economici, né
tanto meno è concorrenza sleale. Si chiede solo di divulgare la conoscenza di
opere che già sul web sono conosciutissime e che possono anche esser lette
gratuitamente. Evento editoriale esclusivo ed aggiornato periodicamente. Di
sicuro interesse generale. Fa niente se dietro non ci sono grandi o piccoli
gruppi editoriali. Ciò è garanzia di libertà.
Grazie per l’adesione e la
partecipazione oltre che per la solidarietà.
POLITICA, GIUSTIZIA ED
INFORMAZIONE. IN TEMPO DI VOTO SI PALESA L’ITALIETTA DELLE VERGINELLE.
Politica, giustizia ed
informazione. In tempo di voto si palesa l’Italietta delle verginelle.
Da scrittore navigato, il cui
sacco di 50 libri scritti sull’Italiopoli degli italioti lo sta a dimostrare, mi
viene un rigurgito di vomito nel seguire tutto quanto viene detto da scatenate
sgualdrine (in senso politico) di ogni schieramento politico. Sgualdrine che si
atteggiano a verginelle e si presentano come aspiranti salvatori della patria in
stampo elettorale.
In Italia dove non c’è libertà
di stampa e vige la magistratocrazia è facile apparire verginelle sol perché si
indossa l’abito bianco.
I nuovi politici non si
presentano come preparati a risolvere i problemi, meglio se liberi da pressioni
castali, ma si propongono, a chi non li conosce bene, solo per le loro presunti
virtù, come verginelle illibate.
Ci si atteggia a migliore
dell’altro in una Italia dove il migliore c’ha la rogna.
L’Italietta è incurante del
fatto che Nicola Vendola a Bari sia stato assolto in modo legittimo dall’amica
della sorella o Luigi De Magistris sia stato assolto a Salerno in modo legale
dalla cognata di Michele Santoro, suo sponsor politico.
L’Italietta che non batte
ciglio quando a Bari Massimo D’Alema in modo lecito esce pulito da un’inchiesta
penale. Accogliendo la richiesta d’archiviazione avanzata dal pm, il gip
Concetta Russi il 22 giugno ’95 decise per il proscioglimento, ritenendo
superfluo ogni approfondimento: «Uno degli episodi di illecito finanziamento
riferiti – scrisse nelle motivazioni - e cioè la corresponsione di un contributo
di 20 milioni in favore del Pci, ha trovato sostanziale conferma, pur nella
diversità di alcuni elementi marginali, nella leale dichiarazione dell’onorevole
D’Alema, all’epoca dei fatti segretario regionale del Pci (...). L’onorevole
D’Alema non ha escluso che la somma versata dal Cavallari fosse stata proprio
dell’importo da quest’ultimo indicato». Chi era il titolare dell’inchiesta che
sollecitò l’archiviazione? Il pm Alberto Maritati, eletto coi Ds e
immediatamente nominato sottosegretario all’Interno durante il primo governo
D’Alema, numero due del ministro Jervolino, poi ancora sottosegretario alla
giustizia nel governo Prodi, emulo di un altro pm pugliese diventato
sottosegretario con D’Alema: Giannicola Sinisi. E chi svolse insieme a Maritati
gli accertamenti su Cavallari? Chi altro firmò la richiesta d’archiviazione per
D’Alema? Semplice: l’amico e collega Giuseppe Scelsi, magistrato di punta della
corrente di Magistratura democratica a Bari, poi titolare della segretissima
indagine sulle ragazze reclutate per le feste a Palazzo Grazioli, indagine
«anticipata» proprio da D’Alema.
L’Italietta non si scandalizza
del fatto che sui Tribunali e nella scuole si spenda il nome e l’effige di
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino da parte di chi, loro colleghi, li hanno
traditi in vita, causandone la morte.
L’Italietta non si sconvolge
del fatto che spesso gli incriminati risultano innocenti e ciononostante il 40%
dei detenuti è in attesa di giudizio. E per questo gli avvocati in Parlamento,
anziché emanar norme, scioperano nei tribunali, annacquando ancor di più la
lungaggine dei processi.
L’Italietta che su giornali e
tv foraggiate dallo Stato viene accusata da politici corrotti di essere evasore
fiscale, nonostante sia spremuta come un limone senza ricevere niente in cambio.
L’Italietta, malgrado ciò,
riesce ancora a discernere le vergini dalle sgualdrine, sotto l’influenza
mediatica-giudiziaria.
Fa niente se proprio tutta la
stampa ignava tace le ritorsioni per non aver taciuto le nefandezze dei
magistrati, che loro sì decidono chi candidare al Parlamento per mantenere e
tutelare i loro privilegi.
Da ultimo è la perquisizione
ricevuta in casa dall’inviato de “La Repubblica”, o quella ricevuta dalla
redazione del tg di Telenorba.
Il re è nudo: c’è qualcuno che
lo dice. E’ la testimonianza di Carlo Vulpio sull’integrità morale di Nicola
Vendola, detto Niki. L’Editto bulgaro e l’Editto di Roma (o di Bari). Il primo è
un racconto che dura da anni. Del secondo invece non si deve parlare.
I giornalisti della tv e
stampa, sia quotidiana, sia periodica, da sempre sono tacciati di faziosità e
mediocrità. Si dice che siano prezzolati e manipolati dal potere e che esprimano
solo opinioni personali, non raccontando i fatti. La verità è che sono solo
codardi.
E cosa c’è altro da pensare.
In una Italia, laddove alcuni magistrati tacitano con violenza le contro voci.
L’Italia dei gattopardi e dell’ipocrisia. L’Italia dell’illegalità e
dell’utopia.
Tutti hanno taciuto "Le mani
nel cassetto. (e talvolta anche addosso...). I giornalisti perquisiti
raccontano". Il libro, introdotto dal presidente nazionale dell’Ordine Enzo
Jacopino, contiene le testimonianze, delicate e a volte ironiche, di ventuno
giornalisti italiani, alcuni dei quali noti al grande pubblico, che hanno subito
perquisizioni personali o ambientali, in casa o in redazione, nei computer e
nelle agende, nei libri e nei dischetti cd o nelle chiavette usb, nella
biancheria e nel frigorifero, “con il dichiarato scopo di scoprire la fonte
confidenziale di una notizia: vera, ma, secondo il magistrato, non divulgabile”.
Nel 99,9% dei casi le perquisizioni non hanno portato “ad alcun rinvenimento
significativo”.
Cosa pensare se si è
sgualdrina o verginella a secondo dell’umore mediatico. Tutti gli ipocriti si
facciano avanti nel sentirsi offesi, ma che fiducia nell’informazione possiamo
avere se questa è terrorizzata dalle querele sporte dai PM e poi giudicate dai
loro colleghi Giudici.
Alla luce di quanto detto, è
da considerare candidabile dai puritani nostrani il buon “pregiudicato”
Alessandro Sallusti che ha la sol colpa di essere uno dei pochi coraggiosi a
dire la verità?
Si badi che a ricever querela
basta recensire il libro dell’Ordine Nazionale dei giornalisti, che racconta gli
abusi ricevuti dal giornalista che scrive la verità, proprio per denunciare
l'arma intimidatoria delle perquisizioni alla stampa.
Che giornalisti sono coloro
che, non solo non raccontano la verità, ma tacciono anche tutto ciò che succede
a loro?
E cosa ci si aspetta da questa
informazione dove essa stessa è stata visitata nella loro sede istituzionale
dalla polizia giudiziaria che ha voluto delle copie del volume e i dati
identificativi di alcune persone, compreso il presidente che dell'Ordine è il
rappresentante legale?
La Costituzione all’art. 104
afferma che “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere.”
Ne conviene che il dettato
vuol significare non equiparare la Magistratura ad altro potere, ma
differenziarne l’Ordine con il Potere che spetta al popolo. Ordine
costituzionalizzato, sì, non Potere.
Magistrati. Ordine, non
potere, come invece il più delle volte si scrive, probabilmente ricordando
Montesquieu; il quale però aggiungeva che il potere giudiziario é “per così dire
invisibile e nullo”. Solo il popolo è depositario della sovranità: per questo
Togliatti alla Costituente avrebbe voluto addirittura che i magistrati fossero
eletti dal popolo, per questo sostenne le giurie popolari. Ordine o potere che
sia, in ogni caso è chiaro che di magistrati si parla.
Allora io ho deciso: al posto
di chi si atteggia a verginella io voterei sempre un “pregiudicato” come
Alessandro Sallusti, non invece chi incapace, invidioso e cattivo si mette
l’abito bianco per apparir pulito.
E facile dire pregiudicato.
Parliamo del comportamento degli avvocati. Il caso della condanna di Sallusti.
Veniamo al primo grado: l’avvocato di Libero era piuttosto noto perché
non presenziava quasi mai alle udienze, preferendo mandarci sempre un sostituto
sottopagato, dice Filippo Facci. E qui, il giorno della sentenza, accadde un
fatto decisamente singolare. Il giudice, una donna, lesse il dispositivo che
condannava Sallusti a pagare circa 5mila euro e Andrea Monticone a pagarne 4000
(più 30mila di risarcimento, che nel caso dei magistrati è sempre altissimo) ma
nelle motivazioni della sentenza, depositate tempo dopo, lo stesso giudice si
dolse di essersi dimenticato di prevedere una pena detentiva. Un’esagerazione?
Si può pensarlo. Tant’è, ormai era andata: sia il querelante sia la Procura sia
gli avvocati proposero tuttavia appello (perché in Italia si propone sempre
appello, anche quando pare illogico o esagerato) e la sentenza della prima
sezione giunse il 17 giugno 2011. E qui accadeva un altro fatto singolare:
l’avvocato di Libero tipicamente non si presentò in aula e però neppure
il suo sostituto: il quale, nel frattempo, aveva abbandonato lo studio
nell’ottobre precedente come del resto la segretaria, entrambi stufi di lavorare
praticamente gratis. Fatto sta che all’Appello dovette presenziare un legale
d’ufficio – uno che passava di lì, letteralmente – sicché la sentenza cambiò
volto: come richiesto dall’accusa, Monticone si beccò un anno con la
condizionale e Sallusti si beccò un anno e due mesi senza un accidente di
condizionale, e perché? Perché aveva dei precedenti per l’omesso controllo
legato alla diffamazione. Il giudice d’Appello, in pratica, recuperò la
detenzione che il giudice di primo grado aveva dimenticato di scrivere nel
dispositivo.
Ma anche il Tribuno Marco
Travaglio è stato vittima degli avvocati. Su Wikipedia si legge che nel 2000 è
stato condannato in sede civile, dopo essere stato citato in giudizio da Cesare
Previti a causa di un articolo in cui Travaglio ha definito Previti «un
indagato» su “L’Indipendente”. Previti era effettivamente indagato ma a causa
dell'impossibilità da parte dell' avvocato del giornale di presentare le prove
in difesa di Travaglio in quanto il legale non era retribuito, il giornalista fu
obbligato al risarcimento del danno quantificato in 79 milioni di lire. Comunque
lui stesso a “Servizio Pubblico” ha detto d’aver perso una querela con Previti,
parole sue, «perché l’avvocato non è andato a presentare le mie prove». Colpa
dell’avvocato.
Ma chi e quando le cose
cambieranno?
Per fare politica in Italia le
strade sono poche, specialmente se hai qualcosa da dire e proponi soluzioni ai
problemi generali. La prima è cominciare a partecipare a movimenti studenteschi
fra le aule universitarie, mettersi su le stellette di qualche occupazione e poi
prendere la tessera di un partito. Se di sinistra è meglio. Poi c'è la strada
della partecipazione politica con tesseramento magari sfruttando una professione
che ti metta in contatto con molti probabili elettori: favoriti sono gli
avvocati, i medici di base ed i giornalisti. C'è una terza via che sempre più
prende piede. Fai il magistrato.
Se puoi occupati di qualche inchiesta che abbia come bersaglio un soggetto
politico, specie del centro destra, perché gli amici a sinistra non si toccano.
Comunque non ti impegnare troppo. Va bene anche un'archiviazione. Poi togli la
toga e punta al Palazzo. Quello che interessa a sinistra è registrare questo
movimento arancione con attacco a tre punte: De
Magistris sulla fascia, Di
Pietro in regia e al
centro il nuovo bomber Antonio
Ingroia. Se è un partito dei magistrati e per la corporazione dei
magistrati. Loro "ci stanno".
Rivoluzione Civile è una
formazione improvvisata le cui figure principali di riferimento sono tre
magistrati: De Magistris, Di Pietro e Ingroia. Dietro le loro spalle si
rifugiano i piccoli partiti di Ferrero, Diliberto e Bonelli in cerca di presenza
parlamentare. E poi, ci mancherebbe,
con loro molte ottime persone di sinistra critica all’insegna della purezza.
Solo che la loro severità rivolta in special modo al Partito Democratico, deve
per forza accettare un’eccezione: Antonio Di Pietro. La rivelazione dei metodi
disinvolti con cui venivano gestiti i fondi dell’Italia dei Valori, e dell’uso
personale che l’ex giudice fece di un’eredità cospicua donata a lui non certo
per godersela, lo hanno costretto a ritirarsi dalla prima fila. L’Italia dei
Valori non si presenta più da sola, non per generosità ma perchè andrebbe
incontro a una sconfitta certa. Il suo leader però viene ricandidato da Ingroia
senza troppi interrogativi sulla sua presentabilità politica. “Il Fatto”,
solitamente molto severo, non ha avuto niente da obiettare sul Di Pietro
ricandidato alla chetichella. Forse perchè non era più alleato di Bersani e
Vendola? Si chiede Gad Lerner.
Faceva una certa impressione
nei tg ascoltare Nichi Vendola (che, secondo Marco Ventura su “Panorama”, la
magistratura ha salvato dalle accuse di avere imposto un primario di sua fiducia
in un concorso riaperto apposta e di essere coinvolto nel malaffare della sanità
in Puglia) dire che mentre le liste del Pd-Sel hanno un certo profumo, quelle
del Pdl profumano “di camorra”. E che dire di Ingroia e il suo doppiopesismo:
moralmente ed eticamente intransigente con gli altri, indulgente con se stesso.
Il candidato Ingroia, leader rivoluzionario, da pm faceva domande e i
malcapitati dovevano rispondere. Poi a rispondere, come candidato premier, tocca
a lui. E lui le domande proprio non le sopporta, come ha dimostrato nella
trasmissione condotta su Raitre da Lucia Annunziata. Tanto da non dimettersi
dalla magistratura, da candidarsi anche dove non può essere eletto per legge
(Sicilia), da sostenere i No Tav ed avere come alleato l'inventore della Tav (Di
Pietro), da criticare la legge elettorale, ma utilizzarla per piazzare candidati
protetti a destra e a manca. L'elenco sarebbe lungo, spiega Alessandro Sallusti.
Macchè "rivoluzione" Ingroia le sue liste le fa col manuale Cencelli. L'ex pm e
i partiti alleati si spartiscono i posti sicuri a Camera e Senato, in barba alle
indicazioni delle assemblee territoriali. Così, in Lombardia, il primo lombardo
è al nono posto. Sono tanti i siciliani che corrono alle prossime elezioni
politiche in un seggio lontano dall’isola. C’è Antonio Ingroia
capolista di Rivoluzione Civile un po' dappertutto. E poi ci sono molti
"paracadutati" che hanno ottenuto un posto blindato lontano dalla Sicilia.
Pietro Grasso, ad esempio, è capolista del Pd nel Lazio: "Non
mi candido in Sicilia per una scelta di opportunità", ha detto, in polemica con
Ingroia, che infatti in Sicilia non è eleggibile. In Lombardia per Sel c'è
capolista Claudio Fava, giornalista catanese, e non candidato
alle ultime elezioni regionali per un pasticcio fatto sulla sua residenza in
Sicilia (per fortuna per le elezioni politiche non c'è bisogno di particolare
documentazione....). Fabio Giambrone, braccio destro di
Orlando, corre anche in Lombardia e in Piemonte. Celeste Costantino,
segretaria provinciale di Sel a Palermo è stata candidata, con qualche malumore
locale, nella circoscrizione Piemonte 1. Anna Finocchiaro,
catanese e con il marito sotto inchiesta è capolista del Pd, in Puglia. Sarà lei
in caso di vittoria del Pd la prossima presidente del Senato. Sempre in Puglia
alla Camera c'è spazio per Ignazio Messina al quarto posto
della lista di Rivoluzione civile. E che dire di Don Gallo che canta la canzone
partigiana "Bella Ciao" sull'altare, sventolando un drappo rosso.
"Serve una legge per
regolamentare e limitare la discesa in politica dei magistrati, almeno nei
distretti dove hanno esercitato le loro funzioni, per evitare che nell'opinione
pubblica venga meno la considerazione per i giudici". Lo afferma il presidente
della Cassazione, nel suo discorso alla cerimonia di inaugurazione del nuovo
anno giudiziario 2013. Per Ernesto Lupo devono essere "gli stessi pm a darsi
delle regole nel loro Codice etico". Per la terza e ultima volta - dal momento
che andrà in pensione il prossimo maggio - il Primo presidente della Cassazione,
Ernesto Lupo, ha illustrato - alla presenza del Presidente della Repubblica e
delle alte cariche dello Stato - la «drammatica» situazione della giustizia in
Italia non solo per la cronica lentezza dei processi, 128 mila dei quali si sono
conclusi nel 2012 con la prescrizione, ma anche per la continua violazione dei
diritti umani dei detenuti per la quale è arrivato l’ultimatum dalla Corte Ue.
Sebbene abbia apprezzato le riforme del ministro Paola Severino - taglio dei
“tribunalini” e riscrittura dei reati contro la pubblica amministrazione - Lupo
ha tuttavia sottolineato che l’Italia continua ad essere tra i Paesi più
propensi alla corruzione. Pari merito con la Bosnia, e persino dietro a nazioni
del terzo mondo. Il Primo presidente ha, poi, chiamato gli stessi magistrati a
darsi regole severe per chi scende in politica e a limitarsi, molto, nel ricorso
alla custodia in carcere. «È auspicabile - esorta Lupo - che nella perdurante
carenza della legge, sia introdotta nel codice etico quella disciplina più
rigorosa sulla partecipazione dei magistrati alla vita politica e parlamentare,
che in decenni il legislatore non è riuscito ad approvare». Per regole sulle
toghe in politica, si sono espressi a favore anche il Procuratore generale della
Suprema Corte Gianfranco Ciani, che ha criticato i pm che flirtano con certi
media cavalcando le inchieste per poi candidarsi, e il presidente dell’Anm
Rodolfo Sabelli. Per il Primo presidente nelle celle ci sono 18.861 detenuti di
troppo e bisogna dare più permessi premio. Almeno un quarto dei reclusi è in
attesa di condanna definitiva e i giudici devono usare di più le misure
alternative.
"Non possiamo andare avanti
così - lo aveva già detto il primo presidente della Corte di Cassazione,
Vincenzo Carbone, nella relazione che ha aperto la cerimonia dell’ inaugurazione
dell’ Anno Giudiziario 2009 - In più, oltre a un più rigoroso richiamo dei
giudici ai propri doveri di riservatezza, occorrerebbe contestualmente evitare
la realizzazione di veri e propri 'processi mediatici', simulando al di fuori
degli uffici giudiziari, e magari anche con la partecipazione di magistrati, lo
svolgimento di un giudizio mentre è ancora in corso il processo nelle sedi
istituzionali". "La giustizia - sottolinea Carbone - deve essere trasparente ma
deve svolgersi nelle sedi proprie, lasciando ai media il doveroso ed essenziale
compito di informare l'opinione pubblica, ma non di sostituirsi alla funzione
giudiziaria".
Questo per far capire che il
problema “Giustizia” sono i magistrati. Nella magistratura sono presenti
"sacche di inefficienza e di inettitudine". La denuncia arriva addirittura
dal procuratore generale della Cassazione, Vitaliano Esposito, sempre
nell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2009.
Ma è questa la denuncia più
forte che viene dall'apertura dell'anno giudiziario 2013 nelle Corti d'Appello:
«Non trovo nulla da eccepire sui magistrati che abbandonano la toga per
candidarsi alle elezioni politiche - ha detto il presidente della Corte di
Appello di Roma Giorgio Santacroce. Ma ha aggiunto una stoccata anche ad alcuni
suoi colleghi - Non mi piacciono - ha affermato - i magistrati che non si
accontentano di far bene il loro lavoro, ma si propongono di redimere il mondo.
Quei magistrati, pochissimi per fortuna, che sono convinti che la spada della
giustizia sia sempre senza fodero, pronta a colpire o a raddrizzare le schiene.
Parlano molto di sè e del loro operato anche fuori dalle aule giudiziarie,
esponendosi mediaticamente, senza rendersi conto che per dimostrare quell'
imparzialità che è la sola nostra divisa, non bastano frasi ad effetto, intrise
di una retorica all'acqua di rose. Certe debolezze non rendono affatto il
magistrato più umano. I magistrati che si candidano esercitano un diritto
costituzionalmente garantito a tutti i cittadini, ma Piero Calamandrei diceva
che quando per la porta della magistratura entra la politica, la giustizia esce
dalla finestra».
Dove non arrivano a fare le
loro leggi per tutelare prerogative e privilegi della casta, alcuni magistrati,
quando non gli garba il rispetto e l’applicazione della legge, così come gli è
dovuto e così come hanno giurato, disapplicano quella votata da altri. Esempio
lampante è Taranto. I magistrati contestano la legge, anziché applicarla, a
scapito di migliaia di lavoratori. Lo strapotere e lo straparlare dei magistrati
si incarna in alcuni esempi. «Ringrazio il Presidente della Repubblica, come
cittadino ma anche di giudice, per averci allontanati dal precipizio verso il
quale inconsciamente marciavamo». Sono le parole con le quali il presidente
della Corte d'appello, Mario Buffa, ha aperto, riferendosi alla caduta del
Governo Berlusconi, la relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012
nell'aula magna del palazzo di giustizia di Lecce. «Per fortuna il vento sembra
essere cambiato – ha proseguito Buffa: la nuova ministra non consuma le sue
energie in tentativi di delegittimare la magistratura, creando intralci alla sua
azione». Ma il connubio dura poco. L’anno successivo, nel 2013, ad aprire la
cerimonia di inaugurazione è stata ancora la relazione del presidente della
Corte d’appello di Lecce, Mario Buffa. Esprimendosi sull’Ilva di Taranto ha
dichiarato che “il Governo ha fatto sull’Ilva una legge ad aziendam, che si
colloca nella scia delle leggi ad personam inaugurata in Italia negli ultimi
venti anni, una legge che riconsegna lo stabilimento a coloro che fingevano di
rispettare le regole di giorno e continuavano a inquinare di notte”. Alla faccia
dell’imparzialità. Giudizi senza appello e senza processo. Non serve ai
magistrati candidarsi in Parlamento. La Politica, in virtù del loro strapotere,
anche mediatico, la fanno anche dai banchi dei tribunali. Si vuole un esempio?
"E' una cosa indegna". Veramente mi disgusta il fatto che io debba leggere sul
giornale, momento per momento, 'stanno per chiamare la dottoressa Tizio, la
stanno chiamando...l'hanno interrogato...la posizione si aggrava'". E ancora:
"Perchè se no qua diamo per scontato che tutto viene raccontato dai giornali,
che si fa il clamore mediatico, che si va a massacrare la gente prima ancora di
trovare un elemento di colpevolezza". E poi ancora: "A me pare molto più grave
il fatto che un cialtrone di magistrato dia indebitamente la notizia in
violazione di legge...". Chi parla potrebbe essere Silvio Berlusconi, che tante
volte si è lamentato di come le notizie escano dai tribunali prima sui giornali
che ai diretti interessati. E invece, quelle che riporta il Corriere della Sera,
sono parole pronunciate nel giugno 2010 nientemeno che del capo della polizia
Antonio Manganelli, al telefono col prefetto Nicola Izzo, ex vicario della
polizia. Ed allora “stronzi” chi li sta a sentire.
«L'unica spiegazione che posso
dare è che ho detto sempre quello che pensavo anche affrontando critiche,
criticando a mia volta la magistratura associata e gli alti vertici della
magistratura. E' successo anche ad altri più importanti e autorevoli magistrati,
a cominciare da Giovanni Falcone. Forse non è un caso - ha
concluso Ingroia - che quando iniziò la sua attività di collaborazione con la
politica le critiche peggiori giunsero dalla magistratura. E' un copione che si
ripete». «Come ha potuto Antonio Ingroia paragonare la sua piccola figura di
magistrato a quella di Giovanni Falcone? Tra loro esiste una distanza misurabile
in milioni di anni luce. Si vergogni». È il commento del procuratore aggiunto di
Milano, Ilda Boccassini, ai microfoni del TgLa7 condotto da Enrico
Mentana contro l'ex procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia, ora leader
di Rivoluzione civile. Non si è fatta attendere la replica dell'ex procuratore
aggiunto di Palermo che dagli schermi di Ballarò respinge le accuse della sua ex
collega: «Probabilmente non ha letto le mie parole, s'informi meglio. Io non mi
sono mai paragonato a Falcone, ci mancherebbe. Denunciavo soltanto una certa
reazione stizzita all'ingresso dei magistrati in politica, di cui fu vittima
anche Giovanni quando collaborò con il ministro Martelli. Forse basterebbe
leggere il mio intervento» E poi. «Ho atteso finora una smentita, invano.
Siccome non è arrivata dico che l'unica a doversi vergognare è lei che, ancora
in magistratura, prende parte in modo così indecente e astioso alla competizione
politica manipolando le mie dichiarazioni. La prossima volta pensi e conti fino
a tre prima di aprire bocca. Quanto ai suoi personali giudizi su di me, non mi
interessano e alle sue piccinerie siamo abituati da anni. Mi basta sapere cosa
pensava di me Paolo Borsellino e cosa pensava di lei. Ogni parola in più sarebbe
di troppo». «Sì, è vero. È stato fatto un uso politico delle intercettazioni, ma
questo è stato l’effetto relativo, la causa è che non si è mai fatta pulizia nel
mondo della politica». Un'ammissione in piena regola fatta negli studi di La7
dall'ex procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia. Che sostanzialmente ha
ammesso l'esistenza (per non dire l'appartenenza) di toghe politicizzate. Il
leader di Rivoluzione civile ha spiegato meglio il suo pensiero: «Se
fosse stata pulizia, non ci sarebbero state inchieste così clamorose e non ci
sarebbe state intercettazioni utilizzate per uso politico». L’ex pm ha poi
affermato che «ogni magistrato ha un suo tasso di politicità nel modo in cui
interpreta il suo ruolo. Si può interpretare la legge in modo più o meno
estensiva, più o meno garantista altrimenti non si spiegherebbero tante
oscillazione dei giudici nelle decisioni. Ogni giudice dovrebbe essere
imparziale rispetto alle parti, il che non significa essere neutrale rispetto ai
valori o agli ideali, c’è e c’è sempre stata una magistratura conservatrice e
una progressista». Guai a utilizzare il termine toga rossa però, perché
"mi offendo, per il significato deteriore che questo termine ha avuto", ha
aggiunto Ingroia. Dice dunque Ingroia, neoleader dell'arancia meccanica: «Piero
Grasso divenne procuratore nazionale perché scelto da Berlusconi grazie a una
legge ad hoc che escludeva Gian Carlo Caselli». Come se non bastasse, Ingroia
carica ancora, come in un duello nella polvere del West: «Grasso è il collega
che voleva dare un premio, una medaglia al governo Berlusconi per i suoi meriti
nella lotta alla mafia». Ma poi, già che c'è, Caselli regola i conti anche con
Grasso: «È un fatto storico che ai tempi del concorso per nominare il successore
di Vigna le regole vennero modificate in corso d'opera dall'allora maggioranza
con il risultato di escludermi. Ed è un fatto che questo concorso lo vinse
Grasso e che la legge che mi impedì di parteciparvi fu dichiarata
incostituzionale». Dunque, la regola aurea è sempre quella. I pm dopo aver
bacchettato la società tutta, ora si bacchettano fra di loro, rievocano pagine
più o meno oscure, si contraddicono con metodo, si azzannano con ferocia. E così
i guardiani della legalità, le lame scintillanti della legge si graffiano, si
tirano i capelli e recuperano episodi sottovuoto, dissigillando giudizi
rancorosi. Uno spettacolo avvilente. Ed ancora a sfatare il mito dei magistrati
onnipotenti ci pensano loro stessi, ridimensionandosi a semplici uomini, quali
sono, tendenti all’errore, sempre impunito però. A ciò serve la polemica tra le
Procure che indagano su Mps. «In certi uffici di procura "sembra che la
regola della competenza territoriale sia un optional. C'è stata una gara tra
diversi uffici giudiziari, ma sembra che la new entry abbia acquisito una
posizione di primato irraggiungibile». Nel suo intervento al congresso di
Magistratura democratica del 2 febbraio 2013 il procuratore di Milano Edmondo
Bruti Liberati ha alluso criticamente, pur senza citarla direttamente, alla
procura di Trani, l'ultima ad aprire, tra
le tante inchieste aperte,
un'indagine su Mps. «No al
protagonismo di certi magistrati che si propongono come tutori del Vero e del
Giusto magari con qualche strappo alle regole processuali e alle garanzie, si
intende a fin di Bene». A censurare il fenomeno il procuratore di Milano Edmondo
Bruti Liberati nel suo intervento al congresso di Md. Il procuratore di Milano
ha puntato l'indice contro il "populismo" e la "demagogia" di certi magistrati,
che peraltro - ha osservato - "non sanno resistere al fascino" dell'esposizione
mediatica. Di tutto quanto lungamente ed analiticamente detto bisogna tenerne
conto nel momento in cui si deve dare un giudizio su indagini, processi e
condanne. Perché mai nulla è come appare ed i magistrati non sono quegli
infallibili personaggi venuti dallo spazio, ma solo uomini che hanno vinto un
concorso pubblico, come può essere quello italiano. E tenendo conto di ciò, il
legislatore ha previsto più gradi di giudizio per il sindacato del sottoposto.
LA REPUBBLICA DELLE
MANETTE.
La Repubblica delle manette
(e degli orrori giudiziari).
Augusto Minzolini, già direttore del Tg1, è stato assolto ieri dall'accusa di
avere usato in modo improprio la carta di credito aziendale. Tutto bene? Per
niente, risponde scrive Alessandro Sallusti. Perché quell'accusa di avere
mangiato e viaggiato a sbafo (lo zelante Pm aveva chiesto due anni di carcere)
gli è costata il posto di direttore oltre che un anno e mezzo di linciaggio
mediatico da parte di colleghi che, pur essendo molto esperti di rimborsi spese
furbetti, avevano emesso una condanna definitiva dando per buono il teorema del
Pm (suggerito da Antonio Di Pietro, guarda caso). Minzolini avrà modo di rifarsi
in sede civile, ma non tutti i danni sono risarcibili in euro, quando si toccano
la dignità e la credibilità di un uomo. Fa rabbia che non il Pm, non la Rai, non
i colleghi infangatori e infamatori sentano il bisogno di chiedere scusa. È
disarmante che questo popolo di giustizialisti non debba pagare per i propri
errori. Che sono tanti e si annidano anche dentro l'ondata di manette fatte
scattare nelle ultime ore: il finanziere Proto, l'imprenditore Cellino, il
manager del Montepaschi Baldassarri. Storie diverse e tra i malcapitati c'è
anche Angelo Rizzoli, l'erede del fondatore del gruppo editoriale, anziano e
molto malato anche per avere subito un calvario giudiziario che gli ha bruciato
un terzo dell'esistenza: 27 anni per vedersi riconosciuta l'innocenza da accuse
su vicende finanziarie degli anni Ottanta. L'uso spregiudicato della giustizia
distrugge le persone, ma anche il Paese. Uno per tutti: il caso Finmeccanica,
che pare creato apposta per oscurare la vicenda Montepaschi, molto scomoda alla
sinistra. Solo la magistratura italiana si permette di trattare come se fosse
una tangente da furbetti del quartierino il corrispettivo di una mediazione per
un affare internazionale da centinaia di milioni di euro. Cosa dovrebbe fare la
più importante azienda di alta tecnologia italiana (70mila dipendenti iper
qualificati, i famosi cervelli) in concorrenza con colossi mondiali, grandi
quanto spregiudicati? E se fra due anni, come accaduto in piccolo a Minzolini,
si scopre che non c'è stato reato, chi ripagherà i miliardi in commesse persi a
favore di aziende francesi e tedesche? Non c'entra «l'elogio della tangente» che
ieri il solito Bersani ha messo in bocca a Berlusconi, che si è invece limitato
a dire come stanno le cose nel complicato mondo dei grandi affari
internazionali. Attenzione, che l'Italia delle manette non diventi l'Italia
degli errori e orrori.
Un tempo era
giustizialista. Ora invece ha cambiato idea. Magari si avvicinano le
elezioni e Beppe Grillo comincia ad avere paura anche lui.
Magari per i suoi. Le toghe quando agiscono non guardano in faccia nessuno. E
così anche Beppe se la prende con i magistrati: "La legge protegge i
delinquenti e manda in galera gli innocenti", afferma dal palco di
Ivrea. Un duro attacco alla magistratura da parte del comico genovese, che
afferma: "Questa magistratura fa paura. Io che sono un comico
ho più di ottanta processi e Berlusconi da presidente del Consiglio ne ha 22 in
meno, e poi va in televisione a lamentarsi". Il leader del Movimento Cinque
Stelle solo qualche tempo fa chiedeva il carcere immediato per il crack Parmalat
e anche oggi per lo scandalo di Mps. Garantista part-time -
Beppe ora si scopre garantista. Eppure per lui la presunzione di innocenza non è
mai esistita. Dai suoi palchi ha sempre emesso condanne prima che finissero le
istruttorie. Ma sull'attacco alle toghe, Grillo non sembra così lontano dal Cav.
Anche se in passato, il leader Cinque Stelle non ha mai perso l'occasione per
criticare Berlusconi e le sue idee su una riforma della
magistratura. E sul record di processi Berlusconi, ospite di Sky Tg24,
ha precisato: "Grillo non è informato. Io ho un record assoluto di 2700 udienze.
I procedimenti contro di me più di cento, credo nessuno possa battere un record
del genere".
"La vera mafia è lo
Stato, alcuni magistrati che lo rappresentano si comportano da mafiosi. Il
magistrato che mi racconta che Andreotti ha baciato Riina io lo voglio in galera".
Così Vittorio Sgarbi il 6 maggio 2013 ad “Un Giorno Da Pecora su Radio 2.
«Da noi -
ha dichiarato Silvio
Berlusconi ai cronisti di una televisione greca il 23 febbraio 2013 - la
magistratura è una mafia più pericolosa della mafia siciliana, e lo dico sapendo
di dire una cosa grossa». «In Italia regna una "magistocrazia". Nella
magistratura c'è una vera e propria associazione a delinquere» Lo ha detto
Silvio Berlusconi il 28 marzo 2013 durante la riunione del gruppo Pdl a
Montecitorio. Ed ancora Silvio Berlusconi all'attacco ai magistrati: «L'Anm è
come la P2, non dice chi sono i loro associati». Il riferimento dell'ex
premier è alle associazioni interne ai magistrati, come Magistratura
Democratica. Il Cavaliere è a Udine il 18 aprile 2013 per un comizio.
Sui media prezzolati e/o
ideologicizzati si parla sempre dei privilegi, degli sprechi e dei costi della
casta dei rappresentanti politici dei cittadini nelle istituzioni, siano essi
Parlamentari o amministratori e consiglieri degli enti locali. Molti di loro
vorrebbero i barboni in Parlamento. Nessuno che pretenda che i nostri
Parlamentari siano all’altezza del mandato ricevuto, per competenza, dedizione e
moralità, al di là della fedina penale o delle prebende a loro destinate.
Dimenticandoci che ci sono altri boiardi di Stato: i militari, i dirigenti
pubblici e, soprattutto, i magistrati. Mai nessuno che si chieda: che fine fanno
i nostri soldi, estorti con balzelli di ogni tipo. Se è vero, come è vero, che
ci chiudono gli ospedali, ci chiudono i tribunali, non ci sono vie di
comunicazione (strade e ferrovie), la pensione non è garantita e il lavoro
manca. E poi sulla giustizia, argomento dove tutti tacciono, ma c’è tanto da
dire. “Delegittimano la Magistratura” senti accusare gli idolatri sinistroidi in
presenza di velate critiche contro le malefatte dei giudici, che in democrazia
dovrebbero essere ammesse. Pur non avendo bisogno di difesa d’ufficio c’è sempre
qualche manettaro che difende la Magistratura dalle critiche che essa fomenta.
Non è un Potere, ma la sinistra lo fa passare per tale, ma la Magistratura, come
ordine costituzionale detiene un potere smisurato. Potere ingiustificato, tenuto
conto che la sovranità è del popolo che la esercita nei modi stabiliti dalle
norme. Potere delegato da un concorso pubblico come può essere quello italiano,
che non garantisce meritocrazia. Criticare l’operato dei magistrati nei
processi, quando la critica è fondata, significa incutere dubbi sul loro
operato. E quando si sentenzia, da parte dei colleghi dei PM, adottando le tesi
infondate dell’accusa, si sentenzia nonostante il ragionevole dubbio. Quindi si
sentenzia in modo illegittimo che comunque è difficile vederlo affermare da una
corte, quella di Cassazione, che rappresenta l’apice del potere giudiziario. Le
storture del sistema dovrebbero essere sanate dallo stesso sistema. Ma quando
“Il Berlusconi” di turno si sente perseguitato dal maniaco giudiziario, non vi
sono rimedi. Non è prevista la ricusazione del Pubblico Ministero che palesa il
suo pregiudizio. Vi si permette la ricusazione del giudice per inimicizia solo
se questi ha denunciato l’imputato e non viceversa. E’ consentita la ricusazione
dei giudici solo per giudizi espliciti preventivi, come se non vi potessero
essere intendimenti impliciti di colleganza con il PM. La rimessione per
legittimo sospetto, poi, è un istituto mai applicato. Lasciando perdere
Berlusconi, è esemplare il caso ILVA a Taranto. Tutta la magistratura locale fa
quadrato: dal presidente della Corte d’Appello di Lecce, Buffa, al suo
Procuratore Generale, Vignola, fino a tutto il Tribunale di Taranto. E questo
ancora nella fase embrionale delle indagini Preliminari. Quei magistrati contro
tutti, compreso il governo centrale, regionale e locale, sostenuti solo dagli
ambientalisti di maniera. Per Stefano Livadiotti, autore di un libro sui
magistrati, arrivano all'apice della carriera in automatico e guadagnano 7 volte
più di un dipendente”, scrive Sergio Luciano su “Il Giornale”.
Pubblichiamo ampi stralci
dell'intervista di Affaritaliani.it a Stefano Livadiotti realizzata da Sergio
Luciano. Livadiotti, giornalista del settimanale l'Espresso e autore di
Magistrati L'ultracasta, sta aggiornando il suo libro sulla base dei dati
del rapporto 2012 del Cepej (Commissione europea per l'efficienza della
giustizia del Consiglio d'Europa). Livadiotti è anche l'autore di un libro sugli
sprechi dei sindacati, dal titolo L'altra casta.
La giustizia italiana non
funziona, al netto delle polemiche politiche sui processi Berlusconi. Il
rapporto 2012 del Cepej (Commissione europea per l'efficienza della giustizia
del Consiglio d'Europa) inchioda il nostro sistema alla sua clamorosa
inefficienza: 492 giorni per un processo civile in primo grado, contro i 289
della Spagna, i 279 della Francia e i 184 della Germania. Milioni di
procedimenti pendenti. E magistrati che fanno carriera senza alcuna selezione
meritocratica. E senza alcun effettivo rischio di punizione nel caso in cui
commettano errori o illeciti. «Nessun sistema può essere efficiente se non
riconosce alcun criterio di merito», spiega Stefano Livadiotti, giornalista del
settimanale l'Espresso e autore di Magistrati-L'ultracasta. «È evidente che
Silvio Berlusconi ha un enorme conflitto d'interessi in materia, che ne
delegittima le opinioni, ma ciò non toglie che la proposta di riforma avanzata
all'epoca da Alfano, con la separazione delle carriere, la ridefinizione della
disciplina e la responsabilità dei magistrati, fosse assolutamente giusta».
Dunque niente meritocrazia,
niente efficienza in tribunale?
«L'attuale normativa prevede
che dopo 27 anni dall'aver preso servizio, tutti i magistrati raggiungano la
massima qualifica di carriera possibile. Tanto che nel 2009 il 24,5% dei circa
9.000 magistrati ordinari in servizio era appunto all'apice dell'inquadramento.
E dello stipendio. E come se un quarto dei giornalisti italiani fosse direttore
del Corriere della Sera o di Repubblica».
E come si spiega?
«Non si spiega. Io stesso
quando ho studiato i meccanismi sulle prime non ci credevo. Eppure e così. Fanno
carriera automaticamente, solo sulla base dell'anzianità di servizio. E di esami
che di fatto sono una barzelletta. I verbali del Consiglio superiore della
magistratura dimostrano che dal 1° luglio 2008 al 31 luglio 2012 sono state
fatte, dopo l'ultima riforma delle procedure, che avrebbe dovuto renderle più
severe, 2.409 valutazioni, e ce ne sono state soltanto 3 negative, una delle
quali riferita a un giudice già in pensione!».
Tutto questo
indipendentemente dagli incarichi?
«Dagli incarichi e dalle sedi.
E questa carriera automatica si riflette, ovviamente, sulla spesa per le
retribuzioni. I magistrati italiani guadagnano più di tutti i loro colleghi
dell'Europa continentale, e al vertice della professione percepiscono uno
stipendio parti a 7,3 volte lo stipendio medio dei lavoratori dipendenti
italiani».
Quasi sempre i magistrati
addebitano ritardi e inefficienze al basso budget statale per la giustizia.
«Macché, il rapporto Cepej
dimostra che la macchina giudiziaria costa agli italiani, per tribunali,
avvocati d'ufficio e pubblici ministeri, 73 euro per abitante all'anno (dato
2010, ndr) contro una media europea di 57,4. Quindi molto di più».
Ma almeno rischiano
sanzioni disciplinari?
«Assolutamente no, di fatto.
Il magistrato è soggetto solo alla disciplina domestica, ma sarebbe meglio dire
addomesticata, del Csm. E cane non mangia cane. Alcuni dati nuovi ed esclusivi
lo dimostrano».
Quali dati?
«Qualunque esposto venga
rivolto contro un magistrato, passa al filtro preventivo della Procura generale
presso la Corte di Cassazione, che stabilisce se c'è il presupposto per avviare
un procedimento. Ebbene, tra il 2009 e il 2011 - un dato che fa impressione -
sugli 8.909 magistrati ordinari in servizio, sono pervenute a questa Procura
5.921 notizie di illecito: il PG ha archiviato 5.498 denunce, cioè il 92,9%;
quindi solo 7,1% è arrivato davanti alla sezione disciplinare del Csm».
Ma poi ci saranno state
delle sanzioni, o no?
«Negli ultimi 5 anni, tra il
2007 e il 2011, questa sezione ha definito 680 procedimenti, in seguito ai quali
i magistrati destituiti sono stati... nessuno. In dieci anni, tra il 2001 e il
2011, i magistrati ordinari destituiti dal Csm sono stati 4, pari allo 0,28 di
quelli finiti davanti alla sezione disciplinare e allo 0,044 di quelli in
servizio».
Ma c'è anche una legge
sulla responsabilità civile, che permette a chi subisca un errore giudiziario di
essere risarcito!
«In teoria sì, è la legge 117
dell'88, scritta dal ministro Vassalli per risponde al referendum che aveva
abrogato le norme che limitavano la responsabilità dei magistrati».
E com'è andata, questa
legge?
«Nell'arco 23 anni, sono state
proposte in Italia 400 cause di richiesta di risarcimento danni per
responsabilità dei giudici. Di queste, 253 pari al 63% sono state dichiarate
inammissibili con provvedimento definitivo. Ben 49, cioè 12% sono in attesa di
pronuncia sull'ammissibilità, 70, pari al 17%, sono in fase di impugnazione di
decisione di inammissibilità, 34, ovvero l'8,5%, sono state dichiarate
ammissibili. Di queste ultime, 16 sono ancora pendenti e 18 sono state decise:
lo Stato ha perso solo 4 volte. In un quarto di secolo è alla fine è stato
insomma accolto appena l'1 per cento delle pochissime domande di risarcimento».
Cioè non si sa quanto
lavorano e guadagnano?
«Risulta che da un magistrato
ci si possono attendere 1.560 ore di lavoro all'anno, che diviso per 365 vuol
dire che lavora 4,2 ore al giorno. Sugli stipendi bisogna vedere caso per caso,
perché ci sono molte variabili. Quel che è certo, un consigliere Csm, sommando
stipendi base, gettoni, rimborsi e indennizzi, e lavorando 3 settimane su 4 dal
lunedì al giovedì, quindi 12 giorni al mese, guadagna 2.700 euro per ogni giorno
di lavoro effettivo».
TRALASCIANDO L’ABILITAZIONE
UNTA DAI VIZI ITALICI, A FRONTE DI TUTTO QUESTO CI RITROVIAMO CON 5 MILIONI DI
ITALIANI VITTIME DI ERRORI GIUDIZIARI.
MAGISTRATI CHE SONO
MANTENUTI DAI CITTADINI E CHE SPUTANO NEL PIATTO IN CUI MANGIANO.
Chi frequenta assiduamente le
aule dei tribunali, da spettatore o da attore, sa benissimo che sono luogo di
spergiuro e di diffamazioni continue da parte dei magistrati e degli avvocati.
Certo è che sono atteggiamenti impuniti perché i protagonisti non possono punire
se stessi. Quante volte le requisitorie dei Pubblici Ministeri e le arringhe
degli avvocati di parte civile hanno fatto carne da macello della dignità delle
persone imputate, presunte innocenti in quella fase processuale e, per lo più,
divenuti tali nel proseguo. I manettari ed i forcaioli saranno convinti che
questa sia un regola aurea per affermare la legalità. Poco comprensibile e
giustificabile è invece la sorte destinata alle vittime, spesso trattate peggio
dei delinquenti sotto processo.
Tutti hanno sentito le parole
di Ilda Boccassini: "Ruby è furba di quella furbizia orientale propria della sua
origine". «E' una giovane di furbizia orientale che come molti dei giovani delle
ultime generazioni ha come obbiettivo entrare nel mondo spettacolo e fare soldi,
il guadagno facile, il sogno italiano di una parte della gioventù che non ha
come obiettivo il lavoro, la fatica, lo studio ma accedere a meccanismi che
consentano di andare nel mondo dello spettacolo, nel cinema. Questo obiettivo -
ha proseguito la Boccassini - ha accomunato la minore "con le ragazze che sono
qui sfilate e che frequentavano la residenza di Berlusconi: extracomunitarie,
prostitute, ragazze di buona famiglia anche con lauree, persone che hanno un
ruolo nelle istituzioni e che pure avevano un ruolo nelle serate di Arcore come
la europarlamentare Ronzulli e la europarlamentare Rossi. In queste serate -
afferma il pm - si colloca anche il sogno di Kharima. Tutte, a qualsiasi prezzo,
dovevano avvicinare il presidente del Consiglio con la speranza o la certezza di
ottenere favori, denaro, introduzione nel mondo dello spettacolo».
Fino a prova contraria Ruby,
Karima El
Mahroug, è parte offesa nel processo.
La ciliegina sulla torta, alla
requisitoria, è quella delle 14.10 circa del 31 maggio 2013, quando Antonio
Sangermano era sul punto d'incorrere su una clamorosa gaffe che avrebbe fatto
impallidire quella della Boccassini su Ruby: "Non si può considerare la Tumini
un cavallo di ....", ha detto di Melania Tumini, la principale
teste dell'accusa, correggendosi un attimo prima di pronunciare la fatidica
parola.
Ancora come esempio riferito
ad un caso mediatico è quello riconducibile alla morte di Stefano Cucchi.
“Vi annuncio che da oggi
pomeriggio (8 aprile 2013) provvederò a inserire sulla mia pagina ufficiale di
Facebook quanto ci hanno riservato i pm ed avvocati e le loro poco
edificanti opinioni sul nostro conto. Buon ascolto”, ha scritto sulla pagina del
social network Ilaria Cucchi, sorella di Stefano. E il primo audio è dedicato
proprio a quei pm con i quali la famiglia Cucchi si è trovata dall’inizio in
disaccordo. «Lungi dall’essere una persona sana e sportiva, Stefano Cucchi
era un tossicodipendente da 20 anni,…….oltre che essere maleducato, scorbutico,
arrogante, cafone». Stavolta a parlare non è il senatore del Pdl Carlo
Giovanardi – anticipa Ilaria al Fatto –, ma il pubblico ministero
Francesca Loy, durante la requisitoria finale. Secondo lei mio fratello
aveva cominciato a drogarsi a 11 anni…”, commenta ancora sarcastica la sorella
del ragazzo morto. Requisitoria che, a suo dire, sembra in contraddizione con
quella dell’altro pm, Vincenzo Barba, il quale “ammette – a differenza
della collega – che Stefano potrebbe essere stato pestato. Eppure neanche lui
lascia fuori dalla porta l’ombra della droga e, anzi, pare voglia lasciare
intendere che i miei genitori ne avrebbero nascosto la presenza ai carabinieri
durante la perquisizione, la notte dell’arresto”.
A tal riguardo è uscito un
articolo su “L’Espresso”. A firma di Ermanno Forte. “Ora processano
Mastrogiovanni”. Requisitoria da anni '50 nel dibattimento sull'omicidio del
maestro: il pm difende gli imputati e se la prende con le 'bizzarrie' della
vittima. Non c'è stato sequestro di persona perché la contenzione è un atto
medico e quindi chi ha lasciato un uomo legato mani e piedi a un letto, per
oltre 82 ore, ha semplicemente agito nell'esercizio di un diritto medico. Al
massimo ha ecceduto nella sua condotta, ma questo non basta a considerare
sussistente il reato di sequestro. E' questa la considerazione centrale della
requisitoria formulata da Renato Martuscelli al processo che vede imputati
medici e infermieri del reparto di psichiatria dell'ospedale San Luca di Vallo
della Lucania, per la morte di Francesco Mastrogiovanni. Il pm ha dunque in gran
parte sconfessato l'impianto accusatorio imbastito nella fase delle indagini e
di richiesta di rinvio a giudizio da Francesco Rotondo, il magistrato che sin
dall'inizio ha lavorato sul caso, disponendo l'immediato sequestro del video
registrato dalle telecamere di sorveglianza del reparto psichiatrico, e che poi
è stato trasferito. Nella prima parte della requisitoria - durata un paio d'ore,
davanti al presidente del tribunale Elisabetta Garzo –Martuscelli si è
soffermato a lungo sui verbali di carabinieri e vigili urbani relativi alle ore
precedenti al ricovero (quelli dove si descrivono le reazioni di Mastrogiovanni
alla cattura avvenuta sulla spiaggia di San Mauro Cilento e le presunte
infrazioni al codice della strada commesse dal maestro), oltre a ripercorrere la
storia sanitaria di Mastrogiovanni, già sottoposto in passato a due Tso, nel
2002 e nel 2005. "Una buona metà dell'intervento del pm è stata dedicata a
spiegare al tribunale quanto fosse cattivo e strano Franco Mastrogiovanni"
commenta Michele Capano, rappresentante legale del Movimento per la Giustizia
Robin Hood, associazione che si è costituita parte civile al processo "sembrava
quasi che l'obiettivo di questa requisitoria fosse lo stesso maestro cilentano,
e non i medici di quel reparto".
Beati coloro che hanno fame e sete di
giustizia perché saranno giustiziati.
“Il carcere uno stupro. Ora
voglio la verità”, dice Massimo Cellino, presidente del Cagliari calcio, ad
Ivan Zazzaroni.
«Voglio conoscere la vera ragione di
tutto questo, i miei legali l’hanno definito “uno stupro”. Cassazione e Tar
hanno stabilito che non ci sono stati abusi, dandomi ragione piena. -
Ricorda:
riordina. - La forestale s’è presentata a casa mia alle sette del mattino. Ho le
piante secche?, ho chiesto. E loro: deve venire con noi. Forza, tirate fuori le
telecamere, dove sono le telecamere? Siete di Scherzi a parte. L’inizio di un
incubo dal quale non esco. Sto male, non sono più lo stesso. A Buoncammino mi
hanno messo in una cella minuscola, giusto lo spazio per un letto, il vetro
della finestra era rotto, la notte faceva freddo. Un detenuto mi ha regalato una
giacca, un altro i pantaloni della tuta, alla fine ero coperto a strati con in
testa una papalina. Mi hanno salvato il carattere e gli altri detenuti. Un
ragazzo che sconta otto anni e mezzo perché non ha voluto fare il nome dello
spacciatore che gli aveva consegnato la roba. Otto anni e mezzo, capisci? “Se
parlo non posso più tornare a casa, ho paura per i miei genitori”, ripeteva. E
poi un indiano che mi assisteva in tutto, credo l’abbiano trasferito come altri
a Macomer. Mi sento in colpa per loro, solo per loro. Ringrazio
le guardie carcerarie, si sono dimostrate sensibili… Mi ha tradito la Sardegna
delle istituzioni. Ma adesso voglio il perché, la verità. Non si può finire in
carcere per arroganza». Una situazione di straordinario strazio per un uomo fin
troppo diretto ma di un’intelligenza e una prontezza rare quale è il presidente
del Cagliari. «Non odio nessuno (lo ripete più volte). Ma ho provato vergogna.
Non ho fatto un cazzo di niente. Dopo la revoca dei domiciliari per un paio di
giorni non ho avuto la forza di tornare a casa. Sono rimasto ad Assemini con gli
avvocati, Altieri e Cocco – Cocco per me è un fratello. E le
intercettazioni? Pubblicatele, nulla, non c’è nulla. Mi hanno accusato
di aver trattato con gente che non ho mai incontrato, né sentito; addirittura mi
è stato chiesto cosa fossero le emme-emme di cui parlavo durante una telefonata:
solo un sardo può sapere cosa significhi emme-emme, una pesante volgarità (sa
minchia su molente, il pene dell’asino). Da giorni mi raccontano di assessori
che si dimettono, di magistrati che chiedono il trasferimento. Mi domando cosa
sia diventata Cagliari, e dove sia finita l’informazione che non ha paura di
scrivere o dire come stanno realmente le cose.
Cosa penso oggi dei magistrati? Io sono dalla parte dei pm, lo sono sempre
stato!»
VEDETE, E’ TUTTO INUTILE. NON C’E’ NIENTE
DA FARE. SE QUANTO PROVATO SULLA PROPRIA PELLE E SE QUANTO DETTO HA UN RISCONTRO
E TUTTO CIO' NON BASTA A RIBELLARSI O ALMENO A RICREDERSI SULL'OPERATO DELLA
MAGISTRATURA, ALLORA MAI NULLA CAMBIERA' IN QUESTA ITALIA CON QUESTI ITALIANI.
D'altronde di italiani si tratta:
dicono una cosa ed un’altra ne fanno. Per esempio, rimanendo in ambito sportivo
in tema di legalità, è da rimarcare come la
parola di un altoatesino vale di più di quella di un napoletano. Almeno secondo
Alex Schwazer, atleta nato in quel di Vipiteno il 26 dicembre 1984, trovato
positivo al test antidoping prima delle Olimpiadi di Londra 2012. Era il 28
giugno 2012. Due giorni dopo, un test a sorpresa della Wada, l'agenzia mondiale
antidoping, avrebbe rivelato la sua positività all'assunzione dell'Epo. «Posso
giurare che non ho fatto niente di proibito – scriveva Schwazer, il 28 giugno
2012, al medico della Fidal Pierluigi Fiorella – ti ho dato la mia parola e non
ti deluderò. Sono altoatesino, non sono napoletano». Due giorni dopo, il 30
giugno, l'atleta viene trovato positivo all'Epo. Ma l'insieme della
contraddizioni (a voler essere gentili) non finisce qui. Nella sua confessione
pubblica dell'8 agosto 2012, Schwazer ammise di aver assunto Epo a causa di un
cedimento psicologico. Era un brutto periodo, e qualcosa bisognava pur fare. Ma
le indagini dei Ros di Trento e dei Nas di Firenze contraddicono la versione
dell'assunzione momentanea. I carabinieri, addirittura, parlano di “profilo
ematologico personale”, un'assunzione continua e costante di sostanze dopanti
per la quale non è escluso che Schwazer facesse utilizzo di Epo anche durante i
giochi di Pechino 2008. Competizione, lo ricordiamo, dove l'atleta di Vipiteno,
vinse l'oro alla marcia di 50 chilometri. Infatti, questo si evince anche nel
decreto di perquisizione della Procura di Bolzano. “La polizia giudiziaria
giunge pertanto a ritenere che non possa escludersi che Schwazer Alex, già
durante la preparazione per i Giochi Olimpici di Pechino 2008 (e
forse ancor prima), sia stato sottoposto a trattamenti farmacologici
o a manipolazioni fisiologiche capaci di innalzare considerevolmente i suoi
valori ematici.” Insomma: Schwazer non solo offende i napoletani e di
riporto tutti i meridionali, incluso me, ma poi, come un fesso, si fa cogliere
pure con le mani nel sacco. E dire che, oltretutto, è la parola di un
carabiniere, qual è Alex Schwazer.
L'Italia è un Paese fondato
sulla fregatura: ecco tutti i modi in cui gli italiani raggirano gli altri (e sé
stessi). In un libro, "Io ti
fotto" di Carlo Tecce e Marco Morello, la pratica dell'arte della fregatura
in Italia. Dai più alti livelli ai più infimi, dalle truffe moderne realizzate
in Rete a quelle più antiche e consolidate.
In Italia, fottere
l'altro - una parola più tenue non renderebbe l'idea - è un vizio che è quasi un
vanto, "lo ti fotto" è una legge: di più, un comandamento.
E
fottuti siamo stati dagli albori della Repubblica.
L'armistizio di Cassabile in
Sicilia o armistizio corto, siglato segretamente il 3 settembre 1943, è
l'atto con il quale il Regno d’Italia cessò le ostilità contro le forze
anglo-americane (alleati) nell'ambito della seconda guerra mondiale. In realtà
non si trattava affatto di un armistizio ma di una vera e propria resa senza
condizioni da parte dell'Italia. Poiché tale atto stabiliva la sua entrata in
vigore dal momento del suo annuncio pubblico, esso è comunemente detto dell'" 8
settembre", data in cui, alle 18.30, fu pubblicamente reso noto prima dai
microfoni di Radio Algeri da parte del generale Dwight D. Eisenhower e, poco più
di un'ora dopo, alle 19.42, confermato dal proclama del maresciallo Pietro
Badoglio trasmesso dai microfoni dell' Eiar. In quei frangenti vi fu grande
confusione e i gerarchi erano in fuga. L’esercito allo sbando. Metà Italia
combatteva contro gli Alleati, l’altra metà a favore.
La grande ipocrisia vien da
lontano. “I Vinti non dimenticano” (Rizzoli 2010), è il titolo del volume
di Giampaolo Pansa. Ci si fa largo tra i morti, ogni pagina è
una fossa e ci sono perfino preti che negano la benedizione ai condannati. E poi
ci sono le donne, tante, tutte ridotte a carne su cui sbattere il macabro
pedaggio dell’odio. È un viaggio nella memoria negata, quella della guerra
civile, altrimenti celebrata nella retorica della Resistenza.. Le storie inedite
di sangue e violenza che completano e concludono "Il sangue dei vinti", uscito
nel 2003. Si tenga conto che da queste realtà politiche
uscite vincenti dalla guerra civile è nata l'alleanza catto-comunista, che ha
dato vita alla Costituzione Italiana e quantunque essa sia l'architrave delle
nostre leggi, ad oggi le norme più importanti, che regolano la vita degli
italiani (codice civile, codice penale, istituzione e funzionamento degli Ordini
professionali, ecc.), sono ancora quelle fasciste: alla faccia dell'ipocrisia
comunista, a cui quelle leggi non dispiacciono.
Esecuzioni, torture, stupri.
Le crudeltà dei partigiani. La Resistenza mirava alla dittatura comunista. Le
atrocità in nome di Stalin non sono diverse dalle efferatezze fasciste. Anche se
qualcuno ancora lo nega scrive Giampaolo Pansa. (scrittore notoriamente
comunista osteggiato dai suoi compagni di partito per essere ai loro occhi
delatore di verità scomode). C’è da scommettere che il libro di Giampaolo Pansa,
"La guerra sporca dei partigiani e dei fascisti" (Rizzoli, pagg. 446), farà
infuriare le vestali della Resistenza. Mai in maniera così netta come
nell’introduzione al volume (di cui per gentile concessione “Il Giornale”
pubblica un estratto) i crimini partigiani sono equiparati a quelli dei
fascisti. Giampaolo Pansa imbastisce un romanzo che, sull’esempio delle sue
opere più note, racconta la guerra civile in chiave revisionista, sottolineando
le storie dei vinti e i soprusi dei presunti liberatori, i partigiani comunisti
in realtà desiderosi di sostituire una dittatura con un’altra, la loro.
Altra storica menzogna è stata
sbugiardata da
"Mai più terroni. La fine della questione
meridionale"
di Pino Aprile. Come abbattere i pregiudizi che rendono il meridione diverso?
Come mettere fine a una questione costruita ad arte sulla pelle di una parte
d'Italia? La risposta sta anche negli strumenti di comunicazione odierni, capaci
di abbattere i confini, veri o fittizi, rompere l'isolamento, superare le
carenze infrastrutturali. E se per non essere più "meridionali" bastasse un
clic? Con la sua solita vis polemica, Pino Aprile ci apre un mondo per mostrare
quanto questo sia vero, potente e dilagante. "Ops... stanno finendo i terroni.
Ma come, già? E così, da un momento all'altro?"
Terroni a chi? Tre libri
sul pregiudizio antimeridionale. Come è nata e come si è sviluppata la
diffidenza verso il Sud. Tre libri ne ricostruiscono le origini e provano a
ipotizzarne gli scenari.
"Negli ormai
centocinquant'anni di unità italiana il Mezzogiorno non ha mai mancato di creare
problemi". D'accordo, la frase è netta e controversa. Sulla questione
meridionale, nell'ultimo secolo e mezzo, si sono sprecati fiumi di inchiostro,
tonnellate di pagine, migliaia di convegni. In gran parte dedicati all'indagine
sociologica, al pregiudizio politico o alla rivendicazione identitaria. Ciò che
colpisce allora di "La palla al piede" di Antonino De Francesco
(Feltrinelli) è lo sguardo realistico e l'approccio empirico. De Francesco è
ordinario di Storia moderna all'Università degli studi di Milano, ma definire il
suo ultimo lavoro essenzialmente storico è quantomeno limitativo. In poco meno
di duecento pagine, l'autore traccia l'identikit di un pregiudizio, quello
antimeridionale appunto, nei suoi aspetti sociali, storici e politici. Lo fa
rincorrendo a una considerevole pubblicistica per niente autoreferenziale, che
non si ostina nel solito recinto storiografico. Il risultato si avvicina a una
controstoria dell'identità italiana e, al tempo stesso, a un'anamnesi dei vizi e
dei tic dell'Italia Unita. Ma per raccontare una storia ci si può ovviamente
mettere sulle tracce di una tradizione e cercare, attraverso le sue strette
maglie, di ricostruire una vicenda che ha il respiro più profondo di una
semplice schermaglia localistica. E' quello che accade nel "Libro napoletano
dei morti" di Francesco Palmieri (Mondadori). Racconta la Napoli eclettica e
umbratile che dall’Unità d'Italia arriva fino alla Prima guerra mondiale. Per
narrarla, si fa scudo della voce del poeta napoletano Ferdinando Russo
ricostruendo con una certa perizia filologica e una sottile verve
narrativa le luci e le smagliature di un'epopea in grado di condizionare la
realtà dei giorni nostri. Ha il respiro del pamphlet provocatorio e spiazzante
invece l'ultimo libro di Pino Aprile, "Mai più terroni" (Piemme), terzo
volume di una trilogia di successo (Terroni e Giù al Sud i titoli
degli altri due volumi). Aprile si domanda se oggi abbia ancora senso dividere
la realtà sulla base di un fantomatico pregiudizio etnico e geografico
che ha la pretesa di tagliare Nord e Sud. E si risponde che no, che in tempi di
iperconnessioni reali (e virtuali), quelli stereotipo è irrimediabilmente
finito. "Il Sud - scrive - è un luogo che non esiste da solo, ma soltanto se
riferito a un altro che lo sovrasta". Nelle nuove realtà virtuali, vecchie
direzioni e punti cardinali non esistono più, relegati come sono a un
armamentario che sa di vecchio e obsoleto.
D'altronde siamo abituati alle
stronzate dette da chi in mala fede parla e le dice a chi, per ignoranza, non
può contro ribattere. Cominciamo a dire: da quale pulpito viene la predica.
Vediamo in Inghilterra cosa succede. I sudditi inglesi snobbano gli italiani. Ci
chiamano mafiosi, ma perché a loro celano la verità. Noi apprendiamo la notizia
dal tg2 delle 13.00 del 2 gennaio 2012. Il loro lavoro è dar la caccia ai
criminali, ma alcuni ladri non sembrano temerle: le forze di polizia del Regno
sono state oggetto di furti per centinaia di migliaia di sterline, addirittura
con volanti, manette, cani ed uniformi tutte sparite sotto il naso degli agenti.
Dalla lista, emersa in seguito ad una richiesta secondo la legge sulla libertà
d'informazione, emerge che la forza di polizia più colpita è stata quella di
Manchester, dove il valore totale degli oggetti rubati arriva a quasi 87.000
sterline. Qui i ladri sono riusciti a fuggire con una volante da 10.000 sterline
e con una vettura privata da 30.000.
E poi. Cosa sarebbe oggi la
Germania se avesse sempre onorato con puntualità il proprio debito pubblico? Si
chiede su “Il Giornale” Antonio Salvi,
Preside della Facoltà di Economia
dell’Università Lum "Jean Monnet".
Forse non a tutti è noto, ma il Paese della cancelliera Merkel è stato
protagonista di uno dei più grandi, secondo alcuni il più grande, default del
secolo scorso, nonostante non passi mese senza che Berlino stigmatizzi il
comportamento vizioso di alcuni Stati in materia di conti pubblici. E invece,
anche la Germania, la grande e potente Germania, ha qualche peccatuccio che
preferisce tenere nascosto. Anche se numerosi sono gli studi che ne danno conto,
di seguito brevemente tratteggiati. Riapriamo i libri di storia e cerchiamo di
capire la successione dei fatti. La Germania è stata protagonista «sfortunata»
di due guerre mondiali nella prima metà dello scorso secolo, entrambe perse in
malo modo. Come spesso accade in questi casi, i vincitori hanno presentato il
conto alle nazioni sconfitte, in primis alla Germania stessa. Un conto salato,
soprattutto quello successivo alla Prima guerra mondiale, talmente tanto salato
che John Maynard Keynes, nel suo Conseguenze economiche della pace, fu uno dei
principali oppositori a tale decisione, sostenendo che la sua applicazione
avrebbe minato in via permanente la capacità della Germania di avviare un
percorso di rinascita post-bellica. Così effettivamente accadde, poiché la
Germania entrò in un periodo di profonda depressione alla fine degli anni '20
(in un più ampio contesto di recessione mondiale post '29), il cui esito minò la
capacità del Paese di far fronte ai propri impegni debitori internazionali.
Secondo Scott Nelson, del William and Mary College, la Germania negli anni '20
giunse a essere considerata come «sinonimo di default». Arrivò così il 1932,
anno del grande default tedesco. L'ammontare del debito di guerra, secondo gli
studiosi, equivalente nella sua parte «realistica» al 100% del Pil tedesco del
1913 (!), una percentuale ragguardevole. Poi arrivò al potere Hitler e
l'esposizione debitoria non trovò adeguata volontà di onorare puntualmente il
debito (per usare un eufemismo). I marchi risparmiati furono destinati ad
avviare la rinascita economica e il programma di riarmo. Si sa poi come è
andata: scoppio della Seconda guerra mondiale e seconda sconfitta dei tedeschi.
A questo punto i debiti pre-esistenti si cumularono ai nuovi e l'esposizione
complessiva aumentò. Il 1953 rappresenta il secondo default tedesco. In
quell'anno, infatti, gli Stati Uniti e gli altri creditori siglarono un accordo
di ridefinizione complessiva del debito tedesco, procedendo a «rinunce
volontarie» di parte dei propri crediti, accordo che consentì alla Germania di
poter ripartire economicamente (avviando il proprio miracolo economico, o
«wirtschaftswunder»). Il lettore non sia indotto in inganno: secondo le agenzie
di rating, anche le rinegoziazioni volontaristiche configurano una situazione di
default, non solo il mancato rimborso del capitale e degli interessi (la Grecia
nel 2012 e l'Argentina nel 2001 insegnano in tal senso). Il risultato ottenuto
dai tedeschi dalla negoziazione fu davvero notevole:
1) l'esposizione debitoria fu
ridotta considerevolmente: secondo alcuni calcoli, la riduzione concessa alla
Germania fu nell'ordine del 50% del debito complessivo!
2) la durata del debito fu
estesa sensibilmente (peraltro in notevole parte anche su debiti che erano stati
non onorati e dunque giunti a maturazione già da tempo). Il rimborso del debito
fu «spalmato» su un orizzonte temporale di 30 anni;
3) le somme corrisposte
annualmente ai creditori furono legate al fatto che la Germania disponesse
concretamente delle risorse economiche necessarie per effettuare tali
trasferimenti internazionali.
Sempre secondo gli accordi del
'53, il pagamento di una parte degli interessi arretrati fu subordinata alla
condizione che la Germania si riunificasse, cosa che, come noto, avvenne
nell'ottobre del 1990. Non solo: al verificarsi di tale condizione l'accordo del
1953 si sarebbe dovuto rinegoziare, quantomeno in parte. Un terzo default, di
fatto. Secondo Albrecht Frischl, uno storico dell'economia tedesco, in una
intervista concessa a Spiegel, l'allora cancelliere Kohl si oppose alla
rinegoziazione dell'accordo. A eccezione delle compensazioni per il lavoro
forzato e il pagamento degli interessi arretrati, nessun'altra riparazione è
avvenuta da parte della Germania dopo il 1990. Una maggiore sobrietà da parte
dei tedeschi nel commentare i problemi altrui sarebbe quanto meno consigliabile.
Ancora Fritschl, precisa meglio il concetto: «Nel Ventesimo secolo, la Germania
ha dato avvio a due guerre mondiali, la seconda delle quali fu una guerra di
annientamento e sterminio, eppure i suoi nemici annullarono o ridussero
pesantemente le legittime pretese di danni di guerra. Nessuno in Grecia ha
dimenticato che la Germania deve la propria prosperità alla generosità delle
altre nazioni (tra cui la Grecia, ndr)». È forse il caso di ricordare inoltre
che fu proprio il legame debito-austerità-crisi che fornì linfa vitale ad Adolf
Hitler e alla sua ascesa al potere, non molto tempo dopo il primo default
tedesco. Tre default, secondo una contabilità allargata. Non male per un Paese
che con una discreta periodicità continua a emettere giudizi moralistici sul
comportamento degli altri governi. Il complesso da primo della classe ottunde la
memoria e induce a mettere in soffitta i propri periodi di difficoltà. «Si sa
che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio». Era un
tempo la «bocca di rosa» di De André, è oggi, fra gli altri, la bocca del
Commissario europeo Ottinger (e qualche tempo fa del ministro delle Finanze
tedesco Wolfgang Schauble). A suo avviso, Bruxelles «non si è ancora resa
abbastanza conto di quanto sia brutta la situazione» e l'Europa invece di
lottare contro la crisi economica e del debito, celebra «il buonismo» e si
comporta nei confronti del resto del mondo come una maestrina, quasi un
«istituto di rieducazione». Accidenti, da quale pulpito viene la predica.
Non solo. Un altro luogo
comune viene sfatato ed abbattuto. La Germania di Angela Merkel
è il paese che ha l'economia sommersa più grande d'Europa in termini assoluti.
L'economia in nero teutonica vale 350 miliardi di euro. Sono circa otto milioni
i cittadini tedeschi che vivono lavorando in nero. Secondo gli esperti il dato è
figlio dell'ostilità dei tedeschi ai metodi di pagamento elettronici. I crucchi
preferiscono i contanti. La grandezza dell'economia in nero della Germania è
stata stimata e calcolata dal colosso delle carte di credito e dei circuiti di
pagamento Visa in collaborazione con l'università di Linz. In relazione al Pil
tedesco il nero sarebbe al 13 per cento, pari a un sesto della ricchezza
nazionale. Quindi in termini relativi il peso del sommerso è minore, ma per
volume e in termini assoluti resta la più grande d'Europa. Chi lavora in nero in
Germania di solito opera nel commercio e soprattutto nell'edilizia, poi c'è il
commercio al dettaglio e infine la gastronomia. Il livello del nero in Germania
comunque si è stabilizzato. Il picco è arrivato dieci anni fa. Nel 2003 la
Germania ha attraversato la peggiore stagnazione economica degli ultimi
vent'anni e all'epoca il nero valeva 370 miliardi. Ora con l'economia in ripresa
che fa da locomotiva per l'Europa, il nero è fermo al 13 per cento del Pil.
Tornando alla repubblica delle
manette ci si chiede. Come può, chi indossa una toga, sentirsi un padreterno,
specie se, come è noto a tutti, quella toga non rispecchia alcun meritocrazia?
D’altronde di magistrati ve ne sono più di 10 mila a regime, cosi come gli
avvocati sono intorno ai 150 mila in servizio effettivo.
Eppure nella mia vita non ho
mai trovato sulla mia strada una toga degna di rispetto, mentre invece, per loro
il rispetto si pretende. A me basta ed avanza essere Antonio Giangrande, senza
eguali per quello che scrive e dice. Pavido nell’affrontare una ciurma togata
pronta a fargli la pelle, mal riuscendoci questi, però, a tacitarlo sulle verità
a loro scomode.
Si chiedeva Sant’Agostino
(354-430): «Eliminata la giustizia, che cosa sono i regni se non bande di
briganti? E cosa sono le bande di briganti se non piccoli regni?». Secondo il
Vescovo di Ippona è la giustizia il principale, per non dire l’unico, argine
contro la voracità dei potenti.
Da quando è nato l’uomo, la
libertà e la giustizia sono gli unici due strumenti a disposizione della gente
comune per contrastare la condizione di sudditanza in cui tendono a relegarla i
detentori del potere. Anche un bambino comprende che il potere assoluto equivale
a corruzione assoluta.
Certo. Oggi nessuno parlerebbe
o straparlerebbe di assolutismo. I tempi del Re Sole sembrano più lontani di
Marte. Ma, a differenza della scienza e delle tecnologie, l’arte del governo è
l’unica disciplina in cui non si riscontrano progressi. Per dirla con lo storico
Tacito (55-117 d. C.), la sete di potere è la più scandalosa delle passioni. E
come si manifesta questa passione scandalosa? Con l’inflazione di spazi, compiti
e competenze delle classi dirigenti. Detto in termini aggiornati: elevando il
tasso di statalismo presente nella nostra società.
Friedrich Engels (1820-1895)
tutto era tranne che un liberale, ma, da primo marxista della Storia, scrisse
che quando la società viene assorbita dallo Stato, che a suo giudizio è
l’insieme della classe dirigente, il suo destino è segnato: trasformarsi in «una
macchina per tenere a freno la classe oppressa e sfruttata». Engels ragionava in
termini di classe, ma nelle sue parole riecheggiava una palese insofferenza
verso il protagonismo dello Stato, che lui identificava con il ceto dirigente
borghese, che massacrava la società. Una società libera e giusta è meno corrotta
di una società in cui lo Stato comanda in ogni pertugio del suo territorio.
Sembra quasi un’ovvietà, visto che la scienza politica lo predica da tempo: lo
Stato, per dirla con Sant’Agostino, tende a prevaricare come una banda di
briganti. Bisogna placarne gli appetiti.
E così i giacobini e i
giustizialisti indicano nel primato delle procure la vera terapia contro il
malaffare tra politica ed economia, mentre gli antigiustizialisti accusano i
magistrati di straripare con le loro indagini e i loro insabbiamenti fino al
punto di trasformarsi essi stessi in elementi corruttivi, dato che spesso le
toghe, secondo i critici, agirebbero per fini politici, se non, addirittura,
fini devianti, fini massonici e fini mafiosi.
Insomma. Uno Stato efficiente
e trasparente si fonda su buone istituzioni, non su buone intenzioni. Se le
Istituzioni non cambiano si potranno varare le riforme più ambiziose, dalla
giustizia al sistema elettorale; si potranno pure mandare in carcere o a casa
tangentisti e chiacchierati, ma il risultato (in termini di maggiore onestà del
sistema) sarà pari a zero. Altri corrotti si faranno avanti. La controprova? Gli
Stati meno inquinati non sono quelli in cui l’ordinamento giudiziario è
organizzato in un modo piuttosto che in un altro, ma quelli in cui le leggi sono
poche e chiare, e i cui governanti non entrano pesantemente nelle decisioni e
nelle attività che spettano a privati e società civile.
Oggi ci si scontra con una
dura realtà. La magistratura di Milano? Un potere separatista. Procure e
tribunali in Italia fanno quello che vogliono: basta una toga e arrivederci,
scrive Filippo Facci su “Libero Quotidiano”. L’equivoco prosegue da una vita: un
sacco di gente pensa che esista una sinergia collaudatissima tra i comportamenti
della politica e le decisioni della giustizia, come se da qualche parte ci fosse
una camera di compensazione in cui tutti i poteri (politici, giudiziari,
burocratici, finanziari) contrattassero l’uno con l’altro e rendessero tutto
interdipendente. Molti ragionano ancora come Giorgio Straquadanio
sul Fatto: «Questo clima pacifico porta a Berlusconi una marea di
benefici, l’aggressione giudiziaria è destinata a finire... c’è da aspettarsi
che le randellate travestite da sentenze, così come gli avvisi di garanzie e le
inchieste, cessino». Ora: a parte che solo una nazione profondamente arretrata
potrebbe funzionare così, questa è la stessa mentalità che ha contribuito al
crollo della Prima Repubblica, protesa com’era a trovare il volante «politico»
di inchieste che viceversa avevano smesso di averne uno. In troppi, in Italia,
non hanno ancora capito che non esiste più niente del genere, se non, in misura
fisiologica e moderata, a livello di Quirinale-Consulta-Csm. Ma per il resto
procure e tribunali fanno quello che vogliono: basta un singolo magistrato e
arrivederci. L’emblema ne resta Milano, dove la separatezza tra giudici e
procuratori non ci si preoccupa nemmeno di fingerla: la magistratura, più che
separato, è ormai un potere separatista.
Prodigio delle toghe: per lo
stesso reato salvano il Pd e non il Pdl. A Bergamo "non luogo a procedere" per
un democratico, a Milano invece continua il processo contro Podestà, scrive
Matteo Pandini su “Libero Quotidiano”.
Stesso fatto (firme tarocche
autenticate), stesso capo d’accusa (falso ideologico), stesso appuntamento
elettorale (le Regionali lombarde), stesso anno (il 2010). Eppure a Bergamo un
esponente di centrosinistra esce dal processo perché il giudice stabilisce il
«non luogo a procedere», mentre a Milano altri politici di centrodestra - tra
cui il presidente della Provincia Guido Podestà - restano alla sbarra. Ma
andiamo con ordine. Nel febbraio 2010 fervono i preparativi in vista delle
elezioni. È sfida tra Roberto Formigoni e Filippo Penati. Matteo Rossi,
consigliere provinciale di Bergamo del Pd, è un pubblico ufficiale e quindi può
vidimare le sottoscrizioni a sostegno delle varie liste. Ne autentica una
novantina in quel di Seriate a sostegno del Partito pensionati, all’epoca
alleato del centrosinistra. Peccato che tra gli autografi ne spuntino sette
irregolari, tra cui due persone decedute, una nel 2009 e l’altra nel 1992. È il
Comune a sollevare dubbi e il caso finisce in Procura. All’udienza preliminare
l’avvocato Roberto Bruni, ex sindaco del capoluogo orobico e poi consigliere
regionale della lista Ambrosoli, invoca la prescrizione. Lo fa appellandosi a
una riforma legislativa e il giudice gli dà ragione. È successo che Bruni, tra i
penalisti più stimati della città, ha scandagliato il testo unico delle leggi
sulle elezioni. Testo che in sostanza indica in tre anni il tempo massimo per
procedere ed emettere la sentenza. Parliamo di una faccenda da Azzeccagarbugli,
anche perché un recente pronunciamento della Cassazione conferma sì il limite di
tre anni per arrivarne a una, ma solo se la denuncia è partita dai cittadini.
Mentre nel caso di Rossi tutto è scattato per un intervento del Comune di
Seriate. Fatto sta che a Milano c’è un altro processo con lo stesso capo
d’imputazione e che riguarda la lista Formigoni. Nessuno, finora, ha sollevato
la questione della prescrizione ma in questi giorni la decisione del giudice
orobico ha incuriosito non poco gli avvocati Gaetano Pecorella e Maria
Battaglini, dello stesso studio dell’ex parlamentare del Pdl. Vogliono capire
com’è andata la faccenda di Rossi, così da decidere eventuali strategie a difesa
dei loro assistiti, tra cui spicca Podestà. Nel suo caso, le sottoscrizioni
fasulle sarebbero 770, raccolte in tutta la Lombardia: nell’udienza il
procuratore aggiunto Alfredo Robledo e il pm Antonio D’Alessio hanno indicato
come testimoni 642 persone che, sentite dai carabinieri nel corso
dell’inchiesta, avevano affermato che quelle firme a sostegno del listino di
Formigoni, apposte con il loro nome, erano false. Tra i testi ammessi figura
anche l’allora responsabile della raccolta firme del Pdl, Clotilde Strada, che
ha già patteggiato 18 mesi. A processo, oltre a Podestà, ci sono quattro ex
consiglieri provinciali del Popolo della Libertà milanese: Massimo Turci, Nicolò
Mardegan, Barbara Calzavara e Marco Martino. Tutti per falso ideologico, come
Rossi, e tutti per firme raccolte tra gennaio e febbraio del 2010. All’ombra
della Madonnina il processo era scattato per una segnalazione dei Radicali, in
qualità di semplici cittadini. Non è detto che il destino del democratico Rossi
coinciderà con quello degli imputati azzurri di Milano. Strano ma vero.
Certo c’è da storcere il naso
nel constatare che non di democrazia si parla (POTERE DEL POPOLO) ma di
magistocrazia (POTERE DEI MAGISTRATI).
Detto questo parliamo del
Legittimo Impedimento. Nel diritto processuale penale italiano, il legittimo
impedimento è l'istituto che permette all'imputato, in alcuni casi, di
giustificare la propria assenza in aula. In questo caso l’udienza si rinvia nel
rispetto del giusto processo e del diritto di difesa. In caso di assenza
ingiustificata bisogna distinguere se si tratta della prima udienza o di una
successiva. Nel caso di assenza in luogo della prima udienza il giudice,
effettuate le operazioni riguardanti gli accertamenti relativi alla costituzione
delle parti (di cui al 2° comma dell'art. 420), in caso di assenza non
volontaria dell'imputato se ne dichiara la condizione di contumacia e il
procedimento non subisce interruzioni. Se invece l'assenza riguarda una udienza
successiva alla prima ed in quella l'imputato non è stato dichiarato contumace,
questi è dichiarato semplicemente assente. E ancora, se nell'udienza successiva
alla prima alla quale l'imputato non ha partecipato (per causa maggiore, caso
fortuito o forza maggiore) questi può essere ora dichiarato contumace.
''L'indipendenza,
l'imparzialità, l'equilibrio dell'amministrazione della giustizia sono più che
mai indispensabili in un contesto di persistenti tensioni e difficili equilibri
sia sul piano politico che istituzionale''. Lo afferma il
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano l’11 giugno 2013 al
Quirinale ricevendo i neo giudici al Quirinale e, come se sentisse puzza
nell’aria, invita al rispetto della Consulta. Tre
''tratti distintivi'' della magistratura, ha sottolineato il capo dello Stato,
ricevendo al Quirinale i 343 magistrati ordinari in tirocinio,
che rappresentano ''un costume da acquisire interiormente, quasi al pari di una
seconda natura''. Napolitano ha chiesto poi rispetto verso la
Consulta: serve "leale collaborazione, oltre
che di riconoscimento verso il giudice delle leggi, ossia la Corte
Costituzionale, chiamata ad arbitrare anche il conflitto tra poteri dello
Stato''. E dopo aver fatto osservare che sarebbe ''inammissibile e scandaloso
rimettere in discussione la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, per
ciechi particolarismi anche politici'', Napolitano parlando del Consiglio
superiore della magistratura ha detto che ''non è un organo di mera autodifesa,
bensì un organo di autogoverno, che concorre alle riforme obiettivamente
necessarie'' della giustizia.
D’altronde il Presidente della
Repubblica in quanto capo dei giudici, non poteva dire altrimenti cosa diversa.
Eppure la corte Costituzionale
non si è smentita.
Per quanto riguarda il
Legittimo Impedimento attribuibile a Silvio Berlusconi, nelle funzioni di
Presidente del Consiglio impegnato in una seduta dello stesso Consiglio dei
Ministri, puntuale, atteso, aspettato, è piovuto il 19 giugno 2013 il "no" al
legittimo impedimento. La Corte Costituzionale, nel caso Mediaset, si schiera
contro Silvio Berlusconi. Per le toghe l'ex premier doveva
partecipare all'udienza e non al CDM. È stato corretto l'operato dei giudici di
Milano nel processo “Mediaset” quando, il primo marzo del 2010, non hanno
concesso il legittimo impedimento a comparire in udienza all'allora premier e
imputato di frode fiscale Silvio Berlusconi. A deciderlo, nel conflitto di
attribuzioni sollevato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in dissidio
con i togati milanesi, è stata la Corte Costituzionale che ha ritenuto che
l'assenza dall'udienza non sia stata supportata da alcuna giustificazione
relativa alla convocazione di un Cdm fuori programma rispetto al calendario
concordato in precedenza.
"Incredibile" -
In una nota congiunta i
ministri PDL del governo Letta, Angelino Alfano,
Gaetano Quagliariello, Maurizio Lupi,
Nunzia De Girolamo e Beatrice Lorenzin,
commentano: "E' una decisione incredibile. Siamo allibiti, amareggiati e
profondamente preoccupati. La decisione - aggiungono - travolge ogni principio
di leale collaborazione e sancisce la subalternità della politica all'ordine
giudiziario". Uniti anche tutti i deputati azzurri, che al termine della seduta
della Camera, hanno fatto sapere in un comunicato, "si sono riuniti e hanno
telefonato al presidente Berlusconi per esprimere la loro profonda
indignazione e preoccupazione per la vergognosa decisione della
Consulta che mina gravemente la leale collaborazione tra gli organi dello Stato
e il corretto svolgimento dell’esercizio democratico". Al Cavaliere, si legge,
"i deputati hanno confermato che non sarà certo una sentenza giudiziaria a
decretare la sua espulsione dalla vita politica ed istituzionale del nostro
Paese, e gli hanno manifestato tutta la loro vicinanza e il loro affetto".
"Siamo infatti all’assurdo di una Corte costituzionale che non ritiene legittimo
impedimento la partecipazione di un presidente del Consiglio al Consiglio dei
ministri", prosegue il capogruppo del Pdl alla Camera, Renato Brunetta, "Dinanzi
all’assurdo, che documenta la resa pressoché universale delle istituzioni
davanti allo strapotere dell’ingiustizia in toga, la tentazione sarebbe quella
di chiedere al popolo sovrano di esprimersi e di far giustizia con il voto".
Occorre – dice – una riforma del sistema per limitare gli abusi
e una nuova regolazione dei poteri dell’ordine giudiziario che non è un potere
ma un ordine in quanto la magistratura non è eletta dal popolo. ''A mente fredda
e senza alcuna emozione il giudizio sulla sentenza è più chiaro e netto che mai.
Primo: la sentenza è un'offesa al buon senso, tanto varrebbe dichiarare
l'inesistenza del legittimo impedimento a prescindere, qualora ci sia di mezzo
Silvio Berlusconi. Secondo: la Consulta sancisce che la magistratura può agire
in quanto potere assoluto come princeps legibus solutus. Terzo: la risposta di
Berlusconi e del Pdl con lui è di netta separazione tra le proteste contro
l'ingiustizia e leale sostegno al governo Letta. Quarto: non rinunceremo in
nessun caso a far valere in ogni sede i diritti politici del popolo di
centrodestra e del suo leader, a cui vanno da parte mia solidarietà e
ammirazione. Quinto: credo che tutta la politica, di destra, di sinistra e di
centro, dovrebbe manifestare preoccupazione per una sentenza che di fatto,
contraddicendo la Costituzione, subordina la politica all'arbitrio di qualsiasi
Tribunale''. E' quanto afferma Renato Brunetta, presidente dei deputati del Pdl.
Gli fa eco il deputato Pdl Deborah Bergamini, secondo cui "è difficile accettare
il fatto che viviamo in un Paese in cui c’è un cittadino, per puro caso leader
di un grande partito moderato votato da milioni di italiani, che è considerato
da una parte della magistratura sempre e per forza colpevole e in malafede.
Purtroppo però è così".
Nessuna preoccupazione a
sinistra. "Per quanto riguarda il Pd le sentenze si applicano e si rispettano
quindi non ho motivo di ritenere che possa avere effetti su un governo che è di
servizio per i cittadini e il Paese in una fase molto drammatica della vita
nazionale e dei cittadini", ha detto Guglielmo Epifani, "È una sentenza che era
attesa da tempo. Dà ragione a una parte e torto all’altra, non vedo un rapporto
tra questa sentenza e il quadro politico".
Non si aveva nessun dubbio chi
fossero gli idolatri delle toghe.
LE SENTENZE DEI GIUDICI SI
APPLICANO, SI RISPETTANO, MA NON ESSENDO GIUDIZI DI DIO SI POSSONO BEN CRITICARE
SE VI SONO FONDATE RAGIONI.
Piero Longo e Niccolò Ghedini,
legali di Silvio Berlusconi, criticano duramente la decisione della Consulta
sull'ex premier. «I precedenti della Corte Costituzionale in tema di legittimo
impedimento sono inequivocabili e non avrebbero mai consentito soluzione diversa
dall'accoglimento del conflitto proposto dalla presidenza del Consiglio dei
Ministri», assicurano. Per poi aggiungere: «Evidentemente la decisione assunta
si è basata su logiche diverse che non possono che destare grave
preoccupazione»."La preminenza della giurisdizione rispetto alla legittimazione
di un governo a decidere tempi e modi della propria azione - continuano i due
legali di Silvio Berlusconi - appare davvero al di fuori di ogni logica
giuridica. Di contro la decisione, ampiamente annunciata da giorni da certa
stampa politicamente orientata, non sorprende visti i precedenti della stessa
Corte quando si è trattato del presidente Berlusconi e fa ben comprendere come
la composizione della stessa non sia più adeguata per offrire ciò che sarebbe
invece necessario per un organismo siffatto". Mentre per Franco Coppi, nuovo
legale al posto di Longo, si tratta di «una decisione molto discutibile che crea
un precedente pericoloso perché stabilisce che il giudice può decidere quando un
Consiglio dei ministri è, o meno, indifferibile. Le mie idee sul legittimo
impedimento non coincidono con quelle della Corte Costituzionale ma, purtroppo,
questa decisione la dobbiamo tenere così come è perché è irrevocabile».
Ribatte l'Associazione
Nazionale Magistrati: «È inaccettabile attribuire alla Consulta logiche
politiche»; un'accusa che «va assolutamente rifiutata». A breve distanza dalla
notizia che la Consulta ha negato il legittimo impedimento a Silvio Berlusconi
nell'ambito del processo Mediaset, arriva anche la reazione di Rodolfo Sabelli,
presidente dell'associazione nazionale magistrati, che ribadisce alle voci
critiche che si sono sollevate dal Pdl la versione delle toghe."Non si può
accettare, a prescindere dalla decisione presa - dice Sabelli - l’attribuzione
alla Corte Costituzionale di posizioni o logiche di natura politica". Ribadendo
l'imparzialità della Corte Costituzionale "a prescindere dal merito della
sentenza", chiede "una posizione di rispetto" per la Consulta e una discussione
che - se si sviluppa - sia però fatta "in modo informato, conoscendo le
motivazioni della sentenza, e con rigore tecnico".
La Corte costituzionale ha
detto no. Respinto il ricorso di Silvio Berlusconi per il legittimo impedimento
(giudicato non assoluto, in questo caso) che non ha consentito all’allora
premier di partecipare all’udienza del 10 marzo 2010 del processo Mediaset,
per un concomitante consiglio dei ministri. Nel dare ragione ai giudici di
Milano che avevano detto no alla richiesta di legittimo impedimento di
Berlusconi, la Corte Costituzionale ha osservato che «dopo che per più volte il
Tribunale (di Milano), aveva rideterminato il calendario delle udienze a seguito
di richieste di rinvio per legittimo impedimento, la riunione del Consiglio dei
ministri, già prevista in una precedente data non coincidente con un giorno di
udienza dibattimentale, è stata fissata dall'imputato Presidente del Consiglio
in altra data coincidente con un giorno di udienza, senza fornire alcuna
indicazione (diversamente da quanto fatto nello stesso processo in casi
precedenti), nè circa la necessaria concomitanza e la non rinviabilità»
dell'impegno, né circa una data alternativa per definire un nuovo calendario.
"La riunione del Cdm - spiega la Consulta - non è un impedimento assoluto". Si
legge nella sentenza: "Spettava all'autorità giudiziaria stabilire che non
costituisce impedimento assoluto alla partecipazione all'udienza penale del 1
marzo 2010 l'impegno dell'imputato Presidente del Consiglio dei ministri" Silvio
Berlusconi "di presiedere una riunione del Consiglio da lui stesso convocata per
tale giorno", che invece "egli aveva in precedenza indicato come utile per la
sua partecipazione all'udienza".
Ma è veramente imparziale la
Corte costituzionale?
Tutta la verità sui giornali
dopo la bocciatura del “Lodo Alfano”, sulla sospensione dei procedimenti penali
per le più alte cariche dello Stato, avvenuta da parte della Corte
Costituzionale il 7 ottobre 2009. La decisione della Consulta
è arrivata con nove voti a favore e sei contrari. Quanto al
Lodo Alfano, si sottolinea che il
mutamento di indirizzo della Corte "oltre che una scelta politica si
configura anche come violazione del principio di leale
collaborazione tra gli organi costituzionali che ha avuto la conseguenza
di sviare l'azione legislativa del Parlamento". Berlusconi dice: "C'è
un presidente della Repubblica di sinistra, Giorgio Napolitano, e c'è una Corte
costituzionale con undici giudici di sinistra, che non è certamente un
organo di garanzia, ma è un organo politico. Il presidente è stato eletto da una
maggioranza di sinistra, ed ha le radici totali della sua storia nella sinistra.
Credo che anche l'ultimo atto di nomina di un magistrato della Corte dimostri da
che parte sta". La Corte ha 15 membri, con mandato di durata 9 anni: 5 nominati
dal Presidente della Repubblica, Ciampi e Napolitano (di area centro-sinistra);
5 nominati dal Parlamento (maggioranza centro-sinistra); 5 nominati dagli alti
organi della magistratura (che tra le sue correnti, quella più influente è di
sinistra). Non solo. Dalla Lega Nord si scopre che 9 giudici su 15 sono campani.
«Ci sembra alquanto strano che ben 9 dei 15 giudici della Consulta siano
campani» osservano due consiglieri regionali veneti della Lega Nord, Emilio
Zamboni e Luca Baggio. «È quasi incredibile - affermano Zamboni e Baggio - che
un numero così elevato di giudici provenga da una sola regione, guarda caso la
Campania. Siamo convinti che questo dato numerico debba far riflettere non solo
l'opinione pubblica, ma anche i rappresentanti delle istituzioni». «Il Lodo
Alfano è stato bocciato perché ritenuto incostituzionale. Ma cosa c'è di
costituzionale - si chiedono Baggio e Zamboni - nel fatto che la maggior parte
dei giudici della Consulta, che ha bocciato la contestata legge provenga da
Napoli? Come mai c'è un solo rappresentante del Nord?».
Da “Il Giornale” poi,
l’inchiesta verità: “Scandali e giudizi politici: ecco la vera Consulta”.
Ermellini rossi, anche per l’imbarazzo. Fra i giudici della Corte costituzionale
che hanno bocciato il Lodo Alfano ve n’è uno che da sempre strizza un occhio a
sinistra, ma li abbassa tutti e due quando si tratta di affrontare delicate
questioni che riguardano lui o i suoi più stretti congiunti. È Gaetano
Silvestri, 65 anni, ex csm, ex rettore dell’ateneo di Messina, alla Consulta per
nomina parlamentare («alè, hanno eletto un altro comunista!» tuonò il 22 giugno
2005 l’onorevole Carlo Taormina), cognato di quell’avvocato Giuseppe «Pucci»
Fortino arrestato a maggio 2007 nell’inchiesta Oro Grigio e sotto processo a
Messina per volontà del procuratore capo Luigi Croce. Che ha definito quel
legale intraprendente «il Ciancimino dello Stretto», con riferimento all’ex
sindaco mafioso di Palermo, tramite fra boss e istituzioni. Per i pm
l’«avvocato-cognato» era infatti in grado di intrattenere indifferentemente
rapporti con mafiosi, magistrati, politici e imprenditori. Di Gaetano Silvestri
s’è parlato a lungo anche per la vicenda della «parentopoli» all’università di
Messina. Quand’era rettore s’è scoperto che sua moglie, Marcella Fortino
(sorella di Giuseppe, il «Ciancimino di Messina») era diventata docente
ordinario di Scienze Giuridiche. E che costei era anche cognata dell’ex
pro-rettore Mario Centorrino, il cui figlio diventerà ordinario, pure lui, nel
medesimo ateneo. E sempre da Magnifico, Silvestri scrisse una lettera riservata
al provveditore agli studi Gustavo Ricevuto per perorare la causa del figlio
maturando, a suo dire punito ingiustamente all’esito del voto (si fermò a
97/100) poiché agli scritti - sempre secondo Silvestri - il ragazzo aveva osato
criticare un certo metodo d’insegnamento. La lettera doveva rimanere riservata,
il 5 agosto 2001 finì in edicola. E fu scandalo. «Come costituzionalista -
scrisse Silvestri - fremo all’idea che una scuola di una Repubblica democratica
possa operare siffatte censure, frutto peraltro di un non perfetto aggiornamento
da parte di chi autoritariamente le pone in atto. Ho fatto migliaia di esami in
vita mia, ma sentirei di aver tradito la mia missione se avessi tolto anche un
solo voto a causa delle opinioni da lui professate». Andando al luglio ’94,
governo Berlusconi in carica, Silvestri firma un appello per «mettere in guardia
contro i rischi di uno svuotamento della carta costituzionale attraverso
proposte di riforme e revisione, che non rispettino precise garanzie». Nel 2002
con una pletora di costituzionalisti spiega di «condividere le critiche delle
opposizioni al Ddl sul conflitto di interessi». L’anno appresso, a proposito del
Lodo sull’immunità, se ne esce così: «Siamo costretti a fare i conti con
questioni che dovrebbero essere scontate, che risalgono ai classici dello stato
di diritto (...). Se si va avanti così fra breve saremo capaci di metabolizzare
le cose più incredibili». Altro giudice contrarissimo al Lodo è Alessandro
Criscuolo. Ha preso la difesa e perorato la causa dell’ex pm di Catanzaro, Luigi
De Magistris, nel procedimento disciplinare al Csm: «Non ha mai arrestato
nessuno ingiustamente, De Magistris è stato molto attento alla gestione dei suoi
provvedimenti». Smentito. Quand’era presidente dell’Anm, alle accuse dei
radicali sulla (mala) gestione del caso Tortora, Criscuolo rispose prendendo le
parti dei magistrati, difese la sentenza di primo grado, ringraziò i pentiti per
il loro contributo (sic!). Nel ’97 entrò a gamba tesa in un altro processo,
quello per l’omicidio del commissario Calabresi, al grido di «meglio un
colpevole libero che un innocente dentro». E che dire del giudice Franco Gallo,
già ministro delle Finanze con Ciampi, nemico giurato del successore visto che
all’insediamento di Giulio Tremonti (scrive Il Fatto) rassegnò le dimissioni
dalla scuola centrale tributaria dopo esser uscito da un’inchiesta finita al
tribunale dei ministri, su presunti illeciti compiuti a favore del Coni per il
pagamento di canoni irrisori per alcuni immobili. Altro ministro-giudice di
Ciampi, rigorosamente no-Lodo, è il professor Sabino Cassese, gettonatissimo in
commissioni di studio e d’inchiesta, ai vertici di società importanti e di
banche. A proposito della sentenza del gip Clementina Forleo, che assolveva
cinque islamici accusati di terrorismo definendoli «guerriglieri», chiosò
dicendo che gli Stati Uniti avevano violato lo stato di diritto. Giuseppe
Tesauro, terza creatura di Ciampi alla Consulta, viene ricordato al vertice
dell’Antitrust per la sua battaglia contro la legge Gasparri («è una legge
contro la concorrenza», oppure, «il testo non è in odor di santità, la riforma
mescola coca-cola, whisky e acqua»). Di lui si parlò come candidato dell’Ulivo a
fine mandato 2005 e come «persecutore» di Gilberto Benetton e della sua Edizioni
Holding interessata ad acquistare la società Autogrill (l’inchiesta venne
archiviata). Considerato a sinistra da sempre anche Ugo De Siervo, almeno dal
’95 quando al convegno «Con la Costituzione non si scherza» parlò di
comportamenti «ispirati a dilettantismo e tatticismo, interpretazioni di stampo
plebiscitario, spregio della legalità costituzionale». A maggio 2001 è a fianco
dell’ex sottosegretario e senatore dei Ds Stefano Passigli, che annuncia un
esposto contro Berlusconi per la violazione dei limiti di spesa per la legge
elettorale.
Tanto comandano loro: le
toghe! Magistrati, raddoppiati gli incarichi extragiudiziari. Le richieste per
svolgere un secondo lavoro sono aumentate in 12 mesi del 100%. Sono passate da
961 a 494. Un record. Consulenze e docenze le più appetibili, scrive “Libero
Quotidiano”. La doppia vita dei magistrati. Alle toghe di casa nostra non
bastano mai i soldi che incassano con il loro lavoro da magistrato. Le toghe
preferiscono la seconda attività. Negli ultimi sei mesi il totale degli
incarichi autorizzati dal Csm alle toghe ha toccato quota 961, quasi il doppio
dei 494 concessi nei sei mesi precedenti. Insomma il doppio lavoro e la doppia
busta paga servono per riempire le tasche. La doppia attività è
una tradizione dei nostri magistrati. E la tendenza è in
crescita. Si chiamano incarichi “extragiudiziari”, in
quanto relativi ad attività che non fanno riferimento alla professione
giudiziaria. Gli incarichi per le toghe arrivano dalle società, dagli enti di
consulenza e università private, come quella della Confindustria. I dati
sull'incremento degli incarichi extragiudiziari li fornisce il Csm. Tra novembre
2012 e maggio 2013 gli incarichi sono raddoppiati. A dare l'ok alla doppia
attività è proprio il Csm. Le toghe amano le cattedre e così vanno ad insegnare
alla Luiss, l’ateneo confindustriale diretto da Pier Luigi Celli. Poi ci sono le
consulenze legali per la Wolters Kluwer, multinazionale che si occupa di
editoria e formazione professionale. Ma non finisce qua. Qualche magistrato
lavora per la Altalex Consulting, altra società attiva nell’editoria e nella
formazione giuridica. Le paghe sono sostanziose. Ad esempio Giovanni Fanticini,
racconta Lanotiziagiornale.it, è giudice al tribunale di Reggio
Emilia. Ma ha 11 incarichi extragiudiziali. Tra docenze, seminari e lezioni
varie, è semplicemente impressionante: dalla Scuola superiore dell’economia e
delle finanze (controllata al ministero di via XX Settembre) ha avuto un
incarico di 7 ore con emolumento orario di 130 euro (totale 910 euro); dalla
società Altalex ha avuto sei collaborazioni: 15 ore per complessivi
2.500 euro, 7 ore per 1.300, 8 ore per 1.450, 15 ore per 2.500, 5 ore
per 750 e 5 ore per 700; dal Consorzio interuniversitario per l’aggiornamento
professionale in campo giuridico ha ottenuto due incarichi, complessivamente 8
ore da 100 euro l’una (totale 800 euro). Insomma un buon bottino. In
Confindustria poi c'è l'incarico assegnato a Domenico Carcano,
consigliere della Corte di cassazione, che per 45 ore di lezioni ed esami di
diritto penale ha ricevuto 6 mila euro. C’è Michela Petrini, magistrato
ordinario del tribunale di Roma, che ha incassato due docenze di diritto penale
dell’informatica per complessivi 4.390 euro. Ancora, Enrico Gallucci, magistrato
addetto all’Ufficio amministrazione della giustizia, ha ottenuto 5.500 euro per
36 ore di lezione di diritto penale. Il doppio incarico di certo non va molto
d'accordo con l'imparzialità della magistratura. Se le società dove lavorano
questi magistrati dovessero avere problemi giudiziari la magistratura e i
giudici quanto sarebbero equidistanti nell'amministrare giustizia? L'anomalia
degli incarichi extragiudiziari va eliminata.
“VADA A BORDO, CAZZO!!”.
E’ celebre il “vada a bordo,
cazzo” del comandante De Falco. L’Italia paragonata al destino ed agli eventi
che hanno colpito la nave Concordia. Il naufragio della Costa Concordia, è
un sinistro marittimo "tipico" avvenuto venerdì 13 gennaio 2012 alle 21:42
alla nave da crociera al comando di Francesco Schettino e di proprietà della
compagnia di navigazione genovese Costa Crociere, parte del gruppo
anglo-americano Carnival Corporation & plc. All'1.46 di sabato mattina 14
gennaio il comandante della Concordia Francesco Schettino riceve l'ennesima
telefonata dalla Capitaneria di Porto. In linea c'è il comandante Gregorio Maria
De Falco. La chiamata è concitata e i toni si scaldano rapidamente.
De Falco: «Sono De Falco da
Livorno, parlo con il comandante?
Schettino: «Sì, buonasera
comandante De Falco»
De Falco: «Mi dica il suo nome
per favore»
Schettino: «Sono il comandante
Schettino, comandante»
De Falco: «Schettino? Ascolti
Schettino. Ci sono persone intrappolate a bordo. Adesso lei va con la sua
scialuppa sotto la prua della nave lato dritto. C'è una biscaggina. Lei sale su
quella biscaggina e va a bordo della nave. Va a bordo e mi riporta quante
persone ci sono. Le è chiaro? Io sto registrando questa comunicazione comandante
Schettino...».
Schettino: «Comandante le dico
una cosa...»
De Falco: «Parli a voce alta.
Metta la mano davanti al microfono e parli a voce più alta, chiaro?».
Schettino: «In questo momento
la nave è inclinata...».
De Falco: «Ho capito. Ascolti:
c'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la
percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa
hanno a bordo. Chiaro? Mi dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di
assistenza. E mi dice il numero di ciascuna di queste categorie. E' chiaro?
Guardi Schettino che lei si è salvato forse dal mare ma io la porto… veramente
molto male… le faccio passare un’anima di guai. Vada a bordo, cazzo!»
“TUTTI DENTRO, CAZZO!!”
Parafrasando la celebre frase
di De Falco mi rivolgo a tutti gli italiani: ““TUTTI DENTRO CAZZO!!”. Il tema è
“chi giudica chi?”. Chi lo fa, ha veramente una padronanza morale, culturale
professionale per poterlo fare? Iniziamo con il parlare della preparazione
culturale e professionale di ognuno di noi, che ci permetterebbe, in teoria, di
superare ogni prova di maturità o di idoneità all’impiego frapposta dagli esami
scolastici o dagli esami statali di abilitazione o di un concorso pubblico. In
un paese in cui vigerebbe la meritocrazia tutto ciò ci consentirebbe di occupare
un posto di responsabilità. In Italia non è così. In ogni ufficio di prestigio e
di potere non vale la forza della legge, ma la legge del più forte. Piccoli
ducetti seduti in poltrona che gestiscono il loro piccolo potere incuranti dei
disservizi prodotti. La massa non è li ha pretendere efficienza e dedizione al
dovere, ma ad elemosinare il favore. Corruttori nati. I politici non scardinano
il sistema fondato da privilegi secolari. Essi tacitano la massa con
provvedimenti atti a quietarla.
Panem et circenses,
letteralmente: "pane e giochi del circo", è una locuzione in lingua latina molto
conosciuta e spesso citata. Era usata nella Roma antica. Contrariamente a quanto
generalmente ritenuto, questa frase non è frutto della fantasia popolare, ma è
da attribuirsi al poeta latino Giovenale:
« ...duas tantum res
anxius optat panem et circenses».
« ...[il popolo] due sole cose
ansiosamente desidera pane e i giochi circensi».
Questo poeta fu un grande
autore satirico: amava descrivere l'ambiente in cui viveva, in un'epoca nella
quale chi governava si assicurava il consenso popolare con elargizioni
economiche e con la concessione di svaghi a coloro che erano governati (in
questo caso le corse dei carri tirati da cavalli che si svolgevano nei circhi
come il Circo Massimo e il Circo di Massenzio).
Perché quel “TUTTI DENTRO
CAZZO!!”. Perché la legge dovrebbe valere per tutti. Non applicata per i più ed
interpretata per i pochi. E poi mai nessuno, in Italia, dovrebbe permettersi di
alzare il dito indice ed accusare qualcun altro della sua stessa colpa.
Prendiamo per esempio la cattiva abitudine di copiare per poter superare una
prova, in mancanza di una adeguata preparazione. Ognuno di noi almeno un volta
nella vita ha copiato. In principio era la vecchia “cartucciera” la fascia di
stoffa da stringere in vita con gli involtini a base di formule trigonometriche,
biografie del Manzoni e del Leopardi, storia della filosofia e traduzioni di
Cicerone. Poi il vocabolario farcito d'ogni foglio e foglietto, giubbotti
imbottiti di cultura bignami e addirittura scarpe con suola manoscritta. Oggi i
metodi per “aiutarsi” durante gli esami sono più tecnologici: il telefonino, si
sa, non si può portare, ma lo si porta lo stesso. Al massimo, se c’è la
verifica, lo metti sul tavolo della commissione. Quindi non è malsana l'idea
dell'iPhone sul banco, collegato a Wikipedia e pronto a rispondere ad ogni
quesito nozionistico. Comunque bisogna attrezzarsi, in maniera assolutamente
diversa. La rete e i negozi di cartolibreria vendono qualsiasi accrocchio
garantendo si tratti della migliore soluzione possibile per copiare durante le
prove scritte. C'è ad esempio la penna UV cioè a raggi ultravioletti scrive con
inchiostro bianco e si legge passandoci sopra un led viola incluso nel corpo
della penna. Inconveniente: difficile non far notare in classe una luce da
discoteca. Poi c'è la cosiddetta penna-foglietto: nel corpo della stilo c'è un
foglietto avvolto sul quale si è scritto precedentemente formule, appunti
eccetera. Foglietto che in men che non si dica si srotola e arrotola. Anche in
questo caso l'inconveniente è che se ti sorprendono sono guai. E infine, c'è
l'ormai celebre orologio-biglietto col display elettronico e una porta Usb
sulla quale caricare testi d'ogni tipo. Pure quello difficile da gestire: solo
gli artisti della copia copiarella possono.
Il consiglio è quello di
studiare e non affidarsi a trucchi e trucchetti. Si rischia grosso e non tutti
lo sanno. Anche perché il copiare lo si fa passare per peccato veniale. Copiare
ad esami e concorsi, invece, potrebbe far andare in galera. E' quanto stabilito
dalla legge n. 475/1925 e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 32368/10.
La legge recita all'art.1 :“Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti
da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni
altro grado o titolo scolastico o accademico, per l’abilitazione
all’insegnamento ed all’esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi
o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti
tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la
reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non può essere
inferiore a sei mesi qualora l’intento sia conseguito”. A conferma della legge è
intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n.32368/10, che ha condannato
una candidata per aver copiato interamente una sentenza del TAR in un elaborato
a sua firma presentato durante un concorso pubblico. La sentenza della sezione
VI penale n. 32368/10 afferma: “Risulta pertanto ineccepibile la valutazione dei
giudici di merito secondo cui la (…) nel corso della prova scritta effettuò, pur
senza essere in quel frangente scoperta, una pedissequa copiatura del testo
della sentenza trasmessole (…). Consegue che il reato è integrato anche qualora
il candidato faccia riferimento a opere intellettuali, tra cui la produzione
giurisprudenziale, di cui citi la fonte, ove la rappresentazione del suo
contenuto sia non il prodotto di uno sforzo mnemonico e di autonoma elaborazione
logica ma il risultato di una materiale riproduzione operata mediante
l’utilizzazione di un qualsiasi supporto abusivamente impiegato nel corso della
prova”.
In particolare per gli
avvocati la Riforma Forense, legge 247/2012, al CAPO II (ESAME DI STATO PER
L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO) Art. 46. (Esame di
Stato) stabilisce che “….10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno
o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema
proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena
della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel
comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del
distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per
i provvedimenti di sua competenza.”
Ma, di fatto, quello previsto
come reato è quello che succede da quando esiste questo tipo di esame e vale
anche per i notai ed i magistrati. Eppure, come ogni altra cosa italiana c’è
sempre l’escamotage tutto italiano. Una sentenza del Consiglio di Stato
stabilisce che copiare non è reato: niente più punizione. Dichiarando tuttavia
“legale” copiare a scuola, si dichiara pure legale copiare nella vita. Non viene
sanzionato un comportamento che è senza dubbio scorretto. Secondo il
Consiglio di Stato, il superamento dell’esame costituisce di per sè attestazione
delle “competenze, conoscenze e capacità anche professionali acquisite”
dall'alunna e la norma che regola l'espulsione dei candidati dai pubblici
concorsi per condotta fraudolenta, non può prescindere "dal contesto valutativo
dell’intera personalità e del percorso scolastico dello studente, secondo i
principi che regolano il cosiddetto esame di maturità": le competenze e le
conoscenze acquisite….in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di
ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità
critiche del candidato. A ciò il Cds ha anche aggiunto un'attenuante, cioè "uno
stato d’ansia probabilmente riconducibile anche a problemi di salute" della
studentessa stessa, che sarebbe stato alla base del gesto. Il 12 settembre 2012
una sentenza del Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar della
Campania che aveva escluso dagli esami di maturità una ragazza sorpresa a
copiare da un telefono palmare. Per il Consiglio di Stato la decisione del Tar
non avrebbe adeguatamente tenuto conto né del “brillante curriculum scolastico”
della ragazza in questione, né di un suo “stato di ansia”. Gli esami, nel
frattempo, la giovane li aveva sostenuti seppur con riserva. L’esclusione della
ragazza dagli esami sarà forse stata una sanzione eccessiva. Probabilmente la
giovane in questione, sulla base del suo curriculum poteva esser perdonata. Gli
insegnanti, conoscendola e comprendendo il suo stato d’ansia pre-esame,
avrebbero potuto chiudere un occhio. Tutto vero. Ma sono valutazioni che
spettavano agli insegnanti che la studente conoscono. Una sentenza del Consiglio
di Stato stabilisce invece, di fatto, un principio. E in questo caso il
principio è che copiare vale. Non è probabilmente elegante, ma comunque va bene.
Questo principio applicato alla scuola, luogo in cui le generazioni future si
forgiano ed educano, avrà ripercussioni sulla società del futuro. Se ci viene
insegnato che a non rispettar le regole, in fondo, non si rischia nulla più che
una lavata di capo, come ci porremo di fronte alle regole della società una
volta adulti? Ovviamente male. La scuola non è solo il luogo dove si insegnano
matematica e italiano, storia e geografia. Ma è anche il luogo dove dovrebbe
essere impartito insegnamento di civica educazione, dove si impara a vivere
insieme, dove si impara il rispetto reciproco e quello delle regole. Dove si
impara a “vivere”. Se dalla scuola, dalla base, insegniamo che la “furbizia” va
bene, non stupiamoci poi se chi ci amministra si compra il Suv con i soldi delle
nostre tasse. In fondo anche lui avrà avuto il suo “stato d’ansia”. Ma il punto
più importante non è tanto la vicenda della ragazza sorpresa a copiare e di come
sia andata la sua maturità. Il punto è la sanzionabilità o meno di un
comportamento che è senza dubbio scorretto. In un paese già devastato dalla
carenza di etica pubblica, dalla corruzione e dall’indulgenza programmatica di
molte vulgate pedagogiche ammantate di moderno approccio relazionale, ci mancava
anche la corrività del Consiglio di Stato verso chi imbroglia agli esami.
E, comunque, vallo a dire ai
Consiglieri di Stato, che dovrebbero già saperlo, che nell’ordinamento giuridico
nazionale esiste la gerarchia della legge. Nell'ordinamento giuridico italiano,
si ha una pluralità di fonti di produzione; queste sono disposte secondo una
scala gerarchica, per cui la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto
con la norma di fonte superiore (gerarchia delle fonti). nel caso in cui avvenga
un contrasto del genere si dichiara l'invalidità della fonte inferiore dopo un
accertamento giudiziario, finché non vi è accertamento si può applicare la
"fonte invalida". Al primo livello della gerarchia delle fonti si pongono la
Costituzione e le leggi costituzionali (fonti superprimarie). La Costituzione
della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1º gennaio 1948, è composta da
139 articoli: essa detta i principi fondamentali dell'ordinamento (artt. 1-12);
individua i diritti e i doveri fondamentali dei soggetti (artt. 13-54); detta la
disciplina dell'organizzazione della Repubblica (artt. 55-139). La Costituzione
italiana viene anche definita lunga e rigida, lunga perché non si limita "a
disciplinare le regole generali dell'esercizio del potere pubblico e delle
produzioni delle leggi" riguardando anche altre materie, rigida in quanto per
modificare la Costituzione è richiesto un iter cosiddetto aggravato (vedi
art. 138 cost.). Esistono inoltre dei limiti alla revisione costituzionale. Al
di sotto delle leggi costituzionali si pongono i trattati internazionali e gli
atti normativi comunitari, che possono presentarsi sotto forma di regolamenti o
direttive. I primi hanno efficacia immediata, le seconde devono essere attuate
da ogni paese facente parte dell'Unione europea in un determinato arco di tempo.
A queste, si sono aggiunte poi le sentenze della Corte di Giustizia Europea
"dichiarative" del Diritto Comunitario (Corte Cost. Sent. n. 170/1984). Seguono
le fonti primarie, ovvero le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge
(decreti legge e decreti legislativi), ma anche le leggi regionali e delle
provincie autonome di Trento e Bolzano. Le leggi ordinarie sono emanate dal
Parlamento, secondo la procedura di cui gli artt. 70 ss. Cost., le cui fasi
essenziali sono così articolate: l'iniziativa di legge; l'approvazione del testo
di legge è affidata alle due Camere del Parlamento (Camera dei deputati e Senato
della Repubblica); la promulgazione del Presidente della Repubblica; la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Al di sotto delle fonti primarie, si
collocano i regolamenti governativi, seguono i regolamenti ministeriali e di
altri enti pubblici e all'ultimo livello della scala gerarchica, si pone la
consuetudine, prodotta dalla ripetizione costante nel tempo di una determinata
condotta. Sono ammesse ovviamente solo consuetudini secundum legem e
praeter legem non dunque quelle contra legem.
Pare che molte consuetudini
sono contra legem e pervengono proprio da coloro che dovrebbero dettare i giusti
principi.
Tutti in pensione da
"presidente emerito". I giudici della Corte Costituzionale si danno una mano tra
loro per dare una spinta in più alla remunerazione pensionistica a fine
carriera. Gli ermellini in pratica a rotazione, anche breve, cambiano il
presidente della Corte per regalargli il titolo più prestigioso prima che giunga
il tramonto professionale. Nulla di strano se non fosse che il quinto comma
dell'articolo 135 della Costituzione recita: "La Corte elegge tra i suoi
componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in
carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di
scadenza dall’ufficio di giudice". Dunque secondo Costituzione il presidente
dovrebbe cambiare ogni 3 anni, o quanto meno rieletto anche per un secondo
mandato dopo 36 mesi. Le cose invece vanno in maniera completamente diversa. La
poltrona da presidente con relativa pensione fa gola a tanti e allora bisogna
accontentare tutti. Così dagli Anni Ottanta la norma è stata aggirata per un
tornaconto personale, scrive “Libero Quotidiano”. Per consentire al maggior
numero di membri di andare in pensione col titolo da presidente emerito, e fino
al 2011 con tanto di auto blu a vita, si è deciso che il prescelto debba essere
quello con il maggior numero di anni di servizio. Il principio di anzianità.
Questo passaggio di consegne oltre a garantire una pensione più sostanziosa
rispetto a quella di un semplice giudice costituzionale, offre anche
un’indennità aggiuntiva in busta paga: "I giudici della Corte costituzionale
hanno tutti ugualmente una retribuzione corrispondente al complessivo
trattamento economico che viene percepito dal magistrato della giurisdizione
ordinaria investito delle più alte funzioni. Al Presidente è inoltre attribuita
una indennità di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione", recita la
legge 87/1953. Successivamente, il legislatore è intervenuto con legge 27
dicembre 2002, n. 289, sostituendo il primo periodo dell'originario art. 12,
comma 1, della legge 87/1953 nei seguenti termini: "I giudici della Corte
costituzionale hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al più
elevato livello tabellare che sia stato raggiunto dal magistrato della
giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni, aumentato della
metà". Resta ferma l'attribuzione dell'indennità di rappresentanza per il
Presidente. Quella era intoccabile. Così ad esempio accade che Giovanni Maria
Flick è stato presidente per soli 3 mesi, dal 14 novembre 2008 al 18 febbraio
2009. Flick si difese dicendo che quella "era ormai una prassi consolidata".
Già, consolidata in barba alla Carta Costituzionale che loro per primi
dovrebbero rispettare. Gustavo Zagerblesky ad esempio è stato presidente per
soli 7 mesi. Poi è stato il turno di Valerio Onida, presidente per 4 mesi dal 22
settembre 2004 al 30 maggio 2005. Ugo De Servio invece ha tenuto la poltrona dal
10 dicembre 2010 al 29 aprile 2011, 4 mesi anche per lui. Recordman invece
Alfonso Quaranta che è stato in carica per un anno e sette mesi, dal 6 giugno
2011 al 27 gennaio 2012. Ora la corsa alla poltrona è per l'attuale presidente
Franco Gallo, in carica dal gennaio 2013. Durerà fin dopo l'estate?
Probabilmente no.
“TUTTI DENTRO, CAZZO!!”
Per esempio nei processi,
anche i testimoni della difesa.
Tornando alla parafrasi del
“TUTTI DENTRO, CAZZO!!” si deve rimarcare una cosa. Gli italiani sono: “Un
popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di
navigatori, di trasmigatori”. Così è scritto sul Palazzo della Civiltà Italiana
dell’EUR a Roma. Manca: “d’ingenui”. Ingenui al tempo di Mussolini, gli
italiani, ingenui ancora oggi. Ma no, un popolo d’ingenui non va bene. Sul
Palazzo della Civiltà aggiungerei: “Un popolo d’allocchi”, anzi “Un popolo di
Coglioni”. Perché siamo anche un popolo che quando non sa un “cazzo” di quello
che dice, parla. E parla sempre. Parla..…parla. Specialmente sulle cose di
Giustizia: siamo tutti legulei.
Chi frequenta bene le aule dei
Tribunali, non essendo né coglione, né in mala fede, sa molto bene che le
sentenze sono già scritte prima che inizi il dibattimento. Le pronunce sono
pedisseque alle richieste dell’accusa, se non di più. Anche perché se il
soggetto è intoccabile l’archiviazione delle accuse è già avvenuta nelle fasi
successive alla denuncia o alla querela: “non vi sono prove per sostenere
l’accusa” o “il responsabile è ignoto”. Queste le motivazioni in calce alla
richiesta accolta dal GIP, nonostante si conosca il responsabile o vi siano un
mare di prove, ovvero le indagini non siano mai state effettuate. La difesa: un
soprammobile ben pagato succube dei magistrati. Il meglio che possono fare è
usare la furbizia per incidere sulla prescrizione. Le prove a discarico: un
perditempo, spesso dannoso. Non è improbabile che i testimoni della difesa siano
tacciati di falso.
Nel formulare la richiesta la
Boccassini nel processo Ruby ha fatto una gaffe dicendo: "Lo condanno", per poi
correggersi: "Chiedo la condanna" riferita a Berlusconi.
Esemplare anche è il caso di
Napoli. Il gip copia o si limita a riassumere le tesi accusatorie della Procura
di Napoli e per questo il tribunale del riesame del capoluogo campano annulla
l'arresto di Gaetano Riina, fratello del boss di Cosa nostra, Totò, avvenuto il
14 novembre 2011. L'accusa era di concorso esterno in associazione camorristica.
Il gip, scrive il Giornale
di Sicilia, si sarebbe limitato a riassumere la richiesta di
arresto della Procura di Napoli, incappando peraltro in una serie di errori e
non sostituendo nella sua ordinanza neanche le parole «questo pm» con «questo
gip».
Il paradosso, però, sono le profezie cinematografiche adattate ai
processi:
«... e lo condanna ad anni sette di reclusione, all'interdizione
perpetua dai pubblici uffici, e all'interdizione legale per la durata della
pena». Non è una frase registrata Lunedì 24 giugno 2013 al Tribunale di Milano,
ma una battuta presa dagli ultimi minuti del film «Il caimano» di Nanni Moretti.
La condanna inflitta al protagonista (interpretato dallo stesso regista) è
incredibilmente identica a quella decisa dai giudici milanesi per Silvio
Berlusconi. Il Caimano Moretti, dopo la sentenza, parla di «casta dei
magistrati» che «vuole avere il potere di decidere al posto degli elettori».
Sul degrado morale dell’Italia
berlusconiana (e in generale di tutti quelli che hanno votato Berlusconi
nonostante sia, per dirla con Gad Lerner, un “puttaniere”) è stato detto di
tutto, di più. Ma poco, anzi meno, è stato detto a mio parere sul degrado
moralista della sinistra anti-berlusconiana (e in generale di molti che hanno
votato “contro” il Cavaliere e che hanno brindato a champagne, festeggiato a
casa o in ufficio, tirato un sospiro di sollievo come al risveglio da un incubo
di vent’anni). Quella sinistra che, zerbino dei magistrati, ha messo il potere
del popolo nelle mani di un ordine professionale, il cui profilo
psico-fisico-attitudinale dei suoi membri non è mai valutato e la loro idoneità
professionale incute dei dubbi.
Condanna a sette anni di
carcere per concussione per costrizione (e non semplice induzione indebita) e
prostituzione minorile, con interdizione perpetua dai pubblici uffici per
Silvio Berlusconi: il processo Ruby a Milano
finisce come tutti, Cavaliere in testa, avevano pronosticato. Dopo una camera di
consiglio-fiume iniziata alle 10 di mattina e conclusa sette ore abbondanti
dopo, le tre giudici della quarta sezione penale Giulia Turri,
Orsola De Cristofaro e Carmen D'Elia hanno
accolto in pieno, e anzi aumentato, le richieste di 6 anni dell'accusa,
rappresentata dai pm Ilda Boccassini (in ferie e quindi non in
aula, sostituita dal procuratore capo di Milano Edmondo Bruti Liberati,
fatto mai avvenuto quello che il procuratore capo presenzi in dibattimento)
e Antonio Sangermano. I giudici hanno anche trasmesso alla
Procura, per le opportune valutazioni, gli atti relativi alla testimonianza, tra
gli altri, di Giorgia Iafrate, la poliziotta che affidò Ruby a
Nicole Minetti. Inoltre, sono stati trasmessi anche i verbali
relativi alle deposizioni di diverse olgettine, di Mariano
Apicella e di Valentino Valentini. Il tribunale di
Milano ha disposto anche la confisca dei beni sequestrati a Ruby,
Karima El Mahroug e al compagno Luca Risso, ai sensi dell'articolo 240
del codice penale, secondo cui il giudice "può ordinare la confisca delle cose
che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono
il prodotto o il profitto".
I paradossi irrisolti della
sentenza sono che colpiscono anche la “vittima” Ruby e non solo il “carnefice”
Berlusconi. L’ex minorenne, Karima El Mahroug, «per un astratta tutela della
condizione di minorenne», viene dichiarata prima “prostituta” e poi i suoi beni
le vengono confiscati: «Come nel caso del concusso, la parte lesa non si
dichiara tale anzi si manifesta lesa per l’azione dei magistrati». Ruby «è
doppiamente lesa dai magistrati», spiega Sgarbi, «nella reputazione e nel
vedersi sottrarre, in via cautelativa, i denari che Berlusconi le ha dato».
«Non chiamiamola sentenza. Non
chiamiamolo processo. Soprattutto, non chiamiamola giustizia». Comincia così,
con queste amarissime parole, la nota di Marina Berlusconi in difesa di suo
padre. «Quello cui abbiamo dovuto assistere è uno spettacolo assurdo che con la
giustizia nulla ha a che vedere, uno spettacolo che la giustizia non si merita.
La condanna - scrive Marina - era scritta fin dall'inizio, nel copione messo in
scena dalla Procura di Milano. Mio padre non poteva non essere condannato. Ma se
possibile il Tribunale è andato ancora più in là, superando le richieste
dell'accusa e additando come spergiuri tutti i testi in contrasto con il suo
teorema». Nonostante la "paccata" di testimoni portati in tribunale dalla difesa
di Silvio Berlusconi, il presidente della Corte Giulia Turri e i giudici
Orsolina De Cristofano e Carmen D'Elia hanno preferito inseguire il teorema
costruito ad arte dal pm Ilda Boccassini e tacciare di falsa testimonianza tutte
le persone che, con le proprie parole, hanno scagionato il Cavaliere. Insomma,
se la "verità" non coincide con quella professata dalla magistratura milanese,
allora diventa automaticamente bugia. Non importa che non ci sia alcuna prova a
dimostrarlo.
L'accusa dei giudici milanesi
è sin troppo chiara, spiega Andrea Indini su "Il Giornale": le trentadue persone
che si sono alternate sul banco dei testimoni per rendere dichiarazioni
favorevoli a Berlusconi hanno detto il falso. Solo le motivazioni, previste tra
novanta giorni, potranno chiarire le ragioni per cui il collegio abbia deciso di
trasmettere alla procura i verbali di testimoni che vanno dall’amico storico
dell’ex premier Mariano Apicella all’ex massaggiatore del Milan Giorgio
Puricelli, dall’europarlamentare Licia Ronzulli alla deputata Maria Rosaria
Rossi. Da questo invio di atti potrebbe nascere, a breve, un maxi procedimento
per falsa testimonianza. A finir nei guai per essersi opposta al teorema della
Boccassini c'è anche il commissario Giorgia Iafrate che era in servizio in
Questura la notte del rilascio di Ruby. La funzionaria aveva, infatti,
assicurato di aver agito "nell’ambito dei miei poteri di pubblico ufficiale".
"Di fronte alla scelta se lasciare la ragazza in Questura in condizioni non
sicure o affidarla ad un consigliere regionale - aveva spiegato - ho ritenuto di
seguire quest’ultima possibilità". Proprio la Boccassini, però, nella
requisitoria aveva definito "avvilenti le dichiarazioni della Iafrate che
afferma che il pm minorile Fiorillo le aveva dato il suo consenso". Alla procura
finiscono poi i verbali di una ventina di ragazze. Si va da Barbara Faggioli a
Ioana Visan, da Lisa Barizonte alle gemelle De Vivo, fino a Roberta Bonasia.
Davanti ai giudici avevano descritto le serate di Arcore come "cene eleganti",
con qualche travestimento sexy al massimo, e avevano sostenuto che Ruby si era
presentata come una 24enne. "I giudici hanno dato per scontato che siamo sul
libro paga di Berlusconi - ha tuonato Giovanna Rigato, ex del Grande Fratello
- io tra l’altro al residence non ho mai abitato, sono una che ha sempre
lavorato, l’ho detto in mille modi che in quelle serata ad Arcore non ho mai
visto nulla di scabroso ma tanto...". Anche Marysthelle Polanco è scioccata
dalla sentenza: "Non mi hanno creduto, non ci hanno creduto, io ho detto la
verità e se mi chiamano di nuovo ripeterò quello che ho sempre raccontato".
Sebbene si siano lasciate scivolare addosso insulti ben più pesanti, le ragazze
che hanno partecipato alle feste di Arcore non sono disposte ad accettare l’idea
di passare per false e bugiarde. Da Puricelli a Rossella, fino al pianista
Mariani e ad Apicella, è stato tratteggiato in Aula un quadro di feste fatto di
chiacchiere, balli e nessun toccamento.
Nel tritacarne giudiziario
finisce anche la Ronzulli, "rea" di aver fornito una versione diversa da quella
resa da Ambra e Chiara nel processo "gemello" e di aver negato di aver visto una
simulazione di sesso orale con l’ormai famosa statuetta di Priapo. Stesso
destino anche per l’ex consigliere per le relazioni internazionali Valentino
Valentini che aveva svelato di esser stato lui a far contattare la Questura di
Milano per "capire cosa stesse accadendo". Ed era stato sempre lui a parlare di
una conversazione tra Berlusconi e l'ex raìs Hosni Mubarak sulla parentela con
Ruby. Anche il viceministro Bruno Archi, all’epoca diplomatico, ai giudici aveva
descritto quel pranzo istituzionale nel quale si sarebbe parlato di Karima. E
ancora: sono stati trasmessi ai pm anche i verbali di Giuseppe Estorelli, il
capo scorta di Berlusconi, e del cameriere di Arcore Lorenzo Brunamonti, "reo"
di aver regalato al Cavaliere, di ritorno da un viaggio, la statuetta di Priapo.
Tutti bugiardi, tutti nella tritarcarne del tribunale milanese. La loro colpa?
Aver detto la verità. Una verità che non piace ai giudici che volevano far fuori
a tutti i costi Berlusconi.
C'era un solo modo per
condannare Silvio Berlusconi nel processo cosiddetto Ruby, spiega Alessandro
Sallusti su "Il Giornale": fare valere il teorema della Boccassini senza tenere
conto delle risultanze processuali, in pratica cancellare le decine e decine di
testimonianze che hanno affermato, in due anni di udienze, una verità
assolutamente incompatibile con le accuse. E cioè che nelle notti di Arcore non
ci furono né vittime né carnefici, così come in Questura non ci furono concussi.
Questo trucco era l'unica possibilità e questo è accaduto. Trenta testimoni e
protagonisti della vicenda, tra i quali rispettabili parlamentari, dirigenti di
questura e amici di famiglia sono stati incolpati in sentenza, cosa senza
precedenti, di falsa testimonianza e dovranno risponderne in nuovi processi.
Spazzate via in questo modo le prove non solo a difesa di Berlusconi ma
soprattutto contrarie al teorema Boccassini, ecco spianata la strada alla
condanna esemplare per il capo: sette anni più l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici, esattamente la stessa pronunciata nella scena finale del film
Il Caimano di Nanni Moretti, in cui si immagina l'uscita di scena di Berlusconi.
Tra questa giustizia e la finzione non c'è confine. Siamo oltre l'accanimento,
la sentenza è macelleria giudiziaria, sia per il metodo sia per l'entità.
Ricorda molto, ma davvero molto, quelle che i tribunali stalinisti e nazisti
usavano per fare fuori gli oppositori: i testimoni che osavano alzare un dito in
difesa del disgraziato imputato di turno venivano spazzati via come vermi,
bollati come complici e mentitori, andavano puniti e rieducati. Come osi,
traditore - sostenevano i giudici gerarchi - mettere in dubbio la parola dello
Stato padrone? Occhio, che in galera sbatto pure te. Così, dopo Berlusconi,
tocca ai berlusconiani passare sotto il giogo di questi pazzi scatenati
travestiti da giudici. I quali vogliono che tutti pieghino la testa di fronte
alla loro arroganza e impunità. In trenta andranno a processo per aver
testimoniato la verità, raccontato ciò che hanno visto e sentito. Addio Stato di
diritto, addio a una nobile tradizione giuridica, la nostra, in base alla quale
il giudizio della corte si formava esclusivamente sulle verità processuali, che
se acquisite sotto giuramento e salvo prova contraria erano considerate sacre.
Omicidi, tentati omicidi,
sequestro di persona, occultamenti di cadavere.
Per la giustizia italiana questi reati non sono poi così diversi da quello di
concussione, scrive Nadia Francalacci su "Panorama". La condanna inflitta a
Silvio Berlusconi a 7 anni di carcere, uno in più rispetto alla pena chiesta dai
pubblici ministeri, e interdizione perpetua dai pubblici uffici per i reati di
prostituzione minorile e concussione, non differisce che di poche settimane da
quella inflitta a Michele Misseri il contadino di Avetrana che ha occultato il
cadavere della nipotina Sara Scazzi in un pozzo delle campagne pugliesi. Non
solo. La condanna all’ex premier è addirittura ancor più pesante rispetto
a quella inflitta a due studenti di Giurisprudenza, Scattone e Ferraro, che “ quasi
per gioco” hanno mirato alla testa di una studentessa, Marta Russo,
uccidendola nel cortile interno della facoltà. Quasi per gioco. Così in pochi
istanti hanno ucciso, tolto la vita, ad una ragazza che aveva tanti sogni da
realizzare. Marta Russo così come Sara Scazzi oppure un Gabriele Sandri, il
tifoso laziale ucciso nell’area di servizio dopo dei tafferugli con i tifosi
juventini. Il poliziotto che ha premuto il grilletto colpendolo alla nuca, è
stato condannato a 9 anni e 4 mesi. A soli 28
mesi in più di carcere rispetto a Silvio Berlusconi.
Analizzando casi noti e quelli
meno conosciuti dall’opinione pubblica, non è possibile non notare una
“sproporzione” di condanna tra il caso Ruby e una vicenda quale il caso
Scazzi o Russo. Ecco alcuni dei casi e delle sentenze di condanna.
Caso Sandri: 9 anni e 4 mesi.
Per la Cassazione è omicidio volontario. Per l'agente della Polstrada Luigi
Spaccarotella, la sentenza è diventata definitiva con la pronuncia della
Cassazione. La condanna è di nove anni e quattro mesi di reclusione per aver
ucciso il tifoso della Lazio Gabriele Sandri dopo un tafferuglio con tifosi
juventini nell'area di servizio aretina di Badia al Pino sulla A1. Sandri era
sulla Renault che doveva portarlo a Milano, la mattina dell'11 novembre 2007,
per vedere Inter-Lazio insieme ad altri quattro amici. Spaccarotella era stato
condannato in primo grado a sei anni di reclusione per omicidio colposo,
determinato da colpa cosciente. In secondo grado i fatti erano stati qualificati
come omicidio volontario per dolo eventuale e la pena era stata elevata a nove
anni e quattro mesi di reclusione.
Caso Scazzi: per Michele
Misseri, 8 anni. Ergastolo per Sabrina. Ergastolo per sua madre Cosima Serrano.
Otto anni per Michele Misseri, che ora rischia anche un procedimento per
autocalunnia. Questo è il verdetto di primo grado sulla tragedia di Avetrana. il
contadino è accusato di soppressione di cadavere insieme al fratello e al
nipote.
Caso Marta Russo. L’omicidio
quasi per gioco di Marta Russo è stato punito con la condanna di Giovanni
Scattone e Salvatore Ferraro, rispettivamente puniti con 5 anni e quattro mesi
il primo e 4 anni e due mesi il secondo; Marta Russo, 22 anni, studentessa di
giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma, fu uccisa all'interno della
Città universitaria il 9 maggio 1997, da un colpo di pistola alla testa.
Caso Jucker. Ruggero Jucker,
reo di aver assassinato la propria fidanzata sotto l’effetto di stupefacenti, è
stato condannato, con un patteggiamento in appello a 16 anni di reclusione salvo
poi essere stato liberato dopo 10 anni.
Casi minori e meno
conosciuti dall’opinione pubblica.
Bari. 8 anni di carcere ad un
politico che uccise un rapinatore. 5 giugno 2013. La Corte d’appello di Bari, ha
chiesto la condanna a otto anni di reclusione per Enrico Balducci, l’ex
consigliere regionale pugliese, gestore del distributore di carburante di Palo
del Colle, accusato di omicidio volontario e lesioni personali, per aver ucciso
il 23enne Giacomo Buonamico e ferito il 25enne Donato Cassano durante un
tentativo di rapina subito il 5 giugno 2010. In primo grado, Balducci era stato
condannato con rito abbreviato alla pena di 10 anni di reclusione. Dinanzi ai
giudici della Corte d’Assise d’Appello di Bari l’accusa ha chiesto una riduzione
di pena ritenendo sussistente l’attenuante della provocazione, così come era
stato chiesto anche dal pm in primo grado ma non era stato riconosciuto dal gup.
Chiesta una condanna a quattro anni di reclusione per Cassano (condannato in
primo grado a 5 anni) per i reati di rapina e tentativo di rapina. Prima di
recarsi in moto al distributore di carburante gestito da Balducci, infatti, i
due avrebbero compiuto un’altra rapina al vicino supermercato. Balducci, questa
la ricostruzione dell’accusa, vedendosi minacciato, non sarebbe riuscito a
controllare la sua ira, e consapevole di poter uccidere, avrebbe fatto fuoco
ferendo Cassano e uccidendo Buonamico.
Sequestro Spinelli (ragioniere
di Berlusconi): 8 anni e 8 mesi di carcere al capobanda Leone. Condannati anche
i tre complici albanesi. Ma le pene sono state dimezzate rispetto alle
richieste dell'accusa. Il pm Paolo Storari ha chiesto la condanna a 16 anni di
carcere per Francesco Leone, ritenuto il capo banda, e pene tra gli 8 e i 10
anni per gli altri tre imputati. I quattro furono arrestati nel novembre
dell'anno scorso assieme ad altri due italiani, Pier Luigi Tranquilli e
Alessandro Maier, per i quali invece è stata chiesta l'archiviazione. Il gup di
Milano Chiara Valori ha condannato con il rito abbreviato a 8 anni e 8 mesi
Francesco Leone, riqualificando il reato in sequestro semplice. Sono arrivate
due condanne a 4 anni e 8 mesi, e una a 6 anni e 8 mesi, per gli altri tre
imputati. La vicenda è quella del sequestro lampo di Giuseppe Spinelli e della
moglie.
Pesaro. Picchiò e gettò la ex
dal cavalcavia: condannato a 10 anni di carcere. Il 22 giugno scorso, Saimo
Luchetti è stato condannato ieri a 10 anni di reclusione per sequestro di
persona, stalking, violenza privata e tentato omicidio. Dovrà versare anche una
provvisionale immediata di 60mila euro per la ragazza, 40mila per la madre e 15
per la sorella. Luchetti, 23 anni, calciatore dilettante, la notte del 18 marzo
2012 aveva malmenato e rapito sotto casa l’ex fidanzata Andrea Toccaceli di 18
anni, gettandola poi da un viadotto di Fossombrone alto 15 metri. Lui si gettò
giù subito dopo. Sono sopravvissuti entrambi, ristabilendosi completamente.
Luchetti è in carcere ad Ancona e dove dovrà rimanerci altri nove anni.
Caso Mancuso: condannato per
tentato omicidio a 5 anni di carcere. Il diciannovenne Luigi Mancuso è stato
condannato a 5 anni di reclusione per il tentato omicidio di Ion Sorin Sheau, un
cittadino romeno aggredito e abbandonato in strada a San Gregorio d'Ippona.
Assieme a Mancuso, figlio di Giuseppe Manuso, boss della 'ndrangheta, è stato
condannato anche Danilo Pannace, 18 anni, che dovrà scontare la pena di 4 anni e
8 mesi sempre per tentato omicidio. I due imputati, giudicati col rito
abbreviato, sono stati ritenuti responsabili del tentato omicidio del romeno Ion
Sorin Sheau, aggredito e lasciato in strada con il cranio sfondato ed in un lago
di sangue il 10 agosto del 2011 a San Gregorio d’Ippona, in provincia di Vibo.
Mancuso è stato ritenuto responsabile anche del reato di atti persecutori nei
confronti della comunità romena di San Gregorio.
All’estero. In Argentina l’ex-presidente
Carlos Menem è stato condannato a 8 anni di carcere per traffico d'armi
internazionale. Sono otto gli anni di carcere che l’ex presidente, ora
senatore al parlamento di Buenos Aires, dovrà scontare insieme a Óscar Camilión,
ministro della difesa durante il suo governo, con l’accusa di contrabbando
aggravato d’armi a Croazia ed Ecuador. Tra il 1991 e il 1995, l’Argentina
esportò 6.500 tonnellate di armamenti destinati ufficialmente a Panama e
Venezuela. Questi raggiunsero però la Croazia nel pieno del conflitto jugoslavo,
e l’Ecuador che nel ‘95, combatteva con il Perú.
Parlare, però, di Berlusconi è
come sminuire il problema. I Pasdaran della forca a buon mercato storcerebbero
il naso: Bene, parliamo d’altro.
«In questo processo chiunque
ha detto cose in contrasto con la tesi accusatoria è stato tacciato di falso,
mentre ben altri testi non hanno detto la verità e sono passati per super
testimoni» ha detto Franco De Jaco difensore di Cosima Serrano. E’ così è stato,
perché sotto processo non c’è solo Sabrina Misseri, Michele Misseri, Cosima
Serrano Misseri, Carmine Misseri, Cosimo Cosma, Giuseppe Nigro, Cosima
Prudenzano Antonio Colazzo, Vito Junior Russo, ma c’è tutta Avetrana e tutti
coloro che non si conformano alla verità mediatica-giudiziaria. Ed ancora
Morrone fu arrestato mezz’ora dopo la mattanza, il 30 gennaio ’91. Sul terreno
c’erano i corpi di due giovani e le forze dell’ordine di Taranto cercavano un
colpevole a tutti i costi. La madre di una delle vittime indirizzò i sospetti su
di lui. Lo presero e lo condannarono. Le persone che lo scagionavano furono
anche loro condannate per falsa testimonianza. Così funziona a Taranto. Vai
contro la tesi accusatoria; tutti condannati per falsa testimonianza. Nel ’96
alcuni pentiti svelarono la vera trama del massacro: i due ragazzi erano stati
eliminati perché avevano osato scippare la madre di un boss. Morrone non
c’entrava, ma ci sono voluti altri dieci anni per ottenere giustizia. E ora
arriva anche l’indennizzo per le sofferenze subite: «Avevo 26 anni quando mi
ammanettarono - racconta lui - adesso è difficile ricominciare. Ma sono
soddisfatto perché lo Stato ha capito le mie sofferenze, le umiliazioni subite,
tutto quello che ho passato». Un procedimento controverso: due volte la
Cassazione annullò la sentenza di condanna della corte d’Assise d’Appello, ma
alla fine Morrone fu schiacciato da una pena definitiva a 21 anni. Non solo:
beffa nella beffa, fu anche processato e condannato a 1 anno e 8 mesi per
calunnia. La sua colpa? Se l’era presa con i magistrati che avevano trascurato i
verbali dei pentiti.
Taranto, Milano, l’Italia.
“Egregi signori, forse
qualcuno di voi, componente delle più disparate commissioni di esame di avvocato
di tutta Italia, da Lecce a Bari, da Venezia a Torino, da Palermo a Messina o
Catania, pensa di intimorirmi con la forza di intimidazione del vincolo
associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Sicuramente il più
influente tra di voi, bocciandomi o (per costrizione e non per induzione)
facendomi bocciare annualmente senza scrupoli all’esame di avvocato dal lontano
1998, (da quando ho promosso interrogazioni parlamentari e inoltrato denunce
penali, che hanno ottenuto dei risultati eclatanti, come l’esclusione dei
consiglieri dell’ordine degli avvocati dalle commissioni d’esame e ciononostante
uno di loro è diventato presidente nazionale), pensa che possa rompermi le reni
ed impedirmi di proseguire la mia lotta contro questo concorso forense e tutti i
concorsi pubblici che provo nei miei libri essere truccati. E sempre su quei
libri provo il vostro sistema giudiziario essere, per gli effetti, fondato
sull’ingiustizia. Mi conoscete tutti bene da vent’anni, come mi conoscono bene,
prima di giudicarmi, i magistrati che critico. Per chi non fa parte del sistema
e non MI conosce e non VI conosce bene, al di là dell’immagine patinata che vi
rendono i media genuflessi, pensa che in Italia vige la meritocrazia e quindi
chi esamina e giudica e chi supera gli esami, vale. Non è così e non mi
impedirete mai di gridarlo al mondo. Avete la forza del potere, non la ragione
della legge. Forse qualcuno di voi, sicuramente il più influente, perseguendomi
artatamente anche per diffamazione a mezzo stampa, senza mai riuscire a
condannarmi, pur con le sentenze già scritte prima del dibattimento, pensa di
tagliarmi la lingua affinchè non possa denunciare le vostre malefatte. Non è
così e non mi impedirete mai di gridarlo al mondo. E non per me, ma per tutti
coloro che, codardi, non hanno il coraggio di ribellarsi. Anche perché se lo
fate a me, lo fate anche agli altri. Fino a che ci saranno centinaia di migliaia
di giovani vittime che mi daranno ragione, voi sarete sempre dalla parte del
torto. Avete un potere immeritato, non la ragione. Un ordine che dileggia il
Potere del popolo sovrano. In Italia succede anche questo. Potete farmi passare
per mitomane o pazzo. E’ nell’ordine delle cose: potrebbe andarmi peggio, come
marcire in galera o peggio ancora. Potete, finché morte non ci separi, impedirmi
di diventare avvocato. Farò vita eremitica e grama. Comunque, cari miei, vi
piaccia o no, di magistrati ce ne sono più di dieci mila, criticati e non sono
certo apprezzati; di avvocati più di 250 mila e questi, sì, disprezzati. Alla
fine per tutti voi arriva comunque la Livella e l’oblio. Di Antonio Giangrande
c’è uno solo. Si ama o si odia, ma fatevene un ragione: sarò per sempre una
spina nel vostro fianco e sopravviverò a voi. Più mi colpite, più mi rendete
altrettanto forte. Eliminarmi ora? E’ troppo tardi. Il virus della verità si
diffonde. E ringraziate Dio che non ci sia io tra quei 945 parlamentari che vi
vogliono molto, ma molto bene, che a parlar di voi si cagano addosso. Solo in
Italia chi subisce un’ingiustizia non ha nessuno a cui rivolgersi, siano essi
validi bocciati ai concorsi pubblici o innocenti in galera, che si chiamino
Berlusconi o Sallusti o Mulè o Riva (e tutti questi li chiamano “persone
influenti e potenti”). I nostri parlamentari non sanno nemmeno di cosa tu stia
parlando, quando ti prestano attenzione. Ed è raro che ciò succeda. In fede
Antonio Giangrande”.
Una denuncia per calunnia,
abuso d’ufficio e diffamazione contro la Commissione d’esame di avvocato di
Catania per tutelare l’immagine dei professionisti e di tutti i cittadini
leccesi, tarantini e brindisini è quanto propone il dr Antonio Giangrande,
presidente della “Associazione Contro Tutte le Mafie” (www.controtuttelemafie.it)
e profondo conoscitore del fenomeno degli esami e dei concorsi pubblici
truccati. Proposta presentata a tutti coloro che sono stati esclusi ed a tutti
gli altri, anche non candidati all’esame di avvocato, che si sentono vittime di
questo fenomeno di caccia alle streghe o che si sentano diffamati come
rappresentanti e come cittadini del territorio, ormai sputtanato in tutta
Italia. E proposta di presentazione del ricorso al Tar che sarebbe probabilmente
accolto, tenuto conto dei precedenti al Consiglio di Stato.
«A Lecce sarebbero solo 440 su
1258 i compiti ritenuti validi. Questo il responso della Commissione di Catania,
presieduta dall’Avvocato Antonio Vitale, addetta alla correzione degli
elaborati. Più di cento scritti finiscono sul tavolo della Procura della
Repubblica con l’accusa di plagio, per poi, magari, scoprire che è tutta una
bufala. Copioni a parte, sarebbe, comunque, il 65% a non superare l’esame:
troppi per definirli asini, tenuto conto che, per esperienza personale, so che
alla fase di correzione non si dedicano oltre i 5 minuti, rispetto ai 15/20
minuti occorrenti. Troppo pochi per esprimere giudizi fondati. Da 20 anni
denuncio che in Italia agli esami tutti si copia ed adesso scoprono l’acqua
calda. E copiano tutti. Si ricordi il “Vergogna, Vergogna” all’esame per
magistrato o il “Buffoni, Buffoni” all’esame di notaio, o le intemperanze agli
esami per l’avvocatura di Stato o la prova annullata per l’esame di notaio nel
2010 o di magistrato nel 1992.
Le mie denunce sono state
sempre archiviate ed io fatto passare per pazzo o mitomane.
Quindi chi si è abilitato
barando, ha scoperto l’acqua calda. Questa caccia alle streghe, perché? Vagito
di legalità? Manco per idea. In tempo di magra per i professionisti sul mercato,
si fa passare per plagio, non solo la dettatura uniforme dell’intero elaborato
(ripeto, che c’è sempre stata), ma anche l’indicazione della massima
giurisprudenziale senza virgolette. Ergo: dov’è il dolo? Per chi opera in ambito
giuridico le massime della Cassazione sono l’appiglio per tutte le tesi
difensive di parte o accusatorie. Senza di queste sarebbero solo opinioni
personali senza valore. Altra cosa è riportare pari pari, più che le massime, le
motivazioni delle sentenze.
Prescindendo dalla caccia
mirata alle streghe, c’è forse di più?
Ed allora i candidati esclusi
alla prova scritta dell’esame di avvocato tenuta presso la Corte d’Appello di
Lecce si rivolgano a noi per coordinare tutte le azioni di tutela: una denuncia
per calunnia, abuso d’ufficio e per diffamazione contro tutti coloro che si son
resi responsabili di una campagna diffamatoria ed un accanimento senza
precedenti. Premo ricordare che l’esame è truccato insitamente e non bisogna
scaricare sulla dignità e l’onore dei candidati gli interessi di una categoria
corporativistica. Nessuno li difende i ragazzi, esclusi e denunciati (cornuti e
mazziati) ma, dato che io c’ero e ci sono dal 1998, posso testimoniare che se
plagio vi è stato, vi è sempre stato, e qualcuno ha omesso il suo intervento
facendola diventare una consuetudine e quindi una norma da rispettare, e sono
concorsi nel reato anche la commissione di Lecce ed il Presidente della Corte
d’Appello, Mario Buffa, in quanto hanno agevolato le copiature. L’esame di
avvocato in tutta Italia si apre alle 9 con la lettura delle tracce, che così
finiscono in rete sul web. A Lecce l’esame non inizia mai prima delle undici. I
ragazzi più furbi hanno tutto il tempo di copiare legalmente, in quanto l’esame
non è ancora iniziato e quindi, se hanno copiato, non lo hanno fatto in quel
frangente, perché non ci si può spostare dal banco. Anche se, devo dire, si è
sempre permessa la migrazione per occupare posti non propri.
Su questi punti chiamerei a
testimoniare, a rischio di spergiuro, tutti gli avvocati d’Italia.
Ai malfidati, poi, spiegherei
per filo e per segno come si trucca l’esame, verbalmente, in testi ed in video.
Mi chiedo, altresì, perché
tanto accanimento su Lecce se sempre si è copiato ed in tutta Italia? E perché
non ci si impegna ha perseguire le commissioni che i compiti non li correggono e
li dichiarano tali?
Ma la correzione era mirata al
dare retti giudizi o si sono solo impegnati a fare opera inquisitoria e
persecutoria?
Inoltre ci sono buone
possibilità che il ricorso al Tar avverso all’esclusione possa essere accolto in
base ai precedenti del Consiglio di Stato».
Sarebbe il colmo dei paradossi
se tra quei 100 ci fosse il mio nome.
I commissari dovrebbero
dimostrare che, in quei pochi minuti, la loro attenzione era rivolta, non a
correggere ed a valutare i compiti, ma esclusivamente a cercare l’opera
primaria, fonte del plagio, presentata come propria dal candidato, per
verificarne l’esatta ed integrale corrispondenza.
Essi, al di là della foga
persecutoria, dovrebbero dimostrare che la Premessa, la Tesi e l’Antitesi, le
Conclusioni sono frutto di imitazione totale dell’altrui pensiero. Dovrebbero,
altresì, dimostrare che il richiamo essenziale alle massime giurisprudenziali
(spesso contrastanti tra loro) per suffragare la propria tesi e renderla
convincente, siano anch’esse plagio, pur essendo ammessi i codici commentati
dalla giurisprudenza, così come non lo sono per i magistrati e per i prossimi
esami di avvocato (tempi di applicazione della riforma permettendo).
Dovrebbero, i commissari,
dimostrare che quei pochi minuti sono bastati a loro per correggere, accusare e
giudicare, rischiando si dichiarare il falso.
Sarebbe il colmo dei paradossi
se tra quei 100 ci fosse il mio nome.
Io che ho denunciato e
dimostrato che gli esami ed i concorsi pubblici sono truccati. Forse per questo
per le mie denunce sono stato fatto passare per mitomane o pazzo ed ora anche
per falsario.
Denigrare la credibilità delle
vittime e farle passare per carnefici. Vergogna, gentaglia.
INDIZIONE DEL CONCORSO:
spesso si indice un concorso quando i tempi sono maturi per soddisfare da parte
dei prescelti i requisiti stabiliti (acquisizione di anzianità, titoli di
studio, ecc.). A volte chi indice il concorso lo fa a sua immagine e somiglianza
(perché vi partecipa personalmente come candidato). Spesso si indice il concorso
quando non vi sono candidati (per volontà o per induzione), salvo il prescelto.
Queste anomalie sono state riscontrate nei concorsi pubblici tenuti presso le
Università e gli enti pubblici locali. Spesso, come è successo per la polizia ed
i carabinieri, i vincitori rimangono casa.
COMMISSIONE D’ESAME:
spesso a presiedere la commissione d’esame di avvocato sono personalità che
hanno una palese incompatibilità. Per esempio nella Commissione d’esame centrale
presso il Ministero della Giustizia del concorso di avvocato 2010 è stato
nominato presidente colui il quale non poteva, addirittura, presiedere la
commissione locale di Corte d’Appello di Lecce. Cacciato in virtù della riforma
(decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, coordinato con la legge di conversione 18
luglio 2003, n. 180). La legge prevede che i Consiglieri dell’Ordine degli
Avvocati non possono essere Commissari d’esame (e per conseguenza i nominati dal
Consiglio locale per il Consiglio Nazionale Forense, che tra i suoi membri
nomina il presidente di Commissione centrale). La riforma ha cacciato gli
avvocati e sbugiardato i magistrati e professori universitari (in qualità
anch’essi di commissari d’esame) perché i compiti vengono letti presso altre
sedi: tutto questo perché prima tutti hanno raccomandato a iosa ed abusato del
proprio potere dichiarando altresì il falso nei loro giudizi abilitativi od
osteggiativi. Spesso le commissioni d’esame di avvocato sono mancanti delle
componenti necessarie per la valutazione tecnica della materia d’esame.
Essenziale nelle commissioni a cinque è la figura del magistrato, dell’avvocato,
del professore universitario: se una manca, la commissione è nulla. Le
Commissioni d’esame hanno sempre e comunque interessi amicali, familistiche e
clientelari.
I CONCORSI FARSA:
spesso i concorsi vengono indetti per sanare delle mansioni già in essere, come
il concorso truffa a 1.940 posti presso l’INPS, bandito per sistemare i
lavoratori socialmente utili già operanti presso l’Ente.
LE TRACCE:
le tracce sono composte da
personalità ministeriali scollegate alla realtà dei fatti. Ultimamente le tracce
si riferiscono a massime giurisprudenziali espresse nell’imminenza della
stilazione della traccia, quindi, in prossimità dell’esame. Quasi nessun testo
recente, portato legalmente dai candidati, è talmente aggiornato da riportare
quella massima. Altre volte si son riportate tracce con massime vecchissime e
non corrispondenti con le riforme legislative successive. Sessione d’esame
d’avvocato 2002-2003. Presidente di Commissione, Avv. Luigi Rella, Principe del
Foro di Lecce. Ispettore Ministeriale, Giorgino. Sono stato bocciato. Il
Ministero, alla prova di scritto di diritto penale, alla traccia n. 1,
erroneamente chiede ai candidati cosa succede al Sindaco, che prima nega e poi
rilascia una concessione edilizia ad un suo amico, sotto mentite spoglie di
un’ordinanza. In tale sede i Commissari penalisti impreparati suggerivano in
modo sbagliato. Solo io rilevavo che la traccia era errata, in quanto riferita a
sentenze della Cassazione riconducibili a violazioni di legge non più in vigore.
Si palesava l’ignoranza dell’art.107, D.Lgs. 267/00, Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali, in cui si dispongono le funzioni dei
dirigenti, e l’ignoranza del D.P.R. 380/01, Testo Unico in materia edilizia. Da
molti anni, con le varie Bassanini, sono entrate in vigore norme, in cui si
prevede che è competente il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune a
rilasciare o a negare le concessioni edilizie. Rilevavo che il Sindaco era
incompetente. Rilevavo altresì che il Ministero dava per scontato il
comportamento dei Pubblici Ufficiali omertosi, che lavorando con il Sindaco e
conoscendo i fatti penalmente rilevanti, non li denunciavano alla Magistratura.
Per non aver seguito i loro suggerimenti, i Commissari mi danno 15 (il minimo)
al compito esatto, 30 (il massimo) agli altri 2 compiti. I candidati che hanno
scritto i suggerimenti sbagliati, sono divenuti idonei.
LE PROVE D’ESAME:
spesso sono conosciute in anticipo. A volte sono pubblicate su internet giorni
prima, come è successo per il concorso degli avvocati (con denuncia del
sottosegretario Alfredo Mantovano di Lecce), dei dirigenti scolastici, o per
l’accesso alle Università a numero chiuso (medicina), ovvero, come succede
all’esame con più sedi (per esempio all’esame forense o per l’Agenzia delle
Entrate, le tracce sono conosciute tramite cellulari o palmari in virtù del
tardivo inizio delle prove in una sede rispetto ad altre. Si parla di ore di
ritardo tra una sede ed un’altra). A volte le tracce sono già state elaborate in
precedenza in appositi corsi, così come è successo all’esame di notaio. A volte
le prove sono impossibili, come è successo al concorsone pubblico per insegnanti
all’estero: 40 quesiti a risposta multipla dopo averli cercati, uno ad uno, in
un volume di oltre 4mila che i partecipanti alla selezione hanno visto per la
prima volta, leggere quattro testi in lingua straniera e rispondere alle
relative domande. Il tutto nel tempo record di 45 minuti, comprese parti di
testo da tradurre. Quasi 1 minuto a quesito.
MATERIALE CONSULTABILE:
c’è da dire che intorno al materiale d’esame c’è grande speculazione e un grande
salasso per le famiglie dei candidati, che sono rinnovati anno per anno in caso
di reiterazione dell’esame a causa di bocciatura. Centinaia di euro per codici e
materiale vario. Spesso, come al concorso di magistrato o di avvocato dello
Stato ed in tutti gli altri concorsi, ad alcuni è permessa la consultazione di
materiale vietato (codici commentati, fogliettini, fin anche compiti elaborati
dagli stessi commissari) fino a che non scoppia la bagarre. Si ricordi il
“Vergogna, Vergogna” all’esame per magistrato o il “Buffoni, Buffoni” all’esame
di notaio, o le intemperanze agli esami per l’avvocatura di Stato o la prova
annullata per l’esame di notaio nel 2010. Al concorso di avvocato, invece, è
permesso consultare codici commentati con la giurisprudenza. Spesso, come
succede al concorso di avvocato, sono proprio i commissari a dettare il parere
da scrivere sull’elaborato, tale da rendere le prove dei candidati uniformi e
nonostante ciò discriminati in sede di correzione. Il caso esemplare è lo
scandalo di Catanzaro: oltre duemila compiti-fotocopia. Su 2301 prove scritte
per l’accesso all’albo degli avvocati consegnate a metà dicembre del 1997 alla
commissione d’esame di Catanzaro, ben 2295 risultano identiche. Soltanto sei
elaborati, cioè lo 0,13 per cento del totale, appare non copiato. Compiti
identici, riga per riga, parola per parola. Le tre prove di diritto civile,
diritto penale e atti giudiziari non mettono in risalto differenze. Sono uguali
anche negli errori: tutti correggono l’avverbio «recisamente» in «precisamente».
Una concorrente rivela che un commissario avrebbe letteralmente dettato lo
svolgimento dei temi ai candidati. Racconta: «Entra un commissario e fa:
“scrivete”. E comincia a dettare il tema, piano piano, per dar modo a tutti di
non perdere il filo». «Che imbecilli quelli che hanno parlato, sono stati loro
a incasinare tutto. Se non avessero piantato un casino sarebbe andato tutto
liscio», dice una candidata, che poi diventerà avvocato e probabilmente
commissario d’esame, che rinnegherà il suo passato e che accuserà di plagio i
nuovi candidati. L’indagine è affidata ai pm Luigi de Magistris e Federica
Baccaglini, che ipotizzano il reato di falso specifico e inviano ben 2295 avvisi
di garanzia. Catanzaro non è l’unica mecca delle toghe: le fa concorrenza anche
Reggio Calabria che, tra l’altro, nel 2001 promuove il futuro ministro
dell’Istruzione per il Pdl Mariastella Gelmini in trasferta da Brescia. Ma
Catanzaro è da Guinness dei primati. I candidati arrivano da tutta Italia, e i
veri intoccabili soprattutto dalle sedi del Nord dove gli esami sono molto
selettivi per impedire l’accesso di nuovi avvocati nel mercato saturo. Gli
aspiranti avvocati milanesi o torinesi risultano residenti a Catanzaro per i sei
mesi necessari per il tirocinio, svolto in studi legali del luogo, i quali
certificano il praticantato dei futuri colleghi. Frotte di giovani si fanno
consigliare dove e come chiedere ospitalità. In città esistono numerose pensioni
e alloggi, oltre a cinque alberghi, che periodicamente accolgono con pacchetti
scontati i pellegrini forensi. Tutti sanno come funziona e nessuno se ne
lamenta. L’omertà è totale. I magistrati interrogano gruppi di candidati
dell’esame del dicembre 1997, che rispondono all’unisono: «Mi portai sovente in
bagno per bisogni fisiologici […]. Non so spiegare la coincidenza tra gli
elaborati da me compilati e quelli esibiti. Mi preme tuttavia evidenziare che
qualcuno potrebbe avermi copiato durante la mia assenza». Mentre il procedimento
giudiziario avanza a fatica per la difficoltà di gestire un numero così grande
di indagati, tutti gli aspiranti avvocati dell’esame del 1997 rifanno le prove
nel 1998 nel medesimo posto e sono promossi. Dopo otto anni di indagini e
rinvii, nell’estate 2005 il pm Federico Sergi, nuovo titolare dell’indagine,
chiede e ottiene per ciascuno il «non luogo a procedere per avvenuta
prescrizione». Tutto finito. Ultimamente le tracce si riferiscono a massime
giurisprudenziali espresse nell’imminenza della stilazione della traccia,
quindi, in prossimità dell’esame. Quasi nessun testo recente, portato legalmente
dai candidati, è talmente aggiornato da riportare quella massima. Ecco perché i
commissari d’esame, con coscienza e magnanimità, aiutano i candidati. Altrimenti
nessuno passerebbe l’esame. I commissari dovrebbero sapere quali sono le fonti
di consultazioni permesse e quali no. Per esempio all’esame di avvocato può
capitare che il magistrato commissario d’esame, avendo fatto il suo esame senza
codici commentati, non sappia che per gli avvocati ciò è permesso. I commissari
d’esame dovrebbero dimostrare che, in quei pochi minuti, la loro attenzione era
rivolta, non a correggere ed a valutare i compiti, ma esclusivamente a cercare
l’opera primaria, fonte del plagio, presentata come propria dal candidato, per
verificarne l’esatta ed integrale corrispondenza. Essi, al di là della foga
persecutoria, dovrebbero dimostrare che la Premessa, la Tesi e l’Antitesi, le
Conclusioni sono frutto di imitazione totale dell’altrui pensiero. Dovrebbero,
altresì, dimostrare che il richiamo essenziale alle massime giurisprudenziali
(spesso contrastanti tra loro) per suffragare la propria tesi e renderla
convincente, siano anch’esse plagio, pur essendo ammessi i codici commentati
dalla giurisprudenza, così come non lo sono per i magistrati e per i prossimi
esami di avvocato (tempi di applicazione della riforma permettendo). Dovrebbero,
i commissari, dimostrare che quei pochi minuti sono bastati a loro per
correggere, accusare e giudicare, rischiando si dichiarare il falso. Impuniti,
invece sono coloro che veramente copiano integralmente i compiti. In principio
era la vecchia “cartucciera” la fascia di stoffa da stringere in vita con gli
involtini. Poi il vocabolario farcito d'ogni foglio e foglietto, giubbotti
imbottiti di cultura bignami e addirittura scarpe con suola manoscritta. Oggi i
metodi per “aiutarsi” durante gli esami sono più tecnologici: il telefonino, si
sa, non si può portare, ma lo si porta lo stesso. Al massimo, se c’è la
verifica, lo metti sul tavolo della commissione. Quindi non è malsana l'idea
dell'iPhone sul banco, collegato a Wikipedia e pronto a rispondere ad ogni
quesito nozionistico. Comunque bisogna attrezzarsi, in maniera assolutamente
diversa. La rete e i negozi di cartolibreria vendono qualsiasi accrocchio
garantendo si tratti della migliore soluzione possibile per copiare durante le
prove scritte. C'è ad esempio la penna UV cioè a raggi ultravioletti scrive con
inchiostro bianco e si legge passandoci sopra un led viola incluso nel corpo
della penna. Inconveniente: difficile non far notare in classe una luce da
discoteca. Poi c'è la cosiddetta penna-foglietto: nel corpo della stilo c'è un
foglietto avvolto sul quale si è scritto precedentemente formule, appunti
eccetera. Foglietto che in men che non si dica si srotola e arrotola. E infine,
c'è l'ormai celebre orologio-biglietto col display elettronico e una porta Usb
sulla quale caricare testi d'ogni tipo.
IL MATERIALE CONSEGNATO:
il compito dovrebbe essere inserito in una busta da sigillare contenente
un’altra busta chiusa con inserito il nome del candidato. Non ci dovrebbero
essere segni di riconoscimento. Non è così come insegna il concorso di notaio.
Oltre ai segni di riconoscimento posti all’interno (nastri), i commissari
firmano in modo diverso i lembi di chiusura della busta grande consegnata.
LA CORREZIONE DEGLI
ELABORATI.
Quanto già indicato sono i trucchi che i candidati possono vedere ed
eventualmente denunciare. Quanto avviene in sede di correzione è lì la madre di
tutte le manomissioni. Proprio perchè nessuno vede. La norma prevede che la
commissione d’esame (tutti i componenti) partecipi alle fasi di:
• apertura della busta grande
contenente gli elaborati;
• lettura del tema da parte
del relatore ed audizione degli altri membri;
• correzione degli errori di
ortografia, sintassi e grammatica;
• richiesta di chiarimenti,
valutazione dell’elaborato affinchè le prove d’esame del ricorrente evidenzino
un contesto caratterizzato dalla correttezza formale della forma espressiva e
dalla sicura padronanza del lessico giuridico, anche sotto il profilo più
strettamente tecnico-giuridico, e che anche la soluzione delle problematiche
giuridiche poste a base delle prove d’esame evidenzino un corretto approccio a
problematiche complesse;
• consultazione collettiva,
interpello e giudizio dei singoli commissari, giudizio numerico complessivo,
motivazione, sottoscrizione;
• apertura della busta piccola
contenete il nome del candidato da abbinare agli elaborati corretti;
• redazione del verbale.
Queste sono solo fandonie
normative. Di fatto si apre prima la busta piccola, si legge il nome, se è un
prescelto si dà agli elaborati un giudizio positivo, senza nemmeno leggerli.
Quando i prescelti sono pochi rispetto al numero limite di idonei stabilito
illegalmente, nonostante il numero aperto, si aggiungono altri idonei diventati
tali “a fortuna”.
La riforma del 2003 ha
cacciato gli avvocati e sbugiardato i magistrati e professori universitari (in
qualità anch’essi di commissari d’esame) perché i compiti vengono letti presso
altre sedi: tutto questo perché prima tutti hanno raccomandato a iosa ed abusato
del proprio potere dichiarando altresì il falso nei loro giudizi abilitativi od
osteggiativi. Spesso le commissioni d’esame sono mancanti delle componenti
necessarie per la valutazione tecnica della materia d’esame. Le Commissioni
d’esame hanno sempre e comunque interessi amicali, familistiche e clientelari.
Seguendo una crescente letteratura negli ultimi anni abbiamo messo in relazione
l’età di iscrizione all’albo degli avvocati con un indice di frequenza del
cognome nello stesso albo. In particolare, per ogni avvocato abbiamo calcolato
la frequenza del cognome nell’albo, ovvero il rapporto tra quante volte quel
cognome vi appare sul totale degli iscritti, in relazione alla frequenza dello
stesso cognome nella popolazione. In media, il cognome di un avvocato appare
nell’albo 50 volte di più che nella popolazione. Chi ha un cognome
sovra-rappresentato nell’albo della sua provincia diventa avvocato prima. Infine
vi sono commissioni che, quando il concorso è a numero aperto, hanno tutto
l’interesse a limitare il numero di idonei per limitare la concorrenza: a detta
dell’economista Tito Boeri: «Nelle commissioni ci sono persone che hanno tutto
da perderci dall’entrata di professionisti più bravi e più competenti».
Paola Severino incoraggia gli
studenti e racconta: “Anch’io la prima volta fui bocciata all’esame per
diventare avvocato”. Raccontare una propria disavventura per infondere coraggio
alle nuove generazioni. Questa è la tecnica adottata dal Ministro della
Giustizia Paola Severino con i ragazzi della «Summer School» promossa dalla
Fondazione Magna Charta di Gaetano Quagliariello e Maurizio Gasparri. “Cari
ragazzi, non dovete scoraggiarvi perché anch’io la prima volta fui bocciata
all’esame per diventare avvocato… Quella volta ero con il mio futuro marito: lui
fu promosso e io non ce la feci… Ma eccoci ancora qua. Siamo sposati da tanti
anni” ha raccontato di fronte ai futuri avvocati puntando tutto sulla love story
e omettendo che, nonostante quella bocciatura, sarà titolare fino a novembre di
uno degli studi legali più importanti d’Italia (con cifre che si aggirano
intorno ai 7 milioni di euro). Una piccola consolazione non solo per i laureati
in legge, ma anche per tutte le future matricole che sosterranno i test di
ammissione. In fondo anche Albert Einstein venne bocciato. E a quanto pare anche
la Severino. Bisognerebbe, però, chiedere al ministro: gli amorosi l’aiuto se lo
son dato vicendevolmente ed i compiti sicuramente erano simili, quindi perché un
diverso giudizio?
In quei mesi di tormenti a
cavallo tra il 2000 e il 2001 la Mariastella Gelmini si trova dunque a
scegliere, spiegherà essa stessa a Flavia Amabile de “La Stampa.it”: «La mia
famiglia non poteva permettersi di mantenermi troppo a lungo agli studi, mio
padre era un agricoltore. Dovevo iniziare a lavorare e quindi dovevo superare
l'esame per ottenere l'abilitazione alla professione». Quindi? «La sensazione
era che esistesse un tetto del 30% che comprendeva i figli di avvocati e altri
pochi fortunati che riuscivano ogni anno a superare l'esame. Per gli altri,
nulla. C'era una logica di casta». E così, «insieme con altri 30-40 amici molto
demotivati da questa situazione, abbiamo deciso di andare a fare l'esame a
Reggio Calabria». I risultati della sessione del 2000, del resto, erano
incoraggianti. Nonostante lo scoppio dello scandalo, nel capoluogo calabrese
c'era stato il primato italiano di ammessi agli orali: 93,4%. Il triplo che
nella Brescia della Gelmini (31,7) o a Milano (28,1), il quadruplo che ad
Ancona. Idonei finali: 87% degli iscritti iniziali. Contro il 28% di Brescia, il
23,1% di Milano, il 17% di Firenze. Totale: 806 idonei. Cinque volte e mezzo
quelli di Brescia: 144. Quanti Marche, Umbria, Basilicata, Trentino, Abruzzo,
Sardegna e Friuli Venezia Giulia messi insieme. Insomma, la tentazione era
forte. Spiega il ministro dell'Istruzione: «Molti ragazzi andavano lì e abbiamo
deciso di farlo anche noi». E l'esame? Com'è stato l'esame? Quasi 57% di ammessi
agli orali. Il doppio che a Roma o a Milano. Quasi il triplo che a Brescia.
Dietro soltanto la solita Catanzaro, Caltanissetta, Salerno.
Quello per giudici e pm resta
uno dei concorsi più duri. Dopo la laurea occorrono oltre due anni di
preparazione negli studi forensi. Oppure nelle scuole universitarie di
specializzazione per le professioni legali. Sui 3.193 candidati che nel novembre
2008 hanno consegnato i tre scritti di diritto amministrativo, penale e civile,
la commissione ha mandato agli orali soltanto 309 aspiranti magistrati. Per poi
promuoverne 253. Nonostante i quasi due anni di prove e correzioni e i soldi
spesi, il ministero non è nemmeno riuscito a selezionare i 500 magistrati
previsti dal concorso. E tanto attesi negli uffici giudiziari di tutta Italia.
Se questi sono i risultati dei corsi di formazione post-laurea, il fallimento
degli obiettivi è totale. Eppure almeno cinque tra i 28 commissari sono stati
scelti dal ministro Alfano proprio tra quanti hanno insegnato nelle scuole di
specializzazione per le professioni legali. "I componenti della commissione
rispondono che il livello degli elaborati non ammessi era basso", dice
l'avvocato Anna Sammassimo, dell'Unione giuristi cattolici: "Ma alla lettura
degli elaborati dichiarati idonei si resta perplessi e molto. Tanto più che i
curricula dei candidati esclusi destano ammirazione. Dal verbale da me
visionato, il 227, risulta che la correzione dei tre elaborati di ciascun
candidato ha impegnato la sottocommissione per circa 30 minuti: per leggere tre
temi di tre materie, discuterne e deciderne il voto o la non idoneità sembra
obiettivamente un po' poco". Riguardo la magistratura, l’avvocato astigiano
Pierpaolo Berardi, classe 1964, per anni ha battagliato per far annullare il
concorso per magistrati svolto nel maggio 1992. Secondo Berardi, infatti, in
base ai verbali dei commissari, più di metà dei compiti vennero corretti in 3
minuti di media (comprendendo “apertura della busta, verbalizzazione e richiesta
chiarimenti”) e quindi non “furono mai esaminati”. I giudici del tar gli hanno
dato ragione nel 1996 e nel 2000 e il Csm, nel 2008, è stato costretto ad
ammettere: “Ci fu una vera e propria mancanza di valutazione da parte della
commissione”. Giudizio che vale anche per gli altri esaminati. In quell’esame
divenne uditore giudiziario, tra gli altri, proprio Luigi de Magistris, giovane
Pubblico Ministero che si occupò inutilmente del concorso farsa di abilitazione
forense a Catanzaro: tutti i compiti identici e tutti abilitati.
Al Tg1 Rai delle 20.00 del 1
agosto 2010 il conduttore apre un servizio: esame di accesso in Magistratura,
dichiarati idonei temi pieni zeppi di errori di ortografia. La denuncia è stata
fatta da 60 candidati bocciati al concorso 2008, che hanno spulciato i compiti
degli idonei e hanno presentato ricorso al TAR per manifesta parzialità dei
commissari con abuso del pubblico ufficio.
Di scandali per i compiti non
corretti, ma ritenuti idonei, se ne è parlato.
Nel 2008 un consigliere del
Tar trombato al concorso per entrare nel Consiglio di Stato, si è preso la briga
di controllare gli atti del giorno in cui sono state corrette le sue prove,
scoprendo che i cinque commissari avevano analizzato la bellezza di 690 pagine.
"Senza considerare la pausa pranzo e quella della toilette, significa che hanno
letto in media tre pagine e mezzo in 60 secondi. Un record da guinness, visto
che la materia è complessa", ironizza Alessio Liberati. Che ha impugnato anche i
concorsi del 2006 e del 2007: a suo parere i vincitori hanno proposto
stranamente soluzioni completamente diverse per la stessa identica sentenza. Il
magistrato, inoltre, ha sostenuto che uno dei vincitori, Roberto Giovagnoli, non
aveva nemmeno i titoli per partecipare al concorso. L'esposto viene palleggiato
da mesi tra lo stesso Consiglio di Stato e la presidenza del Consiglio dei
ministri, ma i dubbi e "qualche perplessità" serpeggiano anche tra alcuni
consiglieri. "Il bando sembra introdurre l'ulteriore requisito dell'anzianità
quinquennale" ha messo a verbale uno di loro durante una sessione dell'organo di
presidenza: "Giovagnoli era stato dirigente presso la Corte dei conti per circa
6 mesi (...) Il bando non sembra rispettato su questo punto". Per legge, a
decidere se i concorsi siano stati o meno taroccati, saranno gli stessi membri
del Consiglio. Vedremo.
In effetti, con migliaia di
ricorsi al TAR si è dimostrato che i giudizi resi sono inaffidabili. La carenza,
ovvero la contraddittorietà e la illogicità del giudizio negativo reso in
contrapposizione ad una evidente assenza o rilevanza di segni grafici sugli
elaborati, quali glosse, correzioni, note, commenti, ecc., o comunque la
infondatezza dei giudizi assunti, tale da suffragare e giustificare la
corrispondente motivazione indotta al voto numerico. Tutto ciò denota l’assoluta
discrasia tra giudizio e contenuto degli elaborati, specie se la correzione
degli elaborati è avvenuta in tempi insufficienti, tali da rendere un giudizio
composito. Tempi risibili, tanto da offendere l’umana intelligenza. Dai Verbali
si contano 1 o 2 minuti per effettuare tutte le fasi di correzione, quando il
Tar di Milano ha dichiarato che ci vogliono almeno 6 minuti solo per leggere
l’elaborato. La mancanza di correzione degli elaborati ha reso invalido il
concorso in magistratura. Per altri concorsi, anche nella stessa magistratura,
il ministero della Giustizia ha fatto lo gnorri e si è sanato tutto, alla faccia
degli esclusi. Già nel 2005 candidati notai ammessi agli orali nonostante errori
da somari, atti nulli che vengono premiati con buoni voti, mancata
verbalizzazione delle domande, elaborati di figli di professionisti ed
europarlamentari prima considerati “non idonei” e poi promossi agli orali. Al
Tg1 Rai delle 20.00 del 1 agosto 2010 il conduttore apre un servizio: esame di
accesso in Magistratura, dichiarati idonei temi pieni zeppi di errori di
ortografia. La denuncia è stata fatta da 60 candidati bocciati al concorso 2008,
che hanno spulciato i compiti degli idonei e hanno presentato ricorso al TAR per
manifesta parzialità dei commissari con abuso del pubblico ufficio. Riguardo la
magistratura, l’avvocato astigiano Pierpaolo Berardi, classe 1964, per anni ha
battagliato per far annullare il concorso per magistrati svolto nel maggio 1992.
Secondo Berardi, infatti, in base ai verbali dei commissari, più di metà dei
compiti vennero corretti in 3 minuti di media (comprendendo “apertura della
busta, verbalizzazione e richiesta chiarimenti”) e quindi non “furono mai
esaminati”. I giudici del tar gli hanno dato ragione nel 1996 e nel 2000 e il
Csm, nel 2008, è stato costretto ad ammettere: “Ci fu una vera e propria
mancanza di valutazione da parte della commissione”. Giudizio che vale anche per
gli altri esaminati. In quell’esame divenne uditore giudiziario, tra gli altri,
proprio Luigi de Magistris, giovane Pubblico Ministero che si occupò inutilmente
del concorso farsa di abilitazione forense a Catanzaro: tutti i compiti identici
e tutti abilitati. O ancora l’esame di ammissione all’albo dei giornalisti
professionisti del 1991, audizione riscontrabile negli archivi di radio
radicale, quando la presenza di un folto gruppo di raccomandati venne scoperta
per caso da un computer lasciato acceso nella sala stampa del Senato proprio sul
file nel quale il caposervizio di un’agenzia, commissario esaminatore, aveva
preso nota delle prime righe dei temi di tutti quelli da promuovere. E ancora lo
scandalo denunciato da un’inchiesta del 14 maggio 2009 apparsa su “La Stampa”. A
finire sotto la lente d’ingrandimento del quotidiano torinese l’esito del
concorso per allievi per il Corpo Forestale. Tra i 500 vincitori figli di
comandanti, dirigenti, uomini di vertice. La casualità ha voluto, inoltre, che
molti dei vincitori siano stati assegnati nelle stazioni dove comandano i loro
genitori. Una singolare coincidenza che diventa ancor più strana nel momento in
cui si butta un occhio ad alcuni “promemoria”, sotto forma di pizzini, ritrovati
nei corridoi del Corpo forestale e in cui sono annotati nomi, cognomi, date di
nascita e discendenze di alcuni candidati. «Per Alfonso, figlio di Rosetta»,
«Per Emidio, figlio di Cesarina di zio Antonio», «Per Maria, figlia di Raffaele
di zia Maria». Piccole annotazioni, certo. Il destino, però, ha voluto che le
tutte persone segnalate nei pizzini risultassero vincitrici al concorso.
GLI ESCLUSI, RIAMMESSI.
Candidati che sono stati esclusi dalla prova per irregolarità, come è successo
al concorso per Dirigenti scolastici, o giudicati non idonei, che poi si
presentano regolarmente agli orali. L’incipit della confidenza di Elio
Belcastro, parlamentare dell’Mpa di Raffaele Lombardo, pubblicata su “Il
Giornale”. Belcastro ci fa subito capire, scandendo bene le parole, che Tonino
non era nemmeno riuscito a prenderlo quel voto, minimo. «Tempo fa l’ex
procuratore capo di Roma, Felice Filocamo, che di quella commissione d’esami era
il segretario, mi ha raccontato che quando Carnevale si accorse che i vari
componenti avevano bocciato Di Pietro, lo chiamò e si arrabbiò molto. Filocamo
fu costretto a tornare in ufficio, a strappare il compito del futuro paladino di
Mani pulite e a far sì che, non saprei dire come, ottenesse il passaggio agli
orali, seppur con il minimo dei voti». Bocciato e ripescato? Magistrato per un
falso? Possibile? Non è l’unico caso. Era già stato giudicato non idoneo, ma in
una seconda fase sarebbero saltati fuori degli strani fogli aggiuntivi che prima
non c’erano. Ecco come sarebbe sorto il sospetto che qualcuno li avesse inseriti
per “salvare” il candidato già bocciato, in modo da giustificare una valutazione
diversa oppure da consentire un successivo ricorso al TAR. I maggiori quotidiani
nazionali e molti locali, ed anche tanti periodici, si sono occupati di tale
gravissimo fatto, e che è stato individuato con nome e cognome il magistrato
(una donna) in servizio a Napoli quale autore del broglio accertato. Per tale
episodio il CSM ha deciso di sospendere tale magistrato dalle funzioni e dallo
stipendio. In quella sessione a fronte di 350 candidati ammessi alle prove orali
pare che oltre 120 siano napoletani, i quali sembrano avere particolari
attitudini naturali verso le scienze giuridiche e che sembrano essere
particolarmente facilitati nel loro cammino anche dalla numerosa presenza nella
commissione di esami di magistrati e professori napoletani.
TUTELA AMMINISTRATIVA: non
è ammesso ricorso amministrativo gerarchico.
Sessione d’esame d’avvocato
2002-2003. Presidente di Commissione, Avv. Luigi Rella, Principe del Foro di
Lecce. Ispettore Ministeriale, Giorgino. Sono stato bocciato. Il Ministero, alla
prova di scritto di diritto penale, alla traccia n. 1, erroneamente chiede ai
candidati cosa succede al Sindaco, che prima nega e poi rilascia una concessione
edilizia ad un suo amico, sotto mentite spoglie di un’ordinanza. In tale sede i
Commissari penalisti impreparati suggerivano in modo sbagliato. Solo io rilevavo
che la traccia era errata, in quanto riferita a sentenze della Cassazione
riconducibili a violazioni di legge non più in vigore. Si palesava l’ignoranza
dell’art.107, D.Lgs. 267/00, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, in
cui si dispongono le funzioni dei dirigenti, e l’ignoranza del D.P.R. 380/01,
Testo Unico in materia edilizia. Da molti anni, con le varie Bassanini, sono
entrate in vigore norme, in cui si prevede che è competente il Dirigente
dell’Ufficio Tecnico del Comune a rilasciare o a negare le concessioni edilizie.
Rilevavo che il Sindaco era incompetente. Rilevavo altresì che il Ministero dava
per scontato il comportamento dei Pubblici Ufficiali omertosi, che lavorando con
il Sindaco e conoscendo i fatti penalmente rilevanti, non li denunciavano alla
Magistratura. Per non aver seguito i loro suggerimenti, i Commissari mi danno 15
(il minimo) al compito esatto, 30 (il massimo) agli altri 2 compiti. I candidati
che hanno scritto i suggerimenti sbagliati, sono divenuti idonei. Il presidente
di Commissione d’esame di Lecce, ricevendo il ricorso amministrativo gerarchico
contro l’esito della valutazione della sottocommissione, non ha risposto entro i
trenta giorni (nemmeno per il diniego) impedendomi di presentare ricorso al Tar.
TUTELA GIUDIZIARIA.
Un ricorso al TAR non si nega a nessuno: basta pagare la tangente delle spese di
giudizio. Per veder accolto il ricorso basta avere il principe del Foro
amministrativo del posto; per gli altri non c’è trippa per gatti. Cavallo di
battaglia: mancanza della motivazione ed illogicità dei giudizi. Nel primo caso,
dovendo accertare un’ecatombe dei giudizi, la Corte Costituzionale, con sentenza
175 del 2011, ha legittimato l’abuso delle commissioni: “buon andamento,
economicità ed efficacia dell’azione amministrativa rendono non esigibile una
dettagliata esposizione, da parte delle commissioni esaminatrici, delle ragioni
sottese ad un giudizio di non idoneità, sia per i tempi entro i quali le
operazioni concorsuali o abilitative devono essere portate a compimento, sia per
il numero dei partecipanti alle prove”. Così la Corte Costituzionale ha sancito,
il 7 giugno 2011, la legittimità costituzionale del cd. “diritto vivente”,
secondo cui sarebbe sufficiente motivare il giudizio negativo, negli esami di
abilitazione, con il semplice voto numerico. La Corte Costituzionale per ragion
di Stato (tempi ristretti ed elevato numero) afferma piena fiducia nelle
commissioni di esame (nonostante la riforma e varie inchieste mediatiche e
giudiziarie ne minano la credibilità), stabilendo una sorta d’infallibilità del
loro operato e di insindacabilità dei giudizi resi, salvo che il sindacato non
promani in sede giurisdizionale. I candidati, quindi, devono sperare nel Foro
presso cui vi sia tutela della meritocrazia ed un certo orientamento
giurisprudenziale a favore dei diritti inviolabili del candidato, che nella
massa è ridimensionato ad un semplice numero, sia di elaborato, sia di giudizio.
Giudizi rapidi e sommari, che spesso non valorizzano le capacità tecniche e
umane che da un’attenta lettura dell’elaborato possono trasparire. Fatto
assodato ed incontestabile il voto numerico, quale giudizio e motivazione
sottesa. Esso deve, però, riferire ad elementi di fatto corrispondenti che
supportino quel voto. Elementi di fatto che spesso mancano o sono insussistenti.
All’improvvida sentenza della Corte Costituzionale viene in soccorso la Corte di
Cassazione. Il sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice
amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici di
esami o concorsi pubblici (valutazioni inserite in un procedimento
amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo
tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica
amministrazione), è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione
esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in
relazione ai presupposti stessi in base ai quali è stato dedotto il giudizio
sull’elaborato sottoposto a valutazione. In sostanza il TAR può scendere sul
terreno delle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici per l’accesso
a una professione o in un concorso pubblico, quando il giudizio è viziato da
evidente illogicità e da travisamento del fatto. Ad affermare l’importante
principio di diritto sono le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.
8412, depositata il 28 maggio 2012. Insomma, la Cassazione afferma che le
commissioni deviano il senso della norma concorsuale.
Sì, il Tar può salvare tutti,
meno che Antonio Giangrande. Da venti anni inascoltato Antonio Giangrande
denuncia il malaffare di avvocati e magistrati ed il loro malsano accesso alla
professione. Cosa ha ottenuto a denunciare i trucchi per superare l’esame? Prima
di tutto l’ostracismo all’abilitazione. Poi, insabbiamento delle denunce contro
i concorsi truccati ed attivazione di processi per diffamazione e calunnia,
chiusi, però, con assoluzione piena. Intanto ti intimoriscono. Ed anche la
giustizia amministrativa si adegua. A parlar delle loro malefatte i giudici
amministrativi te la fanno pagare. Presenta l’oneroso ricorso al Tar di Lecce
(ma poteva essere qualsiasi altro Tribunale Amministrativo Regionale) per
contestare l’esito negativo dei suoi compiti all’esame di avvocato:
COMMISSIONE NAZIONALE D'ESAME PRESIEDUTA DA CHI NON POTEVA RICOPRIRE L'INCARICO,
COMMISSARI (COMMISSIONE COMPOSTA DA MAGISTRATI, AVVOCATI E PROFESSORI
UNIVERSITARI) DENUNCIATI CHE GIUDICANO IL DENUNCIANTE E TEMI SCRITTI NON
CORRETTI, MA DA 15 ANNI SONO DICHIARATI TALI. Ricorso, n. 1240/2011
presentato al Tar di Lecce il 25 luglio 2011 contro il voto numerico
insufficiente (25,25,25) dato alle prove scritte di oltre 4 pagine cadaune della
sessione del 2010 adducente innumerevoli nullità, contenente, altresì, domanda
di fissazione dell’udienza di trattazione. Tale ricorso non ha prodotto alcun
giudizio nei tempi stabiliti, salvo se non il diniego immediato ad una istanza
cautelare di sospensione, tanto da farlo partecipare, nelle more ed in pendenza
dell’esito definitivo del ricorso, a ben altre due sessioni successive, i cui
risultati sono stati identici ai temi dei 15 anni precedenti (25,25,25): compiti
puliti e senza motivazione, voti identici e procedura di correzione nulla in più
punti. Per l’inerzia del Tar si è stati costretti a presentare istanza di
prelievo il 09/07/2012. Inspiegabilmente nei mesi successivi all’udienza fissata
e tenuta del 7 novembre 2012 non vi è stata alcuna notizia dell’esito
dell’istanza, nonostante altri ricorsi analoghi presentati un anno dopo hanno
avuto celere ed immediato esito positivo di accoglimento. Eccetto qualcuno che
non poteva essere accolto, tra i quali i ricorsi dell'avv. Carlo Panzuti e
dell'avv. Angelo Vantaggiato in cui si contestava il giudizio negativo reso ad
un elaborato striminzito di appena una pagina e mezza. Solo in data 7 febbraio
2013 si depositava sentenza per una decisione presa già in camera di consiglio
della stessa udienza del 7 novembre 2012. Una sentenza già scritta, però, ben
prima delle date indicate, in quanto in tale camera di consiglio (dopo aver
tenuto anche regolare udienza pubblica con decine di istanze) i magistrati
avrebbero letto e corretto (a loro dire) i 3 compiti allegati (più di 4 pagine
per tema), valutato e studiato le molteplici questioni giuridiche presentate a
supporto del ricorso. I magistrati amministrativi potranno dire che a loro
insindacabile giudizio il ricorso di Antonio Giangrande va rigettato, ma devono
spiegare a chi in loro pone fiducia, perché un ricorso presentato il 25 luglio
2011, deciso il 7 novembre 2012, viene notificato il 7 febbraio 2013?
Un'attenzione non indifferente e particolare e con un risultato certo e
prevedibile, se si tiene conto che proprio il presidente del Tar era da
considerare incompatibile perchè è stato denunciato dal Giangrande e perché le
sue azioni erano oggetto di inchiesta video e testuale da parte dello stesso
ricorrente? Le gesta del presidente del Tar sono state riportate da Antonio
Giangrande, con citazione della fonte, nella pagina d'inchiesta attinente la
città di Lecce. Come per dire: chi la fa, l'aspetti?
In Italia tutti sanno che i
concorsi pubblici sono truccati e nessuno fa niente, tantomeno i magistrati. Gli
effetti sono che non è la meritocrazia a condurre le sorti del sistema Italia,
ma l’incompetenza e l’imperizia. Non ci credete o vi pare un’eresia? Basta dire
che proprio il Consiglio Superiore della Magistratura, dopo anni di giudizi
amministrativi, è stato costretto ad annullare un concorso già effettuato per
l’accesso alla magistratura. Ed i candidati ritenuti idonei? Sono lì a giudicare
indefessi ed ad archiviare le denunce contro i concorsi truccati. E badate, tra
i beneficiari del sistema, vi sono nomi illustri.
Certo che a qualcuno può
venire in mente che comunque una certa tutela giuridica esiste. Sì, ma dove? Ma
se già il concorso al TAR è truccato. Nel 2008 un consigliere del Tar trombato
al concorso per entrare nel Consiglio di Stato, si è preso la briga di
controllare gli atti del giorno in cui sono state corrette le sue prove,
scoprendo che i cinque commissari avevano analizzato la bellezza di 690 pagine.
“Senza considerare la pausa pranzo e quella della toilette, significa che hanno
letto in media tre pagine e mezzo in 60 secondi. Un record da guinness, visto
che la materia è complessa”, ironizza Alessio Liberati. Che ha impugnato anche i
concorsi del 2006 e del 2007: a suo parere i vincitori hanno proposto
stranamente soluzioni completamente diverse per la stessa identica sentenza. Il
magistrato, inoltre, ha sostenuto che uno dei vincitori, Roberto Giovagnoli, non
aveva nemmeno i titoli per partecipare al concorso. Mentre il Governo rifiuta da
mesi di rispondere alle varie interrogazioni parlamentari sul concorso delle
mogli (il concorso per magistrati Tar vinto da Anna Corrado e Paola Palmarini,
mogli di due membri dell’organo di autogoverno che ne nominò la commissione) si
è svolto un altro – già discusso – concorso per l’accesso al Tar. Nonostante
l’organo di autogoverno dei magistrati amministrativi (Consiglio di Presidenza –
Cpga) si sia stretto in un imbarazzante riserbo, che davvero stride con il
principio di trasparenza che i magistrati del Tar e del Consiglio di Stato sono
preposti ad assicurare controllando l’operato delle altre amministrazioni, tra i
magistrati amministrativi si vocifera che gli elaborati scritti del concorso
sarebbero stati sequestrati per mesi dalla magistratura penale, dopo aver
sorpreso un candidato entrato in aula con i compiti già svolti, il quale avrebbe
già patteggiato la pena. Dopo il patteggiamento la commissione di concorso è
stata sostituita completamente ed è ricominciata la correzione dei compiti. Si è
già scritto della incredibile vicenda processuale del dott. Enrico Mattei,
fratello di Fabio Mattei (oggi membro dell’organo di autogoverno), rimesso “in
pista” nel precedente concorso c.d. delle mogli grazie ad una sentenza del
presidente del Tar Lombardia, assolutamente incompetente per territorio, che,
prima di andare in pensione coinvolto dallo scandalo della c.d. cricca, si era
autoassegnato il ricorso ed aveva ammesso a partecipare al concorso il Mattei,
redigendo addirittura una sentenza breve (utilizzabile solo in caso di manifesta
fondatezza), poco dopo stroncata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 6190/2008),
che ha rilevato perfino l’appiattimento lessicale della motivazione della
decisione rispetto alle memorie difensive presentate dal Mattei. Dopo il
concorso delle mogli e il caso Mattei, un altro concorso presieduto da Pasquale
De Lise è destinato a far parlare di sé. Si sono infatti concluse le prove
scritte del concorso per 4 posti a consigliere di Stato, presieduto da una
altisonante commissione di concorso: il presidente del Consiglio di Stato
(Pasquale De Lise), il presidente aggiunto del Consiglio di Stato (Giancarlo
Coraggio), il presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
regione Sicilia (Riccardo Virgilio), il preside della facoltà di giurisprudenza
(Carlo Angelici) ed un presidente di sezione della Corte di Cassazione (Luigi
Antonio Rovelli). Ma anche il concorso al Consiglio di Stato non è immune da
irregolarità. Tantissime le violazioni di legge già denunciate all’organo di
autogoverno: area toilettes non sigillata e accessibile anche da avvocati e
magistrati durante le prove di concorso, ingresso a prove iniziate di pacchi non
ispezionati e asseritamente contenenti cibi e bevande, ingresso di estranei
nella sala durante le prove di concorso, uscita dei candidati dalla sala prima
delle due ore prescritte dalla legge, mancanza di firma estesa dei commissari di
concorso sui fogli destinati alle prove, presenza di un solo commissario in
aula. Tutti vizi, questi, in grado di mettere a rischio la validità delle prove.
Qual è l’organo deputato a giudicare, in caso di ricorso, sulla regolarità del
concorso per consigliere di Stato? Il Consiglio di Stato… naturalmente! Ecco
perché urge una riforma dei concorsi pubblici. Riforma dove le lobbies e le
caste non ci devono mettere naso. E c’è anche il rimedio. Niente esame di
abilitazione. Esame di Stato contestuale con la laurea specialistica. Attività
professionale libera con giudizio del mercato e assunzione pubblica per nomina
del responsabile politico o amministrativo che ne risponde per lui (nomina
arbitraria così come di fatto è già oggi). E’ da vent’anni che Antonio
Giangrande studia il fenomeno dei concorsi truccati. Anche la fortuna fa parte
del trucco, in quanto non è tra i requisiti di idoneità. Qualcuno si
scandalizzerà. Purtroppo non sono generalizzazioni, ma un dato di fatto. E da
buon giurista, consapevole del fatto che le accuse vanno provate, pur in una
imperante omertà e censura, l’ha fatto. In video ed in testo. Se non basta ha
scritto un libro, tra i 50, da leggere gratuitamente su
www.controtuttelemafie.it o su Google
libri o in ebook su Amazon.it o cartaceo su Lulu.com. Invitando ad informarsi
tutti coloro che, ignoranti o in mala fede, contestano una verità
incontrovertibile, non rimane altro che attendere: prima o poi anche loro si
ricrederanno e ringrazieranno iddio che esiste qualcuno con le palle che non ha
paura di mettersi contro Magistrati ed avvocati. E sappiate, in tanti modi
questi cercano di tacitare Antonio Giangrande, con l’assistenza dei media
corrotti dalla politica e dall’economia e genuflessi al potere. Ha perso le
speranze. I praticanti professionali sono una categoria incorreggibile: “so
tutto mi”, e poi non sanno un cazzo, pensano che essere nel gota, ciò garantisca
rispetto e benessere. Che provino a prendere in giro chi non li conosce. La
quasi totalità è con le pezze al culo e genuflessi ai Magistrati. Come avvoltoi
a buttarsi sulle carogne dei cittadini nei guai e pronti a vendersi al miglior
offerente. Non è vero? Beh! Chi esercita veramente sa che nei Tribunali, per
esempio, vince chi ha più forza dirompente, non chi è preparato ed ha ragione.
Amicizie e corruttele sono la regola. Naturalmente per parlare di ciò, bisogna
farlo con chi lavora veramente, non chi attraverso l’abito, cerca di fare il
monaco.
Un esempio per tutti di come
si legifera in Parlamento, anche se i media lo hanno sottaciuto. La riforma
forense, approvata con Legge 31 dicembre 2012, n. 247, tra gli ultimi interventi
legislativi consegnatici frettolosamente dal Parlamento prima di cessare di fare
danni. I nonni avvocati in Parlamento (compresi i comunisti) hanno partorito, in
previsione di un loro roseo futuro, una contro riforma fatta a posta contro i
giovani. Ai fascisti che hanno dato vita al primo Ordinamento forense
(R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 - Ordinamento della professione di avvocato e
di procuratore convertito con la legge 22 gennaio 1934 n.36) questa contro
riforma reazionaria gli fa un baffo. Trattasi di una “riforma”, scritta
come al solito negligentemente, che non viene in alcun modo incontro ed anzi
penalizza in modo significativo i giovani.
In tema di persecuzione
giudiziaria, vi si racconta una favola e per tale prendetela.
C‘era una volta in un paese
ridente e conosciuto ai più come il borgo dei sognatori, un vecchietto che
andava in bicicletta per la via centrale del paese. Il vecchietto non era quello
che in televisione indicano come colui che buttava le bambine nei pozzi. In quel
frangente di tempo una sua coetanea, avendo parcheggiato l’auto in un tratto di
strada ben visibile, era in procinto di scendere, avendo aperto la portiera.
Ella era sua abitudine, data la sua tarda età, non avere una sua auto, ma usare
l’auto della nipote o quella simile del fratello. Auto identiche in colore e
marca. Il vecchietto, assorto nei suoi pensieri, investe lo sportello aperto
dell’auto e cade. Per sua fortuna, a causa della bassa velocità tenuta, la
caduta è indolore. Assicurato alla signora che nulla era accaduto, il vecchietto
inforca la bicicletta e va con le sue gambe. Dopo poco tempo arriva alla signora
da parte del vecchietto una richiesta di risarcimento danni, su mandato dato
allo studio legale di sua figlia. L’assicurazione considera che sia inverosimile
la dinamica indicata ed il danno subito e ritiene di non pagare.
Dopo due anni arriva una
citazione da parte di un’altro avvocato donna. Una richiesta per danni tanto da
farsi ricchi. Ma non arriva alla vecchietta, ma a sua nipote. Essa indica
esattamente l’auto, la zona del sinistro e la conducente, accusando la nipote di
essere la responsabile esclusiva del sinistro.
E peccato, però, che nessun
testimone in giudizio ha riconosciuto la targa, pur posti a pochi metri del
fatto; che nessun testimone in giudizio ha riconosciuto l’auto distinguendola da
quella simile; che nessun testimone in giudizio ha disconosciuto la vecchietta
come protagonista; che nessun testimone in giudizio ha ammesso che vi siano
stati conseguenze per la caduta.
E peccato, però, che l’auto
non era in curva, come da essa indicato.
Peccato, però, che la
responsabile del sinistro non fosse quella chiamata in giudizio, ma la
vecchietta di cui sopra.
Una prima volta sbaglia il
giudice competente ed allora cambia l’importo, riproponendo la domanda.
Tutti i giudici di pace ed
onorari (avvocati) fanno vincere la causa del sinistro fantasma alla collega.
La tapina chiamata in causa
afferma la sua innocenza e presenta una denuncia contro l’avvocato. La
poveretta, che poteva essere querelata per lesioni gravissime, si è cautelata.
La sua denuncia è stata archiviata, mentre contestualmente, alla stessa ora, i
testimoni venivano sentiti alla caserma dei carabinieri.
La poveretta non sapeva che
l’avvocato denunciato era la donna del pubblico ministero, il cui ufficio era
competente sulla denuncia contro proprio l’avvocato.
Gli amorosi cosa hanno pensato
per tacitare chi ha osato ribellarsi? L’avvocato denuncia per calunnia la
poveretta, ingiustamente accusata del sinistro, la procura la persegue e gli
amici giudici la condannano.
L’appello sacrosanto non viene
presentato dagli avvocati, perché artatamente ed in collusione con la contro
parte sono fatti scadere i termini. L’avvocato amante del magistrato altresì
chiede ed ottiene una barca di soldi di danni morali.
La poveretta ha due fratelli:
uno cattivo, amico e succube di magistrati ed avvocati, che le segue le sue
cause e le perde tutte: uno buono che è conosciuto come il difensore dei deboli
contro i magistrati e gli avvocati. I magistrati le tentano tutte per
condannarlo: processi su processi. Ma non ci riescono, perché è innocente e le
accuse sono inventate. L’unica sua colpa è ribellarsi alle ingiustizie su di sé
o su altri. Guarda caso il fratello buono aveva denunciato il magistrato amante
dell’avvocato donna di cui si parla. Magistrato che ha archiviato la denuncia
contro se stesso.
La procura ed i giudici
accusano anche il fratello buono di aver presentato una denuncia contro
l’avvocato e di aver fatto conoscere la malsana storia a tutta l’Italia. Per
anni si cerca la denuncia: non si trova. Per anni si riconduce l’articolo a lui:
non è suo.
Il paradosso è che si vuol
condannare per un denuncia, che tra tante, è l’unica non sua.
Il paradosso è che si vuol
condannare per un articolo, che tra tanti (è uno scrittore), è l’unico non suo e
su spazio web, che tra tanti, non è suo.
Se non si può condannare, come
infangare la sua credibilità? Dopo tanti e tanti anni si fa arrivare il conto
con la prescrizione e far pagare ancora una volta la tangente per danni morali
all’avvocato donna, amante di magistrati.
Questa è il finale triste di
un favola, perché di favola si tratta, e la morale cercatevela voi.
Ed in fatto di mafia c’è
qualcuno che la sa lunga. «Io non cercavo nessuno, erano loro che cercavano
me….Mi hanno fatto arrestare Provenzano e Ciancimino, non come dicono, i
carabinieri……Di questo papello non ne sono niente….Il pentito Giovanni Brusca
non ha fatto tutto da solo, c'è la mano dei servizi segreti. La stessa cosa vale
anche per l'agenda rossa. Ha visto cosa hanno fatto? Perchè non vanno da quello
che aveva in mano la borsa e si fanno consegnare l'agenda. In via D'Amelio
c'erano i servizi……. Io sono stato 25 anni latitante in campagna senza che
nessuno mi cercasse. Com'è possibile che sono responsabile di tutte queste cose?
La vera mafia sono i magistrati e i politici che si sono coperti tra di loro.
Loro scaricano ogni responsabilità sui mafiosi. La mafia quando inizia una cosa
la porta a termine. Io sto bene. Mi sento carico e riesco a vedere oltre queste
mura……Appuntato, lei mi vede che possa baciare Andreotti? Le posso dire che era
un galantuomo e che io sono stato dell'area andreottiana da sempre». Le
confidenze fatte da Toto Riina, il capo dei capi, sono state fatte in due
diverse occasioni, a due guardie penitenziarie del Gom del carcere Opera di
Milano. Il dialogo tra polizia penitenziaria e l'ex numero uno della mafia, è
avvenuto lo scorso 31 maggio 2013, durante la pausa di un'udienza alla quale il
boss partecipava in teleconferenza. Queste frasi sono contenute in una relazione
di servizio stilata dagli agenti del Gom, il gruppo speciale della polizia
penitenziaria che si occupa della gestione dei detenuti eccellenti. La relazione
è stata inviata ai magistrati della Procura di Palermo che si occupano della
trattativa Stato-mafia, Nino Di Matteo, Francesco Del Bene e Roberto Tartaglia.
La legge forse è uguale per
tutti, le toghe certamente no. Ci sono quelle buone e quelle cattive. Ci sono i
giudici e i pm da una parte e gli avvocati dall'altra. Il Ministro della
Giustizia Anna Maria Cancellieri al convegno di Confindustria del 2 luglio 2013
risponde senza peli sulla lingua alla domanda del direttore del Tg de La7 Enrico
Mentana , su chi sia al lavoro per frenare le riforme: «gli avvocati... le
grandi lobby che impediscono che il Paese diventi normale». Così come è
altrettanto diretta quando Mentana le chiede se nel governo c’è una unità di
intenti sulla giustizia: «non c’è un sentimento comune, o meglio c’è solo a
parole», dice, spiegando che «quando affrontiamo il singolo caso, scattano i
campanilismi e le lobby». Magari ha ragione lei. Forse esiste davvero la lobby
degli azzeccagarbugli, scrive Salvatore Tramontano su “Il Giornale”. Ogni
categoria fa nel grande gioco del potere la sua partita. Non ci sono, però, solo
loro. Il Guardasigilli, ex Ministro dell’Interno ed ex alto burocrate come ex
Prefetto non si è accorto che in giro c'è una lobby molto più forte, un Palazzo,
un potere che da anni sogna di sconfinare e che fa dell'immobilismo la sua
legge, tanto da considerare qualsiasi riforma della giustizia un attentato alla
Costituzione. No, evidentemente no.
Oppure il ministro fa la voce
grossa con le toghe piccole, ma sta bene attenta a non infastidire i mastini di
taglia grossa. La lobby anti riforme più ostinata e pericolosa è infatti quella
dei dottor Balanzone, quella con personaggi grassi e potenti. È la Lobby ed
anche Casta dei magistrati. Quella che se la tocchi passi guai, e guai seri.
Quella che non fa sconti. Quella che ti dice: subisci e taci. Quella che non si
sottopone alla verifica pisco-fisica-attitudinale. Quella vendicativa. Quella
che appena la sfiori ti inquisisce per lesa maestà. È una lobby così minacciosa
che perfino il ministro della Giustizia non se la sente neppure di nominarla.
Come se al solo pronunciarla si evocassero anatemi e disgrazie. È un'ombra che
mette paura, tanto che la sua influenza agisce perfino nell'inconscio. Neanche
in un fuori onda la Cancellieri si lascia scappare il nome della gran casta. È
una censura preventiva per vivere tranquilli. Maledetti avvocati, loro portano
la scusa. Ma chi soprattutto non vuole riformare la giustizia in Italia ha un
nome e un cognome: magistratura democratica. Quella delle toghe rosse. Dei
comunisti che dovrebbero tutelare i deboli contro i potenti.
Ma si sa in Italia tutti
dicono: “tengo famiglia e nudda sacciu, nudda vidi, nudda sentu”.
I magistrati, diceva
Calamandrei, sono come i maiali. Se ne tocchi uno gridano tutti. Non puoi
metterti contro la magistratura, è sempre stato così, è una corporazione.
In tema di Giustizia l'Italia
è maglia nera in Europa. In un anno si sono impiegati 564 giorni per il
primo grado in sede civile, contro una media di 240 giorni nei Paesi Ocse. Il
tempo medio per la conclusione di un procedimento civile nei tre gradi di
giudizio si attesta sui 788 giorni. Non se la passa meglio la giustizia
penale: la sua lentezza è la causa principale di sfiducia nella giustizia
(insieme alla percezione della mancata indipendenza dei magistrati e della loro
impunità, World Economic Forum). La durata media di un processo penale, infatti,
tocca gli otto anni e tre mesi, con punte di oltre 15 anni nel 17% dei
casi. Ora, tale premessa ci sbatte in faccia una cruda realtà. Per Silvio
Berlusconi la giustizia italiana ha tempi record, corsie preferenziali e premure
impareggiabili. Si prenda ad esempio il processo per i diritti televisivi:
tre gradi di giudizio in nove mesi, una cosa del genere non si è mai vista in
Italia. Il 26 ottobre 2012 i giudici del Tribunale di Milano hanno
condannato Silvio Berlusconi a quattro anni di reclusione, una pena più dura di
quella chiesta dalla pubblica accusa (il 18 giugno 2012 i PM Fabio De Pasquale e
Sergio Spadaro chiedono al giudice una condanna di 3 anni e 8 mesi per frode
fiscale di 7,3 milioni di euro). Il 9 novembre 2012 Silvio Berlusconi, tramite i
suoi legali, ha depositato il ricorso in appello. L'8 maggio 2013 la
Corte d'Appello di Milano conferma la condanna di 4 anni di reclusione, 5 anni
di interdizione dai pubblici uffici e 3 anni dagli uffici direttivi. Il 9 luglio
2013 la Corte di Cassazione ha fissato al 30 luglio 2013 l'udienza del
processo per frode fiscale sui diritti Mediaset. Processo pervenuto in
Cassazione da Milano il 9 luglio con i ricorsi difensivi depositati il 19
giugno. Per chi se ne fosse scordato - è facile perdere il conto tra i 113
procedimenti (quasi 2700 udienze) abbattutisi sull'ex premier dalla sua
discesa in campo, marzo 1994 - Berlusconi è stato condannato in primo grado e in
appello a quattro anni di reclusione e alla pena accessoria di cinque anni di
interdizione dai pubblici uffici. Secondo i giudici, l'ex premier sarebbe
intervenuto per far risparmiare a Mediaset tre milioni di imposte nel 2002-2003.
Anni in cui, per quanto vale, il gruppo versò all'erario 567 milioni di tasse.
I legali di Berlusconi avranno adesso appena venti giorni di tempo per
articolare la difesa. «Sono esterrefatto, sorpreso, amareggiato» dichiara Franco
Coppi. Considerato il migliore avvocato cassazionista d'Italia, esprime la sua
considerazione con la sua autorevolezza e il suo profilo non politicizzato: «Non
si è mai vista un'udienza fissata con questa velocità», che «cade tra capo e
collo» e «comprime i diritti della difesa». Spiega: «Noi difensori dovremo fare
in 20 giorni quello che pensavamo di fare con maggior respiro». Tutto perché?
«Evidentemente - ragiona Coppi -, la Cassazione ha voluto rispondere a chi
paventava i rischi della prescrizione intermedia. Ma di casi come questo se ne
vedono molti altri e la Suprema Corte si limita a rideterminare la pena, senza
andare ad altro giudice. Al di là degli aspetti formali, sul piano sostanziale,
dover preparare una causa così rinunciando a redigere motivi nuovi, perché i
tempi non ci sono, significa un'effettiva diminuzione delle possibilità di
difesa». Il professore risponde così anche all'Anm che definisce «infondate» le
polemiche e nega che ci sia accanimento contro il Cavaliere.
113 procedimenti.
Tutto iniziò nel
1994 con un avviso di garanzia (poi dimostratosi infondato) consegnato a mezzo
stampa dal Corriere della Sera durante il G8 che si teneva a Napoli. Alla faccia
del segreto istruttorio. E’ evidentemente che non una delle centinaia di accuse
rivoltegli contro era fondata. Nessun criminale può farla sempre franca se
beccato in castagna. E non c’è bisogno di essere berlusconiano per affermare
questo.
E su come ci sia commistione
criminale tra giornali e Procure è lo stesso Alessandro Sallusti
che si confessa. In un'intervista al Foglio di
Giuliano Ferrara, il direttore de Il Giornale racconta i suoi
anni al Corriere della Sera, e il suo rapporto con Paolo Mieli:
«Quando pubblicammo l'avviso di garanzia che poi avrebbe fatto cadere il primo
governo di Silvio Berlusconi, ero felicissimo. Era uno scoop pazzesco.
E lo rifarei. Ma si tratta di capire perché certe notizie te le passano. Sin dai
tempi di Mani pulite il Corriere aveva due direttori, Mieli e
Francesco Saverio Borrelli, il procuratore capo di Milano. I magistrati
ci passavano le notizie, con una tempistica che serviva a favorire le loro
manovre. Mi ricordo bene la notte in cui pubblicammo l'avviso di
garanzia a Berlusconi. Fu una giornata bestiale, Mieli
a un certo punto, nel pomeriggio, sparì. Poi piombò all'improvviso nella mia
stanza, fece chiamare Goffredo Buccini e Gianluca Di Feo, che firmavano il
pezzo, e ci disse, pur con una certa dose di insicurezza, di scrivere tutto, che
lo avremmo pubblicato. Parlava con un tono grave, teso. Quella notte, poi, ci
portò in pizzeria, ci disse che aveva già scritto la lettera di dimissioni, se
quello che avevamo non era vero sarebbero stati guai seri. Diceva di aver
parlato con Agnelli e poi anche con il presidente Scalfaro. Ma poi ho
ricostruito che non era così, non li aveva nemmeno cercati, secondo me lui
pendeva direttamente dalla procura di Milano».
Si potrebbe sorridere al fatto
che i processi a Silvio Berlusconi, nonostante cotanto di principi del foro al
seguito, innalzino sensibilmente la media nazionale dello sfascio della nostra
giustizia. Ma invece la domanda, che fa capolino e che sorge spontanea, è sempre
la stessa: come possiamo fidarci di "questa" giustizia, che se si permette di
oltraggiare se stessa con l’uomo più potente d’Italia, cosa potrà fare ai poveri
cristi? La memoria corre a quel film di Dino Risi, "In nome del popolo
italiano", 1971. C'è il buono, il magistrato impersonato da Tognazzi. E poi
c'è il cialtrone, o presunto tale, che è uno strepitoso Gassman. Alla fine il
buono fa arrestare il cialtrone, ma per una cosa che non ha fatto, per un reato
che non ha commesso. Il cialtrone è innocente, ma finalmente è dentro.
Ciononostante viviamo in
un’Italia fatta così, con italiani fatti così, bisogna subire e tacere. Questo
ti impone il “potere”. Ebbene, si faccia attenzione alle parole usate per
prendersela con le ingiustizie, i soprusi e le sopraffazioni, le incapacità dei
governati e l’oppressione della burocrazia,i disservizi, i vincoli, le tasse, le
code e la scarsezza di opportunità del Belpaese. Perché sfogarsi con il
classico "Italia paese di merda", per quanto liberatorio, non può essere
tollerato dai boiardi di Stato. E' reato, in quanto vilipendio alla nazione.
Lo ha certificato la Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 4 luglio
2013 n. 28730. Accadde che un vigile, a Montagnano, provincia di Campobasso, nel
lontano 2 novembre 2005 fermò un uomo di 70 anni: la sua
auto viaggiava con un solo faro acceso. Ne seguì una vivace discussione tra il
prossimo multato e l'agente. Quando contravvenzione fu, il guidatore si lasciò
andare al seguente sfogo: "Invece di andare ad arrestare i tossici a Campobasso,
pensate a fare queste stronzate e poi si vedono i risultati. In questo schifo di
Italia di merda...". Il vigile zelante prese nota di quella frase e lo denunciò.
Mille euro di multa - In appello, il 26 aprile del 2012, per il
viaggiatore senza faro che protestò aspramente contro la contravvenzione
arrivò la condanna, pena interamente coperta da indulto. L'uomo decise
così di rivolgersi alla Cassazione. La sentenza poi confermata dai giudici
della prima sezione penale del Palazzaccio. Il verdetto: colpevole di "vilipendio
alla nazione". Alla multa di ormai otto anni fa per il faro spento, si
aggiunge quella - salata - di mille euro per l'offesa al
tricolore. L'uomo si era difeso sostenendo che non fosse sua intenzione
offendere lo Stato e appellandosi al "diritto alla libera manifestazione di
pensiero". «Il diritto di manifestare il proprio pensiero in qualsiasi modo - si
legge nella sentenza depositata - non può trascendere in offese grossolane e
brutali prive di alcuna correlazione con una critica obiettiva»: per integrare
il reato, previsto dall'articolo 291 del codice penale, «è sufficiente una
manifestazione generica di vilipendio alla nazione, da intendersi come comunità
avente la stessa origine territoriale, storia, lingua e cultura, effettuata
pubblicamente». Il reato in esame, spiega la Suprema Corte, «non consiste in
atti di ostilità o di violenza o in manifestazioni di odio: basta l'offesa alla
nazione, cioè un'espressione di ingiuria o di disprezzo che leda il prestigio o
l'onore della collettività nazionale, a prescindere dai vari sentimenti nutriti
dall'autore». Il comportamento dell'imputato, dunque, che «in luogo pubblico, ha
inveito contro la nazione», gridando la frase “incriminata”, «sia pure nel
contesto di un'accesa contestazione elevatagli dai carabinieri per aver condotto
un'autovettura con un solo faro funzionante, integra - osservano gli “ermellini”
- il delitto di vilipendio previsto dall'articolo 291 cp, sia nel profilo
materiale, per la grossolana brutalità delle parole pronunciate pubblicamente,
tali da ledere oggettivamente il prestigio o l'onore della collettività
nazionale, sia nel profilo psicologico, integrato dal dolo generico, ossia dalla
coscienza e volontà di proferire, al cospetto dei verbalizzanti e dei numerosi
cittadini presenti sulla pubblica via nel medesimo frangente, le menzionate
espressioni di disprezzo, a prescindere dai veri sentimenti nutriti dall'autore
e dal movente, nella specie di irata contrarietà per la contravvenzione subita,
che abbia spinto l'agente a compiere l'atto di vilipendio».
A questo punto ognuno di noi
ammetta e confessi che, almeno per un volta nella sua vita, ha proferito la
fatidica frase “che schifo questa Italia di merda” oppure “che schifo questi
italiani di merda”.
Bene, allora cari italiani:
TUTTI DENTRO, CAZZO!!
Non sarà la mafia a uccidermi
ma alcuni miei colleghi magistrati (Borsellino). La verità sulle stragi non la
possiamo dire noi Magistrati ma la deve dire la politica se non proprio la
storia (Ingroia). Non possiamo dire la verità sulle stragi altrimenti la classe
politica potrebbe non reggere (Gozzo). Non sono stato io a cercare loro ma loro
a cercare me (Riina). In Italia mai nulla è come appare. Ipocriti e
voltagabbana. Le stragi come eccidi di Stato a cui non è estranea la
Magistratura e e gran parte della classe politica del tempo tranne quei pochi
che ne erano i veri destinatari (Craxi e Forlani) e quei pochissimi che si
rifiutarono di partecipare al piano stragista (Andreotti Lima e Mannino) e che
per questo motivo furono assassinati o lungamente processati. La Sinistra non di
governo sapeva. La Sinistra Democristiana ha partecipato al piano stragista fino
all'elezione di Scalfaro poi ha cambiato rotta. I traditori di Craxi e la destra
neofascista sono gli artefici delle stragi. Quelli che pensavamo essere i peggio
erano i meglio. E quelli che pensavamo essere i meglio erano i peggio. In questo
contesto non si può cercare dai carabinieri Mario Mori e Mario Obinu che
comunque dipendevano dal Ministero degli Interni e quindi dal Potere Politico,
un comportamento lineare e cristallino.
Ed a proposito del “TUTTI
DENTRO”, alle toghe milanesi Ruby non basta mai. Un gigantesco terzo processo
per il caso Ruby, dove sul banco degli imputati siedano tutti quelli che,
secondo loro, hanno cercato di aiutare Berlusconi a farla franca: poliziotti,
agenti dei servizi segreti, manager, musicisti, insomma quasi tutti i testimoni
a difesa sfilati davanti ai giudici. Anche Ruby, colpevole di avere negato di
avere fatto sesso con il Cavaliere. Ma anche i suoi difensori storici, Niccolò
Ghedini e Piero Longo. E poi lui medesimo, Berlusconi. Che della opera di
depistaggio sarebbe stato il regista e il finanziatore. I giudici con questa
decisione mandano a dire (e lo renderanno esplicito nelle motivazioni) che
secondo loro in aula non si è assistito semplicemente ad una lunga serie di
false testimonianze, rese per convenienza o sudditanza, ma all'ultima puntata di
un piano criminale architettato ben prima che lo scandalo esplodesse, per
mettere Berlusconi al riparo dalle sue conseguenze. Corruzione in atti
giudiziari e favoreggiamento, questi sono i reati che i giudici intravedono
dietro quanto è accaduto. Per l'operazione di inquinamento e depistaggio la
sentenza indica una data di inizio precisa: il 6 ottobre 2010, quando Ruby viene
a Milano insieme al fidanzato Luca Risso e incontra l'avvocato Luca Giuliante,
ex tesoriere del Pdl, al quale riferisce il contenuto degli interrogatori che ha
già iniziato a rendere ai pm milanesi. I giudici del processo a Berlusconi
avevano trasmesso gli atti su quell'incontro all'Ordine degli avvocati,
ritenendo di trovarsi davanti a una semplice violazione deontologica. Invece la
sentenza afferma che fu commesso un reato, e che insieme a Giuliante ne devono
rispondere anche Ghedini e Longo. E l'operazione sarebbe proseguita a gennaio,
quando all'indomani delle perquisizioni e degli avvisi di garanzia, si tenne una
riunione ad Arcore tra Berlusconi e alcune delle «Olgettine» che erano state
perquisite. Berlusconi come entra in questa ricostruzione? Essendo imputato nel
processo, il Cavaliere non può essere accusato né di falsa testimonianza né di
favoreggiamento. La sua presenza nell'elenco vuol dire che per i giudici le
grandi manovre compiute tra ottobre e gennaio si perfezionarono quando
Berlusconi iniziò a stipendiare regolarmente le fanciulle coinvolte
nell'inchiesta. Corruzione di testimoni, dunque. Ghedini e Longo ieri reagiscono
con durezza, definendo surreale la mossa dei giudici e spiegando che gli
incontri con le ragazze erano indagini difensive consentite dalla legge. Ma la
nuova battaglia tra Berlusconi e la Procura di Milano è solo agli inizi. D’altra
parte anche Bari vuol dire la sua sulle voglie sessuali di Berlusconi. Silvio
Berlusconi avrebbe pagato l'imprenditore barese Gianpaolo Tarantini tramite il
faccendiere Walter Lavitola, perchè nascondesse dinanzi ai magistrati la verità
sulle escort portate alle feste dell’ex premier. Ne è convinta la procura di
Bari che ha notificato avvisi di conclusioni delle indagini sulle presunte
pressioni che Berlusconi avrebbe esercitato su Tarantini perchè lo coprisse
nella vicenda escort. Nell’inchiesta Berlusconi e Lavitola sono indagati per
induzione a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria. Secondo
quanto scrivono alcuni quotidiani, l’ex premier avrebbe indotto Tarantini a
tacere parte delle informazioni di cui era a conoscenza e a mentire nel corso
degli interrogatori cui è stato sottoposto dai magistrati baresi (tra luglio e
novembre 2009) che stavano indagando sulla vicenda escort. In cambio avrebbe
ottenuto complessivamente mezzo milione di euro, la promessa di un lavoro e la
copertura delle spese legali per i processi. Secondo l’accusa, Tarantini avrebbe
mentito, tra l'altro, negando che Berlusconi fosse a conoscenza che le donne che
Gianpy reclutava per le sue feste erano escort. Sono indagati Berlusconi e
Lavitola, per induzione a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria.
Comunque torniamo alle
condanne milanesi. Dopo il processo Ruby 1, concluso con la condanna in primo
grado di Silvio Berlusconi a 7 anni, ecco il processo Ruby 2,
con altri 7 anni di carcere per Emilio Fede e Lele Mora
e 5 per Nicole Minetti. Ma attenzione, perché si
parlerà anche del processo Ruby 3, perché come accaduto con la
Corte che ha giudicato il Cav anche quella che ha condannato Fede, Mora e
Minetti per induzione e favoreggiamento della prostituzione ha stabilito la
trasmissione degli atti al pm per valutare eventuali ipotesi di reato in
relazione alle indagini difensive. Nel mirino ci sono, naturalmente, Silvio
Berlusconi, i suoi legali Niccolò Ghedini e Piero Longo
e la stessa Karima el Mahroug, in arte Ruby. Come accaduto per
il Ruby 1 anche per il Ruby 2 il profilo penale potrebbe essere quello della
falsa testimonianza. La procura, rappresentata dal pm Antonio
Sangermano e dall’aggiunto Piero Forno, per gli imputati aveva chiesto sette
anni di carcere per induzione e favoreggiamento della prostituzione anche
minorile. Il processo principale si era concluso con la condanna a sette anni di
reclusione per Silvio Berlusconi, accusato di concussione e prostituzione
minorile. Durante la requisitoria l’accusa aveva definito le serate di Arcore
“orge bacchiche”. Secondo gli inquirenti sono in tutto 34 le ragazze che sono
state indotte a prostituirsi durante le serate ad Arcore per soddisfare, come è
stato chiarito in requisitoria, il “piacere sessuale” del Cavaliere. Serate che
erano “articolate” in tre fasi: la prima “prevedeva una cena”, mentre la seconda
“definita ‘bunga bunga’” si svolgeva “all’interno di un locale adibito a
discoteca, dove le partecipanti si esibivano in mascheramenti, spogliarelli e
balletti erotici, toccandosi reciprocamente ovvero toccando e facendosi toccare
nelle parti intime da Silvio Berlusconi”. La terza fase riguardava infine la
conclusione della serata e il suo proseguimento fino alla mattina dopo:
consisteva, scrivono i pm, “nella scelta, da parte di Silvio Berlusconi, di una
o più ragazze con cui intrattenersi per la notte in rapporti intimi, persone
alle quali venivano erogate somme di denaro ed altre utilità ulteriori rispetto
a quelle consegnate alle altre partecipanti”. A queste feste, per 13 volte (il
14, il 20, il 21, il 27 e il 28 febbraio, il 9 marzo, il 4, il 5, il 24, il 25 e
il 26 aprile, e l’1 e il 2 maggio del 2010) c’era anche Karima El Mahroug, in
arte Ruby Rubacuori, non ancora 18enne. La ragazza marocchina, in base
all’ipotesi accusatoria, sarebbe stata scelta da Fede nel settembre del 2009
dopo un concorso di bellezza in Sicilia, a Taormina, dove lei era tra le
partecipanti e l’ex direttore del Tg4 uno dei componenti della giuria. Secondo
le indagini, andò ad Arcore la prima volta accompagnata da Fede con una macchina
messa a disposizione da Mora. Per i pm, però, ciascuno dei tre imputati, in
quello che è stato chiamato “sistema prostitutivo”, aveva un ruolo ben preciso.
Lele Mora “individuava e selezionava”, anche insieme a Emilio Fede, “giovani
donne disposte a prostituirsi” nella residenza dell’ex capo del Governo
scegliendole in alcuni casi “tra le ragazze legate per motivi professionali
all’agenzia operante nel mondo dello spettacolo” gestita dall’ex agente dei vip.
Inoltre Mora, come Fede, “organizzava” in alcune occasioni “l’accompagnamento da
Milano ad Arcore” di alcune delle invitate alla serate “mettendo a disposizione
le proprie autovetture”, con tanto di autista. I pm in requisitoria hanno
paragonato Mora e Fede ad “assaggiatori di vini pregiati”, perché valutavano la
gradevolezza estetica delle ragazze e le sottoponevano a “un minimo esame di
presentabilità socio-relazionale”, prima di immetterle nel “circuito” delle
cene. Nicole Minetti, invece, avrebbe fatto da intermediaria per i compensi alle
ragazze – in genere girati dal ragionier Giuseppe Spinelli, allora fiduciario e
“ufficiale pagatore” per conto del leader del Pdl – che consistevano “nella
concessione in comodato d’uso” degli appartamenti nel residence di via Olgettina
e “in contributi economici” per il loro mantenimento o addirittura per il
pagamento delle utenze di casa o delle spese mediche fino agli interventi di
chirurgia estetica.
Il rischio di una sentenza che
smentisse quella inflitta a Berlusconi è stato dunque scongiurato: e di fatto la
sentenza del 19 luglio 2013 e quella che del 24 giugno 2013 rifilò sette anni di
carcere anche al Cavaliere si sorreggono a vicenda. Chiamati a valutare
sostanzialmente il medesimo quadro di prove, di testimonianze, di
intercettazioni, due tribunali composti da giudici diversi approdano alle stesse
conclusioni. Vengono credute le ragazze che hanno parlato di festini hard. E non
vengono credute le altre, Ruby in testa, che proprio nell’aula di questo
processo venne a negare di avere mai subito avances sessuali da parte di
Berlusconi. La testimonianza di Ruby viene trasmessa insieme a quella di altri
testimoni alla procura perché proceda per falso, insieme a quella di molti altri
testimoni. I giudici, come già successo nel processo principale, hanno trasmesso
gli atti alla Procura perché valutino le dichiarazioni di 33 testimoni della
difesa compresa la stessa Ruby; disposta la trasmissione degli atti anche per lo
stesso Silvio Berlusconi e dei suoi avvocati: Niccolò Ghedini e Piero Longo per
violazione delle indagini difensive. Il 6-7 ottobre 2010 (prima che scoppiasse
lo scandalo) e il 15 gennaio 2011 (il giorno dopo l’avviso di garanzia al
Cavaliere) alcune ragazze furono convocate ad Arcore, senza dimenticare
l’interrogatorio fantasma fatto a Karima. Durante le perquisizioni in casa di
alcune Olgettine erano stati trovati verbali difensivi già compilati. Vengono
trasmessi gli atti alla procura anche perché proceda nei confronti di Silvio
Berlusconi e dei suoi difensori Niccolò Ghedini e Piero Longo, verificando se
attraverso l'avvocato Luca Giuliante abbiano tentato di addomesticare la
testimonianza di Ruby. In particolare la Procura dovrà valutare la posizione, al
termine del processo di primo grado «Ruby bis» non solo per Silvio Berlusconi, i
suoi legali e Ruby, ma anche per altre ventinove persone. Tra queste, ci sono
numerose ragazze ospiti ad Arcore che hanno testimoniato, tra le quali: Iris
Berardi e Barbara Guerra (che all'ultimo momento avevano ritirato la
costituzione di parte civile) e Alessandra Sorcinelli. Il tribunale ha disposto
la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica anche per il primo
avvocato di Ruby, Luca Giuliante. «Inviare gli atti a fini di indagini anche per
il presidente Berlusconi e i suoi difensori è davvero surreale». Lo affermano i
legali di Berlusconi, Niccolò Ghedini e Piero Longo, in merito alla decisione
dei giudici di Milano di trasmettere gli atti alla procura in relazione alla
violazione delle indagini difensive. «Quando si cerca di esplicare il proprio
mandato defensionale in modo completo, e opponendosi ad eventuali
prevaricazioni, a Milano possono verificarsi le situazioni più straordinarie»
proseguono i due avvocati. E ancora: «La decisione del Tribunale di Milano nel
processo cosiddetto Ruby bis di inviare gli atti per tutti i testimoni che
contrastavano la tesi accusatoria già fa ben comprendere l'atteggiamento del
giudicante. Ma inviare gli atti ai fini di indagini anche per il presidente
Berlusconi e per i suoi difensori è davvero surreale. Come è noto nè il
presidente Berlusconi nè i suoi difensori hanno reso testimonianza in quel
processo. Evidentemente si è ipotizzato che vi sarebbe stata attività penalmente
rilevante in ordine alle esperite indagini difensive. Ciò è davvero assurdo».
La sentenza è stata
pronunciata dal giudice Annamaria Gatto. Ad assistere all'udienza anche per il
Ruby 2, in giacca e cravatta questa volta e non in toga, anche il procuratore
Edmondo Bruti Liberati, che anche in questo caso, come nel
processo a Berlusconi, ha voluto rivendicare in questo modo all'intera Procura
la paternità dell'inchiesta Ruby. Il collegio presieduto da Anna Maria Gatto e
composto da Paola Pendino e Manuela Cannavale è formato da sole donne. Giudici
donne come quelle del collegio del processo principale formato dai giudici
Orsola De Cristofaro, Carmela D'Elia e dal presidente Giulia Turri. Anche la
Turri, come la Gatto, ha deciso anche di rinviare al pm le carte per valutare
l'eventuale falsa testimonianza per le dichiarazioni rese in aula da 33 testi:
una lunga serie di testimoni che hanno sfilato davanti alla corte.
TOGHE ROSA
Dici donna e dici danno,
anzi, "condanno".
È il sistema automatico che
porta il nome di una donna, Giada (Gestione informatica assegnazioni
dibattimentali) che ha affidato il caso della minorenne Karima el Mahroug, detta
Ruby Rubacuori, proprio a quelle tre toghe. Che un processo possa finire a un
collegio tutto femminile non è una stranezza, come gridano i falchi del Pdl che
dopo troppi fantomatici complotti rossi ora accusano la trama rosa: è solo il
segno dell'evoluzione storica di una professione che fino a 50 anni fa era solo
maschile. Tra i giudici del tribunale di Milano oggi si contano 144 donne e 78
uomini: quasi il doppio.
Donna è anche Ilda
Boccassini,
che rappresentava l’accusa contro Berlusconi. Tutti hanno sentito le parole di
Ilda Boccassini: "Ruby è furba di quella furbizia orientale propria della sua
origine". «E' una giovane di furbizia orientale che come molti dei giovani delle
ultime generazioni ha come obbiettivo entrare nel mondo spettacolo e fare soldi,
il guadagno facile, il sogno italiano di una parte della gioventù che non ha
come obiettivo il lavoro, la fatica, lo studio ma accedere a meccanismi che
consentano di andare nel mondo dello spettacolo, nel cinema. Questo obiettivo -
ha proseguito la Boccassini - ha accomunato la minore "con le ragazze che sono
qui sfilate e che frequentavano la residenza di Berlusconi: extracomunitarie,
prostitute, ragazze di buona famiglia anche con lauree, persone che hanno un
ruolo nelle istituzioni e che pure avevano un ruolo nelle serate di Arcore come
la europarlamentare Ronzulli e la europarlamentare Rossi. In queste serate -
afferma il pm - si colloca anche il sogno di Kharima. Tutte, a qualsiasi prezzo,
dovevano avvicinare il presidente del Consiglio con la speranza o la certezza di
ottenere favori, denaro, introduzione nel mondo dello spettacolo».
Dovesse mai essere fermata
un'altra Ruby, se ne occuperebbe lei. Il quadro in rosa a tinta forte si
completa con il gip Cristina Di Censo, a cui il computer giudiziario ha
affidato l'incarico di rinviare a "giudizio immediato" Berlusconi, dopo averle
fatto convalidare l'arresto di Massimo Tartaglia, il folle che nel 2010 lo ferì
al volto con una statuetta del Duomo. Per capirne la filosofia forse basta la
risposta di una importante giudice di Milano a una domanda sulla personalità di
queste colleghe: «La persona del magistrato non ha alcuna importanza: contano
solo le sentenze. È per questo che indossiamo la toga».
Donna di carattere anche
Annamaria Fiorillo, il magistrato dei minori che, convocata dal tribunale,
ha giurato di non aver mai autorizzato l'affidamento della minorenne Ruby alla
consigliera regionale del Pdl Nicole Minetti e tantomeno alla prostituta
brasiliana Michelle Conceicao. Per aver smentito l'opposta versione accreditata
dall'allora ministro Roberto Maroni, la pm si è vista censurare dal Csm per
"violazione del riserbo".
Ruby 2, chi sono le tre
giudicesse che hanno condannato Mora, Fede e la Minetti, e trasmesso gli atti
per far condannare Berlusconi, i suoi avvocati e tutti i suoi testimoni? Anna
Maria Gatto, Paola Pendino e Manuela Cannavale. Si assomigliano molto anche nel
look alle loro colleghe del Ruby 1.
Anna Maria Gatto si ricorda per una
battuta.
La testimone Lisa Barizonte, sentita in aula,
rievoca le confidenze tra lei e Karima El Mahrough, alias Ruby.
In particolare il giudice le chiede di un incidente con l’olio bollente. La
teste conferma: “Mi disse che lo zio le fece cadere addosso una pentola
di olio bollente”. “Chi era lo zio? Mubarak?”, chiede
Anna Maria Gatto strappando un sorriso ai presenti in aula.
Ironia che punta dritta al centro dello scandalo. La teste, sottovoce, risponde:
“No, non l’ha detto”. Annamaria Gatto, presidente della quinta sezione penale, è
il giudice che, tra le altre cose, condannò in primo grado a 2 anni l'ex
ministro Aldo Brancher per ricettazione e appropriazione indebita, nell'ambito
di uno stralcio dell'inchiesta sulla tentata scalata ad Antonveneta da parte di
Bpi.
Manuela Cannavale,
invece, ha fatto parte del collegio che nel 2008 ha condannato in primo grado a
tre anni di reclusione l'ex ministro della Sanità Girolamo Sirchia.
Paola Pendino
è stata invece in passato membro della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione di
Milano, e si è occupata anche di Mohammed Daki, il marocchino che era stato
assolto dall'accusa di terrorismo internazionale dal giudice Clementina Forleo.
Ruby 1, chi sono le tre
giudichesse che hanno condannato Berlusconi?
Giulia Turri, Carmen D’Elia e Orsola
De Cristofaro:
sono i nomi dei tre giudici che hanno firmato la sentenza di condanna di
Berlusconi a sette anni. La loro foto sta facendo il
giro del web e tra numerosi commenti di stima e complimenti, spunta anche
qualche offesa (perfino dal carattere piuttosto personale).
L’aggettivo più ricorrente, inteso chiaramente in senso dispregiativo, è quello
di “comuniste”. Federica De Pasquale le ha definite “il peggior
esempio di femminismo” arrivando ad ipotizzare per loro il reato di
stalking. Ma su twitter qualche elettore del Pdl non ha esitato a definirle come
“represse” soppesandone il valore professionale con l’aspetto fisico e
definendole “quasi più brutte della Bindi”. Ma cosa conta se il giudice
è uomo/donna, bello/brutto?
Condanna a Berlusconi: giudici
uomini sarebbero stati più clementi? Ma per qualcuno il problema non è tanto che
si trattasse di “toghe rosse” quanto piuttosto di “giudici rosa”.
Libero intitola l’articolo sulla sentenza di condanna alle “giudichesse”,
sottolineando con un femminile forzato di questo sostantivo la natura di genere
della condanna e quasi a suggerire che se i giudici fossero stati uomini la
sentenza sarebbe stata diversa da quella che il giornale definisce “castrazione”
e “ergastolo politico” del Cav. La natura rosa del collegio
quindi avrebbe influenzato l’esito del giudizio a causa di un “dente
avvelenato in un caso così discusso e pruriginoso. Un dente avvelenato che ha
puntualmente azzannato Berlusconi”. Eppure è lo stesso curriculum
dei giudici interessati, sintetizzato sempre da Libero, a confermare la
preparazione e la competenza delle tre toghe a giudicare con lucidità in casi di
grande impatto mediatico.
Giulia Turri
è nota come il giudice che nel marzo del 2007 firmò l’ordinanza di arresto per
Fabrizio Corona ma è anche la stessa che ha giudicato in qualità di gup due
degli assassini del finanziere Gian Mario Roveraro e che, nel 2010, ha disposto
l’arresto di cinque persone nell’ambito dell’inchiesta su un giro di tangenti e
droga che ha coinvolto la movida milanese, e in particolare le note discoteche
Hollywood e The Club.
Orsola De Cristofaro
è stata giudice a latere nel processo che si è concluso con la condanna a
quindici anni e mezzo di carcere per Pier Paolo Brega Massone, l’ex primario di
chirurgia toracica, nell’ambito dell’inchiesta sulla clinica Santa Rita.
Carmen D’Elia
si è già trovata faccia a faccia con Berlusconi in tribunale: ha fatto infatti
parte del collegio di giudici del processo Sme in cui era imputato.
A condannare Berlusconi sono
state tre donne: la Turri, la De Cristofaro e la D'Elia che già lo aveva
processato per la Sme. La presentazione è fatta da “Libero Quotidiano” con un
articolo del 24 giugno 2013. A condannare Silvio Berlusconi a 7
anni di reclusione e all'interdizione a vita dai pubblici uffici nel primo grado
del processo Ruby sono state tre toghe rosa. Tre giudichesse che hanno propeso
per una sentenza pesantissima, ancor peggiore delle richieste di Ilda
Boccassini. Una sentenza con cui si cerca la "castrazione" e
l'"ergastolo politico" del Cav. Il collegio giudicante della quarta sezione
penale del Tribunale di Milano che è entrato a gamba tesa contro il governo
Letta e contro la vita democratica italiana era interamente composto da donne,
tanto che alcuni avevano storto il naso pensando che la matrice "rosa" del
collegio avrebbe potuto avere il dente avvelenato in un caso così discusso e
pruriginoso. Un dente avvelenato che ha puntualmente azzannato Berlusconi.
A presiedere il collegio è
stata Giulia Turri, arrivata in Tribunale dall'ufficio gip
qualche mese prima del 6 aprile 2011, giorno dell'apertura del dibattimento.
Come gup ha giudicato due degli assassini del finanziere Gian Mario
Roveraro, sequestrato e ucciso nel 2006, pronunciando due condanne, una
all'ergastolo e una a 30 anni. Nel marzo del 2007 firmò l'ordinanza di arresto
per il "fotografo dei vip" Fabrizio Corona, e nel novembre del
2008 ha rinviato a giudizio l'ex consulente Fininvest e deputato del Pdl
Massimo Maria Berruti. Uno degli ultimi suoi provvedimenti come gip, e
che è salito alla ribalta della cronaca, risale al luglio 2010: l'arresto di
cinque persone coinvolte nell'inchiesta su un presunto giro di tangenti e droga
nel mondo della movida milanese, e in particolare nelle discoteche Hollywood
e The Club, gli stessi locali frequentati da alcune delle ragazze
ospiti delle serate ad Arcore e che sono sfilate in aula.
La seconda giudichessa è
stata Orsola De Cristofaro, con un passato da pm e gip, che è
stata giudice a latere nel processo che ha portato alla condanna a quindici anni
e mezzo di carcere per Pier Paolo Brega Massone, l'ex primario
di chirurgia toracica, imputato con altri medici per il caso della clinica Santa
Rita e che proprio sabato scorso si è visto in pratica confermare la condanna
sebbene con una lieve diminuzione per via della prescrizioni di alcuni casi di
lesioni su pazienti.
Carmen D'Elia invece è un
volto noto nei procedimenti contro il Cavaliere: nel 2002, ha fatto parte parte
del collegio di giudici del processo Sme che vedeva come imputato, tra gli
altri, proprio Silvio Berlusconi. Dopo che la posizione del premier venne
stralciata - per lui ci fu un procedimento autonomo - insieme a Guido
Brambilla e a Luisa Ponti, il 22 novembre 2003
pronunciò la sentenza di condanna in primo grado a 5 anni per Cesare
Previti e per gli altri imputati, tra cui Renato Squillante
e Attilio Pacifico. Inoltre è stata giudice nel processo sulla
truffa dei derivati al Comune di Milano.
Donna è anche Patrizia
Todisco del caso Taranto.
Ed è lo stesso “Libero Quotidiano” che la presenta con un articolo del 13 agosto
2012. Patrizia Todisco, gip: la zitella rossa che licenzia 11mila operai Ilva.
Patrizia Todisco,
il giudice per le
indagini preliminari che sabato 11 agosto ha corretto il tiro rispetto alla
decisione del Tribunale di Riesame decidendo di fermare la produzione dell'area
a caldo dell'Ilva si Taranto lasciando quindi a casa 11mila operai, è molto
conosciuta a Palazzo di giustizia per la sua durezza. Una rigorosa, i suoi
nemici dicono "rigida", una a cui gli avvocati che la conoscono bene non osano
avvicinarsi neanche per annunciare la presentazione di un'istanza. Il gip è nata
a Taranto, ha 49 anni, i capelli rossi, gli occhiali da intellettuale, non è
sposata, non ha figli e ha una fama di "durissima". Come scrive il Corriere
della Sera, è una donna che non si fermerà davanti alle reazioni alla sua
decisione che non si aspetta né la difesa della procura tarantina né di quella
generale che sulle ultime ordinanze non ha aperto bocca. Patrizia Todisco è
entrata in magistratura 19 anni fa, e non si è mai spostata dal Palazzo di
giustizia di Taranto, non si è mai occupata dell'Ilva dove sua sorella ha
lavorato come segretaria della direzione fino al 2009. Non si è mai occupata del
disastro ambientale dell'Ilva ma, vivendo da sempre a Taranto, ha osservato da
lontano il profilo delle ciminiere che hanno dato lavoro e morte ai cittadini.
La sua carriera è cominciata al Tribunale per i minorenni, poi si si è occupata
di violenze sessuali, criminalità organizzata e corruzione. Rigorosissima
nell'applicazione del diritto, intollerante verso gli avvocati che arrivano in
ritardo, mai tenera con nessuno. Sempre il Corriere ricorda quella volta che,
davanti a un ragazzino che aveva rubato un pezzo di formaggio dal frigorifero di
una comunità. Fu assolto, come come dice un avvocato "lo fece così nero da farlo
sentire il peggiore dei criminali".
Ma anche Giusi Fasano
per "Il Corriere della Sera" ne dà una definizione. Patrizia va alla
guerra. Sola. Gli articoli del codice penale sono i suoi soldati e il rumore
dell'esercito «avversario» finora non l'ha minimamente spaventata. «Io faccio il
giudice, mi occupo di reati...» è la sua filosofia. Il presidente della
Repubblica, il Papa, il ministro dell'Ambiente, il presidente della Regione, i
sindacati, il Pd, il Pdl... L'Ilva è argomento di tutti. Da ieri anche del
ministro Severino, che ha chiesto l'acquisizione degli atti, e del premier Mario
Monti che vuole i ministri di Giustizia, Ambiente e Sviluppo a Taranto il 17
agosto, per incontrare il procuratore della Repubblica. Anna Patrizia Todisco
«ha le spalle grosse per sopportare anche questa» giura chi la conosce. Ha
deciso che l'Ilva non deve produrre e che Ferrante va rimosso? Andrà fino in
fondo. Non è donna da farsi scoraggiare da niente e da nessuno: così dicono di
lei. E nemmeno si aspetta la difesa a spada tratta della procura tarantina o di
quella generale che sulle ultime ordinanze, comunque, non hanno aperto bocca.
Ieri sera alle otto il procuratore generale Giuseppe Vignola, in Grecia in
vacanza, ha preferito non commentare gli interventi del ministro Severino e del
premier Monti «perché non ho alcuna notizia di prima mano e non me la sento di
prendere posizione». È stato un prudente «no comment» anche per il procuratore
capo di Taranto Franco Sebastio. Nessuna affermazione. Che vuol dire allo stesso
tempo nessuna presa di posizione contro o a favore della collega Todisco. Quasi
un modo per studiare se prenderne o no le distanze. Lei, classe 1963, né sposata
né figli, lavora e segue tutto in silenzio. La rossa Todisco (e parliamo del
colore dei capelli) è cresciuta a pane e codici da quando diciannove anni fa
entrò nella magistratura scegliendo e rimanendo sempre nel Palazzo di giustizia
di Taranto. Dei tanti procedimenti aperti sull'Ilva finora non ne aveva seguito
nessuno. Il mostro d'acciaio dove sua sorella ha lavorato fino al 2009 come
segretaria della direzione, lo ha sempre osservato da lontano. Non troppo
lontano, visto che è nata e vive a pochi chilometri dal profilo delle ciminiere
che dev'esserle quantomeno familiare. Il giudice Todisco non è una persona
riservata. Di più. E ovviamente è allergica ai giornalisti. «Non si dispiaccia,
proprio non ho niente da dire» è stata la sola cosa uscita dalle sue labbra
all'incrocio delle scale che collegano il suo piano terra con il terzo, dov'è la
procura. Lei non parla, ma i suoi provvedimenti dicono di lei. Di quel «rigore
giuridico perfetto» descritto con ammirazione dai colleghi magistrati, o
dell'interpretazione meno benevola di tanti avvocati: «Una dura oltremisura,
rigida che più non si può». Soltanto un legale che non la conosce bene potrebbe
avvicinarla al bar del tribunale per dirle cose tipo «volevo parlarle di
quell'istanza che vorrei presentare...». Nemmeno il tempo di finire la frase.
«Non c'è da parlare, avvocato. Lei la presenti e poi la valuterò». E che dire
dei ritardi in aula? La sua pazienza dura qualche minuto, poi si comincia, e
poco importa se l'avvocatone sta per arrivare, come spiega inutilmente il
tirocinante. Istanza motivata o niente da fare: si parte senza il principe del
foro. La carriera di Patrizia Todisco è cominciata nel più delicato dei settori:
i minorenni, poi fra i giudici del tribunale e infine all'ufficio gip dove si è
occupata di violenze sessuali, criminalità organizzata, corruzione. Qualcuno
ricorda che la giovane dottoressa Todisco una volta fece marcia indietro su un
suo provvedimento, un bimbetto di cinque anni che aveva tolto alla famiglia per
presunti maltrattamenti. Una perizia medica dimostrò che i maltrattamenti non
c'entravano e lei si rimangiò l'ordinanza. Mai tenera con nessuno. Nemmeno con
il ragazzino che aveva rubato un pezzo di formaggio dal frigorifero di una
comunità: «alla fine fu assolto» racconta l'avvocato «ma lo fece così nero da
farlo sentire il peggiore dei criminali».
Donne sono anche le giudici
del caso Scazzi.
Quelle del tutti dentro anche i testimoni della difesa e del fuori onda.
«Bisogna un po' vedere, no, come imposteranno...potrebbe essere mors tua vita
mea». È lo scambio di opinioni tra il presidente della Corte d'assise di
Taranto, Rina Trunfio, e il giudice a latere Fulvia Misserini. La
conversazione risale al 19 marzo ed è stata registrata dai microfoni delle
telecamere «autorizzate a filmare l'udienza». Il presidente della corte, tra
l'altro, afferma: «Certo vorrei sapere se le due posizioni sono collegate.
Quindi bisogna vedere se si sono coordinati tra loro e se si daranno l'uno
addosso all'altro»; il giudice a latere risponde: «Ah, sicuramente». Infine il
presidente conclude: «(Non è che) negheranno in radice».
Donne sono anche le giudici
coinvolte nel caso Vendola.
Susanna De Felice, il magistrato fu al centro delle polemiche dopo che i
due magistrati che rappresentavano l'accusa nel processo a Vendola,
Desirée Digeronimo
(trasferita alla procura di Roma) e Francesco Bretone, dopo l'assoluzione
del politico (per il quale avevano chiesto la condanna a 20 mesi di reclusione)
inviarono un esposto al procuratore generale di Bari e al capo del loro ufficio
segnalando l'amicizia che legava il giudice De Felice alla sorella del
governatore, Patrizia.
Donna è anche il giudice
che ha condannato Raffaele Fitto.
Condannarono Fitto: giudici sotto inchiesta. Sentenza in tempi ristretti e
durante le elezioni: Lecce apre un fascicolo. L'ira di Savino: procedura
irrituale, non ci sono ancora le motivazioni del verdetto, scrive Giuliano
Foschini su “La Repubblica”. La procura di Lecce ha aperto un'inchiesta sul
collegio di giudici che, nel dicembre scorso, ha condannato l'ex ministro del
Pdl, Raffaele Fitto a quattro anno di reclusione per corruzione e abuso di
ufficio. Nelle scorse settimane il procuratore Cataldo Motta ha chiesto al
presidente del Tribunale di Bari, Vito Savino, alcune carte che documentano lo
svolgimento del processo. Una richiesta che ha colto di sorpresa il presidente
che ha inviato tutti gli atti alla procura. Ma contestualmente ha segnalato la
vicenda al presidente della Corte d'Appello, Vito Marino Caferra, indicandone
l'originalità non fosse altro perché si sta indagando su una sentenza della
quella non si conoscono ancora le motivazioni. L'indagine della procura di Lecce
nasce dopo le durissime accuse di Fitto, 24 ore dopo la sentenza nei confronti
della corte che lo aveva condannato. Secondo l'ex ministro il presidente di
sezione Luigi Forleo, e gli altri due giudici Clara Goffredo e Marco Galesi
avrebbero imposto un ritmo serrato al suo processo in modo da condannarlo
proprio nel mezzo della campagna elettorale. "Si è aperta in maniera ufficiale
un'azione da parte della magistratura barese - aveva detto Fitto - che è entrata
a piedi uniti in questa campagna elettorale. Non c'era bisogno di fare questa
sentenza in questi tempi. Attendo di sapere dal presidente Forleo, dalla
consigliera Goffredo e dal presidente del tribunale Savino - aveva attaccato
Fitto - perché vengono utilizzi due pesi e due misure in modo così clamoroso. Ci
sono dei processi - aveva spiegato per i quali gli stessi componenti del
collegio che mi ha condannato hanno fatto valutazioni differenti con tre udienze
all'anno, salvo dichiarare la prescrizione di quei procedimenti a differenza del
caso mio nel quale ho avuto il privilegio di avere tre udienze a settimana". Il
riferimento era al processo sulla missione Arcobaleno che era appunto seguito
dagli stessi giudici e che invece aveva avuto tempi molto più lunghi. "Questa è
la volontà precisa di un collegio che ha compiuto una scelta politica precisa,
che è quella di dare un'indicazione a questa campagna elettorale". Alle domande
di Fitto vuole rispondere evidentemente ora la procura di Lecce che ha aperto
prontamente l'indagine e altrettanto prontamente si è mossa con il tribunale.
Tra gli atti che verranno analizzati ci sono appunti i calendari delle udienze:
l'obiettivo è capire se sono stati commessi degli abusi, come dice Fitto, o se
tutto è stato svolto secondo le regole.
Donna è anche Rita Romano,
giudice di Taranto
che è stata denunciata da Antonio Giangrande, lo scrittore autore di decine di
libri/inchieste, e da questa denunciato perchè lo scrittore ha chiesto la
ricusazione del giudice criticato per quei processi in cui questa giudice doveva
giudicarlo. La Romano ha condannato la sorella del Giangrande che si proclamava
estranea ad un sinistro di cui era accusata di essere responsabile esclusiva,
così come nei fatti è emerso, e per questo la sorella del Giangrande aveva
denunciato l'avvocato, che aveva promosso i giudizi di risarcimento danni.
Avvocato, molto amica di un pubblico ministero del Foro. La Romano ha condannato
chi si professava innocente e rinviato gli atti per falsa testimonianza per la
sua testimone.
E poi giudice donna è per il
processo………
E dire che la Nicole Minetti
ebbe a dire «Ovvio che avrei preferito evitarlo, ma visto che ci sarà sono certa
che riuscirò a chiarire la mia posizione e a dimostrare la mia innocenza. Da
donna mi auguro che a giudicarmi sia un collegio di donne o per lo meno a
maggioranza femminile». Perché, non si fida degli uomini? «Le donne
riuscirebbero a capire di più la mia estraneità ai fatti. Le donne hanno una
sensibilità diversa».
Quello che appare accomunare
tutte queste donne giudice è, senza fini diffamatori, che non sono donne
normali, ma sono donne in carriera. Il lavoro, innanzi tutto, la famiglia è un
bisogno eventuale. E senza famiglia esse sono. Solo la carriera per esse vale e
le condanne sono una funzione ausiliare e necessaria, altrimenti che ci stanno a
fare: per assolvere?!?
Ma quanti sono le giudici
donna? A
questa domanda risponde Gabriella Luccioli dal sito Donne Magistrato. La
presenza delle donne nella Magistratura Italiana.
L'ammissione delle donne
all'esercizio delle funzioni giurisdizionali in Italia ha segnato il traguardo
di un cammino lungo e pieno di ostacoli. Come è noto, l'art. 7 della legge 17
luglio 1919 n. 1176 ammetteva le donne all'esercizio delle professioni ed agli
impieghi pubblici, ma le escludeva espressamente dall'esercizio della
giurisdizione. L'art. 8 dell'ordinamento giudiziario del 1941 poneva quali
requisiti per accedere alle funzioni giudiziarie “essere cittadino italiano, di
razza ariana, di sesso maschile ed iscritto al P.N.F.". Pochi anni dopo, il
dibattito in seno all’Assemblea Costituente circa l’accesso delle donne alla
magistratura fu ampio e vivace ed in numerosi interventi chiaramente rivelatore
delle antiche paure che la figura della donna magistrato continuava a suscitare:
da voci autorevoli si sostenne che “nella donna prevale il sentimento sul
raziocinio, mentre nella funzione del giudice deve prevalere il raziocinio sul
sentimento” (on. Cappi); che “ soprattutto per i motivi addotti dalla scuola di
Charcot riguardanti il complesso anatomo-fisiologico la donna non può giudicare”
(on. Codacci); si ebbe inoltre cura di precisare che “non si intende affermare
una inferiorità nella donna; però da studi specifici sulla funzione
intellettuale in rapporto alle necessità fisiologiche dell’uomo e della donna
risultano certe diversità, specialmente in determinati periodi della vita
femminile” (on. Molè). Più articolate furono le dichiarazioni dell’onorevole
Leone, il quale affermò: “Si ritiene che la partecipazione illimitata delle
donne alla funzione giurisdizionale non sia per ora da ammettersi. Che la donna
possa partecipare con profitto là dove può far sentire le qualità che le
derivano dalla sua sensibilità e dalla sua femminilità, non può essere negato.
Ma negli alti gradi della magistratura, dove bisogna arrivare alla rarefazione
del tecnicismo, è da ritenere che solo gli uomini possono mantenere
quell’equilibrio di preparazione che più corrisponde per tradizione a queste
funzioni”; e che pertanto alle donne poteva essere consentito giudicare soltanto
in quei procedimenti per i quali era maggiormente avvertita la necessità di una
presenza femminile, in quanto richiedevano un giudizio il più possibile conforme
alla coscienza popolare. Si scelse infine di mantenere il silenzio sulla
specifica questione della partecipazione delle donne alle funzioni
giurisdizionali, stabilendo all’art. 51 che “tutti i cittadini dell’uno e
dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”. Si intendeva in tal
modo consentire al legislatore ordinario di prevedere il genere maschile tra i
requisiti per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali, in deroga al principio
dell’eguaglianza tra i sessi, e ciò ritardò fortemente l’ingresso delle donne in
magistratura. Solo con la legge 27 dicembre 1956 n. 1441 fu permesso alle donne
di far parte nei collegi di corte di assise, con la precisazione che almeno tre
giudici dovessero essere uomini. La legittimità costituzionale di tale
disposizione fu riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 56
del 1958, nella quale si affermò che ben poteva la legge “ tener conto,
nell’interesse dei pubblici servizi, delle differenti attitudini proprie degli
appartenenti a ciascun sesso, purchè non fosse infranto il canone fondamentale
dell’eguaglianza giuridica”. Fu necessario aspettare quindici anni dall’entrata
in vigore della Carta fondamentale perchè il Parlamento - peraltro direttamente
sollecitato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 33 del 1960, che aveva
dichiarato parzialmente illegittimo il richiamato art. 7 della legge n. 1176 del
1919, nella parte in cui escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che
implicavano l’esercizio di diritti e di potestà politiche - approvasse una
normativa specifica, la legge n. 66 del 9 febbraio 1963, che consentì l' accesso
delle donne a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la
magistratura. Dall'entrata in vigore della Costituzione si erano svolti ben
sedici concorsi per uditore giudiziario, con un totale di 3127 vincitori, dai
quali le donne erano state indebitamente escluse. Con decreto ministeriale del 3
maggio 1963 fu bandito il primo concorso aperto alla partecipazione delle donne:
otto di loro risultarono vincitrici e con d.m. 5 aprile del 1965 entrarono nel
ruolo della magistratura. Da quel primo concorso l’accesso delle donne
nell’ordine giudiziario ha registrato nel primo periodo dimensioni modeste, pari
ad una media del 4% -5% per ogni concorso, per aumentare progressivamente
intorno al 10% -20%“ dopo gli anni ’70, al 30% - 40% negli anni ’80 e registrare
un’impennata negli anni successivi, sino a superare ormai da tempo ampiamente la
metà. Attualmente le donne presenti in magistratura sono 3788, per una
percentuale superiore al 40% del totale, e ben presto costituiranno
maggioranza, se continuerà il trend che vede le donne vincitrici di
concorso in numero di gran lunga superiore a quello degli uomini. Come è
evidente, tale fenomeno è reso possibile dal regime di assunzione per concorso
pubblico, tale da escludere qualsiasi forma di discriminazione di genere; esso è
inoltre alimentato dalla presenza sempre più marcata delle studentesse nelle
facoltà di giurisprudenza, superiore a quello degli uomini. Dal primo concorso
ad oggi il profilo professionale delle donne magistrato è certamente cambiato.
Alle prime generazioni fu inevitabile, almeno inizialmente, omologare totalmente
il proprio ideale di giudice all’unico modello professionale di riferimento ed
integrarsi in quel sistema declinato unicamente al maschile attraverso un
processo di completa imitazione ed introiezione di tale modello, quale passaggio
necessario per ottenere una piena legittimazione. Ma ben presto, una volta
pagato per intero il prezzo della loro ammissione, superando la prova che
si richiedeva loro di essere brave quanto gli uomini, efficienti quanto gli
uomini, simili il più possibile agli uomini, e spesso vivendo in modo
colpevolizzante i tempi della gravidanza e della maternità come tempi sottratti
all’attività professionale, si pose alle donne magistrato il dilemma se
continuare in una assunzione totale del modello dato, di per sé immune da rischi
e collaudata da anni di conquistate gratificazioni, o tentare il recupero di una
identità complessa, tracciando un approccio al lavoro, uno stile, un
linguaggio, delle regole comportamentali sulle quali costruire una figura
professionale di magistrato al femminile.
Certo che a parlar male di
loro si rischia grosso. Ma i giornalisti questo coraggio ce l’hanno?
Certo che no! Per fare vero
giornalismo forse è meglio non essere giornalisti.
PARLIAMO DEI BRAVI CHE NON
POSSONO ESERCITARE, EPPURE ESERCITANO.
Questa è “Mi-Jena Gabanelli”
(secondo Dagospia), la Giovanna D’Arco di Rai3, che i grillini volevano al
Quirinale. Milena Gabanelli intervistata da Gian
Antonio Stella per "Sette - Corriere della Sera".
Sei impegnata da anni nella denuncia delle
storture degli ordini professionali: cosa pensi dell'idea di Grillo di abolire
solo quello dei giornalisti?
«Mi fa un po' sorridere. Credo
che impareranno che esistono altri ordini non meno assurdi. Detto questo, fatico
a vedere l'utilità dell'Ordine dei giornalisti. Credo sarebbe più utile, come da
altre parti, un'associazione seria e rigorosa nella quale si entra per quello
che fai e non tanto per aver dato un esame...».
Ti pesa ancora la bocciatura?
«Vedi un po' tu. L'ho fatto
assieme ai miei allievi della scuola di giornalismo. Loro sono passati, io no».
Bocciata agli orali per una domanda su
Pannunzio.
«Non solo. Avrò risposto a tre
domande su dieci. Un disastro. Mi chiesero cos'era il Coreco. Scena muta».
Come certi parlamentari beccati dalle Iene
fuori da Montecitorio...
«Le Iene fanno domande più
serie. Tipo qual è la capitale della Libia. Il Coreco!».
Essere bocciata come Alberto Moravia
dovrebbe consolarti.
«C'era una giovane praticante
che faceva lo stage da noi. Le avevo corretto la tesina... Lei passò, io no.
Passarono tutti, io no».
Mai più rifatto?
«No. Mi vergognavo. Per fare
gli orali dovevi mandare a memoria l'Abruzzo e io lavorando il tempo non
l'avevo».
Nel senso del libro di Franco Abruzzo,
giusto?
«Non so se c'è ancora quello.
So che era un tomo che dovevi mandare a memoria per sapere tutto di cose che
quando ti servono le vai a vedere volta per volta. Non ha senso. Ho pensato che
si può sopravvivere lo stesso, anche senza essere professionista».
Tornando al caso Ruby, logica
vorrebbe che chi ha avuto la fortuna nella vita di fare tanti soldi dovrebbe
sistemare innanzi tutto i propri figli. Fatto ciò, dovrebbe divertirsi e godersi
la vita e se, altruista, fare beneficenza.
Bene. L’assurdità di un modo
di ragionare sinistroide ed invidioso, perverso e squilibrato, pretenderebbe (e
di fatto fa di tutto per attuarlo) che per i ricchi dovrebbe valere la
redistribuzione forzosa della loro ricchezza agli altri (meglio se sinistri) e
se a questo vi si accomuna un certo tipo di divertimento, allora vi è
meretricio. In questo caso non opera più la beneficenza volontaria, ma scatta
l’espropriazione proletaria.
Una cosa è certa. In questa
Italia di m….. le tasse aumentano, cosi come le sanguisughe. I disservizi e le
ingiustizie furoreggiano. Ma allora dove cazzo vanno a finire i nostri soldi se
è vero, come è vero, che sono ancora di più gli italiani che oltre essere
vilipesi, muoiono di fame? Aumenta in un anno l’incidenza della povertà assoluta
in Italia. Come certifica l’Istat, le persone in povertà assoluta passano dal
5,7% della popolazione del 2011 all’8% del 2012, un record dal 2005. È quanto
rileva il report «La povertà in Italia», secondo cui nel nostro Paese sono 9
milioni 563 mila le persone in povertà relativa, pari al 15,8% della
popolazione. Di questi, 4 milioni e 814 mila (8%) sono i poveri assoluti, cioè
che non riescono ad acquistare beni e servizi essenziali per una vita dignitosa.
Una situazione accentuata soprattutto al Sud. Nel 2012 infatti quasi la metà dei
poveri assoluti (2 milioni 347 mila persone) risiede nel Mezzogiorno. Erano 1
milione 828 mila nel 2011.
Ed è con questo stato di cose
che ci troviamo a confrontarci quotidianamente. Ed a tutto questo certo non
corrisponde un Stato efficace ed efficiente, così come ampiamente dimostrato.
Anzi nonostante il costo del suo mantenimento questo Stato si dimostra incapace
ed inadeguato.
Eppure ad una mancanza di
servizi corrisponde una Spesa pubblica raddoppiata.
E tasse locali che schizzano all'insù. Negli ultimi venti anni le imposte
riconducibili alle amministrazioni locali sono aumentate da 18 a 108 miliardi di
euro, «con un eccezionale incremento di oltre il 500% ». È quanto emerge da uno
studio della Confcommercio in collaborazione con il Cer (Centro Europa Ricerche)
che analizza le dinamiche legate al federalismo fiscale a partire dal 1992. È
uno studio del Corriere della Sera a riportare al centro del dibattito la
questione delle tasse locali e della pressione fiscale sugli italiani. Con una
interessante intervista a Luca Antonini, presidente della Commissione sul
federalismo fiscale e poi alla guida del Dipartimento delle Riforme di Palazzo
Chigi, si mettono in luce le contraddizioni e il peso di “un sistema
ingestibile”: “Cresce la spesa statale e cresce la spesa locale, crescono le
tasse nazionali (+95% in 20 anni secondo Confcommercio) e crescono quelle locali
(+500%). Così non può funzionare. Non c'è una regia, manca completamente il
ruolo di coordinamento dello Stato”. Sempre dal 1992 la spesa corrente delle
amministrazioni centrali (Stato e altri enti) è cresciuta del 53%. La spesa di
regioni, province e comuni del 126% e quella degli enti previdenziali del 127%:
il risultato è che la spesa pubblica complessiva è raddoppiata. «Per
fronteggiare questa dinamica - sottolinea il dossier - si è assistito ad una
esplosione del gettito derivante dalle imposte (dirette e indirette) a livello
locale con un aumento del 500% a cui si è associato il sostanziale raddoppio a
livello centrale. I cittadini si aspettavano uno Stato più efficiente, una
riduzione degli sprechi, maggior responsabilità politica dagli amministratori
locali. Non certo di veder aumentare le tasse pagate allo Stato e pure quelle
versate al Comune, alla Provincia e alla Regione. E invece è successo proprio
così: negli ultimi vent'anni le imposte nazionali sono raddoppiate, e i tributi
locali sono aumentati addirittura cinque volte. Letteralmente esplosi. Tanto che
negli ultimi dodici anni le addizionali Irpef regionali e comunali sono
cresciute del 573%, ed il loro peso sui redditi è triplicato, arrivando in
alcuni casi oltre il 17%.
Nonostante che i Papponi di
Stato, centrali e periferici, siano mantenuti dai tartassati ecco che è
clamorosa l'ennesima uscita dell'assessore Franco D'Alfonso, lo stesso che
voleva proibire i gelati dopo mezzanotte ricoprendo Milano di ridicolo e che si
è ripetuto in versione giacobina accusando Dolce e Gabbana di evasione fiscale a
iter giudiziario non ancora concluso. Provocando i tre giorni di serrata dei
nove negozi D&G di Milano. E a chi avesse solo immaginato la possibilità di
rinnegarlo, il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia fa subito capire che il suo
vero bersaglio non è D'Alfonso e il suo calpestare il più elementare stato di
diritto, ma gli stilisti offesi. «Che c'entra “Milano fai schifo”? Sono molte -
va all'attacco un durissimo Pisapia - le cose che fanno schifo, ma non ho mai
visto chiudere i loro negozi per le stragi, le guerre, le ingiustizie».
Ricordando che il fisco, le sue regole e le sanzioni contro le infrazioni, non
sono materia di competenza del Comune. Giusto. Perché in quella Babilonia che è
diventata il Comune tra registri per le coppie omosessuali, no-global che
occupano e rom a cui rimborsare le case costruite abusivamente, nulla succede
per caso. Intanto, però, i negozi, i ristoranti, i bar e l'edicola di Dolce e
Gabbana sono rimasti chiusi per giorni. In protesta contro le indagini della Gdf
e le sentenze di condanna in primo grado del Tribunale, dopo le dichiarazioni
dell'assessore al Commercio, Franco D'Alfonso, sul non «concedere spazi pubblici
a marchi condannati per evasione». «Spazi mai richiesti», secondo i due
stilisti, che con l'ennesimo tweet hanno rilanciato la campagna contro il
Comune.
Uomini trattati da animali dai perbenisti
di maniera. Politici inetti, incapaci ed ipocriti che si danno alla zoologia.
Anatra
– Alla politica interessa solo se è zoppa. Una maggioranza senza maggioranza.
Asino
– Simbolo dei democrat Usa. In Italia ci provò Prodi con risultati scarsi.
Balena
– La b. bianca fu la Dc. La sua estremità posteriore è rimasta destinazione da
augurio.
Caimano
– Tra le definizioni correnti di Berlusconi. Dovuto a un profetico film di Nanni
Moretti.
Cignalum
– Sistema elettorale toscano da cui, per involuzione, nacque il porcellum
(v.).
Cimice
– Di provenienza statunitense, di recente pare abbia invaso l’Europa.
Colomba
– Le componenti più disponibili al dialogo con gli avversari. Volatili.
Coccodrillo
– Chi piange sul latte versato. Anche articolo di commemorazione redatto
pre-mortem.
Delfino
– Destinato alla successione. Spesso è un mistero: a oggi non si sa chi sia il
d. del caimano (v.).
Elefante
– Simbolo dei republican Usa. L’e. rosso fu il Pci. La politica si muove “Come
un e. in una cristalleria”.
Falco
– Le componenti meno disponibili al dialogo con gli avversari. Amano le
picchiate.
Gambero
– Il suo passo viene evocato quando si parla della nostra economia.
Gattopardo
– Da Tomasi di Lampedusa in poi segno dell’immutabilità della politica. Sempre
attuale.
Giaguaro
– Ci fu un tentativo di smacchiarlo. Con esiti assai deludenti.
Grillo
– Il primo fu quello di Pinocchio. L’attuale, però, dice molte più parolacce.
Gufo
– Uno che spera che non
vincano né i falchi né le colombe.
Orango
– L’inventore del Porcellum (vedi Roberto Calderoli Cecile Kyenge) ne
ha fatto un uso ributtante confermandosi uomo bestiale.
Piccione
– Di recente evocato per sé, come obiettivo di tiro libero, da chi disprezzò il tacchino
(v.).
Porcellum
– Una porcata di sistema elettorale che tutti vogliono abolire, ma è sempre lì.
Pitonessa
– Coniato specificatamente per Daniela Santanchè. Sinuosa e infida, direi.
Struzzo
- Chi non vuol vedere e mette
la testa nella sabbia. Un esercito.
Tacchino
– Immaginato su un tetto da Bersani, rischiò di eclissare il giaguaro.
Tartaruga
– La t. un tempo fu un animale che correva a testa in giù. Ora dà il passo alla
ripresa.
Ed a proposito di
ingiustizia e “canili umani”.
La presidente della Camera, Laura Boldrini, il 22 luglio 2013 durante la visita
ai detenuti del carcere di Regina Coeli, ha detto: «Il sovraffollamento delle
carceri non è più tollerabile, spero che Governo e Parlamento possano dare una
risposta di dignità ai detenuti e a chi lavora. Ritengo che sia importante
tenere alta l’attenzione sull’emergenza carceri e sono qui proprio per dare
attenzione a questo tema, la situazione delle carceri è la cartina di tornasole
del livello di civiltà di un Paese. La certezza del diritto è fondamentale: chi
ha sbagliato deve pagare, non chiediamo sconti, ma è giusto che chi entra in
carcere possa uscire migliore, è giusto che ci sia la rieducazione e in una
situazione di sovraffollamento è difficile rieducare perché non si fa altro che
tirare fuori il peggio dell’essere umano e non il meglio. Nel codice non c’è
scritto che un’ulteriore pena debba essere quella del sovraffollamento.
Costruire nuove strutture è complicato perché non ci sono risorse ma in alcuni
carceri ci sono padiglioni non utilizzati e con un po’ di fondi sarebbe
possibile renderli agibili. In più bisogna mettere in atto misure alternative e
considerare le misure di custodia cautelare perché il 40% dei detenuti non ha
una condanna definitiva. Bisogna ripensare, rivedere il sistema di custodia
cautelare. Perché se quelle persone sono innocenti, il danno è irreparabile».
«Dignità, dignità». Applaudono e urlano, i detenuti della terza sezione del
carcere di Regina Coeli quando vedono arrivare il presidente della Camera Laura
Boldrini, in visita ufficiale al carcere romano che ha una capienza di 725 unità
e ospita, invece, più di mille persone. Urlano i detenuti per invocare
«giustizia e libertà» che il sovraffollamento preclude non solo a loro, ma anche
agli agenti di polizia penitenziaria costretti a turni insostenibili (a volte
«c'è un solo agente per tre piani, per circa 250 detenuti» confessa un
dipendente). “Vogliamo giustizia, libertà e dignità”, sono queste invece le
parole che hanno intonato i detenuti durante la visita della Boldrini. I
detenuti nell'incontro con il presidente della Camera hanno voluto sottolineare
che cosa significa in concreto sovraffollamento: "Secondo la Corte europea di
Giustizia ", ha detto uno di loro "ogni detenuto ha diritto a otto metri quadri
di spazio, esclusi bagno e cucina. Noi abbiamo 17 metri quadri per tre detenuti,
in letti a castello con materassi di gomma piuma che si sbriciolano e portano
l'orma di migliaia di detenuti. Anche le strutture ricreative sono state ridotte
a luoghi di detenzione. Questo non è un carcere ma un magazzino di carne umana".
E' stata la seconda visita a un istituto carcerario italiano per Laura Boldrini
da quando è diventata presidente della Camera dei deputati. A Regina Coeli, dove
la capienza sarebbe di 725 detenuti, ve ne sono attualmente circa 1.050; le
guardie carcerarie sono 460 ma ne sarebbero previste 614. «Ho voluto fortemente
questo incontro, non avrebbe avuto senso la mia visita, sarebbe stata una farsa.
Ora mi sono resa conto di persona della situazione nelle celle e condivido la
vostra indignazione» ha replicato la Boldrini ai detenuti. Dici Roma, dici
Italia.
Già!! La giustizia e le
nostre vite in mano a chi?
«Antonio Di Pietro è il primo
a lasciare l'ufficio di Borrelli. È irriconoscibile. Cammina come un ubriaco,
quasi appoggiandosi ai muri». Così scrive Goffredo Buccini sul Corriere della
Sera del 24 luglio 1993, il giorno dopo il suicidio di Raul Gardini.
«Per me fu una sconfitta
terribile - racconta oggi Antonio Di Pietro ad Aldo Cazzullo su “Il Corriere
della Sera” -. La morte di Gardini è il vero, grande rammarico che conservo
della stagione di Mani pulite. Per due ragioni. La prima: quel 23 luglio Gardini
avrebbe dovuto raccontarmi tutto: a chi aveva consegnato il miliardo di lire che
aveva portato a Botteghe Oscure, sede del Pci; chi erano i giornalisti economici
corrotti, oltre a quelli già rivelati da Sama; e chi erano i beneficiari del
grosso della tangente Enimont, messo al sicuro nello Ior. La seconda ragione: io
Gardini lo potevo salvare. La sera del 22, poco prima di mezzanotte, i
carabinieri mi chiamarono a casa a Curno, per avvertirmi che Gardini era
arrivato nella sua casa di piazza Belgioioso a Milano e mi dissero: "Dottore che
facciamo, lo prendiamo?". Ma io avevo dato la mia parola agli avvocati che lui
sarebbe arrivato in Procura con le sue gambe, il mattino dopo. E dissi di
lasciar perdere. Se l'avessi fatto arrestare subito, sarebbe ancora qui con
noi».
Ma proprio questo è il
punto. Il «Moro di Venezia», il condottiero dell'Italia anni 80, il padrone
della chimica non avrebbe retto l'umiliazione del carcere. E molte cose lasciano
credere che non se la sarebbe cavata con un interrogatorio. Lei, Di Pietro,
Gardini l'avrebbe mandato a San Vittore?
«Le rispondo con il cuore in
mano: non lo so. Tutto sarebbe dipeso dalle sue parole: se mi raccontava
frottole, o se diceva la verità. Altre volte mi era successo di arrestare un
imprenditore e liberarlo in giornata, ad esempio Fabrizio Garampelli: mi sentii
male mentre lo interrogavo - un attacco di angina -, e fu lui a portarmi in
ospedale con il suo autista... Io comunque il 23 luglio 1993 ero preparato.
Avevo predisposto tutto e allertato la mia squadretta, a Milano e a Roma.
Lavoravo sia con i carabinieri, sia con i poliziotti, sia con la Guardia di
Finanza, pronti a verificare quel che diceva l'interrogato. Se faceva il nome di
qualcuno, prima che il suo avvocato potesse avvertirlo io gli mandavo le forze
dell'ordine a casa. Sarebbe stata una giornata decisiva per Mani pulite.
Purtroppo non è mai cominciata».
Partiamo dall'inizio. Il 20
luglio di vent'anni fa si suicida in carcere, con la testa in un sacchetto di
plastica, Gabriele Cagliari, presidente dell'Eni.
«L'Eni aveva costituito con la
Montedison di Gardini l'Enimont. Ma Gardini voleva comandare - è la
ricostruzione di Di Pietro -. Quando diceva "la chimica sono io", ne era davvero
convinto. E quando vide che i partiti non intendevano rinunciare alla mangiatoia
della petrolchimica pubblica, mamma del sistema tangentizio, lui si impuntò: "Io
vendo, ma il prezzo lo stabilisco io". Così Gardini chiese tremila miliardi, e
ne mise sul piatto 150 per la maxitangente. Cagliari però non era in carcere per
la nostra inchiesta, ma per l'inchiesta di De Pasquale su Eni-Sai. Non si
possono paragonare i due suicidi, perché non si possono paragonare i due
personaggi. Cagliari era un uomo che sputava nel piatto in cui aveva mangiato.
Gardini era un uomo che disprezzava e comprava, e disprezzava quel che comprava.
Il miliardo a Botteghe Oscure lo portò lui. Il suo autista Leo Porcari mi aveva
raccontato di averlo lasciato all'ingresso del quartier generale comunista, ma
non aveva saputo dirmi in quale ufficio era salito, se al secondo o al quarto
piano: me lo sarei fatto dire da Gardini. Ma era ancora più importante stabilire
chi avesse imboscato la maxitangente, probabilmente portando i soldi al sicuro
nello Ior. Avevamo ricostruito la destinazione di circa metà del bottino;
restavano da rintracciare 75 miliardi».
Chi li aveva presi?
«Qualcuno l'abbiamo trovato.
Ad esempio Arnaldo Forlani: non era certo Severino Citaristi a gestire simili
cifre. Non è vero che il segretario dc fu condannato perché non poteva non
sapere, e lo stesso vale per Bettino Craxi, che fu condannato per i conti in
Svizzera. Ma il grosso era finito allo Ior. Allora c'era il Caf».
Craxi. Forlani. E Giulio
Andreotti.
«Il vero capo la fa girare,
ma non la tocca. Noi eravamo arrivati a Vito Ciancimino, che era in carcere, e a
Salvo Lima, che era morto. A Palermo c'era già Giancarlo Caselli, tra le due
Procure nacque una stretta collaborazione, ci vedevamo regolarmente e per non
farci beccare l'appuntamento era a casa di Borrelli. Ingroia l'ho conosciuto
là».
Torniamo a Gardini. E al 23
luglio 1993.
«Con Francesco Greco avevamo
ottenuto l'arresto. Un gran lavoro di squadra. Io ero l'investigatore.
Piercamillo Davigo era il tecnico che dava una veste giuridica alle malefatte
che avevo scoperto: arrivavo nel suo ufficio, posavo i fascicoli sulla
scrivania, e gli dicevo in dipietrese: "Ho trovato quindici reati di porcata.
Ora tocca a te trovargli un nome". Gherardo Colombo, con la Guardia di Finanza,
si occupava dei riscontri al mio lavoro di sfondamento, rintracciava i conti
correnti, trovava il capello (sic) nell'uovo. Gli avvocati Giovanni Maria Flick
e Marco De Luca vennero a trattare il rientro di Gardini, che non era ancora
stato dichiarato latitante. Fissammo l'appuntamento per il 23, il mattino
presto». «Avevamo stabilito presidi a Ravenna, Roma, a Milano e allertato le
frontiere. E proprio da Milano, da piazza Belgioioso dove Gardini aveva casa, mi
arriva la telefonata: ci siamo, lui è lì. In teoria avrei dovuto ordinare ai
carabinieri di eseguire l'arresto. Gli avrei salvato la vita. Ma non volevo
venir meno alla parola data. Così rispondo di limitarsi a sorvegliare con
discrezione la casa. Il mattino del 23 prima delle 7 sono già a Palazzo di
Giustizia. Alle 8 e un quarto mi telefona uno degli avvocati, credo De Luca, per
avvertirmi che Gardini sta venendo da me, si sono appena sentiti. Ma poco dopo
arriva la chiamata del 113: "Gardini si è sparato in testa". Credo di essere
stato tra i primi a saperlo, prima anche dei suoi avvocati». «Mi precipito in
piazza Belgioioso, in cinque minuti sono già lì. Entro di corsa. Io ho fatto il
poliziotto, ne ho visti di cadaveri, ma quel mattino ero davvero sconvolto.
Gardini era sul letto, l'accappatoio insanguinato, il buco nella tempia».
E la pistola?
«Sul comodino. Ma solo perché
l'aveva raccolta il maggiordomo, dopo che era caduta per terra. Capii subito che
sarebbe partito il giallo dell'omicidio, già se ne sentiva mormorare nei
conciliaboli tra giornalisti e pure tra forze dell'ordine, e lo dissi fin
dall'inizio: nessun film, è tutto fin troppo chiaro. Ovviamente in quella casa
mi guardai attorno, cercai una lettera, un dettaglio rivelatore, qualcosa:
nulla».
Scusi Di Pietro, ma spettava a
lei indagare sulla morte di Gardini?
«Per carità, Borrelli affidò
correttamente l'inchiesta al sostituto di turno, non ricordo neppure chi fosse,
ma insomma un'idea me la sono fatta...».
Quale?
«Fu un suicidio d'istinto. Un
moto d'impeto, non preordinato. Coerente con il personaggio, che era lucido,
razionale, coraggioso. Con il pelo sullo stomaco; ma uomo vero. Si serviva di
Tangentopoli, che in fondo però gli faceva schifo. La sua morte per me fu un
colpo duro e anche un coitus interruptus».
Di Pietro, c'è di mezzo la
vita di un uomo.
«Capisco, non volevo essere
inopportuno. È che l'interrogatorio di Gardini sarebbe stato una svolta, per
l'inchiesta e per la storia d'Italia. Tutte le altre volte che nei mesi
successivi sono arrivato vicino alla verità, è sempre successo qualcosa, sono
sempre riusciti a fermarmi. L'anno dopo, era il 4 ottobre, aspettavo le carte
decisive dalla Svizzera, dal giudice Crochet di Ginevra: non sono mai arrivate.
Poi mi bloccarono con i dossier, quando ero arrivato sulla soglia dell'istituto
pontificio...».
Ancora i dossier?
«Vada a leggersi la relazione
del Copasir relativa al 1995: contro di me lavoravano in tanti, dal capo della
polizia Parisi a Craxi».
Lei in morte di Gardini
disse: «Nessuno potrà più aprire bocca, non si potrà più dire che gli imputati
si ammazzano perché li teniamo in carcere sperando che parlino».
«Può darsi che abbia detto
davvero così. Erano giornate calde. Ma il punto lo riconfermo: non è vero, come
si diceva già allora, che arrestavamo gli inquisiti per farli parlare. Quando
arrestavamo qualcuno sapevamo già tutto, avevamo già trovato i soldi. E avevamo
la fila di imprenditori disposti a parlare».
Altri capitani d'industria
hanno avuto un trattamento diverso.
«Carlo De Benedetti e Cesare
Romiti si assunsero le loro responsabilità. Di loro si occuparono la Procura di
Roma e quella di Torino. Non ci furono favoritismi né persecuzioni. Purtroppo,
nella vicenda di Gardini non ci furono neanche vincitori; quel giorno abbiamo
perso tutti».
Dopo 20 anni Di Pietro è
senza: pudore: «Avrei potuto salvarlo». Mani Pulite riscritta per
autoassolversi. L'ex pm: "Avrei dovuto arrestarlo e lui avrebbe parlato delle
mazzette al Pci". La ferita brucia ancora. Vent'anni fa Antonio Di Pietro,
allora l'invincibile Napoleone di Mani pulite, si fermò sulla porta di Botteghe
Oscure e il filo delle tangenti rosse si spezzò con i suoi misteri, scrive
Stefano Zurlo su “Il Giornale”.
Per questo, forse per trovare una spiegazione che in realtà spiega solo in
parte, l'ex pm racconta che il suicidio di Raul Gardini, avvenuto il 23 luglio
'93 a Milano, fu un colpo mortale per quell'indagine. «La sua morte - racconta
Di Pietro ad Aldo Cazzullo in un colloquio pubblicato ieri dal Corriere della
Sera - fu per me un coitus interruptus». Il dipietrese s'imbarbarisce ancora di
più al cospetto di chi non c'è più, ma non è questo il punto. È che l'ormai ex
leader dell'Italia dei Valori si autoassolve a buon mercato e non analizza con
la dovuta brutalità il fallimento di un'inchiesta che andò a sbattere contro
tanti ostacoli. Compresa l'emarginazione del pm Tiziana Parenti, titolare di
quel filone. E non s'infranse solo sulla tragedia di piazza Belgioioso. Di
Pietro, come è nel suo stile, semplifica e fornisce un quadro in cui lui e il
Pool non hanno alcuna responsabilità, diretta o indiretta, per quel fiasco.
Tutto finì invece con quei colpi di pistola: «Quel 23 luglio Gardini avrebbe
dovuto raccontarmi tutto: a chi aveva consegnato il miliardo di lire che aveva
portato a Botteghe Oscure, sede del Pci; chi erano i giornalisti economici
corrotti, oltre a quelli già rivelati da Sama; e chi erano i beneficiari del
grosso della tangente Enimont, messo al sicuro nello Ior». E ancora, a proposito
di quel miliardo su cui tanto si è polemizzato in questi anni, specifica: «Il
suo autista Leo Porcari mi aveva raccontato di averlo lasciato all'ingresso del
quartier generale comunista, ma non aveva saputo dirmi in quale ufficio era
salito, se al secondo o al quarto piano: me lo sarei fatto dire da Gardini». Il
messaggio che arriva è chiaro: lui ha fatto tutto quel che poteva per scoprire i
destinatari di quel contributo illegale, sulla cui esistenza non c'è il minimo
dubbio, ma quel 23 luglio cambiò la storia di Mani pulite e in qualche modo
quella d'Italia e diventa una data spartiacque, come il 25 luglio 43. Vengono i
brividi, ma questa ricostruzione non può essere accettata acriticamente e
dovrebbero essere rivisti gli errori, e le incertezze dell'altrove insuperabile
Pool sulla strada del vecchio Pci. Non si può scaricare su chi non c'è più la
responsabilità di non aver scoperchiato quella Tangentopoli. Di Pietro invece se
la cava così, rammaricandosi solo di non aver fatto ammanettare il signore della
chimica italiana la sera prima, quando i carabinieri lo avvisarono che Gardini
era a casa, in piazza Belgioioso. «M avevo dato la mia parola agli avvocati che
lui sarebbe arrivato in procura con le sue gambe, il mattino dopo». Quello
fatale. «E dissi di lasciar perdere. Se l'avessi fatto arrestare subito sarebbe
ancora qui con noi. Io Gardini lo potevo salvare». La storia non si fa con i se.
E quella delle tangenti rosse è finita prima ancora di cominciare.
Pomicino: il pm Di Pietro
tentò di farmi incastrare Napolitano.
L'ex ministro Cirino Pomicino: "Inventando una confessione, cercò di spingermi a
denunciare una tangente all'attuale capo dello Stato, poi spiegò il trucco",
scrive Paolo
Bracalini su “Il Giornale”.
E mentre la truccatrice gli passa la spazzola sulla giacca, prima di entrare
nello studio tv di Agorà, 'o ministro ti sgancia la bomba: «Di Pietro mi chiese:
"È vero che Giorgio Napolitano ha ricevuto soldi da lei?". Io risposi che non
era vero, ma lui insisteva. "Guardi che c'è un testimone, un suo amico, che lo
ha confessato". "Se l'ha detto, ha detto una sciocchezza, perché non è vero"
risposi io. E infatti la confessione era finta, me lo rivelò lo stesso Di Pietro
poco dopo, un tranello per farmi dire che Napolitano aveva preso una tangente.
Ma si può gestire la giustizia con questi metodi? E badi bene che lì aveva
trovato uno come me, ma normalmente la gente ci metteva due minuti a dire quel
che volevano fargli dire". "In quegli anni le persone venivano arrestate,
dicevano delle sciocchezze, ammettevano qualsiasi cosa e il pm li faceva subito
uscire e procedeva col patteggiamento. Quando poi queste persone venivano
chiamate a testimoniare nel processo, contro il politico che avevano accusato,
potevano avvalersi della facoltà di non rispondere. E quindi restavano agli atti
le confessioni false fatte a tu per tu col pubblico ministero», aveva già
raccontato Pomicino in una lunga intervista video pubblicata sul suo blog
paolocirinopomicino.it. La stessa tesi falsa, cioè che Napolitano, allora
presidente della Camera, esponente Pds dell'ex area migliorista Pci, avesse
ricevuto dei fondi, per sé e per la sua corrente, col tramite dell'ex ministro
democristiano, Pomicino se la ritrovò davanti in un altro interrogatorio,
stavolta a Napoli. «Il pm era il dottor Quatrano (nel 2001 partecipò ad un
corteo no global e l'allora Guardasigilli Roberto Castelli promosse un'azione
disciplinare). Mi fece incontrare una persona amica, agli arresti, anche lì per
farmi dire che avevo dato a Napolitano e alla sua corrente delle risorse
finanziaria». La ragione di quel passaggio di soldi a Napolitano, mai
verificatosi ma da confermare a tutti i costi anche col tranello della finta
confessione di un amico (uno dei trucchi dell'ex poliziotto Di Pietro, "altre
volte dicevano che se parlavamo avremmo avuto un trattamento più mite"), per
Cirino Pomicino è tutta politica: «Obiettivo del disegno complessivo era far
fuori, dopo la Dc e il Psi, anche la componente amendoliana del Pci, quella più
filo-occidentale, più aperta al centrosinistra. Tenga presente che a Milano fu
arrestato Cervetti, anch'egli della componente migliorista di Giorgio
Napolitano, e fu accusata anche Barbara Pollastrini. Entrambi poi scagionati da
ogni accusa». I ricordi sono riemersi di colpo, richiamati dalle «corbellerie»
dette da Di Pietro al Corriere a proposito del suicidio di Raul Gardini,
vent'anni esatti fa (23 luglio 1993). «Sono allibito che il Corriere della Sera
dia spazio alle ricostruzioni false raccontate da Di Pietro. Ho anche mandato un
sms a De Bortoli, ma quel che gli ho scritto sono cose private. Di Pietro dice
che Gardini si uccise con un moto d'impeto, e che lui avrebbe potuto salvarlo
arrestandolo il giorno prima. Io credo che Gardini si sia ucciso per il motivo
opposto», forse perché era chiaro che di lì a poche ore sarebbe stato arrestato.
Anche Luigi Bisignani, l'«Uomo che sussurra ai potenti» (bestseller
Chiarelettere con Paolo Madron), braccio destro di Gardini alla Ferruzzi,
conferma questa lettura: «Raul Gardini si suicidò perché la procura aveva
promesso che la sua confessione serviva per non andare in carcere, ma invece
scoprì che l'avrebbero arrestato». Processo Enimont, la «madre di tutte le
tangenti», l'epicentro del terremoto Tangentopoli. «La storia di quella
cosiddetta maxitangente, che poi invece, come diceva Craxi, era una maxiballa, è
ancora tutta da scrivere. - Pomicino lo spiega meglio - Alla politica andarono
15 o 20 miliardi, ma c'erano 500 miliardi in fondi neri. Dove sono finiti? A chi
sono andati? E chi ha coperto queste persone in questi anni? In parte l'ho
ricostruito, con documenti che ho, sui fondi Eni finiti a personaggi all'interno
dell'Eni. Ma di questo non si parla mai, e invece si pubblicano false
ricostruzioni della morte tragica di Gardini».
Ieri come oggi la farsa
continua.
Dopo 5 anni arriva la sentenza
di primo grado: l'ex-governatore dell'Abruzzo Ottaviano del Turco
è stato condannato a 9 anni e 6 mesi di reclusione dal Tribunale collegiale di
Pescara nell'inchiesta riguardo le presunti tangenti nella sanità abruzzese.
L’ex ministro delle finanze ed ex segretario generale aggiunto della Cgil
all’epoca di Luciano Lama è accusato di associazione per
delinquere, corruzione, abuso, concussione, falso. Il pm aveva chiesto 12 anni.
Secondo la Procura di Pescara l’allora governatore avrebbe intascato 5 milioni
di euro da Vincenzo Maria Angelini, noto imprenditore della
sanità privata, all’epoca titolare della casa di cura Villa Pini.
«E' un processo che è nato da
una vicenda costruita dopo gli arresti, cioè senza prove -
attacca l'ex governatore dell'Abruzzo intervistato al Giornale Radio Rai
-. Hanno cercato disperatamente le prove per 4 anni e non le hanno
trovate e hanno dovuto ricorrere a una specie di teorema e con il teorema hanno
comminato condanne che non si usano più nemmeno per gli assassini, in questo
periodo. Io sono stato condannato esattamente a 20 anni di carcere come
Enzo Tortora». E a Repubblica ha poi affidato un
messaggio-shock: «Ho un tumore, ma voglio vivere per
dimostrare la mia innocenza».
Lunedì 22 luglio 2013, giorno
della sentenza, non si era fatto attendere il commento del legale di Del Turco,
Giandomenico Caiazza, che ha dichiarato: «Lasciamo
perdere se me lo aspettassi o no perchè questo richiederebbe ragionamenti un pò
troppo impegnativi. Diciamo che è una sentenza che condanna un protagonista
morale della vita politica istituzionale sindacale del nostro paese accusato di
aver incassato sei milioni e 250 mila euro a titolo di corruzione dei quali non
si è visto un solo euro. Quindi penso che sia un precedente assoluto nella
storia giudiziaria perchè si possono non trovare i soldi ma si trovano le tracce
dei soldi».
Nello specifico, Del Turco è
accusato insieme all’ex capogruppo del Pd alla Regione Camillo Cesarone
e a Lamberto Quarta, ex segretario generale
dell’ufficio di presidenza della Regione, di aver intascato mazzette per 5
milioni e 800mila euro. Per questa vicenda fu arrestato il 14 luglio 2008
insieme ad altre nove persone, tra le quali assessori e consiglieri regionali.
L’ex presidente finì in carcere a Sulmona (L'Aquila) per 28 giorni e trascorse
altri due mesi agli arresti domiciliari. A seguito dell’arresto, Del Turco il 17
luglio 2008 si dimise dalla carica di presidente della Regione e con una lettera
indirizzata all’allora segretario nazionale Walter Veltroni si
autosospese dal Pd, di cui era uno dei 45 saggi fondatori nonchè membro della
Direzione nazionale. Le dimissioni comportarono lo scioglimento del consiglio
regionale e il ritorno anticipato alle urne per i cittadini abruzzesi.
Del Turco condannato senza
prove. All'ex presidente dell'Abruzzo 9 anni e sei mesi per presunte tangenti
nella sanità. Ma le accuse non hanno riscontri: nessuna traccia delle mazzette
né dei passaggi di denaro, scrive Gian Marco Chiocci su “Il Giornale”. In
dubio pro reo. Nel dubbio - dicevano i latini - decidi a favore dell'imputato.
Duole dirlo, e non ce ne voglia il collegio giudicante del tribunale di Pescara,
ma la locuzione dei padri del diritto sembra sfilacciarsi nel processo all'ex
presidente della Regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco. Processo che in assenza
di prove certe s'è concluso come gli antichi si sarebbero ben guardati dal
concluderlo: con la condanna del principale imputato e dei suoi presunti sodali.
Qui non interessa riaprire il dibattito sulle sentenze da rispettare o
sull'assenza o meno di un giudice a Berlino. Si tratta più semplicemente di
capire se una persona - che su meri indizi è finita prima in cella e poi con la
vita politica e personale distrutta - di fronte a un processo per certi versi
surreale, contraddistintosi per la mancanza di riscontri documentali, possa
beccarsi, o no, una condanna pesantissima a nove anni e sei mesi (non nove mesi,
come ha detto erroneamente in aula il giudice). Noi crediamo di no. E vi
spieghiamo perché. In cinque anni nessuno ha avuto il piacere di toccare con
mano le «prove schiaccianti» a carico dell'ex governatore Pd di cui parlò, a
poche ore dalle manette, l'allora procuratore capo Trifuoggi. Un solo euro fuori
posto non è saltato fuori dai conti correnti dell'indagato eccellente, dei suoi
familiari o degli amici più stretti, nemmeno dopo centinaia di rogatorie
internazionali e proroghe d'indagini. E se non si sono trovati i soldi, nemmeno
s'è trovata una traccia piccola piccola di quei soldi. Quanto alle famose case
che Del Turco avrebbe acquistate coi denari delle tangenti (sei milioni di euro)
si è dimostrato al centesimo esser state in realtà acquistate con mutui, oppure
prima dei fatti contestati o ancora coi soldi delle liquidazioni o le vendite di
pezzi di famiglia. Non c'è un'intercettazione sospetta. Non un accertamento
schiacciante. Non è emerso niente di clamoroso al processo. Ma ciò non vuol dire
che per i pm non ci sia «niente» posto che nella requisitoria finale i
rappresentanti dell'accusa hanno spiegato come l'ex segretario della Cgil in
passato avesse ricoperto i ruoli di presidente della commissione parlamentare
Antimafia e di ministro dell'Economia, e dunque fosse a conoscenza dei «sistemi»
criminali utilizzati per occultare i quattrini oltre confine. Come dire: ecco
perché i soldi non si trovano (sic !). Per arrivare a un verdetto del genere i
giudici, e in origine i magistrati di Pescara (ieri assolutamente sereni prima
della sentenza, rinfrancati dalla presenza a sorpresa in aula del loro ex
procuratore capo) hanno creduto alle parole del re delle cliniche abruzzesi,
Vincenzo Maria Angelini, colpito dalla scure della giunta di centrosinistra che
tagliava fondi alla sanità privata, per il quale i carabinieri sollecitarono
(invano) l'arresto per tutta una serie di ragioni che sono poi emerse, e
deflagrate, in un procedimento parallelo: quello aperto non a Pescara bensì a
Chieti dove tal signore è sotto processo per bancarotta per aver distratto oltre
180 milioni di euro con operazioni spericolate, transazioni sospette, spese
compulsive per milioni e milioni in opere d'arte e beni di lusso. Distrazioni,
queste sì, riscontrate nel dettaglio dagli inquirenti teatini. Da qui il
sospetto, rimasto tale, che il super teste possa avere utilizzato per sé (vedi
Chieti) ciò che ha giurato (a Pescara) di avere passato ai politici. Nel «caso
Del Turco» alla mancanza di riscontri si è supplito con le sole dichiarazioni
dell'imprenditore, rivelatesi raramente precise e puntuali come dal dichiarante
di turno pretendeva un certo Giovanni Falcone. Angelini sostiene che prelevava
contanti solo per pagare i politici corrotti? Non è vero, prelevava di continuo
ingenti somme anche prima, e pure dopo le manette (vedi inchiesta di Chieti).
Angelini giura che andava a trovare Del Turco nella sua casa di Collelongo,
uscendo al casello autostradale di Aiello Celano? Non è vero, come dimostrano i
telepass, le testimonianze e le relazioni degli autisti, a quel casello l'auto
della sua azienda usciva prima e dopo evidentemente anche per altri motivi.
Angelini dice che ha incontrato Del Turco a casa il giorno x? Impossibile, quel
giorno si festeggiava il santo patrono e in casa i numerosi vertici
istituzionali non hanno memoria della gola profonda. Angelini porta la prova
della tangente mostrando una fotografia sfocata dove non si riconosce la persona
ritratta? In dibattimento la difesa ha fornito la prova che quella foto
risalirebbe ad almeno un anno prima, e così cresce il giallo del taroccamento.
Angelini corre a giustificarsi consegnando ai giudici il giaccone che indossava
quando passò la mazzetta nel 2007, e di lì a poco la casa produttrice della
giubba certifica che quel modello nel 2007 non esisteva proprio essendo stato
prodotto a far data 2011. Questo per sintetizzare, e per dire che le prove
portate da Angelini, che la difesa ribattezza «calunnie per vendetta», sono
tutt'altro che granitiche come una sana certezza del diritto imporrebbe. Se per
fatti di mafia si è arrivati a condannare senza prove ricorrendo alla
convergenza del molteplice (il fatto diventa provato se lo dicono più pentiti)
qui siamo decisamente oltre: basta uno, uno soltanto, e sei fregato. «Basta la
parola», recitava lo spot di un celebre lassativo. Nel dubbio, d'ora in poi, il
reo presunto è autorizzato a farsela sotto. Del Turco: "Ho un cancro, voglio
vivere per provare la mia innocenza". «Da tre mesi so di avere un tumore, da due
sono in chemioterapia. Domani andrò a Roma a chiedere al professor Mandelli di
darmi cinque anni di vita, cinque anni per dimostrare la mia innocenza e
riabilitare la giunta della Regione Abruzzo che ho guidato». A dichiararlo in
una intervista a Repubblica è Ottaviano Del Turco, condannato a nove anni e sei
mesi per presunte tangenti nella sanità privata abruzzese. «Mi hanno condannato
senza una prova applicando in maniera feroce il teorema Angelini, oggi in Italia
molti presidenti di corte sono ex pm che si portano dietro la cultura
accusatoria. Il risultato, spaventoso, sono nove anni e sei mesi basati sulle
parole di un bandito. Ho preso la stessa condanna di Tortora, e questo mi dà
sgomento». Il Pd? «Ha così paura dei giudici che non è neppure capace di
difendere un suo dirigente innocente», ha aggiunto Del Turco.
MA CHE CAZZO DI GIUSTIZIA
E’!?!?
Funziona alla grande, la
giustizia in Italia, scrive Marco Ventura su Panorama. Negli ultimi tempi
abbiamo assistito a punizioni esemplari, sentenze durissime nei confronti di
fior di criminali. Castighi detentivi inflitti da giudici inflessibili. Due
esempi per tutti. Il primo: Lele Mora e Emilio Fede condannati a 7 anni di
carcere e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici per aver “presentato”
Ruby a Silvio Berlusconi. Il secondo: Ottaviano Del Turco condannato a 9 anni e
6 mesi per le tangenti sulla sanità in Abruzzo, anche se i 6 milioni di mazzette
non sono mai stati trovati sui conti suoi o riconducibili a lui, e anche se il
suo grande accusatore ha dimostrato in diverse occasioni di non essere
attendibile nell’esibire “prove” contro l’ex governatore. In compenso, per
cinque imputati del processo sul naufragio della Costa Concordia (32 i morti,
più incalcolabili effetti economici, d’inquinamento ambientale e d’immagine
internazionale dell’Italia), sono state accettate le richieste di
patteggiamento. Risultato: a fronte di accuse come omicidio plurimo colposo e
lesioni colpose, ma anche procurato naufragio, i cinque ottengono condanne che
variano, a seconda delle responsabilità e dei reati contestati, da 1 anno e 8
mesi a 2 anni e 10 mesi. Tutto previsto dal codice. Tutto legale. Tutto
giuridicamente ineccepibile. Ma avverto un certo disagio se poi faccio
confronti. Se navigo nel web e scopro che mentre l’ex direttore del Tg4, Fede,
subisce la condanna a 7 anni di carcere per il caso Ruby, la stessa pena viene
inflitta a un tale che abusa della figlia di 8 anni e a un altro che, imbottito
di cocaina, travolge e uccide una diciottenne sulle strisce pedonali. E non
trovo altri colpevoli per crimini analoghi a quelli contestati a Fede a Milano,
né personaggi che abbiano pagato (o per i quali sia valsa la fatica di provare a
identificarli) per complicità nella pubblicazione di intercettazioni coperte da
segreto come qualcuno ben noto agli italiani, che di intercettazioni pubblicate
è vittima quasi ogni giorno. E temo pure che la percezione della pubblica
opinione sia molto distante dalla scala di gravità dei tribunali, almeno stando
a questi casi. Un anno e 8 mesi è un quarto della pena comminata a Fede. Ho
ancora nella mente, negli occhi, la scena della “Costa Concordia” coricata col
suo carico di morte per l’incosciente inchino al Giglio. E ricordo il massacro
dei media di tutto il mondo sull’Italietta di Schettino (l’unico per il quale
non ci sarà patteggiamento e che presumibilmente pagherà per intero le sue
colpe). Nei paesi anglosassoni con una tradizione marinara, colpe come quelle
emerse nella vicenda “Costa Concordia” sono trattate con la gravità che
meritano: la sicurezza è una priorità assoluta. Ciascuno di noi ha esperienza
diretta o indiretta di come funzioni la giustizia in Italia: della sua rapidità
o lentezza, della sua spietatezza o clemenza, dei suoi pesi e delle sue misure.
Une, doppie, trine. La lettera della legge e delle sentenze non combacia col
(buon) senso comune. Sarà un caso che la fiducia nelle toghe, in Italia, risulti
ai livelli più bassi delle classifiche mondiali?
Sul Foglio del del 24 luglio
2013 Massimo Bordin spiega bene che nel processo Del Turco la difesa ha
dimostrato che in determinati giorni citati dai pm nel capo d'accusa, l'ex
governatore abruzzese sicuramente non aveva potuto commettere il reato che gli
era imputato. "E' vero" risponde l'accusa. Vorrà dire che cambieremo la data"
Capito? Le date non corrispondono così le cambieranno, elementare. Perché Del
Turco è, nella loro formazione barbarica, colpevole a prescindere. E quindi quel
corpo lo vogliono, anche senza prove. Tutto per loro. Dunque, ecco a voi servita
"l'indipendenza della magistratura". A me avevano insegnato che per essere
indipendenti, bisogna prima esseri liberi. E per essere liberi, bisogna essere
soprattutto Responsabili. A questi giudici gli si potrebbe sicuramente
attribuire una certa inclinazione alla libertà, ma intesa come legittimazione a
delinquere. E' vero, Del Turco non sarà Tortora. Ma il comportamento da canaglie
di alcuni magistrati italiani - salvaguardato da sessant'anni da giornali e
apparati - continua e continuerà ad avere, nel tempo, lo stesso tanfo di sempre.
E che dire del Processo Mediaset. Un processo "assurdo e risibile", per di più
costato ai contribuenti "una ventina di milioni di euro". I conti, e le
valutazioni politiche, sono del Pdl che mette nero su bianco i motivi per cui
"in qualunque altra sede giudiziaria, a fronte di decisioni consimili si sarebbe
doverosamente ed immediatamente pervenuti ad una sentenza più che assolutoria.
Ma non a Milano". "Il 'processo diritti Mediaset', così convenzionalmente
denominato, è basato su una ipotesi accusatoria così assurda e risibile che in
presenza di giudici non totalmente appiattiti sull'accusa e "super partes",
sarebbe finito ancor prima di iniziare, con grande risparmio di tempo per i
magistrati e di denaro per i contribuenti", si legge nel documento politico
elaborato dal Pdl a proposito del processo "diritti Mediaset", "dopo una
approfondita analisi delle carte processuali". "Basti pensare - scrive ancora il
Pdl - che una sola delle molte inutili consulenze contabili ordinate dalla
Procura è costata ai cittadini quasi tre milioni di euro. Non è azzardato
ipotizzare che tra consulenze, rogatorie ed atti processuali questa vicenda sia
già costata allo Stato una ventina di milioni di euro".
Del Turco come Tortora.
Un punto di
vista (di sinistra) contro la condanna dell'ex governatore Del Turco. Il caso
Del Turco come il caso Tortora: Una condanna senza indizi né prove, scrive Piero
Sansonetti il 23 luglio 2013 su “Gli Altri. Il problema non è quello della
persecuzione politica o dell’accanimento. La persecuzione è lo spunto, ma il
problema è molto più grave: se la cosiddetta “Costituzione materiale” si
adatterà al metodo (chiamiamolo così) Del Turco-Minetti, la giustizia in Italia
cambierà tutte le sue caratteristiche, sostituendosi allo stato di diritto. E ci
rimetteranno decine di migliaia di persone. E saranno riempite le carceri di
persone innocenti. Non più per persecuzione ma per “burocrazia” ed eccesso di
potere. Il rischio è grandissimo perché, in qualche modo, prelude ad un salto di
civiltà. Con le sentenze contro Minetti e, neppure sette giorni dopo, contro Del
Turco, la magistratura ha maturato una svolta fondata su due pilastri: il primo
è la totale identificazione della magistratura giudicante con la magistratura
inquirente: tra le due magistrature si realizza una perfetta integrazione e
collaborazione (non solo non c’è separazione delle carriere ma viene stabilita
la unità e l’obbligo di lealtà e di collaborazione attiva); il secondo pilastro
è la cancellazione, anzi proprio lo sradicamento del principio di presunzione di
innocenza. Nel caso della Minetti (accusata di avere organizzato una festa e per
questo condannata a cinque anni di carcere) al processo mancavano, più che le
prove, il reato. E infatti i giudici, in assenza di delitti definibili
giuridicamente, sono ricorsi al “favoreggiamento”. L’hanno condannata per aver
“favorito” un festino. Nel caso di Del Turco il reato c’era, ma erano del tutto
assenti le prove, e anzi – cosa più grave – i pochi indizi racimolati si sono
rivelati falsi durante il processo. Non solo mancavano le prove, e persino gli
indizi, ma mancava il corpo del reato. In questi casi è difficile la condanna
anche in situazioni di dittatura. I giudici hanno deciso allora di usare questo
nuovo principio: è vero che non ci sono né prove né indizi a carico
dell’imputato, però la sua difesa ha mostrato solo indizi di innocenza e non una
prova regina. E hanno stabilito che non sono consentite “assoluzioni
indiziarie”, decidendo di conseguenza la condanna con una nuova formula:
insufficienza di prove a discolpa. Avete presenti quei processi americani nei
quali il giudice a un certo punto chiede ai giurati: “siete sicuri, oltre ogni
ragionevole dubbio, della colpevolezza dell’imputato?”. In America basta che un
solo giurato dica: “no, io un piccolo dubbio ce l’ho ancora…” e l’imputato è
assolto. Può essere condannato solo all’unanimità e senza il più piccolo dubbio.
Con Del Turco si è fatto al contrario: i giurati hanno stabilito che a qualcuno
(per esempio a Travaglio) poteva essere rimasto qualche ragionevole dubbio sulla
sua innocenza. E gli hanno rifilato 10 anni di carcere, come fecero una trentina
d’anni fa con Enzo Tortora. Con Tortora i Pm avevano lavorato sulla base di
indizi falsi o del tutto inventati. In appello Tortora fu assolto, il mondo
intero si indignò, ma i pubblici ministeri non ricevettero neppur una noticina
di censura e fecero delle grandi carrierone. Sarà così anche con Del Turco. Per
oggi dobbiamo però assistere allo spettacolo di uno dei protagonisti della
storia del movimento operaio e sindacale italiano condannato sulla base
esclusivamente dell’accusa di un imprenditore che probabilmente non aveva
ottenuto dalla Regione quello che voleva.
Toghe impunite e
fannullone: loro il problema della giustizia.
Le condanne abnormi sono ormai
quotidiane: da Tortora a Del Turco, è colpa dei magistrati. Ma non si può dire.
Su Libero di mercoledì 24 luglio il commento di Filippo Facci: "Toghe
impunite e fannullone. Così c'è un Del Turco al giorno". Secondo Facci le
condanne abnormi sono ormai quotidiane: dal caso Tortora a oggi il problema
giustizia, spiega, è colpa dei magistrati. Ma è vietato dirlo. I casi Del
Turco durano un giorno, ormai: scivolano subito in una noia mediatica che è
generazionale. La verità è che l’emergenza giustizia e l’emergenza magistrati
(ripetiamo: magistrati) non è mai stata così devastante: solo che a forza di
ripeterlo ci siamo sfibrati, e l’accecante faro del caso Berlusconi ha finito
per vanificare ogni battaglia. E’ inutile girarci attorno: in nessun paese
civile esiste una magistratura così, una casta così, una sacralità e
un’intangibilità così.
Accade, nelle carceri
italiani, che persone indagate per i reati più disparati vengano sbattute in
cella per obbligarle a vuotare il sacco. Accade anche che le chiavi che danno la
libertà vengano dimenticate in un cassetto per settimane, se non mesi. In barba
al principio di non colpevolezza fino al terzo grado di giudizio. Tanto che il
carcere preventivo diventa una vera e propria tortura ad uso e consumo
delle toghe politicizzate. Toghe che con tipi loschi come gli stupratori
si trasformano in specchiati esempi di garantismo. No alla custodia cautelare in
carcere per il reato di violenza sessuale di gruppo qualora il caso concreto
consenta di applicare misure alternative. Lo ha stabilito la Corte
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo
275, comma 3, terzo periodo, del Codice di procedura penale. I «gravi indizi di
colpevolezza». si legge nella motivazione, non rendono automatica la custodia in
carcere. La decisione segue quanto già stabilito in relazione ad altri reati,
tra cui il traffico di stupefacenti, l'omicidio, e delitti a sfondo sessuale e
in materia di immigrazione. La norma “bocciata” dalla Corte Costituzionale con
la sentenza n.232 depositata il 23 luglio 2013, relatore il giudice Giorgio
Lattanzi, prevede che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per il
delitto di violenza sessuale di gruppo si applica unicamente la custodia
cautelare in carcere. Ora la Consulta ha stabilito che, se in relazione al caso
concreto, emerga che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre
misure, il giudice può applicarle. Nella sentenza, peraltro, la Corte conferma
la gravità del reato, da considerare tra quelli più «odiosi e riprovevoli». Ma
la «più intensa lesione del bene della libertà sessuale», «non offre un
fondamento giustificativo costituzionalmente valido al regime cautelare speciale
previsto dalla norma censurata», scrive la Corte. Alla base del pronunciamento
una questione di legittimità sollevata dalla sezione riesame del Tribunale di
Salerno. Richiamando anche precedenti decisioni la Consulta ricorda in sentenza
come «la disciplina delle misure cautelari debba essere ispirata al criterio del
“minore sacrificio necessario”: la compressione della libertà personale deve
essere, pertanto, contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le
esigenze cautelari del caso concreto. Ciò impegna il legislatore, da una parte,
a strutturare il sistema cautelare secondo il modello della “pluralità
graduata”, predisponendo una gamma di misure alternative, connotate da
differenti gradi di incidenza sulla libertà personale, e, dall’altra, a
prefigurare criteri per scelte “individualizzanti” del trattamento cautelare,
parametrate sulle esigenze configurabili nelle singole fattispecie concrete».
Sul punto si era pronunciata analogamente la Corte di Cassazione nel 2012,
accogliendo il ricorso di due imputati per lo stupro subìto da una minorenne a
Cassino. Il Tribunale di Roma aveva confermato il carcere nell'agosto 2011, ma
la Cassazione motivò così la sua decisione: «L'unica interpretazione compatibile
con i principi fissati dalla sentenza 265 del 2010 della Corte Costituzionale è
quella che estende la possibilità per il giudice di applicare misure diverse
dalla custodia in carcere anche agli indagati sottoposti a misura cautelare per
il reato previsto all'art. 609 octies c.p.». In pratica recependo il dettato
della Consulta del 2010 e l'indicazione della Corte di Strasburgo.
Da questo si evince che la
Corte Costituzionale se ne infischia della violenza sessuale di gruppo. Oggi le
toghe hanno, infatti, deciso che gli stupratori non dovranno scontare la
custodia cautelare in carcere qualora il caso concreto consenta di applicare
misure alternative. Nessuna preoccupazione, da parte dei giudici
costituzionalisti, che le violenze possano essere reiterate. La beffa maggiore?
Nella sentenza, della Corte costituzionale le toghe si premurano di confermare
la gravità del reato invitando i giudici a considerarlo tra quelli più "odiosi e
riprovevoli". Non abbastanza - a quanto pare - per assicurarsi che lo stupratore
non commetta più la brutale violenza di cui si macchia. "La più intensa lesione
del bene della libertà sessuale - si legge nella sentenza shock redatta dalla
Corte - non offre un fondamento giustificativo costituzionalmente valido al
regime cautelare speciale previsto dalla norma censurata". Alla base del
pronunciamento della Consulta c'è una questione di legittimità sollevata dalla
sezione riesame del Tribunale di Salerno. Richiamando anche precedenti
decisioni, la Consulta ricorda come la disciplina delle misure cautelari
debba essere ispirata al criterio del "minore sacrificio necessario". Già nel
2010 la Corte aveva bocciato le norme in materia di misure cautelari nelle parti
in cui escludevano la facoltà del giudice di decidere se applicare la custodia
cautelare in carcere o un altro tipo di misura cautelare per chi ha abusato di
un minore. Insomma, adesso appare chiaro che il carcere preventivo sia una
misura "cautelare" pensata ad hoc per far fuori gli avversari politici.
Nemmeno per gli stupratori è più prevista.
Stupro, dalla parte dei
carnefici: niente carcere (per un po’) per il branco. Firmato: Corte
Costituzionale,
scrive Deborah Dirani su Vanity Fair. C’era una volta, 3 anni fa, a Cassino,
comune ciociaro di 33 mila anime (per la maggior parte buone), una ragazzina che
non aveva ancora compiuto 18 anni ed era molto graziosa. Sgambettava tra libri e
primi “ti amo” sussurrati all’orecchio del grande amore, e pensava che la vita
fosse bella. Pensava che il sole l’avrebbe sempre scaldata, che le avrebbe
illuminato la vita ogni giorno. Non pensava che il sole potesse scomparire, che
potesse tramontare e non tornare più a riscaldarle la pelle, a illuminarle la
vita. Ma un giorno, un giorno di 3 anni fa, il suo sole tramontò oscurato dal
buio di due ragazzi del suo paese, due che la volevano e, dato che con le buone
non erano riusciti a prenderla, quel giorno scuro decisero di ricordarle che la
donna è debole e l’uomo è forte. Così, quei due maschi del suo paese, la
stuprarono, assieme, dandosi il cambio, a turno. Lei non voleva, lei piangeva,
lottava, mordeva e graffiava con le sue unghie dipinte di smalto. Lei urlava, ci
provava, perché poi quelli erano in due e si ritrovava sempre con una mano sulla
bocca che la faceva tacere, che non la faceva respirare. Ma gli occhi quella
ragazzina li aveva aperti a cercare quelli di quei due, a chiedere pietà, a
scongiurarli di ritirarsi su i pantaloni, di uscire da lei, che le facevano
male, nel cuore, più ancora che tra le gambe. Raccontano che quella ragazzina
oggi non viva più nel suo paese, che quella notte sia scesa sulla sua vita e
ancora non l’abbia lasciata. Raccontano che non esca di casa, che soffra di
depressione e attacchi di panico. Raccontano che il suo buio sia denso come il
petrolio. Raccontano che sia come un cormorano con le ali zuppe di olio nero che
non può più volare. Raccontano anche che quando, a pochi mesi dal giorno
più brutto della sua vita, la Corte di Cassazione ha stabilito che i suoi due
stupratori non dovessero stare in custodia cautelare in carcere, ma potessero
(in attesa della sentenza definitiva) essere trattenuti ai domiciliari, lei
abbia pensato che Rino Gaetano non avesse mica ragione a cantare che il cielo è
sempre più blu. Secondo la Cassazione, la galera (prevista da una legge
approvata dal Parlamento nel 2009 che stabiliva che dovesse stare in carcere
chiunque avesse abusato di una minorenne) non era giusta per quei due bravi
figlioli perché quella stessa legge del 2009 violava gli articoli 3 (uguaglianza
davanti alla legge), 13 (libertà personale) e 27 (funzione rieducativa della
pena) della Costituzione. Secondo i giudici, insomma, ci sono misure alternative
al carcere (nella fattispecie gli arresti domiciliari) alle quali ricorrere in
casi come questo. Questo che, per la cronaca, è uno stupro di gruppo. I giorni
passano, la vita continua, le sentenze si susseguono e quella della Cassazione
apre un’autostrada a 4 corsie per chi, in compagnia di un paio di amici, prende
una donna le apre le gambe e la spacca a metà. Così la Corte Costituzionale, la
Suprema Corte, con una decisione barbara, incivile, retrograda, vigliacca,
pilatesca, giusto poche ore fa, ha dichiarato illegittimo l’articolo 275, comma
3, periodo terzo del Codice di Procedura Penale che prevede che gravi indizi di
colpevolezza rendano automatica la custodia cautelare in carcere per chi
commette il reato previsto all’articolo 609 octies del Codice Penale: lo stupro
di gruppo (niente carcere subito per chi violenta in gruppo, non importa, dice
la Corte Costituzionale). Fortuna che quella ragazzina, che lo stupro di gruppo
lo ha provato sulla sua luminosa pelle di adolescente, non può guardare in
faccia i giudici di quella che si chiama Suprema Corte che hanno sentenziato
che i suoi stupratori in galera non ci debbano andare (almeno fino al terzo
grado di giudizio), ma che possano beatamente starsene ai domiciliari. Che
possano evadere dai domiciliari (fossero i primi), possano prendere un’altra
ragazzina, un’altra donna, un’altra mamma, una vedova, una che comunque in mezzo
alle gambe ha un taglio e abusarne a turno, per ore, per giorni. Fino a quando
ne hanno voglia. E poi, ritirati su i pantaloni, possano tonarsene a casa, ai
domiciliari, che il carcere chissà se e quando lo vedranno. Bastardi, loro, e
chi non fa giustizia. Che una donna non è un pezzo di carne con un taglio tra le
gambe. Questa ragazzina non era quello che quei due maschi avevano visto in lei:
un pezzo di carne, giovane, con un taglio in cui entrare a forza. No, non era un
pezzo di carne, era un essere umano, e la Corte Costituzionale, la CORTE
COSTITUZIONALE, non un giudice qualunque oberato e distratto di carte e senza un
cancelliere solerte, ha certificato che il suo dolore non meritava nemmeno la
consolazione che si dovrebbe alle vittime, agli esseri umani umiliati e offesi.
Chi ha negato a questa giovane donna il diritto a credere nel sole della
giustizia non è in galera, oggi. Chi da oggi lo negherà a qualunque donna: a voi
che mi leggete, alle vostre figlie, mamme, nonne, sorelle, non andrà in galera.
Non ci andrà fino a quando l’ultimo grado di giudizio non avrà stabilito che sì,
in effetti, un po’ di maschi che tengono ferma una donna e che a turno le
entrano dentro al corpo e all’anima, sono responsabili del suo dolore, del buio
in cui l’hanno sepolta. E allora, voglio le parole della presidente della
Camera, del ministro per le Pari opportunità, voglio le parole di ogni donna: le
voglio sentire perché non serve essere femministe e professioniste delle
dichiarazioni per scendere in piazza, in tutte le piazze, e incazzarsi. Non ci
vuole sempre un capo del Governo antipatico e discutibile per fare scendere in
piazza noi donne. Perché: SE NON OGGI, QUANDO?
Bene, allora cari italiani:
TUTTI DENTRO, CAZZO!!
LA LEGGE NON E’ UGUALE PER
TUTTI.
Tutti dentro se la legge fosse
uguale per tutti. Ma la legge non è uguale per tutti. Così la Cassazione si è
tradita.
Sconcertante linea delle Sezioni unite civili sul caso di un magistrato
sanzionato. La Suprema Corte: vale il principio della discrezionalità. E le
toghe di Md si salvano, scrive
Stefano Zurlo su “Il
Giornale”. La legge è uguale per tutti. Ma non al tribunale dei giudici.
Vincenzo Barbieri, toga disinvolta, viene inchiodato dalle intercettazioni
telefoniche, ma le stesse intercettazioni vengono cestinate nel caso di Paolo
Mancuso, nome storico di Magistratura democratica. Eduardo Scardaccione, altro
attivista di Md, la corrente di sinistra delle toghe italiane, se la cava anche
se ha avuto la faccia tosta di inviare un pizzino al collega, prima
dell'udienza, per sponsorizzare il titolare di una clinica. Assolto pure lui,
mentre Domenico Iannelli, avvocato generale della Suprema corte, si vede
condannare per aver semplicemente sollecitato una sentenza attesa da quasi sette
anni. Sarà un caso ma il tribunale disciplinare funziona così: spesso i giudici
al di fuori delle logiche correntizie vengono incastrati senza pietà. Quelli che
invece hanno un curriculum sfavillante, magari a sinistra, magari dentro Md,
trovano una via d'uscita. Non solo. Quel che viene stabilito dalla Sezione
disciplinare del Csm trova facilmente sponda nel grado superiore, alle Sezioni
unite civili della Cassazione, scioglilingua chilometrico, come i titoli dei
film di Lina Wertmüller, per indicare la più prestigiosa delle corti. E proprio
le Sezioni unite civili della Cassazione, nei mesi scorsi, hanno teorizzato il
principio che sancisce la discrezionalità assoluta per i procedimenti
disciplinari: se un magistrato viene punito e l'altro no, si salva anche se la
mancanza è la stessa, pazienza. Il primo se ne dovrà fare una ragione. Testuale.
Così scrive l'autorevolissimo collegio guidato da Roberto Preden, dei Verdi,
l'altra corrente di sinistra della magistratura italiana, e composto da eminenti
giuristi come Renato Rordorf e Luigi Antonio Rovelli, di Md, e Antonio Segreto
di Unicost, la corrente di maggioranza, teoricamente centrista ma spesso
orientata a sua volta a sinistra. A lamentarsi è Vincenzo Brancato, giudice di
Lecce, incolpato per gravi ritardi nella stesura delle sentenze e di altri
provvedimenti. La Cassazione l'ha condannato e le sezioni unite civili
confermano ribadendo un principio choc: la legge non è uguale per tutti. O
meglio, va bene per gli altri, ma non per i giudici. Un collega di Lecce, fa
notare Brancato, ha avuto gli stessi addebiti ma alla fine è uscito indenne dal
processo disciplinare. Come mai? È tutto in regola, replica il tribunale di
secondo grado. «La contraddittorietà di motivazione - si legge nel verdetto del
25 gennaio 2013 - va colta solo all'interno della stessa sentenza e non dal
raffronto fra vari provvedimenti, per quanto dello stesso giudice». Chiaro? Si
può contestare il diverso trattamento solo se i due pesi e le due misure
convivono dentro lo stesso verdetto. Altrimenti ci si deve rassegnare. E poiché
Brancato e il collega più fortunato, valutato con mano leggera, sono
protagonisti di due sentenze diverse, il caso è chiuso. Senza se e senza ma: «Va
ribadito il principio già espresso da queste sezioni unite secondo cui il
ricorso avverso le pronunce della sezione disciplinare del Csm non può essere
rivolto a conseguire un sindacato sui poteri discrezionali di detta sezione
mediante la denuncia del vizio di eccesso di potere, attesa la natura
giurisdizionale e non amministrativa di tali pronunce». Tante teste, tante
sentenze. «Pertanto non può censurarsi il diverso metro di giudizio adottato
dalla sezione disciplinare del Csm nel proprio procedimento rispetto ad altro,
apparentemente identico, a carico di magistrato del medesimo ufficio
giudiziario, assolto dalla stessa incolpazione». Tradotto: i magistrati, nelle
loro pronunce, possono far pendere la bilancia dalla parte che vogliono. Il
principio è srotolato insieme a tutte le sue conseguenze e porta il timbro di
giuristi autorevolissimi, fra i più titolati d'Italia. È evidente che si tratta
di una massima sconcertante che rischia di creare figli e figliastri. È, anche,
sulla base di questo ragionamento che magistrati appartenenti alle correnti di
sinistra, in particolare Md, così come le toghe legate alle corporazioni più
strutturate, sono stati assolti mentre i loro colleghi senza reti di rapporti o
di amicizie sono stati colpiti in modo inflessibile. Peccato che questo
meccanismo vada contro la Convenzione dei diritti dell'uomo: «L'articolo 14
vieta di trattare in modo differente, salvo giustificazione ragionevole e
obiettiva, persone che si trovino in situazioni analoghe». Per i giudici
italiani, a quanto pare, questo criterio non è valido. Non solo. La stessa
Cassazione, sezione Lavoro, afferma che la bilancia dev'essere perfettamente in
equilibrio. Il caso è quello di due dipendenti Telecom che avevano usato il
cellulare aziendale per conversazioni private. Il primo viene licenziato, il
secondo no. E dunque quello che è stato spedito a casa si sente discriminato e
fa causa. La Cassazione gli dà ragione: «In presenza del medesimo illecito
disciplinare commesso da più dipendenti, la discrezionalità del datore di lavoro
non può trasformarsi in arbitrio, con la conseguenza che è fatto obbligo al
datore di lavoro di indicare le ragioni che lo inducono a ritenere grave il
comportamento illecito di un dipendente, tanto da giustificare il licenziamento,
mentre per altri dipendenti è applicata una sanzione diversa». Il metro
dev'essere sempre lo stesso. Ma non per i magistrati, sudditi di un potere
discrezionale che non è tenuto a spiegare le proprie scelte. La regola funziona
per i dipendenti Telecom, insomma, per i privati. Non per i magistrati e il loro
apparato di potere. La legge è uguale per tutti ma non tutti i magistrati sono
uguali davanti alla legge. La Legge che non sia uguale per tutti è pacifico.
Invece è poco palese la sua conoscenza, specie se in Italia è tutto questione di
famiglia. Famiglia presso cui si devono lavare i panni sporchi.
Quando anche per i comunisti è
tutto questione di famiglia.
Luigi Berlinguer (ex ministro
PD) è il cugino di Bianca Berlinguer (direttrice del Tg3 e figlia di Enrico) che
è sposata con Luigi Manconi (senatore PD, fondatore e presidente
dell’Associazione “A Buon Diritto”) che è cognato di Luca Telese (giornalista
La7 e Canale 5) che è marito di Laura Berlinguer (giornalista MEDIASET) che è
cugina di Sergio Berlinguer (consigliere di Stato), fratello di Luigi e cugino
di Enrico.
Bene, allora cari italiani:
TUTTI DENTRO, CAZZO??? QUASI TUTTI!!!!
ITALIA PAESE DELL’IMMUNITA’
E DELLA CENSURA. PER L’EUROPA INADEMPIENTE SU OGNI NORMA.
La Commissione europea, la
Corte Europea dei diritti dell’uomo e “Le Iene”, sputtanano. Anzi, “Le Iene”
no!!
E la stampa censura pure…..
Pensavo di averle viste tutte.
La Commissione Europea ha
aperto una procedura di infrazione contro l'Italia
perchè non adegua la sua normativa sulla responsabilità civile dei
giudici al diritto comunitario. Bruxelles si aspetta
che il governo nostrano estenda la casistica per i risarcimenti
"cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie". Casistica regolata da una
legge del 1988 e assai stretta: il legislatore prevede che le
toghe rispondano in prima persona solo in caso di dolo o colpa grave
nel compimento dell'errore giudiziario. Qual è il problema per l'Ue? Si chiede
“Libero Quotidiano”. Che i giudici italiani sono chiamati a pagare per i propri
errori in casi troppo ristretti, godendo di una normativa che non solo li
avvantaggia rispetto ad altri lavoratori e
professionisti italiani, ma anche rispetto ai propri colleghi
europei. La legge italiana 117/88 restringe la
responsabilità dei giudici ai soli casi di errore viziato da "dolo e colpa
grave". E, come se non fosse abbastanza, il legislatore assegna l'onere della
prova (ovvero la dimostrazione del dolo e della colpa del giudice) al
querelante che chiede risarcimento per il
danno subito. Per l'Ue troppo poco. La Commissione Ue chiede all'Italia
di conformarsi al diritto comunitario. Innanzitutto via l'onere della
dimostrazione del dolo e della colpa. E poi estensione della responsabilità del
giudice di ultima istanza anche ai casi di sbagliata interpretazione
delle leggi e di errata valutazione delle prove, anche
senza il presupposto della malevolezza della toga verso l'imputato. Anche per
colpa semplice, insomma. E, comunque, non pagano i giudici, paghiamo noi.
Inoltre su un altro punto è
intervenuta l’Europa. Condannare un giornalista alla prigione è una violazione
della libertà d’espressione, salvo casi eccezionali come incitamento alla
violenza o diffusione di discorsi razzisti. A stabilirlo, ancora una volta. è la
Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza in cui dà ragione a Maurizio
Belpietro, direttore di Libero, condannato a quattro anni dalla Corte d’Appello
di Milano.
La Convenzione e la Corte
europea dei diritti dell’uomo ampliano il diritto di cronaca (“dare e
ricevere notizie”) e proteggono il segreto professionale dei giornalisti. No
alle perquisizioni in redazione! Il giudice nazionale deve tener conto delle
sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo ai fini della decisione,
anche in corso di causa, con effetti immediati e assimilabili al giudicato: è
quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19985 del
30/9/2011.
Cedu. Decisione di Strasburgo.
Il diritto di cronaca va sempre salvato. Per i giudici l'interesse della
collettività all'informazione prevale anche quando la fonte siano carte
segretate, scrive Marina Castellaneta per Il Sole 24 Ore il 17/4/2012. La Corte
europea dei diritti dell'uomo pone un freno alle perquisizioni nei giornali e al
sequestro da parte delle autorità inquirenti dei supporti informatici dei
giornalisti. Con un preciso obiettivo. Salvaguardare il valore essenziale della
libertà di stampa anche quando sono pubblicate notizie attinte da documenti
coperti da segreto. Lo ha chiarito la Corte dei diritti dell'uomo nella sentenza
depositata il 12 aprile 2012 (Martin contro Francia) che indica i criteri ai
quali anche i giudici nazionali devono attenersi nella tutela del segreto
professionale dei giornalisti per non incorrere in una violazione della
Convenzione e in una condanna dello Stato. A Strasburgo si erano rivolti quattro
giornalisti di un quotidiano francese che avevano pubblicato un resoconto di
documenti della Corte dei conti che riportavano anomalie nell'amministrazione di
fondi pubblici compiute da un ex governatore regionale. Quest'ultimo aveva agito
contro i giornalisti sostenendo che era stato leso il suo diritto alla
presunzione d'innocenza anche perché erano stati pubblicati brani di documenti
secretati. Il giudice istruttore aveva ordinato una perquisizione nel giornale
con il sequestro di supporti informatici, agende e documenti annotati. Per i
giornalisti non vi era stato nulla da fare. Di qui il ricorso a Strasburgo che
invece ha dato ragione ai cronisti condannando la Francia per violazione del
diritto alla libertà di espressione (articolo 10 della Convenzione). Per la
Corte la protezione delle fonti dei giornalisti è una pietra angolare della
libertà di stampa. Le perquisizioni nel domicilio e nei giornali e il sequestro
di supporti informatici con l'obiettivo di provare a identificare la fonte che
viola il segreto professionale trasmettendo un documento ai giornalisti
compromettono la libertà di stampa. Anche perché il giornalista potrebbe essere
dissuaso dal fornire notizie scottanti di interesse della collettività per non
incorrere in indagini. È vero - osserva la Corte - che deve essere tutelata la
presunzione d'innocenza, ma i giornalisti devono informare la collettività. Poco
contano - dice la Corte - i mezzi con i quali i giornalisti si procurano le
notizie perché questo rientra nella libertà di indagine che è inerente allo
svolgimento della professione. D'altra parte, i giornalisti avevano rispettato
le regole deontologiche precisando che i fatti riportati erano ricavati da un
rapporto non definitivo. Giusto, quindi, far conoscere al pubblico le
informazioni in proprio possesso sulla gestione di fondi pubblici.
Ed ancora. La Corte europea
dei diritti dell’Uomo ha accolto il ricorso presentato dall’autore di “Striscia
la notizia”, Antonio Ricci, per violazione dell’art. 10 della Convenzione
europea dei diritti dell’Uomo. Il ricorso era stato presentato in seguito alla
sentenza con la quale, nel 2005, la Corte di cassazione – pur dichiarando la
prescrizione del reato – aveva ritenuto integrato il reato previsto dall’art.
617 quater e 623 bis c.p., per avere “Striscia la notizia” divulgato
nell’ottobre del 1996 un fuori onda della trasmissione di Rai3 “L’altra
edicola”, con protagonisti il filosofo Gianni Vattimo e lo scrittore Aldo Busi
che se ne dicevano di tutti i colori.
I fatti risalgono al 1996 e
c'erano voluti 10 anni perchè la Cassazione ritenesse Ricci colpevole per la
divulgazione del fuori onda di Rai Tre.
«Superando le eccezioni
procedurali interposte dal Governo Italiano, che - dicono i legali di Ricci,
Salvatore Pino e Ivan Frioni - ha provato a scongiurare una pronuncia che
entrasse nel merito della vicenda, ha ottenuto l’auspicato risarcimento morale,
sancito dalla Corte che – al termine di una densa motivazione – ha riconosciuto
la violazione dell’art. 10 della Convenzione, posto a tutela della libertà
d’espressione».
«La Corte – dopo aver riconosciuto
che “il rispetto della vita privata e il diritto alla libertà d’espressione
meritano a priori un uguale rispetto”
– diversamente da quanto sostenuto dai giudici italiani, “che -spiega l’avvocato
Salvatore Pino- avevano escluso la possibilità stessa di un bilanciamento – ha
ritenuto che la condanna di Antonio Ricci abbia costituito un’ingerenza nel suo
diritto alla libertà di espressione garantito dall’articolo 10 § 1 della
Convenzione ed ha altresì stigmatizzato la sproporzione della pena applicata
rispetto ai beni giuridici coinvolti e dei quali era stata lamentata la
lesione».
«Sono felice per la sentenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo - ha commentato Antonio Ricci,
creatore di Striscia la notizia.- La condanna aveva veramente dell’incredibile,
tra l’altro sia in primo che in secondo grado la Pubblica Accusa aveva chiesto
la mia assoluzione. E' una vittoria di Antonio Ricci contro lo Stato italiano,
per questo la sentenza di Strasburgo è molto importante». E' soddisfatto il
patron di Striscia la notizia per quella che ritiene essere stata una
vittoria di principio. «Il fatto che l'Europa si sia pronunciata a mio favore -
ha dichiarato Ricci - implica che esiste una preoccupazione in merito alla
libertà d'espressione nel nostro Paese». Una vittoria importante nella battaglia
per la libertà d'espressione che segna un punto a favore di Ricci e che pone
ancora una volta l'accento sui lacci e lacciuoli con i quali bisogna fare i
conti in Italia quando si cerca di fare informazione, come spiega lo stesso
Ricci nella video intervista. «Quante volte sono andati in onda dei fuori onda -
si è chiesto Ricci - E nessuno è mai stato punito? Per questo sono voluto andare
fino in fondo, la mia è stata una battaglia di principio».
Trattativa stato-mafia,
Ingroia rientra nel processo come avvocato parte civile. Rappresenta
l'associazione vittime della strage di via Georgofili. Si presenta con la sua
vecchia toga, abbracciato dagli amici pm. Antonio Ingroia, nelle vesti di
avvocato di parte civile. Il leader di Azione civile rappresenta l'associazione
dei familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili, presieduta da
Giovanna Maggiani Chelli. Ingroia sarà il sostituto processuale dell'avvocato
Danilo Ammannato. Antonio Ingroia denunciato per esercizio
abusivo della professione? Il rischio c'è. Il segretario dell’Ordine di Roma,
dove Ingroia è iscritto, e il presidente del Consiglio di Palermo, dove sarebbe
avvenuto l’esercizio abusivo della professione, ritengono "che prima di
potere esercitare la professione l’avvocato debba giurare davanti al Consiglio".
Ed Ancora. Bruxelles avvia
un'azione contro l'Italia per l'Ilva di Taranto. La Commissione "ha accertato"
che Roma non garantisce che l'Ilva rispetti le prescrizioni Ue sulle emissioni
industriali, con gravi conseguenze per salute e ambiente. Roma è ritenuta
"inadempiente" anche sulla norma per la responsabilità ambientale. La
Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione sull’Ilva per
violazione delle direttive sulla responsabilità ambientale e un’altra sul
mancato adeguamento della legislazione italiana alle direttive europee in
materia di emissioni industriali. Le prove di laboratorio «evidenziano un forte
inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde
acquifere, sia sul sito dell'Ilva, sia nelle zone abitate adiacenti della città
di Taranto. In particolare, l'inquinamento del quartiere cittadino di Tamburi è
riconducibile alle attività dell'acciaieria». Oltre a queste violazioni della
direttiva IPPC e al conseguente inquinamento, risulta che «le autorità italiane
non hanno garantito che l'operatore dello stabilimento dell'Ilva di Taranto
adottasse le misure correttive necessarie e sostenesse i costi di tali misure
per rimediare ai danni già causati».
Bene. Di tutto questo la
stampa si guarda bene di indicare tutti i responsabili, non fosse altro che sono
i loro referenti politici. Ma sì, tanto ci sono “Le Iene” di Italia 1 che ci
pensano a sputtanare il potere.
Cosa????
Invece “Le Iene” ci ricascano.
Tralasciamo il fatto che è da anni che cerco un loro intervento a pubblicizzare
l’ignominia dell’esame forense truccato, ma tant’è. Ma parliamo di altro. La
pubblicazione del video di Alessandro Carluccio denuncia la censura de “Le Iene”
su Francesco Amodeo, quando Francesco ha parlato è stato censurato...non serve
parlare !! il Mes, il gruppo Bilderberg, Mario Monti, Enrico Letta, Giorgio
Napolitano, il Signoraggio Bancario, la Guerra Invisibile,...e tanta truffa
ancora!!! Alessandro Carluccio, il bastardo di professione .. "figlio di
iene"….indaga,..spiegando che non è crisi.. è truffa..se accarezzi la iena
rischi di esser azzannato...in quanto la iena approfitta delle prede facili...ma
se poi dopo diventi il leone sono costrette a scappare...un faccia a faccia con
Matteo Viviani e Pablo Trincia in arte LE IENE....con Francesco Amodeo.
Dopo questo, ci si imbatte nel
caso di Andrea Mavilla, vittima di violenza e di censura. C’è il servizio
shock delle Iene sui carabinieri, ma il video scompare scatenando le ire del
web. Una storia davvero incredibile che ha lasciato tutto il pubblico de Le
Iene Show senza parole. Peccato che le stesse Iene abbiano censurato, o siano
state costrette a farlo, il loro stesso lavoro. “Ma il servizio di Viviani?”,
“dove si può vedere il video riguardo Andrea Mavilla e il vergognoso abuso di
potere che ha subito?”, “TIRATE FUORI IL VIDEO!”. Sono solo alcuni dei commenti
che hanno inondato il 25 settembre 2013 la pagina Facebook di Le Iene,
noto programma di Italia Uno la cui fama è legata ai
provocatori, ma anche il più delle volte illuminanti, servizi di inchiesta,
scrive Francesca su “Che Donna”. Proprio oggi però l’intrepido coraggio dei
ragazzi in giacca e cravatta è stato messo in dubbio proprio dai loro stessi
fan. Tempo fa Andrea Mavilla, blogger, filmò
un’auto dei carabinieri mentre sostava contromano sulle strisce pedonali:
l’uomo dimostrò che i tre militari rimasero diversi minuti
nella pasticceria lì vicino, uscendo poi con un pacchetto della stessa. I
carabinieri dovettero poi ricorrere alle vie legali,
dimostrando con tanto di verbale che il pasticcere
li aveva chiamati e loro, seguendo il regolamento, erano intervenuti
parcheggiando la volante quanto più vicino possibile al locale.
Il pacchetto? Un semplice regalo del negoziante riconoscente per la celerità
dell’arma. Storia finita dunque? A quanto pare no. Il blogger infatti sostiene
di aver subito una ritorsione da parte dell’arma: i
carabinieri sarebbero entrati senza mandato in casa sua svolgendo una
perquisizione dunque non autorizzata. Proprio qui sono
intervenute Le Iene: Viviani, inviato del programma,
ha infatti realizzato sull’accaduto un servizio andato in onda
la sera del 24 settembre 2013, alla ripresa del programma dopo la pausa estiva.
Inutile dire che la cosa ha subito calamitato l’attenzione del pubblico che
così, la mattina dopo, si è catapultato sul web per rivedere il servizio.
Peccato che questo risulta ad oggi irreperibile e la cosa non è proprio piaciuta
al pubblico che ora alza la voce su Facebook per richiedere il filmato in
questione. Come mai manca proprio quel filmato? Che i temerari di Italia
Uno non siano poi così impavidi? Le provocazioni e le domande fioccano
sul social network e la storia sembra dunque non finire qui.
Quando la tv criminalizza
un territorio.
7 ottobre 2013. Dal sito di
Striscia la Notizia si legge “Stasera a Striscia la notizia Fabio e Mingo
documentano la situazione di drammatico degrado in cui vivono migliaia di
persone nelle campagne di Foggia. Si tratta di lavoratori stranieri che vengono
in Italia per raccogliere i pomodori e lavorano dalle 5 del mattino fino a notte
per pochi euro. Il caso documentato da Striscia riguarda un gruppo di lavoratori
bulgari che per otto mesi l'anno vivono con le loro famiglie in case
improvvisate, senza acqua, gas e elettricità, in condizioni igieniche
insostenibili, tra fango e rifiuti di ogni genere, tra cui anche lastre di
amianto.”
In effetti il filmato
documenta una situazione insostenibile. Certo, però, ben lontana dalla
situazione descritta. Prima cosa è che non siamo in periodo di raccolta del
pomodoro, né dell’uva. Nel filmato si vede un accampamento di poche famiglie
bulgare, ben lontane dal numero delle migliaia di persone richiamate nel
servizio. Famiglie senza acqua, luce e servizi igienici. Un accampamento immerso
nell’immondizia e con auto di grossa cilindrata parcheggiate vicino alle
baracche. «Scusate ma a me sembra un "normale" accampamento di Zingari, come ci
sono ahimè in tutte le città italiane - scrive Antonio sul sito di Foggia Today
- Purtroppo oggi la televisione per fare audience, deve proporre continuamente
lo scoop, specialmente quando si tratta di televisione cosiddetta commerciale.
Ma anche la televisione pubblica a volte non è esente da criticare a riguardo.
Fare televisione oggi significa soprattutto speculare sulla notizia, e molte
volte non ci si fa scrupoli di speculare anche sulle tragedie, pur di
raggiungere gli agognati indici di ascolto. E tutto questo senza preoccuparsi
minimamente, di quanto viene proposto agli spettatori, a volte paganti (vedi il
canone Rai). Tanto a nessuno importa, perchè vige la regola: "Il popolo è
ignorante".» Giovanni scrive: «quello è un campo nomadi e non il campo dei
lavoratori agricoli stagionali».
Questo non per negare la
terribile situazione in cui versano i lavoratori stagionali, a nero e spesso
clandestini, che coinvolge tutta l’Italia e non solo il Foggiano, ma per dare a
Cesare quel che è di Cesare.
In effetti di ghetto ne parla
“Foggia Città Aperta”. Ma è un’altra cosa rispetto a quel campo documentato da
Striscia. Una fetta di Africa a dodici chilometri da Foggia. Benvenuti nel
cosiddetto Ghetto di Rignano, un villaggio di cartone sperduto fra le campagne
del Tavoliere Dauno che ogni estate ospita circa 700 migranti. Tutti, o quasi,
impegnati nella raccolta dei campi, in modo particolare dei pomodori. Dodici ore
di lavoro sotto al sole e al ritorno neanche la possibilità di farsi la doccia.
Attenzione si parla di Africani, non di Bulgari.
Sicuramente qualcuno mi farà
passare per razzista, ma degrado e sudiciume illustrato da Striscia, però, sono
causati da quelle persone che ivi abitano e non sono certo da addebitarsi
all’amministrazione pubblica Foggiana, che eventualmente, per competenza, non ha
ottemperato allo sgombero ed alla bonifica dei luoghi.
Ai buonisti di maniera si
prospettano due soluzioni:
L’Amministrazione pubblica
assicura ai baraccati vitto, alloggio e lavoro, distogliendo tale diritto ai
cittadini italiani, ove esistesse;
L’Amministrazione pubblica
assicura la prole ad un centro per minori, togliendoli alle famiglie; libera con
forza l’accampamento abusivo e persegue penalmente i datori di lavori, ove vi
sia sfruttamento della manodopera; chiede ai baraccati ragione del loro tenore
di vita in assenza di lavoro, per verificare che non vi siano da parte loro
atteggiamenti e comportamenti criminogeni, in tal caso provvede al rimpatrio
coatto.
Colui il quale dalla lingua
biforcuta sputerà anatemi per aver ristabilito una certa verità, sicuramente non
avrà letto il mio libro “UGUAGLIANZIOPOLI L’ITALIA DELLE DISUGUAGLIANZE.
L'ITALIA DELL'INDISPONENZA, DELL'INDIFFERENZA, DELL'INSOFFERENZA”, tratto dalla
collana editoriale “L’Italia del Trucco, l’Italia che siamo”. Opere reperibili
su Amazon.it.
Alla fine della fiera, si può
dire che stavolta Fabio e Mingo e tutta Striscia la Notizia per fare
sensazionalismo abbiano toppato?
Che anche le toghe
paghino per i loro errori: adesso lo pretende la
Ue, chiede “Libero Quotidiano”. La Commissione Europea ha
aperto una procedura di infrazione contro l'Italia
perchè non adegua la sua normativa sulla responsabilità civile dei
giudici al diritto comunitario. Bruxelles si
aspetta che il governo nostrano estenda la casistica per i risarcimenti
"cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie". Casistica regolata da una
legge del 1988 e assai stretta: il legislatore prevede che le
toghe rispondano in prima persona solo in caso di dolo o colpa grave
nel compimento dell'errore giudiziario. All'Ue non sta bene, e il procedimento
di infrazione non è un fulmine a ciel sereno. E' del novembre 2011 la
condanna all'Italia da parte della Corte di Giustizia Ue per
l'inadeguatezza della nostra normativa in materia di responsabilità civile dei
giudici, mentre già nel settembre 2012 la Commissione aveva
chiesto al governo aggiornamenti sull'applicazione del decreto di condanna. Ma
non è bastato. In due anni i governi di Mario Monti e
Enrico Letta non hanno adeguato la legge italiana a quella europea, e
ora l'Ue passa ai provvedimenti sanzionatori. L'Italia è responsabile della
violazione del diritto dell'Unione da parte di un suo organo (in questo caso
giudiziario), e per questo sarà chiamata a pagare. Qual è il problema per l'Ue?
Che i giudici italiani sono chiamati a pagare per i propri errori in casi troppo
ristretti, godendo di una normativa che non solo li avvantaggia rispetto ad
altri lavoratori e professionisti italiani, ma
anche rispetto ai propri colleghi europei. La legge
italiana 117/88 restringe la responsabilità dei giudici ai soli
casi di errore viziato da "dolo e colpa grave". E, come se non fosse abbastanza,
il legislatore assegna l'onere della prova (ovvero la dimostrazione del dolo e
della colpa del giudice) al querelante che chiede
risarcimento per il danno subito. Per l'Ue troppo
poco. La Commissione Ue chiede all'Italia di conformarsi al diritto comunitario.
Innanzitutto via l'onere della dimostrazione del dolo e della colpa. E poi
estensione della responsabilità del giudice di ultima istanza anche ai casi di
sbagliata interpretazione delle leggi e di errata valutazione
delle prove, anche senza il presupposto della malevolezza della toga
verso l'imputato. Anche per colpa semplice, insomma. Interpellate da Bruxelles
nel settembre 2012, le autorità italiane avevano risposto in maniera
rassicurante: cambieremo la legge. In dodici mesi non si è
mossa una foglia, e ora il Belpaese va incontro a un procedimento di infrazione,
cioè a una cospicua multa. Insomma, non pagano i giudici,
paghiamo noi.
La proposta di aprire una
nuova procedura d'infrazione è stata preparata dal servizio giuridico della
Commissione che fa capo direttamente al gabinetto del presidente Josè Manuel
Barroso, scrive “La Repubblica”. Bruxelles si è in pratica limitata a constatare
che a quasi due anni dalla prima condanna, l'Italia non ha fatto quanto
necessario per eliminare la violazione del diritto europeo verificata nel 2011.
La prima sentenza emessa dai giudici europei ha decretato che la legge italiana
sulla responsabilità civile dei magistrati li protegge in modo eccessivo dalle
conseguenze del loro operato, ovvero rispetto agli eventuali errori commessi
nell'applicazione del diritto europeo (oggi circa l'80% delle norme nazionali
deriva da provvedimenti Ue). Due in particolare le ragioni che hanno portato
Commissione e Corte a censurare la normativa italiana giudicandola incompatibile
con il diritto comunitario. In primo luogo, osservano fonti europee, la legge
nazionale esclude in linea generale la responsabilità dei magistrati per i loro
errori di interpretazione e valutazione. Inoltre, la responsabilità dello Stato
scatta solo quando sia dimostrato il dolo o la colpa grave. Un concetto,
quest'ultimo, che secondo gli esperti Ue la Cassazione ha interpretato in
maniera troppo restrittiva, circoscrivendola a sbagli che abbiano un carattere
“manifestamente aberrante”.
Ciò che l'Unione Europea
contestava, e ancora contesta, è l'eccessiva protezione garantita alla
magistratura italiana, scrive “Il Giornale”. Per eventuali errori commessi
nell'applicare il diritto europeo, non è infatti prevista
responsabilità civile, che entra in gioco per dolo o colpa grave, ma non per
errori di valutazione o interpretazione. Una differenzia importante, se si
considera che circa l'80% delle norme italiana deriva ormai da provvedimenti
comunitari.
Pronta la replica delle toghe:
guai a toccare i magistrati.
Nessun "obbligo per l'Italia
di introdurre una responsabilità diretta e personale del singolo giudice":
l'Europa "conferma che nei confronti del cittadino l'unico responsabile è lo
Stato". Il vice presidente del Csm Michele Vietti commenta così la notizia
dell'avvio di una procedura da parte dell'Ue. "L'Europa ha parlato di
responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario; non entra
invece nella questione della responsabilità personale dei giudici perché é un
problema di diritto interno, regolato diversamente nei vari Stati membri", ha
puntualizzato il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Rodolfo
Sabelli, che sin da ora avverte: "Denunceremo ogni tentativo di condizionamento
dei magistrati attraverso una disciplina della responsabilità civile che violi i
principi di autonomia e indipendenza".
Tutti uguali davanti alla
legge. Tutti uguali? Anche i magistrati? E invece no. I magistrati sono al di
sopra della legge, ci si tengono - al di sopra - con pervicacia, si rifugiano
sotto l’ombrello dell’autonomia, indipendenza dalla politica, in realtà
tenendosi stretto il privilegio più anacronistico che si possa immaginare:
l’irresponsabilità civile. O irresponsabilità incivile, scrive Marvo Ventura su
“Panorama”. La Commissione Europea ha deciso di avviare una procedura
d’infrazione nei confronti dell’Italia per l’eccessiva protezione offerta dalle
norme ai magistrati, per i limiti all’azione di risarcimento delle vittime di
palesi e magari volute ingiustizie. Per l’irresponsabilità del magistrato che
per dolo o colpa grave rovini la vita delle persone con sentenze chiaramente
errate, se non persecutorie. Succede che in capo direttamente al presidente
della Commissione UE, Barroso, è partita la proposta di agire contro l’Italia
per aver totalmente ignorato la condanna del 2011 della Corte di Giustizia che
fotografava l’inadeguatezza del sistema italiano agli standard del diritto
europeo rispetto alla responsabilità civile delle toghe. Dov’è finita allora
l’urgenza, la fretta, quel rimbocchiamoci le maniche e facciamo rispettare la
legge e le sentenze, che abbiamo visto negli ultimi giorni, settimane, mesi,
come una battaglia di principio che aveva e ha come bersaglio l’avversario
politico Silvio Berlusconi. Perché dal 1987, anno del referendum sulla
responsabilità civile dei magistrati, c’è stata solo una legge, la Vassalli
dell’anno successivo, che serviva purtroppo per introdurre una qualche
responsabilità ma non troppa, per non pestare i piedi alla magistratura, forte
già allora di uno strapotere discrezionale nella sua funzione inquirente e nella
sua vocazione sovente inquisitoria. Adesso che l’Europa ci bacchetta (e la
minaccia è anche quella di farci pagare per l’irresponsabilità dei nostri
magistrati, dico far pagare a noi contribuenti che sperimentiamo ogni giorno le
inefficienze e i ritardi della giustizia civile e penale), l’Europa non è più
quel mostro sacro che ha sempre ragione. Non è più neanche il depositario del
bene e del giusto. È invece la fonte di una raccomandazione che merita a stento
dichiarazioni di seconda fila. E l’Associazione nazionale magistrati stavolta
non tuona, non s’indigna, non incalza. Si limita a scaricare il barile al
governo, dice per bocca dei suoi vertici che la Commissione non ha infilzato i
singoli magistrati ma lo Stato italiano per la sua inadempienza al diritto UE,
comunitario. Come se i magistrati e la loro associazione corporativa non
avessero avuto alcuna voce in capitolo nel tornire una legislazione che non è in
linea con lo stato di diritto di un avanzato paese europeo. Come se in questo
caso le toghe potessero distinguere le loro (ir)responsabilità da quelle di una
parte della politica che ha fatto sponda alle correnti politiche giudiziarie e
alla loro campagna ventennale. Come se i magistrati più in vista, più esposti,
non avessero facilmente e disinvoltamente travalicato i confini e non si fossero
gettati in politica facendo tesoro della popolarità che avevano conquistato
appena il giorno prima con le loro inchieste di sapore “politico”. Ma quel che è
peggio è l’odissea di tanti cittadini vittime di ingiustizia che si sono dovuti
appellare all’Europa, avendo i soldi per farlo e il tempo di aspettare senza
morire (a differenza di tanti altri). A volte ho proprio l’impressione di non
trovarmi in Europa ma in altri paesi che non saprei citare senza peccare di
presunzione. L’Italia, di certo, non appartiene più al novero dei paesi nei
quali vi è certezza del diritto. Per quanto ancora?
Di altro parere rispetto a
quello espresso dalle toghe, invece è il Presidente della Repubblica e capo del
CSM. L’opposizione dei giudici alla riforma della giustizia è eccessiva, spiega
“Libero Quotidiano”. Se ne è accorto anche Giorgio Napolitano che, il 20
settembre 2013 intervenendo alla Luiss per ricordare Loris D'Ambrosio, riflette
sul rapporto tra magistratura e politica: entrambi i poteri sbagliano, ma la
magistratura è troppo piegata sulle sue posizioni ed una rinfrescata ai codici
sarebbe cosa buona. Secondo Napolitano, le critiche che le piovono addosso,
vero, sono eccessive; ma ai punti a perdere sono i magistrati, sempre più
convinti di essere intoccabili. La politica e la giustizia devono smettere di
"concepirsi come mondi ostili, guidati dal sospetto reciproco", dice Napolitano
che sogna, invece, l’esaltazione di quella "comune responsabilità istituzionale"
propria dei due poteri. "Ci tocca operare in questo senso - precisa Napolitano -
senza arrenderci a resistenze ormai radicate e a nuove recrudescenze del
conflitto da spegnere nell'interesse del Paese". Per superare quelle criticità
emerse con foga negli ultimi vent’anni (prendendo Tangentopoli come primo e vero
momento di scontro tra politica e magistratura), secondo Napolitano, la
soluzione si può trovare "attraverso un ridistanziamento tra politica e diritto"
ma soprattutto non senza la cieca opposizione ad una riforma completa della
magistratura. Il presidente della Repubblica sembra non sapersi spiegare perché
proprio i magistrati siano sulle barricate per difendere il loro status. Tra i
giudici, dice Napolitano, dovrebbe "scaturire un'attitudine meno difensiva e più
propositiva rispetto al discorso sulle riforme di cui la giustizia ha indubbio
bisogno da tempo e che sono pienamente collocabili nel quadro dei principi della
Costituzione repubblicana". Sul Quirinale non sventola mica la bandiera di Forza
Italia, ma bastano le lampanti criticità ad illuminare il discorso di Re
Giorgio. "L'equilibrio, la sobrietà ed il riserbo, l'assoluta imparzialità e il
senso della misura e del limite, sono il miglior presidio dell'autorità e
dell'indipendenza del magistrato". Così Napolitano non si lascia sfuggire
l’occasione di parlare indirettamente a quei magistrati che fanno del
protagonismo la loro caratteristica principale. Pm, come Henry John Woodcock, o
giudicanti, come il cassazionista Antonio Esposito, che si sono lasciarti
sedurre da taccuini e telecamere quando, invece, avrebbero dovuto seguire quei
dettami di "sobrietà e riserbo". Il presidente, poi, ricorda che nessun lavoro è
delicato quanto quello del giudice perché sa che dalla magistratura dipende la
vita (o la non-vita) degli indagati.
Inoltre su un altro punto è
intervenuta l’Europa. Condannare un giornalista alla prigione è una violazione
della libertà d’espressione, salvo casi eccezionali come incitamento alla
violenza o diffusione di discorsi razzisti. A stabilirlo, ancora una volta. è la
Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza in cui dà ragione a Maurizio
Belpietro, direttore di Libero, condannato a quattro anni dalla Corte d’Appello
di Milano. In sostanza, scrive Vittorio Feltri, i giudici continentali si sono
limitati a dire ai tribunali italiani che i giornalisti non devono andare in
galera per gli sbagli commessi nello svolgimento del loro lavoro, a meno che
inneggino alla violenza o incitino all'odio razziale. Tutti gli altri eventuali
reati commessi dai colleghi redattori vanno puniti, a seconda della gravità dei
medesimi, con sanzioni pecuniarie. Perché la libertà di espressione non può
essere compressa dal terrore dei giornalisti di finire dietro le sbarre. La
Corte, per essere ancora più chiara, ha detto che il carcere collide con la
Carta dei diritti dell'uomo. Inoltre, scrive “Panorama”, ha condannato lo Stato
italiano a risarcire Belpietro - per il torto patito - con 10mila euro, più
5mila per le spese legali. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha
condannato lo Stato italiano a pagare a Maurizio Belpietro 10 mila euro per
danni morali e 5 mila per le spese processuali a causa della condanna a 4 anni
di carcere, inflittagli dai giudici d'appello di Milano, per aver ospitato sul
suo giornale un articolo del 2004 ritenuto gravemente diffamatorio a firma Lino
Jannuzzi, allora senatore PdL. Senza entrare nel merito della questione
giudiziaria, la Corte ha cioè ribadito un principio assimilato da tutti i Paesi
europei: il carcere per i giornalisti per il reato di diffamazione - previsto
dal nostro codice penale - è un abominio giuridico incompatibile con i principi
della libertà d'informazione. A questo tema, di cui si è occupato anche
Panorama , è dedicato il fondo di Vittorio Feltri su Il Giornale
intitolato E l'Europa ci bastona. Un orrore il carcere per i giornalisti
. “La vicenda dell'attuale direttore di Libero è
addirittura paradossale. Udite. Lino Jannuzzi scrive un articolo scorticante sui
misteri della mafia, citando qualche magistrato, e lo invia al Giornale. La
redazione lo mette in pagina. E il dì appresso partono le querele delle suddette
toghe. Si attende il processo di primo grado. Fra la sorpresa generale, il
tribunale dopo avere udito testimoni ed esaminato approfonditamente le carte,
assolve sia Jannuzzi sia Belpietro. Jannuzzi perché era senatore ed era suo
diritto manifestare le proprie opinioni, senza limitazioni. Belpietro perché
pubblicare il pezzo di un parlamentare non costituisce reato. Ovviamente, i
soccombenti, cioè i querelanti, ricorrono in appello. E qui si ribalta tutto. Il
direttore si becca quattro mesi di detenzione, per non parlare della sanzione
economica: 100mila e passa euro. Trascorrono mesi e anni, e si arriva in
Cassazione - suprema corte - che, lasciando tutti di stucco, conferma la
sentenza di secondo grado, a dimostrazione che la giustizia è un casino, dove la
certezza del diritto è un sogno degli ingenui o dei fessi. Belpietro, allora,
zitto zitto, inoltra ricorso alla Corte di Strasburgo che, essendo più civile
rispetto al nostro sistema marcio, riconosce al ricorrente di avere ragione.
Attenzione. Le toghe europee non se la prendono con i colleghi italiani che,
comunque , hanno esagerato con le pene, bensì con lo Stato e chi lo guida
(governo e Parlamento) che consentono ancora - non avendo mai modificato i
codici - di infliggere ai giornalisti la punizione del carcere, prediletta dalle
dittature più infami.”
Anche il fondo di Belpietro è
dedicato alla storica decisione della Corte di Strasburgo che ha dato ragione a
quanti, tra cui Panorama, sostengono che il carcere per i giornalisti sia
una stortura liberticida del nostro sistema penale che un Parlamento degno di
questo nome dovrebbe subito cancellare con una nuova legge che preveda la pena
pecuniaria, anziché il carcere. Così ricostruisce la vicenda il direttore di
Libero.
La questione è che per aver
dato conto delle opinioni di un senatore su un fatto di rilevante interesse
nazionale un giornalista è stato condannato al carcere. Ho sbagliato a dar voce
a Iannuzzi? Io non credo, perché anche le opinioni sbagliate se corrette da un
contraddittorio o da una rettifica contribuiscono a far emergere la verità.
Tuttavia, ammettiamo pure che io sia incorso in un errore, pubblicando opinioni
non corrette: ma un errore va punito con il carcere? Allora cosa dovrebbe
succedere ai magistrati che commettono errori giudiziari e privano della libertà
una persona? Li mettiamo in cella e buttiamo via la chiave? Ovvio che no, ma
nemmeno li sanzioniamo nella carriera o nel portafoglio, a meno che non
commettano intenzionalmente lo sbaglio. Naturalmente non voglio mettere noi
infimi cronisti sullo stesso piano di superiori uomini di legge, ma è evidente
che c’è qualcosa che non va. Non dico che i giornalisti debbano avere licenza di
scrivere, di diffamare e di insultare, ma nemmeno devono essere puniti con la
galera perché sbagliano. Altrimenti la libertà di stampa e di informare va a
quel paese, perché nel timore di incorrere nei rigori della legge nessuno scrive
più nulla. Tradotto in giuridichese, questo è quel che i miei avvocati hanno
scritto nel ricorso contro la condanna presentato alla Corte europea dei diritti
dell’uomo, la quale proprio ieri ci ha dato ragione, condannando l’Italia a
risarcirmi per i danni morali subiti e sentenziando che un omesso controllo in
un caso di diffamazione non giustifica una sanzione tanto severa quale il
carcere. Qualcuno penserà a questo punto che io mi sia preso una rivincita
contro i giudici, ma non è così.
Siamo una masnada di fighetti
neppure capaci di essere una corporazione, anzi peggio, siamo dei professionisti
terminali e già «morti» come direbbe un qualsiasi Grillo, scrive Filippo Facci.
La Corte di Strasburgo ha sancito che il carcere per un giornalista - Maurizio
Belpietro, nel caso - costituisce una sproporzione e una violazione della
libertà di espressione. È una sentenza che farà giurisprudenza più di cento
altri casi, più della nostra Cassazione, più degli estenuanti dibattiti
parlamentari che da 25 anni non hanno mai partorito una legge decente sulla
diffamazione. Il sindacato dei giornalisti si è detto soddisfatto e anche molti
quotidiani cartacei (quasi tutti) hanno almeno dato la notizia, che resta
essenzialmente una notizia: ora spiegatelo ai censori del Fatto Quotidiano (il
giornale di Marco Travaglio), a questi faziosi impregnati di malanimo che
passano la vita a dare dei servi e chi non è affiliato al loro clan. Non una
riga. Niente.
Tutt’altro trattamento, però,
è riservato a Roberto Saviano. Ci dev'essere evidentemente un delirio nella
mente di Saviano dopo la condanna per plagio, scrive Vittorio Sgarbi. Lo hanno
chiamato per una occasione simbolico-folkloristica: guidare la Citroen Mehari
che fu di Giancarlo Siani, un'automobile che rappresenta il gusto per la libertà
di una generazione. All'occasione Saviano dedica un'intera pagina della
Repubblica. Possiamo essere certi che non l'ha copiata, perché senza paura del
ridicolo, di fronte alla tragedia della morte del giornalista, per il suo
coraggio e le sue idee, che si potrebbero semplicemente celebrare ripubblicando
i suoi articoli in un libro da distribuire nelle scuole (pensiero troppo facile)
scrive: «Riaccendere la Mehari, ripartire, è il più bel dono che Paolo Siani (il
fratello) possa fare non solo alla città di Napoli ma al Paese intero... la
Mehari che riparte è il contrario del rancore, è il contrario di un legittimo
sentimento di vendetta che Paolo Siani potrebbe provare». Eppure Roberto Saviano
e la Mondadori sono stati condannati per un presunto plagio ai danni del
quotidiano Cronache di Napoli, scrive “Il Corriere del Mezzogiorno”.
Editore e scrittore sono stati ritenuti responsabili di «illecita riproduzione»
nel bestseller Gomorra di tre articoli (pubblicati dai quotidiani locali
«Cronache di Napoli» e «Corriere di Caserta»). In particolare, Saviano e
Mondadori , suo editore prima del passaggio con Feltrinelli, sono stati
condannati in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, per 60mila
euro. Questa la decisione del secondo grado di giudizio. Spetterà adesso ai
giudici di Cassazione dire l'ultima parola su una querelle che si trascina da
almeno cinque anni, da quando cioè la società Libra, editrice dei due quotidiani
campani, imputò allo scrittore anticamorra di essersi appropriato di diversi
articoli senza citare la fonte per redigere alcune parti di Gomorra
(corrispondenti, sostiene Saviano, a due pagine).
Detto questo si presume che le ritorsioni
su chi testimonia una realtà agghiacciante abbiano uno stop ed invece c’è il
servizio shock delle Iene sui carabinieri, ma il video scompare scatenando le
ire del web.
“Ma il servizio di Viviani?”,
“dove si può vedere il video riguardo Andrea Mavilla e il vergognoso abuso di
potere che ha subito?”, “TIRATE FUORI IL VIDEO!”. Sono solo alcuni dei commenti
che hanno inondato il 25 settembre 2013 la pagina Facebook di Le Iene,
noto programma di Italia Uno la cui fama è legata ai
provocatori, ma anche il più delle volte illuminanti, servizi di inchiesta,
scrive “Che Donna”. Proprio oggi però l’intrepido coraggio dei ragazzi in giacca
e cravatta è stato messo in dubbio proprio dai loro stessi fan.
Ma andiamo con ordine.
Tempo fa Andrea
Mavilla, blogger, filmò un’auto dei carabinieri mentre sostava
contromano sulle strisce pedonali: l’uomo dimostrò che i tre
militari rimasero diversi minuti nella pasticceria lì vicino, uscendo
poi con un pacchetto della stessa. I carabinieri
dovettero poi ricorrere alle vie legali, dimostrando con tanto di
verbale che il pasticcere li aveva chiamati e
loro, seguendo il regolamento, erano intervenuti parcheggiando la
volante quanto più vicino possibile al locale. Il pacchetto? Un
semplice regalo del negoziante riconoscente per la celerità dell’arma. Storia
finita dunque? A quanto pare no. Il blogger infatti sostiene di aver subito una
ritorsione da parte dell’arma: i carabinieri
sarebbero entrati senza mandato in casa sua svolgendo una perquisizione
dunque non autorizzata. Proprio qui sono intervenute Le Iene:
Viviani, inviato del programma, ha infatti realizzato sull’accaduto un
servizio andato in onda la sera del 25 settembre 2013, alla
ripresa del programma dopo la pausa estiva. Inutile dire che la cosa ha subito
calamitato l’attenzione del pubblico che così, la mattina dopo, si è catapultato
sul web per rivedere il servizio. Peccato che questo risulta ad oggi
irreperibile e la cosa non è proprio piaciuta al pubblico che ora alza la voce
su Facebook per richiedere il filmato in questione. Come mai manca proprio quel
filmato? Che i temerari di Italia Uno non siano poi così
impavidi? Le provocazioni e le domande fioccano da questa mattina sul social
network e la storia sembra dunque non finire qui.
Andrea Mavilla,
blogger dallo spiccato senso civico, ha pubblicato su YouTube
un filmato in cui pizzicava un’auto dei carabinieri in divieto di sosta, sulle
strisce pedonali, in prossimità di un semaforo e controsenso, scrive “Blitz
Quotidiano”. Oltre trecentomila contatti in poche ore e poco dopo un plotone di
30 carabinieri si precipita a casa sua, a Cavenago di Brianza,
comune alle porte di Milano. Il video è stato girato domenica mattina, nel
filmato intitolato “operazione pasticcini” il blogger insinua
che i militari stessero comprando pasticcini all’interno della pasticceria
accanto. Per svariati minuti il videoamatore resta in attesa dei carabinieri:
ferma i passanti “signora guardi sono sulle strisce, in prossimità di un
semaforo, saranno entrati a prendere i pasticcini in servizio”, commenta ironico
“è scioccante”, “normale parcheggiare sulle strisce vero?”. Quando infine i
carabinieri escono dalla pasticceria, con in mano un pacchetto, notano l’uomo
con la telecamera in mano. Il blogger li bracca e chiede loro spiegazioni e i
militari lo fermano per identificarlo. Il legale dei tre carabinieri, Luigi
Peronetti, spiega che: “La realtà è un’altra. E lo dicono i
documenti, non solo i miei assistiti. Il caso è agghiacciante e mostra come
immagini neutre con un commentatore che insinua a e fa deduzioni malevole
possano distorcere la realtà”. Sulla carta, in effetti, risulta che i
carabinieri erano in quella pasticceria perché il proprietario aveva chiesto il
loro intervento, hanno lasciato l’auto nel posto più vicino, come prevedono le
disposizioni interne all’Arma in materia di sicurezza, hanno verificato
richieste e problemi del pasticcere, hanno redatto un verbale, poi sono usciti.
In mano avevano un pacchetto, è vero: “Ma certo. Solo che non
l’avevano acquistato – continua l’avvocato Peronetti – in realtà i negozianti,
per ringraziare i militari della gentilezza e della professionalità, hanno
regalato loro alcune brioches avanzate a fine mattinata, da portare anche ai
colleghi in caserma. I militari hanno rifiutato, e solo dopo alcune insistenze,
hanno accettato il pacchetto. Al blogger bastava chiedere, informarsi prima di
screditare così i miei assistiti!. Ora il blogger rischia guai grossi,
perché i militari stanno valutando se procedere contro di lui legalmente per
aver screditato la loro professionalità. Ma Andrea Mavilla non si arrende e
controbatte: “Ho le prove che dimostrano i soprusi di cui sono stato
vittima – annuncia – ho solo cercato di documentare un fatto che ho
visto e ho ripreso per il mio blog, la mia passione. Ho visto quella che secondo
me è una violazione al codice della strada, che in realtà è concessa ai
carabinieri solo in caso di pericolo o emergenze. Poi hanno effettuato una
perquisizione, ma i carabinieri non dovevano entrare in casa mia
e la vicenda è in mano agli avvocati. Per questo motivo sono sotto choc,
sconvolto e mi sento sotto attacco”.
Nel servizio de Le
Iene, in onda martedì 25 settembre 2013, Andrea Mavilla
è protagonista di un sequestro di beni non dovuto, a seguito di un video che
documentava una macchina dei carabinieri parcheggiata sulle
strisce pedonali e in controsenso, davanti ad una pasticceria. Mavilla,
già ospite a Pomeriggio 5 per via di un’altra vicenda, è stato poi convocato in
questura dove, racconta a Matteo Viviani de Le Iene, sarebbe
stato costretto a denudarsi mentre veniva insultato: dichiarazioni che tuttavia
non sono supportate da registrazioni audio o video, e che quindi non possono
essere provate. Un esperto di informatica, però, ha fatto notare che, in seguito
al sequestro dei computer di Mavilla, i carabinieri
avrebbero cancellato ogni cosa presente sul pc dell’autore del filmato
incriminato.
Uno dei servizi più
interessanti (e, a tratti, agghiaccianti) andati in onda nella prima puntata de
Le Iene Show, è stato quello curato da Matteo Viviani
che ha documentato un presunto caso di abuso di potere
perpetrato dai Carabinieri nei confronti di Andrea Mavilla.
L’uomo è molto famoso su internet e, ultimamente, è apparso anche in televisione
ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Ecco cos’è
accaduto nel servizio de Le Iene.
Andrea accoglie la Iena Matteo
Viviani in lacrime: ha la casa a soqquadro, come se fosse stata
appena svaligiata dai ladri. Ma la verità è ben diversa. Purtroppo. L’incubo
comincia quando Andrea Mavilla filma, con il proprio
cellulare, una volante dei Carabinieri parcheggiata sulle strisce pedonali e
davanti ad uno scivolo per disabili. L’auto rimane parcheggiata sulle strisce
per circa venti minuti mentre i Carabinieri, presumibilmente, sono in
pasticceria. Non appena gli agenti si accorgono di essere
filmati, intimano ad Andrea di spegnere il cellulare e di
mostrare loro i documenti. Poi inizia l’incubo. Il Comandante dei
Carabinieri si sarebbe recato a casa di Andrea per intimargli di
consegnargli tutto il materiale video e fotografico in suo possesso. Al rifiuto
del ragazzo, gli agenti avrebbero iniziato a perquisire
la sua casa alla ricerca di materiale compromettente. Matteo Viviani,
nel suo servizio, ha riportato l’audio della la conversazione tra Andrea ed i
carabinieri registrato tramite Skype da una collaboratrice di
Andrea. Nel servizio andato in onda a Le Iene Show, poi,
Andrea racconta quel che è accaduto dopo la presunta perquisizione: secondo
Mavilla i Carabinieri lo avrebbero condotto in Caserma ed insultato
pesantemente. Il giovane si sarebbe sentito poi male tanto da rendere necessario
il suo ricovero in Ospedale. Una storia davvero incredibile che ha lasciato
tutto il pubblico de Le Iene Show senza parole. Peccato che le stesse Iene
abbiano censurato, o siano state costrette a farlo, il loro stesso lavoro.
MALAGIUSTIZIA. PUGLIA: BOOM DI CASI.
C’è l’elettricista incensurato scambiato per un
pericoloso narcotrafficante per un errore nella trascrizione delle
intercettazioni; e ci sono i due poliziotti accusati di rapina ai danni di un
imprenditore, sottoposti nel 2005 a misura cautelare per 13 mesi, spogliati
della divisa e poi assolti con formula piena. Ma nel frattempo hanno perso il
lavoro, scrive Vincenzo Damiani su “Il Corriere del Mezzogiorno”. Sino alla
drammatica storia di Filippo Pappalardi, ammanettato e rinchiuso in una cella
con l’accusa - rivelatasi poi completamente sbagliata - di aver ucciso i suoi
due figli, Francesco e Salvatore. E’ lungo l’elenco delle persone incastrate
nelle maglie della malagiustizia, che hanno - loro malgrado - vissuto per mesi o
per anni un incubo chiamato carcere. A Bari, secondo i dati ufficiali raccolti
dal sito errori giudiziari.com, le richieste di risarcimento presentate per
ingiusta detenzione, nell’ultimo anno, si sono più che raddoppiate: nel 2012 i
giudici della Corte di appello hanno riconosciuto 29 errori da parte dei loro
colleghi, condannando lo Stato a pagare complessivamente 911mila euro. A metà
dell’ultimo anno i casi sono già passati a 64, valore totale degli indennizzi
oltre 1,7 milioni. In aumento gli errori anche a Taranto, dove si è passati dai
due risarcimenti riconosciuti nel 2012 ai sette del 2013. In controtendenza,
invece, l’andamento nel distretto di Lecce: nel 2012 gli errori riconosciuti
sono stati ben 97, quest’anno la statistica è ferma a 37. Spesso i mesi o
addirittura gli anni trascorsi da innocente dietro le sbarre vengono "liquidati"
con poche migliaia di euro, al danno così si unisce la beffa. Secondo quanto
disposto dagli articoli 314 e 315 del codice penale e dalla Convenzione dei
diritti dell’uomo, la persona diventata suo malgrado imputato ha diritto ad
un’equa riparazione. La legge "Carotti" ha aumentato il limite massimo di
risarcimento per aver patito un'ingiusta permanenza in carcere, passando da
cento milioni di lire a 516mila euro, ma raramente viene riconosciuto il
massimo. Per non parlare dei tempi per ottenere la riparazione: le cause durano
anni, basti pensare che Filippo Pappalardi, giusto per fare un esempio, è ancora
in attesa che venga discussa la sua richiesta. Ma il papà dei due fratellini di
Gravina, i ragazzini morti dopo essere caduti accidentalmente in una cisterna,
non è l’unico arrestato ingiustamente. Attenzione ingiusta detenzione da non
confondere il risarcimento del danno per l’errore giudiziario causato da colpa
grave o dolo. Eventi, questi, quasi mai rilevati dai colleghi magistrati contro
i loro colleghi magistrati. Gianfranco Callisti conduceva una vita normale e
portava avanti serenamente la sua attività di elettricista. Sino al giorno in
cui, nel 2002, viene prelevato dai carabinieri e trasferito in carcere
all’improvviso. La Procura e il Tribunale di Bari erano convinti che fosse
coinvolto in un vasto traffico di droga, la storia poi stabilirà che si trattò
di un tragico errore provocato da uno sbaglio nella trascrizione delle
intercettazioni. Callisti da innocente fu coinvolto nella maxi inchiesta
denominata "Operazione Fiume", come ci finì? Il suo soprannome, "Callo", fu
confuso con il nome "Carlo", che era quello di una persona effettivamente
indagato. Il telefono dell’elettricista non era sotto controllo, ma quello di un
suo conoscente si, una casualità sfortunata che lo fece entrare nell’ordinanza
di custodia cautelare. Si fece sei mesi in carcere, tre mesi ai domiciliari e
tre mesi di libertà vigilata, prima che i giudici riconobbero il clamoroso
abbaglio. Dopo 10 anni lo Stato gli ha riconosciuto un indennizzo di 50mila
euro, nulla in confronto all’inferno vissuto.
Correva l'anno 1985 e Indro Montanelli, che
a quel tempo direttore del Giornale, era ospite di Giovanni Minoli a
Mixer, scrive Francesco Maria Del Vigo su “Il Giornale”. In un'intervista
del 1985 il giornalista attacca le toghe. Dopo ventotto anni è ancora attuale:
"C'è pieno di giudici malati di protagonismo. Chiedo ed esigo che la
magistratura risponda dei suoi gesti e dei suoi errori spesso catastrofici"Un
pezzo di modernariato, direte voi. Invece è una perfetta, precisa, lucida ma
soprattutto attuale, fotografia della giustizia italiana. Sono passati ventotto
anni. Si vede dai colori delle riprese, dagli abiti e anche dal format stesso
della trasmissione. Ma solo da questo. In tutto il resto, il breve spezzone che
vi riproponiamo, sembra una registrazione di poche ore fa. Attuale. Più che mai.
Una prova della lungimiranza di Montanelli, ma anche la testimonianza
dell'immobilità di un Paese che sembra correre su un tapis roulant: sempre in
movimento, ma sempre nello stesso posto, allo stesso punto di partenza.
Montanelli parla di giustizia e ci va giù pesante. Minoli lo interpella
sul un articolo in cui aveva attaccato i giudici che avevano condannato Vincenzo
Muccioli, fondatore ed allora patron di San Patrignano. Una presa di posizione
che gli costò una querela. "Quello di Muccioli è uno dei più clamorosi casi in
cui la giustizia si è messa contro la coscienza popolare", spiega Montanelli.
Poi torna sulla sua querela: "Ne avrò delle altre. Non sono affatto disposto a
tollerare una magistratura come quella che abbiamo in Italia". Montanelli
continua attaccando il protagonismo delle toghe, puntando il dito in particolare
contro il magistrato Carlo Palermo, e denunciando le degenerazioni di una stampa
sempre più sensazionalistica e di una magistratura sempre più arrogante. Ma non
solo. Il giornalista mette alla berlina i giudici che cavalcano le indagini per
farsi vedere e poi, dopo aver rovinato uomini e aziende, non pagano per i loro
errori. Parole profetiche. Sembra storia di oggi, invece è storia e
basta. Insomma, una lezione attualissima. Una pagina sempreverde dell'infinita
cronaca del Paese Italia. Purtroppo.
Libri. "Discorsi potenti. Tecniche di persuasione
per lasciare il segno" di Trupia Flavia. Giusto per dire: con le parole fotti il
popolo…che i fatti possono aspettare. Alcuni discorsi colpiscono; altri,
invece, generano solo un tiepido applauso di cortesia. Dov'è la differenza? Cosa
rende un discorso potente? Certamente l'argomento, l'oratore, il luogo e il
momento storico sono fattori rilevanti. Ma non basta, occorre altro per dare
forza a un discorso. Occorre la retorica. L'arte del dire non può essere
liquidata come artificio ampolloso e manieristico. È, invece, una tecnica che
permette di dare gambe e respiro a un'idea. È la persuasione la sfida
affascinante della retorica. Quell'istante magico in cui le parole diventano
condivisione, emozione, voglia di agire, senso di appartenenza, comune sentire
dell'uditorio. Non è magia nera, ma bianca, perché la parola è lo strumento
della democrazia. La retorica non è morta, non appartiene al passato. Fa parte
della nostra vita quotidiana molto più di quanto immaginiamo. Siamo tutti
retori, consapevoli o inconsapevoli. Tuttavia, per essere buoni retori è
necessaria la conoscenza dell'arte oratoria. Ciò non vale solo per i politici ma
per tutti coloro che si trovano nella condizione di pronunciare discorsi,
presentare relazioni, convincere o motivare i propri interlocutori, argomentare
sulla validità di una tesi o di un pensiero. Ecco allora un manuale che analizza
le tecniche linguistiche utilizzate dai grandi oratori dei nostri giorni e ne
svela i meccanismi di persuasione. Perché anche noi possiamo imparare a
"lasciare il segno".
«Grillo è l'invidia», B. è l'inganno', dice Trupia
a Rossana Campisi su “L’Espresso”.
Quali sono gli strumenti retorici dei politici?
Un'esperta di comunicazione li ha studiati. E sostiene che il fondatore del M5S
punta sulla rabbia verso chi sta in alto, mentre il capo del Pdl 'vende' sempre
un sogno che non si realizzerà mai.
Che la nostra felicità dipendesse da un pugnetto
di anafore, non ce lo avevano ancora detto. O forse si. «Gorgia da Lentini si
godeva la Magna Grecia. Un bel giorno, smise di pensare e disse: la parola è
farmacon. Medicina ma anche veleno». Flavia Trupia, ghostwriter ed esperta di
comunicazione, ce lo ricorda. La storia dell'umanità, del resto, è lunga di
esempi che lei ha ripreso in Discorsi potenti. Tecniche di persuasione per
lasciare il segno (FrancoAngeli) e nel suo
blog. «Spesso
dimentichiamo il potere dell'arte della parola. La retorica insomma. Poi
arrivano certi anniversari e tutti lì a prendere appunti».
Sono i 50 anni di I Have a Dream. Martin Luther
King Jr., davanti al Lincoln Memorial di Washington, tiene il discorso
conclusivo della marcia su Washington. Partiamo da qui?
«Sì, è uno di quelli che i linguisti non hanno mai
smesso di studiare. Si tratta di un vero atto linguistico: le parole diventano
azione. King aveva 34 anni, sarebbe morto dopo cinque anni. Quel 28 agosto del
1963 ha cambiato il mondo».
Con le sue parole?
«Chiamale parole. Lì dentro c'è tutto il mondo in
cui credono ancora oggi gli americani: i riferimenti alla Bibbia, ne trovi una
in ogni hotel e in ogni casa, quelli alle costituzioni e alle dichiarazioni
nazionali, quelli ai motel, luogo tipico della cultura americana dove ti puoi
riposare in viaggio. E poi ripeteva sempre "today": l'efficienza americana è da
sempre impaziente».
Strategia dei contenuti.
«Magari fossero solo quelli. C'è il ritmo che è
fondamentale. E poi cosa dire di quella meravigliosa anafora diventata quasi il
ritornello di una canzone? "I Have a Dream" è ripetuto ben otto volte».
Il potere ha proprio l'oro in bocca.
«King ha cambiato il mondo rendendo gli uomini più
uomini e meno bestie. Anche Goebbles faceva discorsi molto applauditi. Ma ha
reso gli uomini peggio delle bestie».
Anche gli italiani hanno avuto bisogno di
"discorsi" veri, no?
«Certo. Beppe Grillo è stato un grande
trascinatore, ha emozionato le piazze, le ha fatte ridere e piangere. Il suo
stile però è quello delle Filippiche. Inveire sempre. Scatenare l'invidia e
l'odio per chi ha il posto fisso, per chi sta in Parlamento. Muove le folle ma
costruisce poco».
Abbiamo perso anche questa occasione.
«King diceva di non bere alla coppa del rancore e
dell'odio. Questa è una grande differenza tra i due. Il suo era in fondo un
invito in fondo all'unità nazionale e la gente, bianca e nera, lo ha sentito».
Ma era anche un invito a sognare.
«Anche Berlusconi ha fatto sognare gli italiani.
Indimenticabile il suo discorso d'esordio: "L'Italia è il paese che io amo". La
gente aveva iniziato a pensare che finalmente si poteva fare politica in modo
diverso e che si poteva parlare di ricchezza senza imbarazzi. Quello che propone
però è un sogno infinito».
In che senso?
«Lo scorso febbraio ha fatto ancora promesse: non
far pagare l'Imu. Lo ha fatto anche lui in termini biblici sancendo una sorta di
alleanza tra gli italiani e lo Stato. Ma non è questo quello di cui abbiamo
bisogno».
E di cosa?
«L'Imu da non pagare non basta. Aneliamo tutti a
una visione diversa del paese dove viviamo, della nostra storia comune e
personale».
Ci faccia un esempio.
«Alcide De Gasperi. Era appena finita la seconda
guerra mondiale, lo aspettava la Conferenza di pace a Parigi. Partì per andare a
negoziare le sanzioni per l'Italia che ne era uscita perdente. Questo piccolo
uomo va ad affrontare letteralmente il mondo. Arriva e non gli stringono neanche
la mano».
Cosa otterrà?
«Inizia il suo discorso così: "Avverto che in
quest'aula tutto è contro di me...". Ha usato parole semplici ed educate. E'
riuscito a far capire che l'Italia era ancora affidabile. Ha ottenuto il massimo
del rispetto. Tutti cambiarono idea, capirono che il paese aveva chiuso col
fascismo».
Sono passati un bel po' di anni.
«Solo dopo dieci quel discorso l'Italia divenne
tra le potenze industriali più potenti del mondo».
La domanda «Perché oggi non ci riusciamo?»
potrebbe diventare un'ennesima figura retorica: excusatio non petita
accusatio manifesta.... Tanto vale.
STATO DI DIRITTO?
Berlusconi, il discorso
integrale. Ecco l’intervento video del Cavaliere: «Care amiche, cari
amici, voglio parlarvi con la sincerità con cui ognuno di noi parla alle persone
alle quali vuole bene quando bisogna prendere una decisione importante che
riguarda la nostra famiglia. Che si fa in questi casi? Ci si guarda negli occhi,
ci si dice la verità e si cerca insieme la strada migliore. Siete certamente
consapevoli che siamo precipitati in una crisi economica senza precedenti, in
una depressione che uccide le aziende, che toglie lavoro ai giovani, che
angoscia i genitori, che minaccia il nostro benessere e il nostro futuro. Il
peso dello Stato, delle tasse, della spesa pubblica è eccessivo: occorre
imboccare la strada maestra del liberalismo che, quando è stata percorsa, ha
sempre prodotto risultati positivi in tutti i Paesi dell’Occidente: qual è
questa strada? Meno Stato, meno spesa pubblica, meno tasse. Con la sinistra al
potere, il programma sarebbe invece, come sempre, altre tasse, un’imposta
patrimoniale sui nostri risparmi, un costo più elevato dello Stato e di tutti i
servizi pubblici. I nostri ministri hanno già messo a punto le nostre proposte
per un vero rilancio dell’economia, proposte che saranno principalmente volte a
fermare il bombardamento fiscale che sta mettendo in ginocchio le nostre
famiglie e le nostre imprese. Ma devo ricordare che gli elettori purtroppo non
ci hanno mai consegnato una maggioranza vera, abbiamo sempre dovuto fare i conti
con i piccoli partiti della nostra coalizione che, per i loro interessi
particolari, ci hanno sempre impedito di realizzare le riforme indispensabili
per modernizzare il Paese, prima tra tutte quella della giustizia. E proprio per
la giustizia, diciamoci la verità, siamo diventati un Paese in cui non vi è più
la certezza del diritto, siamo diventati una democrazia dimezzata alla mercé di
una magistratura politicizzata, una magistratura che, unica tra le magistrature
dei Paesi civili, gode di una totale irresponsabilità, di una totale impunità.
Questa magistratura, per la prevalenza acquisita da un suo settore, Magistratura
Democratica, si è trasformata da “Ordine” dello Stato, costituito da impiegati
pubblici non eletti, in un “Potere” dello Stato, anzi in un “Contropotere” in
grado di condizionare il Potere legislativo e il Potere esecutivo e si è data
come missione, quella - è una loro dichiarazione - di realizzare “la via
giudiziaria” al socialismo. Questa magistratura, dopo aver eliminato nel ’92 -
’93 i cinque partiti democratici che ci avevano governati per cinquant’anni,
credeva di aver spianato definitivamente la strada del potere alla
sinistra. Successe invece quel che sapete: un estraneo alla politica, un certo
Silvio Berlusconi, scese in campo, sconfisse la gioiosa macchina da guerra della
sinistra, e in due mesi portò i moderati al governo. Ero io. Subito, anzi
immediatamente, i P.M. e i giudici legati alla sinistra e in particolare quelli
di Magistratura Democratica si scatenarono contro di me e mi inviarono un avviso
di garanzia accusandomi di un reato da cui sarei stato assolto, con formula
piena, sette anni dopo. Cadde così il governo, ma da quel momento fino ad oggi
mi sono stati rovesciati addosso, incredibilmente, senza alcun fondamento nella
realtà, 50 processi che hanno infangato la mia immagine e mi hanno tolto tempo,
tanto tempo, serenità e ingenti risorse economiche. Hanno frugato ignobilmente e
morbosamente nel mio privato, hanno messo a rischio le mie aziende senza alcun
riguardo per le migliaia di persone serie ed oneste che vi lavorano, hanno
aggredito il mio patrimonio con una sentenza completamente infondata, che ha
riconosciuto a un noto, molto noto, sostenitore della sinistra una somma quattro
volte superiore al valore delle mie quote, con dei pretesti hanno attaccato me,
la mia famiglia, i miei collaboratori, i miei amici e perfino i miei ospiti. Ed
ora, dopo 41 processi che si sono conclusi, loro malgrado, senza alcuna
condanna, si illudono di essere riusciti ad estromettermi dalla vita politica,
con una sentenza che è politica, che è mostruosa, ma che potrebbe non essere
definitiva come invece vuol far credere la sinistra, perché nei tempi giusti,
nei tempi opportuni, mi batterò per ottenerne la revisione in Italia e in
Europa. Per arrivare a condannarmi si sono assicurati la maggioranza nei collegi
che mi hanno giudicato, si sono impadroniti di questi collegi, si sono inventati
un nuovo reato, quello di “ideatore di un sistema di frode fiscale”, senza
nessuna prova, calpestando ogni mio diritto alla difesa, rifiutandosi di
ascoltare 171 testimoni a mio favore, sottraendomi da ultimo, con un ben
costruito espediente, al mio giudice naturale, cioè a una delle Sezioni
ordinarie della Cassazione, che mi avevano già assolto, la seconda e la terza,
due volte, su fatti analoghi negando - cito tra virgolette - “l’esistenza in
capo a Silvio Berlusconi di reali poteri gestori della società
Mediaset”. Sfidando la verità, sfidando il ridicolo, sono riusciti a condannarmi
a quattro anni di carcere e soprattutto all’interdizione dai pubblici uffici,
per una presunta ma inesistente evasione dello zero virgola, rispetto agli oltre
10 miliardi, ripeto 10 miliardi di euro, quasi ventimila miliardi di vecchie
lire, versati allo Stato, dal ’94 ad oggi, dal gruppo che ho fondato. Sono
dunque passati vent’anni da quando decisi di scendere in campo. Allora dissi che
lo facevo per un Paese che amavo. Lo amo ancora, questo Paese, nonostante
l’amarezza di questi anni, una grande amarezza, e nonostante l’indignazione per
quest’ultima sentenza paradossale, perché, voglio ripeterlo ancora, con
forza, “io non ho commesso alcun reato, io non sono colpevole di alcunché, io
sono innocente, io sono assolutamente innocente”. Ho dedicato l’intera seconda
parte della mia vita, quella che dovrebbe servire a raccogliere i frutti del
proprio lavoro, al bene comune. E sono davvero convinto di aver fatto del bene
all’Italia, da imprenditore, da uomo di sport, da uomo di Stato. Per il mio
impegno ho pagato e sto pagando un prezzo altissimo, ma ho l’orgoglio di aver
impedito la conquista definitiva del potere alla sinistra, a questa sinistra che
non ha mai rinnegato la sua ideologia, che non è mai riuscita a diventare
socialdemocratica, che è rimasta sempre la stessa: la sinistra dell’invidia, del
risentimento e dell’odio. Devo confessare che sono orgoglioso, molto orgoglioso,
di questo mio risultato. Proprio per questo, adesso, insistono nel togliermi di
mezzo con un’aggressione scientifica, pianificata, violenta del loro braccio
giudiziario, visto che non sono stati capaci di farlo con gli strumenti della
democrazia. Per questo, adesso, sono qui per chiedere a voi, a ciascuno di voi,
di aprire gli occhi, di reagire e di scendere in campo per combattere questa
sinistra e per combattere l’uso della giustizia a fini di lotta politica, questo
male che ha già cambiato e vuole ancora cambiare la storia della nostra
Repubblica. Non vogliamo e non possiamo permettere che l’Italia resti rinchiusa
nella gabbia di una giustizia malata, che lascia tutti i giorni i suoi segni
sulla carne viva dei milioni di italiani che sono coinvolti in un processo
civile o penale. È come per una brutta malattia: uno dice “a me non capiterà”,
ma poi, se ti arriva addosso, entri in un girone infernale da cui è difficile
uscire. Per questo dico a tutti voi, agli italiani onesti, per bene, di buon
senso: reagite, protestate, fatevi sentire. Avete il dovere di fare qualcosa di
forte e di grande per uscire dalla situazione in cui ci hanno precipitati. So
bene, quanto sia forte e motivata la vostra sfiducia, la vostra nausea verso la
politica, verso “questa” politica fatta di scandali, di liti in tv, di una
inconcludenza e di un qualunquismo senza contenuti: una politica che sembra un
mondo a parte, di profittatori e di mestieranti drammaticamente lontani dalla
vita reale. Ma nonostante questo, ed anzi proprio per questo, occorre che noi
tutti ci occupiamo della politica. È sporca? Ma se la lasci a chi la sta
sporcando, sarà sempre più sporca… Non te ne vuoi occupare? Ma è la politica
stessa che si occuperà comunque di te, della tua vita, della tua famiglia, del
tuo lavoro, del tuo futuro. È arrivato quindi davvero il momento di svegliarci,
di preoccuparci, di ribellarci, di indignarci, di reagire, di farci sentire. È
arrivato il momento in cui tutti gli italiani responsabili, gli italiani che
amano l’Italia e che amano la libertà, devono sentire il dovere di impegnarsi
personalmente. Per questo credo che la cosa migliore da fare sia quella di
riprendere in mano la bandiera di Forza Italia. Perché Forza Italia non è un
partito, non è una parte, ma è un’idea, un progetto nazionale che unisce tutti.
Perché Forza Italia è l’Italia delle donne e degli uomini che amano la libertà
e che vogliono restare liberi. Perché Forza Italia è la vittoria dell’amore
sull’invidia e sull’odio. Perché Forza Italia difende i valori della nostra
tradizione cristiana, il valore della vita, della famiglia, della solidarietà,
della tolleranza verso tutti a cominciare dagli avversari. Perché Forza Italia
sa bene che lo Stato deve essere al servizio dei cittadini e non invece i
cittadini al servizio dello Stato. Perché Forza Italia è l’ultima chiamata prima
della catastrofe. È l’ultima chiamata per gli italiani che sentono che il
nostro benessere, la nostra democrazia, la nostra libertà sono in pericolo e
rendono indispensabile un nuovo, più forte e più vasto impegno. Forza Italia
sarà un vero grande movimento degli elettori, dei cittadini, di chi vorrà
diventarne protagonista. Una forza che può e che deve conquistare la
maggioranza dei consensi perché, vi ricordo, che solo con una vera e autonoma
maggioranza in Parlamento si può davvero fare del bene all’Italia, per tornare
ad essere una vera democrazia e per liberarci dall’oppressione giudiziaria, per
liberarci dall’oppressione fiscale, per liberarci dall’oppressione burocratica.
Per questo vi dico: scendete in campo anche voi. Per questo ti dico: scendi in
campo anche tu, con Forza Italia. Diventa anche tu un missionario di libertà,
diffondi i nostri valori e i nostri programmi, partecipa ai nostri convegni e
alle nostre manifestazioni, impegnati nelle prossime campagne elettorali e
magari anche nelle sezioni elettorali per evitare che ci vengano sottratti
troppi voti, come purtroppo è sempre accaduto. Voglio ripeterlo ancora: in
questo momento, nella drammatica situazione in cui siamo, ogni persona
consapevole e responsabile che vuol continuare a vivere in Italia ha il dovere
di occuparsi direttamente del nostro comune destino. Io sarò sempre con voi, al
vostro fianco, decaduto o no. Si può far politica anche senza essere in
Parlamento. Non è il seggio che fa un leader, ma è il consenso popolare, il
vostro consenso. Quel consenso che non mi è mai mancato e che, ne sono sicuro,
non mi mancherà neppure in futuro. Anche se, dovete esserne certi, continueranno
a tentare di eliminare dalla scena politica, privandolo dei suoi diritti
politici e addirittura della sua libertà personale, il leader dei moderati,
quegli italiani liberi che, voglio sottolinearlo, sono da sempre la maggioranza
del Paese e lo saranno ancora se sapranno finalmente restare uniti. Sono
convinto che mi state dando ragione, sono convinto che condividete questo mio
allarme, sono convinto che saprete rispondere a questo mio appello, che è prima
di tutto una testimonianza di amore per la nostra Italia. E dunque: Forza
Italia! Forza Italia! Forza Italia! Viva l’Italia, viva la libertà: la libertà è
l’essenza dell’uomo e Dio creando l’uomo, l’ha voluto libero.»
Lettera aperta al dr Silvio
Berlusconi.
«Sig. Presidente, sono Antonio
Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Diverso, perché, nell’informare la
gente dell’imperante ingiustizia, i magistrati se ne lamentano. E coloro che io
critico, poi, sono quelli che mi giudicano e mi condannano. Ma io, così come
altri colleghi perseguitati che fanno vera informazione, non vado in televisione
a piangere la mia malasorte.
Pur essendo noi, per i
forcaioli di destra e di sinistra, “delinquenti” come lei.
Sono un liberale, non come
lei, ed, appunto, una cosa a Lei la voglio dire.
Quello che le è capitato, in
fondo, se lo merita. 20 anni son passati. Aveva il potere economico. Aveva il
potere mediatico. Aveva il potere politico. Aveva il potere istituzionale. E non
è stato capace nemmeno di difendere se stesso dallo strapotere dei magistrati.
Li ha lasciati fare ed ha tutelato gli interessi degli avvocati e di tutte le
lobbies e le caste, fregandosene dei poveri cristi. Perché se quello di cui si
lamenta, capita a lei, figuriamoci cosa capita alla povera gente. E i suoi
giornalisti sempre lì a denunciare abusi ed ingiustizie a carico del loro
padrone. Anzi, lei, oltretutto, imbarca nei suoi canali mediatici gente
comunista genuflessa ai magistrati. Non una parola sul fatto che l’ingiustizia
contro uno, siffatto potente, è l’elevazione a sistema di un cancro della
democrazia. Quanti poveri cristi devono piangere la loro sorte di innocenti in
carcere per convincere qualcuno ad intervenire? Se è vero, come è vero, che se
funzionari di Stato appartenenti ad un Ordine si son elevati a Potere, è
sacrosanto sostenere che un leader politico che incarna il Potere del popolo non
sta lì a tergiversare con i suoi funzionari, ma toglie loro la linfa che
alimenta lo strapotere di cui loro abusano. Ma tanto, chi se ne fotte della
povera gente innocente rinchiusa in canili umani.
“Chi non conosce la verità è
uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma
di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che
la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica,
anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso! Ha mai
pensato, per un momento, che c’è qualcuno che da anni lavora indefessamente per
farle sapere quello che non sa? E questo al di là della sua convinzione di
sapere già tutto dalle sue fonti? Provi a leggere un e-book o un book di Antonio
Giangrande. Scoprirà, cosa succede veramente in Italia. Cose che nessuno a lei
vicino le dirà mai. Non troverà le cose ovvie. Cose che servono solo a bacare la
mente. Troverà quello che tutti sanno, o che provano sulla loro pelle, ma che
nessuno ha il coraggio di raccontare.
Può anche non leggere questi
libri, frutto di anni di ricerca, ma nell’ignoranza imperante che impedisce
l’evoluzione non potrà dire che la colpa è degli altri e che gli altri son tutti
uguali.
Ad oggi, per esempio, sappiamo
che lo studio di due ricercatori svela: i magistrati di sinistra indagano di più
gli avversari politici; i magistrati di destra insabbiano di più le accuse
contro i loro amici e colleghi. E poi. Parla l’ex capo dei Casalesi. La camorra
e la mafia non finirà mai, finchè ci saranno politici, magistrati e forze
dell’ordine mafiosi. Inutile lamentarci dei "Caccamo" alla Cassazione. Carmine
Schiavone ha detto: Roma nostra! "Ondata di ricorsi dopo il «trionfo». Un
giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici, Napoli capitale dei promossi.
L'area coperta dalla Corte d'appello ha «prodotto» un terzo degli aspiranti
magistrati. E un terzo degli esaminatori". O la statistica è birichina assai
o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale concorso di accesso alla
magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici ammessi agli orali vengono
infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli, che rappresenta solo un
trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della popolazione italiana. Un
trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza: erano della stessa area,
più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della commissione e 5 su 8 dei docenti
universitari. Cioè oltre un terzo degli esaminatori. Lo strumento per
addentrarsi nei gangli del potere sono gli esami di Stato ed i concorsi pubblici
truccati.
Bene, dr Berlusconi, Lei,
avendone il potere per 20 anni, oltre che lamentarsi, cosa ha fatto per
tutelare, non tanto se stesso, i cui risultati sono evidenti, ma i cittadini
vittime dell’ingiustizia (contro il singolo) e della malagiustizia (contro la
collettività)?
Quello che i politici oggi
hanno perso è la credibilità: chi a torto attacca i magistrati; chi a torto li
difende a spada tratta; chi a torto cerca l’intervento referendario inutile in
tema di giustizia, fa sì che quel 50 % di astensione elettorale aumenti. Proprio
perché, la gente, è stufa di farsi prendere in giro. Oltremodo adesso che siete
tutti al Governo delle larghe intese per fottere il popolo. Quel popolo che mai
si chiede: ma che cazzo di fine fanno i nostri soldi, che non bastano mai? E
questo modo di fare informazione e spettacolo della stampa e della tv,
certamente, alimenta il ribrezzo contro l'odierno sistema di potere.
Per fare un sillogismo. Se
l’Italia è la Costa Concordia, e come tale è affondata, la colpa non è dello
Schettino di turno, ma dell’equipaggio approssimativo di cui si è circondato. E
se la Costa Crociere ha la sua Flotta e l’Italia ha la sua amministrazione
centrale e periferica, quanti Schettino e relativi equipaggi ci sono in giro a
navigare? E quante vittime i loro naufragi provocano? Si dice che l’Italia, come
la Costa Concordia, è riemersa dall’affondamento? Sì, ma come? Tutta ammaccata e
da rottamare!!! E gli italioti lì a belare……»
Antonio Giangrande,
orgoglioso di essere diverso.
“Chi non conosce la verità
è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. È uno Stato di diritto che funziona quello che
è costretto a sborsare ogni anno decine di milioni per rimborsare cittadini che
hanno dovuto trascorrere giorni, mesi, anni in carcere da innocenti? È uno Stato
di diritto quello in cui dove dovrebbero stare 100 detenuti ce ne stanno 142? È
uno Stato di diritto quello in cui ogni quattro procedimenti già fissati per il
dibattimento tre vengono rinviati per motivi vari?
Domande che con Andrea Cuomo
su “Il Giornale” giriamo al premier Enrico Letta del Partito Democratico (ex
PCI), che - in funzione chiaramente anti-Cav - ha giurato: «In Italia lo Stato
di diritto funziona». Postilla: «Non ci sono persecuzioni». Chissà che cosa
pensano in particolare di questa ultima affermazione categorica le tantissime
vittime di errori giudiziari a cui il quotidiano romano Il Tempo ha dedicato
un'inchiesta di cinque giorni che ha contrassegnato l'insediamento alla
direzione del nostro ex inviato Gian Marco Chiocci, che di giornalismo
giudiziario ne mastica eccome.
Tanti i dati sciorinati e le
storie raccontate dal quotidiano di piazza Colonna. Secondo cui per il Censis,
nel dopoguerra, sono stati 5 milioni gli italiani coinvolti in inchieste
giudiziarie e poi risultati innocenti. Di essi circa 25mila sono riusciti a
ottenere il rimborso per ingiusta detenzione a partire dal 1989, per un esborso
totale di 550 milioni di euro in tutto: del resto per ogni giorno passato in
carcere lo Stato riconosce all'innocente 235,83 euro, e la metà (117,91) in caso
di arresti domiciliari. Il tetto massimo di rimborso sarebbe di 516.456,90 euro.
Ma Giuseppe Gulotta, che con il marchio di duplice assassino impresso sulla
pelle da una confessione estorta a forza di botte (metodo usato per tutti) ha
trascorso in cella 22 anni per essere scagionato nel 2012, pretende 69 milioni.
Tanto, se si pensa al tetto di cui sopra. Nulla se questo è il prezzo di una
vita squartata, merce che un prezzo non ce l'ha. Per il caso Sebai, poi, è
calata una coltre di omertà. I condannanti per i delitti di 13 vecchiette, anche
loro menati per rendere una confessione estorta, sono ancora dentro, meno uno
che si è suicidato. Questi non risultano come vittime di errori giudiziari,
nonostante il vero assassino, poi suicidatosi, ha confessato, con prove a
sostegno, la sua responsabilità. Lo stesso fa Michele Misseri, non creduto,
mentre moglie e figlia marciscono in carcere. Siamo a Taranto, il Foro
dell’ingiustizia.
E siccome i cattivi giudici
non guardano in faccia nessuno, spesso anche i vip sono caduti nella trappola
dell'errore giudiziario. Il più famoso è Enzo Tortora. Ma ci sono anche Serena
Grandi, Gigi Sabani, Lelio Luttazzi, Gioia Scola, Calogero Mannino e Antonio
Gava nel Who's Who della carcerazione ingiusta. Carcerazione che è a suo modo
ingiusta anche per chi colpevole lo è davvero quando è trascorsa nelle 206
carceri italiane. La cui capienza ufficiale sarebbe di 45.588 persone ma ne
ospitano 66.632. Lo dice il rapporto «Senza Dignità 2012» dell'associazione
Antigone, vero museo degli orrori delle prigioni d'Italia. Il Paese secondo il
cui premier «lo Stato di diritto è garantito». Pensate se non lo fosse.
Non solo ci è impedito dire
“Italia di Merda” in base alla famosa sentenza della Corte di Cassazione. In
questo Stato, addirittura, è vietato dire “Fisco di Merda”. Per gli stilisti
Domenico Dolce e Stefano Gabbana, con le
motivazioni della sentenza del tribunale di Milano che il 19 luglio 2013 li ha
condannati a un anno e otto mesi di reclusione per il reato di omessa
dichiarazione dei redditi, è arrivata, dopo il danno, anche la beffa. La
sentenza li obbliga a risarcire con 500mila euro il «danno morale»
arrecato al Fisco italiano. Di cosa sono colpevoli? Da molti anni i «simboli»
della moda italiana denunciano l’eccessiva pressione fiscale. All’indomani della
sentenza avevano chiuso per protesta i negozi di Milano. E una critica, pare,
può costare cara. La sentenza sembra quasi contenere una excusatio non petita:
il danno, scrivono i magistrati, è dovuto «non tanto, ovviamente, per
l’esposizione a legittime critiche in merito agli accertamenti, quanto per il
pregiudizio che condotte particolarmente maliziose cagionano alla funzionalità
del sistema di accertamento ed alla tempestiva percezione del tributo».
Ora venite a ripeterci che le
sentenze non si discutono, scrive Filippo Facci. Gli stilisti Dolce & Gabbana
sono già stati condannati a un anno e otto mesi per evasione fiscale, e pace, lo
sapevamo. Ma, per il resto, chiudere i propri negozi per protesta è un reato
oppure non lo è. E non lo è. Il semplice denunciare l’eccesso di pressione
fiscale è un reato oppure non lo è. E non lo è. Comprare una pagina di giornale
per lamentarsi contro Equitalia è un reato oppure non lo è. E non lo è.
Rilasciare interviste contro il fisco rapace è un reato oppure non lo è. E non
lo è. E se non lo è - se queste condotte non sono reati - la magistratura non
può prendere questi non-reati e stabilire che nell’insieme abbiano inferto un
«danno morale» al fisco italiano, come si legge nelle motivazioni della sentenza
appena rese note. I giudici non possono stabilire che degli atti leciti
«cagionano pregiudizio alla funzionalità del sistema di accertamento e alla
tempestiva percezione del tributo». Ergo, i giudici non possono affibbiare a
Dolce & Gabbana altri 500mila euro di risarcimento per «danno morale», come
hanno fatto: perché significa che il diritto di critica è andato definitivamente
a ramengo e che la sola cosa da fare è pagare e stare zitti, perché sennò la
gente, sai, poi pensa male di Equitalia. Ecco perché occorre proteggerla da
quella moltitudine di crudeli cittadini pronti a infliggerle terrificanti danni
morali con le loro lagnanze. Siamo alla follia.
Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei
miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio
i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Ha mai pensato, per un
momento, che c’è qualcuno che da anni lavora indefessamente per farle sapere
quello che non sa? E questo al di là della sua convinzione di sapere già tutto
dalle sue fonti?
Provi a leggere un e-book o un
book di Antonio Giangrande. Scoprirà, cosa succede veramente nella sua regione o
in riferimento alla sua professione. Cose che nessuno le dirà mai.
Non troverà le cose ovvie
contro la Mafia o Berlusconi o i complotti della domenica. Cose che servono solo
a bacare la mente. Troverà quello che tutti sanno, o che provano sulla loro
pelle, ma che nessuno ha il coraggio di raccontare.
Può anche non leggere questi
libri, frutto di anni di ricerca, ma nell’ignoranza imperante che impedisce
l’evoluzione non potrà dire che la colpa è degli altri e che gli altri son tutti
uguali.
CHI E’ IL POLITICO?
Ora lo dice anche la scienza:
la politica manda fuori di testa. Incapace di accettare idee diverse e pronto a
manipolare i dati a proprio comodo. Il cervello della casta secondo Yale, scrive
“Libero Quotidiano”. Oramai c'è anche il sigillo della scienza: la
politica rende intellettualmente disonesti. Lo
dimostra uno studio condotto da Dan Kahan della Yale
University: la passione politica compromette il funzionamento della
mente e induce a distorcere logica e capacità di calcolo. Perché? Perché il
cervello del politico, come risulta dallo studio, prova a ogni costo
a modificare i dati reali per farli aderire alla propria visione del mondo.
L'esperimento, la prima parte
- Tra i vari esperimenti che hanno composto lo studio (pubblicato col titolo “Motivated
numeracy and Enlightened self-government”), ce n'è uno che illustra meglio
di tutti il meccanismo di deformazione intellettuale dei politici. E' stato
chiesto alle "cavie" di interpretare delle tavole numeriche relativa alla
capacità di provocare prurito di alcune creme dermatologiche.
Non avendo l'argomento implicazioni sociali, i politici sono
stati in grado di eseguire correttamente i calcoli aritmetici.
L'esperimento, la seconda parte -
In seconda battuta, allo stesso campione umano è stato chiesto di leggere tavole
che per tema, però, avevano il rapporto tra licenze dei porti d'armi e
variazione del tasso di criminalità. E i nodi sono venuti al pettine. Avendo
l'argomento ovvia rilevanza politica, le cavie sono andate in
tilt. Quando si trovavano a dover rispondere a quesiti aritmetici in
contraddizione con le proprie convinzioni, sbagliavano
in maniera inconscia anche calcoli semplici per non dover arrivare a una
soluzione sgradita. Insomma: meglio andare fuori strada che
imboccare una strada spiacevole.
Le conclusioni -
Il prof della Yale non
ha dubbi: la passione politica è una fatto congenito che però condiziona
il cervello. Una volta che il politico fa sua una certa visione del
mondo, non c'è dato o riscontro oggettivo che possa fargli cambiare idea.
CHI E’ L’AVVOCATO?
Chi è l’avvocato:
fenomenologia di una categoria, spiega un anonimo sul portale “La Legge per
tutti”.
O li si ama o li si odia: non
esistono vie di mezzo per gli avvocati, una delle categorie professionali più
contraddittorie e discusse dai tempi degli antichi greci.
“E il Signore disse:
Facciamo Satana, così la gente non mi incolperà di tutto. E facciamo gli
avvocati, così la gente non incolperà di tutto Satana”.
La battuta del comico
statunitense, George Burns, è il modo migliore per aprire l’argomento su una
delle professioni da sempre più discusse. Perché, diciamoci la verità, appena si
parla di “avvocati” la prima idea che corre è quella di una “categoria“: non
tanto nel senso di lobby, quanto di un mondo sociale a parte, con i suoi strani
modi di essere e di pensare. Insomma, proprio come quando si pensa ad una razza
animale.
Difensori dei diritti o
azzeccagarbugli abili solo a far assolvere i colpevoli? Professionisti della
logica o dotati retori? La linea di confine è così labile che l’immaginario
collettivo li ha sempre collocati a cavallo tra la menzogna e il rigore.
Di tutto questo, però, una
cosa è certa: gli avvocati formano un mondo a sé.
La parola “avvocato” deriva
dal latino “vocatus“‘ ossia “chiamato”. Non nel senso, come verrebbe spontaneo
pensare, che all’indirizzo di questa figura vengono rivolti irripetibili epiteti
offensivi, ma nel significato che a lui ci si rivolge quando si ha bisogno di
aiuto.
L’odio da sempre legato al
legale va a braccetto con la parola “parcella“: un peso che ha trascinato questa
categoria nel più profondo girone dantesco. Perché – la gente si chiede –
bisogna pagare (anche profumatamente) per far valere i propri diritti? In
realtà, la risposta è la stessa per cui bisogna remunerare un medico per godere
di buona salute o aprire un mutuo per avere un tetto sotto cui dormire.
Tuttavia, i fondamenti della difesa legale risalgono a quando, già dagli antichi
greci, i soliti individui omaggiati di improvvisa ricchezza erano anche quelli
inabissati di profonda ignoranza: costoro trovarono più conveniente affidare ai
più istruiti la difesa dei propri interessi. E ciò fu anche la consegna delle
chiavi di un’intera scienza. Perché, da allora, il popolo non si è più
riappropriato di ciò che era nato per lui: la legge.
I primi avvocati erano anche
filosofi, e questo perché non esistevano corpi legislativi definiti e certi.
Erano, insomma, la classe che non zappava, ma guardava le stelle. Un’anima
teorica che, a quanto sembra, è rimasta sino ad oggi.
Ciò che, però, si ignora è
che, ai tempi dei romani, il compenso dell’avvocato era la fama, acquisita la
quale si poteva pensare d’intraprendere la carriera politica. In quel periodo
sussisteva il divieto di ricevere denaro in cambio delle proprie prestazioni
professionali e la violazione di tale precetto era sanzionata con una pena
pecuniaria. Il divieto, sin da allora e secondo buona prassi italica, veniva
sistematicamente raggirato poiché era consentito – proprio come avviene oggi nei
migliori ambienti della pubblica amministrazione – accettare doni e regalie da
parte dei clienti riconoscenti. Da qui venne il detto: “ianua advocati pulsanda
pede” (“alla porta dell’avvocato si bussa col piede”, visto che le mani sono
occupate a reggere i doni).
“La giurisprudenza estende la
mente e allarga le vedute”: una considerazione che, seppur vera, si scontra con
la prassi. Il carattere di un avvocato, infatti, è permaloso e presuntuoso.
Provate a fargli cambiare idea: se ci riuscirete sarà solo perché lui vi ha
fatto credere così. In realtà, ogni avvocato resta sempre della propria idea.
Giusta o sbagliata che sia. Ed anche dopo la sentenza che gli dà torto. A
sbagliare è sempre il giudice o la legge.
L’avvocato è una persona
abituata a fare domande e, nello stesso tempo, ad essere evasivo a quelle che
gli vengono rivolte. È solito prendere decisioni e a prenderle in fretta
(calcolate la differenza di tempi con un ingegnere e vedrete!). È dotato di
problem solving e il suo obiettivo è trovare l’escamotage per uscire fuori dal
problema, in qualsiasi modo possibile.
Inoltre, l’avvocato,
nell’esercizio della propria professione, è un irriducibile individualista: se
ne sta nel suo studio, a coltivare le sue pratiche, e l’idea dell’associativismo
gli fa venire l’orticaria.
Egli considera ogni minuto
sottratto al proprio lavoro una perdita di tempo. Il tempo appunto: ogni legale
nasce con l’orologio al polso, e questo perché la vita professionale è
costellata di scadenze. Tra termini iniziali, finali, dilatori, ordinatori,
perentori, ogni avvocato considera la propria agenda più della propria compagna
di letto.
Così come la caratteristica di
ogni buon medico è quella di scrivere le ricette con una grafia incomprensibile,
dote di ogni avvocato è parlare con un linguaggio mai chiaro per il cittadino.
Tra latinismi, istituti, tecnicismi, concettualismi, astrazioni, teorie e
interpretazioni, commi, articoli, leggi, leggine e sentenze, il vocabolario del
legale è precluso ad ogni persona che non sia, appunto, un altro legale. E
questo – a quanto sembra – gratifica infinitamente ogni avvocato che si
rispetti.
Su tutto, però, l’avvocato è
un relativista nell’accezione più pirandelliana del termine. La realtà non
esiste (e chi se ne frega!): esiste solo ciò che appare dalle carte. Tutto il
resto è mutevole, contraddittorio, variabile, volubile, capriccioso, instabile.
Tanto vale non pensarci e accontentarsi di ciò che racconta il cliente.
Si dice che il problema
dell’avvocatura sia il numero. Su 9.000 giudici, in Italia ci sono circa 220.000
avvocati. In realtà, il problema sarebbe di gran lunga più grave se di avvocati
ve ne fossero pochi, circostanza che aprirebbe le porte alla scarsità e, quindi,
a tariffe ancora più alte e a una certa difficoltà a poter difendere tutti.
La ragione di tale eccesso di
offerta risiede nel fatto che la facilità con cui si accede, oggi,
all’avvocatura ha fatto si che tale professione venisse considerata una sorta di
area di transito in cui potersi parcheggiare in attesa di un lavoro più
soddisfacente (e, di questi tempi, remunerativo). Poi, però, le cose non vanno
mai come programmato e ciò che doveva essere un impegno momentaneo diventa
quello di una vita (salvo tentare il classico concorso pubblico e inseguire la
chimera del posto fisso a reddito certo).
Ci piace terminare con le
parole di Giulio Imbarcati, pseudonimo di un collega che ha saputo prendere in
giro la categoria, disegnandola anche finemente in un suo libro di successo.
“Il
problema è che oggi nel campo dell’avvocatura (più che in altre professioni) non
è il mercato a operare la selezione.
Se così fosse tutti saremmo
più tranquilli e fiduciosi, perché questo vorrebbe dire qualità del servizio. E,
come dovrebbe essere in qualsiasi sistema sociale che voglia definirsi giusto,
dopo l’uguale allineamento ai nastri di partenza, i più dotati procedono veloci,
i mediocri arrancano, gli inadatti si fermano.
Ma, nel mondo
all’incontrario che abbiamo costruito con lungimirante impegno, le cose
funzionano diversamente.
Capita che siano proprio i
più dotati a soccombere e non solo davanti ai mediocri, ma anche rispetti agli
inadatti.
Perché? Ma perché proprio i
mediocri e gli inadatti sono quelli più disposti al compromesso e all’ipocrisia.
Proprio loro, cioè, per
raggiungere gli obiettivi, e consapevoli della modesta dote professionale, hanno
meno difficoltà a discostarsi da quelle coordinate di riferimento che i dotati
continuano a considerare sacre e inviolabili.
L’effetto, nel settore
dell’avvocatura, è dirompente e a pagarne gli effetti non sarà solo il fruitore
immediato (ossia il cittadino), ma l’intero sistema giustizia.“
DELINQUENTE A CHI?
“Chi non conosce la verità è
uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma
di Bertolt Brecht.
Parla l’ex capo dei Casalesi.
La camorra e la mafia non finirà mai, finchè ci saranno politici, magistrati e
forze dell’ordine mafiosi.
CARMINE SCHIAVONE.
MAGISTRATI: ROMA NOSTRA!
"Ondata
di ricorsi dopo il «trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici,
Napoli capitale dei promossi. L'area coperta dalla Corte d'appello ha «prodotto»
un terzo degli aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori".
O la statistica è
birichina assai o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale concorso di accesso
alla magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici ammessi agli orali
vengono infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli, che rappresenta solo
un trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della popolazione italiana.
Un trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza: erano della stessa
area, più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della commissione e 5 su 8 dei
docenti universitari. Cioè oltre un terzo degli esaminatori.
CHI E’ IL MAGISTRATO?
"Giustizia usata per scopi
politici". Se lo dice anche la Boccassini...
Una sparata senza precedenti contro le toghe politicizzate,
contro quella branca della magistratura che ha usato le aule di tribunale per
spiccare il volo in parlamento. A Ilda la Rossa, che la politica l'ha sempre
fatta direttamente nei corridoi del Palazzo di Giustizia di Milano, proprio non
vanno giù i vari Antonio Di Pietro, Luigi De Magistris e Antonio Ingroia che,
negli ultimi anni, hanno amaramente tentato di accaparrarsi una poltrona.
"Non è una patologia della magistratura - ha spiegato la pm di Milano - ma ci
sono dei pubblici ministeri che hanno usato il loro lavoro per altro".
«Ognuno deve fare la sua
parte, anche i politici, anche i giornalisti, ma in questi vent'anni lo sbaglio
di noi magistrati è di non aver mai fatto un'autocritica o una riflessione.
Perché si è verificato ed è inaccettabile che alcune indagini sono servite ad
altro (per gli stessi magistrati, per carriere, per entrare in politica)».
Alcuni suoi colleghi si sono sentiti portatori di verità assolute per le loro
indagini grazie al "consenso sociale", cosa sbagliatissima, una "patologia", sia
per lei, sia per Giuseppe Pignatone, procuratore capo di Roma, seduto al suo
fianco. Una sparata senza precedenti contro le toghe politicizzate,
contro quella branca della magistratura che ha usato le aule di tribunale per
spiccare il volo in parlamento. A Ilda la Rossa, che la politica l'ha sempre
fatta direttamente nei corridoi del Palazzo di Giustizia di Milano, proprio non
vanno giù i vari Antonio Di Pietro, Luigi De Magistris e Antonio Ingroia che,
negli ultimi anni, hanno amaramente tentato di accaparrarsi una poltrona.
"Non è una patologia della magistratura - ha spiegato la pm di Milano - ma ci
sono dei pubblici ministeri che hanno usato il loro lavoro per altro".
«Io - racconta Boccassini, che
dopo trent'anni ha cambiato colore e taglio di capelli, è diventata bionda -
durante Tangentopoli, stavo in Sicilia. Noi vivevano in hotel "bunkerizzati",
con i sacchi di sabbia, intorno era guerra. E quando arrivavo a Milano, per
salutare i colleghi, vedevo le manifestazioni a loro favore, "Forza mani
pulite""». E non le piaceva, anzi "ho provato una cosa terribile" quando la
folla scandiva i nomi dei magistrati, perché a muoverli "non dev'essere
l'approvazione". «Non è il consenso popolare che ci deve dare la forza di andare
avanti, ma il fatto di far bene il nostro mestiere. Ho sempre vissuto molto male
gli atteggiamenti osannanti delle folle oceaniche degli anni di Mani pulite e
delle stragi di mafia"». Intervenuta alla presentazione del libro di Lionello
Mancini, "L'onere della toga", il 14 settembre 2013 il pm milanese Ilda
Boccassini ha sottolineato gli atteggiamenti e le dinamiche che si sono
sviluppate nella magistratura negli ultimi vent'anni. «Un'anomalia dalla quale
dovremo uscire per forza di cose. Quello che rimprovero alla mia categoria è di
non aver mai fatto una seria autocritica in tutti questi anni», ha concluso.
Come ha sottolineato Giuseppe
Pignatone, una riflessione dovrebbe nascere in seguito al processo Borsellino:
ci sono stati dei condannati sino alla cassazione, ma poi le confessioni di un
collaboratore di giustizia hanno raccontato che la verità era un'altra: "Chi ha
sbagliato in buona fede deve dirlo", perché i magistrati dell'accusa devono
muoversi sempre sulle prove certe, invece, a volte, ripete Pignatone, "quando le
prove non ci sono, alcune notizie vengono fatte uscire sui giornali, per una
carica moralistica che non deve appartenere alla magistratura". Anzi, è il
contrario. La parola che Pignatone usa di più è "equilibrio", sia per fermarsi,
per evitare che persone finiscano nei guai senza prove, sia "per partire e
andare sino in fondo quando le prove ci sono". Tutti e due hanno collaborato a
lungo nelle inchieste che hanno decimato alcune tra le cosche più potenti della
'ndrangheta.

Sono entrambi - e lo dicono -
in prima pagina dieci volte di più dei colleghi citati nel libro di Mancini, ma
conoscono la "nausea" comune a chiunque debba fare un mestiere difficile, che ha
a che fare con la vita, la morte, il dolore. E per questo, "se un giornalista ha
una notizia che mette in pericolo la vita di una persona, non la deve dare",
dice Boccassini, Pignatone concorda, De Bortoli e Mancini alzano gli occhi al
cielo.
L’idolatria è il male endemico
di una società debole. Ha come effetti il ridimensionamento della condizione
civile del singolo, il suo declassamento da cittadino a cliente oppure a
percettore di una identità e/o idealità passive, chiuse nel recinto di una
tifoseria. Io sono con te, sempre e comunque. Non amo altro Dio all’infuori di
te. Fa dunque bene Ilda Boccassini a denunciare la
trasformazione sociale dell’identità del magistrato, sia esso giudice o
pubblico ministero, che nella storia recente della Repubblica è spesso assurto a
stella del firmamento sociale, si è fatto, malgrado ogni sua buona e
condivisibile intenzione, parte di una battaglia; ha goduto di un
riconoscimento che magari esuberava dalle sue funzioni, dalla qualità
di rappresentante della legge (“uguale per tutti”) che gli avrebbe dovuto far
osservare l’obbligo di assoluta e rigorosa discrezione.
LA SCIENZA LO DICE: I
MAGISTRATI FANNO POLITICA. I ROSSI ATTACCANO. GLI AZZURRI INSABBIANO.
Ecco la prova: i giudici fanno
politica. Lo studio di due ricercatori svela: i magistrati di sinistra
indagano di più la destra. Ecco la prova: i giudici fanno politica. La
persecuzione degli avversari rilevata in un saggio scientifico, scrive Luca
Fazzo su “Il Giornale”. Alla fine, la questione può essere riassunta così, un
po' cinicamente: ma d'altronde il convegno si tiene nella terra del Machiavelli.
«Chiunque di noi fa preferenze. Se può scegliere se indagare su un nemico o su
un amico, indaga sul nemico. È l'istinto umano. E vale anche in politologia».
Parola di Andrea Ceron, ricercatore alla facoltà di Scienze politiche di Milano.
Che insieme al collega Marco Mainenti si è messo di buzzo buono a cercare
risposte scientifiche a una domanda che si trascina da decenni: ma è vero che in
Italia i giudici indagano in base alle loro preferenze politiche? La risposta
Ceron e Mainenti la daranno oggi a Firenze, presentando il loro paper -
anticipato ieri dal Foglio - in occasione del convengo annuale della Società
italiana di Scienza politica. È una risposta basata su tabelle un po' difficili
da capire, modelli matematici, eccetera. Ma la risposta è chiara: sì, è vero. La
magistratura italiana è una magistratura politicizzata, le cui scelte sono
condizionate dalle convinzioni politiche dei magistrati. I pm di sinistra
preferiscono indagare sui politici di destra. I pm di destra chiudono un occhio
quando di mezzo ci sono i loro referenti politici. Una tragedia o la conferma
scientifica dell'esistenza dell'acqua calda? Forse tutte e due le cose insieme.
Ventidue pagine, rigorosamente scritte in inglese, intitolate «Toga Party: the
political basis of judicial investigations against MPs in Italy, 1983-2013».
Dove MPs è l'acronimo internazionale per «membri del Parlamento». I politici, la
casta, quelli che da un capo all'altro della terra devono fare i conti con le
attenzioni della magistratura. Racconta Ceron: «Nei paesi dove i magistrati sono
eletti dalla popolazione, come l'America o l'Australia, che si facciano
condizionare dalla appartenenza politica è noto e quasi scontato. Ma cosa
succede nei paesi, come l'Italia, dove in magistratura si entra per concorso e
dove non c'è un controllo politico? Questa è la domanda da cui abbiamo preso le
mosse». Ricerca articolata su due hypothesis, come si fa tra scienziati
empirici: 1) più l'orientamento politico di un giudice è lontano da quello di un
partito, più il giudice è disposto a procedere contro quel partito; 2) i giudici
sono più disponibili a indagare su un partito, quanto più i partiti rivali
aumentano i loro seggi. Come si fa a dare una risposta che non sia una
chiacchiera da bar? Andando a prendere una per una le richiesta di
autorizzazione a procedere inviate dalle procure di tutta Italia al Parlamento
nel corso di trent'anni, prima, durante e dopo Mani Pulite; catalogando il
partito di appartenenza dei destinatari. E andando a incrociare questo dato con
l'andamento, negli stessi anni e negli stessi tribunali, delle elezioni per gli
organi dirigenti dell'Associazione nazionale magistrati, l'organizzazione
sindacale delle toghe, catalogandoli in base al successo delle correnti di
sinistra (Magistratura democratica e Movimento per la giustizia), di centro
(Unicost) e di destra (Magistratura indipendente); e dividendo un po'
bruscamente in «tribunali rossi» e in «tribunali blu». «Il responso è stato
inequivocabile», dice Ceron. Ovvero, come si legge nel paper: «I risultati
forniscono una forte prova dell'impatto delle preferenze dei giudici sulle
indagini. I tribunali dove un numero più alto di giudici di sinistra
appartengono a Md e all'Mg, tendono a indagare maggiormente sui partiti di
destra. La politicizzazione funziona in entrambe le direzioni: un aumento di
voti per le fazioni di destra fa scendere le richieste contro i partiti di
destra». I numeri sono quelli di una gigantesca retata: 1.256 richieste di
autorizzazione a procedere nei confronti di 1.399 parlamentari. Di queste, i due
ricercatori hanno focalizzato quelle relative ai reati di corruzione e
finanziamento illecito: 526, per 589 parlamentari. Fino al 1993, come è noto,
l'autorizzazione serviva anche per aprire le indagini, oggi è necessaria solo
per arrestare o intercettare. Ma, secondo la richiesta di Ceron e Mainardi, non
è cambiato nulla: almeno nella componente ideologica dell'accusa, che i due
considerano scientificamente e platealmente dimostrata. Dietro due grandi alibi,
che sono la mancanza di risorse e la presunta obbligatorietà dell'azione penale,
di fatto vige la più ampia discrezionalità. È un pm quasi sempre ideologicamente
schierato a scegliere su quale politico indagare. E quasi sempre dimentica di
dimenticarsi le sue opinioni. «L'analisi dei dati - spiega Ceron - dice che i
comportamenti sono lievemente diversi tra giudici di sinistra e di destra:
quelli di sinistra sono più attivi nell'indagare gli avversari, quelli di destra
preferiscono risparmiare accuse ai politici del loro schieramento». Ma in ogni
caso, di giustizia piegata all'ideologia e all'appartenenza politica si tratta.
Unita ad un'altra costante, di cui pure qualche traccia si coglie a occhio nudo:
fino a quando un partito è saldamente al potere, i pm sono cauti. Ma quando il
suo potere traballa e si logora, allora si scatenano.
Parla l’ex capo dei Casalesi.
La camorra e la mafia non finirà mai, finchè ci saranno politici, magistrati e
forze dell’ordine mafiosi.
CARMINE SCHIAVONE. MAGISTRATI:
ROMA NOSTRA!
"Ondata di ricorsi dopo il
«trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici, Napoli capitale
dei promossi. L'area coperta dalla Corte d'appello ha «prodotto» un terzo degli
aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori". O la statistica è
birichina assai o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale concorso di accesso
alla magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici ammessi agli orali
vengono infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli, che rappresenta solo
un trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della popolazione italiana.
Un trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza: erano della stessa
area, più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della commissione e 5 su 8 dei
docenti universitari. Cioè oltre un terzo degli esaminatori.
TRAMONTO ROSSO. I COMUNISTI E
LA GIUSTIZIA.
Questo libro va usato come uno
strumento per capire chi sono i Rossi, la classe politica di centrosinistra
chiamata a rinnovare il paese. Scritto come un viaggio in Italia, da nord a sud,
regione per regione, città per città. I protagonisti, gli affari, gli scandali,
le inchieste. Uomini chiave come l’ex capo della segreteria politica Pd Filippo
Penati, accusato di aver imposto tangenti, o il tesoriere della fu Margherita
Luigi Lusi, che ha fatto sparire 22 milioni di euro di fondi elettorali.
Roccaforti rosse come l’Emilia investite da casi di malaffare e penetrazioni
mafiose mai visti. Nel Comune di Serramazzoni (Modena) indagini su abusi edilizi
e gare pubbliche. I 3 milioni di cittadini accorsi alle primarie per la scelta
del leader sono un’iniezione di fiducia. Ma nella contesa manca un programma
chiaro di riforme in termini di diritti, lavoro, crescita. La difesa del
finanziamento pubblico ai partiti spetta al tesoriere dei Ds Ugo Sposetti da
Viterbo. Sposetti blinda in una serie di fondazioni il “patrimonio comunista”
prima della fusione con la Margherita. Il Pd continua a occuparsi di banche dopo
la scalata illegale di Unipol a Bnl (caso Monte dei Paschi). Il sistema
sanitario nelle regioni rosse è piegato agli interessi corporativi. Tutta una
classe politica che per anni ha vissuto di inciuci con Berlusconi, ora si
dichiara ripulita e finalmente pronta a governare. Ma i nomi sono gli stessi di
sempre. Ma anche il sistema Ds prima e Pd poi in tutte le regioni d’Italia dove
il governo si è protratto per anni e che tra sanità, cemento e appalti e
municipalizzata , i conflitti di interesse dal Lazio alla Puglia all’Emilia si
moltiplicano.
Così gli ex Pci condizionano
le procure. Inchieste insabbiate, politici protetti, giudici trasferiti: le
anomalie da Nord a Sud nel libro "Tramonto rosso", scrive Patricia Tagliaferri
su “Il Giornale”. Il Pd e i suoi scandali, dal nord al sud d'Italia, dentro e
fuori le Procure. Abusi, tangenti, speculazioni edilizie, scalate bancarie,
interessi corporativi nel sistema sanitario, magistrati scomodi isolati,
intimiditi, trasferiti. Potenti di turno miracolosamente soltanto sfiorati da
certe indagini. È un libro che farà discutere quello scritto da Ferruccio
Pinotti, giornalista d'inchiesta autore di numerosi libri di indagine su temi
scomodi, e Stefano Santachiara, blogger del Fatto. Atteso e temuto Tramonto
rosso, edito da Chiarelettere, sarà in libreria a fine ottobre 2013, nonostante
le voci di un blocco, smentito dagli autori, e dopo un piccolo slittamento
(inizialmente l'uscita era prevista a giugno 2013) dovuto, pare, ad un capitolo
particolarmente spinoso su una forte influenza «rossa» che agirebbe all'interno
di uno dei tribunali più importanti d'Italia, quello di Milano, dove indagini
che imboccano direzioni non previste non sarebbero le benvenute mentre altre
troverebbero la strada spianata. Il libro presenta un ritratto della classe
politica di centrosinistra, quella che si dichiara pulita e pronta a prendere in
mano le redini del Paese, ma che è sempre la stessa. Stessi nomi, stesse beghe,
stessi affanni. Un partito, il Pd, per niente diverso dagli altri nonostante si
proclami tale. Gli uomini chiave della sinistra troveranno molte pagine dedicate
a loro. Ce n'è per tutti. Per il tesoriere dei Ds Ugo Sposetti, che ha blindato
in una serie di fondazioni il «patrimonio comunista» prima della fusione con la
Margherita, per l'ex componente della segreteria di Bersani, Filippo Penati,
accusato di corruzione e di finanziamento illecito, per l'ex tesoriere della
Margherita Luigi Lusi, che avrebbe fatto sparire 22 milioni di euro di fondi
elettorali. Gli autori passano dagli abusi edilizi e dalle infiltrazioni mafiose
nell'Emilia rossa al pericoloso rapporto della sinistra con gli istituiti
bancari, da Unipol a Monte dei Paschi. Molto è stato scritto sulla scalata
Unipol-Bnl, sulla partecipazione ai vertici Ds e sul sequestro di 94 milioni di
euro di azioni di Antonveneta disposto nel 2005 dal gip Clementina Forleo. Poco
si sa, invece, su cosa è accaduto dopo al giudice che si è trovato tra le mani
un fascicolo con i nomi di pezzi molto grossi del Pd. «Tramonto rosso» riordina
alcuni fatti e segnala circostanze, talvolta inquietanti, che certamente fanno
riflettere. Come le gravi intimidazioni subite dalla Forleo, le minacce, gli
attacchi politici, le azioni disciplinari, l'isolamento. Fino al trasferimento
per incompatibilità ambientale, nel 2008, poi clamorosamente bocciato da Tar e
Consiglio di Stato. Il tutto nel silenzio dei colleghi per i quali i guai del
gip erano legati al suo brutto carattere e non certo ai suoi provvedimenti sulle
scalate bancarie. «Questa pervicacia contra personam è l'emblema
dell'intromissione politica nella magistratura», si legge nel testo. Gli autori
approfondiscono poi il noto salvataggio operato dalla Procura di Milano nei
confronti di Massimo D'Alema e Nicola Latorre, descritti dalla Forleo
nell'ordinanza del luglio 2007, finalizzata a chiedere il placet parlamentare
all'uso delle telefonate nei procedimenti sulle scalate, come concorrenti del
reato di aggiotaggio informativo del presidente di Unipol Gianni Consorte. Con
la Forleo, sempre più nel mirino, oggetto di riunioni pomeridiane in cui alcuni
colleghi milanesi avrebbero discusso la strategia contro di lei, come rivelato
dal gip Guido Salvini. Per trovare un altro esempio di come riescono ad essere
minimizzate le inchieste che coinvolgono il Pd basta scendere a Bari. Qui a fare
le spese di un'indagine scomoda su alcuni illeciti nel sistema sanitario
regionale è stato il pm Desirèe Digeronimo, duramente osteggiata dai colleghi
fino al trasferimento.
DUE PAROLE SULLA MAFIA.
QUELLO CHE LA STAMPA DI REGIME NON DICE.
«Berlusconi aveva assunto lo
stalliere Vittorio Mangano per far entrare Cosa Nostra dentro la sua villa. Il
patto sancito in una cena a Milano alla quale avevano partecipato lo stesso
Cavaliere e diversi esponenti della criminalità organizzata siciliana». Le
motivazioni (pesantissime) della condanna d'appello per Dell'Utri. «E' stato
definitivamente accertato che Dell'Utri, Berlusconi, Cinà, Bontade e Teresi (tre
mafiosi) avevano siglato un patto in base al quale l'imprenditore milanese
avrebbe effettuato il pagamento di somme di denaro a Cosa nostra per ricevere in
cambio protezione (...)». E poi: «Vittorio Mangano non era stato assunto per la
sua competenza in materia di cavalli, ma per proteggere Berlusconi e i suoi
familiari e come presidio mafioso all'interno della villa dell'imprenditore».
Sono parole pesantissime quelle che i giudici della terza sezione penale della
Corte di appello di Palermo nelle motivazioni della sentenza con cui Marcello
Dell'Utri è stato condannato il 25 marzo 2013 a sette anni di reclusione per
concorso esterno in associazione mafiosa. Parole pesanti verso lo stesso
Dell'Utri, che «tra il 1974 e il 1992 non si è mai sottratto al ruolo di
intermediario tra gli interessi dei protagonisti», e «ha mantenuto sempre vivi i
rapporti con i mafiosi di riferimento», ma anche verso l'ex premier dato che
Dell'Utri viene definito «mediatore contrattuale» del patto tra Cosa Nostra e lo
stesso Berlusconi. Secondo i giudici, «è stato acclarato definitivamente che
Dell'Utri ha partecipato a un incontro organizzato da lui stesso e Cinà (mafioso
siciliano) a Milano, presso il suo ufficio. Tale incontro, al quale erano
presenti Dell'Utri, Gaetano Cinà, Stefano Bontade, Mimmo Teresi, Francesco Di
Carlo e Silvio Berlusconi, aveva preceduto l'assunzione di Vittorio Mangano
presso Villa Casati ad Arcore, così come riferito da Francesco Di Carlo e de
relato da Antonino Galliano, e aveva siglato il patto di protezione con
Berlusconi». «In tutto il periodo di tempo in oggetto (1974-1992) Dell'Utri ha,
con pervicacia, ritenuto di agire in sinergia con l'associazione e di rivolgersi
a coloro che incarnavano l'anti Stato, al fine di mediare tra le esigenze
dell'imprenditore milanese (Silvio Berlusconi) e gli interessi del sodalizio
mafioso, con ciò consapevolmente rafforzando il potere criminale
dell'associazione», è scritto poi nelle motivazioni. Dell'Utri quindi è
«ritenuto penalmente responsabile, al di là di ogni ragionevole dubbio, della
condotta di concorso esterno in associazione mafiosa dal 1974 al 1992» e la sua
personalità «appare connotata da una naturale propensione ad entrare attivamente
in contatto con soggetti mafiosi, da cui non ha mai mostrato di volersi
allontanare neppure in momenti in cui le proprie vicende personali e lavorative
gli aveva dato una possibilità di farlo» .
Per i magistrati è più utile
considerare Berlusconi un mafioso, anziché considerarlo una vittima
dell’inefficienza dello Stato che non sa difendere i suoi cittadini. Una vittima
che è disposta ai compromessi per tutelare la sicurezza dei suoi affari e della
sua famiglia.
Chi paga il pizzo per lo Stato
è un mafioso. E se non ti adegui ti succede quello che succede a tutti. Una
storia esemplare. Valeria Grasso: “Ho denunciato la mafia, ora denuncio lo
Stato”. “Una vergogna, una vergogna senza fine”. Con queste poche parole si può
descrivere la situazione dei Testimoni di Giustizia in Italia. Dove lo Stato non
riesce a fare il proprio dovere. Fino in fondo. Sono troppe le storie
drammatiche, che restano nel silenzio. Troppi gli ostacoli, le difficoltà, i
pericoli, i drammi. I testimoni di giustizia, fondamentali per la lotta alla
criminalità organizzata, devono essere protetti e sostenuti. Nel Paese delle
mafie lo Stato abbandona i suoi testimoni. Lo ha fatto in passato e sta
continuando a farlo. Non stiamo parlando dei "pentiti", dei collaboratori di
giustizia. Di chi ha commesso dei reati e ha deciso, per qualsiasi ragione, di
"collaborare" con lo Stato. Anche i "pentiti" (quelli credibili) servono, sono
necessari per combattere le organizzazioni criminali. Ma i testimoni sono
un’altra cosa. Sono semplici cittadini, che non hanno commesso reati. Hanno
visto, hanno subito e hanno deciso di "testimoniare". Per dovere civico, perché
è giusto comportarsi in un certo modo. Nel BelPaese il dovere civico è poco
apprezzato. I testimoni di giustizia, in Italia, denunciano le stesse
problematiche. Ma nessuno ascolta, risponde. Si sentono abbandonati. Prima
utilizzati e poi lasciati in un "limbo" profondo. Senza luce e senza futuro.
“La mafia, come ci è
inculcata dalla stampa di regime, è un’entità astratta, impossibile da
debellare, proprio perché non esiste.”
Lo scrittore Antonio
Giangrande sul fenomeno “Mafia” ha scritto un libro: “MAFIOPOLI. L’ITALIA DELLE
MAFIE. QUELLO CHE NON SI OSA DIRE”. Book ed E-Book pubblicato su Amazon.it e che
racconta una verità diversa da quella profusa dai media genuflessi alla sinistra
ed ai magistrati.
«L'Italia tenuta al guinzaglio
da un sistema di potere composto da caste, lobbies, mafie e massonerie:
un'Italia che deve subire e deve tacere. La “Politica” deve essere legislazione
o amministrazione nell’eterogenea rappresentanza d’interessi, invece è
meretricio o mendicio, mentre le “Istituzioni” devono meritarlo il rispetto, non
pretenderlo. Il rapporto tra cittadini e il rapporto tra cittadini e Stato è
regolato dalla forza della legge. Quando non vi è cogenza di legge, vige la
legge del più forte e il debole soccombe. Allora uno “Stato di Diritto” degrada
in anarchia. In questo caso è palese la responsabilità politica ed istituzionale
per incapacità o per collusione. Così come è palese la responsabilità dei media
per omertà e dei cittadini per codardia o emulazione.»
Continua Antonio Giangrande.
«La mafia cos'è? La risposta
in un aneddoto di Paolo Borsellino: "Sapete che cos'è la Mafia... faccia conto
che ci sia un posto libero in tribunale..... e che si presentino 3 magistrati...
il primo è bravissimo, il migliore, il più preparato.. un altro ha appoggi
formidabili dalla politica... e il terzo è un fesso... sapete chi vincerà??? Il
fesso. Ecco, mi disse il boss, questa è la MAFIA!"
“La vera mafia è lo Stato,
alcuni magistrati che lo rappresentano si comportano da mafiosi. Il magistrato
che mi racconta che Andreotti ha baciato Riina io lo voglio in galera”.
Così Vittorio Sgarbi il 6 maggio 2013 ad “Un Giorno Da Pecora su Radio 2.
“Da noi -
ha dichiarato Silvio
Berlusconi ai cronisti di una televisione greca il 23 febbraio 2013 - la
magistratura è una mafia più pericolosa della mafia siciliana, e lo dico sapendo
di dire una cosa grossa”. “In Italia regna una "magistocrazia". Nella
magistratura c'è una vera e propria associazione a delinquere”. Lo ha detto
Silvio Berlusconi il 28 marzo 2013 durante la riunione del gruppo Pdl a
Montecitorio. Ed ancora Silvio Berlusconi all'attacco ai magistrati: «L'Anm è
come la P2, non dice chi sono i loro associati». Il riferimento dell'ex
premier è alle associazioni interne ai magistrati, come Magistratura
Democratica. Il Cavaliere è a Udine il 18 aprile 2013 per un comizio.
Questi sono solo pochi esempi
di dichiarazioni ufficiali.
Abbiamo una Costituzione
catto-comunista predisposta e votata dagli apparati politici che rappresentavano
la metà degli italiani, ossia coloro che furono i vincitori della guerra civile
e che votarono per la Repubblica. Una Costituzione fondata sul lavoro (che oggi
non c’è e per questo ci rende schiavi) e non sulla libertà (che ci dovrebbe
sempre essere, ma oggi non c’è e per questo siamo schiavi). Un diritto
all’uguaglianza inapplicato in virtù del fatto che il potere, anziché essere
nelle mani del popolo che dovrebbe nominare i suoi rappresentanti politici,
amministrativi e giudiziari, è in mano a mafie, caste, lobbies e massonerie.
Siamo un popolo corrotto:
nella memoria, nell’analisi e nel processo mentale di discernimento. Ogni dato
virulento che il potere mediatico ci ha propinato, succube al potere politico,
economico e giudiziario, ha falsato il senso etico della ragione e logica del
popolo. Come il personal computer, giovani e vecchi, devono essere formattati.
Ossia, azzerare ogni cognizione e ripartire da zero all’acquisizione di
conoscenze scevre da influenze ideologiche, religiose ed etniche. Dobbiamo
essere consci del fatto che esistono diverse verità.
Ogni fatto è rappresentato da
una verità storica; da una verità mediatica e da una verità giudiziaria.
La verità storica è conosciuta
solo dai responsabili del fatto. La verità mediatica è quella rappresentata dai
media approssimativi che sono ignoranti in giurisprudenza e poco esperti di
frequentazioni di aule del tribunale, ma genuflessi e stanziali negli uffici dei
pm e periti delle convinzioni dell’accusa, mai dando spazio alla difesa. La
verità giudiziaria è quella che esce fuori da una corte, spesso impreparata
culturalmente, tecnicamente e psicologicamente (in virtù dei concorsi pubblici
truccati). Nelle aule spesso si lede il diritto di difesa, finanche negando le
più elementari fonti di prova, o addirittura, in caso di imputati poveri, il
diritto alla difesa. Il gratuita patrocinio è solo una balla. Gli avvocati
capaci non vi consentono, quindi ti ritrovi con un avvocato d’ufficio che spesso
si rimette alla volontà della corte, senza conoscere i carteggi. La sentenza è
sempre frutto della libera convinzione di una persona (il giudice). Mi si chiede
cosa fare. Bisogna, da privato, ripassare tutte le fasi dell’indagine e carpire
eventuali errori dei magistrati trascurati dalla difesa (e sempre ve ne sono).
Eventualmente svolgere un’indagine parallela. Intanto aspettare che qualche
pentito, delatore, o intercettazione, produca una nuova prova che ribalti
l’esito del processo. Quando poi questa emerge bisogna sperare nella fortuna di
trovare un magistrato coscienzioso (spesso non accade per non rilevare l’errore
dei colleghi), che possa aprire un processo di revisione.
Non sarà la mafia a uccidermi
ma alcuni miei colleghi magistrati (Borsellino). La verità sulle stragi non la
possiamo dire noi Magistrati ma la deve dire la politica se non proprio la
storia (Ingroia). Non possiamo dire la verità sulle stragi altrimenti la classe
politica potrebbe non reggere (Gozzo). Non sono stato io a cercare loro ma loro
a cercare me (Riina). In Italia mai nulla è come appare. Ipocriti e
voltagabbana. Le stragi come eccidi di Stato a cui non è estranea la
Magistratura e gran parte della classe politica del tempo.
Chi frequenta bene le aule dei
Tribunali, non essendo né coglione, né in mala fede, sa molto bene che le
sentenze sono già scritte prima che inizi il dibattimento. Le pronunce sono
pedisseque alle richieste dell’accusa, se non di più. Anche perché se il
soggetto è intoccabile l’archiviazione delle accuse è già avvenuta nelle fasi
successive alla denuncia o alla querela: “non vi sono prove per sostenere
l’accusa” o “il responsabile è ignoto”. Queste le motivazioni in calce alla
richiesta accolta dal GIP, nonostante si conosca il responsabile o vi siano un
mare di prove, ovvero le indagini non siano mai state effettuate. La difesa: un
soprammobile ben pagato succube dei magistrati. Il meglio che possono fare è
usare la furbizia per incidere sulla prescrizione. Le prove a discarico: un
perditempo, spesso dannoso. Non è improbabile che i testimoni della difesa siano
tacciati di falso.
Nel formulare la richiesta la
Boccassini nel processo Ruby ha fatto una gaffe dicendo: "Lo condanno", per poi
correggersi: "Chiedo la condanna" riferita a Berlusconi.
Esemplare anche è il caso di
Napoli. Il gip copia o si limita a riassumere le tesi accusatorie della Procura
di Napoli e per questo il tribunale del riesame del capoluogo campano annulla
l'arresto di Gaetano Riina, fratello del boss di Cosa nostra, Totò, avvenuto il
14 novembre 2011. L'accusa era di concorso esterno in associazione camorristica.
Il gip, scrive il Giornale
di Sicilia, si sarebbe limitato a riassumere la richiesta di
arresto della Procura di Napoli, incappando peraltro in una serie di errori e
non sostituendo nella sua ordinanza neanche le parole «questo pm» con «questo
gip».
Il paradosso, però, sono le profezie cinematografiche adattate ai
processi:
«... e lo condanna ad anni sette di reclusione, all'interdizione
perpetua dai pubblici uffici, e all'interdizione legale per la durata della
pena». Non è una frase registrata Lunedì 24 giugno 2013 al Tribunale di Milano,
ma una battuta presa dagli ultimi minuti del film «Il caimano» di Nanni Moretti.
La condanna inflitta al protagonista (interpretato dallo stesso regista) è
incredibilmente identica a quella decisa dai giudici milanesi per Silvio
Berlusconi. Il Caimano Moretti, dopo la sentenza, parla di «casta dei
magistrati» che «vuole avere il potere di decidere al posto degli elettori».
Tutti dentro se la legge fosse
uguale per tutti. Ma la legge non è uguale per tutti. Così la Cassazione si è
tradita. Sconcertante linea delle Sezioni unite civili
sul caso di un magistrato sanzionato. La Suprema Corte: vale il principio della
discrezionalità.
Ed in fatto di mafia c’è
qualcuno che la sa lunga. «Io non cercavo nessuno, erano loro che cercavano
me….Mi hanno fatto arrestare Provenzano e Ciancimino, non come dicono, i
carabinieri……Di questo papello non ne sono niente….Il pentito Giovanni Brusca
non ha fatto tutto da solo, c'è la mano dei servizi segreti. La stessa cosa vale
anche per l'agenda rossa. Ha visto cosa hanno fatto? Perchè non vanno da quello
che aveva in mano la borsa e si fanno consegnare l'agenda. In via D'Amelio
c'erano i servizi……. Io sono stato 25 anni latitante in campagna senza che
nessuno mi cercasse. Com'è possibile che sono responsabile di tutte queste cose?
La vera mafia sono i magistrati e i politici che si sono coperti tra di loro.
Loro scaricano ogni responsabilità sui mafiosi. La mafia quando inizia una cosa
la porta a termine. Io sto bene. Mi sento carico e riesco a vedere oltre queste
mura……Appuntato, lei mi vede che possa baciare Andreotti? Le posso dire che era
un galantuomo e che io sono stato dell'area andreottiana da sempre». Le
confidenze fatte da Toto Riina, il capo dei capi, sono state fatte in due
diverse occasioni, a due guardie penitenziarie del Gom del carcere Opera di
Milano.
Così come in fatto di mafia
c’è qualcun altro che la sa lunga. Parla l’ex capo dei Casalesi. La camorra e la
mafia non finirà mai, finchè ci saranno politici, magistrati e forze dell’ordine
mafiosi.
CARMINE SCHIAVONE. MAGISTRATI:
ROMA NOSTRA!
"Ondata
di ricorsi dopo il «trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici,
Napoli capitale dei promossi. L'area coperta dalla Corte d'appello ha «prodotto»
un terzo degli aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori".
O la statistica è
birichina assai o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale concorso di accesso
alla magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici ammessi agli orali
vengono infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli, che rappresenta solo
un trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della popolazione italiana.
Un trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza: erano della stessa
area, più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della commissione e 5 su 8 dei
docenti universitari. Cioè oltre un terzo degli esaminatori.
Lo strumento per addentrarsi
nei gangli del potere sono gli esami di Stato ed i concorsi pubblici truccati.
I criteri di valutazione
dell’elaborato dell’esame di magistrato, di avvocato, di notaio, ecc.
Secondo la normativa vigente,
la valutazione di un testo dell’esame di Stato o di un Concorso pubblico è
ancorata ad alcuni parametri. Può risultare utile, quindi, che ogni candidato
conosca le regole che i commissari di esame devono seguire nella valutazione dei
compiti.
a) chiarezza, logicità e
rigore metodologico dell’esposizione;
b) dimostrazione della
concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della
conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della
capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
e) relativamente all'atto
giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione.
Ciò significa che la
comprensibilità dell’elaborato — sotto il profilo della grafia, della grammatica
e della sintassi — costituisce il primo criterio di valutazione dei commissari.
Ne consegue che il primo accorgimento del candidato deve essere quello di
cercare di scrivere in forma chiara e scorrevole e con grafia facilmente
leggibile: l’esigenza di interrompere continuamente la lettura, per soffermarsi
su parole indecifrabili o su espressioni contorte, infastidisce (e, talvolta,
irrita) i commissari ed impedisce loro di seguire il filo del ragionamento
svolto nel compito. Le varie parti dell’elaborato devono essere espresse con un
periodare semplice (senza troppi incisi o subordinate); la trattazione dei
singoli argomenti giuridici deve essere il più possibile incisiva; le
ripetizioni vanno evitate; la sequenza dei periodi deve essere rispettosa della
logica (grammaticale e giuridica). Non va mai dimenticato che ogni commissione
esaminatrice è composta da esperti (avvocati, magistrati e docenti
universitari), che sono tenuti a leggere centinaia di compiti in tempi
relativamente ristretti: il miglior modo di presentarsi è quello di esporre —
con una grafia chiara o, quanto meno, comprensibile (che alleggerisca la fatica
del leggere) — uno sviluppo ragionato, logico e consequenziale degli argomenti.
Questa è la regola, ma la
prassi, si sa, fotte la regola. Ed allora chi vince i concorsi pubblici e chi
supera gli esami di Stato e perché si pretende da altri ciò che da sé non si è
capaci di fare, né di concepire?
PARLIAMO DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, MADRE DI TUTTE LE CORTI. UN CASO PER TUTTI.
La sentenza contro il
Cavaliere è zeppa di errori (di grammatica).
Frasi senza soggetto,
punteggiatura sbagliata... Il giudizio della Cassazione è un obbrobrio anche per
la lingua italiana. Dopodiché ecco l’impatto della realtà nella autentica
dettatura delle motivazioni a pag.183: «Deve essere infine rimarcato che
Berlusconi, pur non risultando che abbia trattenuto rapporti diretti coi
materiali esecutori, la difesa che il riferimento alle decisioni aziendali
consentito nella pronuncia della Cassazione che ha riguardato l’impugnazione
della difesa Agrama della dichiarazione a non doversi procedere per
prescrizione in merito ad alcune annualità precedenti, starebbe proprio ad
indicare che occorre aver riguardo alle scelte aziendali senza possibilità.
quindi, di pervernire...». Ecco. Di prim’acchito uno si domanda: oddio, che fine
ha fatto la punteggiatura? Ma dov’è il soggetto? Qual è la coordinata, quante
subordinate transitano sul foglio. «...ad una affermazione di responsabilità di
Berlusconi che presumibilmente del tutto ignari delle attività prodromiche al
delitto, ma conoscendo perfettamente il meccanismo, ha lasciato che tutto
proseguisse inalterato, mantenendo nelle posizioni strategiche i soggetti da lui
scelti...». Eppoi, affiorano, «le prove sono state analiticamente analizzate». O
straordinarie accumulazioni semantiche come «il criterio dell’individuazione del
destinatario principale dei benfici derivanti dall’illecito fornisce un
risultato convergente da quello che s’è visto essere l’esito dell’apprezzamento
delle prove compito dai due gradi di merito..» E poi, nello scorrere delle 208
pagine della motivazione, ci trovi i «siffatto contesto normativo», gli
«allorquando», gli «in buona sostanza», che accidentano la lettura. Ed ancora la
frase «ha posto in essere una frazione importante dell’attività delittuosa che
si è integrata con quella dei correi fornendo un contributo causale...».
Linguaggio giuridico? Bene anch’io ho fatto Giurisprudenza, ed anch’io mi sono
scontrato con magistrati ed avvocati ignoranti in grammatica, sintassi e perfino
in diritto. Ma questo, cari miei non è linguaggio giuridico, ma sono gli effetti
di un certo modo di fare proselitismo.
LE DINASTIE DEI MAGISTRATI.
LA FAMIGLIA ESPOSITO
Qualcuno potrebbe definirla
una famiglia “particolare” scrive “Libero Quotidiano”. Al
centro c'è Antonio Esposito, giudice della Corte di Cassazione
che in una telefonata-intervista al Mattino anticipò le motivazioni della
condanna inflitta a Silvio Berlusconi per frode fiscale nel processo Mediaset. E
che in più occasioni è stato “pizzicato” da testimoni a pronunciare frasi non
proprio di ammirazione nei confronti del Cavaliere. Poi c'è la nipote
Andreana, che sta alla Corte europea dei diritti dell'uomo di
Strasburgo, cui i legali di Berlusconi vorrebbero far ricorso contro la sentenza
emessa dalla Cassazione. Paradosso: a passare al vaglio la sentenza pronunciata
da Esposito potrebbe essere la nipote. Non bastassero loro, c'è il papà di
Andreana, che come scrive, mercoledì 28 agosto, su
Libero Peppe Rinaldi, è stato fotografato mentre
prende il sole e fa il bagno presso il Lido Oasi di Agropoli, nel Cilento. Il
problema è che il lido è abusivo ed è stato soggetto a indagini, interpellanze,
ordinanze di abbattimento. In zona tutti sanno. Curioso che Vitaliano
Esposito, ex procuratore generale della Cassazione, non sappia di
mettersi a mollo in uno stabilimento balneare fuorilegge (abusivo a sua
insaputa). Infine, della famiglia fa parte anche Ferdinando Esposito,
Pubblico Ministero a Milano, che tempo fa finì sotto indagine del Csm
(che poi archiviò) per le cene a lume di candela del giudice (ma va, anche lui?)
in Porsche con Nicole Minetti, allora già imputata per istigazione alla
prostituzione insieme a Lele Mora ed Emilio Fede.
Una famiglia, gli Esposito,
una delle tante dinastie giudiziarie, che non fosse altro dimostra come la
magistratura sia una vera, autentica, casta.
Ciononostante viviamo in
un’Italia fatta così, con italiani fatti così, bisogna subire e tacere. Questo
ti impone il “potere”. Ebbene, si faccia attenzione alle parole usate per
prendersela con le ingiustizie, i soprusi e le sopraffazioni, le incapacità dei
governati e l’oppressione della burocrazia, i disservizi, i vincoli, le tasse,
le code e la scarsezza di opportunità del Belpaese. Perché sfogarsi con il
classico "Italia paese di merda", per quanto liberatorio, non può essere
tollerato dai boiardi di Stato. E' reato, in quanto vilipendio alla nazione. Lo
ha certificato la Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 4 luglio
2013 n. 28730!!!
Ma non di solo della dinastia
Esposito è piena la Magistratura.
LA FAMIGLIA DE MAGISTRIS.
La famiglia e le origini,
secondo “Panorama”. I de Magistris sono giudici da quattro generazioni. Ma
Luigi, l’ultimo erede, della famiglia è stato il primo a essere trasferito per
gli errori commessi nell’esercizio delle funzioni. Il bisnonno era magistrato
del Regno già nel 1860, il nonno ha subito due attentati, il padre, Giuseppe,
giudice d’appello affilato e taciturno, condannò a 9 anni l’ex ministro
Francesco De Lorenzo e si occupò del processo Cirillo. Luigi assomiglia alla
madre Marzia, donna dal carattere estroverso. Residenti nell’elegante quartiere
napoletano del Vomero, sono ricordati da tutti come una famiglia perbene. In via
Mascagni 92 vivevano al terzo piano, al primo l’amico di famiglia, il noto
ginecologo Gennaro Pietroluongo. Ancora oggi la signora Marzia è la sua
segretaria, in una clinica privata del Vomero. Un rapporto che forse ha
scatenato la passione del giovane de Magistris per le magagne della sanità.
Luigi Pisa, da quarant’anni edicolante della via, ricorda così il futuro pm: "Un
ragazzino studioso. Scendeva poco in strada a giocare a pallone e già alle medie
comprava Il Manifesto". Il padre, invece, leggeva Il Mattino e La
Repubblica. Il figlio ha studiato al Pansini, liceo classico
dell’intellighenzia progressista vomerese. Qui il giovane ha conosciuto la
politica: le sue biografie narrano che partecipò diciassettenne ai funerali di
Enrico Berlinguer. All’esame di maturità, il 12 luglio 1985, ha meritato 51/60.
A 22 anni si è laureato in giurisprudenza con 110 e lode. L’avvocato Pierpaolo
Berardi, astigiano, classe 1964, da decenni sta battagliando per far annullare
il concorso per entrare in magistratura svolto nel maggio 1992. Secondo Berardi,
infatti, in base ai verbali dei commissari più di metà dei compiti vennero
corretti in 3 minuti di media (comprendendo "apertura della busta,
verbalizzazione e richiesta chiarimenti") e quindi non "furono mai esaminati". I
giudici del tar gli hanno dato ragione nel 1996 e nel 2000 e il Csm, nel 2008, è
stato costretto ad ammettere: "Ci fu una vera e propria mancanza di valutazione
da parte della commissione". Giudizio che vale anche per gli altri esaminati.
Uno dei commissari, successivamente, ha raccontato su una rivista giuridica
l’esame contestato, narrando alcuni episodi, fra cui quello di un professore di
diritto che, avendo appreso prima dell’apertura delle buste della bocciatura
della figlia, convocò il vicepresidente della commissione. Non basta. Scrive
l’esaminatore: "Durante tutti i lavori di correzione, però, non ho mai avuto la
semplice impressione che s’intendesse favorire un certo candidato dopo che i
temi di questo erano stati riconosciuti". Dunque i lavori erano anonimi solo
sulle buste. "Episodi come questi prevedono, per come riconosciuto dallo stesso
Csm, l’annullamento delle prove in questione" conclude con Panorama
Berardi. In quell’esame divenne uditore giudiziario, tra gli altri, Luigi de
Magistris.
LA FAMIGLIA BORRELLI.
Biografia di Francesco Saverio
Borrelli. Napoli 12 aprile 1930. Ex magistrato (1955-2002). Dal 1992 al 1998
capo della Procura di Milano, divenne noto durante l’inchiesta del pool Mani
pulite. Dal 1999 alla pensione procuratore generale della Corte d’appello
milanese, in seguito è stato capo dell’ufficio indagini della Federcalcio
(maggio 2006-giugno 2007) e presidente del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di
Milano (marzo 2007-aprile 2010). Due fratelli maggiori e una sorella minore,
Borrelli nacque dal secondo matrimonio del magistrato Manlio (figlio e nipote di
magistrati) con Amalia Jappelli detta Miette. «Fino a sette anni non sapevo che
i miei fratelli avessero avuto un’altra madre, morta quando erano piccolissimi.
Nessuno mi aveva mai detto nulla. Me lo rivelò un uomo stupido ridacchiando: “Ma
che fratelli, i tuoi sono fratellastri”. Fu uno shock tremendo. Corsi a casa
disperato. Volevo sapere, capire. I miei avevano voluto salvaguardare
l’uguaglianza tra fratelli: non dovevo sentirmi un privilegiato perché io avevo
entrambi i genitori. Mi chetai, ma mi restò a lungo una fantasia di abbandono,
il timore, che più tardi ho saputo comune a molti bambini, di essere un
trovatello. Tremavo nel mio lettino e pregavo che non fosse così». Dopo due anni
a Lecce, nel 1936 la famiglia traslocò a Firenze: maturità al liceo classico
Michelangelo, laurea in giurisprudenza con Piero Calamandrei (titolo della tesi
Sentenza e sentimento) prese il diploma di pianoforte al conservatorio
Cherubini. Dal 1953 a Milano, dove il padre era stato nominato presidente di
Corte d’appello, nel 1955 vinse il concorso per entrare in magistratura. Dal
1957 sposato con Maria Laura Pini Prato, insegnante di inglese conosciuta
all’università che gli diede i figli Andrea e Federica, passò vent’anni al
Civile, prima in Pretura, poi in Tribunale occupandosi di fallimenti e diritto
industriale, infine in Corte d’Appello. Passato al Penale, dal ’75 all’82 fu in
corte d’Assise, nel 1983 arrivò alla Procura della Repubblica, nel 1992, l’anno
dell’inizio dell’indagine Mani pulite, ne divenne il capo. Quando, nell’aprile
del 2002, Borrelli andò in pensione, a Palazzo Chigi c’era nuovamente Silvio
Berlusconi. Il 3 gennaio di quell’anno, aprendo il suo ultimo anno giudiziario,
l’ex procuratore capo di Milano aveva lanciato lo slogan «Resistere, resistere,
resistere». Nel maggio 2006, in piena Calciopoli, Guido Rossi lo chiamò a
guidare l’ufficio indagini della Federcalcio: «Rifiutare mi sembrava una
vigliaccata». Nel marzo 2007 divenne presidente del Conservatorio “Giuseppe
Verdi” di Milano (la più prestigiosa università musicale d’Italia): «È una nuova
sfida, l’ennesima che affronto con gioia e un certo tremore». In contemporanea
annunciò l’addio alla Figc: «Per ora mantengo il posto in Federcalcio, non c’è
incompatibilità. Se sono uscito dall’ombra lo devo solo a Guido Rossi. Dopo la
nomina del calcio mi riconoscono tutti, i taxisti e anche i più giovani. Ma a
luglio, con il nuovo statuto da me suggerito, l’ufficio indagini confluirà nella
Procura federale. Non voglio fare il Procuratore federale: c’è Stefano Palazzi,
è molto più giovane di me». Nell’aprile 2010 il ministro dell’Istruzione
Mariastella Gelmini, cui spetta la nomina della carica di presidente degli
istituti musicali, gli negò il secondo mandato triennale alla presidenza del
Verdi: «Ragioni evidentemente politiche. Appartengo a una corporazione che è in
odio alle alte sfere della politica. Evidentemente non devo essere gradito agli
esponenti del governo. Ma la mia amarezza è soprattutto quella di aver saputo
della mia mancata conferma in modo indiretto, senza comunicazione ufficiale.
Sono sempre stato abbastanza umile da accettare le critiche, ma ciò che mi
offende è il metodo. Ho lavorato con passione in questi anni». (Giorgio
Dell’Arti Catalogo dei viventi 2015.
ALTRA DINASTIA: LA FAMIGLIA
BOCCASSINI.
Boccassini, una delle famiglie
di magistrati più corrotte della storia d’Italia, scrive “Imola Oggi”. Il
paragone fra certi p.m. di Magistratura Democratica e gli estremisti della
Brigate Rosse è sicuramente improprio ma il fanatismo e la propensione agli
affari degli uni e degli altri è sicuramente simile. Ilda Boccassini appartiene,
secondo la stampa, a una delle famiglie di magistrati più corrotte della storia
d’Italia. Suo zio Magistrato Nicola Boccassini fu arrestato e condannato per
associazione a delinquere, concussione corruzione, favoreggiamento e abuso di
ufficio perchè spillò con altri sodali e con ricatti vari 186 milioni di vecchie
lire a un imprenditore. (vendeva processi per un poker repubblica). Anche suo
padre Magistrato e suo cugino acquisito Attilio Roscia furono inquisiti. Suo
marito Alberto Nobili fu denunciato alla procura di Brescia da Pierluigi Vigna,
Magistrato integerrimo e universalmente stimato per presunte collusioni con gli
affiliati di Cosa Nostra che gestivano l’Autoparco Milanese di via Salamone a
Milano. (attacco ai giudici di Milano Repubblica) (Brescia torna inchiesta
autoparco). Non se ne fece niente perchè la denuncia finì nelle mani del giudice
Fabio Salomone, fratello di Filippo Salomone, imprenditore siciliano condannato
a sei anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso.
L’Autoparco milanese di via Salomone era un crocevia di armi e di droga ha
funzionato per 9 anni di seguito (dal 1984 al 1993), fu smantellato dai
magistrati fiorentini e non da quelli milanesi e muoveva 700 milioni di vecchie
lire al giorno. A Milano tutti sapevano che cosa si faceva lì dentro. Visto ciò
che è emerso a carico del marito per l’Autoparco e visto ciò che sta emergendo a
carico del giudice Francesco Di Maggio (anche lui della Procura di Milano)
relativamente alla strage di Capaci anche il suo trasferimento a Caltanisetta
nel 1992 appare sospetto. In realtà a quel tempo sei magistrati massoni della
Procura di Milano appoggiavano il progetto di Riina e Gardini, i quali erano
soci, di acquisire Eni e poi di fondare Enimont e quindi da un lato favorivano
l’acquisizione di denaro da parte di Cosa Nostra tutelando l’Autoparco
(700.000.000 di vecchie lire al giorno di movimento di denaro) tutelando i
traffici con il c.d. metodo Ros (502.000.000 di euro di ammanchi) e simulando
con altre inchieste minori (Duomo Connenction, Epaminonda) un contrasto alla
mafia che in realtà non c’era, dall’altro con Di Maggio intervennero
pesantemente in Sicilia già nel 1989 per contrastare un attacco della FBI
americana contro i corleonesi attraverso il pentito Totuccio Contorno e facendo
ricadere la responsabilità delle lettere del corvo su Falcone, poi attentato
simulatamente dalla stessa Polizia. Poi nel 1992 sempre con uomini di Di Maggio
contribuirono alla strage di Capaci ove morì Giovanni Falcone il quale si
opponeva acchè il progetto Enimont, a quel tempo gestito da Andreotti e da
Craxi, tornasse nelle mani di Gardini e di Riina. Ora è noto ormai che anche le
Brigate Rosse eseguirono il sequestro Moro per affarismo e rifiutarono dieci
miliardi di vecchie lire da parte del Papa Paolo VI per liberare Aldo Moro
perchè qualcun altro le remunerò di più. Napolitano ha ben fatto appello più
volte a questi Magistrati di moderarsi. Palamara non c’entra niente con questo
discorso perchè è un buon Magistrato ed è affiliato a Unicost, una corrente di
magistrati seri e responsabili e non a M.D. Il tutto sembrerebbe discutibile se
il parente che si è messo in condizione di essere criticato fosse solo uno. Ma
qui i parenti chiacchierati sono tre. Fra l’altro osservo che
Alberto Nobili, dopo che si è separato dalla Boccassini, è tornato a
essere un magistrato stimato, per cui viene il dubbio che nei casini ce lo abbia
messo lei.
CARMINE SCHIAVONE. LA VERA
MAFIA SONO I POLITICI, I MAGISTRATI E LE FORZE DELL’ORDINE.
Parla l’ex capo dei Casalesi.
La camorra e la mafia non finirà mai, finchè ci saranno politici, magistrati e
forze dell’ordine mafiosi.
CARMINE SCHIAVONE. MAGISTRATI:
ROMA NOSTRA!
"Ondata
di ricorsi dopo il «trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici,
Napoli capitale dei promossi . L'area coperta dalla Corte d'appello ha
«prodotto» un terzo degli aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori".
O la
statistica è birichina assai o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale concorso
di accesso alla magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici ammessi
agli orali vengono infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli, che
rappresenta solo un trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della
popolazione italiana. Un trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza:
erano della stessa area, più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della
commissione e 5 su 8 dei docenti universitari. Cioè oltre un terzo degli
esaminatori.
E quindi in tema di giustizia
ed informazione. Lettera aperta a “Quarto Grado”.
Egregio Direttore di “Quarto
Grado”, dr Gianluigi Nuzzi, ed illustre Comitato di Redazione e stimati autori.
Sono il Dr Antonio Giangrande,
scrittore e cultore di sociologia storica. In tema di Giustizia per conoscere
gli effetti della sua disfunzione ho scritto dei saggi pubblicati su Amazon.it:
“Giustiziopoli. Ingiustizia contro i singoli”; “Malagiustiziopoli”.
Malagiustizia contro la Comunità”. Per conoscere bene coloro che la disfunzione
la provocano ho scritto “Impunitopoli. Magistrati ed Avvocati, quello che non si
osa dire”. Per giunta per conoscere come questi rivestono la loro funzione ho
scritto “Concorsopoli. Magistrati ed avvocati col trucco”. Naturalmente per ogni
città ho rendicontato le conseguenze di tutti gli errori giudiziari. Errore
giudiziario non è quello conclamato, ritenuto che si considera scleroticamente
solo quello provocato da dolo o colpa grave. E questo con l’addebito di
infrazione da parte dell’Europa. Né può essere considerato errore quello
scaturito solo da ingiusta detenzione. E’ errore giudiziario ogni qualvolta vi è
una novazione di giudizio in sede di reclamo, a prescindere se vi è stata
detenzione o meno, o conclamato l’errore da parte dei colleghi magistrati.
Quindi vi è errore quasi sempre.
Inoltre, cari emeriti signori,
sono di Avetrana. In tal senso ho scritto un libro: “Tutto su Taranto, quello
che non si osa dire” giusto per far sapere come si lavora presso gli uffici
giudiziari locali. Taranto definito il Foro dell’Ingiustizia. Cosa più
importante, però, è che ho scritto: “Sarah Scazzi. Il delitto di Avetrana. Il
resoconto di un avetranese. Quello che non si osa dire”. Tutti hanno
scribacchiato qualcosa su Sarah, magari in palese conflitto d’interesse, o come
megafono dei magistrati tarantini, ma solo io conosco i protagonisti, il
territorio e tutto quello che è successo sin dal primo giorno. Molto prima di
coloro che come orde di barbari sono scesi in paese pensando di trovare in loco
gente con l’anello al naso e così li hanno da sempre dipinti. Certo che
magistrati e giornalisti cercano di tacitarmi in tutti i modi, specialmente a
Taranto, dove certa stampa e certa tv è lo zerbino della magistratura. Come in
tutta Italia, d’altronde. E per questo non sono conosciuto alla grande massa, ma
sul web sono io a spopolare.
Detto questo, dal mio punto di
vista di luminare dell’argomento Giustizia, generale e particolare, degli
appunti ve li voglio sollevare sia dal punto giuridico (della legge) sia da
punto della Prassi. Questo vale per voi, ma vale anche per tutti quei programmi
salottieri che di giustizia ne sparlano e non ne parlano, influenzando i
telespettatori o da questi sono condizionati per colpa degli ascolti. La domanda
quindi è: manettari e forcaioli si è o si diventa guardando certi programmi
approssimativi? Perché nessuno sdegno noto nella gente quando si parla di gente
rinchiusa per anni in canili umani da innocente. E se capitasse agli ignavi?
Certo, direttore Nuzzi, lei si
vanta degli ascolti alti. Non è la quantità che fa un buon programma, ma la
qualità degli utenti. Fare un programma di buon livello professionale, si
pagherà sullo share, ma si guadagna in spessore culturale e di levatura
giuridica. Al contrario è come se si parlasse di calcio con i tifosi al bar:
tutti allenatori.
Il suo programma, come tutti
del resto, lo trovo: sbilanciatissimo sull’accusa, approssimativo, superficiale,
giustizialista ed ora anche confessionale. Idolatria di Geova da parte di
Concetta e pubblicità gratuita per i suoi avvocati. Visibilità garantita anche
come avvocati di Parolisi. Nulla di nuovo, insomma, rispetto alla conduzione di
Salvo Sottile.
Nella puntata del 27 settembre
2013, in studio non è stato detto nulla di nuovo, né di utile, se non quello di
rimarcare la colpevolezza delle donne di Michele Misseri. La confessione di
Michele: sottigliezze. Fino al punto che Carmelo Abbate si è spinto a dire: «chi
delle due donne mente?». Dando per scontato la loro colpevolezza. Dal punto di
vista scandalistico e gossipparo, va bene, ma solo dalla bocca di un autentico
esperto è uscita una cosa sensata, senza essere per forza un garantista.
Alessandro Meluzzi: «non si
conosce ora, luogo, dinamica, arma, movente ed autori dell’omicidio!!!».
Ergo: da dove nasce la
certezza di colpevolezza, anche se avallata da una sentenza, il cui giudizio era
già stato prematuramente espresso dai giudici nel corso del dibattimento, sicuri
di una mancata applicazione della loro ricusazione e della rimessione del
processo?
E quello del dubbio
scriminante, ma sottaciuto, vale per tutti i casi trattati in tv, appiattiti
invece sull’idolatria dei magistrati. Anzi di più, anche di Geova.
Una cosa è certa, però. Non
sarà la coerenza di questi nostri politicanti a cambiare le sorti delle nostre
famiglie.
2 OTTOBRE 2013. LE
GIRAVOLTE DI BERLUSCONI. L’APOTEOSI DELLA VERGOGNA ITALICA.
«Perché ho scelto di porre
un termine al governo Letta».
Silvio Berlusconi, lettera a Tempi del 1 ottobre 2013. «Gentile direttore, non
mi sfuggono, e non mi sono mai sfuggiti, i problemi che affrontano l’Italia che
amo ed i miei concittadini. La situazione internazionale continua a essere
incerta. I dati economici nazionali non sono indirizzati alla ripresa. E,
nonostante le puntuali resistenze del centrodestra, un esorbitante carico
fiscale continua a deprimere la nostra industria, i commerci, i bilanci delle
famiglie». Inizia così la lunga lettera che Silvio Berlusconi ha scritto a
Tempi. Berlusconi si chiede quanti danni abbia provocato all’Italia «un
ventennio di assalto alla politica, alla società, all’economia, da parte dei
cosiddetti “magistrati democratici” e dei loro alleati nel mondo dell’editoria,
dei salotti, delle lobby? Quanto male ha fatto agli italiani, tra i quali mi
onoro di essere uno dei tanti, una giustizia al servizio di certi obiettivi
politici?». Berlusconi cita il caso dell’Ilva di Taranto, la cui chiusura è
avvenuta «grazie anche a quella che, grottescamente, hanno ancora oggi il
coraggio di chiamare “supplenza dei giudici alla politica”», e torna a chiedere:
«Di quanti casi Ilva è lastricata la strada che ci ha condotto nell’inferno di
una Costituzione manomessa e sostituita con le carte di un potere giudiziario
che ha preso il posto di parlamento e governo? (…) Hanno “rovesciato come un
calzino l’Italia”, come da programma esplicitamente rivendicato da uno dei pm
del pool di Mani Pulite dei primi anni Novanta, ed ecco il bel risultato: né
pulizia né giustizia. Ma il deserto». «Non è il caso Berlusconi che conta –
prosegue -. Conta tutto ciò che, attraverso il caso Silvio Berlusconi, è
rivelatore dell’intera vicenda italiana dal 1993 ad oggi. Il caso cioè di una
persecuzione giudiziaria violenta e sistematica di chiunque non si piegasse agli
interessi e al potere di quella parte che noi genericamente enunciamo come
“sinistra”. Ma che in realtà è rappresentata da quei poteri e forze radicate
nello Stato, nelle amministrazioni pubbliche, nei giornali, che sono
responsabili della rapina sistemica e del debito pubblico imposti agli
italiani. Berlusconi non è uno di quegli imprenditori fasulli che ha chiuso
fabbriche o ha fatto a spezzatini di aziende per darsi alla speculazione
finanziaria. Berlusconi non è uno di quelli che hanno spolpato Telecom o hanno
fatto impresa con gli aiuti di Stato. (…) Berlusconi è uno dei tanti grandi e
piccoli imprenditori che al loro paese hanno dato lavoro e ricchezza. Per
questo, l’esempio e l’eccellenza di questa Italia che lavora dovevano essere
invidiati, perseguitati e annientati (questo era l’obbiettivo di sentenze come
quella che ci ha estorto 500 milioni di euro e, pensavano loro, ci avrebbe
ridotto sul lastrico) dalle forze della conservazione». Il leader del
centrodestra ripercorre poi le vicende politiche degli ultimi anni, ricordando
il suo sostegno al governo Monti e, oggi, al governo Letta. Scrive Berlusconi:
«Abbiamo contribuito, contro gli interessi elettorali del centrodestra, a
sostenere governi guidati da personalità estranee – talvolta ostili – al nostro
schieramento. Abbiamo dato così il nostro contributo perché la nazione tornasse
a respirare, si riuscisse a riformare lo Stato, a costruire le basi per una
nostra più salda sovranità, a rilanciare l’economia. Con il governo Monti le
condizioni stringenti della politica ci hanno fatto accettare provvedimenti
fiscali e sul lavoro sbagliati. Con il governo Letta abbiamo ottenuto più
chiarezza sulle politiche fiscali, conquistando provvedimenti di allentamento
delle tasse e l’impostazione di una riforma dello Stato nel senso della
modernizzazione e della libertà». «Alla fine, però, i settori politicizzati
della magistratura sono pervenuti a un’incredibile, ingiusta perché infondata,
condanna di ultima istanza nei miei confronti. Ed altre manovre persecutrici
procedono in ogni parte d’Italia». «Enrico Letta e Giorgio Napolitano – scrive
l’ex presidente del Consiglio - avrebbero dovuto rendersi conto che, non ponendo
la questione della tutela dei diritti politici del leader del centrodestra
nazionale, distruggevano un elemento essenziale della loro credibilità e
minavano le basi della democrazia parlamentare. Come può essere affidabile chi
non riesce a garantire l’agibilità politica neanche al proprio fondamentale
partner di governo e lascia che si proceda al suo assassinio politico per via
giudiziaria?». «Il Pd (compreso Matteo Renzi) ha tenuto un atteggiamento
irresponsabile soffiando sul fuoco senza dare alcuna prospettiva politica.
Resistere per me è stato un imperativo morale che nasce dalla consapevolezza che
senza il mio argine – che come è evidente mi ha portato ben più sofferenze che
ricompense – si imporrebbe un regime di oppressione insieme giustizialista e
fiscale. Per tutto questo, pur comprendendo tutti i rischi che mi assumo, ho
scelto di porre un termine al governo Letta». Infine la conclusione: «Ho scelto
la via del ritorno al giudizio del popolo non per i “miei guai giudiziari” ma
perché si è nettamente evidenziata la realtà di un governo radicalmente ostile
al suo stesso compagno di cosiddette “larghe intese”. Un governo che non vuole
una forza organizzata di centrodestra in grado di riequilibrarne la sua linea
ondivaga e subalterna ai soliti poteri interni e internazionali». Berlusconi
dice di voler recuperare «quanto di positivo è stato fatto ed elaborato (per
esempio in tema di riforme istituzionali) da questo governo che, ripeto, io per
primo ho voluto per il bene dell’Italia e che io per primo non avrei abbandonato
se soltanto ci fosse stato modo di proseguire su una linea di fattiva, di
giusta, di leale collaborazione». Ma spiega anche di non averlo più voluto
sostenere «quando Letta ha usato l’aumento dell’Iva come arma di ricatto nei
confronti del mio schieramento ho capito che non c’era più margine di
trattativa». «Non solo – aggiunge -. Quando capisci che l’Italia è un Paese dove
la libera iniziativa e la libera impresa del cittadino diventano oggetto di
aggressione da ogni parte, dal fisco ai magistrati; quando addirittura grandi
imprenditori vengono ideologicamente e pubblicamente linciati per l’espressione
di un libero pensiero, quando persone che dovrebbero incarnare con neutralità e
prudenza il ruolo di rappresentanti delle istituzioni pretendono di insegnarci
come si debba essere uomini e come si debba essere donne, come si debbano
educare i figli e quale tipo di famiglia devono avere gli italiani, insomma,
quando lo Stato si fa padrone illiberale e arrogante mentre il governo tace e
non ha né la forza né la volontà di difendere la libertà e le tasche dei suoi
cittadini, allora è bene che la parola ritorni al nostro unico padrone: il
popolo italiano».
Sceneggiata in fondo a
destra,
scrive Stefania Carini su “Europa Quotidiano”. Nessuna sceneggiatura al mondo
può batterci, perché noi teniamo la sceneggiata. Non ci scalfisce manco Sorkin
con West Wing e The Newsroom (uno degli attori di quest’ultima
serie era pure presente al Roma Fiction Fest per annunciarne la messa in onda su
Raitre). Tze, nessun giornalista o politico sul piccolo schermo può batterci in
queste ore. Bastava vedere oggi le prime pagine di due giornali dall’opposto
populismo: per Il Giornale è tradimento, per Il Fatto è inciucio.
Ah, la crisi secondo il proprio target di spettatori! E ‘O Malamente che dice?
Ma come in tutti i melodrammi, i gesti sono più importanti. Vedere per capire.
In senato prima arriva Alfano e si siede accanto a Letta, vorrà dire qualcosa?
Poi arriva Berlusconi, e allora colpa di scena! Marcia indietro? Sardoni (sempre
la più brava) racconta di un Bondi che si scrolla dalla pacca sulla spalla di
Lupi. Non toccarmi, impuro! Biancofiore e Giovanardi litigano a Agorà, ma
ieri sera già aleggiava una forza di schizofrenia sui nostri schermi. Sallusti e
Cicchitto erano seduti a Ballarò dalla stessa parte, secondo solita
partitura visiva del talk. Solo che invece di scannarsi con i
dirimpettai, con quelli della sinistra, si scannavano fra di loro. Una grande
sequenza comico-drammatica, riproposta pure da Mentana durante la sua consueta
lunga maratona in mattinata.
A Matrix pure Feltri
faceva il grande pezzo d’attore, andandosene perché: «Non ne posso più di
Berlusconi, di Letta e di queste discussioni interminabili, come non ne possono
più gli italiani». Oh, sì, gli italiani non ne possono più, ma davanti a un tale
spettacolo come resistere? Siamo lì, al Colosseo pieno di leoni, e noi con i
popcorn. Alla fine ‘O Malamente vota il contrario di quanto detto in mattinata,
e il gesto plateale si scioglie in un risata farsesca per non piangere. Tze,
Sorkin, beccati questo. Noi teniamo Losito. Solo che nella realtà non abbiamo
nessuno bello come Garko.
COSA HA RIPORTATO LA
STAMPA.
IL CORRIERE DELLA SERA - In
apertura: “Resa di Berlusconi, ora il governo è più forte”.
LA REPUBBLICA - In apertura:
“La sconfitta di Berlusconi”.
LA STAMPA - In apertura:
“Fiducia a Letta e il Pdl si spacca”.
IL GIORNALE - In apertura:
“Caccia ai berlusconiani”.
IL SOLE 24 ORE - In apertura:
“Resa di Berlusconi, fiducia larga a Letta”.
IL TEMPO - In apertura:
“Berlusconi cede ad Alfano e vota la fiducia al governo. Pdl sempre più nel
caos”.
IL FATTO QUOTIDIANO – In
apertura: “La buffonata”.
Il Financial Times
titola a caratteri cubitali sulla "vittoria" del premier Letta al senato
e sottolinea che l'Italia si è allontanata dal baratro dopo "l'inversione a U"
di Berlusconi.
Sulla homepage di BBC News
campeggia la foto di Berlusconi in lacrime con sotto il titolo "Vittoria di
Letta dopo l'inversione a U di Berlusconi".
Apertura italiana anche per il
quotidiano The Guardian, che evidenzia un piccolo giallo e chiede la
partecipazione dei lettori. "Cosa ha detto Enrico Letta subito dopo
l'annuncio di Berlusconi di votare per la fiducia al Governo"?. Passando
alle testate spagnole, il progressista El Paìs pubblica in homepage una
photogallery dal titolo "Le facce di Berlusconi" (tutte particolarmente
adombrate) e titola il pezzo portante sulla crisi italiana dicendo che l'ex
premier, "avendo avuto certezza di non poter vincere, ha deciso di non
perdere".
Il conservatore El Mundo,
invece, dedica l'apertura oltre che alla cronaca della giornata al Senato alla
figura di Angelino Alfano, con un editoriale intitolato: "Il delfino che ha
detto basta", nel quale si evidenzia la spaccatura profonda che ha minato
l'integrità finora incrollabile del partito di Silvio Berlusconi.
E poi ci sono i quotidiani
tedeschi. Lo Spiegel International titola a tutta pagina "Fallito il
colpo di Stato in Parlamento. L'imbarazzo di Berlusconi". Lo Spiegel
in lingua madre, invece, pone l'accento sulla "ribellione contro il
Cavaliere, che sancisce la fine di un'epoca".
Foto con cravatta in bocca per
Enrico Letta sul Frankfurter Allgemeine. Il quotidiano, da sempre molto
critico nei confronti di Berlusconi, titola in apertura: "Enrico Letta vince
il voto di fiducia" e poi si compiace che sia "stata scongiurata in
Italia una nuova elezione" dopo una svolta a 180 gradi di Berlusconi.
Il New York Times
dedica uno spazio in prima pagina a "Berlusconi che fa marcia indietro sulla
minaccia di far cadere il governo".
Tra i giornali russi, il primo
ad aprire sull'Italia è il moderato Kommersant, che dedica al voto di
fiducia un articolo di cronaca con foto triste di Berlusconi, sottolineando che
"L'Italia ha evitato nuove elezioni". Stessa cosa vale anche per il sito
in lingua inglese di Al Jazeera, l'emittente del Qatar, che apre la sua
edizione online con una foto di Enrico Letta che sorride sollevato "dopo la
vittoria".
Telegrafico Le Monde,
che titola: "Il governo Letta ottiene la fiducia. Dopo la defezione di 25
senatori del PdL, Silvio Berlusconi ha deciso di votare la fiducia all'esecutivo".
"Berlusconi cambia casacca"
è invece il titolo scelto dal quotidiano di sinistra
Liberation.
Infine Le Figaro,
quotidiano sarkozysta, titola: "Il voltafaccia di Silvio Berlusconi
risparmia all'Italia una crisi".
FARSA ITALIA. UNA GIORNATA
DI ORDINARIA FOLLIA.
Tra le 12, quando Sandro Bondi
scandisce in Aula “fallirete”, e le 13,30, quando Silvio Berlusconi si arrende
e, con un sorriso tirato, annuncia il sì al governo, è racchiuso tutto il senso
di una giornata che, senza enfasi, il premier Enrico Letta definirà storica. Per
la prima volta, infatti, il Cavaliere è costretto a ripiegare e a cedere
sovranità alla decisione imposta da Angelino Alfano, il delfino considerato come
un figlio che ha ucciso il padre. Che per il Pdl sia stata una giornata convulsa
è ormai chiaro a tutti. E lo dimostra anche questa dichiarazione di Renato
Brunetta, il quale, uscendo dalla riunione dei parlamentari del partito a
Palazzo Madama, annuncia convinto che il Pdl toglierà la fiducia al Governo
Letta. Poco dopo, in aula, la retromarcia di Berlusconi. Mercoledì 2 ottobre
intorno alle 13.32 Silvio Berlusconi ha preso la parola al Senato e ha detto a
sorpresa che il PdL avrebbe confermato la fiducia al governo Letta. Poco prima,
il capogruppo del PdL alla Camera Renato Brunetta aveva detto perentoriamente ad
alcuni giornalisti che «dopo lunga e approfondita discussione» nel gruppo dei
parlamentari PdL, «l’opzione di votare la sfiducia al governo è stata assunta
all’u-na-ni-mi-tà dei presenti».
La cronaca della giornata
comincia, infatti, molto presto.
2,30
del mattino, Angelino Alfano ha lasciato palazzo Grazioli dopo un lunghissimo
faccia a faccia con il Cavaliere, concluso con una rottura dolorosa, ed una
sfida, quella lanciata dal leader del centrodestra: "Provate a votare la fiducia
a Letta e vedremo in quanti vi seguiranno".
9.30,
“L’Italia corre un rischio fatale, cogliere o non cogliere l’attimo, con un sì o
un no, dipende da noi”, ha esordito Letta, aggiungendo che "gli italiani ci
urlano che non ne possono più di ‘sangue e arena’, di politici che si scannano e
poi non cambia niente”, ma al tempo stesso ribadendo che “i piani della vicenda
giudiziaria che investe Silvio Berlusconi e del governo, non potevano, né
possono essere sovrapposti” e che ”il governo, questo governo in particolare,
può continuare a vivere solo se è convincente. Per questo serve un nuovo patto
focalizzato sui problemi delle famiglie e dei cittadini”.
Quando il presidente del
Consiglio Letta ha cominciato a parlare in Senato, Giovanardi, Roberto Formigoni
e Paolo Naccarato, i più decisi fra gli scissionisti, facevano circolare una
lista di 23 nomi, aggiungendo però che al momento della conta il risultato
finale sarebbe stato ancoro più corposo. "Siamo già in 25 - dice Roberto
Formigoni parlando con i cronisti in Transatlantico della scissione dal gruppo
Pdl - E' possibile che altri si aggiungano. Nel pomeriggio daremo vita a un
gruppo autonomo chiamato 'I Popolari'. Restiamo alternativi al centrosinistra,
collocati nel centrodestra". Questi i cognomi dei primi firmatari:
Naccarato, Bianconi, Compagna, Bilardi, D'Ascola, Aielo, Augello, Caridi,
Chiavaroli, Colucci, Formigoni, Gentile, Giovanardi, Gualdani, Mancuso,
Marinello, Pagano, Sacconi, Scoma, Torrisi, Viceconte, L.Rossi, Quagliariello.
Con questi numeri, come già aveva pensato anche il ministro Gaetano
Quagliariello, il premier Letta aveva già raggiunto il quorum teorico al Senato.
Infatti il presidente del Consiglio parte da una base di 137 voti (escluso
quello del presidente del Senato che per tradizione non vota), ai quali si
aggiungono i 5 dei senatori a vita ed i 4 annunciati dai fuoriusciti M5s. In
questo modo il governo supera abbondantemente la fatidica ‘quota 161′ necessaria
a Palazzo Madama assestandosi intorno a quota 170.
Berlusconi, che a seduta
ancora in corso ha riunito i suoi per decidere il da farsi, ha detto che
''sarà il gruppo in maniera compatta a decidere cosa fare. Prendiamo una
decisione comune per non deludere il nostro popolo''. Alla riunione non
hanno partecipato i senatori considerati i ormai con le valigie in mano e una
prima votazione si è chiusa con una pattuglia di 27 falchi schieratissimi sulla
sfiducia al governo, mentre 23 erano per lasciare l'aula al momento del voto (al
Senato l'astensione è equiparata al voto contrario) mentre solo due si sono
comunque espressi per il voto di fiducia. Nonostante i no assoluti a Letta
fossero quindi una netta minoranza rispetto al plenum del gruppo Pdl, Berlusconi
ha tagliato corto "voteremo contro la fiducia", come il capo ufficio stampa del
partito si è premurato di far sapere a tutti i giornalisti presenti nella sala
antistante l'aula. Il Cavaliere dichiara: “voteremo no e resteremo in aula Se
uscissimo fuori sarebbe un gesto ambiguo e gli elettori non lo capirebbero''.
In aula al Senato è Sandro Bondi a schierarsi contro Enrico Letta con queste
parole: “avete spaccato il Pdl ma fallirete.
11.30. Contrariamente
a quanto si vociferava, non è Silvio Berlusconi ad intervenire in aula al Senato
ma Sandro Bondi. Bondi ricorda a Letta di essere a Palazzo Chigi grazie anche al
PdL; rimarca il passaggio di Letta circa il concetto di pacificazione e sostiene
che per Letta, la pacificazione sta nell’eliminare politicamente Silvio
Berlusconi. Bondi ricorda a Letta che il problema giudiziario di Berlusconi
nasce anche da Tangentopoli quando la tempesta giudiziaria travolse anche la
Democrazia Cristiana, partito d’origine del Premier. Intanto, il PdL ha deciso:
voterà la sfiducia all’unanimità. Questo è il quanto alle 12.00.
Poco dopo le 12.10
Enrico Letta riprende la parola nell’aula del Senato. Parla di giornata storica
ma dai risvolti drammatici e ricorda che il travaglio di molti senatori va
rispettato. Esprime gratitudine e solidarietà alla Senatrice Paola De Pin, per
l’intervento in aula e per aver rischiato un attacco fisico da parte dei suoi
ormai ex colleghi del M5S e sottolinea, rivolgendosi ai Senatori grillini che il
rispetto della persona è alla base della democrazia. Durante l’intervento di
Letta, vibranti proteste contro Letta da parte del Senatore Scilipoti che viene
zittito dal Presidente Grasso. Letta aggiunge che i numeri che sostengono il
governo sono cambiati ma comunque è fiducioso circa il raggiungimento degli
obiettivi di governo verso i quali si pone con le parole “chiari” e “netti”. Il
presidente del Consiglio ringrazia chi ha votato prima per l’attuale maggioranza
come chi, oggi ha deciso diversamente. Letta rimarca il ruolo importante
dell’Italia nel contesto europeo per il quale auspica centralità ed il
coinvolgimento del Parlamento per il semestre UE. Si conclude qui, la replica
del presidente del Consiglio e si aprono le dichiarazioni di voto. Questo è il
quanto alle 12,30.
13.32.
Berlusconi, e non il capogruppo Renato Schifani, interviene per la
dichiarazione di voto del Pdl. E in meno di tre minuti, con volto terreo, e
senza fare nessun riferimento alle convulsioni dei giorni precedenti, ha
rinnovato la fiducia a Letta "non senza travaglio". Il suo intervento al Senato
è arrivato alle 13.32. Sottolinea che ad aprile ritenne di mettere insieme un
governo di centrosinistra col centrodestra per il bene del Paese. Accettando
tutte le volontà del presidente incaricato Enrico Letta, accettando di avere
solo 5 ministri. “Lo abbiamo fatto con la speranza che potesse cambiare il
clima del nostro Paese - ha sostenuto - andando verso una pacificazione.
Una speranza che non abbiamo deposto. Abbiamo ascoltato le parole del premier
sugli impegni del suo Governo e sulla giustizia. Abbiamo deciso di
esprimere un voto di fiducia a questo governo”. Pone fine al proprio
intervento, torna a sedersi e scoppia a piangere.
La fiducia al Governo Letta è
passata con 235 voti a favore e 70 voti contrari.
Alle 16.00 il
Presidente del Consiglio, Enrico Letta, ha aperto il suo intervento alla Camera.
Sostanzialmente è un rimarcare quanto già espresso stamattina in Senato.
Intanto, nelle ore precedenti, si delinea la formazione del nuovo gruppo
politico costituito da transfughi del PdL e capitanati da Fabrizio Cicchitto;
sono ufficialmente 12 ma si conta di arrivare complessivamente a 26
Parlamentari. A margine della conferenza dei capigruppo alla Camera, la
Presidenza ha dato il disco verde per la costituzione del nuovo gruppo che
interverrà sin da oggi pomeriggio nel dibattito parlamentare che seguirà
l’intervento di Letta.
Poco prima delle 21,30,
la Camera ha espresso il proprio voto nei confronti del governo Letta. 435
favorevoli e 162 contrari. Termina qui, questa lunga giornata politica dalla
quale il Paese esce con un governo confermato ma sostenuto da una nuova
maggioranza.
Vittorio Feltri fa
trapelare il suo malessere su Twitter: "Chi incendia la propria casa e poi
spegne le fiamme è un incendiario, un pompiere o un pirla?".
ITALIA DA VERGOGNA.
Che Italia di merda. Anzi no,
perché non si può dire. Un’Italia da vergogna, però sì. Se volete possiamo
continuare ad enucleare le virtù dell’italica vergogna.
È proprio una storiaccia,
scrive Nicola Porro. Beccare l’esattore che per quattro danari fa lo sconto
sulle tasse da pagare, sembra un roba dell’altro secolo. Secondo la Procura di
Roma è quanto facevano alcuni funzionari (ed ex colleghi) di Equitalia. Vedremo
presto, si spera, se e quanto fosse diffuso il sistema. Una tangente per
alleggerire il proprio carico fiscale fa ribollire il sangue. Equitalia è stata
negli ultimi anni il braccio inflessibile della legge (assurda) tributaria.
Inflessibile nei suoi atteggiamenti oltre che nelle sue regole. La prima
reazione è di sdegno. Come per uno stupro, non si riesce a ragionare, a essere
lucidi. Ad aspettare un processo. In galera i presunti delinquenti. Gli aguzzini
che hanno rovinato la vita a migliaia di contribuenti in sofferenza. Nei
confronti dei quali (i contribuenti, si intende) non hanno mai avuto pietà.
Bene. Ora calmiamoci un po’. E ragioniamo. Il dito è l’indagine di ieri. La luna
è il caso di oggi e di domani. Ci stiamo forse prendendo in giro? Qualcuno pensa
veramente che il catasto sia un luogo di verginelle? Qualcuno ritiene sul serio
che le amministrazioni comunali che forniscono licenze siano immacolate?
Qualcuno si immagina davvero che le Asl e i relativi controlli che fanno alle
imprese siano tutti puliti? La lista potrebbe diventare infinita. Ed è una lista
che sarebbe comunque compilata per difetto. Non c’è giorno che la cronaca non ci
regali uno scandaletto locale su funzionari o dipendenti pubblici che non
svolgono con onestà il proprio lavoro e che si mettono in tasca un stipendio
alternativo a quello fornito dalla mamma Stato. Il nostro non è un punto di
vista rassegnato. E tanto meno un giudizio complessivo sull’amministrazione
pubblica. Il nostro è un puro ragionamento economico, senza alcun intento
moralistico. Questo lo lasciamo a chi legge. La cosa è semplice e ha a che fare
con la burocrazia statale. Essa ha un potere immenso, a ogni suo livello. Che le
deriva dalla legge e dalla possibilità di farla applicare grazie al monopolio
della violenza (legale e giudiziaria) di cui lo Stato dispone. Il caso Equitalia
è particolarmente odioso per il momento in cui ci troviamo. Ma la stecca sulle
tasse era ben più consistente e diffusa prima della riforma tributaria. Il punto
è dunque quello di guardare al principio e non al dettaglio. Troppo Stato e la
troppa burocrazia che ne consegue vuol dire una cosa sola: incentivo alla
corruzione. La nostra bulimia legislativa, normativa e amministrativa nasce
dalla presunzione pubblicistica, per la quale i privati sono più o meno
potenzialmente tutti dei mascalzoni e devono dunque essere preventivamente
controllati. Ecco le norme, le regole, i controlli, le agenzie, i funzionari, le
procedure, le carte. Quanto più sono numerose, quanto maggiore è la possibilità
che un passaggio sia economicamente agevolato da una commissione di
sveltimento/tangente. Niente moralismi: calcolo delle probabilità. Nell’assurda
costruzione pubblicistica che ci ha ormai irrimediabilmente contagiati si è
commesso un enorme refuso logico. E cioè: i privati sono dei furfanti e come
tali debbono essere regolati. Il mercato è in fallimento e dunque deve essere
sostituito dallo Stato. E mai si pensa (ecco il refuso) che altrettanti furfanti
e fallimenti ci possono statisticamente essere in coloro che dovrebbero
legiferare o controllare. La prima vera, grande rivoluzione di questo Paese è
ridurre il peso dello Stato, non solo perché costa troppo, ma perché si presume,
sbagliando, che sia migliore e più giusto del privato.
ITALIA BARONALE.
I concorsi truccati di un
Paese ancora feudale.
Un sistema consolidato di
scambio di favori che ha attraversato tutta la Penisola, da Nord a Sud,
coinvolgendo otto atenei: Bari, Sassari, Trento, Milano Bicocca, Lum, Valle
d'Aosta, Roma Tre, Europea di Roma. È quanto emerge da un'inchiesta condotta
dalla procura di Bari, che ha indagato su possibili manipolazioni di 15 concorsi
pubblici per incarichi di docenti ordinari e associati nelle università.
L’inchiesta di Bari
coinvolge 38 docenti, tra cui i 5 "saggi" chiamati dal governo, ma svela ciò che
tutti sanno: le università sono una lobby, scrive
Vittorio Macioce su “Il
Giornale”. Non servono i saggi per rispondere a questa domanda. Come si diventa
professori universitari? Lo sanno tutti. Non basta fare il concorso. Quello è
l'atto finale, la fatica è arrivarci con qualche possibilità di vincerlo. È una
corsa con regole antiche, dove la bravura è solo una delle tante componenti in
gioco. L'università è un mondo feudale. I baroni non si chiamano così per caso.
Ognuno di loro ha vassalli da piazzare. Entri se sei fedele, se sei pure bravo
tanto meglio. È la logica della cooptazione. Ti scelgo dall'alto, per affinità,
per affidabilità, per simpatia, perché apparteniamo allo stesso partito, alla
stessa lobby, allo stesso giro. I baroni si riproducono tagliando fuori i
devianti, le schegge impazzite, i cani sciolti. Molti sono convinti che in fondo
questo sia un buon modo per selezionare una classe dirigente. Magari hanno
ragione, magari no e il prezzo che si paga è la «mummificazione». Fatto sta che
sotto il concorso pubblico ufficiale ci sono trattative, accordi, arrivi
pilotati, rapporti di forza, «questa volta tocca al mio», «tu vai qui e l'altro
lo mandiamo lì». La stragrande maggioranza dei futuri accademici vive e accetta
questa logica. È l'università. È sempre stato così. Perché cambiare?
L'importante è mandare avanti la finzione dei concorsi. È la consuetudine e
pazienza se è «contra legem». I concorsi in genere funzionano così e il bello è
che non è un segreto. Poi ogni tanto il meccanismo si inceppa. Qualcuno per
fortuna ha il coraggio di denunciare o i baroni la fanno davvero sporca. È
quello che è successo con un'inchiesta che parte da Bari e tocca una
costellazione di atenei: Trento, Sassari, Bicocca, Lum, Valle d'Aosta,
Benevento, Roma Tre e l'Europea. Sotto accusa finiscono 38 docenti, ma la
notizia è che tra questi ci sono cinque «saggi». Cinque costituzionalisti cari
al Colle. Augusto Barbera, Lorenza Violini, Beniamino Caravita, Giuseppe De
Vergottini, Carmela Salazar. Che fanno i saggi? Solo pochi illuminati lo hanno
davvero capito. Forse qualcuno ancora se li ricorda. Sono quel gruppo di
professori nominati da Enrico Letta su consiglio di Napolitano per immaginare la
terza Repubblica. Sulla carta dovevano gettare le basi per cambiare la
Costituzione. In principio erano venti, poi per accontentare le larghe intese
sono diventati trentacinque, alla fine si sono aggiunti anche sette estensori,
con il compito di mettere in italiano corrente i pensieri degli altri.
Risultato: quarantadue. Il lavoro lo hanno finito. Quando servirà ancora non si
sa. I cinque saggi fino a prova contraria sono innocenti. Non è il caso di
metterli alla gogna. Il sistema feudale però esiste. Basta chiederlo in privato
a qualsiasi barone. Ed è qui che nasce il problema politico. Questo è un Paese
feudale dove chi deve cambiare le regole è un feudatario. Non è solo
l'università. L'accademia è solo uno dei simboli più visibili. È la nostra
visione del mondo che resta aggrappata a un eterno feudalesimo. Sono feudali le
burocrazie che comandano nei ministeri, paladini di ogni controriforma. È
feudale il sistema politico. Sono feudali i tecnici che di tanto in tanto si
improvvisano salvatori della patria. È feudale il mondo della sanità, della
magistratura, del giornalismo. È feudale la cultura degli eurocrati di
Bruxelles. È feudale il verbo del Quirinale. È stato sempre così. Solo che il
sistema negli anni è diventato ancora più rigido. Lo spazio per gli outsider sta
scomparendo. L'ingresso delle consorterie è zeppo di cavalli di frisia e filo
spinato. La crisi ha fatto il resto. Se prima era tollerata un quota di non
cooptazione dall'alto, ora la fame di posti liberi ha tagliato fuori i non
allineati. E sono loro che generano cambiamento. Il finale di questa storia
allora è tutto qui. Quando qualcuno sceglie 42 saggi per pilotare il cambiamento
non vi fidate. Nella migliore delle ipotesi sta perdendo tempo, nella peggiore
il concorso è truccato. Il prossimo candidato vincente è già stato scelto. Si
chiama Dc.
È una storia antica quanto i
baroni. Ma i nomi e i numeri, stavolta, fanno più rumore. Hanno trafficato in
cattedre universitarie, sostengono la Procura e la Finanza di Bari. In almeno
sette facoltà di diritto, pilotando concorsi per associati e ordinari. Le
indagini, spiega Repubblica, iniziano nel 2008 presso l’università telematica
“Giustino Fortunato”, di Benevento, che grazie al rettore Aldo Loiodice divenne
una succursale dell’università di Bari: “Tirando il filo che parte dalla
“Giustino Fortunato”, l’indagine si concentra infatti sui concorsi di tre
discipline — diritto costituzionale, ecclesiastico, pubblico comparato —
accertando che i professori ordinari “eletti nell’albo speciale” e dunque
commissari in pectore della Commissione unica nazionale sono spesso in realtà
legati da un vincolo di “reciproca lealtà” che, di fatto, li rende garanti di
vincitori già altrimenti designati dei concorsi che sono chiamati a giudicare.
Non ha insomma alcuna importanza chi viene “sorteggiato” nella Commissione”. La
prova, per la Finanza, sarebbero le conversazioni dei prof insospettiti, che
citano Shakespeare e parlano in latino: “È il caso dell’atto terzo, scena quarta
del Macbeth. «Ciao, sono l’ombra di Banco», ammonisce un professore,
rivolgendosi ad un collega. Già, Banco: la metafora della cattiva coscienza”. Da
una minuscola università telematica al Gotha del mondo accademico italiano,
scrive Giovanni Longo su “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Una intercettazione
dietro l’altra: così la Procura di Bari ha individuato una rete di docenti che
potrebbe avere pilotato alcuni concorsi universitari di diritto ecclesiastico,
costituzionale e pubblico comparato. I finanzieri del nucleo di polizia
tributaria del comando provinciale di Bari avevano iniziato a indagare sulla
«Giustino Fortunato» di Benevento. Gli accertamenti si sono poi estesi: basti
pensare che i pm baresi Renato Nitti e Francesca Pirrelli stanno valutando le
posizioni di un ex ministro, dell'ex garante per la privacy, di cinque dei 35
saggi nominati dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. L’ipotesi è
che qualcuno possa avere influenzato i concorsi. Tra i 38 docenti coinvolti
nell'inchiesta che da Bari potrebbe fare tremare il mondo accademico italiano ci
sono infatti Augusto Barbera (Università di Bologna), Beniamino Caravita di
Toritto (Università La Sapienza Roma), Giuseppe De Vergottini (Università di
Bologna), Carmela Salazar (Università di Reggio Calabria) e Lorenza Violini
(Università di Milano), nominati da Napolitano per affiancare l’esecutivo sul
terreno delle riforme costituzionali. La loro posizione, al pari di quella
dell'ex ministro per le Politiche Comunitarie Anna Maria Bernini e di Francesco
Maria Pizzetti, ex Garante della Privacy, è al vaglio della Procura di Bari che
dovrà verificare se ci sono elementi per esercitare l’azione penale. Gli
accertamenti non sono legati agli incarichi istituzionali dei docenti, ma
riguardano la loro attività di commissari in concorsi da ricercatore e da
professore associato e ordinario, banditi nel secondo semestre del 2008. Quella
tessuta pazientemente nel tempo dalle fiamme gialle, coordinate dalla Procura di
Bari, sarebbe stata una vera e propria «rete» che per anni avrebbe agito su
tutto il territorio nazionale e che a Bari avrebbe avuto una sponda
significativa. Quattro i professori baresi sui quali sono da tempo in corso
accertamenti: Aldo Loiodice, all’epoca ordinario di diritto costituzionale
nell’Università di Bari, Gaetano Dammacco, ordinario di diritto canonico ed
ecclesiastico alla facoltà di scienze politiche; Maria Luisa Lo Giacco e Roberta
Santoro, ricercatrici di diritto ecclesiastico. Le ipotesi di reato a vario
titolo sono associazione per delinquere, corruzione, abuso d'ufficio, falso e
truffa. E’ una élite di studiosi di diritto che si conoscono da sempre, che si
incontrano a seminari e convegni di studio e che, anche in quel contesto,
pianificano i concorsi universitari in tutta Italia. Questa è l’ipotesi. Il
quadro emerso dalle centinaia di intercettazioni e dalle decine di perquisizioni
eseguite negli anni scorsi in abitazioni, studi professionali, istituzioni
universitarie, da Milano a Roma, da Teramo a Bari è da tempo al vaglio della
Procura. Nove gli Atenei coinvolti. Almeno una decina i concorsi universitari
espletati tra il 2006 e il 2010 finiti sotto la lente d’ingrandimento delle
Fiamme Gialle. A quanto pare non sarebbe emersa una vera e propria cabina di
regia, quanto piuttosto una sorta di «circolo privato» in grado di decidere il
destino di concorsi per professori di prima e seconda fascia in tre discipline
afferenti al diritto pubblico. Gli investigatori ritengono che questi concorsi
nascondano un sistema di favori incrociati. Dopo il sorteggio delle commissioni
giudicatrici previsto dalla riforma Gelmini, sarebbe insomma scattato un patto
della serie: «tu fai vincere il mio “protetto” nella tua commissione ed io
faccio vincere il tuo nella mia». «Accordi», «scambi di favore», «sodalizi e
patti di fedeltà» per «manipolare» l’esito di molteplici procedure concorsuali
pubbliche, bandite su tutto il territorio nazionale in quel quadriennio.
Dall’accusa iniziale, evidenziata in uno dei decreti di perquisizione, in oltre
due anni, si sarebbero aggiunti molti altri riscontri trovati dagli
investigatori. E pensare che l’inchiesta era partita dagli accertamenti
sull'università telematica «Giustino Fortunato », considerata dalla Finanza una
sorta di «titolificio» dove si poteva diventare professori in men che non si
dica. Dietro quella pagliuzza sarebbe spuntata una trave molto più grande.
Università, i baroni si
salvano con la prescrizione. Grazie alla riforma voluta da Berlusconi, che
garantisce l'impunità ai colletti bianchi, tre docenti dell'ateneo di Bari sono
stati assolti dall'accusa di spartizione delle cattedre. Ma le intercettazioni
hanno mostrato l'esistenza di una vera e propria cupola in tutta Italia, scrive
Gianluca Di
Feo su “L’Espresso”. È stata l'inchiesta più clamorosa sulla spartizione delle
cattedre, quella che aveva fatto parlare di una mafia che decideva le nomine a
professore negli atenei di tutta Italia. E lo faceva nel settore più delicato:
la cardiologia. Ma nove anni dopo la retata che ha scosso le fondamenta del
mondo universitario, il tribunale di Bari ha assolto tre imputati chiave
dall'accusa di associazione a delinquere. Erano innocenti? Il reato è stato
dichiarato prescritto perché è passato troppo tempo: i fatti contestati
risalgono al 2002. Una beffa, l'ennesima conferma sull'effetto delle riforme
berlusconiane che hanno dilatato la durata dei processi e di fatto garantiscono
l'impunità ai colletti bianchi. Il colpo di spugna arriva proprio mentre da Roma
a Messina si torna a gridare allo scandalo per i concorsi pilotati negli atenei.
L'istruttoria di Bari era andata oltre, radiografando quanto fosse diventato
profondo il malcostume nel corpo accademico. Grazie alle intercettazioni
finirono sotto indagine decine di professori di tutte le regioni. Nel suo atto
di accusa il giudice Giuseppe De Benectis scrisse: «I concorsi universitari
erano dunque celebrati, discussi e decisi molto prima di quanto la loro
effettuazione facesse pensare, a cura di commissari che sembravano simili a
pochi “associati” a una “cosca” di sapore mafioso». Stando agli investigatori,
al vertice della rete che smistava cattedre e borse da di studio da Brescia a
Palermo c'era Paolo Rizzon, trevigiano diventato primario nel capoluogo
pugliese. Le intercettazioni lo hanno descritto come un personaggio da commedia
all'italiana. È stato registrato mentre manovrava la composizione di una
commissione d'esame che approvasse la nomina del figlio. Poi scopre che l'erede
non riesce neppure a mettere insieme la documentazione indicata per l'esame da
raccomandato («Ho guardato su Internet, non c'è niente») e si dà da fare per
trovargli un testo già scritto. Nei nastri finisce una storia dai risvolti
boccacceschi con scambi di amanti e persino l'irruzione della vera mafia. Quando
un candidato non si piega alle trame della “Cupola dei baroni” e presenta un
ricorso per vedere riconosciuti i suoi diritti, gli fanno arrivare questo
avvertimento: «Il professore ha fatto avere il tuo indirizzo a due mafiosi per
farti dare una sonora bastonata». Secondo gli inquirenti, non si trattava di
millanterie. I rapporti con esponenti di spicco della criminalità locale sono
stati documentati, persino nel «commercio di reperti archeologici». A uno di
loro – che al telefono definisce «il boss dei boss» - il primario chiede di
recuperare l'auto rubata nel cortile della facoltà. Salvo poi scoprire che la
vettura non era stata trafugata: si era semplicemente dimenticato dove l'aveva
parcheggiata. I magistrati sono convinti che tra la metà degli anni Novanta e il
2002 il professore avesse creato una macchina perfetta per decidere le nomine di
cardiologia in tutta Italia: «Una vera organizzazione che vedeva Rizzon tra i
capi e organizzatori, con una ripartizione di ruoli, regole interne e sanzioni
per la loro eventuale inosservanza che consentiva ai baroni, attraverso il
controllo dei diversi organismi associativi, di acquisire in ambito accademico
il controllo esecutivo e di predeterminare la composizione delle commissioni
giudicatrici e prestabilire quindi anche l´esito della procedura». Oggi la
sentenza ha prosciolto per prescrizione dall'associazione per delinquere tre
docenti di spicco che avevano scelto il rito abbreviato. Assoluzione nel merito
invece per gli altri reati contestati. Nonostante le accuse, i tre prof sono
tutti rimasti al loro posto e hanno proseguito le carriere accademiche. Uno si è
persino candidato alla carica di magnifico rettore. Una tutela garantista nei
loro confronti, ma anche un pessimo esempio per chiunque sogni di fare strada
con i propri mezzi nel mondo dell'università senza essere costretto a emigrare.
I codici etici negli atenei sono stati introdotti solo dopo gli ultimi scandali,
ma in tutta la pubblica amministrazione non si ricordano interventi esemplari
delle commissioni disciplinari interne: si aspetta la magistratura e la sentenza
definitiva, che non arriva praticamente mai. Anche nel caso del professore
Rizzon e di altri tre luminari per i quali è in corso il processo ordinario
sembra impossibile che si arrivi a un verdetto. Dopo nove anni siamo ancora al
primo grado di giudizio e pure per loro la prescrizione è ormai imminente. Una
lezione magistrale per chi crede nel merito.
CASA ITALIA.
Case popolari solo a
stranieri?
Magari non è proprio così ma basta farsi un giro in certe zone per rendersi
conto che la realtà sembra sempre di più penalizzare gli italiani. Il record
delle case popolari. Una su due va agli stranieri. Ecco le graduatorie per
avere accesso agli alloggi di edilizia residenziale. Più del 50% delle domande
vengono da immigrati. E i milanesi aspettano, scrive Chiara Campo su “Il
Giornale”. Ci sono Aba Hassan, Abad, Abadir. Ventisette cognomi su ventisette
solo nella prima pagina (e almeno 17 idonei). Ma scorrendo il malloppo delle
1.094 pagine che in ordine alfabetico formano le graduatorie per accedere alle
case popolari del Comune, almeno il 50% dei partecipanti è di provenienza
straniera. Basta leggere i primi dieci fogli per avere l'impressione che, tra
gli Abderrahman e gli Abebe, gli italiani siano dei «panda» in estinzione. Le
graduatorie pubblicate da Palazzo Marino si riferiscono al bando aperto fino a
fine giugno 2013 a chi ha bisogno di appartamenti di edilizia residenziale. Chi
entra nell'elenco non ha automaticamente la casa perché la lista d'attesa è
lunga, ma tra i criteri per avanzare in classifica ci sono ovviamente reddito
(basso) e numero di figli (alto). Le proteste dei leghisti sono note: «Gli
immigrati lavorano in nero e fanno tanti figli». Nel 2012 (sono dati del Sicet)
su 1190 assegnazioni nel capoluogo lombardo 495, quasi la metà 455, sono state a
favore di immigrati. A vedere gli elenchi l'impressione è che la percentuale
possa alzarsi ancora, a scapito di tante famiglie milanesi che probabilmente
versano tasse da più tempo e nella crisi avrebbero altrettanto bisogno di una
casa a basso costo. «Sono per l'integrazione - commenta Silvia Sardone,
consigliera Pdl della Zona 2 - ma questa non si può realizzare con una
potenziale discriminazione per gli italiani. Probabilmente il sistema di
costruzione delle graduatorie ha bisogno di essere reso più equo». Ci tiene a
sottolineare: «Non sono razzista, non lo sono mai stata e non lo sarò. Non sono
nemmeno perbenista né figlia di un buonismo di sinistra cieco della realtà. Ho
molto amici italiani con cognomi stranieri, hanno un lavoro ed un mutuo sulla
casa». Ma «nella prime pagine degli elenchi in ordine alfabetico si fa fatica a
trovare un cognome italiano e complessivamente sono tantissimi i cognomi
stranieri. Indipendentemente da chi ha studiato i criteri di partecipazione e
assegnazione e di quando siano stati creati penso che oggi, nel 2013, debbano
essere rivisti. Perché sono stanca di pagare delle tasse per servizi che spesso
godono gli altri». Anche il capogruppo milanese della Lega torna a chiedere agli
enti (Regione per prima) di rivedere i criteri di accesso, alzando ad esempio i
5 anni d residenza minima: «Serve una norma che difenda la nostra gente da chi,
si dice, porta ricchezza, ma invece rappresenta un costo».
Laddove l’alloggio non
viene assegnato, si occupa (si ruba) con il beneplacito delle Istituzioni.
Quando si parla di case
occupate abusivamente o illegalmente, in genere la mente è portata a collegare
tale fenomeno a quello dei centri sociali, scrive “Mole 24”. Un tema che di per
sé sarebbe da approfondire, perché esistono centri sociali occupati da autonomi,
altri da anarchici, altri ancora dai cosiddetti “squatter”, termine che deriva
dall’inglese “to squat”, che non è solo un esercizio per rassodare i glutei ma
significa anche per l’appunto “occupare abusivamente”. Ma l’occupazione abusiva
delle case è in realtà un fenomeno assai nascosto e taciuto, praticamente
sommerso. Un’anomalia che pochi conoscono, ancor meno denunciano o rivelano,
essenzialmente perché non si sa come risolvere. Le leggi ci sono, o forse no, e
se anche esistono pare proprio che le sentenze più attuali siano maggiormente
orientate a tutelare gli interessi dell’occupante abusivo piuttosto che quelli
del proprietario che reclama i suoi diritti da “esautorato”, sia che si parli
del Comune in senso lato sia che si parli di un qualsiasi fruitore di case
popolari che si ritrova il suo alloggio occupato da “ospiti” che hanno deciso di
prenderne il possesso. Il fenomeno si riduce spesso ad essere una guerra tra
poveri. Parliamo, per fare un esempio non così lontano dalla realtà, di un
anziano pensionato costretto ad essere ricoverato in ospedale per giorni,
settimane o anche mesi: ebbene, questo anziano signore, qualora fosse residente
in un alloggio popolare, una volta dimesso potrebbe rischiare di tornare a casa
e non riuscire più ad aprire la porta d’ingresso. Serratura cambiata, e l’amara
sorpresa che nel frattempo alcuni sconosciuti hanno preso possesso
dell’abitazione. Un problema risolvibile? Non così tanto. Anzi, potrebbe essere
l’inizio di un lungo iter giudiziario, e se il nuovo o i nuovi occupanti, siano
essi studenti cacciati di casa, extracomunitari, disoccupati o famiglie
indigenti, dimostrano di essere alle prese con una situazione economica
insostenibile o di non aver mai potuto accedere a bandi di assegnazione alle
case popolari per vari motivi (ad esempio: non ne sono stati fatti per lunghi
periodi), l’anziano in questione potrebbe rischiare di sudare le proverbiali
sette camicie. Trattandosi di case popolari, la proprietà non è di nessuno ma
del Comune. Questo vuol dire che quando qualcuno non è presente, fra gli altri
bisognosi scatta una vera e propria corsa a chi arraffa la casa. Ci sarebbero sì
le graduatorie per assegnare gli immobili, ma non mai vengono rispettate. Nel
sud, affidarsi alla criminalità organizzata, pagando il dovuto, è il metodo più
sicuro per assicurarsi una casa popolare. Chi pensa che questo sia un fenomeno
di nicchia, si sbaglia di grosso. Le cifre infatti sono clamorose, anche se
difficilmente reperibili. L’indagine più recente e affidabile da questo punto di
vista è stata realizzata da Dexia Crediop per Federcasa sul Social Housing 2008.
E parla di ben 40.000 case popolari occupate abusivamente in tutto lo Stivale,
che se venissero assegnate a chi ne ha diritto permetterebbero a circa 100.000
persone di uscire da uno stato di emergenza.
L’onestà non paga. Ti serve
una casa? Sfonda la porta e occupa, scrive Arnaldo Capezzuto su “Il Fatto
Quotidiano”. L’appartamento di edilizia residenziale è abitato da una famiglia
legittima assegnataria del diritto alla casa ottenuto attraverso un regolare
quanto raro bando pubblico con relativo posto in graduatoria? Chi se ne fotte.
Li cacci a calci in culo. E se non vogliono andare via, aspetti che escano e ti
impossessi dell’abitazione. Con calma poi metti i loro mobili, vestiti e effetti
personali in strada. Se malauguratamente qualcuno di loro ha la pazza idea di
contattare le forze dell’ordine per sporgere denuncia, niente problema: li fai
minacciare da qualche “cumpariello” inducendoli a dichiarare che quelle persone
sono amici-parenti. Onde evitare però sospetti, con calma fai presentare un
certificato di stato di famiglia dove i “signori occupanti” risultano dei
conviventi. Il trucco è palese. Non regge l’escamotage dell’appartamento ceduto
volontariamente. Certo. Gli investigatori non dormono. Questo è chiaro. Il
solerte poliziotto esegue l’accertamento. I nodi alla fine vengo al pettine. La
denuncia scatta immediata. La giustizia è lenta ma implacabile. Lo Stato vince.
Gli occupanti abusivi in generale ammettono subito che sono abusivi. Quindi? Nei
fatti c’è un organismo dello Stato – i verbali delle forze dell’ordine, le
lettere di diffida degli enti pubblici gestori degli appartamenti – che
certifica che a decorrere dal giorno x , dal mese x, dall’anno x, l’abitazione
che era assegnata a tizio, caio e sempronio ora con la violenza e il sopruso è
stato occupata da pinco pallino qualsiasi. La malapolitica trasversalmente e
consociativamente per puri e bassi calcoli elettoralistici e non solo mascherati
da esigenze sociali, di povertà, di coesione sociale e stronzate varie
compulsando e piegando le istituzioni si attivano e varano con il classico blitz
leggi, norme, regolamenti che vanno a sanare gli abusivi. Chi ha infranto la
legge, chi ha prevaricato sul più debole, chi ha strizzato l’occhio al
camorrista e al politiconzolo di turno, chi non mai ha presentato una regolare
domanda di assegnazione, chi neppure ha i requisiti minimi per ottenere alla
luce del sole un’abitazione si ritrova per "legge" un alloggio di proprietà
pubblica a canone agevolatissimo. Accade in Campania e dove sennò in Africa?
Martedì 7 maggio 2013 è stato
pubblicato sul Burc la nuova sanatoria per chi ha assaltato le case degli enti
pubblici. La Regione Campania guidata dal governatore Stefano Caldoro ha varato
all’interno della finanziaria regionale un provvedimento che regolarizza e
stabilisce che può richiedere l’alloggio chi lo ha occupato prima del 31
dicembre 2010. Si badi bene che lo scorso anno era stato deciso con una legge
simile che poteva ottenere la casa chi l’aveva assaltata entro il 2009.
L’interrogativo sorge spontaneo: se puntualmente ogni anno varate una sanatoria
per gli abusivi ma perché allora pubblicate i bandi di assegnazione con
graduatoria se poi le persone oneste sono destinate ad avere sempre la peggio?
Misteri regionali. C’è da precisare però che la nuova sanatoria contiene delle
norme “innovative” e “rivoluzionarie” a tutela della legalità (non è una
battuta!) per evitare che tra gli assegnatari in sanatoria ci siano pregiudicati
e che le occupazione siano guidate dalla camorra. A questo punto c’è davvero da
ridere. Le norme per entrare in vigore – però – hanno bisogno del “si” degli
enti locali. Ecco il Comune di Napoli – ad esempio – ha detto “no”. Non è
pragmatismo ma è guardare negli occhi il mostro. A Napoli non è solo malavita ci
sono casi davvero di estrema povertà. Ma è facile adoperare, manipolare e
nascondersi dietro questi ultimi per far proliferare camorra e fauna
circostante. A Napoli i clan hanno sempre gestito le case di edilizia pubblica.
Ad esempio a Scampia chi vive nei lotti di edilizia popolare sa bene che la
continuità abitativa dipende dalle sorti del clan di riferimento. Chi perde la
guerra, infatti, deve lasciare gli appartamenti ai nuovi padroni. Un altro
esempio è il rione De Gasperi a Ponticelli. Qui il boss Ciro Sarno – ora
fortunatamente dietro le sbarre a scontare diversi ergastoli – decideva le
famiglie che potevano abitare negli appartamenti del Comune di Napoli. Una
tarantella durata per decenni tanto che il padrino Ciro Sarno era soprannominato
in senso dispregiativo ‘o Sindaco proprio per questa sua capacità di disporre di
alloggi pubblici. Stesso discorso per le case del rione Traiano a Soccavo, le
palazzine di Pianura, i parchi di Casavatore, Melito e Caivano.
Di cosa parliamo? Alle
conferenze stampa ci si riempie la bocca con parole come legalità, anticamorra,
lotta ai clan. Poi alla prima occasione utile invece di mostrare discontinuità,
polso duro, mano ferma si deliberano norme che hanno effetti nefasti: alimentano
il mercato della case pubbliche gestite dai soliti professionisti
dell’occupazione abusiva borderline con i clan. Circola in Italia una strana
idea di legalità, scrive Antonio Polito su “Il Corriere della Sera”. I suoi
cultori chiedono alle Procure di esercitare il ruolo improprio di «controllori»
ma non appena possono premiano l'illegalità, per demagogia o per calcolo
elettorale. È il caso di Napoli, città-faro del movimento giustizialista visto
che ha eletto sindaco un pm, dove è stata appena approvata, praticamente
all'unanimità, la sanatoria degli occupanti abusivi delle case comunali. Nel
capoluogo partenopeo si tratta di un fenomeno vastissimo: sono circa 4.500 le
domande di condono giunte al Comune per altrettanti alloggi. Per ogni famiglia
che vedrà legalizzato un abuso, una famiglia che avrebbe invece diritto
all'abitazione secondo le regole e le graduatorie perderà la casa. Non c'è modo
migliore di sancire la legge del più forte, del più illegale; e di invitare
altri futuri abusivi a spaccare serrature e scippare alloggi destinati ai
bisognosi. Ma nelle particolari condizioni di Napoli la sanatoria non è solo
iniqua; è anche un premio alla camorra organizzata. È stato infatti provato da
inchieste giornalistiche e giudiziarie che «l'occupazione abusiva di case è per
i clan la modalità privilegiata di occupazione del territorio», come ha detto un
pubblico ministero. In rioni diventati tristemente famosi, a Secondigliano,
Ponticelli, San Giovanni, cacciare con il fuoco e le pistole i legittimi
assegnatari per mettere al loro posto gli affiliati o i clientes della famiglia
camorristica è il modo per impadronirsi di intere fette della città; sfruttando
le strutture architettoniche dell'edilizia popolare per creare veri e propri
«fortini», canyon chiusi da cancelli, garitte, telecamere, posti di blocco,
praticamente inaccessibili dall'esterno e perfetto nascondiglio per latitanti,
armi e droga. Non che tutto questo non lo sappia il sindaco de Magistris, che a
Napoli ha fatto il procuratore. E infatti ha evitato di assumersi in prima
persona la responsabilità di questa scelta. L'ha però lasciata fare al consiglio
comunale, Pd e Pdl in testa, difendendola poi con il solito eufemismo politico:
«Non è una sanatoria. Io la chiamerei delibera sul diritto alla casa». E in
effetti è una delibera che riconosce il diritto alla casa a chi già ce l'ha,
avendola occupata con la forza o l'astuzia.
E gli alloggi di proprietà?
Le Iene, 1 ottobre 2013: case
occupate abusivamente.
23.40. L’associazione Action
organizza occupazioni di case: prima erano per lo più extracomunitari, ora
sempre più spesso esponenti del ceto medio che non riesce più a pagare il mutuo
e viene sfrattata. Occupano così case vuote o sfitte. O, peggio, entrano in case
abitate, cambiano la serratura e addio (un incubo per molti). Una signora, però,
ha rioccupato la casa da cui è stata sfrattata.
23.48. Si racconta la storia
di una ragazza non ancora trentenne, fiorista, che ha occupato una casa comprata
da una famiglia, che ha acceso un mutuo e che ora si trova con un immobile
svalutato e un ambiente ben diverso da quello residenziale che avevano scelto
per far crescere i propri figli. “Si è scatenata una guerra tra poveri” dice una
signora che vive qui ‘legalmente’, che va a lavorare tutti i giorni per pagare
un mutuo per una casa che non rivenderà mai allo stesso prezzo. E’ truffata
anche lei.
L’occupazione abusiva degli
immobili altrui e la tutela delle vittime.
In sede civile, scrive Alessio
Anceschi, chi si veda abusivamente privato del proprio immobile può certamente
adire l’autorità giudiziaria al fine di rientrare nella disponibilità di esso da
coloro che lo hanno illegittimamente occupato. In tal senso, potrà proporre
l’azione di rivendicazione (art. 948 c.c.), oppure, entro i termini previsti
dalla legge, l’azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.). Il legittimo
proprietario o possessore dell’immobile potrà anche agire al fine di ottenere il
risarcimento dei danni sofferti, i quali si prestano ad essere molto ingenti,
sia sotto il profilo patrimoniale, che esistenziale. In tutti i casi, tuttavia,
in considerazione della lunghezza del procedimento civile e soprattutto del
procedimento di esecuzione, il legittimo proprietario o possessore dell’immobile
si trova concretamente privato della propria abitazione (e di tutti i beni che
in essa sono contenuti) e quindi costretto a vivere altrove, da parenti o amici,
quando và bene, in ricoveri o per la strada quando và male.
Sotto il profilo penale sono
ravvisabili molti reati. Prima di tutti, il reato di invasione di terreni od
edifici (art. 633 c.p.), ma anche altri reati contro il patrimonio
funzionalmente collegati all’occupazione abusiva, quali il danneggiamento (art.
635 c.p.) ed il furto (artt. 624 e 625 c.p.). Il secondo luogo, colui che occupa
abusivamente un immobile altrui commette il reato di violazione di domicilio
(art. 614 c.p.). Anche in questo caso, tuttavia, la tutela postuma che consegue
alla sentenza non si presta a tutelare adeguatamente la vittima. Infatti, il
reato di cui all’art. 633 c.p., unica tra le ipotesi citate ad integrare un
reato permanente, non consente l’applicazione né di misure precautelari, né di
misure cautelari. Lo stesso vale per gli altri reati sopra indicati, soprattutto
quando non vi sia stata flagranza di reato. La vittima dovrà quindi attendere
l’interminabile protrarsi del procedimento penale ed anche in caso di condanna,
non avrà garanzie sulla reintegrazione del proprio bene immobile, posto che
l’esiguità delle pene previste per i reati indicati e le mille vie d’uscita che
offre il sistema penale, si presta a beffare nuovamente la povera vittima, anche
laddove si sia costituita parte civile. Laddove poi l’abusivo trascini
nell’immobile occupato la propria famiglia, con prole minorenne, le possibilità
di vedersi restituire la propria abitazione scendono drasticamente, in virtù dei
vari meccanismi presenti tanto sotto il profilo civilistico, quanto di quello
penalistico.
La mancanza di tutela per la
vittima è evidente in tutta la sua ingiustizia. Essa diventa ancora più
oltraggiosa quando le vittime sono i soggetti deboli, soprattutto, come accade
spesso, gli anziani. Che fare ? Nell’attesa che ciò si compia, ove si ritenga
che il nostro “Sistema Giudiziario” sembri tutelare solo i criminali, può
osservarsi che esso può tutelare anche le vittime, laddove siano costrette a
convertirsi, per “necessità” di sopravvivenza e per autotutela. In effetti,
occorre osservare che, il nostro ordinamento penale, che di recente ha anche
ampliato la portata applicativa della scriminante della legittima difesa nelle
ipotesi di violazione di domicilio (art. 52 c.p., come mod. l. 13.2.2006 n. 59),
non consente che una persona ultrasettantenne possa subire una misura custodiale
in carcere (artt. 275 co. 4° c.p.p. e 47 ter, l. 354/1975). Conseguentemente,
solamente laddove l’anziano ultrasettantenne, spinto dall’amarezza, trovasse il
coraggio di commettere omicidio nei confronti di tutti coloro che, senza
scrupoli, lo abbiano indebitamente spogliato della propria abitazione, potrebbe
rientrare immediatamente nel possesso della propria abitazione, con la sicurezza
che, il nostro sistema giudiziario, gli garantirebbe una doverosa permanenza in
essa attraverso gli arresti o la detenzione domiciliare. Contraddizioni di
questa nostra Italia !!!
"Esci di casa e te la
occupano… e alla Cassazione va bene così" ha titolato un quotidiano commentando
una sentenza della Cassazione che avrebbe di fatto legittimato l'occupazione
abusiva degli alloggi. L'articolo riportava le affermazioni di un sedicente
funzionario dell'ex Istituto autonomo case popolari (Iacp) che consigliava
all'assegnatario di un alloggio di mettere una porta blindata perché "Se sua
mamma e suo papa vanno in ferie un paio di settimane, poi arrivano degli
abusivi, quelli sfondano, mettono fuori i mobili, ci mettono i loro, e nessuno
ha il potere di sgomberarli… Non ci si crede, ma è così". Ed infatti non bisogna
credergli… Non è così, scrive “Sicurezza Pubblica”. Gli ipotetici abusivi di cui
sopra commettono il reato di violazione di domicilio, e la polizia giudiziaria
deve intervenire d'iniziativa per "impedire che venga portato a conseguenze
ulteriori" (art. 55 cpp) allontanando (anche con la forza) i colpevoli dai
locali occupati contro la legge. Il secondo comma dell'art. 614 cp commina (cioè
minaccia) la pena della reclusione fino a tre anni a chiunque si trattenga
nell'abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora, o nelle
appartenenze di essi, contro la volontà espressa di chi ha il diritto di
escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. La pena è da
uno a cinque anni (arresto facoltativo, dunque) e si procede d'ufficio se il
fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, o se il colpevole è
palesemente armato. Il reato è permanente. Perciò possiamo andare
tranquillamente in ferie perché se qualcuno viola il nostro domicilio forzando
la porta o una finestra, la polizia giudiziaria è obbligata a liberare
l'alloggio ed il colpevole può essere arrestato. Quali potrebbero essere le
responsabilità della polizia giudiziaria, che eventualmente omettesse o
ritardasse l'intervento? Secondo l'art. 55 c.p.p. la p.g. deve (obbligo
giuridico) impedire che i reati vengano portati a ulteriori conseguenze, mentre
secondo l'art, 40 comma 2 del c.p.: "Non impedire un evento che si ha l'obbligo
giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". Perciò le ulteriori conseguenze
dell'occupazione potrebbero essere addebitate ai responsabili del ritardo o
dell'omissione.
Cosa ha veramente la
Cassazione?
L'equivoco è nato dalla errata
lettura della sentenza 27 giugno - 26 settembre2007, n. 35580, in cui la suprema
Corte ha trattato il caso di una persona che, denunciata per aver occupato
abusivamente un alloggio ex Iacp vuoto, aveva invocato l'esimente dello stato di
necessità previsto dall'art. 54 cp, ma era stata condannata. La Corte non ha
affatto legittimato il reato, ma si è limitata ad annullare la sentenza
d'appello con rinvio ad altro giudice, ritenendo che fosse stata omessa la
dovuta indagine per verificare se l'esimente stessa sussistesse o meno. Nulla di
rivoluzionario dunque, ma applicazione di un principio: quando il giudice
ravvisa l'art. 54 cp, il reato sussiste, ma "non è punibile chi ha commesso il
fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal
pericolo attuale di un danno grave alla persona". In quest'ottica, giova
rammentare la sentenza 9265 del 9 marzo 2012, che ha definitivamente
fatto chiarezza (qualora ce ne fosse stato bisogno). La Cassazione ha respinto
il ricorso di una 43enne contro la sentenza del giudice di merito che aveva
ritenuto la donna colpevole del reato di cui agli articoli 633 e 639 bis Cp per
avere abusivamente occupato un immobile di proprietà dello Iacp di Palermo. La
seconda sezione penale, confermando la condanna, ha escluso lo stato di
necessità precisando che in base all’articolo 54 Cp per configurare questa
esimente (la cui prova spetta all’imputato che la invoca), occorre che «nel
momento in cui l’agente agisce contra ius - al fine di evitare un danno grave
alla persona - il pericolo deve essere imminente e, quindi, individuato e
circoscritto nel tempo e nello spazio. L’attualità del pericolo esclude quindi
tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta
di cronicità essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo». Nell' ipotesi
dell’occupazione di beni altrui, lo stato di necessità può essere invocato
soltanto per un pericolo attuale e transitorio non certo per sopperire alla
necessità di risolvere la propria esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi
Iacp sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di non abbienti,
attraverso procedure pubbliche e regolamentate. In sintesi: una precaria e
ipotetica condizione di salute non può legittimare, ai sensi dell’articolo 54
Cp, un’occupazione permanente di un immobile per risolvere, in realtà, in modo
surrettizio, un’esigenza abitativa.
Sequestro preventivo
dell'immobile occupato abusivamente.
La sussistenza di eventuali
cause di giustificazione non esclude l'applicabilità della misura cautelare
reale del sequestro preventivo. D'altronde la libera disponibilità dell'immobile
comporterebbe un aggravamento o una protrazione delle conseguenze del reato, che
il sequestro preventivo mira invece a congelare. (Corte di Cassazione, sez. II
Penale, sentenza n. 7722/12; depositata il 28 febbraio). Il caso. Due indagati
del reato di invasione e occupazione di un edificio di proprietà dell'Istituto
Autonomo Case Popolari ricorrevano per cassazione avverso l'ordinanza del
Tribunale del Riesame di Lecce, che confermava il sequestro preventivo
dell'immobile disposto dal GIP. A sostegno della loro tesi difensiva, gli
indagati introducevano un elemento afferente il merito della responsabilità
penale, sostenendo come fosse documentato lo stato di assoluta indigenza in cui
versavano, tale da averli costretti ad occupare l'immobile per la necessità di
evitare un danno maggiore alla loro esistenza e salute. In sostanza, invocavano
lo stato di necessità che, secondo la tesi difensiva, avrebbe non solo
giustificato l'occupazione, ma che avrebbe potuto determinare una revoca del
provvedimento cautelare disposto…non opera per le misure cautelari reali. La
Suprema Corte esamina la censura, ma la rigetta perché, nel silenzio della
legge, non può applicarsi la regola - prevista dall'art. 273 comma 2 c.p.p. per
le sole misure cautelari personali - che stabilisce che nessuna misura
(personale) può essere disposta quando il fatto è compiuto in presenza di una
causa di giustificazione, quale appunto l'invocato stato di necessità.
L'ordinanza impugnata ha chiarito che i due indagati hanno abusivamente occupato
un alloggio già assegnato ad altra persona, poi deceduta, e ha correttamente
rilevato che è del tutto irrilevante la circostanza che nel lontano 1983 il B.
sia stato assegnatario di un altro alloggio del cui possesso sarebbe stato
spogliato. Se queste sono le circostanze di fatto non è ravvisabile alcuna
violazione di legge, ma solo una diversa valutazione dei fatti stessi non
consentita in questa sede di legittimità, per di più con riferimento a misure
cautelari reali (art. 325, comma 1, c.p.p.). Per quanto concerne la sussistenza
della dedotta causa di giustificazione, se è vero che, in tema di misure
cautelari personali, ai sensi dall'art. 273, comma 2, cod. proc. pen., nessuna
misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza
di una causa di giustificazione, l'applicabilità di una analoga normativa con
riferimento alle misure cautelari reali, in assenza di espressa previsione di
legge, deve tenere conto dei limiti imposti al Tribunale in sede di riesame, nel
senso che la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare
reale da parte del tribunale del riesame non può tradursi in anticipata
decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona
sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve
limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella
legale (per tutte: Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Bocedi, Rv. 215840). È evidente,
pertanto, che una causa di giustificazione può rilevare nell'ambito del
procedimento relativo a misure cautelari reali solo se la sua sussistenza possa
affermarsi con un ragionevole grado di certezza. Anche sulla sussistenza del
periculum in mora l'ordinanza impugnata, espressamente pronunciandosi sul punto,
afferma che la libera disponibilità da parte degli indagati dell'immobile in
questione comporterebbe un aggravamento o una protrazione delle conseguenze del
reato commesso. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali.
Condotta e dolo specifico.
L'articolo 633 cp stabilisce
che "Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o
privati, al fine di occuparli o trame altrimenti profitto è punito a querela
della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa. Si
procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una
almeno palesemente armata, o da più di dieci persone anche senz'armi". Si
procede altresì d'ufficio (art. 638 bis c.p.) se si tratta di acque, terreni,
fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico. Perché sussista il reato,
occorre che l'agente penetri dall'esterno nell'immobile (anche senza violenza) e
ne violi l'esclusività della proprietà o del possesso per una apprezzabile
durata, contro la volontà del titolare del diritto o senza che la legge
autorizzi tale condotta. Questo reato non consiste nel semplice fatto di
invadere edifici o terreni altrui, ma richiede il dolo specifico, cioè la
coscienza e volontà di invaderli al fine di occuparli o trame altrimenti
profitto. Non occorre neppure l'intenzione dell'occupazione definitiva, anche se
essa deve avere una durata apprezzabile. In caso di immobile già invaso, è
possibile il concorso successivo di persone diverse dai primi autori
dell'invasione (Cass. pen., Sez. Il, sent. 22 maggio 1975, n. 5459). Quanto al
reato di violazione di domicilio, previsto dall'art. 614 del C.P., esso è
ravvisabile anche "nella condotta di abusiva introduzione (o abusiva permanenza)
nei locali di una guardia medica fuori dell'orario ordinario di apertura al
pubblico per l'assistenza sanitaria. Infatti, se nell'orario ordinario di
servizio la guardia medica è aperta al pubblico, nell'orario notturno l'acceso è
limitato a quelli che hanno necessità di assistenza medica e che quindi sono
ammessi all'interno dei locali della stessa. Pertanto in questo particolare
contesto l'ambiente della guardia medica costituisce un'area riservata che può
assimilarsi a quella di un temporaneo privato domicilio del medico chiamato a
permanere lì durante la notte per potersi attivare, ove necessario, per
apprestare l'assistenza sanitaria dovuta" (Cass. pen. Sez. III, sent. 6 giugno -
30 agosto 2012, n. 33518, in Guida al diritto n. 39 del 2012, pag. 88).
Flagranza e procedibilità
d'ufficio.
Il reato d'invasione di
terreno o edifici ha natura permanente e cessa soltanto con l'allontanamento del
soggetto dall'edificio, o con la sentenza di condanna, dato che l'offesa al
patrimonio pubblico perdura sino a che continua l'invasione arbitraria
dell'immobile. Dopo la pronuncia della sentenza, la protrazione del
comportamento illecito da luogo a una nuova ipotesi di reato, che non necessita
del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione
dell'occupazione (Cass. pen., Sez. Il, sent. 22 dicembre 2003, n. 49169). Nella
distinzione tra uso pubblico e uso privato, una recente pronuncia ha affermato
che "l'alloggio realizzato dall'Istituto autonomo delle case popolari (lacp),
conserva la sua destinazione pubblicistica anche quando ne sia avvenuta la
consegna all'assegnatario, cui non abbia ancora fatto seguito il definitivo
trasferimento della proprietà. Ne deriva che, in tale situazione, l'eventuale
invasione ad opera di terzi dell'alloggio medesimo è perseguibile d'ufficio, ai
sensi dell'art. 639 bis cp" (Cass. pen., Sez. Il, 12 novembre 2007, n. 41538).
In caso di invasione arbitraria di edifici costruiti da un appaltatore per conto
dell'ex lacp e non ancora consegnati all'Istituto, la persona offesa, titolare
del diritto di querela è l'appaltatore. Ai fini della procedibilità d'ufficio
del reato di cui all'art. 633 c.p., l'uso della disgiuntiva nell'art. 633-bis
(edifici pubblici o destinati a uso pubblico) pone il carattere pubblico come di
per sè sufficiente a configurare la procedibilità d'ufficio, nel senso che è
sufficiente che l'edificio sia di proprietà di un ente pubblico. A tal fine, si
devono considerare pubblici, secondo la nozione che il legislatore penale ha
mutuato dagli articoli 822 e seguenti del Cc, i beni appartenenti a qualsiasi
titolo allo stato o a un ente pubblico, quindi non solo i beni demaniali, ma
anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti
predetti. Mentre, sempre per la procedibilità d'ufficio, sono da considerare
"destinati a uso pubblico" quegli altri beni che, pur in ipo0tesi appartenenti a
privati, detta destinazione abbiano concretamente ricevuto
(Corte Appello di Palermo, sent. 20-22 giugno 2011,n. 2351 in
Guida al diritto n. 46 del 19 novembre 2011).
L'art. 634 c.p. - Turbativa
violenta del possesso di cose immobili.
Chiunque, fuori dei casi
indicati nell'articolo 633 c.p., turba, con violenza alla persona o con
minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309. Il fatto si
considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci
persone. La maggior parte della dottrina ritiene che l'unica distinzione
possibile sia quella che fa perno sull'elemento soggettivo: mentre nell'art. 633
è previsto il dolo specifico, per l'art. 634 è sufficiente il dolo generico. Di
conseguenza si dovrà applicare l'art. 634 qualora vi sia un'invasione non
qualificata dal fine di occupare i terreno e gli edifici o di trarne altrimenti
profitto. Viceversa sussisterà la fattispecie di cui all'art. 633 anche nel caso
di invasione violenta finalizzata all'occupazione o al profitto. La turbativa di
cui all'art. 634 postula un comportamento minimo più grave della semplice
introduzione (art. 637) e meno grave dell'invasione (art. 633). La nozione di
turbativa deve intendersi come una non pregnante compromissione dei poteri del
possessore. La semplice violenza sulle cose, che non sia usata per coartare
l'altrui volontà, non basta ad integrare il reato. Peraltro il comma 2 dell'art.
634, parifica alla violenza alla persona e alla minaccia, la presenza di un
numero di persone (che commettono il fatto) superiore a dieci. Si discute se si
tratti di un delitto istantaneo o permanente. Prevale l'opinione che ritiene
trattarsi di reato istantaneo, potendo assumere connotazione permanente allorchè
la perturbazione richieda l'esperimento di una condotta prolungata nel tempo,
sostenuta da costante volontà del soggetto agente (Manzini).
Come agire?
Il delitto di violazione di
domicilio è permanente ed ammette l'arresto facoltativo in flagranza (art. 381,
lett. f-bis c.p.p.) Anche il delitto di invasione al fine di occupazione (art.
633 c.p.) è permanente: la condotta criminosa perdura per tutto il tempo
dell'occupazione e deve essere interrotta dalla polizia giudiziaria, che anche
di propria iniziativa deve impedire che i reati vengano portati a ulteriore
conseguenze (art. 55 cpp). Non appena i titolari del diritto sull'alloggio danno
notizia dell'avvenuta invasione agli organi di pg questi ultimi, se dispongono
delle forze necessarie, debbono procedere allo sgombero, senza necessità di
attendere il provvedimento dell'Autorità. In ambedue i casi spetta al giudice
valutare poi l'esistenza di eventuali esimenti.
Inerente l'occupazione abusiva
di un immobile, pare opportuno inserire una breve digressione sulle azioni a
tutela dei diritti di godimento e del possesso. Il panorama si presenta alquanto
vario; troviamo, infatti, le azioni concesse al solo proprietario, quelle
esperibili dal titolare di un diritto di godimento su cosa altrui o dal
possessore in quanto tale. Tali azioni vengono qualificate come reali, in quanto
offrono tutela per il solo fatto della violazione del diritto.
L'azione di rivendicazione,
rientrante fra le azioni petitorie, tende ad ottenere il riconoscimento del
diritto del proprietario sul bene e presuppone la mancanza del possesso da parte
dello stesso; è imprescrittibile e richiede la dimostrazione del proprio diritto
risalendo ad un acquisto a titolo originario.
L'azione negatoria è concessa
al proprietario al fine di veder dichiarata l'inesistenza di diritti altrui
sulla cosa o la cessazione di turbative o molestie; in questo caso al
proprietario si richiede soltanto la prova, anche in via presuntiva,
dell'esistenza di un titolo dal quale risulti il suo acquisto.
L'azione di regolamento di
confini mira all'accertamento del proprio diritto nel caso in cui siano incerti
i confini dello stesso rispetto a quello confinante; in tale ipotesi la prova
del confine può essere data in qualsiasi modo. Nell'azione di apposizione di
termini, al contrario, ciò che si richiede al Giudice è l'individuazione,
tramite indicazioni distintive, dei segni di confine tra due fondi confinanti.
L'azione confessoria è volta a
far dichiarare l'esistenza del proprio diritto contro chi ne contesti
l'esercizio, e a far cessare gli atti impeditivi al suo svolgimento.
A difesa del possesso
incontriamo le categorie delle azioni possessorie e di enunciazione: le prime si
distinguono nell'azione di reintegrazione, che mira a far recuperare il bene a
chi sia stato violentemente o clandestinamente spogliato del possesso, da
proporsi entro un anno dallo spoglio, e l'azione di manutenzione, proposta al
fine di far cessare le molestie e le turbative all'esercizio del diritto.
L'azione di manutenzione, al
contrario di quella di reintegrazione, ha una funzione conservativa, poiché mira
alla cessazione della molestia per conservare integro il possesso, e una
funzione preventiva, poiché può essere esperita anche verso il solo pericolo di
una molestia. Diversamente dalle azioni a difesa della proprietà, che impongono
la prova del diritto, il possessore ha soltanto l'onere di dimostrare il
possesso (in quanto questo prescinde dall'effettiva titolarità del diritto). Le
azioni di enunciazione, con le quali si tende alla eliminazione di un pericolo
proveniente dal fondo vicino, si distinguono nella denunzia di nuova opera e di
danno temuto; esse, infatti, vengono qualificate come azioni inibitorie,
cautelari, che possono dar luogo a provvedimenti provvisori.
ITALIA. SOLIDARIETA’
TRUCCATA E DI SINISTRA.
Ma come sono cari (e di
sinistra) i professionisti dell'accoglienza.
L'emergenza sbarchi comporta un giro vorticoso di denaro pubblico. Che si ripete
senza soluzione, scrive Stefano Filippi su “Il Giornale”. Dietro l'orrore, la
pietà, lo scandalo, il buonismo, le tragedie del mare nascondono il business che
non t'aspetti. Il giro d'affari del primo soccorso e dell'accoglienza. Da una
parte i milioni di euro stanziati dall'Europa e dall'Italia, dall'altra la
pletora di personaggi in attesa di incassare. Onlus, patronati, cooperative,
professionisti dell'emergenza, noleggiatori di aerei e traghetti, perfino i
poveri operatori turistici di Lampedusa: abbandonati dai vacanzieri si
rassegnano a riempire camere d'albergo, appartamenti e ristoranti con agenti,
volontari, giornalisti, personale delle organizzazioni non governative, della
Protezione civile, della Croce rossa. L'emergenza sbarchi comporta un giro
vorticoso di denaro pubblico. Nel 2011, l'anno più drammatico, gli sbarchi
provocati dalle sanguinose rivolte nordafricane sono costati all'Italia un
miliardo di euro. Ogni giorno le carrette del mare da Libia e Tunisia hanno
scaricato in media 1.500 persone. Il governo dovette aumentare le accise sui
carburanti per coprire parte di queste spese. E a qualcuno che sborsa
corrisponde sempre qualcun altro che incassa. Bisogna gestire la prima
accoglienza: acqua, cibo, vestiti, coperte, farmaci. Vanno organizzati i
trasferimenti sul continente ed eventualmente i rimpatri; si aggiungono spese
legali, l'ordine pubblico, l'assistenza (medici, psicologi, interpreti,
mediatori culturali). Ma questo è soltanto l'inizio, perché moltissimi rifugiati
chiedono asilo all'Italia. E l'Italia se ne fa carico, a differenza della Spagna
che ordina di cannoneggiare i barconi e di Malta che semplicemente abbandona i
disperati al loro destino. Nel triennio 2011/13 le casse pubbliche (ministero
dell'Interno ed enti locali) hanno stanziato quasi 50 milioni di euro per
integrare 3000 persone attraverso il Sistema di protezione per i richiedenti
asilo e rifugiati. A testa fanno più di 5.000 euro l'anno. L'Europa soccorre
soltanto in parte. Il finanziamento più cospicuo arriva dal Fondo europeo per le
frontiere esterne destinato alle forze di sicurezza di confine (capitanerie di
porto, marina militare, guardia di finanza): 30 milioni annui. Altri 14,7
milioni arrivano dal Fondo per l'integrazione, non riservato all'emergenza. Dal
Fondo per i rimpatri piovono 7 milioni di euro. Poi c'è il Fondo per i
rifugiati, che nel 2012 ha stanziato 7 milioni in via ordinaria più altri 5 per
misure di emergenza. Tutti questi denari vanno considerati come
co-finanziamento: si aggiungono cioè ai soldi che l'Italia deve erogare. Il
fondo più interessante è quello per i rifugiati, che è tale soltanto di nome
perché i veri destinatari dei 12 milioni di euro (sono stati 10 milioni nel
2008, 4,5 nel 2009, 7,2 nel 2010 e addirittura 20 nel fatidico 2011) sono Onlus,
Ong, cooperative, patronati sindacali e le varie associazioni umanitarie che si
muovono nel settore dell'immigrazione. Dal 2008, infatti, l'Europa ha stabilito
che quel fiume di contributi vada «non più all'attività istituzionale per
l'accoglienza, ma ad azioni complementari, integrative e rafforzative di essa».
Anche queste, naturalmente, co-finanziate dal governo italiano. Le
organizzazioni operano alla luce del sole, sono autorizzate dal ministero
dell'Interno che deve approvare progetti selezionati attraverso concorsi
pubblici. I soldi finiscono in fondi spese destinati non ai disperati ma a vitto
e alloggio delle truppe di volontari e professionisti. Per la felicità degli
albergatori lampedusani. Gli operatori sociali spiegano ai nuovi arrivati i loro
diritti. Li mettono in contatto con interpreti, avvocati, mediatori da essi
retribuiti. Organizzano la permanenza, li aiutano a restare in Italia o a capire
come proseguire il loro viaggio della speranza. Fanno compilare agli sbarcati,
che per la legge sono clandestini, un pacco di moduli per avere assistenza
legale d'ufficio. Pochissime organizzazioni, e tra queste Terre des hommes e
Medici senza frontiere, si fanno bastare i denari privati. A tutte le altre i
soldi italo-europei servono anche a sostenere i rispettivi apparati, come gli
uffici stampa, gli avvocati e gli attivisti per i diritti umani, per i quali
martellare i governi finanziatori è una vera professione. E magari usano
l'emergenza immigrazione come trampolino verso la politica.
Destra, sinistra e
solidarietà.
Come ci segnala un articolo de Il Redattore Sociale, la presenza del Terzo
Settore nelle liste dei candidati alle prossime elezioni è piuttosto
significativa: presidenti e direttori di molte importanti organizzazioni si
presentano nelle liste di PD, SEL, Ingroia e Monti. Questo scrive Gianni Rufini
su “La Repubblica”. Gianni Rufini, esperto di aiuto umanitario, ha lavorato
in missioni di assistenza in quattro continenti e insegna in numerose università
italiane e straniere. Se saranno eletti, buona parte dell’associazionismo e
del movimento cooperativo dovrà rinnovare i propri vertici. Molto meno forte, la
presenza del mondo della solidarietà internazionale. Ci sono personalità di
rilievo, come gli ottimi Laura Boldrini e Giulio Marcon, ma non abbastanza –
temo – da far nascere all’interno del parlamento un nucleo significativo di
deputati e senatori che possano promuovere un rinnovamento della politica
italiana in questo senso. Ma speriamo bene. Tutte queste persone si candidano
con partiti di sinistra o di centro, mentre la destra è completamente assente.
Se è vero che la sinistra è sempre stata più attenta a questi temi, sono
profondamente convinto che questioni come la cooperazione, l’aiuto umanitario o
i diritti umani siano assolutamente trasversali. Possono esserci visioni diverse
sulle politiche in questi campi, ma dovrebbe esserci un’intesa di fondo per
questioni che riguardano tutti i cittadini, di qualunque orientamento, in ogni
regime politico. Purtroppo non è così. In altri paesi, esiste un
“conservatorismo compassionevole” che ritiene moralmente doveroso impegnarsi in
questi ambiti; si trovano politiche estere di destra che vedono comunque nella
cooperazione uno strumento fondamentale; ci sono politiche sociali conservatrici
che promuovono il volontarismo per ridurre il peso dello Stato; ci sono visioni
del capitalismo che ritengono centrali, per il suo sviluppo, i diritti umani.
Nella destra italiana sembra invece prevalere una visione che definirei
“cattivista”. Sembra che da noi, per essere di destra bisogna necessariamente
coltivare cattivi sentimenti: l’irrisione per i poveri, l’avidità, lo sprezzo
del senso civico, il calpestamento dei diritti altrui. Cosa particolarmente
strana, in un paese che ha una forte cultura cattolica e una storia importante
di solidarietà unitaria, per esempio nei grandi disastri. E’ difficile
comprendere la mutazione che ha portato la destra italiana a questa deriva
antropologica. Forse è un altro dei residuati tossici dell’ultimo ventennio.
Questo è un problema per l’Italia, per due ragioni: la prima è che quando si
parla di diritti, di umanità, di relazioni con il mondo, si parla dell’identità
profonda di un paese, e questa dovrebbe essere in massima parte condivisa dalle
forze politiche. E poi, perché le strategie in questo campo esigono tempi
lunghi, per produrre risultati, tempi di decenni. E non possono scomparire e
ricomparire ad ogni cambio di governo. Credo che il lavoro più importante che
dovranno fare quei colleghi che hanno deciso di impegnarsi in politica sia
promuovere un cambiamento culturale dentro la politica, dentro il
parlamento. Perché certi principi e certi valori diventino un patrimonio
condiviso, al di là delle differenze ideologiche.
LA GUERRA TRA ASSOCIAZIONI
ANTIRACKET.
“L’efficienza delle
associazioni antimafia non si misura in fase ai finanziamenti ricevuti, alle
denunce presentate, alla parte politica che li sostiene, alla visibilità data
dai media ed alla santificazione di toghe e divise” risponde così il dr Antonio
Giangrande alle dichiarazioni di Maria Antonietta Gualtieri presidente
dell’Associazione Antiracket Salento (…a Brindisi totale assenza di denunce
nonostante tante associazioni antimafia…) ed alla piccata risposta del
presidente Salvatore Incalza dell’associazione antiracket di Francavilla Fontana
associata FAI (..cerca visibilità perché cessa il foraggiamento di Stato…). Il
Dr Antonio Giangrande, presidente nazionale della “Associazione Contro Tutte le
Mafie” da Taranto interviene nella polemica su stampa e tv sorta tra le
associazioni antiracket ed antiusura brindisine e leccesi. Una polemica che
serpeggia, però, in tutta Italia, laddove vi sono costituiti sodalizi antimafia
di contrapposti schieramenti. «L’attività delle associazioni antiracket ed
antiusura non si misura in base alla visibilità mediatica che certe tv locali
politicamente schierate danno ad alcune di loro, finanziate da progetti di
passati Ministri dell’Interno o da sottosegretari a loro vicini e comunque di
finanziamenti ricevuti perché facenti parte del FAI o di Libera; né tantomeno in
base alle denunce presentate da questi sodalizi o dalla loro costituzione in
giudizio per interesse di qualcuno. Il tutto per fare numero e molte volte
contro poveri cristi a vantaggio di truffatori. Sempre bene attenti a non
toccare i poteri forti: tra cui le banche. La loro efficienza non si misura
neanche in base al sostegno finanziario da loro ricevuto dallo Stato o da una
parte politica regionale. Comunque c’è da dire che il grado di valore che si dà
alle associazioni antimafia non è paragonato al fatto di quanto queste siano lo
zerbino o passacarte di toghe e divise. La capacità delle associazioni è legata
alla loro competenza ed al grado di assistenza e consulenza che loro sanno
offrire: senza fare politica. Questo è il loro compito: informare ed assistere
nella stesura degli atti. Le denunce le presentano le presunte vittime e
l’applicazione della giustizia spetta alle toghe ed i contributi li elargisce lo
Stato. Qualcuno non si deve allargare!». Va giù duro il presidente Antonio
Giangrande. « Io penso che la vittima di qualsivoglia sopraffazione e violenza
non ha bisogno di visibilità, per questo noi usiamo il web oltre che la sede
fissa. In questo modo le vittime non hanno bisogno di farsi vedere, quindi si
informano e le denunce le scaricano direttamente dal sito e le presentano alle
forze dell’ordine. Non mancano, però, le lamentele di abbandono da parte dello
Stato. E questo non bisogna tacerlo. Inoltre non siamo affiliati a nessuno e
quindi non riceviamo nulla da alcuno, né ritorno di immagine, né copertura delle
spese. D’altronde che volontariato è se poi si è sovvenzionati e quindi diventa
un lavoro. Alla stampa dico di seguire ed aiutare tutte quelle associazioni che
lavorano sul campo a rischio delle vite dei loro componenti, senza ricevere
nulla. E se proprio vogliono riportare le polemiche, i giornalisti chiedessero a
tutte queste associazioni, che vanno per la maggiore, chi li paga e chi votano e
come mai aprono sportelli antiracket in città in cui non sono iscritte presso le
locali prefetture, così come vuole la legge, tutto a svantaggio di chi è
legalmente iscritto in loco: se ne scoprirebbero delle belle!» Continua Antonio
Giangrande. «Additare i difetti altrui è cosa che tutti sanno fare, più
improbabile è indicare e correggere i propri. Non abbiamo bisogno di eroi, né,
tantomeno, di mistificatori con la tonaca (toga e divisa). L’abito non fa il
monaco. La legalità non va promossa solo nella forma, ma va coltivata anche
nella sostanza. E’ sbagliato ergersi senza meriti dalla parte dei giusti. Se
scrivi e dici la verità con il coraggio che gli altri non hanno, il risultato
non sarà il loro rinsavimento ma l’essere tu additato come pazzo. Ti scontri
sempre con la permalosità di magistrati e giornalisti e la sornionità degli
avvocati avvezzi solo ai loro interessi. Categorie di saccenti che non ammettono
critiche. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Questa è
sociologia storica, di cui sono massimo cultore. Conosciuto nel mondo come
autore ed editore della collana editoriale “L’Italia del Trucco, l’Italia che
siamo” pubblicata su www.controtuttelemafie.it ed altri canali web, su Amazon in
E-Book e su Lulu in cartaceo, oltre che su Google libri. 50 saggi pertinenti
questioni che nessuno osa affrontare. Ho dei canali youtube e sono anche editore
di Tele Web Italia: la web tv di promozione del territorio italiano. Bastone e
carota. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!»
Il livore del PD, SEL, CGIL
e di tutta la loro costellazione di sigle nel Lazio nei confronti
dell’Associazione Caponnetto.
Perché? Preferiscono forse un’antimafia del bon ton diversa dalla nostra di
indagine e denuncia? O avrebbero voluto che ci etichettassimo politicamente
assoggettandoci ai loro interessi e facendo un’antimafia soft, più retorica e
commemorativa, di parata insomma? Questo di chiede l’Associazione antimafia
“Antonino Caponnetto”. Non che ci dispiaccia. Anzi, è tutto il contrario perché
più stiamo lontani da queste nomenclature politiche screditate e più guadagniamo
in credibilità. Pur tuttavia certe cose vanno annotate per far comprendere ai
più sprovveduti e disinformati fino a che punto arrivano la bassezza, la
vuotaggine, l’insulsaggine, l’insignificanza e l’irresponsabilità della classe
dirigente del PD e del suo accoliti nella provincia di Latina e nel Lazio. Sono
oltre 10 anni che il PD del Lazio e della provincia di Latina fa la guerra
all’Associazione Caponnetto mostrando, peraltro, in maniera sfacciata di voler
privilegiare Libera e solo Libera ed il suo modo di fare antimafia. Non abbiamo
mai capito le ragioni di tanta ostilità. Forse perché abbiamo sempre dichiarato
la nostra assoluta indipendenza da tutto e da tutti mentre il PD voleva che noi
ci fossimo etichettati politicamente ed assoggettati ai suoi interessi? O perché
il PD preferisce un modello di antimafia tutto bon ton, all’acqua di rose,
culturale e basta, commemorativo e parolaio e niente affatto di indagine e
denuncia, nomi e cognomi, come facciamo noi dell’Associazione Caponnetto? Non lo
sappiamo e, a questo punto, nemmeno ci interessa saperlo più perché abbiamo
preso atto di un dato di fatto incontrovertibile e consolidato: il PD ed i suoi
accoliti combattono l’Associazione Caponnetto e riconoscono come propria
referente ed amica solo LIBERA. Bene così per il PD, per tutti i suoi accoliti e
per Libera. Se questa è l’antimafia che vuole il PD vadano avanti così ma non
osino più parlare di lotta alle mafie perché li talloneremo e gli rinfacceremo
di volta in volta che la lotta alle mafie non si fa come fanno lor signori che
si limitano solo a parlarne senza affrontare e risolvere i problemi veri della
lotta alla criminalità mafiosa. Brutto segnale quello che viene da questo
partito che dimostra palesemente di non volere l’antimafia reale, quella
effettiva, la vera antimafia, ma solo quella di parata, delle commemorazioni,
del racconto del passato e via di questo passo. La guerra all’Associazione
Caponnetto viene da lontano, dai tempi della Giunta Marrazzo alla Regione Lazio
quando la Presidente della Commissione Criminalità -la PD ex DS Luisa Laurelli –
volle escludere dai vari organismi consultivi della Regione la nostra
Associazione facendo, al contempo, entrarvi sigle assolutamente inconsistenti ed
esistenti solo sulla carta ma etichettate PD, oltre ovviamente a Libera. Cosa
che si è ripetuta puntualmente all’Amministrazione Provinciale di Roma sotto la
gestione Zingaretti, altro campione dell’antimafia parolaia e non di quella
reale dell’indagine e della denuncia. Non che le nostre ripetute esclusioni ci
siano dispiaciute, vista l’assoluta inutilità ed inerzia di tali organismi che
si sono appalesate a posteriori come delle sole sparate propagandistiche senza
alcuna efficacia. Evitiamo, per non tediare coloro che ci seguono, di raccontare
i dettagli, i continui tentativi di isolarci (dal convegno organizzato sempre
dal PD con Piero Grasso durante l’ultima campagna elettorale, con la
partecipazione della Fondazione nostra omonima, a sostegno della candidatura
dell’ex Procuratore Nazionale antimafia, convegno che, pur avendo visto la
nostra esclusione - e ne siamo stati lieti perché era un convegno elettorale e
di partito -, i relatori si sono visti costretti ad esaltare proprio l’opera
dell’Associazione Caponnetto!!!; all’ultima proprio di stamane 21 giugno con il
convegno promosso a livello provinciale e sempre a Gaeta dal Sindacato
Pensionati Italiani della CGIL sui problemi della legalità, un convegno che ha
visto la partecipazione in massa di elementi di Libera e basta). Potremmo citare
altri esempi della faziosità – e, peraltro, anche dell’ottusità politica- della
classe dirigente del PD e dei suoi accoliti di SEL (vi risparmiamo di
raccontarvi il comportamento inqualificabile di Zaratti uomo di punta di SEL il
quale durante una seduta della Commissione criminalità della Regione Lazio della
quale era Presidente dopo la Laurelli non spese una sola parola in difesa
dell’Associazione Caponnetto aggredita violentemente dal suo vicepresidente, un
consigliere di destra di cui non ricordiamo il nome, quasi a mostrare un
malcelato piacere -, della CGIL e così via. Ma tutto ciò non ci duole affatto.
Anzi, il contrario. Perché tutto questo livore nei nostri confronti da parte del
PD, SEL e di tutta la loro costellazione di sigle e siglette nei nostri
confronti sta a provare che agiamo bene, che colpiamo bene, senza lacci e
lacciuoli e che sono sempre di più coloro che hanno paura di noi in quanto
probabilmente sanno di avere qualche scheletro nell’armadio. Questo ovviamente
ci ha fatto accendere una lampadina e ci induce a porci la domanda del “perché”
di tale comportamento… Quando il cane ringhia rabbioso a difesa di una tana vuol
dire che là dentro nasconde qualcosa di importante, la nidiata, un pezzo di
carne… Ci lavoreremo… per scoprirlo. Poi, però, non si dica che siamo… cattivi
o, peggio, faziosi anche noi.
“LIBERA” di nome ma non di
fatto. E’
solo un problema politico, scrive l'associazione antimafia "Casa della legalità
e della cultura Onlus della sicurezza sociale". E' difficile che le cose che non
funzionano vengano indicate quando riguardano quelli che sono una sorta di
“santuari” della cosiddetta società civile. Eppure le distorsioni, i problemi,
anche seri, ci sono. Sono fatti che, messi uno accanto all'altro, ci dicono che
qualcosa non va. Rompiamo questo silenzio, ponendo alcune semplici domande e
dando a queste una risposta. Non è per polemica, ma per dovere di cronaca, per
elencare i fatti di una questione “politica”. Siamo convinti che solo guardando
in faccia la realtà sia possibile migliorare e correggere quegli errori che
troppo spesso impediscono di fare passi avanti nella lotta alle mafie ed
all'illegalità. Il confronto e non la chiusura è strumento essenziale nella
democrazia, e lo è ancora di più quando si parla di strutture importanti, come è
Libera...
Perché criticate “LIBERA”, che
universalmente è riconosciuta, da destra a sinistra, quale grande organizzazione
antimafia?
«Innanzitutto
bisogna premettere che la critica è costruttiva, finalizzata al confronto per
risolvere i problemi. Criticare non significa distruggere e questo è ancora più
indiscutibile quando, come nel nostro caso, la critica è un elencare di fatti
che non si possono tacere ma che impongono, dovrebbero imporre, una riflessione
e quindi una reazione. Quindi... Avete mai sentito pronunciare un nome e cognome
di quella “zona grigia”, della rete di professionisti e politici collusi e
contigui, dagli esponenti di Libera che tanto a slogan punta l'indice contro
questa “zona grigia”? Mai, né un nome di un mafioso (se non già condannato in
via definitiva), né un nome di una società di famiglie mafiose, né il nome dei
politici che nei vari territori sono compromessi, vuoi per contiguità (che non è
un reato) o peggio. Mai un nome delle grandi imprese e cooperative che nei
propri cantieri, quali fornitori, scelgono le “offerte vantaggiose” delle
società di note famiglie mafiose. Non c'è una denuncia che sia una, se non “il
giorno dopo” ad un dramma o allo scattare delle manette o dei sigilli a qualche
bene.»
Ma questo può essere solo un modo
diverso di combattere la stessa battaglia...
«Non
è un discussione la “diversità” di metodi, ma i fatti ci testimoniano che la
questione non è solo un diverso modo di agire nella lotta alla mafia...La Libera
che abbiamo visto da qualche anno a questa parte, diversa, radicalmente diversa,
da quella delle origini, ha scelto una strada che, pur qualificandosi come
“antimafia”, di antimafia concreta ha ben poco. Cerchiamo di spiegare... Libera,
con la struttura che si è data, vive grazie ai contributi pubblici e privati.
Tra i suoi sponsor troviamo, ad esempio, l'Unieco, colosso cooperativo emiliano,
che si vanta dei finanziamenti che da a Libera. Ma l'Unieco nei propri cantieri
fa lavorare società di famiglie notoriamente mafiose, per l'esattezza di
'ndranghetisti. I soldi risparmiati dalla Unieco in quei cantieri, con le famose
offerte “economicamente vantaggiose”, ad esempio, di società di famiglie
espressione delle cosche MORABITO-PALAMARA-BRUZZANITI e PIROMALLI con i
GULLACE-RASO-ALBANESE, restano nelle casse di Unieco che poi finanzia Libera per
la lotta alla mafia. E' chiaro il controsenso? La contraddizione è palese.
Libera dovrebbe rifiutare quei fondi ed esigere da Unieco, così come dalle
grandi cooperative della Lega Coop, che non abbia alcun tipo di contiguità e
connivenze con società indecenti! Non lo fa, prende i soldi e fa iniziative al
fianco di Unieco e compagnia nel nome dell'antimafia. Ma vi rendete conto di che
impatto fortissimo avrebbe invece una scelta da parte di Libera di rispedire al
mittente quei contributi con la motivazione: prima fate pulizia tra i vostri
fornitori e poi ci potrete finanziare? Sarebbe un segnale concreto
importantissimo! Non è questione di illeciti, ma di opportunità... di decenza.»
Può essere un caso, non si può
confondere il tutto con un caso.
«Prima
di tutto non è “un caso” ma un questione sistematica e non lo diciamo noi, ma
una serie di fatti. Per esempio, oltre alle grandi cooperative “rosse”, c'è il
caso di Unipol. Oggi sappiamo, grazie alle inchieste su Consorte e furbetti
delle “scalate”, di cosa è capace quel gruppo: azioni spregiudicate, sul crinale
tra lecito e illecito... così come sappiamo che, come le altre grandi banche, ha
una inclinazione nel non notare operazioni sospette che si consumano nelle
propri filiali. Ed anche qui Libera si presenta al fianco di Unipol nel nome
della Legalità, della lotta alla corruzione ed alle mafie. Anche qui: vi
immaginate se quando Unipol o la fondazione Unipolis mandano i contributi a
Libera, l'associazione di don Ciotti rimandasse indietro quei contributi con un
bel comunicato stampa in cui dice che finché le indecenze di Unipol non saranno
eliminare loro non vogliono un centesimo dei loro fondi? Sarebbe un segnale
chiaro, durissimo! E poi vi è il campo più prettamente “politico”. Andiamo anche
in questo caso con esempi concreti. A Casal di Principe il sindaco e l'assessore
con Libera distribuivano targhe anti-camorra, ma quell'amministrazione comunale
era legata alla Camorra, ai Casalesi. Cose che si sanno in quei territori. Il
sindaco e l'assessore sono stati poi arrestati perché collusi con i Casalesi...
Libera li portò sul palco della sua principale manifestazione, nel marzo 2009, a
Casal di Principe, per distribuire le targhe intitolate a don Peppe Diana. Ecco:
Antonio Corvino e Cipriano Cristiano avevano ottenuto il loro bel “paravento”.
Spostiamoci in Sicilia. Nel trapanese, la terra del latitante Matteo Messina
Denaro, è stato arrestato Ciro Caravà. L'accusa: associazione mafiosa. Si
presentava in tv e nelle piazze nel nome di Libera, ma era parte della rete
mafiosa che fa capo al latitante di Cosa Nostra. Libera ha dichiarato che non
era nemmeno tesserato... lo ha dichiarato dopo l'arresto. Prima, dell'arresto,
che costui andasse per mari e per monti a promuovere Libera e la sua azione
antimafia da Sindaco andava bene. Siamo già a due casi eclatanti, pesanti come
macigni, in cui Libera era un “paravento”. Non sono opinioni o interpretazioni,
sono fatti.»
Ma due casi su scala nazionale sono
un’eccezione, non la prassi..
«Drammaticamente
non sono solo due casi in tutta Italia. Questi erano due esempi. Vediamone
qualche altro...Polistena, giornata della Memoria e dell'Impegno di Libera. Sul
palco Libera fa salire, a scandire i nomi delle vittime di mafia, Maria Grazia
Laganà vedova Fortugno. In allora già indagata dalla DDA di Reggio Calabria, per
truffa aggravata allo Stato in merito alle forniture della ASL di Locri...
quella dove la signora era vice-direttore sanitario e responsabile del
personale, quella Asl in cui assunzioni, promozioni, incarichi e appalti erano
decisi dalle 'ndrine, a partire dal “casato” dei MORABITO-PALAMARA-BRUZZANITI...
cosca di cui alcuni esponenti erano in contatto telefonico sia con la Laganà,
sia con Fortugno... e non dimentichiamoci la grande amicizia tra gli stessi
Laganà e Fortugno con i MARCIANO', riconosciuti responsabili dell'omicidio del
Fortugno stesso. E' quella stessa Laganà che subito dopo l'omicidio del marito,
omicidio politico-mafioso, ha promosso una lista elettorale per le elezioni
provinciali con Domenico CREA, indicato da più parti come il grande beneficiario
dell'omicidio Fortugno, nella sua veste di “signore della Sanità” in comunella
con la 'ndrangheta. Poi si scoprì anche che il segretario della Laganà, dal
telefono della signora, comunicava al sindaco di Gioia Tauro, l'avanzamento in
tempo reale del lavoro della Commissione di Accesso che ha portato allo
scioglimento di quell'amministrazione perché piegata ai desiderata dei
PIROMALLI. La Laganà infatti era membro della Commissione Parlamentare Antimafia
e quindi con accesso a informazioni riservate, secretate. Che segnale è, in
Calabria, nella Piana di Gioia Tauro, far salire un soggetto del genere sul
palco della cosiddetta “antimafia”? Chiaramente devastante. Ma andiamo avanti. A
Bari chi è stato il grande protagonista della giornata della Memoria e
dell'Impegno di Libera? Massimo D'Alema. Quel D'Alema i cui rapporti indecenti
sono ormai noti, a partire da quelli, con gli uomini della sanità pugliese e
quella vecchia tangente, andata in prescrizione, da uno degli uomini della
sanità legati alla Sacra Corona Unita. A Napoli vi era Bassolino, che sappiamo
cosa abbia rappresentato in materia di gestione dei rifiuti a Napoli e Campania.
A Torino c'era Chiamparino che nuovamente è espressione di quella componente
spregiudicata nella ricerca e costruzione di consenso, e tra i principali
supporter della TAV, un'opera inutile, antieconomica, devastante per ambiente e
salute e manna per le cosche che vogliono, come già avvenuto per altre tratte di
quest'opera, entrarci con i subappalti. Quest'anno è toccato a Genova... Don
Ciotti qui si schiera al fianco di Burlando e della Vincenzi, ad esempio. Li
ringrazia. Li presenta come esempio di lotta alla mafia... peccato che con le
amministrazioni guidate da Burlando e dalla Vincenzi, le mafie abbiano fatto (e
continuano a fare, anche nonostante misure interdittive) ottimi affari a Genova
ed in Liguria, proprio a partire da quelli con le società pubbliche aventi soci
la Regione ed il Comune, o con le grandi cooperative “rosse”. E' più chiara ora
la questione? Più che di “giornata della memoria e dell'impegno”, quella a
Genova, dello scorso marzo, è stata l'ennesima giornata della memoria corta e
dell'ipocrisia! Non ci pare chiedere tanto quando si dice che gli ipocriti della
politica, delle Istituzioni, e gli “indecenti”, non vengano fatti salire su quei
palchi. Ci sembrerebbe una normalità, un atto di rispetto per le vittime.»
Ma Libera non è una struttura
indipendente?
«No!
Purtroppo no. Quello che abbiamo detto lo dimostra e se servono ulteriori esempi
che Libera si sia piegata a “paravento” di chi la sovvenziona e di chi
politicamente le è “caro”, li porto senza esitazione e senza pericolo di
smentita alcuna. Ed attenzione: è pienamente legittimo quanto fa Libera. Non
vorrei che si pensasse l'opposto. Assolutamente no! E' legittimo che Libera si
faccia “braccio” di un blocco di potere politico-economico, ma sarebbe
intellettualmente corretto ed onesto che lo dichiarasse, senza negarlo e senza
dichiararsi “indipendente”. Parliamo del Piemonte? A Torino Libera ha una forte
vicinanza a SEL e già questo basterebbe a chiarire lo strano concetto che Libera
ha di “indipendente”. Michele Cutro, persona degnissima, era dal 2007 il
referente dell'area europea di Libera; si candida a Torino alle Primarie di
centro sinistra e poi per il Consiglio Comunale con SEL, in appoggio a Fassino.
Viene eletto ed entra in Comune. SEL è nella maggioranza di centrosinistra,
quella stessa maggioranza determinatasi grazie anche ai consensi raccolti tra
gli 'ndranghetisti, come ha messo in evidenza l'inchiesta MINOTAURO. Come può
quindi Libera, un esponente di primo piano di Libera, avere una vicinanza
marcata con un partito quando questi è parte integrante di quella maggioranza in
cui vi sono metodi spregiudicati e indecenti di raccolta del consenso? E se poi
vogliamo vi è tutto il capitolo TAV, con la posizione di Libera che fa da
stampella al blocco di potere politico-economico che persegue questa opera!
Scendiamo nell'alessandrino? Qui vi sono pesantissimi interessi ed affari di una
delle più potenti cosche della 'ndrangheta, quella dei GULLACE-RASO-ALBANESE. Il
“locale” della 'ndrangheta guidato da Bruno Francesco PRONESTI' contava tra i
propri affiliati anche il Presidente della Commissione Urbanistica del Comune di
Alessandria. A Novi Ligure è consigliere comunale un giovane della famiglia
SOFIO, coinvolta in più inchieste legate ai MAMONE, ed operativa proprio
nell'alessandrino. Lì vi è uno degli snodi dei traffici e conferimenti illeciti
di sostanze tossiche che coinvolge Piemonte, Liguria e Lombardia. Vi era un bene
confiscato a Cosa Nostra, a Bosco Marengo. Cosa ha proposto Libera come progetto
di riutilizzo a fini sociali per farselo assegnare? Un allevamento di quaglie!
Sì: allevamento di quaglie! Ma davvero non si poteva fare altro di più incisivo
per una bonifica più ampia di quei territori, in quel bene confiscato? Noi
crediamo di sì. Ma non basta. Dopo la presentazione in pompa magna
dell'assegnazione a Libera di questo bene che cosa è successo? Che non si è
proceduto a sistemare quel casolare e così oggi, dopo gli articoli su come sono
brave le Istituzioni e Libera di alcuni anni fa, quel casolare deve essere
demolito perché impossibile, economicamente impossibile, ristrutturarlo! Un
fallimento devastante! Ma non basta ancora. Libera prima delle ultime elezioni
amministrative, cosa fa ad Alessandria, nella sua visione “ecumenica”? Va dal
anche dal Sindaco in carica, quello che aveva, con la sua maggioranza, messo il
CARIDI, l'affiliato alla 'ndrangheta, alla Presidenza della Commissione
Urbanistica, da quel Sindaco che ha contribuito in modo determinante al dissesto
del Bilancio di Alessandria, e gli propone di firmare il documentino contro le
mafie! Ecco, anziché indicarlo come pessimo esempio di gestione della cosa
pubblica e di “sponsor” del CARIDI, loro gli porgono la mano per dichiararsi,
con una firmetta antimafioso! Parliamo dell'Emilia-Romagna? Avete mai sentito
Libera indicare gli affari sporchi di riciclaggio e speculazione edilizia, di
smaltimenti illeciti di rifiuti o altro che non siano quelli più “visibilmente
sporchi”, come droga e prostituzione? No. Anche qui mai un nome o cognome... mai
una denuncia sull'atteggiamento dei colossi cooperativi emiliani come la Cmc, la
Ccc, Coopsette o Unieco che più volte hanno accettato la convivenza con le
società delle cosche. Mai una parola sui grandi colossi privati, come la
PIZZAROTTI, la gestione dell'Aeroporto di Bologna, le grandi colate di cemento
lungo la via Emilia o gli appalti per le infrastrutture dove non mancano gli
incendi dolosi ai mezzi di cantiere che non rispondono alle cosche. Solo qualche
parola, ma non troppe sui Casalesi a Parma, dove governava il centrodestra.
Reggio Emilia è una piccola Beirut, per anni, come il resto dell'Emilia-Romagna,
presentata come indenne dalla presenza mafiosa, quando invece la
“colonizzazione” si è consumata dopo che politica e settori imprenditoriali
hanno aperto le porte alle mafie per riceverne i servizi a “basso costo” e per
avere strada spianata alle cooperative nella partita TAV in Campania o, ancor
prima, a Bagheria e nel grande ed oscuro patto con i Cavalieri dell'Apocalisse
di Catania. A Firenze, Libera era legatissima all'amministrazione di Leonardo
Domenici, quella finita nell'occhio del ciclone per gli episodi di corruzione
nelle operazioni speculative di Salvatore Ligresti... quella del voto di scambio
alle elezioni primarie con cui il Cioni cercava di assicurarsi il consenso. E
mentre a Milano Libera accusava l'amministrazione di centrodestra che era in un
perfetto connubio con Ligresti, a Firenze tace. Anzi, va oltre: la firma “Libera
contro le mafie” siglava un volantino a sostegno del progetto devastante di
tramvia dell'Impregilo nel centro fiorentino! Non un volantino contro lo scempio
devastante della tramvia, così come nemmeno mai una parola contro il tunnel che
dovrebbe sventrare Firenze per la TAV, così come nulla di nulla sulla
devastazione del Mugello. Ecco Libera che tanto sostegno ha ricevuto da
quell'amministrazione fiorentina, passo dopo passo, ha sempre ricambiato.
Bastano come esempi o bisogna andare avanti con questa lista della
non-indipendenza di Libera? Ripetiamo: basterebbe che dichiarassero di essere
“di parte”, cosa legittima... e non dichiararsi per ciò che non sono:
indipendenti...Ancora: in Calabria, per citare un caso e non annoiare, basta
ricordare che il referente di Libera è andato ad un'iniziativa di presentazione
della “Casa dello Stocco” promossa da Francesco D'AGOSTINO, già Consigliere
provinciale dei “Riformisti”... Nella Piana sanno chi è questo imprenditore,
Libera non lo sa? Impossibile. Lo si conosce anche in Liguria. Ad esempio il
marchio “Stocco & Stocco” era in uso al boss Fortunato BARILARO, esponente
apicale del “locale” della 'ndrangheta di Ventimiglia. Perché ci è andato? Non
era meglio disertare tale “evento”? A Genova, in occasione delle ultime elezioni
amministrative, buona parte di Libera locale si è visibilmente schierata,
apertamente, a sostegno di Marco Doria, il candidato del centrosinistra. Scelta
legittima, ma... Un giornalista free-lance ha posto una domanda a Marco Doria: “Può
nominare qualche famiglia dell’ndrangheta che ha interessi a Genova?” e Doria ha
risposto: “No, perché non ho studiato il problema. Se lo sapessi lo
direi.”. Ecco: come possono gli esponenti locali di Libera sostenere un
candidato che non ha studiato il problema, in una città dove da anni ed anni,
ormai, i nomi e cognomi, le imprese ed i fatti sono pubblici, ampiamente noti?
Se mi si dice che lo si sosteneva perché “politicamente” è della loro parte, va
bene, ma lo si dica! Se mi si dice che invece no, perché sono indipendenti, e lo
sostenevano perché con lui si può combattere le mafie, allora non ci siamo, non
c'è onestà intellettuale... e non solo per l'intervista. Raccontiamo due fatti,
abbastanza significativi, crediamo. Tra gli assessori scelti da Doria, per la
delega ai Lavori Pubblici, c'è Gianni Crivello. Questi era il presidente del
Municipio Valpolcevera, lo è stato per dieci anni. Quel territorio è quello
maggiormente e storicamente, più colonizzato dalle mafie, Cosa Nostra e
'Ndrangheta. Lì la presenza delle mafie è palpabile. Bene, Crivello per anni ha
cercato, ed ancora cerca, di “minimizzare” la questione. Eppure sappiamo che
negare e minimizzare sono due linee pericolosissime, devastanti negli effetti
che producono. L'altro fatto che vi racconto è questo: tra gli sponsor di Doria
vi è l'architetto Giontoni, responsabile dell'Abit-Coop Liguria, il colosso
locale, nel settore edile, della Lega Coop Liguria. A parte il fatto che per una
cessione alla Cooperativa “Primo Maggio” dell'Abit-Coop l'ex rimessa di
Boccadasse dell'azienda per il trasporto pubblico locale (finalizzata alla
realizzazione di appartamenti di lusso), l'ex sindaco Pericu ed altri sui uomini
sono stati condannati pesantemente dalla Corte dei Conti per i danni alle casse
pubbliche, l'Abit-Coop vede nel suo Consiglio di Amministrazione tal Raffa
Fortunato. Questi per conto di Abit-Coop è stato nominato nei Cda delle aziende
del gruppo Mario Valle... Raffa Fortunato è il cugino dei FOTIA, la famiglia
della 'ndrangheta, riferimento nel savonese della cosca dei
MORABITO-PALAMARA-BRUZZANITI. Non solo: in diversi cantieri dell'Abit-Coop sono
stati incaricati di operare i FOTIA con la loro SCAVOTER (ora interdetta e per
cui la DIA ha chiesto la confisca) ed i PELLEGRINO di Bordighera con la loro
omonima impresa (sotto sequestro di nuovo per iniziativa della DIA). Doria è
stato informato di questo. Risposte giunte? Nessuna!»
Ma da Genova non poteva “scattare”
l'occasione delle svolta, dove Libera riaffermava la sua indipendenza...
«A
Genova c'è stato e c'è il suggello della dipendenza piena di Libera al blocco
politico-economico “rosso” ed asservita, in cambio di fondi e visibilità, agli
amministratori peggiori che si possano trovare in circolazione. Altro che
svolta... qui c'è stata e si conferma l'apoteosi dell'ipocrisia. Andiamo con
ordine con 5 esempi di fatti:
1) Libera è nata in Liguria
fondata da Legacoop, Unipol, Arci e qualche altro cespuglio. Tutto il fronte
anti-cemento, impegnato da anni contro le attività di riciclaggio delle mafie
nella grandi operazioni di speculazione edilizia, a partire dai porticcioli, e
contro i condizionamenti delle Pubbliche Amministrazioni e degli appalti, è
stato messo alla porta già ai tempi della fondazione di Libera in Liguria. Noi
ed altri. Abbiamo le carte, le abbiamo pubblicate. In una di queste dicono che
bisogna stare attenti a noi che abbiamo un gruppo a Ceriale... e sì quel gruppo
con cui siamo riusciti a far crollare l'impero del costruttore Andrea NUCERA che
dopo un'interdizione antimafia per una sua impresa ed il sequestro che avevamo
sollecitato del mega cantiere di Ceriale, è finito in bancarotta ed è latitante.
Bella colpa vero?
2) Libera organizzò una
fiaccolata antimafia a Sanremo. Chi invitò ad aderire? Quei partiti che hanno
tenuto bel saldamente al proprio interno (difendendoli) i vari esponenti con
pesanti contiguità e complicità con le cosche. C'era l'Udc di Monteleone, il Pdl
degli Scajola, Praticò, Minasso e Saso... il Pd dei Drocchi, Burlando, Vincenzi,
Bertaina... Rc degli Zunino... l'Idv della Damonte, Cosma e compagnia, SEL
dell'assessore al patrimonio di Genova che dava la casa popolare al boss di Cosa
Nostra... ma su questo torniamo dopo. In prima fila, a quella fiaccolata,
c'erano i sindaci “antimafia” di Ventimiglia, Gaetano SCULLINO, e quello di
Bordighera, Giovanni BOSIO. Quest'ultimo lo hanno anche fatto parlare come
testimonianza di impegno per la legalità. Il fatto che le Amministrazioni di
BOSIO e SCULLINO fossero piegate dai condizionamenti della 'ndrangheta era un
dettaglio che è sfuggito a Libera. Ah naturalmente non ci mandarono nemmeno
l'invito... forse sapevano che lo avremmo rimandato al mittente.
3) Libera a Genova ha visto
mettersi a disposizione della Giunta comunale della VINCENZI, dopo l'arresto del
suo braccio destro e portavoce Stefano FRANCESCA, nientemeno che il Presidente
Onorario di Libera, Nando Dalla Chiesa. Quello che a Milano denuncia i silenzi,
le contiguità e connivenze mafiose del centrodestra ma che a Genova ha perso la
vista e non vede quelle pesantissime delle amministrazioni di centrosinistra...
della VINCENZI, di BURLANDO come di REPETTO e di molteplici Comuni della
Provincia e delle riviere. Lui è consulente e si occupa di organizzare dei bei
convegni e delle rassegne antimafia, con manifesti colorati e tanti bei
volantini patinati, ma non si accorge del boss ospitato in albergo dal Comune,
degli incarichi con ribassi da brivido assegnati a soggetti attenzionati o
addirittura interdetti, delle somme urgenze, appalti vari e agevolazioni date ai
MAMONE nonostante l'interdizione atipica antimafia... non parliamo delle
varianti urbanistiche promosse dalla Vincenzi (come sul caso Lido, che poi
abbiamo contribuito a bloccare) o i rapporti con le imprese del gruppo
imprenditoriale dei FOGLIANI di Taurianova... ivi compresa la concessione, poi
annullata dal TAR per una clinica privata ad Albaro. Queste cose a Genova Nando
non le nota... pare che soffra di una grave patologia di “strabismo”, così, da
un lato, da il “patentino” antimafia alle amministrazioni, come quella di cui è
consulente (prima pagato e dopo la nostra denuncia pubblica, gratuitamente,
senza più le decine di migliaia di euro annui), promuovendo tante belle
iniziative e dall'altro tace e “copre” le indecenze.
4) Vi è poi la pantomima con
6... dico SEI... inaugurazioni dei beni confiscati di Vico della Mele. So che la
questione è stata anche oggetto di discussione durante la visita della
Commissione Parlamentare Antimafia a Genova lo scorso anno. Ad ogni occasione
elettorale il Comune di Genova, lo stesso che ospitava in albergo il boss a cui
sono stati confiscati e che noi siamo riusciti, con una serie di iniziative
pubbliche, a far sì che si sgomberasse, con Dalla Chiesa, faceva una bella
inaugurazione... poi il bene tornava ad essere chiuso. Un segnale devastante
dopo l'altro, in un territorio dove il controllo del territorio, come si è
dimostrato con le nuove inchieste e procedimenti a carico dei CACI, CANFAROTTA e
ZAPPONE, era saldamente in mano alla mafia. Qui il Comune, sotto la regia di
Dalla Chiesa (lo ha scritto direttamente lui in una lettera di insulti a noi ed
agli abitanti della Maddalena che avevano collaborato con noi alle indagini che
hanno portato alla confisca di 5 milioni di beni ai CANFAROTTA), ha elaborato un
bando in cui il vincitore era già scritto. Se dici che il bene lo dai a chi
vende i prodotti di Libera Terra secondo voi chi può vincerlo? E poi perché una
bottega in un posto del genere dove invece occorre attività che si dirami e
bonifichi i vicoli tutti intorno? Un’attività di quel tipo non è socialmente
utile lì... Avevamo proposto, insieme ad altri, un progetto di rete, in cui
poteva starci anche Libera, ma senza “monopolio”, e che le attività fossero
scelte insieme agli abitanti perché solo così si può coinvolgere la comunità e
rendere evidente una risposta collettiva alle cosche, facendo riprendere alla
comunità stessa quei beni. Ed invece no... lo hanno dato alla rete di Libera.»
Sì, ma promuovere i prodotti delle
terre confiscate non è importante?
«Premettiamo
una cosa: molti dei ragazzi che vi operano ci mettono l'anima, così come molti
di coloro che credono che Libera sia una struttura che fa antimafia. Ma la
realtà dei fatti è diversa. Il quadro che ci viene presentato è utile a Libera,
che ha di fatto il monopolio della gestione dei beni confiscati riassegnati, ed
alle Istituzioni che così si fanno belle sventolando questo dichiarato
“utilizzo” dei beni confiscati. Ma questo quadro è un falso! Prima di tutto
perché i beni confiscati che vengono riassegnati sono pochissimi. Sono briciole.
Abbiamo pubblicato anche uno studio su questo, sulla normativa e sulla realtà.
Uno studio mai smentito! Secondo perché ad un sistema clientelare, nelle regioni
meridionali, si promuove un nuovo clientelismo nel nome dell'antimafia. Mi
spiego: senza i contributi pubblici quelle cooperative che lavorano sui terreni
confiscati non durerebbero un anno! La gestione di quelle cooperative è poi
piegata dal clientelismo. Prendiamo le cooperative siciliane. Le principali sono
coordinate da Gianluca Faraone, mentre suo fratello fa politica nel PD. E' quel
Davide Faraone “scoperto” da Striscia la Notizia cercare di ottenere voti alle
primarie di Palermo promettendo posti di lavoro nelle cooperative come
contropartita. Questo avrebbe dovuto far sobbalzare sulla sedia chiunque… Invece
silenzio... Come silenzio sulla recente convocazione da parte di una Procura
siciliana di don Luigi Ciotti perché in una delle cooperative di Libera Terra è
stato individuato un soggetto legato a Cosa Nostra. La questione è quindi:
perché Libera deve avere il “monopolio” del riutilizzo dei beni confiscati? Dove
sta scritto? E poi non ci si rende conto che questa situazione non aiuta a
ridare credibilità e fiducia nelle istituzioni, nella concorrenza? Inoltre, è
evidente che se una struttura gestisce, da sola, una quantità immane di beni
confiscati, qualche falla poi si crea. Ed allora perché non perseguire il lavoro
di “rete”, con più soggetti, che concorrono nella gestione dei beni confiscati?
L'idea di azione di “rete” era proprio la base della prima ed originaria Libera.
Poi vi è un'altra questione. Molte realtà locali di pubbliche amministrazioni
usano le assegnazioni dei beni confiscati per farsi una nuova “facciata” e
conquistarsi “credibilità”. In questi casi bisognerebbe valutare prima di
accettare un bene assegnato. Bisognerebbe considerare se quell'amministrazione è
davvero lineare, limpida oppure se ha ombre. Nel primo caso si collabora, nel
secondo si declina. Noi l'abbiamo fatto a Terrasini. Ci si voleva usare come
“paravento”, abbiamo chiesto all'allora Sindaco: o di qua o di là. Lui ha scelto
l'amico che faceva da codazzo al boss Girolamo D'Anna e noi, quindi, abbiamo
rinunciato all'assegnazione del bene confiscato. Non ci pare difficile o
complesso.»
Ma anche qui si tratta di un caso, o
comunque di casi isolati... le cooperative funzionano o no?
«Quelli
che si sono citati sono alcuni esempi. I casi preoccupanti sono molteplici e,
purtroppo, in aumento. Parte del grano veniva (non so se avvenga ancora)
macinato in un mulino dei Riina? Ci è stato raccontato così da chi per anni ha
lavorato alla Commissione Parlamentare Antimafia e vive a Palermo. Non è mai
stato smentito. Oppure c'è la storia di un agriturismo dove, per il centro di
ippoterapia, i cavalli e gli stallieri erano presi dal maneggio della famiglia
mafiosa ben nota in quei territori? Li ha ripresi anche Telejato! Anche sul
fatto del funzionamento delle cooperative poi vi è molto da dire. Già ricordavo
che senza sovvenzioni pubbliche crollerebbero ed altro che riscatto per i
giovani di quelle terre. Sarebbe una mazzata... Ma si può vivere di
assistenzialismo eterno, promuovendo progetti che nel momento in cui dovessero
mancare i fondi pubblici, crollerebbero inesorabilmente? Noi crediamo di no! Lo
spirito della legge Rognoni-La Torre non era quello di sostituire al
clientelismo democristiano e mafioso una sorta di clientelismo dell'antimafia!
Ma entriamo più nello specifico delle cooperative. Pare che nessuno sappia, in
questo Paese, fare due conti. Oppure li sanno fare ma ne tacciono i risultati.
Prendete la pasta prodotta ed impacchettata nelle bustine della pasta biologica
“Libera Terra”. Fate il conto di quanto grano sia necessario per produrre tale
quantità di pasta, non più per i numeri originari di una cerchia ristretta di
vendita ma sulla grande distribuzione. Scoprirete che buona parte del grano
usato per produrre quella pasta non viene affatto dalla coltivazione dei terreni
confiscati in concessione a Libera Terra. In quei terreni possono sorgere minime
percentuali del grano necessario. E' un dato oggettivo, lampante... sotto gli
occhi di tutti. Di “Libera Terra” ci sono quindi, nella grande maggioranza dei
casi, in quei pacchi di pasta, solo le confezioni. Il grano viene comprato da
terzi, non nasce dalla terra confiscata! Ci è stato riferito che addirittura nei
primi anni 2000 giungevano comunicazioni alla Commissione Parlamentare
Antimafia, in cui si evidenziava che parte del grano usato per produrre quella
pasta veniva comprato in Ucraina! Sul vino o sui pomodori il discorso è lo
stesso... In quei pochi ettari di terra confiscata assegnati alle cooperative di
Libera Terra non si può materialmente produrre la quantità di prodotti necessari
per il mercato. Anche qui di Libera c'è solo la confezione. Tutto si regge su
un’illusione che pare nessuno voglia indicare e questo è grave! In ultimo, ma
fondamentale, vi è un elemento che nessuno pare voglia vedere ma che, di nuovo,
è preoccupante. E' il monopolio! Di fatto la gestione delle terre confiscate
avviene in un regime di monopolio da parte delle cooperative di Libera. Ogni
possibilità di concorrenza è cancellata. Questo, nuovamente, è nello spirito
della Legge Rognoni-La Torre? Non ci pare. Così come non era nello spirito di
quel milione di firme che la “prima” Libera ha raccolto per fa sì che quella
norma per l'utilizzo sociale dei beni confiscati fosse approvata. Ed attenzione
questo stato di monopolio impedisce, o quanto meno impedirebbe, che, ad esempio,
in bandi pubblici si possa indicare come criterio l'utilizzo dei prodotti nati
dalle terre confiscate. Ci sono pronunce di sentenze che annullano bandi per
questa ragione. Perché non si vuole cambiare strada? Perché anziché
“monopolizzare” non si promuove una libera concorrenza che sarebbe a vantaggio
non solo della “forma” ma anche della sostanza, nel senso che si spingerebbe a
costruire realtà che vivono davvero sulle proprie gambe, e non quindi nicchie
clientelari.»
Ma perché tanta acredine verso Libera?
Degli errori si possono fare. Avete provato a parlare con don Ciotti?
«Non
c'è acredine, come abbiamo già detto se si indicano i problemi, i fatti che
testimoniano i problemi, è perché si vuole contribuire a risolverli! Premettiamo
che siamo convinti che chi è in buona fede, ed in Libera in tanti sono in buona
fede, colga che il nostro non è un “attacco” o una “guerra”, come alcuni cercano
di far passare per eludere i problemi che poniamo. Chi è in buona fede sa che
non diciamo falsità e non compiamo forzature, ma ci limitiamo ad indicare
questioni, fatti, che è interesse di tutti, ed in primis di Libera, affrontare e
risolvere. Nella vita sociale, di una comunità, così come nella vita privata di
ciascuno, se si vive sulle illusioni, nei sogni, vedendo l'irreale come reale
perché ci fa stare meglio, facciamo danni. Aggiungiamo danni a quelli che già ci
sono. E' come il medico pietoso o che “sbaglia” diagnosi perché è “ottimista” e
perché non vuole guardare al peggio e tantomeno vuol dirlo al paziente. Darà una
terapia sbagliata o comunque inefficace ed il paziente si aggrava e muore. Non è
acredine. E' essere onesti e dire le cose come stanno. A noi farebbe molto
meglio accodarci a Libera, entrare nella sua “rete” che tutto può avere, ma per
farlo dovremmo rinunciare all'indipendenza ed al rigore di guardare sempre e
comunque a 360 gradi, senza mai tacere le cose che devono essere dette e
denunciate. E' indiscutibile poi che gli errori li si può commettere tutti. Ci
mancherebbe... ma qui non sono errori se li si nega, se si esula
dall'affrontarli e risolverli. Qui si è davanti ad una scelta precisa che
conduce agli errori e che vive di “errori”... e don Luigi Ciotti non è solo
consapevole di tutto questo, ma è il principale fulcro di questo sistema che
rappresenta la degenerazione della Libera originaria. Anche perché, se lui
volesse, queste questioni le si sarebbe già risolte! Gli errori si ammettono e
si correggono. Quando si nega, quando si decide di querelare chi indica le cose
che non funzionano, quando si prosegue lungo la strada sbagliata, che è evidente
ad un bambino, quando è conclamato dai fatti che si è persa la direzione
corretta, significa che siamo davanti ad una scelta consapevole, voluta e
perseguita. Questo è l'aspetto che genera rabbia e che impone di non tacere! Noi
abbiamo posto alcuni problemi, abbiamo indicato alcuni fatti, reali, tangibili,
riscontrabili da chiunque li voglia vedere. Per risposta abbiamo avuto due
comunicati ufficiali di Libera, uno della Presidenza ed uno di Nando Dalla
Chiesa, in cui non si rispondeva ad una virgola di quanto da noi sollevato, ma
si dichiarava che ci avrebbero querelati! Siamo noi o loro che hanno acredine,
odio e che rifiutano il confronto sui fatti? Noi viviamo una sorta di “guerra
fredda” mossaci da Libera. Noi, come gli altri che non hanno accettato di
accodarsi al loro monopolio dell'antimafia. Serve una svolta per ritrovare
l'unità del movimento antimafia, ammesso che questa ci sia mai stata
effettivamente, al di là della facciata.»
Il vertice di Libera quindi le sa
queste cose? Ad esempio quelle sulla Liguria...
«Sì,
le sanno. Le sanno da sempre e fanno finta di nulla. Anzi più le sanno, perché i
fatti emergono inequivocabili, più isolano noi, ad esempio, che abbiamo
contribuito a farli emergere, dando avvio alle azioni giudiziarie, e più fanno
da “paravento”. E per coprire quanto accaduto, mistificano la realtà, arrivano a
mentire. Dalla Chiesa, ad esempio, disse che assolutamente non stava operando
sui beni confiscati di Vico Mele, per poi smentirsi da solo! Incontrò noi e gli
abitanti della Maddalena dove gli dicemmo, ad esempio, dell'albergo a CACI...
poi un anno dopo fece quello che cadeva dal pero. Davide Mattiello, altro
esempio. Lo incontrai a Torino, in un bar davanti alla stazione di Porta Susa.
Gli dissi tutto su quelli che volevano fondare Libera in Liguria, gli “amici”
del fronte del cemento. Gli mostrai le carte dell'inchiesta della Guardia di
Finanza dove emergevano i rapporti illeciti e quelli inopportuni ed indecenti
tra Gino MAMONE e gli esponenti politici del centrosinistra genovese, dalla
Vincenzi a Burlando, a partire dalla partita viziata da corruzione per la
variante urbanistica dell'area dell'ex Oleificio Gaslini. Mi disse che avrebbe
provveduto... Sapete chi è stato il “garante” della costruzione di Libera in
Liguria, per allestire il grande “paravento”? Proprio Davide Mattiello... Quando
in diversi gli chiesero se avesse letto il libro-inchiesta “Il Partito del
Cemento” dove vi erano nomi, cognomi e connessioni di quelli che stavano
promuovendo Libera in Liguria, la sua risposta è sempre stata: no, non l'ho
letto e non intendo leggerlo! Non è questione di “noi” e “loro”. Se Libera non
funziona è un problema per tutti! Noi per anni, quando Libera non era ancora
questo, abbiamo chiesto e spinto perché si fondasse Libera in Liguria. Era
salito due volte a Genova per le riunioni da noi richieste anche Alfio Foti, che
in allora per il nazionale di Libera si occupava di queste cose. Inizialmente
l'Arci sosteneva che non vi era “necessità” di costruire Libera in Liguria. Poi,
con la seconda riunione, fecero naufragare tutto. Noi eravamo affiliati a
Libera. In Liguria eravamo solo noi ed il CSI, il Centro Sportivo Italiano. Per
anni è stato così... Ma l'Arci continuava a gestire il “marchio” Libera, con la
Carovana, escludendo sia noi sia il CSI. A noi rimproveravano di aver indicato i
rapporti tra i MAMONE con Burlando e l'amministrazione Pericu del Comune di
Genova. Ma erano fatti quelli che noi indicavamo che oggi sono confermati da
risultanze molteplici di inchieste, da un’interdizione atipica per i MAMONE e da
una condanna proprio di Gino MAMONE e di un ex consigliere comunale della
Margherita, STRIANO, per corruzione in merito ad una variante urbanistica di
un’area dei MAMONE.»
Ma perché secondo voi è così pericolosa
la strada imboccata da Libera?
«La
questione è semplice e parte dalla solita questione italica: illusione o
concretezza. Il sogno non come speranza che si cerca di perseguire con atti
quotidiani concreti, ma il sogno in cui ci si racchiude per stare meglio con se
stessi. L'illusione è la cosa che i preti sanno vendere meglio, lo fanno da
millenni, ed in mezzo a infinite contraddizioni o misteri riescono sempre a
conquistarsi “anime” per atti di fede. Don Ciotti è un prete e questo fa. Ora ad
esempio parla di “scomunica” ai mafiosi... bene, ma perché, realtà per realtà,
né lui, né gli altri responsabili di Libera, non osano mai pronunciare un nome e
cognome! Se si vuole scomunicare qualcuno questo qualcuno è in carne ed ossa, ha
un volto, ha un nome... La mafia non è un ectoplasma. Poi sappiamo tutti che la
lotta alla mafia è fatta anche di segnali. Se i segnali sono equivoci è un
problema. Facciamo un altro esempio concreto. “Avviso Pubblico” è una struttura
nata da Libera che raccoglie gli Enti Locali e le Regioni. Una struttura in cui
i Comuni, le Province e le Regioni possono aderire, previo versamento di una
quota annuale. Ma non c'è verifica, non ci sono discriminanti per l'adesione.
Prendiamo la Regione Liguria che recentemente ha aderito ad Avviso Pubblico. Qui
si ha un presidente della Regione, Burlando, che era amico dei MAMONE, che
frequentava e da cui ha preso sovvenzioni attraverso l'associazione Maestrale,
che aveva tra i propri supporter alle ultime elezioni liste che avevano uomini
legati alla 'ndrangheta tra le proprie fila. Abbiamo un presidente del Consiglio
Regionale che nel 2005 incassò i voti della 'ndrangheta, poi un pacchetto di
tessere sempre da questi per vincere il congresso, poi li ricercò ancora per le
elezioni del 2010, proponendo al capo locale di Genova, GANGEMI, una bella
spaghettata, e che, in ultimo, ha festeggiato la rielezione nel ristorante del
boss di Cosa Nostra Gianni CALVO. Abbiamo poi un consigliere regionale, Alessio
Saso, indagato per il patto politico-elettorale con la 'ndrangheta alle elezioni
del 2010. Davanti a questo panorama Avviso Pubblico, crediamo, avrebbe dovuto
dire: Cara Regione Liguria, prima ripulisci il tuo palazzo da questi soggetti e
poi la tua domanda di adesione sarà accolta. Invece no, accolta subito, con
questo bel quadretto. E così Libera che, per la manifestazione del marzo scorso,
incassa dalla Regione quarantamila euro di contributo e poi si presenta con don
Ciotti al fianco di Burlando e lo ringrazia per quello che fa nella lotta alla
mafia.»
In che senso “grande illusione”?
«Antonino
Caponnetto ha indicato la strada maestra della lotta alle mafie: rifiutare la
logica del favore, indicare i mafiosi perché questi temono più l'attenzione
dell'ergastolo! Paolo Borsellino ha spiegato, credo meglio di ogni altro, che la
lotta alla mafia è una questione civile e culturale, perché la sola azione
giudiziaria non è sufficiente per sconfiggere le mafie. E ci diceva che bisogna
mettere in un angolo i politici compromessi, anche per sole semplici
frequentazioni indegne, e pur se non esistono rilievi penali. Ci diceva che
occorre negare il consenso alle cosche perché gli si fa venir meno la capacità
di condizionamento. Giovanni Falcone invece ha reso evidente già allora che la
mafia non è coppola, lupara e omicidi, ma è affari. Ci ha spiegato che tutte le
attività più cruente e prettamente “criminali” (droga, estorsione,
prostituzione...) servono alle organizzazioni mafiose per avere quei capitali
illeciti da riciclare facendosi impresa, finanza, politica. Ci spiegava che è
lì, seguendo i soldi, che si può colpire l'interesse mafioso. Ed allora perché
Libera questo non lo fa? E perché cerca, in un reciproco scambio di favore con
la politica, di monopolizzare la lotta alla mafia a livello sociale come se ci
fossero solo loro? Libera ha il vantaggio di rafforzarsi e incassare, la
politica ha un ritorno perché usa Libera come paravento per coprire le proprie
indecenze. Ci si può dire: ma sono solo modi diversi di perseguire lo stesso
obiettivo, cioè sconfiggere le mafie. Non ci pare così... Le iniziative
“mediatiche”, il merchandising che diventa la principale attività, le illusioni
di combattere le mafie con spaghettate, cene o pranzi, il parlare di una mafia
ectoplasma e non della concreta e palpabile rete mafiosa, di contiguità,
connivenze e complicità, fatta di soggetti ben precisi, con nomi e cognomi, non
è lotta alla mafia... al massimo possiamo considerarla una “buona azione”, come
il fare l'elemosina davanti alla chiesa al povero cristo di turno... Non risolve
il problema, ci convive! Libera parla sempre dei morti... ci dice che bisogna
ricordare i morti, vittime della mafia. Giusto e come si fa a non condividere il
dovere della Memoria? Ma dei vivi? Dei vivi non si parla mai... le vittime vive
delle mafie sono ben più numerose delle già tante, troppo, vittime morte
ammazzate. Di queste Libera si dimentica... Non è un caso se fu proprio don
Luigi Ciotti a chiedere che venisse previsto anche per i mafiosi l'istituto
della “dissociazione”, cioè ti penti, ti dichiari dissociato ma non confessi
nulla, non racconti nulla di ciò che conosci dell'organizzazione. E' chiaro che
se mai fosse stata accolta questa proposta, di collaboratori di giustizia non ne
avremmo più. Se per avere gli stessi benefici basta dissociarsi, senza rompere
l'omertà e denunciare i sodali e i segreti dell'organizzazione, quale mafioso
rischierebbe la propria vita e quella dei suoi familiari per collaborare?
Nessuno e lo strumento essenziale dei Collaboratori svanirebbe.»
Ma l'azione di Libera arriva a molte
persone, alla massa. Le vostre iniziative se pur incisive nell'azione di
contrasto civile e, nel vostro caso, anche giudiziario, alle organizzazioni
mafiose, le conoscono in pochi.
«Questo
è un problema che non dipende da noi. Dipende da ciò che dicevamo prima: Libera
è utile alla politica ed alle imprese perché gli fa da “paravento”, nascondendo
le loro pratiche indecenti. E' ovvio che Libera in cambio ha qualcosa da questo:
visibilità mediatica, grandi riconoscimenti, finanziamenti e strumenti per
promuoversi. Noi diamo l'orticaria a 360 gradi con la nostra indipendenza. E
quindi la risposta è evidente: l'isolamento! E qui Libera gioca di nuovo un
ruolo servile verso il Potere, verso quel potere compromesso, si presenta come
unica realtà “credibile” ed oscura chi non è gradito e non accetta di piegarsi
alla loro stessa logica. Le operazioni mediatiche non servono a colpire le
mafie. Pensate alla grande campagna mediatica dell'ex Ministro Maroni. Ogni
giorno sfruttava gli arresti di mafiosi fatti da magistrati e forze dell'ordine
per dire che stavano sconfiggendo la mafia. Hanno costruito una campagna
mediatica per cui “l'arresto” sconfigge la mafia. Una falsità assoluta... tanto
è vero che le mafie sono ancora ben forti e radicate sul territorio, con sempre
maggiore capacità di condizionare il voto, e quindi le Amministrazioni
Pubbliche, anche al Nord. Ed allora: è servita questa campagna mediatica sulla
vulnerabilità dei mafiosi per scalfire il loro potere? No. Facciamo alcuni
esempi...Trovate un amministratore pubblico in Italia che abbia speso quanto ha
investito Totò Cuffaro in manifesti di ogni dimensione, tappezzando un'intera
regione, la Sicilia, con lo slogan “la mafia fa schifo”. Non esiste. Cuffaro ha
speso più di ogni altro politico italiano in un’azione mediatica su larga scala.
Noi però sappiamo chi era quel Cuffaro. Un fiancheggiatore degli interessi
mafiosi. Cosa ci dice questo? Semplice: le azioni mediatiche la mafia non le
teme, anzi le vanno pure bene, perché le permettono una più efficace azione di
mimetizzazione. Altro esempio. Francesco Campanella, uomo che agevolò la
latitanza di Provenzano. Questi ebbe un'idea e la propose a Provenzano che
l'accolse con grande entusiasmo. L'idea era semplice: promuovere direttamente
manifestazioni antimafia. Chiaro? Ed ancora: dove facevano le riunioni gli
'ndranghetisti di Lombardia per eleggere il loro “capo”? Nel “Centro Falcone e
Borsellino”! Si vuole o no capire che i mafiosi sono i primi che hanno
l'interesse di “mascherarsi” e presentarsi pubblicamente come attori
dell'antimafia? Devono farlo i sindaci e gli eletti che hanno stretto un patto
con la mafia, così come devono farlo gli affiliati che hanno un ruolo pubblico o
comunque una visibilità pubblica. Gli serve per insabbiarsi! La linea
“ecumenica” di Libera lascia troppe porte aperte a queste “maschere”... E'
pericoloso! E' un insulto alla buona fede dei tanti che in Libera lavorano
seriamente e che da questo vedono, in determinati territori, il proprio lavoro
screditato. Quelle porte devono essere sbarrate! Se una persona vive su un
territorio sa chi sono i mafiosi. E se alla manifestazione antimafia tu vedi che
tra i promotori ci sono i mafiosi, il segnale è devastante! Per semplificare: se
tu sai che il responsabile degli edili di un grande sindacato va a braccetto con
il capobastone che organizza, con la sua rete, il caporalato o le infiltrazioni
nei cantieri edili con le ditte di ponteggi e le forniture, e poi vedi questo
sindacalista che promuove le manifestazioni antimafia, magari con Libera...
magari dicendoti “venite da me a denunciare”, è evidente che nessuno mai si
rivolgerà a lui, al sindacato. Quale lavoratore in nero andrà mai a denunciare
da lui? Nessuno. Ecco fatto che senza intimidazione, senza alcun gesto eclatante
si sono garantiti la pax.»
Ma allora Libera...
«Libera
dovrebbe tornare ad essere Libera “di fatto” oltre che di nome. Oggi non lo è. E
questo è un danno per tutti. E' un problema per tutti. Noi vogliamo che Libera
torni quello che era all'origine. Anche qui un esempio molto tangibile. Il
presidente della Casa della Legalità è una persona a rischio, per le denunce che
abbiamo fatto e l'azione di informazione mirata a colpire la mafia che si è
fatta impresa, la rete di professionisti asserviti, la mafia nella politica. E',
come si dice in gergo, un “obiettivo sensibile”... e lo è perché in questi anni
soprattutto in Liguria, ma anche in altre realtà, come Casa della Legalità siamo
stati soli ad indicare nome per nome, i mafiosi, i professionisti e le imprese
della cosiddetta “zona grigia”, la rete di complicità e contiguità con la
politica, le forze dell'ordine e persino nella magistratura. Abbiamo ottenuto
risultati con lo scioglimento delle Amministrazioni nel Ponente Ligure, così
come con le verifiche in corso su altri Comuni. Abbiamo squarciato l'omertà e
spinto ad adottare provvedimenti quali interdizioni a “colossi” delle imprese
mafiose. Si è contributo a far emergere i patrimoni illeciti che sono stati
aggrediti con sequestri e confische... Con un lavoro difficile, senza soldi, a
volte neppure per un bicchiere d'acqua. Si è piano piano conquistata la fiducia
di persone che poteva parlare e li si è messi in contatto con i reparti
investigativi. In alcuni casi hanno verbalizzato, in altri non vi è stato
nemmeno bisogno che si esponessero in questo. Ecco questo le mafie non ce lo
perdonano, così come non ce lo perdonano i politici che nel rapporto con le
cosche avevano costruito un pezzo determinante del loro consenso elettorale. Se
non fossimo stati soli, ma Libera avesse fatto qualcosa, oggi non sarei
probabilmente identificato dalle cosche come “il problema” da eliminare. Ed
invece no, sapendo la realtà ligure, perché la si conosce e la conoscono anche
quelli di Libera, hanno scelto di lasciarci soli e di fare da paravento alla
politica ed a quelle imprese che la porta alle mafie, in questo territorio, la
spalancarono ed ancora la tengono ben aperta. Non vorremmo che si pensasse che
queste cose siano questioni “astratte” o ancor peggio “personali”. Ed allora è
meglio che, oltre a quanto ho già raccontato, vi faccia un altro esempio
concreto. Alcune mesi fa è finalmente emerso quanto dicevamo da anni: Burlando
sapeva che nella sua rete di consensi nel ponente ligure vi erano soggetti
legati alla 'ndrangheta, della 'ndrangheta. Denunciamo questo con tutti i
dettagli del caso. Quello che è emerso è che il “collettore” era l'ex sindaco di
Camporosso, Marco Bertaina. Questi con la sua lista civica alle provinciali di
Imperia ha candidato due 'ndranghetisti: MOIO e CASTELLANA. Burlando appoggiò
quella lista civica che a sua volta appoggiava Burlando quale candidato alla
Presidenza della Regione Liguria. E chi è BERTAINA? E' l'attuale vice-sindaco di
Camporosso, dopo due anni di mandato come sindaco e diversi come assessore negli
anni Novanta... ed è soprattutto quello che ha promosso un progetto di
“educazione alla legalità” proprio con Libera. Dopo le rivelazioni su questo
asse BERTAINA-MOIO-CASTELLANA-BURLANDO cosa fa Libera? Organizza un convegno con
il Comune di Camporosso dove porta direttamente Gian Carlo Caselli! E' chiaro
che il segnale, su quel territorio, a quella comunità, è devastante? Noi
crediamo di sì e Libera ne ha tutte le responsabilità!»
Non siete stati alla manifestazione
della “Giornata della Memoria e dell'Impegno” che vi è stata a Genova, quindi...
«No,
come Casa della Legalità non ci siamo andati. Ci è dispiaciuto di non poter
“abbracciare” i parenti delle vittime che hanno sfilato. Ci è dispiaciuto per
quelli che in buona fede ci credono... Ma noi non ci prestiamo a fare da
“paravento” in cambio di fondi, soldi o visibilità. La lotta alla mafia è una
cosa seria e le vittime dovrebbero essere rispettate e non usate. No, non ci
siamo andati alla “Giornata della Memoria corta e dell'ipocrisia”... Ma abbiamo
una speranza: che le persone che in buona fede credono in Libera la facciano
tornare Libera nei fatti. Se queste persone riusciranno a laicizzare e
decolonizzare Libera sarebbe importante per tutti. Non credo ci possano
riuscire... perché, come dicevo: un'illusione fa vivere meglio... la realtà è
più problematica ed in questa ci si deve assumere delle responsabilità concrete,
non a parole! Ma la speranza c'è, altrimenti queste cose non le direi, se fossi
convinto al 100% che nulla possa cambiare. Dico di più. Per noi della Casa della
Legalità, che convenienza c'è ad uno “scontro” con Libera? Nessuno. Loro sono,
si potrebbe dire, un “potere forte”, per la rete che hanno e che abbiamo cercato
di rendere evidente con i fatti enunciati. E se diciamo queste cose, se
indichiamo, ripeto, fatti e non opinioni, è perché vorremmo che chi è in buona
fede e crede in Libera, la faccia rinascere, eliminando quelle storture, tutte
quelle situazioni problematiche. Le critiche che poniamo sono reali, chiediamo
di riflettere su queste. Sappiamo già che qualcuno, quelli non in buona fede,
per intenderci, cercheranno di rispondere ignorando tutto quanto si è detto,
oppure scatenando una guerra aperta, non più sottotraccia alla Casa della
Legalità. Punteranno, in estrema sintesi, ad unire il proprio fronte contro il
“nemico” esterno... un'altra delle pratiche italiche che tanti danni hanno
fatto. Sappiamo di questo rischio, ma dobbiamo rischiare se vogliamo che quel
briciolo di speranza che dicevamo, possa avere una possibilità di concretizzarsi
in un cambiamento reale. Non siamo dei pazzi suicidi. Diciamo le cose come
stanno, guardando ai fatti, perché si rifletta e si affronti la realtà per
quello che è e quindi perché si possa agire per “correggerla”.»
Ma siete gli unici a dire queste cose?
«Assolutamente
no. Forse siamo gli unici che riescono in qualche modo a bucare la cappa di
omertà che vi è su questa vicenda di Libera. Come dicevamo prima siamo davanti
ad un “santuario”. Si parla tanto di “poteri forti”, ma questi non sono solo
mica quelli della “politica”, ci sono anche nel “sociale”, nella cosiddetta
società civile. E' difficile trovare chi è disposto a subire una reazione
spietata per il solo fatto di aver indicato dei fatti che sono ritenuti
“indicibili” anche se veri. Chi ha rotto con l'associazione di don Luigi Ciotti
perché non ha avuto timore di vedere la realtà e di dirla, sono in molti.
Partiamo da un giornalista scrittore calabrese, costretto, nell'isolamento, ad
una sorta di perenne esilio dalla sua terra, Francesco Saverio Alessio. Potete
poi chiedere a Umberto Santino, del Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe
Impastato, anche lui le cose le dice senza reticenze...Il problema è che nessuno
domanda a chi risponde senza ipocrisie, perché se si da voce a chi guarda e
parla della realtà, dei fatti, allora l'illusione in cui ci vorrebbero far
vivere ed operare, svanisce.»
Ma proprio nulla va in Libera, pare
impossibile...
«Sarebbe
ingiusto dire che tutto non va. Diciamo che l'impostazione assunta da alcuni
anni a questa parte è altamente preoccupante, come abbiamo visto dai fatti. Poi
non bisogna mai generalizzare. Ci sono realtà locali che operano bene, che fanno
cose importanti e lavorano seriamente. Ci sono attività di formazione che
vengono promosse da Libera che rappresentano un contributo importante nella
sensibilizzazione. Alcune di queste in particolare, altre invece sono una sorta
di promozione di una “educazione alla legalità” slegata dal territorio, dalla
concretezza, diciamo ecumeniche e non laiche. Dire che da una parta c'è il bene
e dall'altra il male, senza dare esempio tangibile, riconoscibile sui territori
dove si promuove quell'attività, rischia di non incidere. Ecco qui vi è una
diversa visione... loro promuovono questa attività in modo meno “laico”, noi
cerchiamo invece di far vedere la realtà dei fatti, partendo da dove vivono quei
ragazzi che si incontrano e far scattare in loro quella capacità critica che gli
permette di arrivare loro a concludere ciò che è giusto e ciò che invece è
sbagliato, quale sia il bene e quale invece il male.»
Ma perché, visto che vi sta a cuore
Libera, non vi confrontate con Libera?
«Anche
qui la domanda è da rivolgere a loro. Noi non abbiamo mai avuto e non abbiamo
problema alcuno a confrontarci su questo e su altre cose con Libera e con
chiunque altro. E' proprio Libera che sfugge al confronto... che ci ignora
totalmente e cerca di isolarci, di “cancellarci”. Ma anche qui ci sono degli
esempi concreti. Andiamo con ordine...A Bologna un’associazione che fa parte di
Libera aveva organizzato un incontro di presentazione del libro “Tra la via
Emilia e il Clan”, invitando gli autori, Abbondanza ed Amorosi, ed il
Procuratore Capo di Bologna. Poi dal Nazionale di Libera arriva il veto: non ci
può essere Abbondanza! Viene comunicato che l'iniziativa è quindi rinviata! A
Genova, nessun invito formale, nemmeno semplicemente per partecipare come
pubblico, ci è stato mai mandato per le iniziative organizzate in preparazione
della manifestazione del marzo scorso...Ma vi è di più. Quando il Consiglio dei
Ministri approva lo scioglimento della Giunta e Consiglio Comunale di
Ventimiglia (a seguito dell'istruttoria seguita alla nostra denuncia), ed il
Presidente della Repubblica firma il Decreto di Scioglimento, il referente
regionale di Libera, Lupi (che è di Imperia) cosa dichiara? Che è “rammaricato”
per l'esito dello scioglimento! Non una parola sulle minacce ed intimidazioni
che ci sono giunte e per la situazione di pericolo che ha portato la Prefettura
di Genova ad adottare a tutela del presidente della Casa della Legalità le
misure di protezione. Silenzio ed isolamento, come se non esistessi, come se non
esistessimo...Per il 23 maggio l'Istituto degli Emiliani a Genova ci ha invitato
per ricordare Falcone e per far capire che la mafia c'è ancora, che è concreta,
che è qui al Nord... Lo scorso anno c'era anche Libera, quest'anno non si è
presentata. Hanno pubblicato due rapporti, redatti da loro, uno sulla Liguria ed
uno sull'Emilia-Romagna, in nessuno dei due casi appare neppure mezza delle
risultanze di indagini che abbiamo contribuito a raggiungere. Non una citazione…
fatti ed atti cancellati. Sull'Emilia-Romagna abbiamo anche pubblicato un
“atlante”, il libro “Tra la via Emilia e il Clan”, dove si è messo in evidenza,
atto dopo atto, che quella regione, quell'economia, non è affatto esente dalla
presenza e dalle attività delle mafie. Un libro che non ha avuto neanche mezza
contestazione, nessuna smentita e nessuna querela (un anomalo miracolo, si
potrebbe dire). Bene, per Libera non esiste...Se non sei dei loro non esisti e
non devi esistere! Poi questa ultima storia di Sarzana, evidenzia un nuovo
eclatante esempio. Tempo fa ci contatta l'ANPI di Sarzana per sapere a chi
potevano assegnare l'onorificenza civica "XXI luglio 1921". Ci dicono che,
essendo il ventennale delle stragi del 1992, volevano assegnarla ad un soggetto
che abbia operato ed operi nella lotta alle mafie. Non abbiamo dubbi e
proponiamo la DIA di Genova. La proposta viene poi accolta. Il Sindaco di
Sarzana contatta il presidente della Casa della Legalità, e gli comunica
ufficialmente l'accoglimento della proposta, gli chiede se poteva essere
presente per un intervento nella tavola rotonda del 20 luglio in cui verrà
consegnata l'onorificenza. Gli risponde di sì. Il giorno seguente Abbondanza
viene contattato dalla segreteria del Sindaco per avere conferma del suo
intervento, dovendo procedere per la stampa degli inviti. Gli viene data
conferma. L'altro ieri ci è arrivato l'invito. Non ci siamo più, l'intervento di
Abbondanza è svanito. C'è Libera. Ora, premesso che la cosa importante,
significativa, è il riconoscimento alla DIA che compie un lavoro straordinario
ma viene “tagliata” continuamente nelle risorse a propria disposizione, spesso
resta inascoltata anche da magistrati e istituzioni ciechi. Come abbiamo detto
anche al Sindaco che si è scusato ed ha fatto inoltrare anche una nota di scuse
ufficiali (tra l'altro nel comunicato stampa questo passaggio è svanito, chissà
perché?!), è che spunta Libera, espressione e “paravento” di quel blocco
politico-economico che corrisponde a quello dell'amministrazione del Comune di
Sarzana, e noi spariamo dagli interventi. Il Sindaco dice che Libera è attiva
nello spezzino. A parte il fatto che anche noi lo siamo da tempo, ci piacerebbe
sapere dove è Libera nella lotta contro le speculazioni edilizie che hanno
devastato quel territorio, contro il progetto della grande colata di cemento
alla Marinella, nato tra l'avvocato Giorgio Giorgi, uomo di Burlando, Monte dei
Paschi di Siena e cooperative rosse? Dove erano nel contrasto alla cricca del
“faraone” delle Cinque Terre, che era “pappa e ciccia” con Legambiente, altro
grande “paravento” del PD, legatissima a Libera? Il Sindaco risponde ad
Abbondanza: hanno proposto la Consulta per la Legalità e l'abbiamo approvata,
una struttura indipendente, con Libera, i sindacati ecc. ecc... Ma come,
Sindaco, se ci sono Libera ed i Sindacati, dove è “indipendente” questa
consulta? Se i Sindacati, a partire da quelli edili, iniziassero a fare il loro
lavoro e denunciassero le infiltrazioni nei cantieri, il caporalato, la lotta
all'illegalità ed alle mafie farebbe passi da gigante, ed invece tacciono,
coprono. La stessa cosa che avviene con le aziende agricole... ricordiamo la
Rosarno, dove tutti sapevano, i sindacati in primis, chi sfruttava come schiavi
quegli immigrati, e non osavano denunciarne nemmeno mezzo, mai un nome, ma solo
parate, fiaccolate, convegni. Noi ad un confronto siamo sempre disponibili, ma
come lo possiamo avere se sfuggono come anguille ad ogni possibilità di
confronto e se quando vi sarebbero occasioni di intervenire, entrambi, se non
saltano le iniziative, come nel caso di Bologna, fanno saltare la nostra
presenza o non si presentano loro?»
Cosa vi aspettate dopo questa
pubblicazione?
«Vorremmo
dire un confronto. Questo è quello che auspichiamo. Pensiamo che invece avremo
da un lato un “muro di gomma”, ovvero il tentativo di tenere tutto questo nel
silenzio, come se non esistesse, dall'altro lato invece subiremo un attacco
feroce, spietato. Crediamo che valga la pena, proprio per quel briciolo di
speranza riposto nelle tante persone in buona fede... Tacere ancora tutto questo
significherebbe perdere quella speranza di cambiamento necessario, perché
ripetiamo: Libera è una struttura importante e se torna alle origini ne abbiamo
tutti un vantaggio! Non vogliamo una “guerra” con Libera, vogliamo dare un
contributo, anche se attraverso una critica senza veli sui fatti, perché si
possa migliorare. Noi non vogliamo la fine di Libera, vogliamo la sua
rinascita.... e chi è in buona fede lo capisce, non può non capirlo.»
ITALIA: PAESE ZOPPO.
Roberto Gervaso: terapie per
un Paese zoppo. Il nuovo libro racconta l’ultimo secolo dell’Italia. Senza
sconti a Grillo, Berlusconi, Renzi, Napolitano...La lezione è quella, come lo
stesso Roberto Gervaso racconta a Stefania Vitulli di “Panorama”, appresa da
Montanelli, Prezzolini, Buzzati, Longanesi. E quanto questa lezione sia ancora
inedita e scomoda nell’Italia contemporanea lo dimostra il suo nuovo libro, Lo
stivale zoppo. Una storia d’Italia irriverente dal fascismo a oggi. Nella
lista dei nomi che ritroviamo alla fine del volume non manca nessuno: Abu
Abbas, Agnelli e Alberto da Giussano aprono un elenco alfabetico che si conclude
con Zaccagnini, Zeman e Zingaretti. Nel mezzo, l’ultimo secolo di storia di un
Paese a cui Gervaso non risparmia ricostruzioni accurate dei fatti e verità dure
da accettare.
Che cosa c’è di nuovo in
questo libro?
«Le
cose che ho sempre detto. Solo che ora le dico con furia. Perché, se non si fa
una diagnosi spietata, l’Italia non avrà mai né terapia né prognosi.»
Filo conduttore?
«La
storia di un Paese senza carattere, che sta ancora in piedi perché non sa da
che parte cadere.»
Si parte dalla Conferenza di
Versailles...
«Sì,
perché l’Ottocento finisce nel 1919, e quell’anno getta il seme dei fascismi.
Suggellò la Prima guerra mondiale, caddero quattro imperi, nacquero le grandi
dittature e l’America soppiantò l’Europa nella leadership mondiale.»
E l’Italia?
«Ha
vinto una guerra nelle trincee e sulla carta ma l’ha perduta in diplomazia,
società, economia. Era divisa fra le squadracce nere all’olio di ricino e quelle
rosse che volevano imporre i soviet. Partiti dilanianti e latitanti, i poteri
forti scelsero i fasci nell’illusione di addomesticare Benito Mussolini.»
Che si affacciò al balcone...
«Tutto
era a pezzi, tutto in vendita. Oggi la situazione non è certo migliore del
1922.»
Partiti dilanianti e
latitanti?
«Non
hanno mai litigato tanto. La sinistra è un’insalata russa senza maionese, la
destra una macedonia di frutta con troppo maraschino giudiziario. Il Paese è a
un bivio: il balcone o la colonia.»
Sarebbe a dire?
«O
qualcuno si leva dalla folla interpretando l’incazzatura della gente, si
affaccia al balcone e dichiara: «Il carnevale è finito», oppure diventiamo una
colonia delle grandi potenze europee o di quelle emergenti, come la Cina. La
moda italiana, tranne pochi del nostro Paese, si divide tra François Pinault e
Bernard Arnault; l’alimentare è in mano ai francesi, la meccanica è dei
tedeschi, gli alberghi diventano spagnoli...»
E gli italiani non se ne
accorgono?
«Abbiamo
un’ancestrale vocazione al servaggio. Gli italiani se ne infischiano della
libertà, le hanno sempre anteposto il benessere. L’uguaglianza non esiste: è
l’utopia dell’invidia.»
Ma che cosa ci deve capitare
di ancora più grave?
«L’Italia
ha sempre dato il meglio di sé in ginocchio, con le spalle al muro, l’acqua alla
gola e gli occhi pieni di lacrime. Nell’emergenza risorgeremo.»
Come si chiama questa
malattia?
«Mancanza
di senso dello stato. Al massimo abbiamo il senso del campanile. L’italiano non
crede in Dio ma in San Gennaro, Sant’Antonio, San Cirillo. A condizione che il
miracolo non lo faccia agli altri ma a se stesso.»
La cura?
«Utopistica:
che ognuno faccia il proprio dovere e magari sacrifici. Che devono
cominciare dall’alto.»
E parliamo di chi sta in alto.
Mario Monti?
«Un
economista teorico, un apprendista politico che ha fatto un passo falso e
fatale. Si fosse dimesso alla scadenza del mandato, sarebbe al Quirinale. Deve
cambiare mestiere: la politica non è affar suo e temo che non lo sia nemmeno
l’economia.»
Beppe Grillo?
«Un
Masaniello senza competenza politica, collettore dei voti di protesta. Se si
instaurasse una seria democrazia, sparirebbero i grillini, che vogliono la
riforma della Costituzione senza averla letta.»
Enrico Letta?
«Un
giovane vecchio democristiano, serio e competente, ma senza quel quid che fa
di un politico un leader o uno statista, cosa che, fra l’altro, non ha mai
preteso. Un buon governante.»
Matteo Renzi?
«Un
pallone gonfiato sottovuoto spinto. Un puffo al Plasmon che recita una parte
che vorrebbe incarnare ma non è la sua. Se lo si guarda bene quando parla e si
muove, si vede che non c’è niente di spontaneo. Ha una virtù: il coraggio. Più
teorico che pragmatico, però, perché oggi va a braccetto con Walter
Veltroni. Non è un rottamatore, è un illusionista.»
Veltroni?
«Un
perdente di successo, ormai attempato e fuori dai tempi. Che ha cercato di
conciliare Kennedy e Che Guevara.»
Pier Luigi Bersani?
«Un
paesano. Un contadino abbonato a Frate Indovino, che parla per proverbi.»
Massimo D’Alema?
«Un
uomo di grandi intuizioni. Tutte sbagliate.»
Silvio Berlusconi?
«Un
grande leader d’opposizione. Che sa vincere le elezioni e ama il potere. Ma
non la politica.»
Giorgio Napolitano?
«Ottimo
presidente della Repubblica. Che conserva una foto dei carri armati che
invasero l’Ungheria nel ’56. La tiene in cassaforte e la mostra solo ai
compagni.»
Cultura a sinistra, Paese a
destra Una «strana» Italia divisa in due.
Il vizio d'origine? Un'agenda politica, dettata da un antifascismo non sempre
democratico, che trova riscontro solo nelle élite, scrive Roberto Chiarini su
“Il Giornale”. Pubblichiamo qui uno stralcio della Premessa del nuovo saggio
dello storico Roberto Chiarini Alle origini di una strana Repubblica. Perché la
cultura politica è di sinistra e il Paese è di destra. Un libro che spiega i
mali che affliggono l'Italia, risalendo alla formazione della democrazia a
partire dalla caduta del fascismo. I tratti originari della nostra Repubblica
hanno reso operante la democrazia ma, alla distanza, l'hanno anche anchilosata.
L'antifascismo ha comportato l'operatività di una precisa sanzione costrittiva
del gioco democratico, sanzione controbilanciata presto sul fronte opposto da
una opposta e simmetrica, l'anticomunismo. Destra e sinistra si sono trovate in
tal modo, invece che protagoniste - come altrove è «normale» - della dialettica
democratica, solo comprimarie, stabilmente impedite da una pesante
delegittimazione ad avanzare una candidatura in proprio per la guida del paese.
Da ultimo, la configurazione di un «paese legale» connotato da una pregiudiziale
antifascista e di un «paese reale» animato da un prevalente orientamento
anticomunista ha comportato una palese, stridente assimetria tra una società
politica orientata a sinistra in termini sia di specifico peso elettorale che di
obiettivi proposti e un'opinione pubblica molto larga - una maggioranza
silenziosa? - per nulla disposta a permettere svolte politiche di segno
progressista. L'emersione nel 1994, grazie al passaggio a un sistema
tendenzialmente bipolare, della «destra occulta» rimasta per un cinquantennio
senza rappresentanza politica diretta ha risolto solo a metà il problema. È
rimasta l'impossibilità per una forza politica mantenuta - e tenutasi - nel
ghetto per mezzo secolo di esprimere di colpo una cultura, un disegno
strategico, una classe dirigente all'altezza del ruolo di comprimaria della
sinistra. Al deficit di maturità democratica ha aggiunto, peraltro,
un'inclinazione a secondare posizioni vuoi etno-regionaliste (se non
dichiaratamente separatiste) inconciliabili con l'ambizione di costruire una
forza politica di respiro nazionale, vuoi populistico-plebiscitarie in aperta
dissonanza con la destra liberale europea. Tutto ciò ha offerto il destro - e
l'alibi - alla sinistra per persistere in una battaglia di demonizzazione
dell'avversario, contribuendo in tal modo a rinviare una piena rigenerazione di
questa «strana democrazia», normale a parole ma ancora in larga parte
prigioniera di comportamenti ispirati alla delegittimazione del nemico. A
pagarne le conseguenze continuano a essere non solo destra e sinistra, ma anche
le istituzioni democratiche, ingessate come sono in un confronto polarizzato che
ha finito con il comprometterne la capacità operativa, soprattutto sul fronte
delle importanti riforme di cui il Paese ha un disperato bisogno. Il risultato è
stato di erodere pesantemente la credibilità e persino la rappresentatività
delle stesse forze politiche. Lo scontento e la disaffezione insorti per
reazione non potevano non ridare nuova linfa a una disposizione stabilmente
coltivata dall'opinione pubblica italiana, conformata a un radicato pregiudizio
sfavorevole alla politica. Una disposizione che ha accompagnato come un fiume
carsico l'intera vicenda politica repubblicana sin dal suo avvio, tanto da
rendere «il qualunquismo (...) maggioritario nell'Italia repubblicana, sia
presso il ceto intellettuale che presso l'opinione pubblica» (Sergio Luzzatto).
Una sorta di controcanto, spesso soffocato, al predominio incontrastato dei
partiti. S'è detto che la funzione dei partiti è cambiata nel tempo divenendo da
maieutica a invalidante della democrazia, da leva per una politicizzazione della
società a strumento di occupazione dello Stato e, per questa via, a stimolo
dell'antipolitica così come la loro rappresentatività da amplissima si è
progressivamente inaridita. Parallelamente anche le forme, i contenuti, gli
stessi soggetti interpreti dell'antipolitica si sono trasformati nel corso di un
sessantennio. Da Giannini a Grillo, la critica alla partitocrazia ha avuto
molteplici voci (da Guareschi a Montanelli fino a Pannella) e solleticato
svariati imprenditori politici a valorizzarne le potenzialità elettorali (dal
Msi alla Lega, alla stessa Forza Italia, passando per le incursioni sulla scena
politica di movimenti poi rivelatisi effimeri, come la Maggioranza Silenziosa
dei primissimi anni settanta o i «girotondini» di pochi anni fa). Costante è
stata la loro pretesa/ambizione di offrire una rappresentanza politica
all'opinione pubblica inespressa e/o calpestata dai partiti, facendo leva sulla
polarità ora di uomo qualunque vs upp (uomini politici professionali) ora di
maggioranza silenziosa vs minoranza rumorosa, ora di Milano «capitale morale» vs
Roma «capitale politica», ora di cittadini vs casta. Altro punto fermo è stato
la denuncia dello strapotere e dell'invadenza dei partiti accompagnata spesso
dall'irrisione demolitoria della figura del politico strutturato nei partiti,
poggiante sull'assunto che la politica possa - anzi, debba - essere appannaggio
di cittadini comuni. Un significativo elemento di discontinuità s'è registrato
solo negli ultimi tempi. L'antipartitismo prima attingeva a un'opinione pubblica
- e esprimeva istanze - marcatamente di destra, per quanto l'etichetta fosse
sgradita. A partire dagli anni Novanta, viceversa, l'antipolitica mostra di
attecchire anche presso il popolo di sinistra. Un'antipolitica debitamente
qualificata come «positiva» e inserita in un «orizzonte virtuoso», comunque non
meno accesamente ostile nei confronti della «nomenk1atura spartitoria», della
«degenerazione della politica in partitocrazia», dell'«occupazione dello Stato e
della cosa pubblica», dell'«arroccamento corporativo della professione
politica». È l'antipolitica che ha trovato la sua consacrazione nel M5S,
rendendo l'attacco al «sistema dei partiti» molto più temibile e imponendo
all'agenda politica del paese l'ordine del giorno del superamento insieme
dell'asimmetria storica esistente tra paese legale e paese reale e del ruolo
protagonista dei partiti nella vita delle istituzioni.
QUANDO I BUONI TRADISCONO.
Lunedì 12 luglio 2010. Il
tribunale di Milano condanna in primo grado il generale Giampaolo Ganzer a 14
anni di prigione, 65mila euro di multa e interdizione perpetua dai pubblici
uffici per traffico internazionale di droga, scrive Mario Di Vito su
“Eilmensile”. Il processo andava avanti da cinque anni e nella sua storia poteva
contare sul numero record di oltre 200 udienze. La sentenza racconta di un
Ganzer disposto a tutto pur di fare carriera, in una clamorosa lotta senza
quartiere al narcotraffico. Una lotta che – sostiene il tribunale – passava
anche per l’importazione, la raffinazione e la vendita di quintali di droga. Il
fine giustifica i mezzi, si dirà. Ma, intanto, l’accusa chiese 27 anni di
prigione per il “grande servitore dello Stato”, che “dirigeva e organizzava i
traffici”. L’indagine su Ganzer nacque per merito del pm Armando Spataro che,
nel 1994, ricevette dal generalissimo l’insolita richiesta di ritardare il
sequestro di 200 chili di cocaina. Il Ros sosteneva di essere in grado di
seguire il percorso dello stupefacente fino ai compratori finali. Spataro firmò
l’autorizzazione, ma i i carabinieri procedettero comunque, per poi non dare più
notizia dell’operazione per diversi mesi, cioè fino a quando, di nuovo Ganzer se
ne uscì con la proposta di vendere il carico di cocaina sequestrata a uno
spacciatore di Bari. Spataro – verosimilmente con gli occhi fuori dalle orbite –
ordinò la distruzione immediata di tutta la droga. Quasi vent’anni dopo, la
procura di Milano avrebbe sostenuto che i carabinieri agli ordini di Ganzer
fossero al centro di un traffico enorme e “le brillanti operazioni non erano
altro che delle retate di pesci piccoli messe in atto per gettare fumo negli
occhi dell’opinione pubblica”. La prima vera, grande, pietra miliare
dell’inchiesta è datata 1997, cioè, quando il giudice bresciano Fabio Salamone
raccolse la testimonianza di un pentito, Biagio Rotondo, detto “il rosso”, che
gli raccontò di come alcuni agenti del Ros lo avvicinarono nel 1991 per
proporgli di diventare una gola profonda dall’interno del mercato della droga.
Rotondo si sarebbe poi suicidato in carcere a Lucca, nel 2007. Secondo
l’accusa, i “confidenti del Ros” – reclutati a decine per tutti gli anni ’90 –
erano degli spacciatori utilizzati come tramite con le varie organizzazioni
malavitose. L’indagine – che negli anni è stata rimpallata tra Brescia, Milano,
Torino, Bologna e poi di nuovo Milano, con centinaia di testimonianze e migliaia
di prove repertate– sfociò nella condanna del generalissimo e di altri membri
del Reparto, che, comunque, sono riusciti tutti ad evitare le dimissioni – e il
carcere – poiché si trattava “solo” di una sentenza di primo grado. Il nome di
Ganzer viene messo in relazione anche con uno strano suicidio, quello del 24enne
brigadiere Salvatore Incorvaia che, pochi giorni prima di morire, aveva detto al
padre Giuseppe, anche lui ex militare, di essere venuto a conoscenza di una
brutta storia in cui erano coinvolti “i pezzi grossi”, addirittura “un
maresciallo”. Incorvaia sarebbe stato ritrovato cadavere il 16 giugno 1994, sul
ciglio di una strada, con un proiettile nella tempia che veniva dalla sua
pistola di ordinanza. Nessuno ebbe alcun dubbio: suicidio. Anche se il vetro
della macchina di Incorvaia era stato frantumato, e non dal suo proiettile –
dicono le perizie – che correva nella direzione opposta. Altra brutta storia che
vede protagonista Ganzer – questa volta salvato dalla prescrizione – riguarda un
carico di armi arrivato dal Libano nel 1993: 4 bazooka, 119 kalashnikov e 2
lanciamissili che, secondo l’accusa, i Ros avrebbero dovuto vendere alla
‘ndrangheta. Zone d’ombra, misteri, fatti sepolti e mai riesumati. Tutte cose
che ora non riguarderanno più il generale Giampaolo Ganzer, già proiettato verso
una vecchiaia da amante dell’arte. Fuori da tutte quelle vicende assurde, ma
“nei secoli fedele”.
«Traditore per smisurata
ambizione».
Questa una delle motivazioni per le quali i giudici dell’ottava sezione penale
di Milano hanno condannato a 14 anni di carcere il generale del Ros Giampaolo
Ganzer, all’interdizione dai pubblici uffici e alla sanzione di 65 mila
euro, scrive “Il Malcostume”. Erano i giorni di Natale del 2010 quando arrivò
questa incredibile sentenza di primo grado. Secondo il Tribunale, il comandante
del Reparto operativo speciale dell’arma, fiore all’occhiello dei Carabinieri,
tra il 1991 e il 1997 «non si è fatto scrupolo di accordarsi con
pericolosissimi trafficanti ai quali ha dato la possibilità di vendere in Italia
decine di chili di droga garantendo loro l’assoluta impunità», dunque «Ganzer
ha tradito per interesse lo Stato e tutti i suoi doveri tra cui quello di
rispettare e fare rispettare la legge». Tutto questo possibile perché «all’interno
del raggruppamento dei Ros c’era un insieme di ufficiali e sottufficiali che, in
combutta con alcuni malavitosi, aveva costituito un’associazione finalizzata al
traffico di droga, al peculato, al falso, al fine di fare una rapida carriera».
La pm Maria Luisa Zanetti aveva chieso 27 anni per il generale Ganzer, ma
il tribunale aveva ridotto la condanna a 14 anni, in quanto la Corte presieduta
da Luigi Capazzo non ha riconosciuto il reato di associazione a
delinquere. Ma non ha concesso nemmeno le attenuanti generiche all’alto
ufficiale, in quanto «pur di tentare di sfuggire alle gravissime
responsabilità della sua condotta, Ganzer ha preferito vestire i panni di un
distratto burocrate che firmava gli atti che gli venivano sottoposti, dando agli
stessi solo una scorsa superficiale». Secondo i giudici, inoltre «Ganzer
non ha minimamente esitato a fare ricorso a operazioni basate su un metodo
assolutamente contrario alla legge ripromettendosi dalle stesse risultati di
immagine straordinari per sé stesso e per il suo reparto». 17 i
condannati nel processo, tra cui il narcotrafficante libanese Jean Bou
Chaaya (tuttora latitante) e molti carabinieri: il colonnello Mario Obinu
(ai servizi segreti) con 7 anni e 10 mesi, 13 anni e mezzo a Gilberto Lovato,
10 anni a Gianfranco Benigni e Rodolfo Arpa, 5 anni e 4 mesi a
Vincenzo Rinaldi, 5 anni e 2 mesi a Michele Scalisi, 6 anni e 2 mesi
ad Alberto Lazzeri Zanoni, un anno e mezzo a Carlo Fischione e
Laureano Palmisano. La clamorosa condanna del generale Ganzer fu accolta tra
il silenzio dell’allora ministro della Difesa Ignazio La Russa, la
solidarietà dell’allora ministro dell’Interno Roberto Maroni e la difesa
dell’ex procuratore antimafia Pierluigi Vigna, benché questa brutta
vicenda che “scuote l’arma” avrebbe dovuto portare alla sospensione della
carica e quindi del servizio di Ganzer, in ottemperanza all’articolo 922 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, la cosiddetta “norma di rinvio” che
dice: “Al personale militare continuano ad applicarsi le ipotesi di
sospensione dall’impiego previste dall’art 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97”
che attiene alle “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento
disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche” e che all’articolo 4 dice espressamente: “In
caso di condanna, anche non definitiva, per alcuno dei delitti indicati
all’articolo 3 comma 1, i dipendenti sono sospesi dal servizio”. Tra i
delitti considerati c’è pure il peculato, reato contemplato nella sentenza a
carico di Ganzer. Eppure, da allora, il generale Ganzer è rimasto in carica
nonostante “I Carabinieri valutano il trasferimento“, malgrado i numerosi
appelli alla responsabilità e all’opportunità delle dimissioni giunti da più
parti. Ganzer non ha mai mollato la poltrona e nessun ministro (La Russa
allora, Di Paola poi) gli ha fatto rispettare la legge, a parte
un’interrogazione parlamentare del deputato radicale Maurizio Turco.
Ganzer ha continuato a dirigere il Ros, ad occuparsi di inchieste della portata
di Finmeccanica, degli attentatori dell’ad di Ansaldo Roberto Adinolfi, senza
contare le presenze ai dibattiti sulla legalità al fianco dell’ex
sottosegretario del Pdl Alfredo Mantovano, suo grande difensore. Proprio
in questi giorni l’accusa in un processo parallelo, ha chiesto 8 anni di
condanna per Mario Conte, ex pm a Bergamo che firmava i decreti di
ritardato sequestro delle partite di droga per consentire alla cricca di
militari guidati da Ganzer di poterla rivendere ad alcune famiglie di
malavitosi. La posizione di Conte era stata stralciata per le sue precarie
condizioni di salute. Ebbene, in attesa della sentenza e senza un solo
provvedimento di rimozione dall’incarico anche a protezione del buon nome del
Ros, ora Ganzer lascia il comando del Reparto. Non per l’infamante
condanna. Ma “per raggiunti limiti d’età” . Ganzer lascerà il posto al
generale Mario Parente per andare in pensione. Da «Traditore per smisurata
ambizione» a fruitore di (smisurata?) pensione. Protetto dagli uomini delle
istituzioni e alla faccia di chi la legge la rispetta.
E poi ancora. Sono stati
arrestati dai loro stessi colleghi, per il più odioso dei reati, quello di
violenza sessuale, ancora più odioso perché compiuto su donne sotto la loro
custodia, una delle quali appena maggiorenne. A finire nei guai tre agenti di
polizia in servizio a Roma raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in
carcere emessa dalla Procura della capitale ed eseguita dagli agenti della
Questura.
Ed ancora. Erano un corpo nel
corpo. Sedici agenti della Polizia Stradale di Lecce sono stati arrestati con
l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al falso ideologico e alla
concussione ambientale. I poliziotti erano 20 anni che, stando alle accuse,
omettevano i controlli ai mezzi di trasporto di circa 100 ditte del Salento in
cambio di denaro e merce varia. Dalle intercettazioni telefoniche è emerso che
ogni agente racimolasse da questa attività extra qualcosa come 40.000 euro ogni
3 anni . Il “leader” dell’ organizzazione sarebbe l’ ispettore capo Francesco
Reggio, 57 anni, leccese. Nel corso di una telefonata intercettata Reggio si
sarebbe complimentato con un suo collega che, grazie alle somme intascate,
sarebbe andato anticipatamente in pensione. L’ indagine è partita solo quando
sulla scrivania del procuratore capo di Lecce, Cataldo Motta, è arrivata una
denuncia anonima contenente i nomi degli agenti e delle ditte coinvolte. Un’
altra lettera, questa volta non anonima, arrivata successivamente in Procura è
partita invece proprio dall’interno della sezione di Polizia Stradale di Lecce.
Ed Ancora. Tre agenti di
polizia e cinque immigrati sono stati arrestati dalla Squadra Mobile della
Questura di
Venezia nell'ambito di un'inchiesta che ha accertato il rilascio di permessi di
soggiorno in mancanza di requisiti di legge, sulla base di documentazione
falsificata.
Ed Ancora. Arrestati due
carabinieri nel Barese, chiedevano soldi per chiudere un occhio. Facevano
coppia, sono stati bloccati dai loro colleghi del comando provinciale di Bari e
della squadra mobile del capoluogo. A due ragazzi fermati durante un controllo
anti-prostituzione avevano chiesto denaro prospettando una denuncia per
sfruttamento.
Ecc. Ecc. Ecc.
G8 Genova. Cassazione: "A
Bolzaneto accantonato lo Stato di Diritto".
La Suprema corte rende note le motivazioni della sentenza dello scorso 14 giugno
2013. "Contro i manifestanti portati in caserma violenze messe in atto per dare
sfogo all'impulso criminale". "Inaccoglibile", secondo la Quinta sezione penale,
"la linea difensiva basata sulla pretesa inconsapevolezza di quanto si
perpetrava all’interno delle celle", scrive "Il Fatto Quotidiano". Un “clima di
completo accantonamento dei principi-cardine dello Stato di
diritto”. La Cassazione mette nero su bianco quello che accadde nella
caserma di Bolzaneto dove furono portati i manifestanti no
global arrestati e percossi durante il G8 di Genova nel
luglio del 2001: “Violenze senza soluzione di continuità” in condizioni di
“assoluta percettibilità visiva e auditiva da parte di chiunque
non fosse sordo e cieco”. Nelle 110 pagine depositate oggi
dalla Suprema corte si spiega perché, lo scorso 14 giugno 2013, sono state rese
definitive sette condanne e accordate quattro
assoluzioni per gli abusi alla caserma contro i
manifestanti fermati. La Cassazione ha così chiuso l’ultimo dei grandi
processi sui fatti del luglio 2001. Nel precedente
verdetto d’appello, i giudici avevano dichiarato prescritti i
reati contestati a 37 dei 45 imputati originari tra poliziotti,
carabinieri, agenti penitenziari e medici – riconoscendoli comunque responsabili
sul fronte dei risarcimenti. Risarcimenti che però la sentenza
definitiva ha ridotto. I giudici puntano il dito contro chi era preposto al
comando: “Non è da dubitarsi che ciascuno dei comandanti dei
sottogruppi, avendo preso conoscenza di quanto accadeva, fosse soggetto
all’obbligo di impedire l’ulteriore protrarsi delle
consumazioni dei reati”. Oltretutto, scrive la Cassazione “non risulta dalla
motivazione della sentenza che vi fossero singole celle da riguardare come oasi
felici nelle quali non si imponesse ai reclusi di mantenere la posizione
vessatoria, non volassero calci, pugni o schiaffi al
minimo tentativo di cambiare posizione, non si adottassero le modalità
di accompagnamento nel corridoio (verso il bagno o gli uffici) con le
modalità vessatorie e violente riferite” dai testimoni
ascoltati nel processo. I giudici di piazza Cavour denunciano come il
“compimento dei gravi abusi in danno dei detenuti si fosse reso
evidente per tutto il tempo, data l’imponenza delle risonanze vocali, sonore,
olfattive e delle tracce visibili sul corpo e sul vestiario delle vittime”. Ecco
perché, osserva la Quinta sezione penale, è “inaccoglibile la linea
difensiva basata sulla pretesa inconsapevolezza di
quanto si perpetrava all’interno delle celle, e anche nel corridoio durante gli
spostamenti, ai danni di quei detenuti sui quali i sottogruppi avrebbero dovuto
esercitare la vigilanza, anche in termini di protezione della loro incolumità”.
La Cassazione descrive inoltre
i comportamenti inaccettabili di chi aveva il comando e non ha
mosso un dito per fermare le violenze sui no global: “E’ fin troppo evidente che
la condotta richiesta dei comandanti dei sottogruppi consisteva nel vietare al
personale dipendente il compimento di atti la cui illiceità era manifesta: ciò
non significa attribuire agli imputati una responsabilità oggettiva, ma soltanto
dare applicazione” alla norma che regola “la posizione di garanzia
da essi rivestita in virtù della supremazia gerarchica sugli agenti al loro
comando”. Erano poi “ingiustificate” le vessazioni ai danni dei fermati “non
necessitate dai comportamenti di costoro e riferibili piuttosto alle condizioni
e alle caratteristiche delle persone arrestate, tutte appartenenti all’area dei
no global”, si legge nelle motivazioni. Insomma, conclude la Suprema corte, le
violenze commesse alla caserma di Bolzaneto sono state un “mero pretesto,
un’occasione per dare sfogo all’impulso criminale“.
Scaroni, l'ultras reso
invalido dalla polizia:
"Dopo anni aspetto giustizia". Il giovane tifoso del Brescia il 24 settembre del
2005 è stato ridotto in fin di vita alla stazione di Verona dagli agenti. Nella
sentenza di primo grado i giudici hanno stabilito la responsabilità delle forze
dell'ordine ("hanno picchiato con il manganello al contrario"), ma nessuna
possibilità di individuare le responsabilità personali. Per questo gli imputati
sono stati tutti assolti, scrive David Marceddu su "Il Fatto Quotidiano". ”Sai
cosa? Secondo me quel giorno alla stazione di Verona
cercavano il morto”. Paolo Scaroni a otto anni esatti da quel pomeriggio di fine
estate in cui la sua vita è totalmente cambiata, alcune idee le ha chiare. Sa
che lui, che ne è uscito miracolosamente vivo, è uno dei pochi che può, e deve,
raccontare. ”Patrizia Moretti, la madre di Federico Aldrovandi,
me lo dice sempre: io posso essere quella voce che altri non hanno più”, spiega
a ilfattoquotidiano.it. Per il giovane tifoso del Brescia, ridotto in fin di
vita a colpi di manganello da agenti di polizia il 24 settembre 2005, per
tragica coincidenza proprio la sera prima dell’omicidio di “Aldro” a Ferrara, la
battaglia nelle aule di giustizia continua: il pubblico ministero della procura
scaligera, Beatrice Zanotti ha presentato a fine aprile il ricorso in appello
contro l’assoluzione di sette poliziotti del Reparto mobile di Bologna. Per la
sentenza di primo grado a pestare l’ultras dopo la partita tra Hellas e Brescia
furono sicuramente dei poliziotti, ma non c’è la prova che
siano stati proprio Massimo Coppola, Michele Granieri, Luca Iodice, Bartolomeo
Nemolato, Ivano Pangione, Antonio Tota e Giuseppe Valente, e non invece altri
appartenenti alla Celere (l’ottavo imputato, un autista, è stato scagionato per
non aver commesso il fatto). Erano 300 in stazione quel pomeriggio tutti in
divisa, tutti col casco, irriconoscibili. Paolo Scaroni, 36 anni, fino al
”maledetto giorno” era un fiero allevatore di tori. Ora, invalido al 100%, dalla
sua casa di Castenedolo dove abita con la moglie, lotta giorno per giorno per
ritrovare una vita un po’ normale. Adesso potrà forse avere un
risarcimento: ora che un giudice ha detto che quello fu un ”pestaggio
gratuito”, ”immotivato rispetto alle esigenze di uso legittimo della forza, di
un giovane, con danni gravissimi allo stesso”, avere qualcosa indietro dallo
Stato potrebbe essere più facile. Il giudice infatti dice che non ci sono prove
sull’identità dei poliziotti colpevoli, ma sulla responsabilità della Polizia
non ci sono dubbi. ”E finora, anche se proprio in questi giorni lo Stato ha
avviato con me una sorta di trattativa, non ho avuto neanche un euro”. Per tutti
questi anni Scaroni è stato omaggiato da migliaia di tifosi in tutta Italia, che
ne hanno fatto un simbolo delle ingiustizie subite dal mondo ultras. Lui, che
ormai raramente va allo stadio, si gode questa vicinanza, ma lamenta la
lontananza delle autorità: ”Solo il questore di Brescia mi ha fatto sentire la
sua solidarietà. Avevo scritto a Roberto Maroni quando era ministro
dell’Interno, persino al Papa. Niente”. Paolo porta sul suo corpo i segni di
quel giorno. La diagnosi dei medici non lasciava molte speranze: ”Trauma
cranio cerebrale. Frattura affondamento temporale destra. Voluminoso
ematoma extradurale temporo parietale destro”. Una persona spacciata: ”Il medico
legale si spaventò perché nonostante fossi in fin di vita non avevo un livido
nel corpo. Avevano picchiato solo in testa”. E avevano picchiato,
certifica il giudice Marzio Bruno Guidorizzi, ”con una certa
impugnatura” del manganello ”al contrario”.
Diritti umani, governo Usa
attacca l'Italia:
“Polizia violenta, carceri invivibili, Cie, femminicidio…”. Un dossier
governativo analizza la situazione di 190 Paesi. Nel nostro, sotto accusa forze
dell'ordine, carceri, Cie, diritti dei rom, violenza sulle donne..., scrive
“FanPage”. Secondo il Governo americano i “principali problemi
risiedono nelle condizioni dei detenuti, con le carceri sovraffollate,
la creazione dei Cie per i migranti, i pregiudizi e l'esclusione sociale di
alcune comunità”. Senza dimenticare “l'uso eccessivo della forza da
parte della polizia, un sistema giudiziario inefficiente, violenza e
molestie sulle donne, lo sfruttamento sessuale dei minori, le aggressioni agli
omosessuali, bisessuali e trans e la discriminazione sui luoghi di lavoro sulla
base dell'orientamento sessuale”. Al sud, denunciati anche i casi di
sfruttamento di lavoratori irregolari. Il prende in esame il caso di
Federico Aldrovandi e quello di Marcello Valentino Gomez Cortes, entrambi uccisi
a seguito di normali controlli di polizia. Ma si critica anche l'assenza del
reato di tortura nel nostro ordinamento giuridico e le violenze che subiscono
autori di piccoli reati da parte di alcuni agenti. Sotto accusa anche i
rimpatri forzati degli immigrati irregolari, oppure la loro detenzione nei
centri di identificazione ed espulsione: “Il 24 maggio decine di detenuti in un
centro di Roma sono stati coinvolti in una rivolta contro quattro guardie, che
hanno utilizzato gas lacrimogeni per impedirne la fuga. L'episodio ha seguito le
proteste della settimana precedente nei Cie di Modena e Bologna. Un rapporto del
Comitato dei Diritti Umani del Senato ha denunciato la promiscuità tra adulti e
minori, il sovraffollamento, i lunghi periodi di detenzione e l'inadeguato
accesso di avvocati e mediatori culturali”. Sotto accusa anche le frequenti
discriminazioni ai danni dei cittadini romanì: “Le violenze nei
confronti di rom, sinti e camminanti rimangono un problema. Durante il
2012 le popolazioni rom sono state sottoposte a discriminazioni da parte di
autorità comunali, soprattutto attraverso sgomberi forzati non autorizzati”.
Naturalmente il report governativo non tralascia le violenze sulle donne, il
femminicidio, l'antisemitismo e il lavoro nero.
Polizia violenta, la
garanzia dell'anonimato.
In Europa gli agenti portano un codice personale sulla divisa. In
Italia no. E, in caso di abusi, non sono identificabili, scrive di Alessandro
Sarcinelli su “Lettera 43. Sarebbero bastati tre numeri e tre lettere sulla
divisa e sul casco dei poliziotti in tenuta anti-sommossa. Sarebbe bastato un
semplice codice alfanumerico e Lorenzo Guadagnucci, giornalista del
Quotidiano Nazionale, avrebbe potuto denunciare chi a manganellate gli
spaccò entrambe le braccia, la notte del 21 luglio 2001 alla scuola Diaz durante
il G8. Invece non ha mai saputo chi stava dietro la furia incontrollata dei
manganelli. Dopo 12 anni in Italia nulla è cambiato e i poliziotti del reparto
mobile non sono ancora identificabili. Per questo in caso di abusi, la
magistratura non ha la possibilità di individuarne i responsabili. In tutto
questo tempo ci sono state numerose petizioni e raccolte firme. Lo scorso
febbraio durante l’ultima campagna elettorale, 117 candidati poi divenuti
parlamentari hanno sottoscritto la campagna Ricordati che devi rispondere
proposta da Amnesty International: il primo punto riguardava proprio la
trasparenza delle forze di polizia. Tuttavia non si è mai arrivati neanche a una
proposta di legge in parlamento. «Nel nostro Paese c’è una bassa consapevolezza
su quali siano i limiti all’uso della forza dei pubblici funzionari. Viviamo
nelle tenebre», ha attaccato Guadagnucci. L’articolo 30 del nuovo ordinamento di
pubblica sicurezza del 1981 recita: «Il ministro dell’Interno con proprio
decreto determina le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla
polizia di Stato nonché i criteri generali concernenti l’obbligo e le modalità
d’uso». Se in fondo a questa legge si aggiungesse la formula «compresi i codici
alfanumerici» la questione sarebbe risolta. In oltre 30 anni nessun ministro
dell’Interno ha mai preso in considerazione questa modifica. Non è andata così
invece nei principali paesi europei: i codici alfanumerici sulle divise delle
forze dell’ordine sono infatti attualmente in uso in Inghilterra, Germania,
Svezia, Spagna, Grecia, Turchia e Slovacchia. In Francia non esistono ancora ma
qualche mese fa, Manuel Valls, attuale ministro dell’Interno, ne ha annunciato
l'introduzione a breve. Inoltre, nel dicembre 2012 una risoluzione del
parlamento Europeo ha chiesto esplicitamente ai paesi che non hanno ancora
adottato i codici di avviare una riforma. Ciononostante, la politica italiana
non ha mostrato particolare interesse sull’argomento: dei tre principali partiti
solo il M5s si è detto completamente favorevole all’introduzione dei codici.
Mentre Pd e Pdl non hanno trovato il tempo per esprimere la loro opinione. A
causa di questo disinteresse è calato il silenzio sul tema. Ma ogni volta che la
cronaca riaccende il dibattito l’opinione pubblica si divide tra chi è a favore
della polizia e chi è a favore dei manifestanti. Posizioni intermedie non
sembrano esistere. Secondo Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International
Italia, l’arroccamento su queste posizioni è frutto di un malinteso: «In Italia
introdurre norme riguardanti i diritti umani delle forze di polizia equivarrebbe
a stigmatizzarne il comportamento. In realtà l’introduzione dei codici
servirebbe a individuare solo i comportamenti penalmente rilevanti». In qualche
modo quindi sarebbe uno strumento per tutelare il corpo di polizia nel suo
insieme dalle azioni illegali dei singoli. Non la pensa così Nicola Tanzi,
segretario generale Sap (Sindacato autonomo di polizia): «Il manifestante
violento tramite il codice sulla divisa può risalire all’identità del poliziotto
mettendo in pericolo l’incolumità sua e dei suoi familiari». È bene precisare,
tuttavia, che per abbinare a un codice l’identità di un agente bisognerebbe
avere un infiltrato all’interno della polizia che fornisse queste informazioni.
Secondo molte realtà della società civile, l’uso (e l’abuso) della forza da
parte della polizia non va affrontato solo da un punto di vista legislativo ma
anche culturale. Guadagnucci è convinto che uno dei problemi principali sia la
poca trasparenza: «All’interno della polizia si risente ancora di cultura
militare e corporativa e non si è sviluppato un forte senso democratico»,
un’atmosfera da «non vedo, non sento, non parlo». I vertici del Sap, però, non
ci stanno, dicendosi convinti che «non ci sia nel modo più assoluto un problema
di trasparenza». Il primo in Italia a proporre i codici identificativi per le
forze dell’ordine fu Giuseppe Micalizio, braccio destro dell’allora capo della
polizia Gianni De Gennaro. Era il 22 luglio 2001 e Micalizio era stato inviato a
Genova per fare una relazione dettagliata sull’irruzione alla scuola Diaz, ma i
suoi consigli rimasero rimasti inascoltati da tutti, politica compresa.
All’orizzonte non si intravede nessun cambiamento e, secondo Amnesty
International, per questo si è interrotto il rapporto di fiducia tra
cittadinanza e forze dell’ordine, fondamentale in uno stato democratico. Ma per
Noury c’è qualcosa di ancora più grave: «Tutto ciò che ha consentito che la
“macelleria messicana” della Diaz accadesse c’è ancora. Quindi potrebbe
succedere ancora». A Genova o in qualsiasi altra città italiana.
Antonio Giangrande, orgoglioso
di essere diverso.
“Chi non conosce la verità
è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio
i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Ha mai pensato, per un
momento, che c’è qualcuno che da anni lavora indefessamente per farle sapere
quello che non sa? E questo al di là della sua convinzione di sapere già tutto
dalle sue fonti?
Provi a leggere un e-book o un
book di Antonio Giangrande. Scoprirà, cosa succede veramente nella sua regione o
in riferimento alla sua professione. Cose che nessuno le dirà mai.
Non troverà le cose ovvie
contro la Mafia o Berlusconi o i complotti della domenica. Cose che servono solo
a bacare la mente. Troverà quello che tutti sanno, o che provano sulla loro
pelle, ma che nessuno ha il coraggio di raccontare.
Può anche non leggere questi
libri, frutto di anni di ricerca, ma nell’ignoranza imperante che impedisce
l’evoluzione non potrà dire che la colpa è degli altri e che gli altri son tutti
uguali.
“Pensino ora i miei
venticinque lettori che impressione dovesse fare sull'animo del poveretto,
quello che s'è raccontato”. Citazione di Alessandro Manzoni.
DUE COSE SU AMNISTIA,
INDULTO ED IPOCRISIA.
“Gli italiani,
giustizialisti? No! Disinformati ed ignoranti. Se l'amnistia e l'indulto serve a
ristabilire una sorta di giustizia riparatrice per redimere anche i peccati
istituzionali: ben vengano.”
E’ chiaro e netto il pensiero
di Antonio Giangrande, scrittore e cultore di sociologia storica ed autore della
Collana editoriale "L'Italia del Trucco, l'Italia che Siamo" edita su Amazon.it
con decine di titoli.
Gli italiani non vogliono né
l'indulto né l'amnistia. A mostrarlo e dimostrarlo il sondaggio Ispo per il
Corriere: il 71 per cento degli intervistati ha detto no a ogni provvedimento di
clemenza. Un vero e proprio plebiscito contro che unisce, trasversalmente,
l'elettorato da sinistra a destra. Sempre secondo Ispo tra chi vota Pd è la
maggioranza (il 67%) a essere contraria. Così come nell'elettorato del Pdl dove,
nonostante ci sia di mezzo il futuro politico e non solo di Berlusconi,
qualunque idea di "salvacondotto " non piace per nulla. Il 63 (% contro 35) dice
no. Allineanti sulla linea intransigente anche gli elettori M5s: contrari 3 e su
4. Questi sondaggi impongono ai politicanti l'adozione di atti che nel loro
interesse elettorale devono essere utili, più che giusti.
Da cosa nasce questo marcato
giustizialismo italico?
Dall’ignoranza, dalla
disinformazione o dall’indole cattiva e vendicativa dei falsi buonisti italici?
Prendiamo in esame tre
fattori, con l’ausilio di Wikipedia, affinchè tutti possano trovare riscontro:
1. Parliamo dei giornalisti
e della loro viltà a parlare addirittura delle loro disgrazie.
Carcere per aver espresso la loro libertà di stampa scomoda per i potenti. Dice
Filippo Facci: «Siamo una masnada di fighetti neppure capaci di essere una
corporazione, anzi peggio, siamo dei professionisti terminali e già «morti» come
direbbe un qualsiasi Grillo. La Corte di Strasburgo ha sancito che il carcere
per un giornalista - Maurizio Belpietro, nel caso - costituisce una sproporzione
e una violazione della libertà di espressione. È una sentenza che farà
giurisprudenza più di cento altri casi, più della nostra Cassazione, più degli
estenuanti dibattiti parlamentari che da 25 anni non hanno mai partorito una
legge decente sulla diffamazione. Il sindacato dei giornalisti si è detto
soddisfatto e anche molti quotidiani cartacei (quasi tutti) hanno almeno dato la
notizia, che resta essenzialmente una notizia: ora spiegatelo ai censori del
Fatto Quotidiano, a questi faziosi impregnati di malanimo che passano la vita a
dare dei servi e chi non è affiliato al loro clan. Non una riga. Niente». Bene.
I giornalisti, censori delle loro disgrazie, possono mai spiegare bene cosa
succede prima, durante e dopo i processi? Cosa succede nelle quattro mura delle
carceri, laddove per paura e per viltà tutto quello che succede dentro, rimane
dentro?
2. Parliamo dei politici e
della loro ipocrisia.
Sovraffollamento e mancanza
di dignità.
«È inaccettabile, non più tollerabile, il sovraffollamento delle carceri
italiane». La presidente della Camera Laura Boldrini visita Regina Coeli, nel
quartiere di Trastevere, a Roma, dove lei vive. «Dignità, dignità», urlano i
detenuti della terza sezione, le cui celle ospitarono durante il fascismo
Pertini e Saragat, al passaggio della presidente della Camera denunciando le
condizioni «insostenibili» di sovraffollamento in cui sono costretti a vivere.
«Il tema carceri è una cruciale cartina di tornasole del livello di civiltà di
un Paese», dice Boldrini, che si ferma ad ascoltare storie e istanze. «Chi ha
sbagliato è giusto che paghi, non chiediamo sconti - aggiunge - ma che ci sia la
rieducazione del detenuto: che chi entra in carcere possa uscirne migliore. E
invece con il sovraffollamento, che è come una pena aggiuntiva, si crea
tensione, abbrutimento, promiscuità e si tira fuori il peggio delle persone.
Questo, come ha detto il presidente della Repubblica, è inaccettabile in un
Paese come l'Italia». Boldrini invoca «quanto prima» una «risposta di dignità»
per superare «una condizione disumana che non fa onore al Paese di Beccaria».
Innocenti in carcere.
Ma soprattutto, secondo la presidente della Camera, bisogna «ripensare il
sistema della custodia cautelare, perché non è ammissibile che più del 40% dei
detenuti sia in attesa di condanna definitiva, con il rischio di danni
irreparabili se innocenti. E bisogna pensare a misure alternative alle pene
detentive».
3. Parliamo della
sudditanza alla funzione giudiziaria e della convinzione della sua
infallibilità.
Il giustizialismo. Nel
linguaggio politico e giornalistico italiano indica una supposta ideologia che
vede la funzione giudiziaria al pari di un potere e come tale il più importante
e lo sostiene, o anche la presunta volontà di alcuni giudici di influenzare la
politica o abusare del proprio potere. Esso si contrappone al garantismo, che
invece è un principio fondamentale del sistema giuridico: le garanzie
processuali e la presunzione di non colpevolezza hanno un valore prevalente su
qualsiasi altra esigenza di esercizio e pubblicità dell'azione penale anche
nella sua fase pre-giudiziale; tale principio è sancito anche dalla
Costituzione: « La responsabilità penale è personale. L'imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva.»
La negazione dell’errore
giudiziario e la idolatria dei magistrati.
E’ certo che gli umani siano
portati all’errore. E’ certo anche che gli italiani hanno il dna di chi è
propenso a sbagliare, soprattutto per dolo o colpa grave. E' palese l'esistenza
di 5 milioni di errori giudiziari dal dopo guerra ad oggi. E' innegabile che il
risarcimento per l'ingiusta detenzione dei detenuti innocenti è un grosso colpo
all'economia disastrata dell'Italia. Nonostante l'idolatria è risaputo che i
magistrati italiani non vengono da Marte.
Sin dal Corpus iuris il reato
di denegata giustizia era oggetto di previsione normativa. La novella 17 colpiva
quei magistrati che obbligavano i sudditi ad andare ad implorare giustizia
dall'imperatore, perché gli era stata negata dai magistrati locali. La novella
134 puniva con la multa di 3 libbre d'oro il giudice di quella provincia, che,
malgrado avesse ricevuto lettere rogatorie, trascurasse l'arresto di un
malfattore che si fosse rifugiato nella detta provincia; la medesima pena era
comminata agli ufficiali del giudice. In tempi più recenti, nonostante il
plebiscitario esito della consultazione referendaria tenutasi sul tema nel 1987,
la legge n. 117 del 1989 di fatto snaturò e vanificò il diritto al conseguimento
del risarcimento del danno per una condotta dolosa o colposa del giudice. Essa
stravolse il risultato del referendum e il principio stesso della responsabilità
personale del magistrato, per affermare quello, opposto, della responsabilità
dello Stato: vi si prevede che il cittadino che abbia subìto un danno ingiusto a
causa di un atto doloso o gravemente colposo da parte di un magistrato non possa
fargli causa, ma debba invece chiamare in giudizio lo Stato e chiedere ad esso
il risarcimento del danno. Se poi il giudizio sarà positivo per il cittadino,
allora sarà lo Stato a chiamare a sua volta in giudizio il magistrato, che, a
quel punto, potrà rispondere in prima persona, ma solo entro il limite di un
terzo di annualità di stipendio, (di fatto è un quinto, oltretutto coperto da
una polizza assicurativa che equivale intorno ai cento euro annui). Quella legge
ha così raggiunto il risultato di confermare un regime di irresponsabilità per i
magistrati. L'inadeguatezza della legge n. 117 del 1989 è dimostrata dal fatto
che, a decenni dalla sua entrata in vigore, non si registra una sola sentenza di
condanna dello Stato italiano per responsabilità colposa del giudice, nonostante
le numerosissime sentenze con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha
acclarato inadempimenti dello Stato italiano. L'esigenza di rivedere la legge n.
117 del 1989 viene ora avvertita anche al fine di dare piena attuazione alla
novella costituzionale approvata sul tema del giusto processo, nonché al fine di
dare concreta esecuzione del principio consacrato dall'articolo 28 della
Costituzione: tali norme subiscono ingiustificabili limitazioni in riferimento
alla responsabilità dei giudici.
Il sistema della
responsabilità civile dei magistrati in Italia deroga quindi alla "grande
regola" della responsabilità aquiliana, secondo quanto è riconducibile agli
altri pubblici funzionari (ai sensi dell'articolo 28 Cost. e con la possibilità
di agire in regresso verso lo Stato). La peculiarità giustificata ai magistrati
è quella della delimitazione al dolo ed alla colpa grave (articolo 3), e la
garanzia di insindacabilità (articolo 2) che fu riconosciuta nella citata
sentenza n. 18 del 1989, per la quale "l'autonomia di valutazione dei fatti e
delle prove e l'imparziale interpretazione delle norme di diritto (…) non può
dar luogo a responsabilità del giudice". Il rapporto tra questa peculiarità e la
denegata giustizia è però assai problematico. La responsabilità civile del
giudice sussiste in un giudizio procedurale, non del merito, ad esempio per la
violazione di termini perentori per l'uso delle intercettazioni, custodia
cautelare, notifica di atti o precetti, prescrizione dei reati. Stante questo
vincolo, con la normativa attuale restano necessari comunque due procedimenti
separati (coi relativi tre gradi di giudizio), uno per l'ammissibilità, perché
la richiesta non deve sindacare l'autonomia del giudice, e uno vero e proprio
per la richiesta di risarcimento.
Detto questo, cosa ne sa la
massa di come si abilita alla funzione giudiziaria e quali siano le capacità,
anche psicologiche di chi giudica? Cosa ne sa la massa di cosa significa errore
giudiziario e questo riguarda prima o poi una persona (anche se stessi, non solo
gli altri) e la sua dignità nella società ed in carcere, dove torture e violenze
sono relegate all’oblio o al segreto del terrore? Cosa ne sa la massa se chi (i
giornalisti), dovendo loro dare corretta e completa informazione, non sa
tutelare nemmeno se stesso?
Ed ecco allora che l'ultimo
sport dei giustizialisti è attaccare Balotelli.
Il commissario della Nazionale
Prandelli ha deciso di portarlo ugualmente a Napoli, nonostante Balotelli fosse
infortunato, per la sfida contro l'Armenia. Qualcuno ha scritto che ci sarebbe
andato anche come testimonial anti-camorra perché prima del match l'Italia
avrebbe giocato su un campo sequestrato ai clan. Senza dire questo qualcuno,
però, come il campo sia stato assegnato ed a chi. Questo qualcuno si è arrogato
il diritto di dare una funzione a Balotelli, senza che questo sia consultato.
Lui ha letto e ha spiegato su Twitter: «Questo lo dite voi. Io vengo perché il
calcio è bello e tutti devono giocarlo dove vogliono e poi c'è la partita».
Questo è bastato a scatenare la reazione indignata di politici, parroci,
pseudointellettuali. Tutti moralisti, perbenisti e giustizialisti. Perché,
secondo loro, questa affermazione sarebbe scorretta, volgare non nella forma ma
nella sostanza, perché ci si legge un sottotesto che strizza l'occhio ai clan.
Poi, naturalmente c’è chi va
sopra le righe, per dovere di visibilità. Perche? Bisogna chiederlo a Rosaria
Capacchione, senatrice Pd e giornalista che è stata la prima ad attaccarlo: «È
un imbecille». Subito dopo al parroco don Aniello Manganiello: «Mi chiedo se
Balotelli abbia ancora diritto a essere convocato nella Nazionale». Aggiungetevi
una serie di insulti sui social network, le dichiarazioni dei politici locali e
avrete il quadro della situazione. Napoli. In terra di Camorra spesso è
difficile diversificare il camorrista da chi non lo è. C'è chi sparla e c'è chi
tace; c'è chi spara e c'è chi copre. A voi sembra che meriti tutto questo (il
bresciano Balotelli)? Si chiede Giuseppe De Bellis su “Il Giornale”. È tornato
quello stanco ritornello dei personaggi popolari che devono essere da esempio.
Dovere, lo chiamano. È un insulto all'intelligenza di chi queste frasi le dice.
C'è il legittimo sospetto che
Balotelli sia soltanto uno straordinario capro espiatorio. Un bersaglio facile:
lo attacchi e non sbagli, perché tanto qualche sciocchezza la fa di sicuro.
Siamo alla degenerazione della critica: sparo su Balotelli perché così ho i miei
trenta secondi di popolarità. È questo ciò che è accaduto. Lui sbaglia, eccome
se sbaglia. In campo e fuori è già successo un sacco di volte. Questa sarà solo
un'altra, devono aver pensato i professionisti dell'anticamorra: buttiamoci,
perché noi siamo i giusti e lui è quello sbagliato. Coni, Federazione, Nazionale
non hanno avuto nulla di meglio da dire che «Balotelli se le cerca», oppure,
«poteva risparmiarsela». Avrebbero dovuto dire solo una cosa: non usate lo sport
e gli sportivi per le vostre battaglie partigiane. Ci vuole coraggio per stare
al proprio posto. A ciascuno il suo e l'anticamorra non spetta al centravanti
della Nazionale. Lui vuole solo giocare a pallone. Lui deve solo giocare a
pallone. Il resto è ipocrisia. Balotelli l'ha solo svelata una volta di più.
Cosa ne sanno gli italiani
della mafia dell’antimafia, o degli innocenti in carcere. Gli italiani bevono
l’acqua che gli danno ed è tutta acqua inquinata e con quella sputano giudizi
sommari che sanno di sentenze.
E la colpa è solo e sempre di
una informazione corrotta ed incompleta da parte di una categoria al cui interno
vi sono rare mosche bianche.
Quindi, ecco perché "Gli
italiani, giustizialisti? No! Disinformati ed ignoranti. Se l'amnistia e
l'indulto serve a ristabilire una sorta di giustizia riparatrice per redimere
anche i peccati istituzionali: ben vengano".
Tanti sono gli esempi lampanti
su come disfunziona la Giustizia in Italia.
Che dire, per esempio, dei 12
mesi di carcere di Scaglia, l'innocente. L'ex fondatore di Fastweb assolto per
non aver commesso il fatto. Storia di ordinaria ingiustizia, scrive Annalisa
Chirico su “Panorama”. Alla fine sono stati assolti. Il pm aveva chiesto
sette anni per Silvio Scaglia e per Stefano Mazzitelli, rispettivamente
fondatore e presidente di Fastweb e amministratore delegato di Telecom Italia
Sparkle. Entrambi accusati di una frode fiscale da circa 365 milioni di euro.
Entrambi passati sotto il torchio delle manette preventive. Insieme a loro sono
stati assolti gli ex funzionari di Tis Antonio Catanzariti e Massimo Comito, gli
ex dirigenti di Fastweb Stefano Parisi, Mario Rossetti e Roberto Contin. Tutti
innocenti per “non aver commesso il fatto” o perché “il fatto non
costituisce reato”. Secondo i giudici della prima sezione penale del
tribunale di Roma, i manager non sapevano quello che stava succedendo, mentre ad
aver ideato e manovrato il sistema di megariciclaggio da due miliardi di euro
era Gennaro Mokbel, faccendiere napoletano con un passato di attivismo
nell’estrema destra. Su di lui adesso pende una condanna di primo grado a 15
anni di reclusione. “Il mondo è un posto imperfetto. Quando succedono cose
di questo tipo ti senti una vittima. Poi però ti guardi attorno e scopri che non
sei solo: in Italia ci sono decine di migliaia di innocenti che stanno dietro le
sbarre”, è il commento a caldo di Scaglia, pochi minuti dopo la lettura
del dispositivo della sentenza. La sua vicenda è solo la miniatura di una piaga
ben più imponente: circa il 40 percento dei detenuti nelle galere italiane sono
persone in attesa di un giudizio definitivo. Sono, letteralmente, imputati da
ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva, lo statuisce l’articolo 27 della
nostra veneranda Costituzione. Oltre 12mila persone attendono un giudizio di
primo grado. Tra questi c’era Scaglia, c’era Mazzitelli, la cui innocenza è
stata adesso certificata da una sentenza giudiziaria. L’operazione Broker scatta
il 23 febbraio 2010. Cinquantasei persone vengono arrestate nell’ambito di una
inchiesta su una maxi operazione di riciclaggio e frode fiscale internazionale
che coinvolgerebbe i vertici di Fastweb e Telekom Sparkle. Tra le misure
cautelari disposte dai magistrati romani, spicca il mandato di cattura per
Scaglia, che trovandosi all’estero noleggia un aereo privato e dalle Antille
atterra all’aeroporto romano di Fiumicino. I beni di Scaglia vengono posti sotto
sequestro preventivo e i carabinieri traducono l’imprenditore nel carcere di
Rebibbia, dove viene rinchiuso in una cella di otto metri quadrati al secondo
piano, sezione G11. In regime di isolamento giudiziario non può avere contatti
con nessuno, neppure col suo avvocato. Attende tre giorni per l’interrogatorio
di garanzia e oltre quaranta per rispondere alle domande dei suoi accusatori,
secondo i quali lui sarebbe membro di una associazione per delinquere
finalizzata alla frode fiscale e a dichiarazione infedele mediante l’uso di
fatture per operazioni inesistenti. Ora sono stati smentiti dai giudici. Ma
dietro le sbarre Scaglia trascorre tre mesi prima di ottenere gli arresti
domiciliari il 19 maggio 2010. In totale, collezionerà 363 giorni di detenzione
da innocente. Ancora oggi viene da chiedersi quali fossero le esigenze cautelari
nei confronti di un indagato, che non ricopriva più alcun incarico societario in
Fastweb e che era montato su un aereo per farsi oltre diecimila chilometri e
consegnarsi all’autorità giudiziaria italiana. Nei suoi confronti i giudici
hanno rigettato il teorema dipietresco del “non poteva non sapere”. Ecco, sì,
all’epoca dei fatti Scaglia era Presidente di Fastweb, ma poteva non sapere. Nel
dibattimento dati, prove e testimonianze hanno dimostrato che Scaglia non
sapeva, e neppure Mazzitelli sapeva. Si poteva evitare tutto questo? Che
giustizia è quella che tratta i cittadini come presunti colpevoli? Arresti
infondati, vite dilaniate e i riverberi economici di una vicenda che ha colpito,
tra gli altri, il guru italiano della New Economy, l’uomo che il “Time” nel 2003
aveva annoverato nella lista dei quindici manager tech survivors, profeti
dell’innovazione usciti indenni dalla bolla della New Economy. Ecco, della New
Economy ma non della giustizia made in Italy.
Nel 2010, quando il gip di
Roma ordina l’arresto di Silvio Scaglia, Stefano Parisi è amministratore
delegato di Fastweb, continua Annalisa Chirico su “Panorama”. A ventiquattro ore
dalla notizia dell’ordinanza di custodia cautelare, mentre Scaglia organizza il
suo rientro dalle Antille con un volo privato, Parisi decide di convocare una
conferenza stampa per spiegare urbi et orbi che Fastweb non ha commesso alcun
reato e che gli ipotetici fondi neri non esistono. “A distanza di tre anni e
mezzo posso dire che i giudici mi hanno dato ragione”. Parisi è stato solo
lambito dall’inchiesta Fastweb – Telecom Italia Sparkle. Destinatario di un
avviso di garanzia, la sua posizione è stata archiviata la scorsa primavera.
“Avrebbero potuto archiviare nel giro di quindici giorni, invece ci sono voluti
tre anni”. Ora che il Tribunale di Roma ha assolto l’ex presidente di
Fastweb Scaglia e altri dirigenti della società di telecomunicazioni, Parisi
prova un misto di soddisfazione e rabbia. “Mi chiedo perché accadano vicende
come questa in un Paese civile. Le vite di alcuni di noi sono state
letteralmente stravolte. La giustizia dovrebbe innanzitutto proteggere cittadini
e imprese, non rendersi responsabile di errori simili”. Perché di errori si
tratta. Quando nel 2007 su Repubblica compare il primo articolo da cui cui
filtrano informazioni riservate sulle indagini condotte dalla procura di Roma su
una presunta frode fiscale internazionale che coinvolgerebbe Fastweb, l’azienda
avvia immediatamente un audit interno per fare chiarezza. “A distanza di sei
anni una sentenza conferma quanto noi abbiamo sostenuto e provato sin
dall’inizio. Da quella analisi interna vennero fuori nel giro di un mese dati e
informazioni che noi trasmettemmo subito alla procura perché sin dall’inizio ci
fu chiaro che la truffa veniva ordita, con la complicità di due dirigenti
infedeli (ora condannati in primo grado per corruzione, ndr), ai danni di
Fastweb. Insomma noi eravamo la vittima di un raggiro che, come hanno
certificato i giudici, ha sottratto circa 50 milioni di euro alla nostra società
e 300 milioni a Tis”. Certo, dalle parole di Parisi trapela l’amarezza per
quello che si poteva evitare e invece non si è evitato. “Purtroppo la stessa
sentenza ha fatto chiarezza su un punto: c’erano dei delinquenti, che sono stati
condannati, e degli innocenti perseguitati dalla giustizia”.
Scaglia dopo l'assoluzione:
"Il carcere peggio di come lo raccontano".
L'imprenditore assolto con
formula piena dall'accusa di riciclaggio parla con Toberto Rho su “La
Repubblica” dell'anno trascorso in stato di detenzione, prima a Rebibbia poi
nella sua casa di Antagnod. "In cella meno spazio che per i maiali. Quel pm non
voleva cercare la verità, ma ora so che in Italia la giustizia funziona". Silvio
Scaglia, trecentosessantatré giorni, tre ore, trentacinque minuti, quaranta
secondi. Ovvero, "la battaglia più dura che ho combattuto nella mia vita, ma
sono contento di averla fatta e di non averla evitata, come avrei facilmente
potuto". Il counter del sito che amici e sostenitori hanno aperto durante il
periodo della sua detenzione per denunciarne pubblicamente l'assurdità, è ancora
fermo su quelle cifre, che misurano il periodo che Silvio Scaglia, uno dei
manager che hanno costruito il successo di Omnitel, l'imprenditore che è
diventato miliardario (in euro) durante il periodo della New economy grazie
all'intuizione di eBiscom-Fastweb, ha passato agli arresti. Prima a Rebibbia,
tre mesi, poi altri nove rinchiuso nella sua casa di Antagnod, in cima alla Val
d'Ayas, finestre affacciate sul gruppo del Monte Rosa. Le sue montagne, che però
non poteva guardare: "Nei primi tempi degli arresti domiciliari non mi potevo
affacciare, tantomeno uscire sul balcone, per disposizione dei giudici". Oggi
che è stato assolto con formula piena dall'accusa di associazione a delinquere
finalizzata a quella che la Procura definì "la più grande frode mai attuata in
Italia", Scaglia ripercorre l'anno più difficile della sua esistenza. A
cominciare da quella notte in cui, alle Antille per affari, rispose alla
telefonata della figlia, ventenne, che chiamava dalla loro casa di Londra. "Era
stata svegliata dagli agenti inglesi, avevano in mano un mandato di cattura. Per
noi era un mistero, non capivamo cosa stesse accadendo. Ho compreso la gravità
delle accuse solo quando ho letto l'ordine di arresto con i miei avvocati".
Ha deciso di rientrare in
Italia, subito.
«Sapevo
esattamente quel che mi aspettava appena scesa la scaletta dell'aereo, ma
immaginavo un'esperienza breve. Poche settimane, il tempo di spiegare che di
quella vicenda avevo già parlato in un interrogatorio di tre anni prima, che da
anni ero uscito da Fastweb, e che l'azienda e i suoi manager non erano gli
artefici, ma le vittime di quella frode».
Come fu quella notte in
volo tra i Caraibi e l'Italia, ingegner Scaglia?
«Presi
una pastiglia per dormire, per non pensare. L'incubo cominciò a Ciampino, era
notte fonda. Si rilegga i giornali di quei giorni, per capire quale era il peso
che mi sono trovato addosso, all'improvviso, quale era la tensione, la pressione
su di me e sulle aziende coinvolte».
Subito in carcere?
«Prima
una lunghissima procedura di identificazione e notifica dell'arresto. Poi
Rebibbia, in isolamento. Una cella lunga tre metri e larga uno e mezzo, il cesso
in vista, intendo in vista anche dall'esterno. Ero nel braccio dei delinquenti
comuni. Il carcere è un posto orribile, sporco, affollato all'inverosimile. C'è
meno spazio di quello che le leggi prevedono per gli allevamenti dei maiali».
Quale è la privazione più
dura?
«Più
ancora della libertà, delle umiliazioni, dello spazio che manca, è il senso di
impotenza, l'impossibilità di difendersi, di spiegare. Dopo cinque giorni di
isolamento, venne il giudice per l'interrogatorio cosiddetto di garanzia. Fu una
farsa. Poi, per due mesi, più nulla. Finalmente l'interrogatorio con il Pm: mi
sembrava di aver spiegato, di aver dimostrato con il mio ritorno dai Caraibi di
non aver alcun progetto di fuga, anzi il contrario. Quanto al possibile
inquinamento delle prove, si trattava di fatti avvenuti anni prima, in
un'azienda da cui ero uscito da anni. Invece, tornai in carcere. Quel Pm,
evidentemente, non aveva interesse a capire».
Poi gli arresti
domiciliari, un po' di respiro.
«Al
contrario. Fu il periodo più duro. Ero chiuso nella mia casa di Antagnod,
l'unica mia abitazione italiana, perché con la mia famiglia vivo da tempo a
Londra. Ero completamente solo, non potevo neppure uscire sul balcone, vedevo
solo la signora che mi procurava il cibo e la mia famiglia nel fine settimana.
Nove mesi così, senza potermi difendere».
Cosa le resta addosso, di
quell'anno?
«Certo
non la voglia di dimenticare. È stata un'esperienza troppo forte per me e per le
persone che mi vogliono bene. Semmai avverto l'urgenza di dire forte che queste
cose non dovrebbero più succedere».
Cosa pensa della giustizia,
oggi?
«Il
mio caso dimostra che la giustizia, in Italia, funziona. Io ho avuto giustizia.
Ma ci sono voluti troppo tempo e troppe sofferenze: il problema è la mancanza di
garanzie per chi è in attesa di giudizio. Vede, in carcere ho parlato con
tantissimi detenuti: la metà di loro erano in attesa di un processo. La metà
della metà risulteranno innocenti, come me».
Mai rimpianto quel viaggio
di ritorno dalle Antille a Roma, pendente un ordine di arresto, neppure nei
giorni più duri?
«Mai,
neppure per un secondo. Lo rifarei domattina. Era l'unico modo per reclamare la
mia innocenza e cancellare ogni possibile ombra. Fu proprio quella scelta a
rendere superflua ogni spiegazione alle persone che mi vogliono bene. La mia
famiglia, le mie figlie si sono fidate del loro padre, della sua parola, dei
suoi gesti. Non c'è stato bisogno d'altro».
Che ne è del Silvio Scaglia
"mister miliardo", l'imprenditore lungimirante e spregiudicato, uno dei dieci
uomini più ricchi e potenti d'Italia?
«Sono
sempre qui. Faccio ancora quel che so fare, cioè l'imprenditore, pochi mesi fa
ho acquistato un'azienda (La Perla, ndr). Certo, la mia reputazione ha subito
danni pesanti. Ancora oggi non posso andare negli Stati Uniti, se compilo il
modulo Esta mi negano il visto. Ma ad altri è andata peggio: vivendo a Londra,
per la mia famiglia è stato relativamente più facile mantenere il distacco
dall'onda di riprovazione che si accompagna ad accuse così gravi come quelle che
ho subito. E poi, ai miei coimputati è stato sequestrato tutto, hanno vissuto
per anni della generosità di amici e conoscenti».
Come vive le eterne
polemiche italiane sulla giustizia?
«Con
fastidio. Mi sembrano agitate strumentalmente per ottenere un vantaggio
politico, non per risolvere i problemi reali delle migliaia di persone che
vivono sulla loro pelle quel che ho vissuto io».
Ma il caso Fastweb (a
proposito così è stato conosciuto da tutti come se Telecom non ci fosse,
ingiustamente, anche lei) ha dimostrato in modo lampante come si debba ragionare
seriamente sul funzionamento della giustizia, scrive Nicola Porro su “Il
Giornale”. Le tesi dell'accusa (come ha denunciato un'altra vittima
dell'accanimento giudiziario, il generale Mario Mori) diventa immediatamente la
tesi della verità. I media non pensano, non riflettono, non investigano, copiano
gli atti dell'accusa. Gli indagati diventano subito colpevoli. Chiunque
conoscesse le carte della difesa, sarebbe stato in grado in un secondo di
verificare l'enormità dell'accusa. Ma andiamo oltre. Anche i pm hanno un obbligo
legale di ricercare la verità. Come hanno potuto aver avuto così poco buon senso
(sì sì certo, non c'è un articolo del codice che lo prevede) nell'applicare
misure cautelari così dure? Gli imputati sono stati tosti. Hanno resistito al
carcere e non hanno accettato sconti, patteggiamenti, ammissioni. Non sono
passati per la strada più facile. Hanno pagato un prezzo altissimo dal punto di
vista personale. Una piccola lezione, l'ennesima, ma forse la più clamorosa: una
persona, un'azienda, un processo non si giudica solo dalla carte dell'accusa. Ma
continuando a fare il nostro mestiere. Il processo Fastweb per il momento è
finito. Un terzo della nostra popolazione carceraria è dietro alle sbarre senza
una sentenza definitiva come Scaglia e soci. Forse prima dell'amnistia ci si
potrebbe occupare di questa mostruosità giuridica.
FACILE DIRE EVASORE FISCALE
A TUTTI I TARTASSATI. GIUSTO PER MANTENERE I PARASSITI. LA LOREN E MARADONA.
Per tutti coloro che del
giustizialismo fanno la loro missione di vita si deve rammentare la storia di
Sofia Loren che non doveva finire in carcere. La Cassazione dà ragione alla
Loren dopo 31 anni: "Non doveva finire in carcere". Dopo un iter giudiziario
di 31 anni, la Suprema Corte dà ragione all'attrice finita in carcere nel 1982:
l'attrice utilizzò correttamente il condono fiscale. Ha vinto
Sofia Loren. Giunge al capolinea, dopo quasi 40 anni, una delle
cause fiscali ancora aperte tra l’attrice due volte premio Oscar Sofia Loren -
nata Scicolone (sorella della madre di Alessandra Mussolini, nipote di Benito),
e rimasta tale all’anagrafe dei contribuenti - e l’ Agenzia delle Entrate. Dopo
una così lunga attesa, per una vicenda legata alla presentazione a reddito zero
del modello 740 della dichiarazione dei redditi del 1974, la Cassazione ha dato
ragione alla Loren concedendole, a norma di quanto previsto dal condono del
1982, di pagare le tasse solo sul 60% dell’imponibile non dichiarato e non sul
70% di quei 920 milioni di vecchie lire sottratti alla tassazione e, invece,
accertati dal fisco. Ma non è l'aspetto fiscale da tenere in considerazione, ma
come sia facile finire dentro, anche per i big non protetti dal Potere. Sophia
Loren aveva ragione e non doveva essere arrestata per evasione fiscale nel 1982.
Ha perso la giustizia, ancora una volta. Lo ha riconosciuto, definitivamente, la
Cassazione. A riconoscerlo, in maniera definitiva, dopo un iter giudiziario
durato 31 anni, è stata la Corte di Cassazione. La sezione tributaria della
Suprema Corte, con una sentenza depositata il 23 ottobre 2013, ha infatti
accolto il ricorso dell’attrice contro una decisione della Commissione
tributaria centrale di Roma risalente al 2006. L'attrice di Pozzuoli vince la
causa contro il fisco per una dichiarazione dei redditi del 1974, poi sottoposta
al condono 8 anni dopo. Il caso suscitò grande scalpore quando la stella del
cinema si consegnò alla polizia a Fiumicino per essere arrestata. Lei finì in
carcere 31 anni fa per 17 giorni con l'accusa di evasione fiscale. Il caso
suscitò grande scalpore dopo che l'attrice decise di consegnarsi alla polizia
all'aeroporto di Fiumicino di ritorno dalla Svizzera dove risiedeva con la
famiglia. Le responsabilità della frode vennero poi attribuite al suo
commercialista. Al centro del procedimento, la dichiarazione dei redditi per il
1974 che la Loren presentò, congiuntamente al marito Carlo Ponti, in cui si
escludeva, per quell’anno, «l’esistenza di proventi e spese», poiché «per i film
ai quali stava lavorando erano sì previsti compensi ma da erogarsi negli anni
successivi». Sofia Loren, nella dichiarazione dei redditi del 1974 presentata
congiuntamente al marito, aveva escluso - ricorda il verdetto della Cassazione -
«l’esistenza di proventi e spese per il detto anno e chiariva che per i film ai
quali stava lavorando erano sì previsti compensi ma da erogarsi negli anni
successivi al 1974, in quanto per gli stessi era stata concordata una
retribuzione pari al 50% dei ricavi provenienti dalla distribuzione dei film».
Il fisco non ci ha creduto ed è andato a scovare quel quasi miliardo non
dichiarato, tassato per poco più della metà del suo valore. Meno propensa
all’applicazione delle ganasce soft era stata la Procura della Suprema Corte,
rappresentata da Tommaso Basile, che aveva chiesto il rigetto del ricorso della
Loren. Nel 1980 all’attrice venne notificato un avviso di accertamento, per un
reddito complessivo netto assoggettabile all’Irpef per il 1974 pari a 922
milioni di vecchie lire (l’equivalente, valutando il potere d’acquisto che
avevano allora quei soldi, di oltre 5.345.000 di euro di oggi). La Loren,
dunque, usufruendo del condono fiscale previsto dalla legge 516/1982, aveva
presentato una dichiarazione integrativa facendo riferimento a un imponibile di
552 milioni di vecchie lire, pari al 60% del reddito accertato, ma il Fisco
aveva iscritto a ruolo un imponibile maggiore, pari a 644 milioni, sostenendo
che la percentuale da applicarsi fosse quella del 70%, poiché la dichiarazione
sul 1974 presentata dall’attrice, doveva considerarsi omessa, perché «priva
degli elementi attivi e passivi necessari alla determinazione dell’imponibile».
Le Commissioni di primo e secondo grado avevano dato ragione alla Loren, mentre
la Commissione tributaria centrale di Roma aveva dichiarato legittima la
liquidazione del condono con l’imponibile al 70%. Nonostante gli ermellini
abbiano sconfessato la pretesa dei giudici fiscali di secondo grado di Roma di
sottoporre a tassazione il 70% dei 920 milioni di lire non dichiarati nel 1974
(ossia di calcolare come imponibile 644 milioni anziché 552 milioni, come
sostenuto dai legali della Loren che si sono battuti per un imponibile pari al
60% della cifra evasa), nulla dovrà essere ridato all’attrice perché il fisco -
in questi tanti anni - le ha usato la cortesia di non chiederle quel 10% di
differenza in attesa della decisione della Cassazione. Oltre alla
certificazione, ora garantita dalla Suprema Corte, di aver presentato un condono
fatto bene, alla Loren rimane anche la soddisfazione di vedere addossate
all’Agenzia delle Entrate le spese legali dei suoi avvocati pari a settemila
euro. La Loren si è detta "felice" per il verdetto della Cassazione: "Finalmente
si chiude una storia che è durata quaranta anni". E Sophia commenta: «Il
miracolo della giustizia: quando non ci credi più trova un modo di ridarti
speranza. È una vicenda vecchia di 30 anni fa in cui ho avuto finalmente
ragione». Interviene anche l‘avvocato Giovanni Desideri che ha difeso Sophia
Loren nel ricorso in Cassazione: «È una vicenda kafkiana durata quaranta anni
quella vissuta dalla signora Loren, per di più per delle tasse correttamente
pagate: adesso la Cassazione ha reso, finalmente, il fisco giusto. Ma
l’amministrazione tributaria, senza arrivare a disturbare la Cassazione, avrebbe
potuto autocorreggersi da sola prendendo atto delle dichiarazioni in autotutela
presentate dalla contribuente Loren anni orsono!».
Forse si sarebbero lasciati
andare a qualche parola di più se non fossero ancora calde le polemiche sul
gesto dell’ombrello rivolto da Maradona al fisco: chi conosce la Loren - madrina
e testimonial di tanti eventi, dalle sfilate di moda al varo di navi da crociera
- sa che non ci tiene a finire in compagnia dell’ex pibe de oro nel novero di
chi si ritiene «vittima» delle tasse. Si sa in Italia: sono le stesse vittime di
ingiustizie che si rendono diverse dai loro disgraziati colleghi e se ne
distanziano. Questo perchè in Italia ognuno guarda ai cazzi suoi. Non si pensa
che si sia tutti vittime della stessa sorte e per gli effetti fare fronte comune
per combatterla. Intanto è polemica sulle dichiarazioni di Diego Armando
Maradona a Che tempo che fa. L'ex "pibe de oro" ha parlato dei propri
problemi fiscali e ha dichiarato: "Io non sono mai stato un evasore. Io non ho
mai firmato contratto, lo hanno fatto Coppola e Ferlaino che ora possono andare
tranquillamente in giro mentre a me hanno sequestrato l’orologio e l’orecchino,
tanti volevano transare per me con fisco per farsi pubblicità, ma io ho detto
no, io non sono un evasore, voglio andare in fondo. Equitalia si fa pubblicità
venendo da me, perché il loro lavoro non è Maradona. Io non mi nascondo". Poi il
gesto dell'ombrello rivolto a Equitalia. E ripartiamo dunque da Maradona che ha
fatto il gesto dell'ombrello a Equitalia «che mi vuole togliere tutto: tié».
Nessun commento da parte del conduttore Fabio Fazio. Il gesto invece non è
piaciuto al viceministro dell'Economia, Stefano Fassina: "È un gesto da
miserabile e credo che vada perseguito con grande determinazione, funzionari di
Equitalia hanno notificato nei giorni scorsi a Diego Armando Maradona un avviso
di mora da oltre 39 milioni di euro, stiamo parlando di quasi 40 milioni di
euro, farebbe bene a imparare a rispettare le leggi", ha tuonato l'esponente del
Pd a Mix 24 su Radio 24.
Diego Armando Maradona
e il gesto dell’ombrello contro Equitalia. Ma perché il Pibe de oro ha
reagito in modo così plateale e non educato durante la trasmissione di Fabio
Fazio? Una possibile motivazione la dà il quotidiano di Napoli, il Mattino.
Maradona sarebbe stato indispettito da quanto accaduto al suo arrivo in
Italia: appena sceso dall’aereo sarebbe stato “ispezionato” da un
funzionario di Equitalia per verificare se addosso avesse oggetti pignorabili
come orecchini, anelli o affini. Memore di quanto accaduto nel 2010, quando gli
fu sequestrato l’orecchino, Maradona si è presentato senza beni pignorabili. Ma
spiega il Mattino, la visita degli ispettori, avvenuta davanti alla figlia
Dalma e alla compagna Rocio, lo ha indispettito. E quindi, al sentir nominare
Equitalia, Diego ha risposto con l’ombrello. Diego Armando Maradona non ci sta.
Finito nel mirino di Equitalia, che lo accusa di aver evaso il
fisco per la cifra di 39 milioni di euro, l'ex calciatore argentino ha deciso di
reagire. E la controffensiva non si è limitata al gesto dell'ombrello verso
l'agenzia di riscossione italiana durante la trasmissione di Fabio Fazio, che
già di per se aveva smosso un marasma di polemiche. Il Pibe de Oro ha infatti
annunciato un'azione legale nei confronti dell'ente tributario.
La ragione? Gli agenti del fisco lo avrebbero perquisito al suo arrivo a
Ciampino "davanti al suo legale Angelo Pisano, alla figlia Dalma e alla compagna
Rocio", mettendogli le mani addosso per cercare presunti oggetti di valore da
poter sequestrare. La denuncia è per "ingiusta attività esecutiva degli organi
tributari". Un'offesa, un'umiliazione che il campione non ha
sopportato. Soprattutto dopo che Equitalia continua a pretendere soldi che in
realtà non sono giustificati sul piano sostanziale. Infatti, la contestazione -
notificata al calciatore argentino solo 11 anni dopo i fatti - riguarda un
eventuale mancato versamento al fisco dal 1985 al 1990 di 13 miliardi di lire,
pari a 6,7 milioni di euro. Quella cifra nel 2013 ammonterebbe a 11,4 milioni di
euro. I 28 milioni di euro in più che vengono pretesi da Equitalia sono la somma
di mora, interessi di mora e sanzioni.
Dopo il "tiè" al Fisco.
Maradona ha ragione: non è un evasore scrive Franco Bechis su “Libero
Quotidiano”. Diego non fece ricorso nel '94 contro la presunta frode
perché era all'estero: lo avrebbero scagionato. Il Fisco lo sa, ma non rinuncia
a sequestri e show. Diego Armando Maradona non ha evaso al fisco italiano i 39
milioni di euro che continuano a chiedergli. Questo è certo, perché nemmeno il
fisco italiano lo sostiene: la contestazione - notificata al calciatore
argentino solo 11 anni dopo i fatti - riguarda un eventuale mancato versamento
al fisco dal 1985 al 1990 di 13 miliardi di lire, pari a 6,7 milioni di euro.
Quella cifra nel 2013 ammonterebbe a 11,4 milioni di euro. I 28 milioni di euro
in più che vengono pretesi da Equitalia sono la somma di mora, interessi di mora
e sanzioni. E questo sarebbe un primo problema di equità per qualsiasi
contribuente, anche per Maradona. Ma anche sui 13 miliardi di lire dell’epoca il
fisco ha torto sul piano sostanziale e lo sa benissimo: per pretenderli ne fa
esclusivamente una questione di forma. Il gruppo di finanzieri e di «messi» di
Equitalia che notifica cartelle, avvisi di mora, e sequestra orecchini e orologi
a Maradona ogni volta che questo entra in Italia, sa benissimo di avere torto
sul piano sostanziale, anche se la forma consente questo show. Maradona è
innocente, ma non si è difeso nei tempi e nei modi consentiti: quando lo ha
fatto era troppo tardi, e la giustizia tributaria italiana non gli ha consentito
di fare valere le sue ragioni (conosciute e indirettamente riconosciute da altre
sentenze) perché era prescritta la possibilità di ricorrere e contestare le
richieste del fisco. Quello di Maradona così è uno dei rarissimi casi in cui la
prescrizione va a tutto danno dell’imputato. Il calciatore più famoso del mondo
è finito nel mirino del fisco insieme alla società calcistica per cui aveva
lavorato in Italia (il Napoli di Corrado Ferlaino), e a due giocatori
dell’epoca: Alemao e Careca. Il fisco ha emesso le sue cartelle esattoriali, e
la giustizia tributaria ha iniziato il suo processo quando Maradona era già
tornato in Argentina, dove avrebbe ancora giocato quattro anni. Conseguenza
naturale: le notifiche del fisco sono arrivate a chi era in Italia (Napoli
calcio, Alemao e Careca), e naturalmente non a chi era in Argentina, perché né
il fisco italiano né altri lo hanno comunicato laggiù. Il fisco si è lavato la
coscienza appendendo le sue cartelle all’albo pretorio di Napoli. Oggi
quell’albo è on line e in teoria uno che fosse curioso potrebbe anche guardarlo
dall’Argentina (ma perché mai dovrebbe farlo?). Allora no: per conoscere quelle
cartelle bisognava andare in comune a Napoli. Non sapendo nulla di quelle
cartelle (fra cui per altro c’erano anche alcune multe prese per violazione al
codice della strada), Maradona non ha potuto fare ricorso. Né conoscere il tipo
di contestazione che veniva fatta. Riassunto in breve. I calciatori allora come
oggi erano lavoratori dipendenti delle società per cui giocavano. Maradona,
Careca e Alemao erano dipendenti del Napoli. Che pagava loro lo stipendio e
fungeva da sostituto di imposta: tratteneva cioè l’Irpef dovuta per quei redditi
e la versava al fisco. Tutti e tre i giocatori (e molti altri in Italia) oltre
al contratto da dipendenti avevano anche una sorta di contratto ulteriore, con
cui cedevano alla società calcistica i propri diritti di immagine anche per
eventuali sponsorizzazioni e pubblicità. In tutti e tre i casi, come avveniva
all’epoca con i calciatori di tutto il mondo e in tutto il mondo, non erano i
calciatori ad incassare dal Napoli il corrispettivo di quei diritti, ma delle
società estere di intermediazione (tre diverse nel caso di Maradona), che poi
avrebbero dovuto dare ai giocatori gli utili di intermediazione. Secondo il
fisco italiano quei diritti in realtà erano stipendio extra per Alemao, Maradona
e Careca. Il Napoli quindi avrebbe dovuto versare al fisco trattenute simili a
quelle operate sugli stipendi base. Non avendolo fatto il Napoli, avrebbero
dovuto versare l’Irpef i singoli giocatori. Squadra di calcio, Alemao e Careca
fanno ricorso (Maradona no, perché non ne sa nulla): in primo grado hanno torto.
In secondo grado vedono riconosciute pienamente le loro ragioni, con una
sentenza che per Careca e Alemao verrà confermata dalla Cassazione. Il Napoli
calcio incassa la sentenza favorevole, ma quando la ottiene sta fallendo.
Preferisce non allungare i tempi: aderisce a un condono fiscale e sana tutto il
passato, pagando in misura ridotta anche l’Irpef che secondo le contestazioni
non era stata versata a nome di Alemao, Careca e Maradona. In teoria il caso
Maradona avrebbe dovuto considerarsi concluso con quel condono operato dal
sostituto di imposta. Ma il fisco va avanti. Si deve fermare davanti a Careca e
Alemao perché la sentenza tributaria di appello che verrà poi confermata prende
a schiaffoni quelli che sarebbero diventati Agenzia delle Entrate ed Equitalia.
La sentenza tributaria ricorda che in parallelo si era già svolto un processo
penale sulla stessa materia, e che il pm aveva proposto e il Gip accolto
l’archiviazione per Maradona, Alemao e Careca, escludendo «per tutti e tre i
calciatori che i corrispettivi versati agli sponsor fossero in realtà ulteriori
retribuzioni destinate ai calciatori». I giudici tributari poi accusano il fisco
italiano di avere preso un abbaglio: avevano accusato tutti sulla base di norme
che per altro sono entrate nel codice italiano con una legge di fine 1989:
quindi al massimo si poteva contestare qualcosa solo per il 1990, non potendo
essere retroattive le regole tributarie. Ma anche per il 1990 la contestazione
non era motivata: nessuna prova che quei diritti fossero cosa diversa e si
fossero trasformati in stipendi. Assolti e liberati dal fisco italiano dunque
sia Alemao che Careca. Maradona no, perché non aveva fatto ricorso. Quando ha
provato a farlo dopo la prima notifica del 2001, è stato respinto perché
tradivo. Quindi Maradona ha ragione, ma non può avere ragione perché la sua
ragione ormai è prescritta. Cose da azzeccagarbugli. Che però giustificano assai
poco lo show che il fisco mette in onda ogni volta che Maradona atterra in
Italia.
Maradona, l'avvocato su "La
Gazzetta dello Sport": "Stufo dell'Italia: lo trattino come qualsiasi
cittadino...". L'appello di Pisani, legale di Diego: "È un campione anche di
pignoramenti. E il bello è che alle multinazionali del gioco con debiti di 2
miliardi e mezzo fanno lo sconto, a lui tolgono l'orologio. L'ombrello? Totò
faceva la pernacchia..." L'ultima puntata del Maradona-show è un appello
accorato di Angelo Pisani via etere. "Faccio un appello ai politici affinchè
trattino Maradona come un qualsiasi cittadino", ha detto l'avvocato di Diego a
"Radio Crc". La visita in Gazzetta, Roma-Napoli all'Olimpico e l'intervista di
Fazio che ha scatenato le polemiche: Diego è andato via, l'onda lunga delle sue
parole è rimasta. "In Italia chi è innocente viene perseguitato e chi invece è
palesemente colpevole viene agevolato dalle leggi - spiega Pisani - Secondo
Equitalia, che all'epoca dei fatti non esisteva, e quindi non secondo i giudici
che hanno assolto il mio assistito, Maradona è responsabile di un'evasione di 6
milioni di euro e non 39 milioni, come appare sui giornali Quella cifra è la
somma di interessi che non rappresentano evasione fiscale. Il paradosso è che le
multinazionali del gioco e delle slot machine, del gioco d'azzardo, che hanno
accumulato un debito enorme, pari a 2miliardi e 500milioni di euro relativi a
tasse, concessioni e tributi non pagati, godranno di uno sconto. Pare che il
Governo abbia inserito, nella legge sull'IMU, un provvedimento relativo allo
sconto del 75% su questa somma enorme accumulata dalle multinazionali. È
responsabile per un cavillo, viene perseguitato ed è l'unica persona al mondo
alla quale viene sequestrato l'orologio e gli orecchini. Maradona è un campione
anche nei pignoramenti ed è quasi stufo dell'Italia". Sul gesto dell'ombrello,
definito "miserabile" da Fassina e mal valutato anche da Letta, Pisani ribatte:
"Si lamentano del gesto di Maradona, di satira, quasi di soddisfazione per non
essere vittima di un pignoramento ingiusto, per essere scampato da un agguato.
Maradona non voleva offendere nessuno. Totò addirittura faceva la pernacchia che
è un gesto goliardico, un gesto che fa parte dell'arte. Tra l'altro, se
guardiamo le immagini, il gesto di Maradona era rivolto a se stesso".
ANCHE GESU' E' STATO
CARCERATO.
Come non dare ragione al Papa.
Il Papa prega per i detenuti: "Facile punire i più deboli, i pesci grossi
nuotano". Il 23 ottobre 2013 prima dell'udienza generale il Pontefice ha
incontrato 150 cappellani delle carceri italiane. "Anche Gesù è stato un
carcerato". Poi rivela: "Chiamo spesso i reclusi di Buenos Aires". Il Papa ha
voluto "far arrivare un saluto a tutti i detenuti" nelle carceri italiane,
ricevendo i cappellani, prima dell'udienza generale che ha raccolto anche oggi
circa 100mila persone. Gremite, oltre a piazza San Pietro, anche piazza Pio XII
e le vie limitrofe, compreso il primo tratto di via Conciliazione. Il Pontefice
ha parlato a braccio toccando diversi argomenti. "È facile punire i più deboli,
mentre i pesci grossi nuotano" ha detto Bergoglio ai cappellani. "Ai detenuti -
ha aggiunto - potete dire che il Signore è dentro con loro. Nessuna cella è così
isolata da escludere il Signore". Anche il Signore è stato "carcerato dai nostri
egoismi, dai nostri sistemi, dalle tante ingiustizie. È facile punire i più
deboli, mentre i pesci grossi nuotano". Parlando a braccio durante l'udienza, il
Pontefice ha detto: "Recentemente avete parlato di una giustizia di
riconciliazione, ma anche una giustizia di speranza, di porte aperte, di
orizzonti, questa non è una utopia, si può fare, non è facile perché le nostre
debolezze sono dappertutto, il diavolo è dappertutto, ma si deve tentare". Il
Papa ha raccontato che spesso, soprattutto la domenica, telefona ad alcuni
carcerati a Buenos Aires e che la domanda che gli viene in mente è: "Perché lui
è lì e non io?". "Mi domando: perché lui è caduto e non io? Le debolezze che
abbiamo sono le stesse... È un mistero che ci avvicina a loro". Poi ha detto ai
cappellani di portare un messaggio da parte sua: "Ai detenuti, a nome del Papa,
potete dire questo: il Signore è dentro con loro. Nessuna cella è così isolata
da escludere il Signore, il suo amore paterno e materno arriva dappertutto". Il
fondamento evangelico. Gesù stesso si riconosce nel carcerato: "ho avuto fame e
mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero
e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato,
carcerato e siete venuti a trovarmi" (Mt.25,35-36). Gesù non giudica e non
condanna come fanno i tribunali delle nostre società civili. Egli muore tra due
ladri, non tra due innocenti condannati ingiustamente, e a uno dei due dice:
"Oggi sarai con me nel paradiso" (Lc 23,43). Gesù insegna a non giudicare e a
non condannare: "Non giudicate, per non essere giudicati…"(Mt.7,1).
ANCHE GLI STUDENTI SONO UNA
CASTA.
E poi ancora, neanche gli
studenti si salvano da questo marasma. Imparare ad essere Casta sin dalle
elementari. Pretendere presunti diritti e ignorare i sacrosanti doveri. Altro
che proteste, gli studenti sono una Casta iniziatica a future corporazioni:
magistrati, avvocati, notai, ecc. Costano molto più di quel che pagano, si
laureano dopo i 27 anni, non si muovono da casa. E non azzeccano una battaglia,
scrive Filippo facci su “Libero Quotidiano. Non è un Paese per studenti, questo:
a meno che siano svogliati, viziati, rammolliti dalla bambagia familiare, cioè
bamboccioni, iper-protetti dal familismo e da un welfare schizofrenico. Allora
sì, ecco che questo diventa un Paese per studenti: purché siano quelli che
sfilavano nel corteo romano, sabato, col fegato di sostenere che «gli stanno
rubando il futuro», quelli che il governatore di Bankitalia Ignazio Visco ha
sconsigliato dal laurearsi perché avrebbero meno probabilità di trovare lavoro,
quelli che hanno scambiato la condizione studentesca per un parcheggio
post-puberale, quelli, insomma, ai quali potete anche dirlo: che sono una
casta. Loro rimarranno di sale, li farete imbestialire, ma lo sono e lo restano.
Lo sono perché lo Stato gli chiede soltanto mille o duemila euro l’anno di tasse
universitarie, mentre ne costano - allo stesso Stato - una media di settemila:
soldi a carico nostro, della fiscalità generale, soldi pagati anche da chi
magari i figli all’università non ce li può mandare, magari perché non può,
perché non ce la fa. Una casta è proprio questo: il privilegio di una minoranza
a spese di una maggioranza. Ma voi provate a dirglielo. Provate a
spiegarglielo. Provate a spiegare a tanti coccolatissimi giovani, che per
definizione hanno sempre ragione, che da una quarantina d’anni non hanno
azzeccato una battaglia che sia una, spesso rincoglioniti dalla cultura bipolare
e catastrofista dei loro cattivissimi maestri sessantottini: dediti,
quest’ultimi, a condire il loro progressivo accomiatarsi con profezie di
sciagura che hanno trasformato ogni futuro in un funerale sociale, ambientale,
economico e tecnologico. Provate a dirglielo senza che vi saltino addosso: loro,
i loro genitori e ovviamente la stampa conformista. Provate a dirgli che l’ex
ministro Elsa Fornero, quando diceva che i giovani non devono essere schizzinosi
all’ingresso nel mondo del lavoro, aveva ragione e basta. Provate a dirgli che
Annamaria Cancellieri, quando parlò degli italiani «mammoni», aveva ragione pure
lei, o, peggio, che ce l’aveva anche l’ex viceministro Michel Martone quando
disse che un 28enne non ancora laureato è spesso uno sfigato. Oh certo, un
laureato italiano resta sfigato a qualsiasi età, molte volte: perché manca il
lavoro, perché la scuola non forma, e poi certo, perché un sacco di giovani si
chiudono nelle università anche per prolungare una sorta di anticamera della
vita reale, sfuggendo ogni minimo approccio col mondo del lavoro. Sta di fatto
che gli studenti lavoratori in Italia restano una minoranza: c’è poco da
sproloquiare. Da noi ci si laurea in media dopo i 27 anni quando in Europa non
si arriva ai 24, con un mercato che ormai è senza confini e rende i giovani
italiani dei potenziali ritardatari agli appuntamenti che contano. A sostenerlo
ci sono tutti i dati del mondo, e il governatore di Bankitalia l’ha detto
chiaro: il livello di istruzione dei nostri giovani è ancora ben distante da
quello degli altri Paesi avanzati, c’è dispersione scolastica, un laureato
italiano ha meno possibilità di trovare lavoro di un diplomato, c’è una
percentuale spaventosa di analfabetismo funzionale e cioè un’incapacità diffusa,
in sostanza, di usare efficacemente la lettura e la scrittura e il calcolo nelle
situazioni quotidiane. Ma dire questo, politicamente, non serve: ci sono animi
da non frustrare - ti spiegano. Teniamoci dunque la patetica casta degli
studenti, questi poveracci che siamo riusciti a rovinare con la scusa di
proteggerli. Non diciamogli che sono gli studenti con meno mobilità al mondo
(l’80 per cento è iscritto nella regione di residenza) e che spesso la facoltà
viene scelta secondo la distanza da casa, anche perché cinque giovani su dieci,
dai 25 ai 34 anni, vivono ancora coi genitori. Non diciamogli che quello
sciagurato e falso egualitarismo chiamato «valore legale del titolo di studio»
ha prodotto milioni di false illusioni perché un pezzo di carta non insegna un
lavoro né ti aiuta davvero a trovarlo, se nel frattempo non l’hai imparato e non
hai capito che una professione e un’emancipazione non sono regali, non sono
diritti, non sono pezzi di carta: sono una durissima conquista.
QUANTO SONO ATTENDIBILI LE
COMMISSIONI D’ESAME?
Ogni anno a dicembre c’è un
evento che stravolge la vita di molte persone. Il Natale? No! L’esame di
avvocato che si svolge presso ogni Corte di Appello ed affrontato da decine di
migliaia di candidati illusi.
La domanda sorge spontanea:
c’è da fidarsi delle commissioni dei concorsi pubblici o degli esami di Stato?
«Dai dati emersi da uno studio
effettuato: per nulla!». Così opina Antonio Giangrande, lo scrittore, saggista e
sociologo storico, che sul tema ha scritto un libro “CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI.
L’Italia dei concorsi e degli esami pubblici truccati” tratto dalla collana
editoriale “L’ITALIA DEL TRUCCO, L’ITALIA CHE SIAMO”.
E proprio dalle tracce delle
prove di esame che si inizia. Appunto. Sbagliano anche le tracce della Maturità.
“Le parole sono importanti”, urlava Nanni Moretti nel film Palombella Rossa
alla giornalista che, senza successo, provava a intervistarlo. E’ proprio dalla
commissione dell’esame di giornalismo partiamo e dalle tracce da queste
predisposte. Giusto per saggiare la sua preparazione. La commissione è quella ad
avere elaborato le tracce d’esame. In particolare due magistrati (scelti dalla
corte d’appello di Roma) e cinque giornalisti professionisti. Ne dà conto il
sito de l’Espresso, che pubblica sia i documenti originali consegnati ai
candidati, sia la versione degli stessi per come appare sul sito dell’Ordine,
cioè con le correzioni (a penna) degli errori. Ossia: “Il pubblico ministero
deciderà se convalidare o meno il fermo”. Uno strafalcione: compito che spetta
al giudice delle indagini preliminari. Seguono altre inesattezze come il cognome
del pm (che passa da Galese a Galesi) e una citazione del regista Carlo Lizzani,
in cui “stacco la chiave” diventa “stacco la spina”.
Sarà per questo che Indro
Montanelli decise di non affrontare l’esame e Milena Gabanelli di non
riaffrontarlo? Sarà per questo che Paolo Mieli è stato bocciato? E che dire di
Aldo Busi il cui compito respinto era considerato un capolavoro e ricercato a
suon di moneta? È in buona compagnia la signora Gabanelli & Company. Infatti si
racconta che anche Alberto Moravia fu bocciato all’esame da giornalista
professionista. Poco male. Sono le eccezioni che confermano la regola. Non sono
gli esami giudicate da siffatte commissioni che possono attribuire patenti di
eccellenza. Se non è la meritocrazia ha fare leva in Italia, sono i mediocri
allora a giudicare. Ed a un lettore poco importa sapere se chi scrive ha
superato o meno l'esame di giornalismo. Peccato che per esercitare una
professione bisogna abilitarsi ed anche se eccelsi non è facile che i mediocri
intendano l'eccellenza. L’esperienza e il buon senso, come sempre, sono le
qualità fondamentali che nessuno (pochi) può trasmettere o sa insegnare. Del
resto, si dice che anche Giuseppe Verdi fu bocciato al Conservatorio e che
Benedetto Croce e Gabriele D’Annunzio non si erano mai laureati.
Che dire delle Commissioni di
esame di avvocato. Parliamo della sessione 2012. Potremmo parlarne per le
sessioni passate, ma anche per quelle future: tanto in questa Italia le cose
nefaste sono destinate a durare in eterno.
A Lecce sarebbero solo 440 su
1258 i compiti ritenuti validi. Questo il responso della Commissione di Catania,
presieduta dall’Avvocato Antonio Vitale, addetta alla correzione degli
elaborati. Più di cento scritti finiscono sul tavolo della Procura della
Repubblica con l’accusa di plagio, per poi, magari, scoprire che è tutta una
bufala. Copioni a parte, sarebbe, comunque, il 65% a non superare l’esame:
troppi per definirli asini, tenuto conto che, per esperienza personale, so che
alla fase di correzione non si dedicano oltre i 5 minuti, rispetto ai 15/20
minuti occorrenti. Troppo pochi per esprimere giudizi fondati. Oltretutto
l’arbitrio non si motiva nemmeno rilasciando i compiti corretti immacolati.
Prescindendo dalla caccia
mirata alle streghe, c’è forse di più?
Eppure c’è chi queste
commissioni li sputtana. TAR Lecce: esame forense, parti estratte da un sito?
Legittimo se presenti in un codice commentato. È illegittimo l’annullamento
dell’elaborato dell’esame di abilitazione forense per essere alcune parti
estratte da un sito, se tali parti sono presenti all’interno di un codice
commentato. (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione
Prima, Ordinanza 19 settembre 2013, n. 465).
E’ lo stesso Tar Catania che
bacchetta la Commissione d’esame di Avvocato della stessa città Esame di
avvocato...Copiare non sempre fa rima con annullare - TAR CATANIA ordinanza n.
1300/2010. Esame avvocato: Qualora in sede di correzione dell'elaborato si
accerta che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro elaborato o da
qualche manuale, per condurre all’annullamento della prova, deve essere esatto e
rigoroso. Tale principio di diritto è desumibile dall’ordinanza in rassegna n.
1300/2010 del TAR Catania che ha accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso
principale avanzata avverso la mancata ammissione del ricorrente alla prova
orale dell’esame di avvocato. In particolare, per il Tar etneo “il ricorso
appare fondato, in quanto la Commissione si è limitata ad affermare
apoditticamente che il compito di diritto penale della ricorrente conteneva
“ampi passi del tutto identici all’elaborato di penale contenuto” in altra busta
recante il n. 459 senza alcuna specificazione, anche sul compito, che consenta
di appurare che questa presunta “identità” vada oltre la semplice preparazione
sui medesimi testi, o la consultazione dei medesimi codici”. Per il TAR
siciliano, inoltre, “l’elaborato di penale del candidato contraddistinto dal
n. 459 era stato corretto da una diversa sottocommissione durante la seduta del
19 marzo 2010, e tale elaborato non risulta essere stato parimenti annullato”.
E a sua volta è la stessa
Commissione d’esame di Avvocato di Lecce ad essere sgamata. Esami di avvocato.
Il Tar di Salerno accoglie i ricorsi dei bocciati. I ricorsi accolti sono già
decine, più di trenta soltanto nella seduta di giovedì 24 ottobre 2013,
presentati da aspiranti avvocati bocciati alle ultime prove scritte da un
giudizio che il Tar ha ritenuto illegittimo in quanto non indica i criteri sui
cui si è fondato. Il Tribunale amministrativo sta quindi accogliendo le domande
cautelari, rinviando al maggio del 2014 il giudizio di merito ma indicando, per
sanare il vizio, una nuova procedura da affidare a una commissione diversa da
quella di Lecce che ha deciso le bocciature. Il numero dei bocciati, reso noto
lo scorso giugno 2013, fu altissimo. Soltanto 366 candidati, su un totale di
1.125, passarono le forche caudine dello scritto e furono ammessi alle prove
orali. Una percentuale del 32,53: quasi 17 punti in meno del 49,16 registrato
alla sessione dell’anno precedente. Numeri, questi ultimi, in linea con una
media che, poco più o poco meno, si è attestata negli ultimi anni
sull’ammissione della metà dei partecipanti. Nel 2012, invece, la ghigliottina è
caduta sul 64,09 per cento degli esaminandi. In numeri assoluti i bocciati
furono 721, a cui vanno aggiunti i 38 compiti (3,38 per cento) annullati per
irregolarità come il rinvenimento di svolgimenti uguali. Adesso una parte di
quelle persone ha visto accogliere dal Tar i propri ricorsi. I criteri usati dai
commissari per l’attribuzione del punteggio, hanno spiegato i giudici, «non si
rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle
ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della
Sottocommissione locale». La valutazione, quindi, «deve ritenersi
l'illegittima».
Che ne sarà di tutti coloro
che quel ricorso non lo hanno presentato. Riproveranno l’esame e, forse, saranno
più fortunati. Anche perché vatti a fidare dei Tar.
Ci si deve chiedere: se il
sistema permette da sempre questo stato di cose con il libero arbitrio in tema
di stroncature dei candidati, come mai solo il Tar di Salerno, su decine di
istituzioni simili, vi ha posto rimedio?
Esami di Stato: forche
caudine, giochi di prestigio o giochi di azzardo? Certo non attestazione di
merito.
Sicuramente nell’affrontare
l’esame di Stato di giornalismo sarei stato bocciato per aver, questo articolo,
superato le 45 righe da 60 caratteri, ciascuna per un totale di 2.700 battute,
compresi gli spazi. Così come previsto dalle norme.
Certamente, però, si leggerà
qualcosa che proprio i giornalisti professionisti preferiscono non dire: tutte
le commissioni di esame sono inaffidabili, proprio perché sono i mediocri a
giudicare, in quanto in Italia sono i mediocri a vincere ed a fare carriera!
LO STATO CON LICENZA DI
TORTURARE ED UCCIDERE.
"Licenza di tortura". Ilaria Cucchi. La famiglia
di Federico Aldrovandi, Aldo Bianzino, Riccardo Rasman. La nipote di Franco
Mastrogiovanni. Parenti e amici di persone picchiate o uccise da forze
dell'ordine, guardie penitenziarie, medici. La giovane fotografa Claudia Guido
ha deciso di immortalare i loro volti. Per mostrare che potrebbe succedere ad
ognuno di noi, scrive Francesca Sironi su “L’Espresso”. Rudra Bianzino
indossa una giacca blu, ha le mani in tasca, sullo sfondo le colline di Perugia.
Suo padre, Aldo, è morto in carcere cinque anni fa. Era entrato in ottima
salute. È uscito due giorni dopo in una bara. L'unica certezza che Rudra e i
suoi fratelli hanno avuto dal processo, finora, è che il padre si sarebbe potuto
salvare, se qualcuno avesse ascoltato le sue urla di dolore. Ma la guardia
carceraria ch'era servizio non ha chiamato i soccorsi. Per questo l'agente è
stata condannato a un anno e mezzo di reclusione: ma in carcere non ci andrà
perché la pena è sospesa. Quella di Aldo Bianzino e dei suoi figli è una delle
undici storie raccontate attraverso i ritratti dei parenti e dei “sopravvissuti”
da Claudia Guido, giovane fotografa padovana che li ha raccolti in una mostra
itinerante intitolata “ Licenza di tortura ”. Un progetto che, spiega l'autrice,
è diventato anche una forma di protesta: «Per due anni ho vissuto con queste
famiglie. Ho conosciuto le loro battaglie, lo sconforto, la difficoltà di
arrivare non dico a una sentenza, alla punizione dei colpevoli, ma anche
semplicemente al processo: che costa tanto, economicamente ed emotivamente. Con
loro ho conosciuto anche la tortura quotidiana dell'abbandono e delle parole di
chi accusa, deride o rilegge le loro storie senza pensare alla sofferenza che
provano intere famiglie». Gli scatti della Guido sono frontali, scarni, senza
forzature: «Non ho aggiunto elementi distintivi, non ho associato ai ritratti le
immagini agghiaccianti delle vittime che abbiamo visto sui giornali», spiega
l'autrice: «Perché quello che vorrei trasmettere è il sentimento che ho provato
io stessa leggendo queste storie sui quotidiani: l'idea che quelle violenze
sarebbero potute capitare a me. Quando mia madre ha visto la foto di Patrizia
Moretti ha detto: “Potrei essere io”». Lucia Uva - sorella di Giuseppe. La notte
tra il 13 e il 14 luglio 2008 Giuseppe Uva rimase per tre ore nella caserma dei
carabinieri di Varese. Da lì fu trasferito in ospedale, dove morì. Il giudice di
primo grado, Orazio Muscato, ha scritto che le cause del decesso andrebbero
individuate "in una tempesta emotiva legata al contenimento, ai traumi auto e/o
etero prodotti, nonché all'agitazione da intossicazione alcolica acuta". Se ha
assolto i medici, il tribunale ha stabilito però che "permangono ad oggi ignote
le ragioni per le quali Giuseppe Uva, nei cui confronti non risulta esser stato
redatto un verbale di arresto o di fermo, mentre sarebbe stata operata una
semplice denuncia per disturbo della quiete pubblica, è prelevato e portato in
caserma, così come tutt'ora sconosciuti rimangono gli accadimenti intervenuti
all'interno della stazione dei carabinieri di Varese (certamente concitati, se è
vero che sul posto confluirono alcune volanti di polizia) ed al cui esito Uva,
che mai in precedenza aveva manifestato problemi di natura psichiatrica, verrà
ritenuto necessitare di un intervento particolarmente invasivo quale il
trattamento sanitario obbligatorio". Patrizia Moretti, la madre di Federico
Aldrovandi , ucciso di botte da quattro poliziotti la notte del 25 settembre
2005, è stata uno dei primi contatti della ventinovenne padovana. Poi sono
arrivati il padre e il fratello di Federico, insieme alle altre vittime che ora
stanno girando per tutta Italia : la mostra arriverà a breve anche a Roma e a
Milano. «Dopo undici casi mi son dovuta fermare: ero troppo coinvolta. Ma non
escludo la possibilità di continuare: l'argomento è purtroppo sempre attuale».
Nel frattempo, dall'aprile del 2011, la Guido ha portato davanti al suo
obiettivo Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano , morto dopo esser stato
arrestato, picchiato, e lasciato senza cure il 22 ottobre del 2009; la famiglia
di Riccardo Rasman, il giovane con problemi psichici immobilizzato, colpito e
asfissiato da tre agenti, a casa sua, il 27 ottobre del 2006; un sopravvissuto
come Paolo Scaroni , il tifoso che nel 2005 finì in coma per le manganellate
della polizia e dal suo risveglio ha avviato una battaglia legale per
individuare i colpevoli; o come Stefano Gugliotta, menato da uomini in divisa il
5 maggio del 2010 e salvatosi da una condanna per “resistenza a pubblico
ufficiale” solo grazie ai video girati col cellulare dagli abitanti della zona.
Nella mostra ci sono poi Grazia Serra, nipote di Franco Mastrogiovanni , il
maestro morto il 4 agosto 2009 in un reparto psichiatrico dell'ospedale di Vallo
della Lucania, dopo esser rimasto per ore legato a un letto senza cure né acqua.
Si sono fatti ritrarre anche il padre, la madre e la sorella di Carlo Giuliani ,
il ragazzo di 23 anni ucciso da un proiettile della polizia il 20 luglio 2001
durante le contestazioni del G8 di Genova ; la figlia di Michele Ferrulli , il
51enne morto d'infarto mentre veniva arrestato il 30 giugno del 2011; Luciano
Isidro Diaz , fermato la notte del 5 aprile del 2009 mentre guidava troppo forte
e reso vittima di lesioni così gravi da causargli la perforazione di un timpano
e il distacco della retina; e infine la sorella e il migliore amico di Giuseppe
Uva , l'uomo morto in ospedale dopo esser stato trattenuto per tre ore nella
caserma dei carabinieri di Varese. Ci sono i volti di tutti loro. Che
interrogano, per primo, lo Stato. Perché non lasci ripetere quelle violenze.
E LA CHIAMANO GIUSTIZIA. CHE CAZZO DI INDAGINI
SONO?
Il perito non capisce il dialetto: tre
anni in cella da innocenti. A causa di intercettazioni
mal interpretate due fratelli pugliesi vengono scambiati per mafiosi e sbattuti
in carcere. Ora chiedono allo Stato un milione di risarcimento, scrive
Peppe Rinaldi su “Libero Quotidiano”. In Italia puoi essere sbattuto
dentro e restarci tre anni perché il consulente incaricato di analizzare le
intercettazioni è di Bologna e, non capendo il dialetto delle tue parti,
interpreta fischi per fiaschi. In Italia puoi esser agguantato d’improvviso
insieme a tuo fratello perché «promotori di un sodalizio mafioso» che ti costerà
36 e passa mesi di cella. È possibile questo e pure altro, tanto non accadrà
nulla a nessuno: tranne che a te, alla tua famiglia e al tuo lavoro. Vecchia
storia, solita storia. La stessa capitata ai fratelli Antonio e Michele Ianno,
di San Marco in Lamis (Foggia) che un bel mattino si sono visti ammanettare
dalla Dda di Bari. Saranno detenuti «cautelarmente» tre anni uno e tre anni e
mezzo l’altro, salvo accorgersi poi che non c’entravano niente, che quel clan
non l’avevano mai costituito e che il duplice omicidio in concorso di cui erano
accusati non lo avevano compiuto. E neppure un altro tentato omicidio, il porto
d’armi illegale, niente di niente. Insomma, si trattava di un gigantesco
abbaglio giudiziario. Nel giugno del 2004 il gip del tribunale di Bari firma la
richiesta di custodia cautelare del pm della Dda per Antonio e Michele Ianno,
poco meno che 40enni all’epoca, di professione «mastri di cantiere», cioè
piccoli imprenditori edili formatisi a botte di secchi di calce sulle spalle.
Sono considerati promotori di una compagine malavitosa facente capo alle
famiglie Martino-Di Claudio, operante nel contesto della così detta mafia
garganica. Associazione mafiosa (il “mitico” art. 416 bis), concorso in tentato
omicidio e in duplice omicidio, porto illegale di armi, il tutto con
l’aggravante di voler favorire i clan. Una gragnuola di accuse da svenire solo a
leggerne i capi d’imputazione, un fulmine che incendia la vita dei due. E non
solo. La difesa, rappresentata dal prof. avv. Giuseppe Della Monica, prova a
spiegare che stavano prendendo un granchio ma quando le cose prendono una certa
piega raddrizzarle è impresa titanica. Sarà così tutto un crescendo di ricorsi e
controricorsi, un supplizio di “calamandreiana” memoria. In queste storie, in
genere o c’è un «pentito» che si ricorda di te oppure, intercettando a strascico
in una certa area sensibile, si rischia di scambiare lucciole per lanterne. Se
di sbagliato poi c’è anche la relazione di un consulente del pm che - chissà
perché scovato a Bologna - fraintende il dialetto pugliese ecco che la faccenda
si complica, fino a farsi kafkiana grazie a un’altra ordinanza che colpirà i
fratelli, per giunta per gli stessi reati più un’estorsione che prima non c’era:
un modo come un altro per mandare a farsi benedire il ne bis in idem. Negli atti
si legge un po’ di tutto oltre al sangue versato: appalti del comune di San
Marco in Lamis di esclusivo appannaggio degli Ianno mentre invece l’ente
attesterà che non era vero esibendo l’elenco delle opere pubbliche; oppure il
pericolo di fuga a giustificazione dell’arresto: per la Dda i due s’erano dati
alla macchia per evitare lo Stub (il guanto di paraffina) ma la difesa riuscirà
a provare che non era così perché un vigile urbano li aveva identificati su un
cantiere per le proteste di un vicino disturbato dai rumori proprio il giorno
del reato contestato. Siamo nel 2006, due anni sono già trascorsi intanto. La
seconda ordinanza viene annullata totalmente in udienza preliminare e il giudice
ordina la scarcerazione «se non detenuto per altro motivo». L’altro motivo,
però, c’era ed era la prima ordinanza, i cui effetti erano ancora in itinere
dinanzi alla Corte d’Assise di Foggia. Per farla breve, i giudici alla fine si
accorgeranno dell’errore della procura e scarcereranno prima Michele e poi
Antonio, a distanza di sei mesi uno dall’altro. Inutile dire delle conseguenze
dirette ed indirette patite. Risultato? Lo stato prepari un bell’assegno
circolare da un milione di euro: tanto hanno chiesto nel 2010 - quando tutto è
passato in giudicato - cioè il massimo previsto dalla legge (500mila euro
cadauno) per tanta gratuita tragedia. Ovviamente ancora aspettano.
Ed ancora. Correva l’anno 2006. Il 29 settembre,
per l’esattezza, scrive di Walter Vecellio su “Libero Quotidiano”.
Il luogo: Ruvo del Monte, comune, informano i manuali di geografia, in
provincia di Potenza, «situato a 638 metri sul livello del mare, nella zona Nord
Occidentale della Basilicata, ai confini con l’Irpinia». A Ruvo del Monte vivono
circa milleduecento persone; è da credere si conoscano tutti. E più di tutti, i
locali carabinieri, che con il locale sacerdote, evidentemente sono a conoscenza
di tutto quello che accade, si fa, si dice. Dovrebbero, si suppone, anche
conoscere due fratelli gemelli, Domenico e Sebastiano. Dovrebbero conoscerli
bene, perché in paese non deve certo essere sfuggito il fatto che patiscono
gravi ritardi mentali. Quando il 29 settembre del 2006 i carabinieri, frugando
nella casa dei due fratelli trovano una rivoltella, hanno evidentemente fatto il
loro dovere, sequestrandola. Ed è quello che prescrive la legge, quando viene
redatto un rapporto che riassume l’accusa in un paio di righe: «Detenzione
illegale di arma». I carabinieri si suppone conoscano le armi; se sostengono che
si tratta di una pistola fabbricata prima del 1890, si suppone sappiano quello
che dicono. E cosa si fa, in casi del genere? Si istruisce un processo; un
processo per detenzione di arma illegale che si conclude nel 2012. La sentenza:
«Non luogo a procedere». E come mai, nel 2006 la detenzione illegale di arma
sei anni dopo diventa «non luogo a procedere»? Come mai, nei fatti e in
concreto, il giudice di Melfi assolve pienamente i due fratelli? Perché la
pistola non è una pistola; perché non si può detenere illegalmente un’arma che
non è un’arma. Perché la pistola che si diceva «fabbricata prima del 1890» in
realtà è una pistola giocattolo. I due fratelli l’avevano detto con tutto il
fiato che avevano in gola: «Non è un’arma, è un giocattolo». Niente da fare.
«Detenzione di arma illegale». Bastava guardarla, quell’«arma illegale»: «Si
vedeva subito che era finta, con quella foggia bizzarra che ricalca quelle
strette alla cintura dei conquistadores spagnoli del ‘500». Per i carabinieri
era «un’arma illegale». I carabinieri come mai erano entrati a casa dei due
fratelli? Cercavano oggetti sacri rubati al cimitero del paese. Qui si può
immaginare la scena: chi può introdursi in un cimitero per rubare? Degli
spostati. E in paese, tutti lo sanno, i due fratelli con la testa non ci sono
del tutto. Allora andiamo da loro. Si bussa alla porta, loro aprono. «Si può?».
«Prego, accomodatevi». Ecco. E lì, in bella vista «l’arma illegale». Subito in
caserma, per l’interrogatorio di rito. Poi l’avviso di garanzia. Passano i
giorni, le settimane e i mesi, e arriva l’imputazione: articolo 687 del codice
di procedura penale, che punisce appunto la detenzione illegale di armi: dai tre
ai dodici mesi, 371 euro di ammenda. Si chiudono le indagini preliminari, c’è il
rinvio a giudizio. Finalmente qualcuno pensa di rivolgersi a un perito.
Naturalmente è l’avvocato dei due fratelli, non ci pensano né i carabinieri né
il Pubblico Ministero. Racconta l’avvocato: «All’apertura della busta contenente
la presunta arma idonea a offendere, presenti io, il giudice e il perito tutto
si è risolto in una risata. Non c’è stato nemmeno bisogno di una analisi
approfondita: una colata unica, un simulacro da bancarella».
Ed Ancora. "Aspettavo questo momento da 36 anni".
Giuseppe Gulotta, accusato ingiustamente di essere l'autore del duplice omicidio
dei carabinieri Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta, avvenuto nella casermetta
di Alcamo Marina il 27 gennaio 1976, lascia da uomo libero il tribunale di
Reggio Calabria dove dopo esattamente 36 anni dal giorno del suo arresto (21 gli
anni trascorsi in cella) è stato dichiarato innocente. Un nuovo macroscopico
caso di malagiustizia, scrive “Libero Quotidiano”. Alla lettura della sentenza,
al termine del processo di revisione che si è svolto a Reggio Calabria, Gulotta
è scoppiato in lacrime, insieme alla sua famiglia. Accanto a lui c'erano gli
avvocati Baldassarre Lauria e Pardo Cellini che lo hanno assistito durante
l'iter giudiziario. "Spero - ha dichiarato l'uomo parlando con i giornalisti -
che anche per le famiglie dei due carabinieri venga fatta giustizia. Non ce
l’ho con i carabinieri - ha precisato - solo alcuni di loro hanno sbagliato in
quel momento". Giuseppe Gulotta, nonostante la complessa vicenda giudiziaria che
lo ha portato a subire nove processi più il procedimento di revisione, non ha
smesso di credere nella giustizia. "Bisogna credere sempre alla giustizia. Oggi
è stata fatta una giustizia giusta", ha però aggiunto. Un ultimo pensiero va
all’ex brigadiere Renato Olino, che con le sue dichiarazioni ha permesso la
riapertura del processo: "Dovrei ringraziarlo perché mi ha permesso di
dimostrare la mia innocenza però non riesco a non pensare che anche lui ha
fatto parte di quel sistema". Il 26 gennaio 1976 furono trucidati i carabinieri
Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo. Ad accusare Gulotta della strage fu
Giuseppe Vesco, considerato il capo della banda, suicidatosi nelle carceri di
San Giuliano a Trapani, nell'ottobre del 1976 (era stato arrestato a febbraio).
Gulotta, in carcere per 21 anni, dal 2007 godeva del regime di semilibertà nel
carcere di San Gimignano (Siena). Venne arrestato il 12 febbraio 1976 dai
militari dell'Arma dopo la presunta confessione di Vesco. Nel 2008 la procura di
Trapani ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di sequestro di
persona e lesioni aggravate alcuni carabinieri, oggi in pensione, che nel 1976
presero parte agli interrogatori degli accusati della strage di Alcamo Marina:
il reato contestato agli agenti è quello di tortura nei confronti degli
interrogati.
Dall’altra parte ci troviamo al paradosso. Il
killer ha confessato 30 delitti e ha fatto luce su altri 50. Pentitosi di essere
diventato un collaboratore di giustizia ha ricominciato dedicandosi allo spaccio
di droga. Per questo era stato riammanettato e condannato a 20 anni di galera,
scrive Peppe Rinaldi su “Libero Quotidiano”. C’è un signore che ha confessato
trenta omicidi e ha fatto luce, con dichiarazioni ad hoc, su altri cinquanta.
Era un «pentito» di camorra che, pentitosi del pentimento, ricominciò alla
grande sbarcando in Emilia Romagna per dedicarsi alla spaccio internazionale di
droga. Ovviamente, in associazione (a delinquere) con altri. Lo stesso signore,
riammanettato e condannato a 20 anni nel secondo grado del nuovo giudizio,
invece che starsene in gattabuia circola liberamente per le strade di Afragola,
popoloso centro dell’hinterland napoletano celebre per essere anche la città
d’origine di Antonio Bassolino. Si chiama Mauro Marra, è tecnicamente un
libero cittadino perché i suoi giudici naturali non hanno trovato il tempo di
rifargli il processo come aveva loro intimato la Corte di Cassazione: sono
scaduti i così detti «termini di fase», non c’è più nulla da fare, se riuscite a
fargli nuovamente il processo che spetta a ogni cittadino italiano
indipendentemente dal reato commesso (si chiama civiltà giuridica) bene,
altrimenti Marra deve starsene a casa, come per ora già sta facendo. È una
storia incredibile ma vera, neanche tanto originale se si considera lo stato
comatoso del servizio giustizia nel Paese. Ne ha scritto ieri il più antico
quotidiano italiano, il Roma. Quando parli di Mauro Marra non ti appare
il ragazzotto di Scampia, imbottito di cocaina scadente e pronto a sparare anche
per 200 euro. No, parli di uno che non solo ha ucciso trenta avversari del clan
nemico, non solo era nei programmi strategici per fare altrettanto con ulteriori
50 persone (cosa che si verificò) ma addirittura di uno dalla cieca fede in
Raffaele Cutolo (l’ultimo, vero, padrino) e braccio destro di Pasquale
Scotti, latitante da 28 anni che difficilmente qualcuno, ormai, prenderà.
Sempre che sia vivo. Marra, poi, è ancora molto altro: è il super killer della
Nco (Nuova camorra organizzata) che sbugiardò gli accusatori di Enzo Tortora
aprendo uno squarcio su una delle punte massime del disonore del sistema
giudiziario. «Hanno accusato un innocente» disse in aula il 25 settembre 1985,
riferendosi alle «visioni» dei vari Barra, Melluso, Auriemma, Catapano,
Pandico e Dignitoso. Anche grazie a quella presa di posizione per l’ex
presentatore televisivo fu possibile risalire la china ed ottenere -diciamo-
giustizia. Scansata la matematica sfilza di ergastoli grazie alla legge sul
pentitismo, dopo una ventina d’anni riprese a delinquere e finì incarcerato nel
2006 mentre era in una località protetta del Nord. Il 26 marzo 2009 la I sezione
penale lo condanna a 18 anni; in secondo grado la IV Corte d’Appello di Napoli
gli aumenta la pena a venti. Siamo nel dicembre 2011. Il 21 novembre scorso la
Cassazione ribalta tutto rinviando gli atti a Napoli per una nuova sentenza: i
tre anni entro cui i magistrati avrebbero dovuto rendere definitiva la pena (i
termini di fase) sono trascorsi vanamente e, pertanto, Marra deve essere
scarcerato. Ovviamente il lavoro minuzioso di ricostruzione degli avvocati (Antonio
Abet e Giuseppe Perfetto) è stato determinante. Da una settimana il
pluriomicida è libero. Aspetta che la sentenza diventi definitiva. Non è scritto
però da nessuna parte che i giudici di II grado lo condannino, così come è
altrettanto probabile che ricorra, eventualmente, ancora in Cassazione. E il
tempo passa. Ma sarà senz’altro colpa dei cancellieri che mancano, degli
stenografi che non si trovano o della carta per fotocopie che scarseggia.
27 NOVEMBRE 2013. LA DECADENZA DI BERLUSCONI.
Storicamente, il populismo, ha
rappresentato una delle più sofisticate manifestazioni politiche di
disprezzo per il popolo.
La premessa serve a fare gli elogi al discorso tenuto in Senato dalla capogruppo
del M5S, Paola Taverna. Un discorso compatto, preciso, ricco di passione e
ritmo, costruito impeccabilmente. “In dieci minuti
quello che il Pd non ha detto per venti anni“,
è stato scritto sulla rete. Lo ripropongo nello stenografico di Palazzo Madama
(i puntini di sospensione segnalano le infinite, e stizzite, interruzioni da
parte di Forza Italia).
«Signor
Presidente, onorevoli colleghi, si chiude, oggi, impietosamente, una «storia
italiana», segnata dal fallimento politico, dall’imbarbarimento morale,
etico e civile della Nazione e da una pesantissima storia criminale. Storie che
si intrecciano, maledettamente, ai danni di un Paese sfinito e che riconducono
ad un preciso soggetto, con un preciso nome e cognome: Silvio Berlusconi.
La sua lunga e folgorante carriera l’abbiamo già ricordata in passato: un
percorso umano e politico costellato di contatti e rapporti mai veramente
chiariti, che passano per società occulte, P2, corruzione in atti giudiziari,
corruzione semplice, concussione, falsa testimonianza, finanziamento illecito,
falso in bilancio, frode fiscale, corruzione di senatori, induzione alla
prostituzione, sfruttamento della prostituzione e prostituzione minorile.
Insomma un delinquente abituale, recidivo e
dedito al crimine, anche organizzato, visti i suoi sodali.
Ideatore, organizzatore e utilizzatore finale dei reati da lui commessi.
Senatore Berlusconi, anzi signor Berlusconi, mi dispiace che lei non sia in
Aula. Forse alcuni hanno dimenticato che la sua discesa in campo ha avuto
soprattutto, per non dire esclusivamente, ragioni imprenditoriali: la situazione
della Fininvest nei primi anni Novanta, con più di 5.000 miliardi di lire di
debiti, parlava fin troppo chiaro; il rischio di bancarotta era dietro
l’angolo. Alcuni suoi dirigenti vedevano come unica via d’uscita il
deposito dei libri contabili in tribunale. La cura Forza Italia è stata
fantastica per le sue finanze, perché – ricordiamolo – non è entrato in politica
per il bene di questo Paese, come declamava da dietro una scrivania su tutte le
sue televisioni. Le elezioni politiche del 1994 hanno segnato l’inizio di una
carriera parlamentare illegittima, sulla base della violazione di una legge
vigente sin dal 1957, la n. 361, secondo la quale Silvio Berlusconi era ed è
palesemente ineleggibile. Quella legge non è mai stata applicata, benché fosse
chiarissima, grazie alla complicità del centrosinistra di dalemiana e
violantiana memoria. Per non parlare dell’eterna promessa, mai mantenuta, di
risolvere il conflitto di interessi. E tutto ciò è avvenuto non per ragioni
giuridiche – come ora qualcuno, mentendo, vorrebbe farci credere – ma per
onorare patti scellerati, firmati sottobanco per dividersi le spoglie di un
Paese. Forse qualcuno si indignerà, urlando che queste sono semplici illazioni.
Lasciamo che sia la storia a rispondere! Camera dei
deputati, 28 febbraio 2002, Resoconto stenografico della seduta n. 106 della XIV
legislatura. Cito le parole dell’onorevole Luciano Violante,
al tempo capogruppo dei Ds, oggi Pd, mentre si rivolge ad un collega
dell’apparentemente opposto schieramento: «(…) l’onorevole Berlusconi (…) sa per
certo che gli è stata data la garanzia piena – e non adesso, nel 1994, quando ci
fu il cambio di Governo – che non sarebbero state toccate le televisioni.. Lo sa
lui e lo sa l’onorevole Letta», zio. «Voi ci avete accusato di regime nonostante
non avessimo fatto il conflitto di interessi, avessimo dichiarato eleggibile
Berlusconi nonostante le concessioni (…). Durante i Governi di centrosinistra il
fatturato di Mediaset è aumentato di 25 volte». Questa è storia! Come storia è
la discesa in campo del senatore, fatta di promesse mai mantenute: dal taglio
delle tasse al milione di posti di lavoro. Ma non era l’imprenditore illuminato
che avrebbe salvato l’Italia, anzi l’azienda Italia? Quello che doveva pensare
alla cosa pubblica? Dal discorso del senatore Berlusconi del 1994 cito: «La
vecchia classe politica è stata travolta dai fatti e superata dai tempi. (…)
L’autoaffondamento dei vecchi governanti, schiacciati dal debito pubblico e dal
finanziamento illegale dei partiti, lascia il Paese impreparato e incerto nel
momento difficile del rinnovamento e del passaggio ad una nuova Repubblica».
Incredibile, ma vero: sono proprio sue parole. Potrà però sorgerci
legittimamente il dubbio che si sia preso gioco di noi per vent’anni, e ancora
adesso? Due mesi fa abbiamo visto diversi Ministri, in suo nome, presentare le
dimissioni dando inizio al siparietto della prima crisi di un Governo
nato precario, per non parlare della legge di stabilità che giaceva
ormai da settimane nella 5a Commissione. Ma lo vogliamo dire agli
italiani che la legge, che dovrebbe assicurare i conti ma soprattutto garantire
la ripartenza economica del nostro Paese e la sua stabilità, è stata svilita e
degradata a semplice espediente dilatorio per farle guadagnare qualche altro
giorno in carica? Oppure vogliamo ricordare i due bei regali che riceverà a
spese di tutti noi contribuenti? Assegno di solidarietà pari a circa 180.000
euro; assegno vitalizio di 8.000 euro mensili. C’è bisogno poi di ricordare
perché ancora oggi qualcuno, nonostante l’evidenza dei fatti, nonostante una
sentenza passata in giudicato, voglia un voto, uno stramaledetto voto per
applicare una legge? Ha senso ribadire lo sfacelo di venti anni di
indottrinamento fondato sull’apparire, sul dire e il non fare, sull’avere e non
sull’essere? Anche nell’ultimo atto della sua storia parlamentare comunque il
senatore riuscirà a segnare un record. L’illegittimità e l’indegnità
della sua carica senatoriale sono addirittura triple: incandidabilità
sopravvenuta, ineleggibilità e interdizione da pubblici uffici per indegnità
morale. In sostanza, un vero e proprio capolavoro! Questo Senato poi sentirà
un’enorme mancanza dell’operato parlamentare del signor Berlusconi. Ho sentito
oggi riprendere i senatori a vita. Dall’inizio della legislatura i dati
dimostrano la sua dedizione al lavoro in questa istituzione; dimostrano la
passione con cui ha interpretato il proprio mandato nell’interesse del Paese:
disegni di legge presentati zero; emendamenti presentati zero; ordini del giorno
zero; interrogazioni zero; interpellanze zero; mozioni zero; risoluzioni zero (Applausi
dal Gruppo M5S); interventi in Aula uno, per dare la fiducia a questo
Governo (eppure oggi è all’opposizione); presenze in Aula 0,01 per cento!
Quindi, di cosa stiamo discutendo? Della decadenza dalla carica di senatore di
un personaggio che il suo mandato non lo ha mai neppure lontanamente svolto, di
un signore che però ha puntualmente portato a Palazzo Grazioli e ad Arcore ben
16.000 euro al mese per non fare assolutamente nulla, se non
godere dell’immunità parlamentare. In questi venti anni il signor Berlusconi è
stato quattro volte Presidente del Consiglio dei ministri, Presidente del
Consiglio dell’Unione europea, due volte Ministro dell’economia e delle finanze,
una volta Ministro dello sviluppo economico, Ministro degli affari esteri,
Ministro della salute ma, soprattutto, è stato il Presidente del Consiglio che
ha mantenuto per più tempo la carica di Governo e che ha disposto della più
ampia maggioranza parlamentare della storia. Un immenso potere svilito e
addomesticato esclusivamente ai propri fini, cioè architettare reati e
incrementare il suo personale patrimonio economico.… Quante cose avrebbe potuto
fare per questo nostro Paese, se solo avesse anteposto il bene comune ai suoi
interessi personali, le riforme strutturali alle leggi ad personam! E,
invece, dopo tutto questo tempo ci troviamo con la disoccupazione al 40 per
cento, pensionati a 400 euro mensili, nessun diritto alla salute, nessun diritto
all’istruzione… un territorio devastato dalle Alpi alla Sicilia, le nostre città
sommerse dalle piogge… e le nostre campagne avvelenate… Era il 1997 quando
Schiavone veniva a denunciare dove erano stati sversati quintali di rifiuti
tossici: lo stesso anno in cui questo Stato decise di segretare tali
informazioni. Tutto ciò con l’IVA al 22 per cento e un carico fiscale che si
conferma il più alto d’Europa, pari al 65,8 per cento dei profitti commerciali…
e gli imprenditori… che si suicidano per disperazione, spesso nemmeno per
debiti, ma per i crediti non pagati dalla pubblica amministrazione, cioè dallo
Stato stesso! Di tutto questo il senatore Berlusconi non sembra
preoccuparsi. La decadenza di un intero Paese sembra non interessargli
minimamente, conta solo la sua. Giusto…Ha il terrore di espiare la propria pena
ai servizi sociali, di svolgere mansioni che ritiene non alla sua altezza… Beh,
sappia che quelli sono lavori che centinaia di migliaia di italiani perbene
svolgono con dignità e onestà… Gli auguriamo che questa possa essere invece
un’occasione per uscire dal suo mondo dorato, così forse potrà rendersi conto
del disastro e del baratro in cui i cittadini normali si trovano a causa del
sistema da lui generato e alimentato…Questo però non deve essere un discorso di
rabbia. Questo vuole essere un discorso di speranza…Concludo,
Presidente. La nostra presenza in quest’Aula oggi rappresenta un solo e semplice
concetto: noi non vogliamo chiamarci politici, ma restituire il potere ai
cittadini… Questa non è una vendetta. Qui non c’è nessuna ingiustizia o
persecuzione. Qui ci sono solo cittadini italiani che vogliono
riprendersi il proprio presente, altrimenti non avranno più un
futuro.»
La decadenza di Berlusconi. Cronaca, frasi,
retroscena di una giornata entrata nella storia della politica, scrive Paola
Sacchi su “Panorama”. Aldo Cazzullo editorialista e commentatore del
"Corriere della sera" inarca il sopracciglio e un po' sorride quando, in uno dei
corridoi di Palazzo Madama, il verace senatore dalemiano Ugo Sposetti confessa:
"La decadenza di Silvio Berlusconi è come la caduta del muro di Berlino, ma i
miei ora devono stare attenti: quel muro in Italia venne addosso tutto a chi lo
aveva preso a picconate, la Dc e il Psi....". Il senatore Pd, Stefano Esposito,
anche lui di rito dalemiano a Panorama.it ammette chiaramente: "Sì, Berlusconi è
decaduto, ma è uscito solo dalla vita parlamentare, non dalla politica. L'uomo è
ancora vivo e vegeto e guai se il Pd lo dà per morto, commetterebbe lo stesso
errore fatto con la sottovalutazione di Beppe Grillo". Se queste sono le grida
d'allarme che vengono dalla sinistra (tendenza riformista), figuriamoci quelle
che vengono da Forza Italia. "Sarà per loro un boomerang", dice secco il
senatore Fi Altero Matteoli. E il vicepresidente del Senato (Fi) Maurizio
Gasparri è caustico sulla conduzione dei lavori in aula da parte del presidente
Pietro Grasso: "Lui è l'ultima rotella di un ingranaggio molto più vasto che
voleva cacciare Berlusconi dal Parlamento a tutti i costi". Gasparri ricorre al
Manzoni: "E' il piccolo untorello .... non sarà lui che spianta Milano". Quasi
in contemporanea, con l'annuncio della sua decadenza da senatore, Silvio
Berlusconi in Via del Plebiscito arringa la folla e annuncia dopo la "giornata
di lutto per la democrazia", già il "primo appuntamento elettorale: l'8 dicembre
riunione dei club di Fi di tutt'Italia", lo stesso giorno delle primarie del
Pd. Rompe di fatto la tregua con Angelino Alfano. La folla urla: "Traditori" E
il Cav: "Parole ruvide ma efficaci". Alfano in serata dirà: "Giornata nera per
la democrazia". Ma "noi andremo avanti con il governo, in un rapporto di
collaborazione-conflittualità", spiega a Panorama.it l'ex governatore lombardo e
ora pezzo da novanta di Ndc, Roberto Formigoni. Che annuncia una formula di
craxiana memoria e cioè "la collaborazione-competizione" del Psi con la Dc, in
questo caso nelle parti del Pd. Sono le 17,40 quando Grasso annuncia con tono
routinario, quasi fosse una pratica burocratica, la "non convalida
dell'elezione a senatore di Silvio Berlusconi in Molise". Grasso ad un certo
punto nel rush sembra ricorrere anche una celebre frase di Nanni Moretti. "E
continuiamo così, continuiamo cosi...". Moretti concludeva "a farci del male".
Ma quel "continuiamo così" non riguardava la mancata conoscenza della torta
sacher. Era "la violazione del regolamento del Senato". Denunciato da Forza
Italia con una valanga di ordini del giorno, ben nove, presentati da Fi
(Elisabetta Alberti Casellati, ne ha presentati la maggioranza e a seguire
Francesco Nitto Palma, Anna Maria Bernini e lo stato maggiore dei senatori
azzurri. Si è invano chiesto il rispetto del regolamento del Senato tornando al
voto segreto. Così come è previsto nelle votazioni che riguardano una singola
persona. Grasso ha risposto picche anche a Pier Ferdinando Casini e al
socialista Enrico Buemi, che hanno tentato di far passare la proposta di buon
senso di aspettare almeno la decisione della Cassazione sulla richiesta di
interdizione per Berlusconi da parte della Corte d'Appello di Milano. Niente da
fare. Alla fine è stato Sandro Bondi ad avvertire tutti "gli amici di Fi" e i
garantisti in generale a fermarsi: "Basta, inutile andare avanti, questa è una
decisione già scritta. Lasciateli fare, lasciateli di fronte alle loro
responsabilità". Poi stilettata ad Alfano: "E ora il Nuovo centrodestra che
governi insieme con questi signori". E' l'inizio di un'opposizione durissima. E
con numeri per la maggioranza meno robusti di quanto Enrico Letta abbia vantato.
Sulla stabiliità c'è stato uno scarto di 36 voti. 171 sono stati quelli della
maggioranza, 135 quelli dell'opposizione. Ma questo perché in realtà una decina
di forzisti non si sarebbero presentati. Roberto Calderoli, vicepresidente del
Senato, che di numeri si intende, a Panorama.it conferma: "Almeno sei non
c'erano e ho visto anche qualche senatore a vita, mai visto di giorno,
figuriamoci a quell'ora di notte". Era presente ieri per la prima volta Renzo
Piano, incorrendo negli strali di Gasparri. Il leader dei lealisti di Fi
Raffaele Fitto avverte: "E' incredibile che Letta faccia finta di nulla".
Decadenza Berlusconi. Le reazioni della
stampa estera. Dalla Spagna al Brasile, passando per
Francia, Usa, Germania, Gran Bretagna, Turchia e Qatar. Le prime pagine dei
media mondiali aprono sul Cavaliere e in molti credono che non sia finita qui,
scrive Anna Mazzone su “Panorama”. La decadenza di Silvio Berlusconi e la
sua uscita dai palazzi ufficiali della politica è un vero e proprio caso
internazionale. Praticamente tutti i media del pianeta pubblicano la notizia o
corposi dossier sul Cavaliere sulle loro pagine online. Mancano all'appello solo
i russi e gli asiatici, ma solo per questione di fuso orario. In Germania la
Frankfurter Allgemeine titola subito dopo la grande coalizione
tedesca su "Berlusconi espulso dal Senato". Sottolineando che con la
decisione di un ramo del Parlamento italiano l'ex premier perde la sua carica
politica più importante. "Fino a poco tempo fa - scrive la FAZ - Berlusconi e il
suo partito avevano tentato di tutto per scongiurare l'espulsione dal Senato. I
sostenitori di Berlusconi hanno dimostrato a Roma denunciando un golpe e la fine
della democrazia". Lo stesso Berlusconi ha nuovamente gridato la sua innocenza
davanti ai suoi seguaci, definendo quello di oggi "Un giorno amaro e un giorno
di lutto per la democrazia". Die Welt mette prima
Berlusconi di Angela Merkel nella priorità delle notizie e sottolinea che "L'ex
premier italiano non reagisce in modo morbido all'espulsione dal Senato e
annuncia un'opposizione serrata", e cita un duro attacco di Berlusconi alla
sinistra italiana: "Oggi sono contenti perché hanno messo i loro avversari
davanti al plotone di esecuzione. Sono euforici, perché aspettavano questo
momento da 20 anni". Il quotidiano tedesco conclude con la frase del Cavaliere
sulla scia delle parole dell'inno di Mameli: "Le parole ci Mameli le prendiamo
come un dovere, siamo pronti a morire ..". Per Die Welt l'espulsione di
Berlusconi dal Parlamento è un momento storico, che segna la fine della Seconda
Repubblica italiana. Lo Spiegel non regala a Berlusconi la
sua apertura online, ma mette la sua decadenza comunque in prima pagina. Nel
sottolineare che l'ex premier non ha alcuna intenzione di arrendersi, il
giornale tedesco pubblica un video che mostra i sostenitori di berlusconi
assiepati fuori palazzo Grazioli a poche ore dal voto del Senato, in cui molti
giovano dichiarano alle telecamere tedesche che "Loro devono decadere e non
Silvio". Lo Spiegel poi affianca Berlusconi a Beppe Grillo, che guida il M5S
pur stando fuori dal Parlamento, ma - comunque - scrive il quotidiano teutonico
"Per il Cavaliere, in politica dal 1994, restare sulla cresta dell'onda da
oggi in poi sarà molto difficile". E passiamo alla Gran Bretagna. Al momento
in cui scriviamo la rivista finanziaria The Economist - che già
aveva dedicato in passato copertine al vetriolo contro Berlusconi - non ha
ancora pubblicato il suo commento sull'avvenuta decadenza. L'ultimo articolo
dedicato alle cose della politica italiana risale al 21 novembre scorso a parla
di "Una opportunità d'oro" per la politica italiana, dopo la decisione di
un gruppo di ex fedelissimi di Berlusconi di passare dall'altra parte. "La
divisione del partito di Berlusconi potrebbe rilanciare la coalizione di
governo", scommette The Economist. Il Guardian apre la sua
edizione online con la decadenza del Cavaliere e pubblica un ricco dossier
sull'ex premier italiano, a cominciare da una dettagliata timeline dal titolo
Ups and downs of Berlusconi's career - Alti e bassi della carriera di
Berlusconi. Il quotidiano britannico, sempre molto duro nei confronti dell'ex
presidente del Consiglio, sottolinea che "Con il loro leader sbattuto fuori
dal Senato adesso i parlamentari di Forza Italia si cimenteranno in
un'opposizione serrata e metteranno in pericolo le riforme istituzionali che il
governo di Letta afferma di voler portare a termine". Immancabile la prima
pagina del Financial Times che pubblica una foto scattata
a Roma con un sostenitore di Berlusconi che agita un manifesto con il Cavlaiere
sotto il simbolo delle Brigate Rosse e la scritta: "Prigioniero politico".
Mentre il quotidiano conservatore di Londra, The Telegraph
scrive nella sua apertura online: "Silvio Berlusconi, l'uomo che ha dato un
nuovo significato alla parola 'faccia tosta', con aria di sfida ha promesso di
rimanere al centro della politica italiana di ieri, nonostante sia stato
ignominiosamente spogliato del suo seggio in parlamento a seguito di una
condanna per massiccia frode fiscale". La versione in inglese di Al
Jazeera , l'emittente del Qatar, mette Berlusconi nelle sue notizie di
apertura, sottolineando che "L'ex primo ministro italiano è stato cacciato dal
Senato in seguito alla sua condanna per frode fiscale". Ma - aggiunge Al Jazeera
- "In molti credono che il 77enne possa risorgere ancora". Andiamo ora
dall'altra parte dell'oceano. Berlusconi campeggia sulle homepage delle
principali testate statunitensi. Sul Wall Street Journal la
sua decadenza è la notizia di apertura. Il quotidiano della City americana
titola sul "Voto per espellere il politico miliardario condannato per frode
fiscale". La testata finanziaria sottolinea che la decadenza di Berlusconi "Ha
segnato il culmine di quasi quattro mesi di furore politico che ha avuto inizio
in agosto con la condanna per frode fiscale dell'uomo che ha dominato la vita
politica italiana per due decenni". In più il WSJ pubblica la storia di
Berlusconi e una sua gallery di foto. Il New York Times dà a
Berlusconi la sua prestigiosa colonna di sinistra in homepage. L'articolo è
firmato da Jim Yardley, che scrive che "L'ex primo ministro, un tempo molto
potente, è stato allontanato dal Senato". Yardley prosegue dicendo che "Dopo
aver speso mesi fabbricando ad arte ritardi procedurali o congiurando melodrammi
politici con il fine di salvarsi, Silvio Berlusconi oggi ha dovuto accettare
l'inevitabile: essere espulso dal Senato, un'espulsione tragica ed umiliante,
mentre altri potenziali problemi si profilano al suo orizzonte". Il
Washington Post preferisce invece aprire sulla politica interna
americana e poi passare solo in seconda battuta al caso della decadenza del
Cavaliere. E sulla "resistenza" di Berlusconi il giornale di Washington è
possibilista: "Anche se Berlusconi non avrà più un seggio in Parlamento -
scrive il giornalista - in molti si aspettano che resti comunque influente
nella politica italiana". Grancassa decadenza sul quotidiano spagnolo
El Pais, che dedica un'apertura a 8 colonne a Berlusconi e un corposo
dossier che ricorda - passo dopo passo - tutta la storia del Cavaliere, dalla
sua discesa in campo all'espulsione dal Senato. Corredano il dossier due gallery
di immagini. L'incipit dell'articolo principale del quotidiano progressista
spagnolo ha toni molto ironici: "Dicono che (Berlusconi) non dorma da molti
giorni, che alterna momenti di depressione profonda con altri di un'euforia
spropositata che lo porta a esclamare: "Giuro che tornerò a Palazzo Chigi [la
sede del Governo]. Il sempre teatrale Silvio Berlusconi sta perdendo la bussola.
E, a pensarci bene, questa non è una sorpresa". Meno ironico e più ottimista per
le sorti del Cavaliere il quotidiano El Mundo , di area
conservatrice. In un editoriale a firma di Miguel Cabanillas che commenta la
notizia sulla decadenza pubblicata in apertura dell'edizione online, si
definisce Berlusconi "Un'araba fenice con molti epitaffi politici sulle
spalle". Un politico sempre pronto a sorprendere e a rinascere. "Come
un'araba fenice che rinasce dalle sue cenerei quando tutti lo danno per
politicamente morto, il magnate italiano - scrive Cabanillas - non rinuncia al
pedigree della sua vita che, nelle ultime due decadi, lo ha trasformato in uno
dei leader più popolari nel mondo, idolatrato da una parte e odiato dall'altra".
Infine, El Pais riporta le parole dell'ex premier italiano che oggi ha
dichiarato: "La battaglia non è ancora finita". Fuoco di fila contro
Berlusconi sui quotidiani francesi. Le Monde titola in
apertura: "L'Italia senza Berlusconi" e pubblica un corposo dossier che include
"I suoi 20 anni di processi" e un articolo sui "Fedelissimi che lo hanno
abbandonato passando all'opposizione". Liberation pubblica la
notizia tra le prime ma non in apertura e sottolinea il j'accuse di
Berlusconi che si dice "vittima di una persecuzione" politica e giudiziaria.
Per Le Figaro (quotidiano conservatore) "Questo è l'ultimo atto
di una discesa agli Inferi cominciata a novembre de 2011", quando Silvio
Berlusconi fu "Attaccato dai mercati, umiliato al G20 di Cannes e congedato dal
presidente Giorgio Napolitano che lo ha rimpiazzato al governo con l'economista
Mario Monti. Apertura anche per O Globo , primo quotidiano
brasiliano, che senza mezzi termini titola: "Il Senato italiano fa fuori
Berlusconi" e poi pubblica un dossier che inizia con un articolo di commento
che recita: "Berlusconi, la fine è arrivata", con fotografie di
manifestanti anti-Cavaliere fuori dal Senato in attesa dell'esito della
votazione. O Globo cita anche un twit di Beppe Grillo, che festeggia
"cinguettando" la decadenza scrivendo: "Berlusconi è stato licenziato dal
Senato. Uno di loro è fuori. Ora dobbiamo mandare a casa anche tutti gli altri".
Infine, prima pagina per Berlusconi anche sui principali media turchi.
Hurriyet scrive che "La decisione del Senato potrebbe essere uno
spartiacque nella carriera del leader che ha dominato la politica italiana per
due decenni". Il quotidiano di Ankara così commenta: "Il voto, che arriva dopo
mesi di scontri politici, apre una fase incerta nella politica italiana, con il
77enne miliardario che si prepara a usare tutte le sue enormi risorse per
attaccare la coalizione di Governo guidata dal premier Enrico Letta".
Urss, Kissinger, massoneria Ecco i
misteri di Napolitano. Da dirigente Pci intrattenne
rapporti riservati con Unione sovietica e Usa, dove andò durante il sequestro
Moro. E da allora la "fratellanza" mondiale lo tratta con riguardo
scrive Paolo Bracalini su “Il Giornale”. «Il
presidente Napolitano è stato sempre garante dei poteri forti a livello
nazionale e degli equilibri internazionali sull'asse inclinato dal peso degli
Stati Uniti» scrivono i giornalisti di inchiesta Ferruccio Pinotti (del Corriere
della sera) e Stefano Santachiara (Il Fatto) in "I panni sporchi della sinistra"
(ed. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano Chiarelettere). Il primo
ritratto, di 60 pagine, è dedicato proprio al presidente della Repubblica («I
segreti di Napolitano»), «l'ex ministro degli esteri del Pci» come lo definì
Bettino Craxi interrogato dal pm Di Pietro nel processo Enimont. I rapporti con
Mosca, quelli controversi con Berlusconi (il mensile della corrente migliorista
del Pci, Il Moderno, finanziato da Fininvest, ma anche dai costruttori Ligresti
e Gavio), e le relazioni oltreoceano, con Washington. Una storia complessa,
dalla diffidenza iniziale del Dipartimento di Stato Usa e dell'intelligence
americana («nel 1975 a Napolitano gli fu negato il visto, come avveniva per
tutti i dirigenti comunisti»), alle aperture dell'ambasciata Usa a Roma, al
«misterioso viaggio» di Napolitano negli Stati uniti nel '78, nei giorni del
sequestro Moro, l'altro viaggio insieme a Occhetto nel 1989, fino «all'incontro
festoso, molti anni dopo, nel 2001, a Cernobbio, con Henry Kissinger, ex braccio
destro di Nixon, che lo saluta calorosamente: My favourite communist, il mio
comunista preferito. Ma Napolitano lo corregge ridendo: Il mio ex comunista
preferito!». Il credito di Napolitano presso il mondo anglosassone si dipana nel
libro-inchiesta anche su un fronte diverso, che Pinotti segue da anni, la
massoneria, e che si intreccia con la storia più recente, in particolare con le
dimissioni forzate di Berlusconi nel 2011, a colpi di spread e pressioni delle
diplomazie internazionali. Su questo terreno gli autori fanno parlare diverse
fonti, tra cui una, di cui non rivela il nome ma l'identikit: «Avvocato di
altissimo livello, cassazionista, consulente delle più alte cariche
istituzionali, massone con solidissimi agganci internazionali in Israele e negli
Stati Uniti, figlio di un dirigente del Pci, massone, e lui stesso molto vicino
al Pd». Il quale racconta: «Già il padre di Giorgio Napolitano è stato un
importante massone, una delle figure più in vista della massoneria partenopea»
(proprio nei giorni successivi all'uscita del libro sarebbe spuntata, dagli
archivi di un'associazione massonica di primo piano, la tessera numerata del
padre di Napolitano). Tutta la storia familiare di Napolitano è riconducibile
all'esperienza massonica partenopea, che ha radici antiche e si inquadra
nell'alveo di quella francese...». Avvocato liberale, poeta e saggista, Giovanni
Napolitano avrebbe trasmesso al figlio Giorgio (legatissimo al padre) non solo
l'amore per i codici «ma anche quello per la fratellanza» si legge. E poi: «Per
quanto riguarda l'attuale presidente, negli ambienti massonici si sussurra da
tempo di simpatie della massoneria internazionale nei confronti dell'unico
dirigente comunista che a metà anni Settanta, all'epoca della Guerra fredda, sia
stato invitato negli Stati Uniti a tenere un ciclo di lectures presso
prestigiosi atenei. Napolitano sarebbe stato iniziato, in tempi lontani,
direttamente alla «fratellanza» anglosassone (inglese o statunitense)». Da lì il
passo ad accreditare la tesi, molto battuta in ambienti complottisti, di un
assist guidato a Mario Monti, è breve, e viene illustrata da un'altra fonte,
l'ex Gran maestro Giuliano Di Bernardo («criteri massonici nella scelta di Mario
Monti») e da uno 007 italiano. L'asse di Berlusconi con Putin - specie sul
dossier energia - poco gradito in certi ambienti, entra in questo quadro
(fantapolitica?). Con un giallo finale nelle pagine del libro, raccontato dalla
autorevole fonte (senza nome): Putin avrebbe dato a Berlusconi delle carte su
Napolitano. Se queste carte esistono, riguardano più i rapporti americani di
Napolitano che quelli con i russi». Materiale per una avvincente spy story su
Berlusconi, Napolitano, Monti, Putin, la Cia, il Bilderberg...
Il Cav fu costretto da Napolitano a
dimettersi perché voleva che l'Italia uscisse dall'euro,
scrive Magdi Cristiano Allam su “Il Giornale”. Alla
luce delle recenti rivelazioni, si conferma che il 12 novembre 2011 Berlusconi
fu costretto da Napolitano a dimettersi da presidente del Consiglio, pur in
assenza di un voto di sfiducia del Parlamento, perché in seno ai vertici dell'Ue
aveva ventilato la possibilità che l'Italia esca dall'euro. Di fatto fu un colpo
di Stato ordinato dai poteri forti in seno all'Unione europea e alla Bce,
innanzitutto la Germania di Angela Merkel, manovrando l'impennata dello spread
(il differenziale tra Btp-Bund) che sfiorò i 600 punti alimentando un clima di
terrorismo finanziario, politico e mediatico, con la connivenza dei poteri
finanziari speculativi che determinarono il crollo delle azioni Mediaset in
Borsa, realizzato con un comportamento autocratico di Napolitano che in quattro
giorni ottenne le dimissioni di Berlusconi, nominò Mario Monti senatore a vita e
lo impose a capo di un governo tecnocratico a cui lo stesso Berlusconi fu
costretto a dare fiducia. Questo complotto contro il governo legittimo di uno
Stato sovrano va ben oltre l'ambito personale. Lorenzo Bini Smaghi, membro del
Comitato esecutivo della Bce dal giugno 2005 al 10 novembre 2011, a pagina 40
del suo recente libro Morire d'austerità rivela: «Non è un caso che le
dimissioni del primo ministro greco Papandreou siano avvenute pochi giorni dopo
il suo annuncio di tenere un referendum sull'euro e che quelle di Berlusconi
siano anch'esse avvenute dopo che l'ipotesi di uscita dall'euro era stata
ventilata in colloqui privati con i governi degli altri Paesi dell'euro».
Hans-Werner Sinn, presidente dell'Istat tedesco, durante il convegno economico
Fuehrungstreffen Wirtschaft 2013 organizzato a Berlino dal quotidiano
Sueddeutsche Zeitung, ha rivelato negli scorsi giorni: «Sappiamo che
nell'autunno 2011 Berlusconi ha avviato trattative per far uscire l'Italia
dall'euro». Lo stesso Berlusconi, intervenendo sabato scorso a un raduno della
Giovane Italia, ha rivelato: «Oggi operiamo con una moneta straniera, che è
l'euro»; «Siamo nelle stesse condizioni dell'Argentina che emetteva titoli in
dollari»; «Il Giappone ha un debito pubblico del 243% rispetto al Pil ma ha
sovranità monetaria»; «Le mie posizioni nell'Ue hanno infastidito la Germania»;
«La Germania ordinò alle sue banche di vendere i titoli italiani per far salire
lo spread, provocando l'effetto gregge»; «Nel giugno 2011 Monti e Passera
preparavano già il programma del governo tecnico»; «Nel 2011 ci fu una volontà
precisa di far fuori il nostro governo»; «Al Quirinale mi dissero che per il
bene del Paese avrei dovuto cedere la guida del governo ai tecnici». Nessuno si
illude che la magistratura, ideologicamente schierata a favore della sinistra,
interverrà per sanzionare Napolitano (che è il presidente del Csm) o per
salvaguardare la sovranità nazionale dell'Italia dalla dittatura dell'Eurocrazia
e della finanza globalizzata. Dobbiamo prendere atto che siamo in guerra.
Abbiamo perso del tutto la sovranità monetaria, all'80% la sovranità legislativa
e ci stanno spogliando della sovranità nazionale. Berlusconi, a 77 anni,
limitato sul piano dell'agibilità politica, può oggi dare un senso alto alla sua
missione politica contribuendo con tutto il suo carisma e le sue risorse al
riscatto della nostra sovranità monetaria, legislativa, giudiziaria e nazionale
dalla schiavitù dell'euro, dalla sudditanza di questa Ue alla Germania, ai
banchieri e ai burocrati, dalla partitocrazia consociativa che ha ucciso la
democrazia sostanziale e lo Stato di diritto, perpetuando uno Stato onerosissimo
che impone il più alto livello di tassazione al mondo che finisce per condannare
a morte le imprese. Ma bisogna rompere ogni indugio schierandosi con
imprenditori, famiglie, sindaci e forze dell'ordine, promuovendo subito la rete
di tutti coloro che condividono la missione di salvare gli italiani e far
rinascere l'Italia libera, sovrana e federalista. Zapatero rivela: il Cav
obiettivo di un attacco dei leader europei.
In un libro l'ex premier spagnolo
svela i retroscena del G20 di Cannes nel 2011 e il pressing sull'Italia per
accettare i diktat Fmi: "Si parlava già di Monti",
scrive Riccardo Pelliccetti su “Il Giornale”. Vorremmo
dire «clamoroso», ma non è così perché sapevamo da tempo, e lo abbiamo più volte
scritto, che non solo in Italia ma anche dall'estero arrivavano pesanti
pressioni per far fuori Silvio Berlusconi. L'ultima prova, che conferma la
volontà di rovesciare un governo democraticamente eletto, la rivela l'ex premier
spagnolo Luis Zapatero, che nel libro El dilema (Il dilemma), presentato a
Madrid, porta alla luce inediti retroscena sulla crisi che minacciò di spaccare
l'Eurozona. Il 3 e 4 novembre 2011 sono i giorni ad altissima tensione del
vertice del G-20 a Cannes, sulla Costa Azzurra. Tutti gli occhi sono puntati su
Italia e Spagna che, dopo la Grecia, sono diventate l'anello debole per la
tenuta dell'euro. Il presidente americano Barack Obama e la cancelliera tedesca
Angela Merkel mettono alle corde Berlusconi e Zapatero, cercando di imporre
all'Italia e alla Spagna gli aiuti del Fondo monetario internazionale. I due
premier resistono, consapevoli che il salvataggio da parte del Fmi avrebbe
significato accettare condizioni capestro e cedere di fatto la sovranità a
Bruxelles, com'era già accaduto con Grecia, Portogallo e Cipro. Ma la Germania
con gli altri Paesi nordici, impauriti dagli attacchi speculativi dei mercati,
considerano il vertice di Cannes decisivo e vogliono risultati a qualsiasi
costo. Le pressioni sono altissime. Zapatero descrive la cena del 3 novembre,
con il tavolo «piccolo e rettangolare per favorire la vicinanza e un clima di
fiducia». Ma l'atmosfera è esplosiva. «Nei corridoi si parlava di Mario Monti»,
rivela il premier spagnolo. Già, Monti. Che solo una settimana dopo sarà
nominato senatore a vita da Napolitano e che il 12 novembre diventerà premier al
posto di Berlusconi. Il piano era già congegnato, con il Quirinale pronto a
soggiacere ai desiderata dei mercati e di Berlino. La Merkel domanda a Zapatero
se sia disponibile «a chiedere una linea di credito preventiva di 50 miliardi di
euro al Fondo monetario internazionale, mentre altri 85 sarebbero andati
all'Italia. La mia risposta fu diretta e chiara: no», scrive l'ex premier
spagnolo. Allora i leader presenti concentrano le pressioni sul governo italiano
perché chieda il salvataggio, sperando di arginare così la crisi dell'euro.
«C'era un ambiente estremamente critico verso il governo italiano», ricorda
Zapatero, descrivendo la folle corsa dello spread e l'impossibilità da parte del
nostro Paese di finanziare il debito con tassi che sfiorano il 6,5 per cento.
Insomma, i leader del G-20 sono terrorizzati dai mercati e temono che il
contagio possa estendersi a Paesi europei come la Francia se non prendono il
toro per le corna. Il toro in questo caso è l'Italia. «Momenti di tensione, seri
rimproveri, invocazioni storiche, perfino invettive sul ruolo degli alleati dopo
la seconda guerra mondiale...», caratterizzano il vertice. «Davanti a questo
attacco - racconta l'ex leader socialista spagnolo - ricordo la strenua difesa,
un catenaccio in piena regola» di Berlusconi e del ministro dell'Economia Giulio
Tremonti. «Entrambi allontanano il pallone dall'area, con gli argomenti più
tecnici Tremonti o con le invocazioni più domestiche di Berlusconi», che
sottolinea la capacità di risparmio degli italiani. «Mi è rimasta impressa una
frase che Tremonti ripeteva: conosco modi migliori di suicidio». Alla fine si
raggiunge un compromesso, con Berlusconi che accetta la supervisione del Fmi ma
non il salvataggio. Ma tutto ciò costerà caro al Cavaliere. «È un fatto -
sostiene Zapatero - che da lì a poco ebbe effetti importantissimi sull'esecutivo
italiano, con le dimissioni di Berlusconi, dopo l'approvazione della Finanziaria
con le misure di austerità richieste dall'Unione europea, e il successivo
incarico al nuovo governo tecnico guidato da Mario Monti».
Un governo, ora sappiamo con certezza, eletto da
leader stranieri nei corridoi di Cannes e non dalla volontà popolare degli
italiani. Verrà un giorno in cui l’Italia troverà il coraggio e l’onestà di
rileggere (alcuni, se la coscienza li soccorrerà, lo faranno non senza vergogna)
la storia di questi giorni, prima ancora di dedicarsi all’analisi del cosiddetto
ventennio di Silvio Berlusconi. Perché è da qui, dai giorni tristi e terribili
dell’umiliazione del Diritto, che bisognerà partire per spiegare come sia stato
possibile arrivare al sabbah giacobino contro il Cavaliere al Senato in barba a
regole, buon senso e dignità, scrive Giorgio Mulè, direttore di “Panorama”, nel
suo editoriale. Era cominciato tutto dopo la sentenza di condanna del 2 agosto
emessa (prima anomalia) da una sezione feriale della Cassazione, presieduta da
un magistrato chiacchierone (seconda anomalia) che non avrebbe dovuto giudicare
l’ex premier. Una sentenza in palese contraddizione con i verdetti di due
sezioni «titolari» della Suprema corte (terza anomalia) che avevano valutato le
stesse identiche prove nella vicenda della compravendita dei diritti televisivi
giungendo alla conclusione opposta, e cioè che l’ex premier era innocente. Ma
innocente nel profondo, senza ombra di dubbio e senza nemmeno una formula
dubitativa che, come un sigaro, non si nega mai a nessuno. Una classe politica
prigioniera della sua mediocrità e ossessionata dalla presenza di Berlusconi non
poteva far altro che cogliere l’occasione. A cominciare da Beppe Grillo e dai
suoi accoliti, arrivati in Parlamento con l’ambizioso programma fondato
sull’eliminazione del Cav. Così, dal 2 agosto, è iniziata una corsa orgiastica e
forsennata per liberarsi dell’odiato Caimano. In prima fila, a battere il
tamburo per la caccia grossa, ci sono stati sempre loro, gli avanguardisti della
Repubblica con i cugini del Fatto quotidiano, la falange editoriale che
tiene al guinzaglio la mejo sinistra e che ha sempre vissuto con il complesso di
disfarsi del male assoluto incarnato nell’uomo di Arcore. Il tutto portato
avanti con la solita tecnica becera delle inchieste da buco della serratura
grazie all’ausilio di compiacenti magistrati (quarta anomalia), della lettura
distorta degli atti, del moralismo ipocrita un tanto al chilo e a senso unico.
Una sentina maleodorante spacciata per giornalismo nobile dove si sorvola se a
finire accusato di gravissimi reati c’è Carlo De Benedetti. Chi poteva fermare
questa ordalia non l’ha fatto. Avrebbe potuto e dovuto farlo Giorgio Napolitano,
in virtù dell’alto ed esclusivo ruolo che gli assegna la Costituzione. Avrebbe
dovuto usare la tanto sbandierata moral suasion (quinta anomalia) per ricondurre
alla ragione i sanculotti del suo ex partito e provare nell’ardua impresa di
riuscirci con gli attuali maggiorenti; a cominciare da Matteo Renzi che
scimmiotta Fonzie, si indigna per una battuta in un cartone animato dei Simpson
e non si rende conto di essere la copia spiccicata (per la profondità delle
riflessioni…) del simpatico Kermit, il leader indiscusso dei pupazzi del Muppet
show. E invece dal Colle sono venute fuori interpretazioni pelose delle
procedure e più o meno pubblici risentimenti per le sacrosante lamentele
espresse da un Berlusconi profondamente deluso. Bisogna prendere atto
chiaramente che Napolitano poteva concedere la grazia al Cavaliere e non solo
per la pena principale ma anche per quella accessoria, cioè l’interdizione dai
pubblici uffici, eventualità da lui espressamente negata nella lunga nota del 13
agosto. Non è vero che per la concessione del beneficio fosse necessario aver
accettato la sentenza o aver iniziato a espiare la pena (sesta anomalia). È una
balla. Il 5 aprile di quest’anno, il Quirinale comunicava: «Il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, ai sensi dell’articolo 87, comma 11, della
Costituzione, ha oggi concesso la grazia al colonnello Joseph L. Romano III, in
relazione alla condanna alla pena della reclusione (7 anni, ndr) e alle pene
accessorie (interdizione perpetua dai pubblici uffici, ndr) inflitta con
sentenza della Corte d’Appello di Milano del 15 dicembre 2010, divenuta
irrevocabile il 19 settembre 2012. La decisione è stata assunta dopo aver
acquisito la documentazione relativa alla domanda avanzata dal difensore
avvocato Cesare Graziano Bulgheroni, le osservazioni contrarie del procuratore
generale di Milano e il parere non ostativo del ministro della Giustizia». Per
la cronaca: il colonnello era fra gli imputati del rapimento e delle
successive torture dell’imam Abu Omar, non si è presentato mai al
processo, non ha mai confessato alcunché, non si è mai pentito del
gesto, non ha chiesto scusa a nessuno, non ha mai scontato un giorno
di carcere e per la giustizia italiana era un latitante al pari del
superboss Matteo Messina Denaro. La grazia giunse dal Colle dopo
appena 7 mesi dalla pronuncia definitiva della Cassazione e con il
parere contrario dei magistrati. C’è ancora qualche anima bella o
dannata disposta a sostenere la tesi che il presidente della
Repubblica non poteva adottare lo stesso metodo nei confronti di
Silvio Berlusconi? Chiamiamo le cose con il loro nome: è mancato il
coraggio per concedere la grazia. Il provvedimento avrebbe aperto una
fase nuova nella storia di questo Paese, sarebbe stato l’atto di non
ritorno verso la pacificazione dopo vent’anni di guerra combattuta nel
nome dell’eliminazione per via giudiziaria del Cavaliere il quale,
statene certi, avrebbe abbandonato la politica attiva. Il capo dello
Stato ha avuto l’opportunità di consegnarsi alla storia e non l’ha
fatto. E solo quando giungerà quel famoso giorno in cui gli
avvenimenti di oggi potranno essere riletti senza veli e senza
partigianerie capiremo se al suo mancato gesto dovremo aggiungere i
caratteri poco commendevoli del cinismo, della pavidità o del calcolo
politico. Nel quadro tenebroso dell’oggi trova un posto nitido Enrico
Letta, il presidente del Consiglio che ha conferito a questo Paese
una stabilità degna di un cimitero, come ha giustamente notato il
Wall Street Journal. Incapace di avviare le riforme oramai
improcrastinabili per l’Italia, Letta non è stato neppure capace di
imporre il più impercettibile distinguo sulla giustizia (settima
anomalia) ed è rimasto avvinghiato al doroteismo stucchevole di una
linea che voleva tenere distinte la vicenda di Berlusconi e le sorti
dell’esecutivo quando anche un bambino ne coglieva l’intimo intreccio.
Ma i bambini, si sa, hanno la vista lunga. E ora tutti sanno, anche
quelli dell’asilo, che l’unico orizzonte di Letta non è quello di
varare le riforme, giustizia compresa, ma quello di mantenere il
potere. E infatti eccoci all’ottava anomalia, Angelino Alfano: ha
mollato il Pdl per fondare il Nuovo centrodestra, che al
momento si distingue solo per la fedeltà interessata al governo.
Sarebbe toccato proprio ad Angelino costringere Napolitano e Letta a
guardare la realtà, a spalancare gli occhi sullo scempio del diritto
che si stava consumando, a denunciare con argomenti solidi e di
verità l’inganno di una procedura interpretata in maniera torbida e
manigolda. Come quella della retroattività della legge Severino sulla
decadenza (nona anomalia), che una pletora di giuristi e politici di
buon senso non affini ma certamente lontani dal mondo berlusconiano
voleva affidare al vaglio della Corte costituzionale per
un’interpretazione autentica. Anche per questo motivo il luogotenente del
Cav avrebbe dovuto elevare il caso B a caso internazionale, avrebbe
dovuto sfidare in campo aperto i satrapi dell’informazione truccata. E
invece ha preferito chinarsi sulla propria poltroncina, talmente
affascinato, e impaurito di perderla, da consumare lo strappo di ogni
linea politica e di ogni rapporto umano con il proprio leader.
Napolitano, Letta, Alfano: in questo triangolo delle Bermude, che si
autoalimenta nel nome dello status quo e di un governo fatto solo di
tasse e bugie, c’è finito Silvio Berlusconi. E la conclusione della
storia è stata ovvia: l’hanno inghiottito, macinato ed espulso senza
tanti complimenti. Neppure il colpo di reni finale hanno sfruttato i
tre del triangolo mortale, quello offerto dalle nuove prove squadernate
dall’ex premier per chiedere la revisione del processo. Un percorso
perfettamente legalitario, quello del Cav, condotto all’interno del
perimetro disegnato dal Codice di procedura penale e che avrebbe
dovuto fermare la mannaia dell’espulsione dal Senato. Per mille motivi,
ma soprattutto per una possibile e atroce beffa: se la Corte
d’appello darà ragione al Cavaliere e lo proscioglierà, lui si troverà
già fuori da Palazzo Madama. E nessuno potrà dirgli: «Prego, ci
scusi, si accomodi e riprenda il suo posto». Con il corollario non
secondario che, senza lo scudo da senatore, i picadores in toga
potranno infilzare il Cav e compiere l’ultimo sfregio: l’arresto
(decima anomalia). In questa cornice assai triste tocca togliersi il
cappello di fronte al coraggio di Francesco Boccia, deputato del Pd
di prima fila (almeno fino al 9 dicembre, quando Matteo «Kermit» si
presenterà sul palco della segreteria del partito) che martedì 26
novembre, dopo aver visto gli elementi esposti da Berlusconi, ha
dichiarato: «Se fosse così mi aspetto una revisione del processo come
per qualsiasi altro cittadino». E ancora: «In un Paese normale si
sarebbe aspettata la delibera della Corte costituzionale
sull’interpretazione della legge Severino». Un Paese normale questo? È
una battutona, ditelo a Matteo «Kermit», che magari se la rivende.
Dovrà fare in fretta, però. Perché adesso inizia un’altra faida, che
lo metterà contro Letta e Napolitano. I tre non possono convivere: i
loro interessi non sono convergenti, i loro orizzonti non
corrispondono. Per questo, già prima dell’8 dicembre, ne vedremo delle
belle. Sarà il seguito della politica da avanspettacolo che ci hanno
rifilato negli ultimi mesi. Successe più o meno la stessa cosa ai
tempi di monsieur de Robespierre e dei giacobini. Fatto fuori il re,
si illusero di avere la Francia in pugno. Manco per niente.
Iniziarono a scannarsi l’un l’altro. Fin quando un giorno
accompagnarono Robespierre, l’Incorruttibile, al patibolo. Gli gridavano
dietro: «Morte al tiranno». Avete capito la storia?
Dopo gli Anni di piombo e le decine di magistrati
uccisi dalle Brigate rosse e dall'eversione di destra e di sinistra la corrente
di Md più vicina al Partito comunista scala le gerarchie della magistratura e
impone il suo diktat, come racconta al Giornale un ex giudice di Md: «Serve una
giurisprudenza alternativa per legittimare la lotta di classe e una nuova pace
sociale». Ma serviva una legittimazione incrociata. Non dallo Stato né dal
popolo, ma da quel Pci diventato Pds in crisi d'identità dopo il crollo del Muro
di Berlino. Tangentopoli nacque grazie a un matrimonio d'interessi e un nemico
comune: Bettino Craxi.
Quell'abbraccio tra Pci e
Md che fece scattare Mani pulite.
Magistratura democratica pianificò l'alleanza col Pds sul giustizialismo per
ridare smalto alle toghe e offrire agli eredi del Pci il ruolo di moralizzatore
contro la corruzione in Italia,
scrive Sergio d'Angelo
su “Il Giornale”. «La
piattaforma politico-programmatica elaborata per la nuova Magistratura
democratica poteva convincere ed attirare buona parte dei giovani magistrati,
cresciuti politicamente e culturalmente nel crogiolo sessantottino. Ma bisognava
fornire a Md una base giuridica teorica che potesse essere accettata dal mondo
accademico e da una parte consistente della magistratura. Ancora una volta fu la
genialità di Luigi Ferrajoli a trovare una risposta: «La giurisprudenza
alternativa (...) è diretta ad aprire e legittimare (...) nuovi e più ampi spazi
alle lotte delle masse in vista di nuovi e alternativi assetti di potere (...).
Una formula che configura il giudice come mediatore dei conflitti in funzione di
una pace sociale sempre meglio adeguata alle necessità della società
capitalistica in trasformazione». In qualunque democrazia matura la prospettiva
tracciata da Ferrajoli non avrebbe suscitato altro che una normale discussione
accademica tra addetti ai lavori: ma la verità dirompente era tutta italiana.
Celato da slogan pseudorivoluzionari, il dibattito nel corpo giudiziario ad
opera di Md negli anni '70 e '80 presentava questo tema fondamentale: a chi
spetta assicurare ai cittadini nuovi fondamentali diritti privati e sociali? Al
potere politico (e di quale colore) attraverso l'emanazione di norme (almeno
all'apparenza) generali ed astratte, o all'ordine giudiziario con la propria
giurisprudenza «alternativa»? Un dubbio devastante cominciò a infiltrarsi tra i
magistrati di Md. Se la magistratura (o almeno la sua parte «democratica») era
una componente organica del movimento di classe e delle lotte proletarie, allora
da dove proveniva la legittimazione dei giudici a «fare giustizia»? Dallo Stato
(come era quasi sempre accaduto), che li aveva assunti previo concorso e li
pagava non certo perché sovvertissero l'ordine sociale? Dal popolo sovrano? Da
un partito? Quelli furono anni tragici per l'Italia. Tutte le migliori energie
della magistratura furono indirizzate a combattere i movimenti eversivi che
avevano scelto la lotta armata e la sfida violenta allo Stato borghese: i
giudici «democratici» pagarono un prezzo elevato, l'ala sinistra della corrente
di Md rimase isolata mentre l'ala filo-Pci di Md mantenne un basso profilo.
Dell'onore postumo legato al pesante prezzo di sangue pagato dai giudici per
mano brigatista beneficiarono indistintamente tutte le correnti dell'ordine
giudiziario, compresa Md e la magistratura utilizzò questo vernissage per
rifarsi un look socialmente accettabile. Solo la frazione di estrema sinistra di
Md ne fu tagliata fuori, e questo determinò - alla lunga - la sua estinzione.
Alcuni furono - per così dire - «epurati»; a molti altri fu garantito un cursus
honorum di tutto rispetto, che fu pagato per molti anni a venire
(Europarlamento, Parlamento nazionale, cariche prestigiose per chi si dimetteva,
carriere brillanti e fulminee per altri). Quelli che non si rassegnarono furono
di fatto costretti al silenzio e poi «suicidati» come Michele Coiro, già
procuratore della Repubblica di Roma, colpito il 22 giugno 1997 da infarto
mortale, dopo essere stato allontanato dal suo ruolo (promoveatur ut amoveatur)
dal Csm. L'ala filo Pci/Pds di Md, vittoriosa all'interno della corrente, non
era né poteva diventare un partito, in quanto parte della burocrazia statale.
Cercava comunque alleati per almeno due ragioni: difendere e rivalutare un
patrimonio di elaborazione teorica passato quasi indenne attraverso il
terrorismo di estrema sinistra e la lotta armata e garantire all'intera
«ultracasta» dei magistrati gli stessi privilegi (economici e di status)
acquisiti nel passato, pericolosamente messi in discussione fin dai primi anni
'90. Questo secondo aspetto avrebbe di sicuro assicurato alla «nuova» Md
l'egemonia (se non numerica certo culturale) sull'intera magistratura associata:
l'intesa andava dunque trovata sul terreno politico, rivitalizzando le parole
d'ordine dell'autonomia e indipendenza della magistratura, rivendicando il
controllo di legalità su una certa politica e proclamando l'inscindibilità tra
le funzioni di giudice e pubblico ministero. Non ci volle molto ad individuare i
partiti «nemici» e quelli potenzialmente interessati ad un'alleanza di reciproca
utilità. Alla fine degli anni '80 il Pci sprofondò in una gravissima crisi di
identità per gli eventi che avevano colpito il regime comunista dell'Urss. Non
sarebbe stato sufficiente un cambiamento di look: era indispensabile un'alleanza
di interessi fondata sul giustizialismo, che esercitava grande fascino tra i
cittadini, in quanto forniva loro l'illusione di una sorta di Nemesi storica
contro le classi dirigenti nazionali, che avevano dato pessima prova di sé sotto
tutti i punti di vista. La rivincita dei buoni contro i cattivi, finalmente, per
di più in forme perfettamente legali e sotto l'egida dei «duri e puri»
magistrati, che si limitavano a svolgere il proprio lavoro «in nome del popolo».
Pochi compresero che sotto l'adempimento di un mero dovere professionale poteva
nascondersi un nuovo Torquemada. Il Pci/Pds uscì quasi indenne dagli attacchi
«dimostrativi» (tali alla fine si rivelarono) della magistratura che furono
inseriti nell'enorme calderone noto come Mani Pulite: d'altronde il «vero»
nemico era già perfettamente inquadrato nel mirino: Bettino Craxi. Chi scrive
non è ovviamente in grado di dire come, quando e ad opera di chi la trattativa
si sviluppò: ma essa è nei fatti, ed è dimostrata dal perfetto incastrarsi
(perfino temporale) dei due interessi convergenti. Naturalmente esistono
alleanze che si costituiscono tacitamente, secondo il principio che «il nemico
del mio nemico è mio amico», e non c'è bisogno di clausole sottoscritte per
consacrarle. Quando il pool graziò il Pds e i giudici diventarono casta.
Mani pulite con la regia di Md sfiorò il partito per dimostrare che avrebbe
potuto colpire tutti Il Parlamento si arrese, rinunciando all'immunità. E così
consegnò il Paese ai magistrati - continua Sergio
d'Angelo su “Il Giornale”. - Per rendersi
credibile alla magistratura, il tacito accordo tra Md e Pds avrebbe dovuto
coinvolgere magistrati della più varia estrazione e provenienza politica e
culturale. Nel 1989 era entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale
che apriva la strada ad un'attività dell'accusa priva di qualunque freno,
nonostante l'introduzione del Gip (giudice delle indagini preliminari), in
funzione di garanzia dei diritti della difesa. C'è un significativo documento -
intitolato I mestieri del giudice - redatto dalla sezione milanese di Md a
conclusione di un convegno tenutosi a Renate il 12 marzo 1988, in casa del pm
Gherardo Colombo. In quel testo l'allora pm di Milano Riccardo Targetti tracciò
una netta distinzione tra «pm dinamico» e «pm statico», schierandosi
naturalmente a favore della prima tipologia, come il nuovo codice gli consentiva
di fare. Che cosa legava tra loro i componenti del pool Mani pulite? Nulla. Che
Gerardo D'Ambrosio (chiamato affettuosamente dai colleghi zio Jerry) fosse
«vicino» al Pci lo si sapeva (lui stesso non ne faceva mistero), ma non si
dichiarò mai militante attivo di Md. Gherardo Colombo era noto per aver guidato
la perquisizione della villa di Licio Gelli da cui saltò fuori l'elenco degli
iscritti alla P2: politicamente militava nella sinistra di Md, anche se su
posizioni moderate. Piercamillo Davigo era notoriamente un esponente di
Magistratura indipendente, la corrente più a destra. Francesco Greco era legato
ai gruppuscoli dell'estrema sinistra romana (lui stesso ne narrava le vicende
per così dire «domestiche»), ma nel pool tenne sempre una posizione piuttosto
defilata. Infine, Di Pietro, una meteora che cominciò ad acquistare notorietà
per il cosiddetto «processo patenti» (che fece piazza pulita della corruzione
nella Motorizzazione civile di Milano) e l'informatizzazione accelerata dei suoi
metodi di indagine, per la quale si avvalse dell'aiuto di due carabinieri
esperti di informatica. Il 28 febbraio 1993, a un anno dall'arresto di Mario
Chiesa, cominciano a manifestarsi le prime avvisaglie di un possibile
coinvolgimento del Pds nell'inchiesta Mani pulite con il conto svizzero di Primo
Greganti alias «compagno G» militante del partito, che sembra frutto di una
grossa tangente. Il 6 marzo fu varato il decreto-legge Conso che depenalizzava
il finanziamento illecito ai partiti. Il procuratore Francesco Saverio Borrelli
va in tv a leggere un comunicato: la divisione dei poteri nel nostro Paese non
c'era più. Il presidente Oscar Luigi Scalfaro si rifiuta di firmare il decreto,
affossandolo. Alla fine di settembre il cerchio sembra stringersi sempre di più
intorno al Pds, per tangenti su Malpensa 2000 e metropolitana milanese: tra
smentite del procuratore di Milano Borrelli e timori di avvisi di garanzia per
Occhetto e D'Alema, la Quercia è nel panico. Il 5 ottobre Il Manifesto titola I
giudici scagionano il Pds: l'incipit dell'articolo - a firma Renata Fontanelli -
è il seguente: «. La posizione di Marcello Stefanini, segretario amministrativo
della Quercia e parlamentare, verrà stralciata e Primo Greganti (il «compagno
G») verrà ritenuto un volgare millantatore. Il gip Italo Ghitti (meglio noto tra
gli avvocati come «il nano malefico») impone alla Procura di Milano di indagare
per altri quattro mesi poi il 26 ottobre come titola il Manifesto a pagina 4
titola D'Ambrosio si ritira dal pool per impedire speculazioni sui suoi rapporti
«amicali» con il Pds. Quali indicazioni si possono trarre da questa vicenda? Il
pool dimostrò che la magistratura sarebbe stata in grado di colpire tutti i
partiti, Pds compreso; la Quercia era ormai un partito senza ideologia e il suo
elettorato si stava fortemente assottigliando (era al 16%): c'era dunque la
necessità di trovare un pensiero politico di ricambio, che poteva venire solo
dall'esterno; nessuna forza politica avrebbe mai potuto modificare l'assetto
istituzionale nonché l'ordinamento giudiziario senza il consenso della
magistratura; alla magistratura fu fatto quindi comprendere che l'unico modo di
conservare i propri privilegi sarebbe stato quello di allearsi con un partito in
cerca di ideologia. Il Psi con Bettino Craxi, Claudio Martelli e Giuliano Amato
avevano minacciato o promesso un drastico ridimensionamento dei poteri e
privilegi dell'ordine giudiziario. Ma la reazione delle toghe fu tanto forte da
indurre un Parlamento letteralmente sotto assedio e atterrito a rinunciare ad
uno dei cardini fondamentali voluto dai costituenti a garanzia della divisione
dei poteri: l'immunità parlamentare. A questo punto il pallino passò al Pds, che
non tardò a giocarselo. Senza una
vera riforma il Paese resterà ostaggio del potere giudiziario.
I giudici sono scesi in guerra per non rinunciare ai privilegi, guidati dalla
nuova "giustizia di classe" che Md è riuscita a imporre alle toghe. È arrivato
il momento di tirare le somme su quanto è accaduto tra magistratura e politica
negli ultimi venti anni. Magistratura democratica avrebbe dovuto rappresentare
una componente del «movimento di classe» antagonista allo sviluppo capitalistico
della società. L'ala filo-Pci della corrente fu decisamente contraria a questa
scelta così netta, e per molti anni praticò una sorta di «entrismo» (né aderire
né sabotare). La scelta di classe operata dalla sinistra di Md presentava rischi
pesantissimi di isolamento all'interno della magistratura e tra le forze
politiche egemoni nella sinistra, che la lotta armata delle brigate rosse
evidenziò immediatamente nel corso degli anni '80 («né con lo Stato né con le
Br? I brigatisti compagni che sbagliano?»). Alla fine degli Anni di piombo, in
pratica l'ala «rivoluzionaria» della magistratura non esisteva già più, e quella
filo-Pci ebbe campo libero. Il crollo dell'Urss gettò il partito egemone della
sinistra nello sconcerto: il Pci non aveva più un'ideologia, né il cambiamento
di sigla (Pds) poteva rivitalizzarlo. Al contrario, l'ala di Md filo Pci/Pds
aveva costruito una immagine ed una ideologia di sé stessa - pagata anche col
sangue di suoi aderenti di spicco - che poteva essere spesa su qualunque piazza,
ma le mancava un alleato sotto la forma partito. L'interesse di entrambi era
comunque troppo forte perché l'alleanza sfumasse, anche se non mancarono
resistenze e ricatti reciproci: così, il Pci/Pds fu duramente minacciato (ed
anche in piccola parte colpito) durante la stagione di Mani Pulite. Alla fine,
intorno al 1994, l'alleanza andò in porto, e un partito senza ideologia accolse
e fece propria (probabilmente senza salti di gioia) un'ideologia senza partito.
Due ostacoli, tuttavia, si frapponevano tra questa alleanza e la conquista del
potere: uno era il cosiddetto Caf (Craxi, Andreotti, Forlani); l'altro era
interno alla magistratura, formato da tutti quei giudici che da sponde opposte
si opponevano a questa operazione. Il primo ostacolo fu eliminato attraverso
Mani pulite, al secondo si applicarono vari metodi; dal promoveatur ut
amoveatur, ai procedimenti disciplinari, alla elevazione al soglio parlamentare
eccetera. Così la magistratura più restia fu lusingata con l'obiettivo di
mantenere i privilegi e la fetta di potere (anche economico) cui era stata
abituata, al punto di farle accettare impunemente l'accordo che era sotto gli
occhi di tutti. Il compito di questa Md era pressochè esaurito, in quanto il
nemico principale (il Caf ma soprattutto Bettino Craxi) era stato abbattuto.
Quando un nuovo nemico si presentò all'orizzonte, i cani da guardia dell'accordo
(ora la magistratura nel suo complesso) non ci misero molto a tirar fuori zanne
ed artigli, con l'appoggio del loro referente politico. Fantasie, opinioni
personali, dirà qualcuno. Può darsi, ma certo occorre riflettere su tre punti
cruciali dell'inchiesta Mani pulite, che sono - come tanti altri elementi -
caduti nel dimenticatoio della Storia. Come abbiamo detto in precedenza, tra i
membri del pool non c'era assolutamente nessuna identità culturale o «politica»,
e non può non destare perplessità la circostanza che essi furono messi insieme
per compiere un'operazione così complessa e delicata: fu davvero per garantire
il pluralismo e l'equidistanza fra i soggetti coinvolti o, come abbiamo
sostenuto, per raccogliere e compattare tutte le diverse anime della
magistratura? Quando esattamente fu costituito il pool? Al riguardo non abbiamo
nessuna certezza, ma di sicuro esso esisteva già il 17 febbraio 1992, data
dell'arresto di Mario Chiesa: chi, nei palazzi di giustizia milanesi e non solo,
aveva la sfera di cristallo? L'allora console statunitense a Milano Peter Semler
dichiarò di aver ricevuto da Antonio Di Pietro - nel novembre '91 -
indiscrezioni sulle indagini in corso, il quale gli avrebbe anticipato l'arresto
di Mario Chiesa (avvenuto nel febbraio '92) e l'attacco a Craxi e al Caf. In
realtà, la magistratura nell'arco di oltre vent'anni e fino ai giorni nostri ha
difeso sé stessa e il proprio status di supercasta: non già per motivi
ideologico-politici bensì per autotutela da un nemico che appariva
pericolosissimo. La casta, in altri termini, ha fatto e sempre farà quadrato a
propria difesa, a prescindere dall'essere «toghe rosse» o di qualunque altro
colore. L'accanimento contro Silvio Berlusconi riguarda - più che la sua persona
- il ruolo da lui svolto ed il pericolo che ha rappresentato e potrebbe ancora
rappresentare per la burocrazia giudiziaria e per gli eredi del Pci/Pds. Si può
senz'altro convenire che i giudici Nicoletta Gandus (processo Mills), Oscar Magi
(processo Unipol, per rivelazione di segreto istruttorio), Luigi de Ruggero
(condanna in sede civile al risarcimento del danno per il lodo Mondadori in
favore di De Benedetti) abbiano militato nella (ex) frazione di sinistra di Md,
come pure il procuratore Edmondo Bruti Liberati (noto come simpatizzante del
Pci/Pds): si può supporre che a quella corrente appartenga pure la presidente
Alessandra Galli (processo di appello Mediaset). Nel novero dei giudici di
sinistra si potrebbe anche ricomprendere la pm Boccassini: ma gli altri? Chi
potrebbe attribuire in quota Md il giudice Raimondo Mesiano (primo processo con
risarcimento del danno a favore di De Benedetti), il presidente Edoardo D'Avossa
(I° grado del processo Mediaset), la presidente Giulia Turri (processo Ruby), il
pm Fabio De Pasquale, il pm Antonio Sangermano, il presidente di cassazione
Antonio Esposito e tutti gli altri che si sono occupati e si stanno occupando
del «delinquente» Berlusconi? La verità è che la magistratura italiana da tempo
è esplosa in una miriade di monadi fuori da qualunque controllo gerarchico e
territoriale, essendo venuto meno (grazie anche al codice di procedura penale
del 1989) perfino l'ultimo baluardo che le impediva di tracimare; quello della
competenza territoriale, travolto dalla disposizione relativa alle cosiddette
«indagini collegate» (ogni pm può indagare su tutto in tutto il Paese, salvo poi
alla fine trasmettere gli atti alla Procura territorialmente competente).
Ciascun pm è padrone assoluto in casa propria, e nessuno - nemmeno un capo
dell'ufficio men che autorevole - può fermarlo. E la situazione non fa altro che
peggiorare, come è sotto gli occhi di tutti coloro che sono interessati a
vedere. La magistratura italiana - unica nel panorama dei Paesi occidentali
democratici - è preda di un numero indeterminato di «giovani» (e meno giovani,
ma anche meno sprovveduti) magistrati pronti a qualunque evenienza e
autoreferenziali. Focalizzare l'attenzione solo su Magistratura democratica
significa non cogliere appieno i pericoli che le istituzioni nazionali stanno
correndo e correranno negli anni a venire, con o senza la preda Berlusconi.
L'ala «ex» comunista del Pd -
dal canto suo - non può più abbandonare l'ideologia giustizialista, che ormai
resta l'unica via che potrebbe portare quella forma-partito al potere. Una
democrazia occidentale matura non può fare a meno di riflettere su questi temi,
cercando una via di uscita dall'impasse politico-istituzionale in cui questo
Paese si è infilato per la propria drammatica incoscienza, immaturità ed
incapacità di governo: con buona pace di una ormai inesistente classe politica.»
Sergio D'Angelo Ex giudice di Magistratura democratica.
A riguardo sentiamo il
cronista che fa tremare i pm. "Sinistra ricattata dalle procure". Dopo 35
anni a seguire i processi nelle aule dei tribunali Frank Cimini è andato in
pensione ma dal suo blog continua a svelare le verità scomode di Milano:
"Magistrati senza controllo", scrive Luca Fazzo su “Il Giornale”. «Antonio
Di Pietro è meno intelligente di me»: nel 1992, quando i cronisti di tutta
Italia scodinzolavano dietro il pm milanese, Frank Cimini fu l'unico cronista
giudiziario a uscire dal coro. Sono passati vent'anni, e Cimini sta per andare
in pensione. Confermi quel giudizio? «Confermo integralmente». Sul motivo
dell'ubriacatura collettiva dei mass media a favore del pm, Cimini ha idee
precise: «C'era un problema reale, la gente non ne poteva più dei politici che
rubavano, e la magistratura ha colto l'occasione per prendere il potere. Di
Pietro si è trovato lì, la sua corporazione lo ha usato. Mani pulite era un
fatto politico, lui era il classico arrampicatore sociale che voleva fare
carriera. Infatti appena potuto si è candidato: non in un partito qualunque, ma
nelle fila dell'unico partito miracolato dalle indagini». Uomo indubbiamente di
sinistra, e anche di ultrasinistra («ma faccio l'intervista al Giornale perché
sennò nessuno mi sta a sentire») Cimini (ex Manifesto, ex Mattino, ex Agcom, ex
Tmnews) resterà nel palazzo di giustizia milanese come redattore del suo blog,
giustiziami.it. E continuerà, dietro l'usbergo dell'enorme barba e
dell'indipendenza, a dire cose per cui chiunque altro verrebbe arrestato. Sulla
sudditanza degli editori verso il pool di Mani Pulite ha idee precise: «Gli
editori in Italia non sono editori puri ma imprenditori che hanno un'altra
attività, e come tali erano sotto scacco del pool: c'è stato un rapporto di do
ut des. Per questo i giornali di tutti gli imprenditori hanno appoggiato Mani
pulite in cambio di farla franca. Infatti poi l'unico su cui si è indagato in
modo approfondito, cioè Berlusconi, è stato indagato in quanto era sceso in
politica, sennò sarebbe stato miracolato anche lui. C'è stato un approfondimento
di indagine, uso un eufemismo, che non ha pari in alcun paese occidentale. Ma
lui dovrebbe fare mea culpa perché anche le sue tv hanno appoggiato la Procura».
Da allora, dice Cimini, nulla è cambiato: nessuno controlla i magistrati. «Il
problema è che la politica è ancora debole, così la magistratura fa quello che
vuole. Il centrosinistra mantiene lo status quo perché spera di usare i pm
contro i suoi avversari politici ma soprattutto perché gran parte del ceto
politico del centrosinistra è ricattato dalle procure. Basta vedere come escono
le cose, Vendola, la Lorenzetti, e come certe notizie spariscono
all'improvviso». Nello strapotere della magistratura quanto conta l'ideologia e
quanto la sete di potere? «L'ideologia non c'entra più niente, quella delle
toghe rosse è una cavolata che Berlusconi dice perché il suo elettorato così
capisce. Ma le toghe rosse non ci sono più, da quando è iniziata Mani pulite il
progetto politico che era di Borrelli e non certo di Di Pietro o del povero
Occhetto è stata la conquista del potere assoluto da parte della magistratura
che ha ottenuto lo stravolgimento dello Stato di diritto con la legge sui
pentiti. Un vulnus da cui la giustizia non si è più ripresa e che ha esteso i
suoi effetti dai processi di mafia a quelli politici. Oggi c'è in galera uno
come Guarischi che avrà le sue colpe, ma lo tengono dentro solo perché vogliono
che faccia il nome di Formigoni». Conoscitore profondo del palazzaccio milanese,
capace di battute irriferibili, Cimini riesce a farsi perdonare dai giudici
anche i suoi giudizi su Caselli («un professionista dell'emergenza») e
soprattutto la diagnosi impietosa di quanto avviene quotidianamente nelle aule:
«Hanno usato il codice come carta igienica, hanno fatto cose da pazzi e
continuano a farle». Chi passa le notizie ai giornali? «Nelle indagini
preliminari c'è uno strapotere della Procura che dà le notizie scientemente per
rafforzare politicamente l'accusa». E i cronisti si lasciano usare? «Se stessimo
a chiederci perché ci passano le notizie, i giornali uscirebbero in bianco».
"La politica ha delegato alla
magistratura tre grandi questioni politiche, il terrorismo, la mafia, la
corruzione, e alcuni magistrati sono diventati di conseguenza depositari di
responsabilità tipicamente politiche". A dirlo è Luciano Violante, ex
presidente della Camera e esponente del Partito democratico. Secondo il
giurista, inoltre, "la legge Severino testimonia il grado di debolezza" della
politica perché non è "possibile che occorra una legge per obbligare i partiti a
non candidare chi ha compiuto certi reati". "È in atto un processo di
spoliticizzazione della democrazia che oscilla tra tecnocrazia e demagogia", ha
aggiunto, "Ne conseguono ondate moralistiche a gettone tipiche di un Paese,
l’Italia, che ha nello scontro interno permanente la propria cifra
caratterizzante". Colpa anche di Silvio Berlusconi, che "ha reso ancora
più conflittuale la politica italiana", ma anche della sinistra che "lo ha
scioccamente inseguito sul suo terreno accontentandosi della modesta identità
antiberlusconiana". "Ma neanche la Resistenza fu antimussoliniana, si era
antifascisti e tanto bastava", aggiunge. Quanto alle sue parole sulla legge
Severino e la decadenza del Cavaliere, Violante aggiunge: "Ho solo detto
che anche Berlusconi aveva diritto a difendersi. Quando ho potuto spiegarmi alle
assemblee di partito ho ricevuto applausi, ma oggi vale solo lo slogan, il
cabaret. Difficile andare oltre i 140 caratteri di Twitter". E sulle toghe
aggiunge: "Pentiti e intercettazioni hanno sostituito la capacità investigativa.
Con conseguenze enormi. Occorrerebbe indicare le priorità da perseguire a
livello penale, rivedendo l’obbligatorietà dell’azione che è un’ipocrisia
costituzionale resa necessaria dal fatto che i pubblici ministeri sono, e a mio
avviso devono restare, indipendenti dal governo".
Io quelli di Forza Italia li
rispetto, scrive Filippo Facci su “Libero Quotidiano”. Conoscendoli,
singolarmente, li rispetto molto meno: ma nell'insieme potrebbero anche sembrare
appunto dei lealisti, dei coerenti, delle schiene dritte, gente che ha
finalmente trovato una linea del Piave intesa come Berlusconi, come capo, come
leader, come rappresentante di milioni di italiani che non si può cancellare
solo per via giudiziaria: almeno non così. Non con sentenze infarcite di
«convincimenti» e prove che non lo sono. Dunque rispetto quelli di Forza Italia
- anche se in buona parte restano dei cavalier-serventi - perché tentano di fare
quello che nella Prima Repubblica non fu fatto per Bettino Craxi e per altri
leader, consegnati mani e piedi alla magistratura assieme al primato della
politica. Solo che, dettaglio, Forza Italia ha perso: ha perso quella di oggi e
ha perso quella del 1994. E non ha perso ieri, o un mese fa, cioè con
Napolitano, la Consulta, la legge Severino, la Consulta, la Cassazione: ha
colpevolmente perso in vent'anni di fallimento politico sulla giustizia.
Dall’altra c’è qualcuno che ha vinto, anche se elencarne la formazione ora è
complicato: si rischia di passare dal pretenzioso racconto di un’ormai stagliata
«jurecrazia» - fatta di corti che regolano un ordine giuridico globale -
all'ultimo straccione di pm o cronista militante. Resta il dato essenziale:
vent’anni fa la giustizia faceva schifo e oggi fa identicamente schifo,
schiacciata com'è sul potere che la esercita; e fa identicamente schifo, per
colpe anche sue, la giustizia ad personam legiferata da Berlusconi, che in
vent'anni ha solo preso tempo - molto - e alla fine non s'è salvato. Elencare
tutte le forzature palesi o presunte per abbatterlo, magari distinguendole dalle
azioni penali più che legittime, è un lavoro da pazzi o da memorialistica
difensiva: solo la somma delle assoluzioni - mischiate ad amnistie e
prescrizioni - brucerebbe una pagina. Basti l'incipit, cioè il celebre mandato
di comparizione che fu appositamente spedito a Berlusconi il 21 novembre 1994
per essere appreso a un convegno Onu con 140 delegazioni governative e 650
giornalisti: diede la spallata decisiva a un governo a discapito di un
proscioglimento che giungerà molti anni dopo. L’elenco potrebbe proseguire sino
a oggi - intralciato anche da tutte le leggi ad personam che Berlusconi fece per
salvarsi - e infatti è solo oggi che Berlusconi cade, anzi decade. Ciò che è
cambiato, negli ultimi anni, è la determinazione di una parte della magistratura
- unita e univoca come la corrente di sinistra che ne occupa i posti chiave - a
discapito di apparenze che non ha neanche più cercato di salvare. I processi per
frode legati ai diritti televisivi non erano più semplici di altri, anzi, il
contrario: come già raccontato, Berlusconi per le stesse accuse era già stato
prosciolto a Roma e pure a Milano. Ciò che è cambiato, appunto, è la
determinazione dei collegi giudicanti a fronte di quadri probatori tuttavia
paragonabili ai precedenti: ma hanno cambiato marcia. Si poteva intuirlo dai
tempi atipici che si stavano progressivamente dando già al primo grado del
processo Mills, che filò per ben 47 udienze in meno di due anni e fece lavorare
i giudici sino al tardo pomeriggio e nei weekend; le motivazioni della sentenza
furono notificate entro 15 giorni (e non entro i consueti 90) così da permettere
che il ricorso in Cassazione fosse più che mai spedito. Ma è il processo
successivo, quello che ora ha fatto fuori Berlusconi, ad aver segnato un record:
tre gradi di giudizio in un solo anno (alla faccia della Corte Europea che ci
condanna per la lunghezza dei procedimenti) con dettagli anche emblematici, tipo
la solerte attivazione di una sezione feriale della Cassazione che è stata
descritta come se di norma esaminasse tutti i processi indifferibili del Paese:
semplicemente falso, la discrezionalità regna sovrana come su tutto il resto. Il
paradosso sta qui: nel formidabile e inaspettato rispetto di regole teoriche -
quelle che in dieci mesi giudicano un cittadino nei tre gradi - al punto da
trasformare Berlusconi in eccezione assoluta. Poi, a proposito di
discrezionalità, ci sono le sentenze: e qui si entra nel fantastico mondo
dell'insondabile o di un dibattito infinito: quello su che cosa sia
effettivamente una «prova» e che differenza ci sia rispetto a convincimenti e
mere somme di indizi. Il tutto sopraffatti dal dogma che le sentenze si
accettano e basta: anche se è dura, talvolta. Quando uscirono le 208 pagine
della condanna definitiva in Cassazione, in ogni caso, i primi commenti dei
vertici piddini furono di pochi minuti dopo: un caso di lettura analogica. E,
senza scomodare espressioni come «teorema» o «prova logica» o peggio «non poteva
non sapere», le motivazioni della sentenza per frode fiscale appalesavano una
gigantesca e motivata opinione: le «prove logiche» e i «non poteva non sapere»
purtroppo abbondavano e abbondano. «È da ritenersi provato» era la frase più
ricorrente, mentre tesi contrarie denotavano una «assoluta inverosimiglianza».
Su tutto imperava l’attribuzione di una responsabilità oggettiva: «La qualità di
Berlusconi di azionista di maggioranza gli consentiva pacificamente qualsiasi
possibilità di intervento», «era assolutamente ovvio che la gestione dei diritti
fosse di interesse della proprietà», «la consapevolezza poteva essere
ascrivibile solo a chi aveva uno sguardo d’insieme, complessivo, sul complesso
sistema». Il capolavoro resta quello a pagina 184 della sentenza, che riguardava
la riduzione delle liste testimoniali chieste dalla difesa: «Va detto per
inciso», è messo nero su bianco, «che effettivamente il pm non ha fornito alcuna
prova diretta circa eventuali interventi dell’imputato Berlusconi in merito alle
modalità di appostare gli ammortamenti dei bilanci. Ne conseguiva l'assoluta
inutilità di una prova negativa di fatti che la pubblica accusa non aveva
provato in modo diretto». In lingua italiana: l’accusa non ha neppure cercato di
provare che Berlusconi fosse direttamente responsabile, dunque era inutile
ammettere testimoni che provassero il contrario, cioè una sua estraneità. Ma le
sentenze si devono accettare e basta. Quando Berlusconi azzardò un
videomessaggio di reazione, in settembre, Guglielmo Epifani lo definì
«sconcertante», mentre Antonio Di Pietro fece un esposto per vilipendio alla
magistratura e Rosy Bindi parlò di «eversione». Il resto - la galoppata per far
decadere Berlusconi in Senato - è cronaca recente, anzi, di ieri, Il precedente
di Cesare Previti - che al termine del processo Imi-Sir fu dichiarato
«interdetto a vita dai pubblici uffici» - è pure noto: la Camera ne votò la
decadenza ben 14 mesi dopo la sentenza della Cassazione. Allora come oggi, il
centrosinistra era dell’opinione che si dovesse semplicemente prendere atto del
dettato della magistratura, mentre il centrodestra pretendeva invece che si
entrasse nel merito e non ci si limitasse a un ruolo notarile. Poi c’è il
mancato ricorso alla Corte Costituzionale per stabilire se gli effetti della
Legge Severino possano essere retroattivi: la Consulta è stata investita di
infinite incombenza da una ventina d’anni a questa parte - comprese le leggi
elettorali e i vari «lodi» regolarmente bocciati – ma per la Legge Severino il
Partito democratico ha ritenuto che la Corte non dovesse dire la sua. Il 30
ottobre scorso, infine, la Giunta per il regolamento del Senato ha stabilito che
per casi di «non convalida dell’elezione» il voto dovesse essere palese, volontà
ripetuta ieri dal presidente del Senato: nessun voto segreto o di coscienza,
dunque. Poi - ma è un altro articolo, anzi, vent'anni di articoli - ci sono le
mazzate che il centrodestra si è tirato da solo. La Legge Severino, come detto.
Il condono tombale offerto a Berlusconi dal «suo» ministro Tremonti nel 2002 -
che l'avrebbe messo in regola con qualsivoglia frode fiscale – ma che al
Cavaliere non interessò. Il demagogico inasprimento delle pene per la
prostituzione minorile promosso dal «suo» ministro Carfagna nel 2008. Però,
dicevamo, non ci sono solo gli autogol: c’è il semplice non-fatto o non-riuscito
degli ultimi vent’anni. Perché nei fatti c’era, e c’è, la stessa magistratura.
Non c’è la separazione delle carriere, lo sdoppiamento del Csm, le modifiche
dell’obbligatorietà dell’azione penale, l’inappellabilità delle sentenze di
assoluzione, la responsabilità civile dei giudici, i limiti alle
intercettazioni. Ci sono state, invece, le leggi sulle rogatorie, la Cirami, i
vari lodi Maccanico-Schifani-Alfano, l’illegittimo impedimento: pannicelli caldi
inutili o, per un po’, utili praticamente solo a lui. Per un po’. Solo per un
po’. Fino al 27 novembre 2013.
CARMINE SCHIAVONE. MAGISTRATI:
ROMA NOSTRA!
"Ondata
di ricorsi dopo il «trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici,
Napoli capitale dei promossi. L'area coperta dalla Corte d'appello ha «prodotto»
un terzo degli aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori".
O la statistica è
birichina assai o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale concorso di accesso
alla magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici ammessi agli orali
vengono infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli, che rappresenta solo
un trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della popolazione italiana.
Un trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza: erano della stessa
area, più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della commissione e 5 su 8 dei
docenti universitari. Cioè oltre un terzo degli esaminatori.
DELINQUENTE A CHI?
“Chi non conosce la verità è
uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma
di Bertolt Brecht. Parla l’ex capo dei Casalesi. La camorra e la mafia non
finirà mai, finchè ci saranno politici, magistrati e forze dell’ordine mafiosi.
CARMINE SCHIAVONE.
MAGISTRATI: ROMA NOSTRA!
"Ondata
di ricorsi dopo il «trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici,
Napoli capitale dei promossi. L'area coperta dalla Corte d'appello ha «prodotto»
un terzo degli aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori".
O la statistica è
birichina assai o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale concorso di accesso
alla magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici ammessi agli orali
vengono infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli, che rappresenta solo
un trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della popolazione italiana.
Un trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza: erano della stessa
area, più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della commissione e 5 su 8 dei
docenti universitari. Cioè oltre un terzo degli esaminatori.
"Noi avevamo la nostra
idea. Dovevamo formare, per la fine del millennio, i nostri giovani come degli
infiltrati dentro lo Stato: quindi dovevano diventare magistrati, poliziotti,
carabinieri e perché no, anche ministri e presidenti del Consiglio. Per avere i
nostri referenti nelle istituzioni".
"I mafiosi non
sono solo i Riina o i Provenzano. I soggetti collusi con la mafia sono ovunque,
sono nelle istituzioni pubbliche, siedono anche in Parlamento". Così il
presidente del Tribunale di Palermo, Leonardo Guarnotta, al convegno “La mafia
non è solo un problema meridionale”, organizzato a Palermo il 29 novembre 2013
dall'associazione Espressione Libre. "In mancanza di sanzioni, ma soprattutto in
assenza di una autoregolamentazione deontologica, la responsabilità politica
rimarrà impunita, nulla più che un pio desiderio, con la conseguenza che si è
arrivati a candidare e fare eleggere a Palermo, politici sotto processo per
concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, come Marcello
Dell'Utri e Calogero Lo Giudice" ha detto ancora Guarnotta al convegno. Il
riferimento a Dell'Utri e Lo Giudice arriva nella parte della relazione di
Leonardo Guarnotta, quando parla di lotta alla mafia perché "è indispensabile
l'impegno della società civile perché la partita, cioè la lotta alla mafia, che
non possiamo assolutamente permetterci di perdere, si gioca nella quotidianità",
ha detto il presidente del Tribunale di Palermo. Guarnotta poi ha voluto
rimarcare che questa lotta si gioca "nelle scelte, individuali e collettive, non
escluse le scelte elettorali, cioè le scelte che vengono fatte dai segretari di
partito nel selezionare i candidati, da inserire nelle liste e quelle che
operano gli elettori nell'esercizio del diritto-dovere di designare i loro
rappresentanti al Parlamento e nelle istituzioni".
FIGLI DI QUALCUNO E FIGLI
DI NESSUNO.
L’Italia dei figli di
qualcuno e dei figli di nessuno,
scrive Luigi Sanlorenzo su “Sicilia Informazioni”. Quel termometro, ancora per
poco infrangibile, dell’indignazione degli italiani ha raggiunto in queste ore
un nuovo picco alla notizia dell’intervento del Ministro della Giustizia Anna
Maria Cancellieri in favore della scarcerazione per motivi umanitari di Giulia
Ligresti. Già ora montano polemiche roventi, immaginabili paragoni con vicende
simili, richieste di dimissioni e promesse di giustificazioni che occuperanno i
giornali e le televisioni in interminabili dietrologie, pindariche rievocazioni,
ardite ipotesi. Ma non c’è da preoccuparsi, perché prima o poi, una cortina
fumogena sarà sapientemente fatta posare sui fatti. Proprio per tale ragione,
questo articolo ha la pretesa di soffermarsi su una diversa e più pressante
preoccupazione degli italiani circa il diverso destino dei figli di nessuno e
dei figli di qualcuno. E’ noto come il decantato benessere italiano, i
cosiddetti anni del boom che interessarono gli anni ’50 e ’60, si fondò su due
principali eventi sociali: la politica industriale sorretta dagli ingenti fondi
del Piano Marshall nel centro nord del Paese e l’accesso ai ruoli della Pubblica
Amministrazione – ed alle migliaia di enti collegati – di intere coorti di
giovani del Mezzogiorno mediante centinaia di concorsi che rappresentarono in un
Sud maggiormente scolarizzato, una risposta occupazionale e un inedito e rapido
ascensore sociale. Grazie alla possibilità per milioni di diplomati e decine di
migliaia di laureati di accedere ad un posto stabile e sicuro, anche se non
sempre disponibile nella regione di nascita, la società italiana nel complesso
passò nel volgere di un decennio dai bisogni ai desideri, alimentando consumi
alti e medio alti e inaugurando stili di vita molto vicini a quelli dei Paesi
europei più avanzati, se non, in molti casi, degli Stati Uniti del tempo. Per la
prima volta nella storia, il figlio di un contadino poteva diventare qualcuno,
rompendo così l’atavico destino riservato a chi lo aveva preceduto. Per la prima
volta il neo dottore, diventato funzionario ministeriale, impiegato di una banca
pubblica, medico della mutua o semplicemente, assolto l’obbligo scolastico,
usciere alla Provincia o portantino in un ospedale, poteva a propria volta
sognare un futuro ancora migliore per i figli che, numerosi, – i baby boomers –
sarebbero venuti al mondo. Certo, dopo i primi anni, i concorsi divennero sempre
più politicizzati e all’insegna della raccomandazione ma il “borghese piccolo
piccolo” che alberga in tutti noi sapeva che far studiare un figlio avrebbe
comunque portato prima o poi, alle soglie del fatidico concorso, varcate le
quali altri sogni potevano diventare realtà: una famiglia, un sorriso assicurato
da parte di una banca lieta di offrire un mutuo per la casa, l’autovettura di
dimensioni crescenti in proporzione alla carriera, l’assistenza sanitaria, le
ferie al mare o all’estero, magari, presto, la seconda casa per le vacanze. Con
il crollo rovinoso di quel mondo, che pur in modo imperfetto e non sempre
trasparente, sembrava voler realizzare i migliori auspici della Costituzione
Repubblicana, i giovani italiani si sono trovati come coloro cui un uragano
scoperchia la casa. Cresciuti ed educati nella prima parte della propria vita in
famiglia e a scuola con la certezza delle opportunità garantite ai propri
genitori, scelta una facoltà universitaria più con l’occhio al “concorso” che
alla propria reale vocazione, si sono trovati davanti il vuoto. Mentre essi
precipitavano nel baratro del precariato infinito del corpo e dell’anima,
risuonavano da ogni possibile mezzo di comunicazione le ipocrisie di una classe
dirigente farisaica e compromessa. Era giusto infatti che i ministri dei nuovi
governi mettessero in guardia i giovani dall’illusione del posto fisso e li
spronassero a mettersi in gioco. La doppiezza di tale morale emerge oggi quando
si scopre, sempre più spesso, che proprio i figli di quei ministri avevano tutti
già un posto fisso, grazie sicuramente all’influenza di mamma e papà. Mario
Monti ha un figlio, Giovanni Monti, ora 39enne. Ripercorriamo la sua carriera: a
20 anni è già associato per gli investimenti bancari per la Goldman Sachs, banca
d’affari in cui il padre ha ricoperto il ruolo di International Advisor. A 25
anni diventa consulente di direzione da Bain & company e ci rimane fino al 2001.
Dal 2004 al 2009, ha lavorato a Citigroup e in Morgan & Stanley occupandosi in
particolare di transazioni economico-finanziarie sui mercati di Europa, Medio
Oriente e Africa, alle dipendenze dirette degli uffici centrali di New York. La
figlia di Elsa Fornero – l’indimenticabile, sensibile fino alle lacrime,
Ministro del Lavoro che dopo aver chiamato i giovani “choosy”, ovvero con poco
spirito di adattamento e dopo aver consigliato a tutti di “tornare a lavorare la
terra” tacciò gli italiani di essere “scansafatiche” – Silvia Deaglio, ha soli
24 anni quando ottiene un incarico presso un prestigioso college di Boston e 30
quando inizia ad insegnare medicina. Diventa associata all’università di Torino,
l’università dove mamma e papà hanno la cattedra, a soli 37 anni. Il figlio di
Annamaria Cancellieri per la quale gli italiani devono liberarsi dell’idea del
posto fisso vicino ai genitori, Piergiorgio Peluso, appena laureato, inizia una
carriera sfolgorante: dall’Arthur Andersen a Mediobanca, fino a Aeroporti di
Roma, Credit Suisse, Unicredit e Fondiaria Sai, dove è direttore generale
guadagnando circa 500mila euro all’anno. Il resto sarà cronaca dei prossimi
giorni. Certamente i citati sono tutti giovani preparati e in gamba ma
probabilmente ambiti da multinazionali anche per altre ragioni. Essi comunque
non saranno stati certo delle menti così eccezionali rispetto a migliaia di
altri coetanei preparati e volenterosi che ormai alle soglie dei 40 anni non
avranno mai una famiglia propria, una casa o una pensione. In una democrazia i
figli di “nessuno” come chi scrive, possono salire la scala sociale soltanto se
messi alla prova del merito comparativo e dei meccanismi dei concorsi da
reinventare modernamente nel nostro disperato Paese. Diverso è infatti il
destino dei figli di qualcuno che, nella vita, “qualcuno” diventano comunque,
spesso ben oltre le proprie reali capacità. Con qualche eccezione di chi, per
sensibilità personale o scelta esistenziale, decide di rifiutare i privilegi a
di rischiare una vita normale e di cui essere il vero, spesso drammatico,
protagonista. La mattina del 15 novembre 2000 il corpo senza vita di Edoardo
Agnelli, 46 anni, venne trovato da un pastore cuneese, Luigi Asteggiano, presso
la base del trentacinquesimo pilone del viadotto autostradale Generale “Franco
Romano” della Torino-Savona, nei pressi di Fossano. La sua Croma scura, con il
motore ancora acceso e il bagagliaio socchiuso, era parcheggiata a lato della
carreggiata del viadotto che sovrasta il fiume Stura di Demonte. La magistratura
concluse presto le indagini formulando l’ipotesi del suicidio. Nelle rare
interviste concesse alla stampa, il figlio del più noto Avvocato della storia
italiana, aveva affermato di voler prendere le distanze dai valori del
capitalismo e di volersi dedicare a studi di teologia. Edoardo Agnelli non
nascondeva di simpatizzare per il marxismo-leninismo in chiave mistica e verso
l’Iran sciita; secondo voci non confermate negli ultimi anni aveva cambiato
persino nome, assumendo un nome islamico. Era comparso in pochissime occasioni
pubbliche e in qualche manifestazione religiosa o antinuclearista. I tentativi
di inserirlo in attività collaterali del grande gruppo aziendale di famiglia,
tra cui anche una breve esperienza nel Consiglio d’Amministrazione della
Juventus nel 1986, non avevano dato buon esito. Edoardo era diverso. La fine di
Edoardo Agnelli, contrapposta all’aridità e all’egoismo di una borghesia che si
auto perpetua non attraverso i meriti ma grazie alla fitta trama di relazioni ed
alleanze che vanno ben oltre gli schieramenti ufficiali nella vita politica o
delle cordate imprenditoriali, mi ha sempre ricordato la figura di Hanno
Buddenbrook, la saga della cui famiglia fu il testo pretesto della mia tesi di
laurea, nel lontano 1980. Hanno Buddenbrook è l’ultimo discendente dei
Buddenbrook, fiorente famiglia della borghesia mercantile tedesca, di cui il
romanzo racconta attraverso tre generazioni la progressiva decadenza che segna
la decomposizione di un certo tipo di società. Hanno ne incarna l’epilogo,
attraverso la sua inettitudine, che tanto più poeticamente risalta in quanto
diviene icona di un’intera epoca che tramonta, schiacciata dal peso dei suoi
riti, dei suoi mascheramenti, dei suoi valori opprimenti. Nei giorni scorsi
Rachid Khadiri Abdelmoula, il 27enne marocchino torinese, dopo una vita passata
a vendere accendini e fazzoletti tra Palazzo Nuovo e la Mole di giorno e a
studiare di notte, si è laureato in ingegneria al Politecnico. Il “marocchino”
(così definisce se stesso, scherzando su provenienza e senso dato in Italia al
termine) più famoso d’Italia è tornato oggi a far parlare di sè per una scelta
decisamente controcorrente. Rachid sta infatti resistendo in questi giorni alle
lusinghe della televisione commerciale rispondendo con insistiti “no, grazie”
alle reiterate proposte che arrivano da Endemol per partecipare all’edizione
2014 del Grande Fratello. Tra lo stupore di tutti ha dichiarato: “I miei valori
sono altrove. Non mi riconosco neanche un po’ in una trasmissione che non trovo
seria ed educativa. Cosa ci andrei a fare? A recitare? Il successo è un mondo di
nicchia, lo stringono in pochissimi. Gli altri si illudono, poi rimangono
spiazzati quando la fama svanisce. Ai sogni bisogna obbedire. Il mio è di fare
l’ingegnere con la cravatta. Come mi vedo tra dieci anni? Spero di aver
svoltato. Non in uno studio televisivo, ma in uno di progettisti.” Nel Capitolo
38 dedicato alle cause della decadenza di Roma , l’illuminista Edward Gibbon,
autore de The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (1776) ha
scritto: “ essa fu conseguenza naturale della sua grandezza. La prosperità portò
a maturazione il principio della decadenza…Invece di chiederci perché fu
distrutto, dovremmo sorprenderci che abbia retto tanto a lungo”. Un monito
estremamente contemporaneo che dovrebbe bastare ad una società come la nostra
che ha smarrito da tempo anche il ricordo delle energie vitali da cui nacque e
che sembra ogni giorno di più di intravedere nelle storie esemplari dei tanti
figli di immigrati che, forse, rifaranno l’Italia.
E che dire ancora.
Non ci sono
anormali, ma normali diversi,
scrive Michele Marzano su “La
Repubblica”. Pochi giorni fa, il Tribunale dei Minori di Roma ha autorizzato una
coppia ad adottare un bambino straniero, a patto però che il bimbo fosse
"perfettamente sano". La decisione è stata subito contestata non solo dall'Aibi
(l'associazione Amici dei bambini) - che intende presentare un esposto alla
Procura generale della Cassazione - ma anche dal Presidente del Tribunale dei
minori, Melita Cavallo, che spera che una cosa del genere "non si ripeta più".
Ma al di là di queste contestazioni più che opportune, che cosa rivela
l'utilizzo di questo tipo di espressioni? Chi di noi può definirsi
"perfettamente sano"? All'epoca del mito della perfezione, sembra scontato ed
evidente poter giudicare le persone e valutarle in base ad una serie di criteri
reputati oggettivi. Come se l'intelligenza, la salute e la bellezza potessero
essere veramente calcolate e misurate. Come se il valore di una persona
dipendesse dalla sua capacità o meno di corrispondere a determinati criteri. E
se tutto ciò fosse solo il retaggio di un determinismo biologico e genetico
ormai desueto? Se il valore di una persona fosse altrove, non solo perché la
perfezione non esiste, ma anche perché, molto spesso, sono proprio coloro che
sembrano "oggettivamente sani" che poi si rivelano "soggettivamente malati"?
Come spiegava bene Georges Canguilhem negli anni Sessanta, la salute non è
un'entità fissa. Anzi, varia a seconda dei contesti e delle persone, e solo chi
soffre può veramente valutare il proprio stato di salute. Ecco perché non esiste
alcuna definizione oggettiva della normalità e dell'anormalità. Tanto più che le
persone sono tutte differenti l'una dall'altra e che, inevitabilmente, ognuno
presenta "un'anomalia" rispetto agli altri. "L'anormale non è ciò che non è
normale", scrive in proposito Canguilhem, "ma è piuttosto un normale
differente". Peccato che, nonostante tutto, la differenza continui ancora oggi
ad essere identificata con l'inferiorità, e che persista un'insopportabile
intolleranza nei confronti delle fragilità umane, al punto da illudersi che la
felicità dipenda dal proprio essere "perfettamente sani". La fragilità, in sé,
non è un problema. Anzi, è proprio nel momento in cui ci fermiamo un istante e
cerchiamo di entrare in contatto con noi stessi, che ci rendiamo poi conto che
questa nostra fragilità può diventare un punto di forza. Perché ci aiuta a
crescere e a cambiare. Perché ci rivela qualcosa di noi che per tanto tempo, a
torto, abbiamo fatto di tutto per ignorare. Soprattutto quando capiamo che
l'essere umano non è una semplice somma di competenze più o meno sviluppate, e
che i successi, come ricorda sempre Georges Canguilhem, sono spesso dei
"fallimenti ritardati". Speriamo che lo capiscano anche i giudici quando
autorizzano o meno una coppia ad adottare. Non solo perché l'essere
"perfettamente sano" è un'espressione priva di senso, ma anche perché l'amore
dei genitori non può certo dipendere dallo stato di salute dei propri figli.
E poi c’è l’anormalità
fatta normalità
con un commento di Susanna Tamaro. «La notizia dei tre miliardi sottratti allo
Stato da parte di 5.000 dipendenti pubblici, che si aggiunge a quella dei finti
poveri, dei falsi ciechi o dei turlupinatori di pensioni che ogni giorno vengono
«scoperti» dalla Guardia di Finanza, non può che turbare - dove «turbare» è un
eufemismo - le tante persone oneste di questo Paese, sempre più perseguitate da
un Fisco che li ritiene gli unici «privilegiati» interlocutori. Non è populismo
affermare che molti dei nostri problemi economici sarebbero in parte risolvibili
con una bella e definitiva pulizia degli sprechi e degli assurdi privilegi che
l’apparato statale permette e concede a tutti coloro che sono riusciti a
infilarsi sotto le sue ali mafiosamente protettive. Com’è possibile, infatti, ci
chiediamo noi contribuenti, che per dieci, venti, trent’anni una persona
percepisca una pensione di invalidità come cieco pur essendo perfettamente
vedente, mentre una nostra qualsiasi minima mancanza, che sia una multa o un
mancato pagamento di un contributo, viene immediatamente sanzionata e punita con
severità? Quanti ciechi ci vogliono per non vedere un finto cieco? Come ci
interroghiamo anche - e purtroppo sappiamo già la risposta - su quanti di questi
5.073 dipendenti dello Stato che hanno rubato, truffato, corrotto avranno come
conseguenza la perdita del loro posto di lavoro. Non sono un’esperta di
amministrazione statale, ma temo che la risposta sia «nessuno». Questi uomini e
donne che hanno tradito il patto di fiducia etico su cui si regge la società,
hanno anche danneggiato i loro colleghi che lavorano con serietà e dedizione.
Quali conseguenze avrà questo tradimento? Forse soltanto una multa o il
trascinarsi in un processo che durerà anni e che finirà in una bolla di sapone.
Il messaggio che ci viene costantemente dato dallo Stato è che in fondo le
nostre azioni non sono influenti, che il comportarsi bene o male non cambia
nulla, se si ha un posto garantito. Il messaggio che quindi passa alle
generazioni future è quello che il merito e l’etica in Italia non hanno alcun
peso, cosa che peraltro viene confermata in ogni ambito della nostra società,
dall’università alla pubblica amministrazione. A volte, quando guardo i politici
immersi nelle loro costanti e sterili polemiche televisive, mi domando: si
rendono veramente conto dello stato di esasperazione della parte sana del nostro
Paese? Credo proprio di no. Se si rendessero conto, infatti, agirebbero di
conseguenza, senza timore dell’impopolarità, sfrondando, pulendo, liberandoci da
tutto ciò che è inutile, offensivo e dannoso. È la mancanza di questa semplice
azione a spingere sempre più italiani verso l’indifferenza, il cinismo, il
disinteresse o tra le braccia dei movimenti che afferrano le viscere e le
torcono, perché è lì che, alla fine, si annida la disperazione degli onesti. È
su questo che riflettevo, andando in bicicletta per le colline umbre, desolata
dallo spettacolo che ormai accompagna ogni mia escursione. Avevo appena superato
la carcassa di un televisore abbandonato in mezzo ai rovi; doveva essere un
lancio recente, dato che la settimana scorsa non c’era, come non c’era neppure
il water di porcellana rovesciato in un fosso, sulla via del ritorno. Anche lui
una new entry nel mio paesaggio ciclistico. Chi, come i nostri politici, viaggia
sempre in automobile forse non sa che quasi la totalità dei bordi delle nostre
strade e autostrade è costellato di rifiuti e spazzatura. Ogni metro quadrato è
invaso da bottiglie di acqua minerale, lattine, scatole di sigarette, pannolini,
preservativi, batterie di automobili, plastiche: tutto viene allegramente
scaraventato fuori dai finestrini. Se poi si abbandonano le strade asfaltate e
si imboccano quelle bianche, il panorama diventa ancora più orrendamente
variegato: frigoriferi, lavatrici, pneumatici di tutte le dimensioni, reti da
letto sfondate, materassi, divani, poltrone, computer, bidet, carcasse di
biciclette o di motorino e spesso anche automobili senza targa, per non parlare
delle lastre di amianto, residui di pollai e di stalle, maldestramente nascosti
sotto pochi centimetri di terra. E tutto questo non accade soltanto nella terra
dei fuochi, ma anche nella verde e felice Umbria. Bisogna aver il coraggio di
dirlo apertamente: il nostro Paese - il meraviglioso giardino d’Europa -
è una discarica a cielo aperto, di cui la «Terra dei fuochi» non è che la punta
di un iceberg. Questo disprezzo per il luogo in cui viviamo, oltre a provocare
un enorme danno all’ambiente e al turismo, è uno specchio fedele dell’assenza di
senso civico che permea ormai tutto il Paese e di cui la classe politica è
stata, fino ad ora, la garante. Dopo di me il diluvio, potrebbe assurgere a
nostro motto nazionale. Il fatto che esistano, in ogni comune, delle isole
ecologiche in cui smaltire ciò che non serve più cambia solo in parte le cose,
perché questi luoghi hanno orari e leggi da rispettare, e perché mai dovrei
rispettare un orario e una legge, se posso non farlo? Per anni, camminando in
montagna, mi sono arrabbiata vedendo tutto quello che veniva abbandonato
lungo i sentieri. Poi ho capito che quello sporco riguardava anche me, che
arrabbiarsi e non fare niente mi rendeva complice del degrado. Così ho
cominciato a raccogliere bottigliette di plastica, rifiuti e lattine come
fossero fiori, riportandoli a valle con me. È questo che tutti noi dovremmo
fare. Ciò che è fuori è sempre lo specchio di ciò che è dentro. L’immondizia che
devasta il nostro Paese non è che la manifestazione del degrado etico che
pervade ogni ambito della nostra società. Così, pedalando desolata, pensavo:
come sarebbe se ogni comune, ogni quartiere di città, mettesse a disposizione di
noi cittadini dei mezzi per permetterci di raccogliere in prima persona i
rifiuti abbandonati criminalmente per strada o nei boschi. E poi sarebbe anche
bello che tutta questa spazzatura, invece di venir immediatamente smaltita e
dimenticata, lasciando spazio all’arrivo di nuova, venisse portata nelle piazze
principali dei paesi e dei quartieri e affidata alle mani esperte di ragazzi
diplomati alle varie Accademie di belle arti, per venir trasformata, grazie alla
loro creatività, in temporanei monumenti alla nostra inciviltà. Così, durante la
passeggiata domenicale, prendendo un caffè o conversando con gli amici, tutti
noi potremmo ammirare per un anno gli oggetti che abbiamo abbandonato: guarda,
la mia vecchia lavatrice, il mio bidet, il televisore della nonna! Sarebbe
istruttivo che poi tutti questi precari monumenti al nostro degrado venissero
fotografati e raccolti in un delizioso libretto dal titolo: «Ciò che eravamo,
ciò che non vogliamo più essere». Susanna Tamaro».
LA TERRA DEI CACHI, DEI
PARLAMENTI ABUSIVI E DELLE LEGGI, PIU’ CHE NULLE: INESISTENTI.
La Terra dei Cachi (di
Belisari, Conforti, Civaschi, Fasani) è la canzone cantata da Elio e le Storie
Tese al Festival di Sanremo 1996, classificatasi al secondo posto nella
classifica finale e vincitrice del premio della critica. Prima nelle classifiche
temporanee fino all'ultima serata, il secondo posto nell'ultima provocò molte
polemiche su presunte irregolarità del voto, confermate dalle indagini dei
carabinieri che confermarono che La terra dei cachi era stata la canzone più
votata. Il testo racconta la vita e le abitudini dell'Italia travolta da
scandali su scandali (il pizzo, episodi criminali mai puniti, la malasanità) e
piena di comportamenti che caratterizzano il cittadino italiano nel mondo, come
la passione per il calcio, la pizza e gli spaghetti.
Parcheggi abusivi, applausi
abusivi,
Villette abusive, abusi
sessuali abusivi;
Tanta voglia di ricominciare
abusiva.
Appalti truccati, trapianti
truccati,
Motorini truccati che scippano
donne truccate;
Il visagista delle dive è
truccatissimo.
Papaveri e papi, la donna
cannolo,
Una lacrima sul visto: Italia
sì, Italia no.
Italia sì, Italia no, Italia
bum, la strage impunita.
Puoi dir di sì, puoi dir di
no, ma questa è la vita.
Prepariamoci un caffè, non
rechiamoci al caffè:
C'è un commando che ci aspetta
per assassinarci un pò.
Commando sì, commando no,
commando omicida.
Commando pam, commando
prapapapam,
Ma se c'è la partita
Il commando non ci sta e allo
stadio se ne va,
Sventolando il bandierone non
più il sangue scorrerà.
Infetto sì? Infetto no?
Quintali di plasma.
Primario sì, primario dai,
primario fantasma.
Io fantasma non sarò, e al tuo
plasma dico no;
Se dimentichi le pinze
fischiettando ti dirò:
"Fi fi fi fi fi fi fi fi, ti
devo una pinza.
Fi fi fi fi fi fi fi fi, ce
l'ho nella panza".
Viva il crogiuolo di pinze,
viva il crogiuolo di panze. Eh
Quanti problemi irrisolti, ma
un cuore grande così.
Italia sì, Italia no, Italia
gnamme, se famo dù spaghi.
Italia sob, Italia prot, la
terra dei cachi.
Una pizza in compagnia, una
pizza da solo;
Un totale di due pizze e
l'Italia è questa qua.
Fufafifi, fufafifi, Italia
evviva.
Squerellerellesh,
cataraparupai,
Italia perfetta, perepepè
nainananai.
Una pizza in compagnia, una
pizza da solo;
In totale molto pizzo ma
l'Italia non ci sta.
Italia sì, Italia no,
scurcurrillu currillo.
Italia sì: uè.
Italia no, spereffere
fellecche.
Uè, uè, uè, uè,uè.
Perchè la terra dei cachi è la
terra dei cachi.
«Una società sciapa e infelice
in cerca di connettività».Così il Censis definisce la situazione sociale
italiana nel suo 47mo illustrato a Roma dal direttore generale Giuseppe Roma e
dal presidente Giuseppe De Rita. Una società, quella italiana, che sembra sempre
ad un passo dal crollo ma che non crolla. «Negli anni della crisi - si legge nel
rapporto del Censis - abbiamo avuto il dominio di un solo processo, che ha
impegnato ogni soggetto economico e sociale: la sopravvivenza. C’è stata la
reazione di adattamento continuato (spesso il puro galleggiamento) delle imprese
e delle famiglie. Abbiamo fatto tesoro di ciò che restava nella cultura
collettiva dei valori acquisiti nello sviluppo passato (lo «scheletro
contadino», l’imprenditorialità artigiana, l’internazionalizzazione su base
mercantile), abbiamo fatto conto sulla capacità collettiva di riorientare i
propri comportamenti (misura, sobrietà, autocontrollo), abbiamo sviluppato la
propensione a riposizionare gli interessi (nelle strategie aziendali come in
quelle familiari). Siamo anche una «società sciapa e infelice» secondo il Censis
«senza fermento e dove circola troppa accidia, furbizia generalizzata,
disabitudine al lavoro, immoralismo diffuso, crescente evasione fiscale,
disinteresse per le tematiche di governo del sistema, passiva accettazione della
impressiva comunicazione di massa». Di conseguenza siamo anche «infelici, perché
viviamo un grande, inatteso ampliamento delle diseguaglianze sociali». A
giudizio dei ricercatori del Censis si sarebbe «rotto il “grande lago della
cetomedizzazione”, storico perno della agiatezza e della coesione sociale.
Troppa gente non cresce, ma declina nella scala sociale. Da ciò nasce uno
scontento rancoroso, che non viene da motivi identitari, ma dalla crisi delle
precedenti collocazioni sociali di individui e ceti». Ciò avrebbe determinato
una vera e propria fuga all’estero. Nell’ultimo decennio il numero di italiani
che hanno trasferito la propria residenza all’estero è più che raddoppiato,
passando dai circa 50mila del 2002 ai 106mila del 2012. Ma è stato soprattutto
nell’ultimo anno che l’aumento dei trasferimenti è stato particolarmente
rilevante: (+28,8% tra il 2011 e il 2012). Una reazione al grave disagio
sociale, all’ instabilità lavorativa e sottoccupazione che interessa il 25,9%
dei lavoratori: una platea di 3,5 milioni di persone ha contratti a termine,
occasionali, sono collaboratori o finte partite Iva. Ci sono poi 4,4 milioni di
italiani che non riescono a trovare un’occupazione «pure desiderandola». Per il
Censis «2,7 milioni sono quelli che cercano attivamente un lavoro ma non
riescono a trovarlo, un universo che dallo scoppio della crisi è quasi
raddoppiato (+82% tra il 2007 e il 2012)». Ci sono poi 1,6 milioni di italiani
che, «pur disponibili a lavorare, hanno rinunciato a cercare attivamente un
impiego perché convinti di non trovarlo». Cresce sempre più il disinteresse per
la politica: il 56% degli italiani (contro il 42% della media europea) non ha
attuato nessun tipo di coinvolgimento civico negli ultimi due anni, neppure
quelli di minore impegno, come la firma di una petizione. Più di un quarto dei
cittadini manifesta una lontananza pressoché totale dalla dimensione politica,
non informandosi mai al riguardo. Al contrario, si registrano nuove energie
difensive in tanta parte del territorio nazionale contro la chiusura di
ospedali, tribunali, uffici postali o presidi di sicurezza. Tuttavia il Censis
vede anche dei segnali positivi e di tenuta sociale. «Si registra una sempre più
attiva responsabilità imprenditoriale femminile (nell’agroalimentare, nel
turismo, nel terziario di relazione), l’iniziativa degli stranieri, la presa in
carico di impulsi imprenditoriali da parte del territorio, la dinamicità delle
centinaia di migliaia di italiani che studiano e/o lavorano all’estero (sono più
di un milione le famiglie che hanno almeno un proprio componente in tale
condizione) e che possono contribuire al formarsi di una Italia attiva nella
grande platea della globalizzazione». Nuove energie si sprigionano inoltre in
due ambiti che permetterebbero anche l’apertura di nuovi spazi imprenditoriali e
di nuove occasioni di lavoro. «Il primo -si legge nel rapporto- è il processo di
radicale revisione del welfare. Il secondo è quello della economia digitale:
dalle reti infrastrutturali di nuova generazione al commercio elettronico, dalla
elaborazione intelligente di grandi masse di dati, dallo sviluppo degli
strumenti digitali ai servizi innovativi di comunicazione, alla crescita
massiccia di giovani “artigiani digitali”». Il nuovo motore dello sviluppo,
secondo il Censis, potrebbe essere la connettività (non banalmente la
connessione tecnica) fra i soggetti coinvolti in questi processi». Se infatti
«restiamo una società caratterizzata da individualismo, egoismo
particolaristico, resistenza a mettere insieme esistenze e obiettivi, gusto per
la contrapposizione emotiva, scarsa immedesimazione nell’interesse collettivo e
nelle istituzioni» avremmo anche raggiunto il punto più basso dal quale non
potrà che derivare un progressivo superamento di questa «crisi antropologica».
Per fare connettività, secondo il Censis, non si può contare sulle istituzioni
«perché autoreferenziali, avvitate su se stesse, condizionate dagli interessi
delle categorie, avulse dalle dinamiche che dovrebbero regolare, pericolosamente
politicizzate, con il conseguente declino della terzietà necessaria per gestire
la dimensione intermedia fra potere e popolo». Neanche la politica può
sviluppare questa connettività perché «più propensa all’enfasi della
mobilitazione che al paziente lavoro di discernimento e mediazione necessario
per fare connettività, scivolando di conseguenza verso l’antagonismo, la
personalizzazione del potere, la vocazione maggioritaria, la strumentalizzazione
delle istituzioni, la prigionia decisionale in logiche semplificate e rigide».
Se dunque, conclude il Censis, «istituzioni e politica non sembrano in grado di
valorizzarla, la spinta alla connettività sarà in orizzontale, nei vari
sottosistemi della vita collettiva. A riprova del fatto che questa società, se
lasciata al suo respiro più spontaneo, produce frutti più positivi di quanto si
pensi».
Quella che emerge è una
nazione senza scrupoli, che lucra su ogni fonte di guadagno fregandosene delle
leggi, della salute della gente e del territorio. Scorie tossiche nelle
campagne, rigassificatori a un chilometro dai templi di Agrigento, la decadenza
dei Sassi di Matera beneficiari di finanziamenti per la tutela di milioni di
euro. L’annientamento di due giudici e dei loro tecnici, avviato e pianificato
con precisione maniacale da politici e colleghi, e approvato senza batter ciglio
da un Consiglio Superiore della Magistratura che anziché proteggerli dagli
attacchi, li consegna agli sciacalli per voce di Letizia Vacca (non me ne voglia
il bovino): “due cattivi magistrati”. Il “non sapevo” oggi non è più tollerato,
perché se un giorno De Magistris sarà punito dal Csm nonostante la Procura di
Salerno dice che contro di lui è in atto un complotto, se la Forleo perderà la
funzione di Gip per aver fatto scoprire all’Italia gli alpinisti della sinistra,
questo avverrà di fronte ad una nazione cosciente, che forse allora reagirà.
Ignorantia legis non excusat.
La certezza della pena non
esiste più. Ci troviamo in una situazione di «indulto quotidiano», in cui tutti
parlano ma nessuno fa. Il capo della Polizia non usa mezzi termini per definire
lo stato della certezza della pena in Italia. «Viviamo una situazione di indulto
quotidiano - dice alle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato
- di cui tutti parlano. Ma su cui non si è fatto nulla negli ultimi anni». La
pena, aggiunge, «oggi è quando di più incerto esiste in Italia»; un qualcosa che
rende «assolutamente inutile» la risposta dello Stato e «vanifica» gli sforzi di
polizia e magistratura. «Non gioco a fare il giurista - prosegue il capo della
Polizia - nè voglio entrare nelle prerogative del Parlamento, ma quella che
abbiamo oggi è una situazione vergognosa. La criminalità diffusa in Italia ha un
segmento di fascia delinquenziale ben identificato che si chiama immigrazione
clandestina» ha aggiunto il capo della polizia. «Il 30 per cento degli autori di
reato di criminalità diffusa sono immigrati clandestini, ma questa media
nazionale del 30 per cento va disaggregata». Così, ha proseguito il capo della
polizia, si scopre, che se al Sud i reati commessi da clandestini incidono
relativamente poco («i reati compiuti da irregolari si attesta intorno al 30 per
cento»), al Nord e in particolare nel Nord est «si toccano picchi del 60-70 per
cento». La maggior parte degli immigrati clandestini entra in Italia non
attraverso gli sbarchi ma con un visto turistico. «Solo il 10 per cento dei
clandestini entra nel nostro Paese attraverso gli sbarchi a Lampedusa- dice il
capo della polizia- mentre il 65-70 per cento arriva regolarmente e poi si
intrattiene irregolarmente». E conclude: «Il 70 per cento di quei crimini
commessi nel Nord est da irregolari è compiuta proprio da chi arriva con visto
turistico e poi rimane clandestinamente sul nostro territorio». Per contrastare
la clandestinità, riflette Manganelli, «occorre quindi non solo il contrasto
all'ingresso, ma il controllo della permanenza sul territorio dei clandestini».
Ma le randellate sono riservate anche alla polizia. "La polizia ha una cultura
deviata delle indagini perché pensa che identificare una persona che partecipa a
una manifestazione consenta, poi, di attribuirle tutti i reati commessi
nell’ambito della stessa manifestazione". A sottolinearlo il sostituto
procuratore generale della Cassazione Alfredo Montagna nella sua requisitoria
del 27 novembre 2008 innanzi alla prima sezione penale della Cassazione
nell’ambito dell’udienza per gli scontri avvenuti a Milano, l’11 marzo 2006 a
corso Buenos Aires, durante una manifestazione antifascista non autorizzata
promossa dalla sinistra radicale dei centri sociali e degli autonomi per
protestare contro un raduno della formazione di estrema destra "Forza Nuova". Lo
ha detto in contrarietà ai suoi colleghi dei gradi di giudizio precedenti.
"Quello affermato per la
Diaz deve valere anche per i cittadini"
"La Giustizia deve essere amministrata - ha proseguito Montagna - con equità e
non con due pesi e due misure: quel che è stato affermato per i poliziotti della
Diaz, nel processo di Genova, deve valere anche per il cittadino qualunque e non
solo per i colletti bianchi. Se è vero, come è vero nel nostro ordinamento che è
personale il principio della responsabilità penale, questo deve valere per tutti
mentre ho l’impressione che nel nostro Paese oggi, si stia allargando la
tendenza ad una minor tutela dei soggetti più deboli, come possono essere i
ragazzi un pò scapestrati". Montagna ha aggiunto che "non può passare, alla
pubblica opinione, un messaggio sbagliato per cui sui fatti della Diaz i giudici
decidono in maniera differente rispetto a quando si trovano a giudicare episodi
come quelli di corso Buenos Aires". Invece i giudici hanno deciso in modo
differente: per i poliziotti e i loro dirigenti assoluzione quasi generale; per
i ragazzi condanne confermate per tutti.
Ma le stoccate vengono portate
su tutto il sistema. "Profili di patologie emergono nel settore dei lavori
pubblici e delle pubbliche forniture, nonché nella materia sanitaria, fornendo
un quadro di corruzione ampiamente diffuso". Lo ha sottolineato il procuratore
generale della Corte dei Conti, nella Relazione all'apertura dell'anno
giudiziario della magistratura contabile. Il Pg ha aggiunto che "in particolare
l'accertamento del pagamento di tangenti è correlato ad artifici ed irregolarità
connesse a fattispecie della più diversa natura, quali la dolosa alterazione di
procedure contrattuali, i trattamenti preferenziali nel settore degli appalti
d'opera, la collusione con le ditte fornitrici, la illecita aggiudicazione, la
irregolare esecuzione o l'intenzionale alterazione della regolare esecuzione
degli appalti di opere, forniture e servizi". Comportamenti illeciti di cui e'
conseguenza "il pagamento di prezzi di gran lunga superiori a quelli di mercato
o addirittura il pagamento di corrispettivi per prestazioni mai rese".
L’Italia non crede più nelle
istituzioni che dovrebbero guidarla. Il potere "esercita il comando senza
obiettivi e senza principi, perde ogni rapporto con la realtà del Paese",
diventa autoreferenziale e alla fine forma "una società separata", con una sua
lingua, le sue gazzette, i suoi clan, i suoi privilegi. Questa "società separata
ha le finestre aperte solo su se stessa", denuncia il Rapporto Italia
dell'Eurispes. In realtà, sottolinea l'Istituto di studi economici e sociali, la
politica non c'è più: è estinta, grazie alla tenacia dei poliburocrati, i
burocrati dei due poli, ora quasi tutti in "overdose", sopraffatti dai loro
stessi abusi.
È una fotografia impietosa
quella scattata dal Censis nel suo Rapporto sulla situazione sociale del
Paese. L’Italia, secondo l’istituto di ricerca socioeconomica presieduto da
Giuseppe De Rita, è un Paese apatico, senza speranza verso il futuro, nel quale
sono sempre più evidenti, sia a livello di massa sia a livello individuale,
«comportamenti e atteggiamenti spaesati, indifferenti, cinici, prigionieri delle
influenze mediatiche». Gli italiani si percepiscono, scrive il Censis, come
«condannati al presente senza profondità di memoria e di futuro», vittime di
fittizi «desideri mai desiderati» come l’ultimo cellulare alla moda e in preda
spesso a «narcisismo autolesionistico», come è testimoniato dal fenomeno del
«balconing». Quella italiana sarebbe, in sostanza, una società «pericolosamente
segnata dal vuoto».
"Una mucillagine sociale
che inclina continuamente verso il peggio".
Così il Censis descrive la
realtà italiana, costituita da una maggioranza che resta "nella vulnerabilità,
lasciata a se stessa", "più rassegnata che incarognita", in un'inerzia diffusa
"senza chiamata al futuro".
La realtà diventa ogni giorno
"poltiglia di massa - spiega il Rapporto sulla situazione sociale del paese -
indifferente a fini e obiettivi di futuro, ripiegata su se stessa"; la società è
fatta di "coriandoli" che stanno accanto per pura inerzia.
Una minoranza industriale,
dinamica e vitale, continua nello sviluppo, attraverso un'offerta di fascia
altissima del mercato, produzioni di alto brand, strategie di nicchia,
investimenti all'estero; cresce così la voglia di successo degli imprenditori e
il loro orgoglio rispetto al mondo di finanza e politica.
Ma "siamo dentro una dinamica
evolutiva di pochi e non in uno sviluppo di popolo": "la minoranza industriale
va per proprio conto, il governo distribuisce 'tesoretti'", ma lo sviluppo non
filtra perché non diventa processo sociale e la società sembra adagiata in
un'inerzia diffusa.
Lo sviluppo di una minoranza
non ha saputo rilanciare i consumi e la maggioranza si orienta per acquisizioni
low cost e su beni durevoli, senza un clima di fiducia.
L'italiano medio dovunque giri
lo sguardo sembra pensare di fare esperienza del peggio: nella politica, nella
violenza intrafamiliare, nella micro-criminalità e nella criminalità
organizzata, nella dipendenza da droga e alcool, nella debole integrazione degli
immigrati, nella disfunzione delle burocrazie, nella bassa qualità dei programmi
tv.
La minoranza industriale,
dinamica e vitale, non ce la fa a trainare tutti, visto che é concentrata sulla
conquista di mercati ricchi e lontani, con prodotti a prezzo così alto che non
possono scatenare effetto imitativo.
La pur indubbia ripresa - fa
notare il Censis - rischia di essere malata se non si immette fiducia nel
futuro.
La classe politica, scossa
dalla ventata di antipolitica, non può fare da collettore di energie.
Solo delle minoranze "possono
trovare la base solida da cui partire" e "sprigionare le energie necessarie per
uscire dallo stallo odierno"; si tratta delle minoranze che fanno ricerca e
innovazione, giovani che studiano all'estero, professionisti che esplorano nuovi
mercati; chi ha scelto di vivere in realtà locali ad alta qualità della vita;
minoranze che vivono l'immigrazione come integrazione, che credono in
un'esperienza religiosa e sono attente alla persona, che hanno scelto di
appartenere a gruppi, movimenti, associazioni, sindacati.
Le diverse minoranze dovranno
gestire da sole una sfida faticosa, immaginando spazi nuovi di impegni
individuali e collettivi: una sfida assolutamente necessaria - per il Censis -
per allontanare l'inclinazione al peggio che "fa rasentare l'ignominia
intellettuale e un'insanabile noia".
Il presidente del Censis, De
Rita: “Italia rassegnata e furba senza senso del peccato. Lo Stato ha perso
autorità morale e sta saltando.”
Nella reazione dell’opinione
pubblica ai ripetuti scandali, c’è una sorta di rassegnazione al peggio, un
atteggiamento diverso rispetto all’era Tangentopoli, eppure questo approccio non
stupisce il presidente del Censis Giuseppe De Rita: «Sì, in giro c’è una
rassegnazione vera, ma anche furba. Chiunque di noi può ascoltare grandi
dichiarazioni indignate: “Qui sono tutti mascalzoni!”. La gente ragiona così:
sento tutti parlare male di tutti e anche io faccio lo stesso. Dopodiché però
non scatta la molla: e io che faccio? Non scatta per l’assenza di codici ai
quali ubbidire. Non scatta perché non c’è più un vincolo collettivo. Tutto può
essere fatto se io stesso ritengo giusto che sia fatto».
La profondità e
l’autorevolezza della sua lettura della società e del costume italiano già da
tempo hanno fatto di Giuseppe De Rita un’autorità morale, una dei pochissimi
intellettuali italiani che è impossibile incasellare.
«Siamo passati dal grande
delitto ai piccoli delitti. Dall’Enimont al piccolo appalto. Ma questa è la
metafora del Paese. A furia di frammentare, anche i reati sono diventati più
piccoli e ciascuno se li assolve come vuole. E’ entrato in crisi il senso del
peccato, ma lo Stato che dovrebbe regolare i comportamenti sconvenienti, non ha
più l’autorità morale per dire: quel reato è veramente grave. E allora salta lo
Stato. Come sta accadendo adesso. Se sei un piccolo ladruncolo, cosa c’è di
meglio che prendersela col grande ladro? Se fai illegalmente il secondo lavoro
da impiegato pubblico, poter dire che quelli lì erano ladri e si sono mangiati
tutto, non è un alibi, ma è una messa in canto della propria debolezza. Le
formichine italiane hanno fatto il Paese, ma hanno preso tutto quello che era
possibile dal corpaccione pubblico. Noi che predicavamo le privatizzazioni
“alte”, non abbiamo capito che il modo italico di privatizzare era tradurre in
interesse privato qualsiasi cosa. Un fenomeno di massa: ognuno si è preso il suo
pezzetto di risorsa pubblica. La classe dirigente della Seconda Repubblica non
è stata soltanto la “serie B” della Prima, ma le sono mancati riferimenti di
autorità morale. Una classe dirigente si forma sotto una qualche autorità etica.
De Gasperi si era formato nell’Austria-Ungheria, il resto della classe dirigente
democristiana, diciamoci la verità, si è formata in parrocchia. La classe
dirigente comunista si era formata in galera o nella singolare moralità del
partito. Questa realtà di illegalità diffusa ha inizio con don Lorenzo Milani.
Con don Milani e l’obiezione di coscienza. Ci voleva una autorità morale come la
sua per dire che la norma della comunità e dello Stato è meno importante della
mia coscienza. E’ da lì che inizia la stagione del soggettivismo etico.
Un’avventura che prende tre strade. La prima: la libertà dei diritti civili.
Prima di allora non dovevi divorziare, non dovevi abortire, dovevi fare il
militare, dovevi obbedire allo Stato e poi sei diventato libero di fare tutto
questo. Seconda strada: la soggettività economica, ciascuno ha voluto essere
padrone della propria vita, non vado sotto padrone, mi metto in proprio. E’ il
boom delle imprese. La terza strada, la più ambigua: la libertà di essere se
stessi e quindi di poter giudicare tutto in base ad un criterio personale. Il
marito è mio e lo cambio se voglio, il figlio è mio e lo abortisco se voglio.
L’azienda è mia e la gestisco io. Io stesso, certe volte parlando con i miei
figli, dico: il peccato è mio, me lo “gestisco” io».
Il Csm, è la convinzione del
capo dello Stato nella cerimonia al Quirinale di commiato dai componenti del Csm
uscenti e di saluto a quelli entranti, deve «contrastare decisamente oscure
collusioni di potere ed egualmente esposizioni e strumentalizzazioni mediatiche,
a fini politici di parte o a scopo di "autopromozione personale"». Il 31 luglio
2010 l'inquilino del Quirinale cita «fenomeni di corruzione di trame inquinanti
che turbano e allarmano, apparendo essi tra l’altro legati all’operare di
"squallide consorterie"».
Per il Colle è importante
«alzare la guardia nei confronti di deviazioni che finiscono per colpire
fatalmente quel bene prezioso che è costituito dalla credibilità morale e
dall'imparzialità e dalla terzietà del magistrato». «Già nella risoluzione
adottata dal Csm il 20 gennaio 2010 - ricorda Napolitano nel discorso di saluto
dei nuovi componenti del Csm - si è mostrata consapevolezza della percezione da
parte dell'opinione pubblica che, alcune scelte consiliari siano in qualche
misura condizionate da logiche diverse, che possono talvolta affermarsi in
"pratiche spartitorie", rispondenti ad "interessi lobbistici, logiche
trasversali, rapporti amicali o simpatie e collegamenti politici"».
Nel documento base della
‘Settimana sociale’, di Agosto 2010, la Cei definisce l’Italia “un Paese
senza classe dirigente”.Nel documento è possibile leggere: “L’Italia è un paese
senza classe dirigente, senza persone che per ruolo politico, imprenditoriale,
di cultura, sappiano offrire alla nazione una visione e degli obiettivi
condivisi e condivisibili”.
L’Italia è un Paese
«sfilacciato», addirittura ridotto «a coriandoli», che ha paura del futuro. È
dirompente la radiografia che il presidente dei vescovi italiani, ha fatto
aprendo i lavori del Consiglio permanente della Cei.
“La verità è che ‘il Paese da
marciapiede’ i segni del disagio li offre (e in abbondanza) da tempo, ma la
politica li toglie dai titoli di testa, sviando l’attenzione con le immagini del
‘Presidente spazzino’, l’inutile ‘gioco dei soldatini’ nelle città, i finti
problemi di sicurezza, la lotta al fannullone”. Questo scrive Famiglia
Cristiana. Ciò svia l’attenzione dai problemi economici del Paese, e con il
rischio “di provocare una guerra fra poveri, se questa battaglia non la si
riconduce ai giusti termini, con serietà e senza le ‘buffonate’, che servono
solo a riempire pagine di giornali”.
Il Vaticano non recepisce più
automaticamente, come fonte del proprio diritto, le leggi italiane. Tre i motivi
principali di questa drastica scelta: il loro numero esorbitante, l'illogicità
e l'amoralità di alcune norme. Lo riferisce l'Osservatore Romano all’atto di
presentazione della nuova legge della Santa Sede sulle fonti del diritto firmata
da Benedetto XVI, vigente dal primo gennaio 2009 e in sostituzione della legge
del 7 giugno 1929.
E che dire della malattia dei
politici. Poltronismo, poltronite. La malattia è presto definita: raccogliere
sotto lo stesso corpo più incarichi possibili. La prima poltrona dà potere e
visibilità. La seconda fiducia e tranquillità. Se casco lì, rimango in piedi
qui. O viceversa.
La Prima Repubblica aveva
molti difetti ma alcune virtù nascoste. Tra queste separare in modo
indiscutibile la guida degli enti locali con l'impegno da parlamentare. Il
divieto, contenuto in una legge del 1957 e limitato ai centri con più di
ventimila abitanti e alle province, tutte, trovava fondamento nell'idea di
offrire parità di condizioni ai candidati. Un deputato che fosse in corsa per
fare il sindaco aveva più possibilità di captare voti. Dunque avrebbe violato la
par condicio. Per anni norma osservata, e disciplina dei sensi unici assoluta.
Con Tangentopoli il mercato della politica si è però ristretto. Molti
presentabili sono divenuti impresentabili. Molti politici in carriera si sono
ritrovati in panchina. Molti altri colleghi addirittura oltre le tribune, fuori
dal gioco, alcuni dietro le sbarre.
Col favore delle tenebre, nel
silenzio assoluto e nella distrazione collettiva, il 2 giugno del 2002 la Giunta
per le elezioni, organo politico a cui sono affidati poteri giurisdizionali,
cambia i sensi, inverte i passaggi. Chi fa il sindaco di una città che abbia più
di ventimila abitanti o il presidente della Provincia non può candidarsi a
deputato o senatore. Ma chi è parlamentare può. Senso inverso possibile. La cosa
è piaciuta ai più: fare il sindaco-deputato è molto meglio che fare soltanto il
sindaco. E se è vero che le indennità non sono cumulabili è certo che le
prerogative invece lo sono. Esempio su tutte: l'immunità.
E quindi è iniziata la
processione. Prima quello, poi quell'altro. Dopo di te io. E allora io. Un
deputato è sindaco a Viterbo, un senatore è sindaco a Catania; una deputata è
presidente della Provincia di Asti, un senatore presiede quella di Avellino. Un
deputato è sindaco a Brescia, un collega è presidente a Napoli. E via così...
I più hanno trasmesso ai nuovi
uffici la stessa foto di rappresentanza data agli uffici parlamentari. Quando
serve siamo qui. Col tesserino. Quando non serve siamo lì. Con la fascia
tricolore. E' un bel segno in questi tempi di crisi: più poltrone per tutti.
Da una ricerca emergono i
difetti del “belpaese”. Italiani maleducati, arroganti e corrotti, con scarso
rispetto per l'ambiente e le diversità. I più viziosi? Senza ombra di dubbio, i
politici seguiti, a ruota, da sindacalisti, imprenditori e banchieri.
Inizia con in esclusiva
dell'indagine, curata dal sociologo Enrico Finzi, che il 'Messaggero di
“Sant’Antonio” ha commissionato ad Astra Ricerche, istituto di ricerca
demoscopica di cui Finzi è presidente.
Uno zoom sui nuovi vizi dal
quale emerge una radiografia 'in presa diretta' sull'Italia.
''Nell'anteprima dell'indagine
pubblicata in questo numero della Rivista, si possono trovare le prime
istantanee - afferma il direttore della rivista, padre Ugo Sartorio - ossia
quali sono i nuovi vizi più diffusi, le cause e, soprattutto, l'identikit degli
italiani più 'viziosi'''.
In testa alla classifica dei
vizi ci sono i politici, secondo il 78% degli interpellati; seguono i
sindacalisti al secondo posto, 40% circa, e poi i giovani, i giornalisti e gli
immigrati, attorno al 35%. Tra i nuovi vizi più diffusi l'arroganza e la
maleducazione, la corruzione, la disonestà, il consumismo, ma anche
l'indifferenza e l'irresponsabilità.
Al primo posto, per quanto
riguarda i vizi nella società, troviamo la maleducazione: ben nove su dieci
abitanti del Belpaese puntano il dito contro questo vizio.
Al terzo posto, col 77% delle
indicazioni, incontriamo il menefreghismo. In stretta connessione, con un valore
di poco inferiore (74%), quel tipo di degenerazione etica che si traduce nella
disonestà e anche nella corruzione.
Insomma, la più aspra
preoccupazione della gente riguarda in generale l'imbarbarimento della vita e
delle relazioni interpersonali, fondato sul trionfo dell''io isolato dagli
altri' e sul venir meno dell'etica personale e collettiva.
Di diversa natura, ''ma in
fondo non così dissimile'', è il quinto macro-difetto, lamentato dal 71% dei
18-79enni: ''lo scarso rispetto per la natura e per l'ambiente''.
Il 49% del campione indica
come vizio più grave ''il carrierismo e la competizione senza regole e senza
freni, essi stessi determinati dall'egoismo o dal considerare gli altri solo un
mezzo per raggiungere i propri obiettivi. Al penultimo posto in questa triste
classifica - rileva il presidente di Astra ricerche - ecco il dilagare tra gli
italiani dell'immaturità e spesso dell'infantilismo.
Infine il 42% denuncia la
crescita nella nostra società dell'intolleranza (a volte religiosa, a volte
politica, spesso culturale, spessissimo sportiva): quell'incapacità di accettare
e anzi di valorizzare la pluralità delle opinioni e dei comportamenti che rende
democratica e civile, oltre che moralmente solida, qualunque civiltà.
Una fotografia, quella voluta
dal 'Messaggero di sant'Antonio', che aiuta a rilevare attraverso un'ottica il
più possibile imparziale i tratti di un Paese dai mille volti.
Un occhio agli italiani anche
da parte straniera, e il risultato per noi non è proprio dei migliori.
Impietosa analisi del Belpaese
dove regna "una dilagante impunità e uno standard di vita in declino".
"L'Italia è oggi una terra
inondata da corruzione, decadenza economica, noia politica, dilagante impunità e
uno standard di vita in declino".
E' l'impietosa analisi che fa
del nostro Paese il Los Angeles Times in occasione delle elezioni politiche del
2008 per la scelta del "62esimo governo in 63 anni". Elezioni nelle quali gli
elettori potranno scegliere fra "rei condannati" o "ballerine della tv". Il
titolo dell'articolo di Tracy Wilkinson è: "In Italia il crimine paga e vi può
far eleggere".
Il Los Angeles Times descrive
l'Italia - un tempo "leggendaria icona di cultura" - come un Paese dove la
gestione di un'impresa "è un'esperienza torbida e frustrante, a meno di non
essere la Mafia, oggi il più grande business in Italia".
Un Paese dove "il sistema
giudiziario raramente funziona", e "i parlamentari sono i più pagati d'Europa
ma, secondo l'opinione di molti, i meno efficaci, una elite che si autoperpetua"
e sembra "voler trascinare giù il Paese con sé".
Un' Italia ormai in ginocchio,
con una classe politica "iper-pagata" preda dell' "immobilismo" e del
"trasformismo" che sta inesorabilmente perdendo "legittimità"' tra i cittadini
stanchi e disillusi. E' un quadro nero della Penisola, il Paese "peggio
governato d'Europa", quello che il professor Martin Rhodes traccia nella pagina
dei commenti del Financial Times.
I giornali lo dicono
chiaramente: non siamo più emblema di stile, ma quintessenza della
maleducazione. "Dimenticatevelo il Bel Paese. Musica rap strombazza da una radio
portatile e un pallone rotola sul vostro asciugamano mentre una mamma italiana
urla a suo figlio insabbiato. Questa è la vita da spiaggia, almeno alla maniera
italiana" sentenzia il Sydney Morning Herald. Ma non solo: "un turista visto una
sola volta viene considerato non una persona, bensì un’incombenza" (The
Guardian), "nelle code ai musei ti ritrovi spinto addirittura da suore" si
sostiene su travelpod.com. E ancora, "ci sono preservativi usati ovunque ad
inquinare i parchi protetti" (italy.net), mentre in città "la colonna sonora
simbolica dell'Italia è il ronzio del motore a due marce degli scooter che
sfrecciano ignorando le regole tra il traffico impenetrabile" (New York Times).
Immagine italiana
all'estero: sempre più opaca.
È il quadro che emerge da una ricerca sulla stampa estera dell’Osservatorio
Giornalistico Internazionale Nathan il Saggio (www.nathanilsaggio.com), reso
noto dall’Agenzia KlausDavi, che ha monitorato le principali testate straniere
(dal New York Times a Le Monde, dall’Herald Tribune al Der Spiegel) e i più
importanti portali di informazioni turistiche sul tema "l’Italia vista dagli
altri". Ne scaturisce un’analisi critica e a volte dura da parte della stampa
estera che denota l’opacizzazione dell’immagine dello stile italiano all’estero.
"Che fine ha fatto la dolce
vita?", il titolo di un articolo del Guardian, pare essere emblematico di questo
cambiamento di percezione nei confronti del paese del sole. Da simpatici
burloni, pronti ad accogliere con il sorriso gli ospiti e pieni del celeberrimo
fascino Italian Style riconosciuto in tutto il mondo, gli italiani di oggi
riempiono le colonne della stampa estera per maleducazione ed eccessi di
arroganza e furbizia. Per strada sono sempre pronti a fischiare le ragazze,
concentrati solo sul proprio aspetto fisico e gettano immondizia ovunque (The
Sidney Morning Herald). Nella classifica compare la città di Viareggio, "invasa
d’estate dalla solita calca italiana stravaccata sotto gli ombrelloni e sempre
impegnata a far squillare i cellulari" (Times) e "meta di chi vuol esibire il
proprio status" (Frankfurter Allgemeine Zeitung). Segue Rimini con le sue
spiagge sovrappopolate e addirittura da evitare, secondo Liberation. Alberghi
non accoglienti e infestati da ragni (Focus), valgono a Bibione la terza
posizione in questa classifica. Chiudono Varigotti, perla della costa ligure che
però è invasa da parcheggiatori e bagni abusivi (Abc), e Amalfi, dove
strombazzate e insulti in auto sono la normalità (The Globe and Mail).
Questo per quanto riguarda
l'Italia degli adulti. E i nostri figli ??
Cresce fra le ragazzine il
fenomeno della microprostituzione: sesso a scuola e sul web per arrotondare la
“paghetta”.
Ricordate, appena qualche anno
fa, quando si parlava di immagini spinte che gli adolescenti facevano girare con
i telefonini? Allora quel fenomeno, che era ai suoi albori, venne inquadrato in
una specie di patologia “esibizionistica” imitativa fra teenagers. Capitarono
anche casi di video “hard” di ragazzine, destinati all’auto-contemplazione
all’interno della coppia o al ristretto giro delle amicizie più intime, diffusi,
invece, sempre tramite i cellulari, ad intere scolaresche ed intercettati anche
dagli allibiti genitori. Alcuni di questi episodi divennero casi di cronaca
anche in Emilia, a Bologna e Modena, con povere ragazze messe in piazza in quel
modo, e genitori costretti a rivolgersi ai carabinieri.
Si parlò poi di “bullismo
elettronico”, quando, oltre alle scene di sesso precoce, vennero fatte circolare
dai cellulari anche immagini girate a scuola di pestaggi (anche ai danni di
minorati) o di “scherzi pesanti” a professori (ricordate il caso di Lecce della
professoressa in perizoma, palpeggiata dagli alunni?). Ci si interrogò allora
sul bisogno dei giovani di “apparire” a tutti i costi, di “visibilità” anche
negativa, per esistere….
Ebbene a distanza di pochi
anni, il fenomeno ha cambiato definizione e modalità: non più “esibizionismo”,
non più “bullismo”, non più violenza gratuita, non più gratuita ostentazione…
nel senso che le ragazzine continua a riprendersi o a farsi riprendere in
situazioni “osè”, ma adesso pretendono di essere pagate. Il fenomeno si sta cioè
convertendo in “microprostituzione” a scuola o tramite web. Una forma di
prostituzione per così dire “under”, estemporanea, praticata per lo più fra
coetanei (per questo la si chiama “micro”), ma è certo alta la possibilità che
queste stesse ragazze possano diventare anche “prede” di adulti senza scrupoli,
ed ovviamente più danarosi dei loro compagni di classe.
Il fenomeno è osservato ed in
preoccupante espansione. Per molte ragazze sta diventando “normale” concedere
prestazioni sessuali, o ritrarsi in pose erotiche tramite la webcam o gli stessi
cellulari, in cambio di soldi per arrotondare la paghetta dei genitori. Paghetta
che magari la crisi può aver un po’ ristretto.
E che dire delle leggi?
Guida pratica comune del
Parlamento Europeo, del Consiglio e della Commissione destinata a coloro che
partecipano alla redazione dei testi legislativi delle istituzioni europee.
La redazione degli atti deve
essere:
chiara, facilmente
comprensibile, priva di equivoci;
semplice, concisa, esente da
elementi superflui;
precisa, priva di
indeterminatezze.
Tale regola ispirata al buon
senso è espressione di principi generali del diritto come i seguenti:
l’uguaglianza dei cittadini
davanti alla legge, nel senso che la legge deve essere accessibile e
comprensibile a tutti;
la certezza del diritto, in
quanto l’applicazione della legge deve essere prevedibile.
Invece in Italia così non è.
L'aspirante dannunziano Roberto Calderoli ha fatto un miracolo: denunciata la
presenza di 29.100 leggi inutili, ne ha bruciate in un bel falò 375.000, scrive
Gian Antonio Stella su “Il Corriere della Sera”. Fatti i conti, lavorando 12 ore
al giorno dal momento in cui si è insediato, più di una al minuto: lettura del
testo compresa. Wow! Resta il mistero dell’ingombro di quelle appena fatte.
Stando al «Comitato per la legislazione» della Camera, i soli decreti del
governo attuale hanno sfondato la media di 2 milioni di caratteri l’uno: 56
decreti, 112 milioni di caratteri. Per capirci: l’equivalente di 124,4 tomi di
500 pagine l’uno. Dicono le rappresentanze di base dei vigili del fuoco che
quella del ministro è stata «una sceneggiata degna del Ventennio». E c’è chi
sottolinea che i roghi di carta, in passato, hanno sempre contraddistinto i
tempi foschi. Per non dire delle perplessità sui numeri: se la relazione della
commissione parlamentare presieduta da Alessandro Pajno e più volte citata da
Calderoli aveva accertato «circa 21.000 atti legislativi, di cui circa 7.000
anteriori al 31 dicembre 1969», come ha fatto lo stesso Calderoli a contarne
adesso 375.000? Al di là le polemiche, tuttavia, resta il tema: fra i faldoni
bruciati ieri nel cortile di una caserma dei pompieri (lui avrebbe voluto fare
lo show a Palazzo Chigi ma Gianni Letta, poco marinettiano, si sarebbe
opposto...) c’erano soltanto antichi reperti burocratici quali l’enfiteusi o
anche qualcosa di più recente? Prendiamo l’articolo 7 delle norme sul fondo
perequativo a favore delle Regioni: «La differenza tra il fabbisogno finanziario
necessario alla copertura delle spese di cui all’articolo 6, comma 1, lettera
a), numero 1, calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo
comma 1 dell’articolo 6 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati,
determinato con l’esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall’esercizio
dell’autonomia tributaria nonché dall’emersione della base imponibile...». Il
ministro Calderoli concorderà: un delirio. Il guaio è che non si tratta di una
legge fatta ai tempi in cui Ferdinando Petruccelli della Gattina scriveva «I
moribondi del Palazzo Carignano». È una legge del governo attuale, presa mesi fa
ad esempio di demenza burocratese da un grande giornalista non certo
catalogabile fra le «penne rosse»: Mario Cervi. Direttore emerito del Giornale
berlusconiano. Eppure c’è di peggio. Nel lodevolissimo sforzo di rendere più
facile la lettura e quindi il rispetto delle leggi, il governo approvò il
18 giugno 2009 una legge che aveva un articolo 3 titolato «Chiarezza dei testi
normativi». Vi si scriveva che «a) ogni norma che sia diretta a sostituire,
modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi
espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate; b) ogni
rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in
regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione,
contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara
comprensione, il testo...». Insomma: basta con gli orrori da azzeccagarbugli.
Eppure, ecco il comma dell’articolo 1 dell’ultimo decreto milleproroghe del
governo in carica: «5-ter. È ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010 il
termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell’articolo 6 del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009
dall’articolo 47-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31». Cioè? Boh...È questo il
punto: che senso c’è a incendiare un po' di scatoloni di detriti
burocratici che parlano di «concessioni per tranvia a trazione meccanica» o di
«acquisto di carbone per la Regia Marina» se poi gli spazi svuotati da quelle
regole in disuso vengono riempiti da nuove norme ancora più confuse, deliranti,
incomprensibili? La risposta è in un prezioso libretto curato dal preside della
facoltà di lettere e filosofia di Padova Michele Cortellazzo. Si intitola: Le
istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione tradotte in
italiano. Sottotitolo: Omaggio al ministero dell’Interno. Non fosse una cosa
seria, potrebbe essere scambiata per satira: se le regole elettorali fossero
comprensibili, perché mai dovrebbero essere «tradotte in italiano»? Anche negli
armadi impolverati delle legislazioni straniere esistono mucchi di leggi in
disuso. Un sito internet intitolato «gogna del legislatore scemo» ne ha steso un
elenco irresistibile. In certi Stati del Far West americano è proibito «pescare
restando a cavallo». Nell’Illinois chi abbia mangiato aglio può essere
incriminato se va a teatro prima che siano trascorse quattro ore. A Little Rock
dopo le 13 della domenica non si può portare a spasso mucche nella Main Street.
Ogni tanto, senza farla tanto lunga, i legislatori svuotano i magazzini. Magari
cercando di non fare gli errori sui quali, nello sforzo di fare in
fretta, era incorsa la "ramazza" di Calderoli, la quale, come via via hanno
segnalato i giornali consentendo di rimediare alle figuracce, aveva spazzato via
per sbaglio anche il trasferimento della capitale da Firenze a Roma,
l’istituzione della Corte dei Conti o le norme che consentono a un cittadino di
non essere imputato per oltraggio a pubblico ufficiale se reagisce ad atti
arbitrari o illegali. Ciò che più conta, però, è fare le leggi nuove con
chiarezza. Se no, ogni volta si ricomincia da capo. Qui no, non ci siamo. E a
dirlo non sono i «criticoni comunisti» ma il Comitato parlamentare per la
legislazione presieduto dal berlusconiano Antonino Lo Presti. Comitato che due
mesi fa spiegò che i decreti del governo Prodi, già gonfi di parole, numeri e
codicilli, contenevano mediamente 1 milione e 128 mila caratteri. Quelli del
governo Berlusconi, a forza di voler tener dentro tutto, hanno superato i 2
milioni. E sarebbe questa, la semplificazione? Ci siamo liberati delle
ottocentesche norme sulla «riproduzione tramite fotografia di cose immobili» per
tenerci oggi astrusità come i rimandi «all’articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, può essere prevista l’applicazione dell’articolo 11,
comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell’articolo 1, comma 853...»? Ma dai...
Non basta sono gli stessi
legislatori ad essere illegittimi, quindi abusivi. Incostituzionalità della
Legge elettorale n. 270/2005. Dal Palazzo della Consulta, 4 dicembre 2013. La
Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme
della legge n. 270/2005 che prevedono l’assegnazione di un premio di maggioranza
– sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica – alla lista
o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che
non abbiano conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei
seggi assegnati a ciascuna Regione. La Corte ha altresì dichiarato
l’illegittimità costituzionale delle norme che stabiliscono la presentazione di
liste elettorali “bloccate”, nella parte in cui non consentono all’elettore di
esprimere una preferenza. Le motivazioni saranno rese note con la pubblicazione
della sentenza, che avrà luogo nelle prossime settimane e dalla quale dipende la
decorrenza dei relativi effetti giuridici. Resta fermo che il Parlamento può
sempre approvare nuove leggi elettorali, secondo le proprie scelte politiche,
nel rispetto dei principi costituzionali.
Il Porcellum è illegittimo,
dice la Corte costituzionale. Bocciato il premio di maggioranza, bocciate le
liste bloccate. La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme
sul premio di maggioranza, per Camera e Senato, attribuito alla lista o alla
coalizione che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e non abbiano avuto
almeno 340 seggi a Montecitorio e il 55 per cento dei seggi assegnati a ogni
regione, a Palazzo Madama. Contrarie alla Carta anche le norme sulle liste
«bloccate»,perché non consentono all’elettore di dare una preferenza.
Accoglie in toto il ricorso contro la legge elettorale del 2005, l’Alta
Corte. Ma nella lunga camera di consiglio è battaglia. Perché dopo il voto
unanime sull’ammissibilità del ricorso e poi sull’eliminazione del premio di
maggioranza, sulla terza questione ci si spacca 7 a 8. Sembra che i giudici più
vicini alla sinistra, dal presidente Gaetano Silvestri a Sabino Cassese e
Giuliano Amato (di nomina presidenziale), allo stesso Sergio Mattarella (scelto
dal parlamento e padre del sistema precedente), volessero che l’Alta Corte
affermasse che abolite le liste bloccate ci fosse la «reviviscenza» del vecchio
sistema. Ma la manovra non sarebbe riuscita perché si sarebbero opposti lo
stesso relatore Giuseppe Tesauro, il vicepresidente Sergio Mattarella, i giudici
Paolo Maria Napolitano, Giuseppe Frigo e altri scelti da Cassazione e Consiglio
di Stato.
GLI EFFETTI GIURIDICI
INCONTESTABILI: SONO DA CONSIDERARSI INESISTENTI, QUINDI NON LEGITTIMATI A
LEGIFERARE, A DECRETARE ED A NOMINARE CHI E’ STATO ELETTO CON UNA LEGGE
INCOSTITUZIONALE, QUINDI INESISTENTE. INESISTENTI SONO, ANCHE, GLI ATTI DA
QUESTI PRODOTTI: NORME GIURIDICHE O NOMINE ISTITUZIONALI.
L'abrogazione di una norma
giuridica, ossia la sua perdita di efficacia, può avvenire mediante l'emanazione
di una norma successiva di pari grado o di grado superiore. Fanno eccezione le
leggi temporanee nelle quali l'abrogazione è indicata con il termine della
durata indicata dal Legislatore.
L'articolo 15 delle Preleggi
delinea tre distinti casi di abrogazione: Art. 15 Abrogazione delle leggi.
"Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione
espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le
precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla
legge anteriore." Nel caso in cui la norma è abrogata, in tutto o in parte,
mediante una legge posteriore con esplicito riferimento alla norma precedente si
parla di "abrogazione espressa". Quando l'abrogazione deriva
dall'incompatibilità delle precedenti norme con quelle emanate successivamente
si parla di "abrogazione tacita". Infine, quando una nuova legge
disciplina un'intera materia già regolamentata, conferendogli una nuova
sistematicità logico-giuridica, le precedenti norme sono abrogate. In
quest'ultimo caso si parla di "abrogazione implicita".
Abrogazione per
incostituzionalità.
Una norma giuridica può essere abrogata anche mediante sentenza
di incostituzionalità pronunciata dalla Corte Costituzionale. Articolo 136 –
Costituzione. "Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di
una norma di legge o di atto avente forza di legge [cfr. art. 134], la norma
cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai
Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario,
provvedano nelle forme costituzionali."
Abrogazione per referendum.
Infine, un altro fenomeno estintivo di una norma giuridica previsto dal nostro
ordinamento giuridico è dato dal referendum abrogativo. Articolo 75 –
Costituzione. "E` indetto referendum popolare [cfr. art. 87 c. 6] per
deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente
valore di legge [cfr. artt. 76, 77], quando lo richiedono cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi
tributarie e di bilancio [cfr. art. 81], di amnistia e di indulto [cfr. art.
79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80].
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata
se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le
modalità di attuazione del referendum."
Abrogazione per
desuetudine.
Nell'ordinamento giuridico italiano non è valida l'abrogazione
per desuetudine. L'abrogazione di una norma giuridica, ossia la sua perdita di
efficacia, può avvenire mediante l'emanazione di una norma successiva di pari
grado o di grado superiore. Fanno eccezione le leggi temporanee nelle quali
l'abrograzione è indicata con il termine della durata indicata dal Legislatore.
L'abrogazione è
l'istituto mediante il quale il legislatore determina la cessazione ex nunc
(non retroattiva) dell'efficacia di una norma giuridica. Si distingue dalla
deroga (posta in essere da una norma speciale o eccezionale) in quanto una norma
"derogata" resta in vigore per la generalità dei casi, mentre una norma abrogata
cessa di produrre effetti giuridici. Si distingue dall'annullamento, che priva
retroattivamente di efficacia una norma. Tutte le norme giuridiche si sviluppano
necessariamente su due piani, quello temporale e quello spaziale. In questo
scritto sarà la dimensione temporale ad essere presa in considerazione. Questo
implica che si muovano i primi passi da una norma ulteriore rispetto a quelle
citate in precedenza.
L'articolo 11 delle Preleggi
disciplina il principio di irretroattività della legge: "la legge non dispone
che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". Il significato di tale
regola è che una norma non può essere applicata a situazioni di fatto o a
rapporti giuridici sorti e conclusisi anteriormente alla sua entrata in vigore.
Il principio di irretroattività, previsto dall'articolo 11 delle Preleggi, è
ripreso dall'articolo 25 della Costituzione il quale lo codifica, meglio lo
costituzionalizza, limitatamente all'ambito penale, disponendo, per assicurare
un'esigenza di certezza ai comportamenti dei consociati, che "nessuno può
essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del
fatto commesso". La previsione costituzionale del principio di
irretroattività delle leggi, anziché definire, almeno in ambito penale, le
problematiche sottese alla efficacia delle norme nel tempo apre delle
problematiche ulteriori soprattutto quando viene letto in combinato con
l'articolo 2 del codice penale. L'articolo 2 del codice penale statuisce che "nessuno
può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu
commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che,
secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna,
ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Se la legge del tempo in cui fu
commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui
disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile".
Quanto detto analiticamente
vale per gli att. Per quanto riguarda le persone elette con norme abrogate
perché ritenute incostituzionali?
Nel diritto la nullità è una
delle massime sanzioni in quanto opera di diritto (ipso iure) cioè non è
richiesto l'intervento del giudice: l'atto nullo è inefficace di diritto. Nel
codice civile si ha un atto nullo quando manca di uno degli elementi essenziali
o risulta in contrasto con norme imperative. Anche la nullità degli atti
amministrativi è riconducibile a questa disciplina avendo però, ovviamente,
elementi essenziali diversi e norme imperative differenti da rispettare. La
conseguenza della nullità è la stessa: l’atto è come mai esistito. Le cause di
nullità, quindi, sono:
- Casi previsti dalla legge,
nel diritto amministrativo non basta il semplice contrasto con una norma ma
occorre che tale norma preveda come conseguenza della sua inosservanza la
nullità dell’atto. Ecco perché si parla più propriamente di casi previsti dalla
legge.
- Inottemperanza alle
sentenze, può essere considerato un sottoinsieme della categoria dei casi
previsti dalla legge, in quanto una legge prevede che nel caso che un atto non
si conformi ad un precedente giudicato sia nullo.
- Mancanza degli elementi
essenziali, si cerca di applicare l’art. 1325 c.c. per individuare gli elementi
degli atti amministrativi.
Partendo dal suddetto articolo
la giurisprudenza ha individuato gli elementi essenziali degli atti
amministrativi in:
- soggetto, è nullo l’atto il
cui autore non sia identificabile;
- oggetto, è nullo l’atto
avente un oggetto inesistente, indeterminato o indeterminabile, o inidoneo
(espropriare un bene demaniale);
- forma, vige il principio di
libertà della forma ma in alcuni casi si ritiene che sia essenziale una certa
forma, perché richiesta da una disposizione espressa o dalla prassi. In tali
casi il difetto di forma causa nullità dell’atto;
- contenuto, è nullo l’atto
con contenuto indeterminato, indeterminabile, inidoneo o illecito (autorizzare
ad uccidere, autorizzare un’attività non definita, ecc…);
- causa, si discute se sia
elemento essenziale e quindi causa di nullità, o consista nell’interesse
pubblico specifico che l’atto deve perseguire e in tal caso la sua violazione
comporta illegittimità per eccesso di potere.
- Difetto assoluto di
attribuzione (incompetenza assoluta), può essere considerato un sottoinsieme in
quanto corrisponde alla mancanza di un elemento essenziale: il soggetto.
Si ha incompetenza assoluta
quando l’atto emanato era di competenza non-amministrativa oppure di altra
amministrazione (Regione che interviene in materie statali è incompetenza
assoluta). La c.d. carenza di potere, che non è prevista espressamente tra le
cause di nullità, se ha quando l’amministrazione adotta un atto senza che
sussistessero i presupposti legali che la autorizzassero ad emanarlo. Le
conseguenze della nullità prevedono che l’atto sia privo di efficacia giuridica
in maniera retroattiva, cioè le eventuali attività già svolte risultano prive di
giustificazione.
Non è necessario che l’atto nullo sia eliminato, è sufficiente la sentenza
dichiarativa del giudice competente.
La nullità è assoluta (può essere chiesta da chiunque, anche d’ufficio) ed è
imprescrittibile.
Spiego meglio. Gli atti sono
invalidi quando risultano difformi da ciò che la legge stabilisce. Possono
essere: inesistenti (o nulli), o annullabili.
1. Inesistenza.
È la mancanza di un elemento essenziale che comporta la totale nullità
dell'atto. I principali casi sono:
a) inesistenza del
soggetto;
quando l'atto non può essere considerato espressione del pubblico potere poiché
emanato da un soggetto non appartenente alla pubblica amministrazione;
b) incompetenza assoluta
per territorio;
quando l'atto è stato emanato da un organo della pubblica
amministrazione ma al di fuori della sua sfera di competenza territoriale;
c) incompetenza assoluta
per materia;
è inesistente quello emanato da un organo della pubblica amministrazione in una
materia che la legge attribuisce a un altro potere pubblico;
d) inesistenza
dell'oggetto;
è inesistente quando manca il destinatario o quando l'oggetto è indeterminato,
indeterminabile o inidoneo: ad es., l'atto di matrimonio tra due persone dello
stesso sesso;
e) inesistenza per
mancanza di forma essenziale;
si verifica quando la legge prevede che l'atto sia espresso in un certo modo
(solitamente per iscritto) ed esso è emanato in modo diverso.
2. Annullabilità.
L'atto amministrativo è annullabile quando, pur presentando tutti gli elementi
essenziali previsti dall'ordinamento, è stato formato in modo diverso da quanto
stabilito dalle norme sulla sua emanazione, ed è pertanto illegittimo;
l'illegittimità deve riguardare uno dei suoi elementi essenziali. Mentre non
esiste un testo normativo che indichi le cause di inesistenza dell'atto
amministrativo, la legge rd 1024 26/6/1924 26 prevede espressamente i vizi di
illegittimità che rendono l'atto annullabile: l'incompetenza relativa, l'eccesso
di potere e la violazione di legge.
a) Incompetenza
relativa.
Mentre l'incompetenza assoluta si riscontra solo tra organi di diverse
amministrazioni, e produce l'inesistenza dell'atto, quella relativa si verifica
tra organi dello stesso settore di amministrazione e costituisce uno dei tre
vizi di legittimità dell'atto che lo rendono annullabile. Essa si verifica nei
seguenti casi:
- quando un organo
gerarchicamente inferiore emana un atto di competenza di quello superiore;
- quando un organo esercita la
potestà di un altro organo dello stesso settore di amministrazione;
- quando un organo emana un
atto riservato all'ambito territoriale di un altro organo del medesimo ramo di
amministrazione.
b) Eccesso di potere.
Si riscontra nei casi in cui la pubblica amministrazione utilizza il potere di
cui è dotata per conseguire uno scopo diverso da quello stabilito dalla legge, o
quando il provvedimento appare illogico, irragionevole o privo di
consequenzialità tra premesse e conclusioni. L'eccesso di potere è configurabile
soltanto per gli atti discrezionali e mai per quelli vincolati.
c) Violazione di legge.
Comprende tutte le cause di illegittimità non previste nei due punti precedenti:
si verificano casi di violazione di legge quando, ad es., non sono rispettate le
regole sul procedimento amministrativo, quando manca la forma prevista dalla
legge, quando mancano i presupposti per l'emanazione dell'atto. L'atto
illegittimo, fino a quando non viene annullato, è efficace e può essere
eseguito. L'annullamento che ha efficacia retroattiva non si verifica di diritto
ma dev'essere fatto valere dagli interessati ed essere pronunciato o con un
provvedimento della pubblica amministrazione o con una sentenza del giudice
amministrativo; in seguito a essi l'atto si considera come mai emanato e gli
effetti eventualmente prodotti vengono annullati; anziché annullato può essere
suscettibile di convalida o di sanatoria.
La inesistenza? L’ ultima
parola, come sempre, alla giurisprudenza, scrive Sergio De Felice. Ancora una
volta il diritto amministrativo mima e mutua le categorie giuridiche del
provvedimento (in particolare, le sue invalidità) dal diritto civile e dal
diritto romano, le madri di tutti i diritti. Si conferma l’assunto di quel
grande autore secondo il quale il civile è il diritto, il penale è il fatto,
l’amministrativo è il nulla, se non altro, perché esso deve rivolgersi alle
altre branche del diritto per disciplinare le categorie patologiche (come
dimostra il tentativo di costruzione negoziale del provvedimento).
E’ noto che la disciplina
delle invalidità (in particolare della annullabilità, che richiede l’intervento
del giudice) deriva dalla sovrapposizione, in diritto romano, dello jus
civile e del diritto pretorio, e dalla integrazione, quindi, del diritto
processuale con quello sostanziale. Quanto ai confini tra l’atto nullo e l’atto
inesistente, ferma restando la chiara distinzione in teoria generale, tanto che
l’una appartiene al mondo del giuridicamente rilevante, l’altra no, nella
pratica, occorrerà vedere in quale categoria verranno comprese le fattispecie
prima liquidate sotto la generale e onnicomprensiva “nullità-inesistenza”
dell’atto amministrativo. Sotto tale aspetto, mentre non desteranno problemi
pratici, i cosiddetti casi di scuola (atto emesso ioci o docendi causa,
la violenza fisica), maggiori problemi, al limite tra nullità e inesistenza,
creeranno altre fattispecie, come il caso dell’usurpatore di pubbliche
funzioni (art. 347 c.p.), i casi più gravi di funzionario di fatto, i casi
di imperfezione materiale (per non completamento della fattispecie), il
difetto di sottoscrizione di un atto. Ancora una volta, sarà la
giurisprudenza amministrativa a chiarire se residuano ipotesi di inesistenza,
quali sono i requisiti essenziali dell’atto ai sensi dell’art. 21 septies
e così via. Allo stesso modo, la giurisprudenza dovrà affrontare i nodi tra il
rimedio della azione dichiarativa di nullità, il rapporto con la disapplicazione
o inapplicazione, che considera l’atto tamquam non esset e non lo
applica (e che perciò dovrebbe riguardare solo gli atti imperativi), ne
prescinde, ma non lo espunge definitivamente dal sistema - mentre la
nullità dichiara che l’atto è di diritto difforme dall’ordinamento. La giustizia
amministrativa conferma ancora una volta, ed è chiamata a confermare, il suo
ruolo di creatrice del diritto amministrativo. Essa è senz’altro
giurisdizione (lo conferma la sentenza n.204/2004 della Corte
Costituzionale); essa è amministrazione (judgér l’administration est
administrer) quando compara interessi (nella fase cautelare) o quando entra
in punto di contatto, annullando l’atto, o quando sostituisce un
segmento di attività, nella giurisdizione di merito. Soprattutto, nella specie,
la giurisprudenza si conferma il legislatore di fatto del diritto
amministrativo, avendo, il legislatore nazionale ripreso dagli orientamenti
consolidati in via giurisprudenziale le varie definizioni di invalidità, di
nullità, conseguimento dello scopo, i casi di esecutorietà e così via. Resta la
osservazione finale che sarà la giurisprudenza a completare (vel adiuvandi,
vel supplendi, vel corrigendi) l’opera del legislatore del 2005.
Venuta meno la fiducia nel mito della completezza della legge, è chiaro che il
legislatore non è né completo, né perfetto (né, d’altronde, deve esserlo).
Osservava la dottrina commercialistica a seguito della invenzione della
categoria della inesistenza delle delibere assembleari (nata proprio per
contrastare la rigida regola, voluta dal legislatore, della generale
annullabilità a pena di decadenza, e la tassatività delle nullità delle delibere
agli artt. 2377-2379 c.c.), che il legislatore non è onnipotente, ma è il
giudice che adegua la norma al fatto, che trova il punto di equilibrio del
sistema, unendo “ li mezzi alle regole e la teoria alla pratica”. La
storia, e anche il futuro, della invalidità del provvedimento, ma in
realtà tutto il diritto amministrativo, poggeranno ancora una volta, emulando
una espressione della dottrina francese, sulle ginocchia del Consiglio di Stato.
Legge Elettorale: ITALIA
allo sbando ! Il popolo non riconosce più l’autorità dello Stato !
Non
sono un esperto di diritto Costituzionale ma, alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale che ha stabilito l’illegittimità del Porcellum, immagino
che qualsiasi semplice cittadino come il sottoscritto, si ponga numerosi
interrogativi ai quali, almeno apparentemente, non risulta agevole trovare
risposta, scrive Paolo Cardenà. Certo che, in prima istanza, una sentenza di
questo genere stimolerebbe il dubbio se questa possa avere effetto retroattivo o
meno. Perché, nel primo caso, si determinerebbero effetti sconvolgenti di
difficile immaginazione. Ciò deriverebbe dal fatto che, a rigor di logica,
essendo incostituzionale una legge elettorale, sarebbero illegittimi anche tutti
gli effetti prodotti in virtù di una norma incostituzionale. Quindi, già da otto
anni, i parlamentari eletti con questa legge avrebbero occupato una posizione in
maniera illegittima, poiché in contrasto con lo spirito costituzionale e quindi
con quanto affermato dalla Consulta. Ne deriverebbe che sarebbero illegittimi
anche tutti gli atti normativi (e non solo) prodotti in questo periodo. Di
conseguenza tutte le leggi varate e tutti gli atti compiuti dal Parlamento
sarebbero affetti dal vizio di illegittimità.
Pensate: secondo
questa logica sarebbe illegittima anche la semplice fiducia votata ai vari
governi che si sono succeduti in questo periodo, che sarebbero essi stessi
illegittimi, quindi naturalmente non abilitati a formare o porre in essere
alcuna azione di governo: decreti compresi. Sarebbero illegittime leggi,
modifiche costituzionali (Fiscal Compact compreso), nomine dei vari organi dello
Stato di competenza del Parlamento, o la nomina stessa del Capo dello Stato e
quant’altro prodotto da organi che, in tutto questo tempo, hanno operato per
effetto di attribuzioni derivanti da atti parlamentari formati da un parlamento
illegittimo, quindi fuori dal perimetro costituzionale. Pensate ancora agli
effetti economici e sociali prodotti in tutto questo periodo. Tutto sarebbe
affetto dal vizio di legittimità. Quanto affermato trova fondamento giuridico
nel fatto che si suole farsi discendere detta efficacia retroattiva dal fatto
che la norma caducata è viziata da nullità e quindi non può produrre ab
origine alcun effetto giuridico. Tuttavia autorevoli commentatori e
costituzionalisti avvertono come un’applicazione così radicale e generalizzata
di tale principio possa determinare gravi inconvenienti. Potrebbero invero
prodursi effetti profondamente sconvolgenti sul piano sociale, ovvero oneri
economici insopportabili, rispetto a situazioni da molto tempo cristallizzate.
In fattispecie del genere si afferma che la pronuncia costituzionale, nel suo
concreto risultato, non aderirebbe affatto alla propria funzione, in quanto
darebbe luogo ad un grave turbamento della convivenza. Facendo una semplice
ricerca in rete, ci si accorgerebbe che quanto appena affermato trova sostegno
in numerose sentenze della Cassazione, della Corte Costituzionale, del Consiglio
di Stato e dei Tribunali di merito che sono stati chiamati dirimere la
problematica relativa a rapporti costituitisi in base ad una norma dichiarata
successivamente incostituzionale.
Ve ne riporto
alcune:
“Mentre
l’efficacia retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale è
giustificata dalla stessa eliminazione della norma che non può più regolare
alcun rapporto giuridico salvo che si siano determinate situazioni giuridiche
ormai esaurite, in ipotesi di successione di legge – dal momento che la norma
anteriore è pienamente valida ed efficace fino al momento in cui non è
sostituita – la nuova legge non può che regolare i rapporti futuri e non anche
quelli pregressi, per i quali vale il principio che la disciplina applicabile è
quella vigente al momento in cui si p realizzata la situazione giuridica o il
fatto generatore del diritto. (Cass. civile, sez. 28 maggio 1979, n. 311 in
giustizia civile mass 1979 fasc. 5)”.
“L’efficacia
retroattiva della sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di
norma di legge non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che,
sorti precedentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale, abbiano dato
luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del
passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di
provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli
effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza,
ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o
processuale. (Trib. Roma 14 febbraio 1995)”.
“Le pronunce
di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando
fin dall’origine la validità e l’efficacia della norma dichiarata contraria alla
Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche “consolidate” per
effetto di eventi che l’ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale
effetto, quali le sentenze passate in giudica, l’atto amministrativo non più
impugnabile, la prescrizione e la decadenza. (Cass. civ. sez. III 28 luglio 1997
n. 7057).”
“La
retroattività delle sentenze interpretative additive, pronunciate dalla Corte
costituzionale, trova il suo naturale limite nella intangibilità delle
situazioni e dei rapporti giuridici ormai esauriti in epoca precedente alla
decisione della Corte ( Fattispecie nella quale il provvedimento di esclusione
dai corsi speciali I.S.E.F. è stato impugnato in sede giurisdizionale e in
quella sede è stato riconosciuto legittimo con sentenza passata in giudicato,
con conseguente intangibilità del relativo rapporto) (Con. giust. amm. Sicilia
24 settembre 1993, n. 319).”
“Sebbene la
legge non penale possa avere efficacia retroattiva, tale retroattività,
specialmente nel settore della c.d. interpretazione legislativa autentica,
incontra limiti nelle singole disposizioni costituzionali e nei fondamentali
principi dell’ordinamento, tra i quali va annoverata l’intangibilità del
giudicato, nella specie giudicato amministrativo, in quanto il suo contenuto
precettivo costituisce un modo di essere non più mutabile della realtà
giuridica; pertanto, l’amministrazione non può più esimersi ancorché sia
intervenuta una nuova legge (nella specie, la l. 23 dicembre 1992 n. 498 art.
13) dall’ottemperare al giudicato, dovendosi anzi ritenere, onde il legislatore,
adottando la norma d’interpretazione autentica, abbia comunque inteso escludere
dalla sua applicazione le situazioni coperte dal giudicato. (Consiglio di Stato
a. plen., 21 febbraio 1994, n. 4).”
“Il principio
secondo il quale l’efficacia retroattiva delle pronunce della Corte
Costituzionale recanti dichiarazione de illegittimità costituzionale incontra il
limite della irrevocabilità degli effetti prodotti dalla norma invalidata
nell’ambito dei rapporti esauriti, è applicabile alle sentenze così dette
additive. (Consiglio di Stato sez. VI, 20 novembre 1995).
Quindi, tutto il
ragionamento proposto, di fatto, a quanto sembra, risolve la questione degli
effetti retroattivi della pronuncia della Corte Costituzionale. Ma se da una
parte risulta risolta la questione della retroattività della pronuncia, non
altrettanto può dirsi riguardo al da farsi, stante un quadro reso ancor più
complesso dalla fragile condizione dell’Italia e dalla necessità di approvare la
Legge di Stabilità al vaglio delle aule parlamentari. Infatti, sia la citata
giurisprudenza che la stessa dottrina, sembrerebbero convergere sul fatto che
siffatta pronuncia della Corte, dovrebbe produrre effetti sui rapporti futuri,
quindi, a parer di chi scrive, su tutti gli atti e i fatti che dovrebbe compiere
il parlamento in carica, dalla data di effetto della pronuncia della Corte.
Tuttavia, secondo quanto si legge nella stampa nazionale sembrerebbe che la
consulta abbia lasciato qualche margine di manovra al Parlamento. Secondo quanto
riportato da Il Messaggero, l’efficacia delle novità decise dalla Corte si avrà
dal momento in cui le motivazioni della sentenza saranno pubblicate e questo
avverrà nelle prossime settimane. Un’indicazione offerta esplicitamente dalla
Corte, il che indica che la Consulta ha in qualche modo voluto mettere in mora
il Parlamento, affinchè si affretti a legiferare o a sanare i punti illegittimi
dell’attuale legge. Resta fermo che le Camere possono approvare una nuova legge
elettorale “secondo le proprie scelte politiche, nel rispetto dei principi
costituzionali” sottolinea la Consulta. La corte ha respinto tutti e due i punti
sottoposti al giudizio di costituzionalità: premio di maggioranza e preferenze.
In ogni caso “L’efficacia della sentenza della Corte Costituzionale sulla legge
elettorale decorrerà dal momento in cui le motivazioni saranno pubblicate». Le
motivazioni della sentenza, informa una nota di Palazzo della Consulta, saranno
rese note con la pubblicazione della sentenza, che avrà luogo nelle prossime
settimane e dalla quale dipende la decorrenza dei relativi effetti giuridici. Da
ciò, a parere di chi scrive, se ne deriverebbe che il Parlamento, dalla data di
deposito delle motivazioni, decadrebbe dalla possibilità di legiferare in ogni
materia, salvo la riforma della legge elettorale che superi la carenza di
legittimità del Porcellum. Ma per un quadro di riflessione più ampio e concreto,
bisognerà comunque attendere il deposito delle motivazioni. Il Parlamento è
(dovrebbe essere) il tempio più elevato della democrazia popolare. Ancorché la
giurisprudenza sani l’illegittimità degli atti consolidati, rimane comunque il
fatto che questo Parlamento risulta illegittimo da un punto di vista
sostanziale e morale rispetto ai principi di democrazia sanciti dalla
Costituzione, e naturalmente appartenenti ad uno stato di diritto. Napolitano,
anch’esso eletto in maniera illegittima, dopo gli strappi alla democrazia
perpetrati in questi anni, dovrebbe rimuovere tutti gli elementi che
compromettono l’esercizio libero della democrazia e quindi, dal momento di
efficacia della sentenza, limitare l’azione del Parlamento alla sola riforma
della legge elettorale da concludersi in tempi strettissimi. Dopodiché,
sciogliere le camere e portare a nuove elezioni ristabilendo la democrazia di
questo Paese. In mancanza di questo, il rischio è proprio quello che la
popolazione non riconosca più l’autorità dello Stato, con tutte le imprevedibili
e nefaste conseguenze che ne deriverebbero, che troverebbero terreno fertile in
animi esasperati da anni di crisi e in questa classe politica.
Il Parlamento abusivo
rischia l'arresto.
Dopo la bocciatura del Porcellum, associazioni e sindacati pronti
a bloccare le prossime leggi. Pioggia di ricorsi in arrivo, scrive Antonio
Signorini su “Il Giornale”. Illegittimo il sistema elettorale che ha portato
quasi mille parlamentari a Roma. Illegittime le leggi che hanno approvato o che,
più verosimilmente, approveranno in seguito. Il sospetto è al momento quasi solo
un argomento da accademia, materia per i giuristi. Ma il tema c'è e su questo
ragionamento stanno rizzando le antenne, avvocati, associazioni, sindacati e,
più in generale, tutti quelli che hanno qualche conto aperto con la legge di
Stabilità o con altri provvedimenti approvati o all'esame del Parlamento. Per
tutti questi soggetti, la decisione della Corte costituzionale che ha dichiarato
illegittimo il sistema elettorale, può diventare un argomento da spendere in
tribunale. Ad accennarlo per prima è stato il presidente emerito della Corte
costituzionale Pietro Alberto Capotosti. «In teoria - ha detto in un'intervista
a Qn - dovremmo annullare le elezioni due volte del presidente della Repubblica,
la fiducia data ai vari governi dal 2005, e tutte le leggi che ha fatto un
Parlamento illegittimo. Sennonché il passato si salva applicando i principi
sulle situazioni giuridiche esaurite».
Il futuro no, quindi. E se la questione venisse posta, spiega un avvocato, non
sarebbe respinta. Tra i provvedimenti che il Parlamento eletto con la legge
incostituzionale dovrà approvare c'è appunto la «finanziaria» del governo Letta.
I consumatori già affilano le armi. Il presidente di Adusbef Elio Lannutti
individua i temi sui quali dal suo punto di vista varrebbe la pena giocare la
carta della illegittimità. «Staremo a vedere, ma nella legge ci sono dei
provvedimenti che vanno a favore delle banche come la rivalutazione delle quote
Bankitalia. Una truffa. Poi ci sono 19,4 miliardi di euro per le banche e la
questione della Cassa depositi e prestiti, ormai diventata peggio dell'Iri».
«Se il Parlamento non fosse abilitato a fare le leggi ci troveremmo di fronte a
una situazione allucinante», aggiunge Rosario Trefiletti, presidente di
Federconsumatori. «Io ho sostenuto la nascita del governo delle larghe intese,
ma se la prospettiva è che ogni legge votata dalle Camere finisca al Tar, a
questo punto sarebbe meglio andare a elezioni».
Tutto dipende da cosa scriverà la Consulta nelle motivazioni. Ed è possibile che
alla fine i giudici costituzionali cerchino di salvare gli atti prodotti durante
la legislatura. «La Corte - spiega il presidente del Codacons Carlo Rienzi -
regola l'efficacia delle sentenze e dirà che l'efficacia vale dalla prossima
legislatura». Il nodo è politico, spiega Rienzi. La legge elettorale è
illegittima, i parlamentari dovrebbero approvarne una nuova. «Ma siccome nessuno
vuole farlo, alla fine si realizzerà quello che volevano Letta e Alfano». Cioè
che arrivare a fine legislatura con questo Parlamento e questa legge. Se
succederà una cosa è certa: gli avvocati dello Stato avranno molto lavoro.
Perché la sentenza è piombata in un momento che ad alcuni sarà sembrato
politicamente perfetto (per fare durare il governo e il mandato parlamentare),
ma pessimo per la politica economica. In piena sessione di bilancio, con diversi
capitoli della legge sui quali sono stati annunciati ricorsi. Ad esempio sul
capitolo pubblico impiego con gli insegnanti delle sigle autonome (dalla Gilda
allo Snals-Confsal all'Anief) sul piede di guerra per il blocco degli stipendi.
Poi le mancate rivalutazioni delle pensioni. Per non parlare del capitolo casa.
Tutti temi sui quali sarà chiamato a pronunciarsi un Parlamento - secondo la
Consulta - eletto con una legge illegittima.
Avete
presente le nane bianche?
La morte delle stelle che lascia nel cielo un lucore che a noi sembra una stella
viva ed è invece la traccia di un astro “imploso” secoli fa? Bene, l’Italia è
quest’illusione ottica, questo effetto visivo che è solo una truffa, scrive
Marco Ventura su “Panorama”. È questa l’impressione che ho, l’associazione
d’idee con la decisione della Corte Costituzionale sulla incostituzionalità del
Porcellum. La legge elettorale con la quale siamo andati a votare nelle
politiche degli ultimi otto-nove anni era fasulla, illegittima, contraria alla
Costituzione. Bisognerebbe riavvolgere la pellicola a rifare tutto da capo.
Barrare con un rigo le liste di eletti, la composizione dei Parlamenti, e poi le
fiducie date ai governi. Uno, due, tre, quattro esecutivi. E tutto ciò che
consegue dalla ripartizione dei seggi a Montecitorio e a Palazzo Madama.
Comprese le nomine pubbliche e la composizione della Consulta che ha sancito
l’illegittimità del Porcellum. Tutto per l’ennesima sentenza tardiva, per i
tempi di una giustizia che non riesce a restaurare la legittimità perché non può
modificare a ritroso gli effetti delle situazioni che riconosce, fuori tempo
massimo, contro la legge. Contro la Carta fondamentale. È un po’ come le
decisioni della Sacra Rota. Matrimonio nullo. È stato uno sbaglio.
Ma il problema
non riguarda soltanto il Porcellum. È di pochi giorni fa la notizia che il
procuratore del Lazio della Corte dei Conti, Raffaele De Dominicis, ha sollevato
questione di legittimità davanti alla Consulta sul finanziamento pubblico dei
partiti. “Tutte le disposizioni a partire dal 1997 e via via riprodotte nel
1999, nel 2002, nel 2006 e per ultimo nel 2012” hanno, scrive, “ripristinato i
privilegi abrogati col referendum del 1993” grazie ad “artifici semantici, come
il rimborso al posto del contributo; gli sgravi fiscali al posto di autentici
donativi; così alimentando la sfiducia del cittadino e l’ondata disgregante
dell’anti-politica”. Se la Consulta (tra quanti mesi o anni?) darà ragione alla
Corte dei Conti, i partiti dovranno restituire quello che hanno continuato a
intascare in tutti questi anni? Voi ci credete che succederà? Io no. E che dire
delle eccezioni di costituzionalità che neppure arrivano alla Consulta, ma che
si trascinano in un silenzio assordante finché qualcuno, sull’onda di qualche
rivoluzione cultural-politica, solleverà il problema? Mi riferisco alla
responsabilità civile dei magistrati, per la quale siamo stati condannati
dall’Europa. E che è uno scandalo per un Paese che pretende di appartenere al
novero delle culture giuridiche civili e liberali. Nel Paese nel quale il
cavillo è elevato al rango di Discrimine Massimo, nella patria dei legulei e
degli avvocati, nel paradiso della casta giudiziaria, il cittadino è senza
difese, privo di tutele, schiavo dei tempi della giustizia che dalla piccola
aula di tribunale fino alle sale affrescate della Consulta dispensa sentenze
intempestive e controverse, contaminate dai tempi della politica. Col risultato
che nella patria delle toghe che esercitano un potere superiore anche a quello
del popolo e dei suoi rappresentanti, non c’è pace né giustizia, e le regole in
vigore oggi domani potrebbero rivelarsi una truffa tra dieci anni. Sempre ai
nostri danni. Chi mai ci risarcirà del Porcellum? Chi mai ci risarcirà della
lentezza della giustizia e dell’irresponsabilità dei magistrati? Chi mai ci
risarcirà dei soldi pubblici destinati a chi non ne aveva diritto?
Filippo Facci: La Casta? Siete
solo dei pezzenti. Siete dei pezzenti, avete lasciato tutto in mano ai giudici e
siete ancora lì a fare calcoli, a preventivare poltrone. I giudici
arrestano o no, sequestrano conti, fermano cantieri, giudicano se stessi e cioè
altri giudici, non pagano per i propri errori, decidono se questo
articolo sia diffamatorio, se una conversazione debba finire sui giornali, se
una cura sia regolare o no, se un bambino possa vedere il padre, se un
Englaro possa terminare la figlia, se uno Welby possa terminare se
stesso, i giudici fanno cose buone e colmano il ritardo culturale e
legislativo che voi avete creato in vent’anni, ma i giudici fanno anche un
sacco di porcate, e sono in grado di svuotare e piegare ogni leggina che voi
gli offriate su un piatto d’argento. Ma siete voi pezzenti che glielo
avete lasciato fare. Siete voi che avete lasciato sguarniti gli spazi dei quali
loro - o l’Europa - non hanno potuto non occuparsi. E non è che captare il
ritardo culturale e legislativo fosse impresa da rabdomanti: della necessità di
cambiare il Porcellum lo sapevano tutti, anche i cani, il Porcellum lo
odiano tutti, da anni, e voi esistereste solo per questo, per cambiarlo,
siete in Parlamento espressamente per questo, e proprio per questo sareste stati
eletti: se non fosse che non siete neanche degli eletti. Ma lo abbiamo già
detto, che cosa siete. E, ormai, c’è una sola cosa che rende
ingiustificata l’antipolitica: che non c’è più la politica. Ci siete voi.
Parlamento dichiarato
illegittimo dalla Corte Costituzionale, anch’essa illegittima perché nominata
dal Parlamento e dal Capo dello Stato, anch’esso nominato dal Parlamento Gli
effetti sono che la sentenza di incostituzionalità del Parlamento è anch’essa
illegittima, perché nominata proprio da un Organo abusivo.
Magari fosse incostituzionale
solo il Parlamento, qui siamo tutti incostituzionali, compreso il Capo dello
Stato (perchè eletto da un Parlamento illegittimo), e per lo stesso motivo tutte
le leggi votate da organismi legislativi illegittimi, e la stessa Corte
Costituzionale a rotazione. Paradossalmente, se la corte costituzionale è
illegittima, la stessa sentenza di i incostituzionalità è illegittima:
paradossale ma assolutamente vero. Mi pare uno dei paradossi filosofici, siamo
senza organi istituzionali legittimi e quindi indirettamente nelle mani di
chiunque abbia potere effettivo, visto che il potere formale non c'è più.
Elementare…….Watson! Il modo
di dire più tipico attribuito ad Holmes è la frase "Elementare, Watson!"
("Elementary, my dear Watson!"), quando egli spiega, con una certa
sufficienza, all'amico medico la soluzione di un caso.
Il governo dei giudici?
Si chiede
Domenico Ferrara su “Il Giornale”. Dal Porcellum all'Ilva, da Stamina
alle province e altro ancora. Ormai la magistratura ha preso il posto del
Parlamento. Quando fu coniata, l'espressione descriveva l'atteggiamento
delle toghe conservatrici della Corte Suprema degli Stati Uniti che per lungo
tempo si opposero alle riforme di Roosvelt e del Congresso, ergendosi a
impropria opposizione politica. A distanza di decenni, in Italia, la
magistratura ha fatto passi da gigante e si è seduta direttamente sui banchi
del governo. Parliamo in senso figurato, per carità, epperò l'immagine
rispecchia fedelmente la fotografia degli ultimi anni della vita politica
italiana. Complice, per non dire colpevole, un Parlamento inetto,
incapace di legiferare di suo pugno (chi ricorda a quando risale l'ultima legge
propugnata dal Transatlantico?) e svuotato da ogni funzione di rappresentanza,
la magistratura – ora contabile ora amministrativa ora ordinaria – ha spesso
dettato l'agenda politica, interpretato norme non scritte o financo imposto
decisioni non suffragate da legittimità popolare e rappresentativa. L'ultima
decisione della Consulta in materia di legge elettorale – arrivata
peraltro dopo otto anni di vacatio decisionis – è solo la punta
dell'iceberg. Basti citare il caso dell'Ilva di Taranto, dove i giudici hanno
pure ammesso di aver preso il posto delle istituzioni. Emblematiche le
dichiarazioni dell'Anm: “La vicenda dell’Ilva è un chiaro esempio del fallimento
di altri poteri dello Stato, delle altre autorità che dovevano prevenire questa
situazione. Non è che la magistratura si diverta a fare supplenza: è costretta a
intervenire di fronte a certe ipotesi di reato con gli strumenti propri del
codice". E che dire del taglio alle superpensioni? Bocciato dalla Corte
Costituzionale, che ha salvato la casta dei pensionati ricchi, di quelli cioè
che incassano pensioni da 90mila euro lordi l'anno (e tra questi ci sono anche i
magistrati, guarda caso). Nessun taglio: si sarebbe trattato di un provvedimento
discriminatorio perché toccava i redditi dei soli pensionati e non di tutti i
lavoratori. Amen. Lo stesso dicasi per la Legge 40, approvata dal
Legislatore e dalla volontà popolare. Stessa fine per spesometro e redditometro,
cassati e corretti dalla Corte dei Conti, la stessa che si è opposta
all'abolizione delle province (motivando la decisione con “basse
possibilità di risparmio per gli enti e paventando il rischio di confusione
amministrativa nel periodo transitorio”). Ha suscitato critiche anche la
decisione sul metodo Stamina presa dal Tar del Lazio, accusato di essersi
sostituito ai medici e al governo e di non aver preso in considerazione i pareri
del comitato scientifico e di alcuni premi Nobel. Poi c'è la magistratura
ordinaria che a volte è passata alle cronache per le diverse interpretazioni
date a una legge. Solo per fare un esempio: a Genova un giudice ha pensato bene
di non applicare la legge Bossi-Fini nei confronti di un immigrato. Motivazione?
Contrasta – a suo dire - con una norma europea. E ancora: dall'affidamento di
minori a coppie omosessuali, alle tematiche sul lavoro, passando per i temi
etici e altro ancora, la magistratura è sempre lì, pronta a colmare il vuoto o
il ritardo della politica, o ancora di più pronta a sostituirsi ad essa. Con
buona pace della sovranità popolare.
«Abusivi».
Li chiama proprio così, l’avvocato Gianluigi Pellegrino
intervistato da Tommaso Montesano su “Libero Quotidiano”, i 148 deputati
eletti a Montecitorio grazie al premio di maggioranza del Porcellum, dichiarato
incostituzionale. Un premio contro cui lui, prima ancora della pronuncia della
Corte costituzionale, già a marzo 2013 aveva presentato ricorso alla Giunta
delle elezioni della Camera. Non ci sarebbe niente di particolare se Gianluigi
Pellegrino, figlio del noto avvocato e politico leccese, Giovanni Pellegrino,
più volte in Parlamento, non fosse che è il legale di fiducia del Partito
Democratico. Gianluigi Pellegrino, come il padre, amministrativista di fama
nazionale, è attivissimo nel campo del centrosinistra per aver condotto nelle
aule giudiziarie battaglie sulla legge elettorale, sui quesiti
referendari, perché si andasse a elezioni anticipate per il consiglio
regionale. Fu lui, per esempio, a investire il Tar del Lazio per spingere l’ex
presidente della Regione Lazio a rassegnare finalmente le dimissioni (gesto al
quale era legata la tempistica per l’indizione del voto del 2013). E’ certo,
però, che la famiglia Pellegrino non ha remore a lavorare con i fascisti. La
prova è lì, sul cornicione all’ingresso: anno XII dell’Era Fascista. Era il 1934
e Benito Mussolini era in città a inaugurare questo sanatorio, lavori diretti
dall’ingegnere Oronzo Pellegrino, padre del senatore Giovanni. Si parla a Lecce
dell’ex ospedale Galateo. È questo l’ospedale che venne
utilizzato per la cura della tubercolosi prima, per quella del cancro al polmone
poi.
Adesso il giurista incalza:
«La mancata convalida delle 148 elezioni è doverosa. Ho presentato in tal senso
una memoria in Giunta».
Non sarebbe meglio
attendere il deposito delle motivazioni della sentenza da parte della Corte?
«Ci sono già alcuni punti
fermi che sono più che sufficienti».
Quali, avvocato?
«La Corte ha emesso una
sentenza in parte additiva, cambiando il contenuto delle norme laddove ha
previsto l’incostituzionalità del voto ai listoni bloccati senza la possibilità
di esprimere almeno una preferenza. Una disposizione solo per il futuro».
E l’altra parte della
sentenza, quella sul premio di maggioranza?
«Una pronuncia di tipo
classico. Con la quale la Corte ha ritenuto illegittimi i commi da due a cinque
dell’articolo 82 del testo unico sull’elezione della Camera così come modificato
dal Porcellum. Quei commi sono stati cassati».
E questo che incidenza ha
sul Parlamento attuale?
«Nel momento in cui la Giunta
delle elezioni affronterà la convalida degli eletti, la procedura dovrà essere
compiuta senza applicare i commi che sono stati eliminati dalla Corte».
Ma cosa succede se a
Montecitorio, fiutato il pericolo, procedono alle convalide prima che la
sentenza produca i suoi effetti?
«Sarebbe un atto indecoroso ed
eversivo dinanzi al quale mi aspetterei l’intervento del presidente della
Repubblica. E comunque non ci sarebbe il tempo. Devono ancora essere convalidate
le elezioni di tutti i deputati. L’articolo 17 del regolamento della Camera
stabilisce che alla convalida degli eletti provveda in via definitiva, alla fine
di tutti i conteggi e dopo la proposta della Giunta, l’Aula».
Perché la convalida a tempo
di record sarebbe un atto eversivo?
«Già a marzo ho impugnato
l’elezione dei deputati promossi grazie al premio. E ora il premio è
ufficialmente incostituzionale. Rigettare il ricorso ora è impossibile se non
con un atto eversivo».
Come deve avvenire
l’espulsione degli abusivi?
«Con lo stesso iter adottato
per Silvio Berlusconi. La Giunta delle elezioni deve proporre all’Aula della
Camera, e la Camera votare, la mancata convalida dei 148 deputati».
Al loro posto chi dovrebbe
subentrare?
«Quei seggi andrebbero
ripartiti in base ai voti ottenuti. La gran parte andrebbe a Forza Italia, poi,
a cascata, al M5S, Scelta civica e così via. Una piccola parte andrebbe anche al
Pd».
Un terremoto che avrebbe
effetti sui numeri della maggioranza che sostiene il governo.
«Non è importante e non si
tratta di una motivazione giuridica. Il rischio è un altro».
Che pericoli vede
all’orizzonte?
«Si scatenerà una pressione
sulla Corte costituzionale perché i giudici, in sede di stesura delle
motivazioni della sentenza, dicano qualche parola in più a favore della salvezza
dei deputati sub judice».
Quanto è alto il rischio
che ci sia una valanga di ricorsi da parte dei possibili subentranti qualora il
Parlamento non procedesse sulla strada delle mancate convalide?
«Premesso che sarebbe un
imbroglio, so già che molti di loro si stanno muovendo. E potranno anche
chiedere i danni puntando ad ottenere, oltre alla proclamazione, le rispettive
indennità per i cinque anni di legislatura. Un ulteriore danno per le casse
dello Stato».
LO SPRECO DI DENARO
PUBBLICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO.
L’opinione di un saggista,
Antonio Giangrande, che sul tema qualcosa ne sa.
In un mondo caposotto
(sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli
ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono
l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I
nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è?
A proposito degli avvocati, si
può dissertare o credere sulla irregolarità degli esami forensi, ma tutti gli
avvocati sanno, ed omertosamente tacciono, in che modo, loro, si sono abilitati
e ciò nonostante pongono barricate agli aspiranti della professione. Compiti
uguali, con contenuto dettato dai commissari d’esame o passato tra i candidati.
Compiti mai o mal corretti. Qual è la misura del merito e la differenza tra
idonei e non idonei? Tra iella e buona sorte?
Detto questo, quanto si
risparmierebbe per le casse dello Stato a far cessare la farsa degli annuali
esami di avvocato?
Gli emolumenti per migliaia di
Commissari d’esame diversificati per gli esami scritti ed orali. Gli oneri per
gli impiegati dello Stato. Le spese della transumanza dei compiti. Le spese di
vitto, alloggio e trasferte per i candidati. Spese astronomiche per codici
spesso inutili. Problemi psicologici non indifferenti per i candidati. Non
sarebbe meglio, almeno una volta far decidere chi non ha interesse in conflitto
e si estinguesse questa inutile prova che serve solo a far pavoneggiare chi non
ha merito? I bravi, se sono bravi, si vedono sul campo. L’avvocato è tale solo
se ha lo studio pieno di gente. Chi ha studiato tanti anni, che faccia un
periodo di tirocinio con cause limitate, e poi sia valutato dal mercato, anziché
farsi giudicare dai primi di questo mondo.
SONO BRAVI I COMUNISTI.
NIENTE DIRITTO DI DIFESA PER I POVERI.
Di seguito un comunicato dei
Giuristi Democratici che entra nel merito delle modifiche che il governo Letta
ha imposto col voto di fiducia sulla legge di stabilità. “Non se ne è parlato
molto, ma nella nuova legge di stabilità sono state introdotte, e già approvate
al Senato, alcune importanti variazioni economiche anche in materia di
giustizia: innanzitutto la riduzione di un 30% dei compensi per i difensori (ma
anche per i consulenti tecnici, gli ausiliari e gli investigatori autorizzati)
dei soggetti ammessi al cosiddetto “gratuito patrocinio”. Le spettanze che
possono essere liquidate per la difesa dei soggetti non abbienti, già ridotte
perchè calcolate in base ai valori medi e decurtate del 50% subiscono così
un'ulteriore drastica riduzione. Gli effetti sono facilmente prevedibili: sempre
meno avvocati, consulenti, investigatori privati si renderanno disponibili a
difendere chi si trova nelle condizioni per accedere al patrocinio a spese dello
stato; si parla di persone che possono vantare il non invidiabile primato di
percepire un reddito lordo di poco più di 10.000 euro di reddito l'anno. Sempre
meno difesa per chi non può, sempre meno garanzie, sempre meno diritti. Verso il
basso, ovviamente. Dal punto di vista dell'avvocatura, ovviamente, questa
ulteriore riduzione dei compensi (che vengono materialmente erogati, lo
ricordiamo per i profani, dopo qualche anno dalla conclusione dei procedimenti)
rende la remunerazione di questa attività difensiva inferiore ad ogni limite
dignitoso. Se lo Stato per difendere un poveraccio ti paga meno di un quarto di
una parcella media quanti saranno i professionisti seri ad accettare la mancetta
posticipata di alcuni anni dal lavoro svolto ? Altro che dignità della
professione forense, altro che diritto alla difesa, altro che importanza del
ruolo professionale... Aumentano poi i costi di notifica e, last but not least,
viene chiarito che, in caso di ricorsi con i quali vengono impugnati più atti,
il contributo unificato va conteggiato in relazione ad ogni singolo atto
impugnato, anche in grado d'appello. Si tratta, tipicamente, dei ricorsi in
materia amministrativa, in cui è ordinario impugnare l'atto principale
unitamente ai presupposti. Quando si pensa che il contributo unificato, in
queste materie, è normalmente di 600 euro, ben si comprende che la giustizia
amministrativa diventa veramente un lusso per pochi. Come Giuristi Democratici
riteniamo intollerabile questo continuo attacco alla giustizia sostanziale
operata sempre verso il basso, a scapito dei soggetti più deboli che incappano
nel sistema giustizia o che al sistema giustizia non possono accedere. Pensiamo
cosa significa l'applicazione di questi tagli in danno delle migliaia di
detenuti prodotto delle leggi criminogene di cui la legislazione ha fatto
autentico abuso in questi anni, in materia di stupefacenti, in materia di
ingresso e soggiorno degli stranieri, in materia di recidiva. Pensiamo cosa
significano questi aumenti per le centinaia di comitati di cittadini che si
muovono contro grandi e piccole opere devastanti nei territori. Non possiamo
quindi che esprimere una profonda e ragionata avversità alle misure economiche
che il governo vuol mettere in campo nel settore giustizia e chiedere la
cassazione senza rinvio di queste disposizioni, che rappresentano un vero e
proprio attentato al diritto di giustizia dei cittadini meno abbienti.”
MENTRE PER LE LOBBIES LE
PORTE SONO SEMPRE APERTE.
I deputati del Movimento 5
Stelle hanno usato espressioni altrettanto forti contro lo strapotere delle
lobby in Parlamento. Scandaloso - hanno ribadito ancora in aula durante il voto
per la legge di Stabilità del Governo Letta - che il Partito democratico si
faccia comandare a bacchetta non dal segretario o dal premier bensì da abili
lobbisti che hanno facile accesso alle stanze che contano. Nel ruolo del censore
c'è questa volta Girgis Giorgio Sorial, il giovane deputato grillino che nel
corso del dibattito in Aula ha usato più volte toni e parole tutt'altro che
diplomatiche all'indirizzo del partito del premier. «Questo governo - ha
aggiunto - è fallimentare e fallito perché permette agli squali di mettere mano
ai conti dello Stato. Mentre lavoravamo in commissione c'erano in giro lobbisti
di ogni genere. Mercanteggiavano e barattavano la sicurezza degli incarichi con
la garanzia che i propri privilegi e interessi non sarebbero stati toccati».
Sorial ha quindi ricordato il nome del relatore Maino Marchi (Pd), non casuale,
a suo giudizio, «per una legge che deve essere chiamata marchetta». Sorial si è
spinto oltre e ha rivelato il nome del presunto lobbista che avrebbe avuto
l'impudenza di vantarsi al telefono, proprio nell'anticamera della commissione
Bilancio, di aver «fatto bloccare l'emendamento che prevedeva il taglio delle
pensioni d'oro». In Aula la protesta dei grillini non ha risparmiato nemmeno la
faccia di Luigi Tivelli, ex funzionario della Camera e, secondo i parlamentari
del Movimento 5 Stelle, lobbista di area Pd. Mentre Sorial stigmatizzava il
dilagare dell'attività lobbista dentro le istituzioni, i suoi colleghi
mostravano volantini con sopra la faccia dell'«indagato». Raggiunto al telefono
dalle agenzie di stampa il diretto interessato ha smentito la sua «funzione»,
giustificando la sua presenza alla Camera per ricerche documentali per un libro.
«Quelle parole al telefono? Con i miei amici siamo soliti usare ironia e
iperboli, figure retoriche che i grillini non conoscono».
Proprio come uno stipendio.
Con regolarità. Mensilmente, racconta Pier Francesco Borgia su “Il Giornale. Ad
alcuni senatori e deputati arriverebbero ogni mese finanziamenti da parte di
alcune multinazionali che farebbero attività di lobby sfruttando soprattutto
l'ingordigia dei nostri rappresentanti politici. Questo almeno il senso
dell'accusa lanciata dalla puntata delle Iene andata in onda su Italia Uno il 19
maggio 2013. Nel servizio si vede un assistente parlamentare ripreso di spalle
che con la voce alterata racconta il sistema utilizzato da alcune multinazionali
per far passare emendamenti «favorevoli». Il meccanismo, racconta la gola
profonda, è semplice. «Ci sono multinazionali che hanno a libro paga alcuni
senatori». Come funziona il meccanismo? «Semplice - spiega il portaborse - un
emissario della società viene da noi a Palazzo Madama e ci consegna i soldi per
i parlamentari per cui lavoriamo». Le cifre? Si tratterebbe di operazioni che
prevedono addirittura una sorta di tariffario: «Per quel che mi riguarda -
spiega l'intervistato - conosco due multinazionali, una del settore dei tabacchi
e un'altra nel settore dei videogiochi e delle slot machine ed entrambe
elargiscono dai mille ai duemila euro ogni mese». La tariffa, inoltre, cambia «a
seconda dell'importanza del senatore e quindi, se è molto influente, sale fino a
5mila euro». Lo scopo è facile da intuire. Questi parlamentari si devono
impegnare a far passare emendamenti favorevoli su leggi che interessano le
stesse aziende. Per fare un esempio preciso, l'anonimo portaborse cita le sale
Bingo per le quali «si sono formati due gruppi, partecipati sia da uomini del
centro sinistra che da uomini del centro destra. I due gruppi fanno capo ad ex
ministri del centro sinistra». Inutile precisare che questo tipo di attività di
lobby non è corretta e, anzi, viola non solo codici morali ma anche le leggi
scritte, nonché i patti con gli elettori. Immediata la reazione di Pietro
Grasso, presidente dell'aula del Senato. «Dal servizio delle Iene - si legge in
una nota di Palazzo Madama - emerge la denuncia di un comportamento che, se
provato, sarebbe gravissimo. Purtroppo la natura di denuncia, anonima nella
fonte e nei destinatari, rende difficile procedere all'accertamento della
verità. Spero quindi che gli autori del servizio e il cittadino informato di
fatti così gravi provvedano senza indugio a fare una regolare denuncia alla
Procura, in modo da poter accertare natura e gravità dei fatti contestati». Il
servizio delle Iene non si limita a questa grave denuncia. La trasmissione
mostra, poi, il diffuso malcostume, da parte dei parlamentari, di rimborsare in
nero i loro assistenti. Molti «portaborse» prenderebbero, a quanto riferiscono
Le iene, 800 euro in nero al mese pur disponendo del regolare tesserino per
entrare a Palazzo Madama. La confessione di questo sfruttamento e questo
malcostume arriva ovviamente in forma anonima: «Il 70% dei colleghi si trova
nelle mie stesse condizioni», racconta la gola profonda spiegando di lavorare in
nero da circa dieci anni e di essere stato assistente «sia di un senatore di
destra che di un senatore di sinistra». Tutta colpa dell'autodichìa, dice il
questore del Senato ed esponente grillina Laura Bottici: «All'interno di Palazzo
Madama, dove si approvano le leggi, non hanno validità le leggi stesse ma solo i
regolamenti interni. È questo il vero problema». È vero che modificare i
regolamenti parlamentari è altrettanto complicato che redigere nuove leggi.
Tuttavia non è su questo aspetto che si focalizza l'attenzione del presidente
del Senato. «Giorni fa ho evidenziato - ricorda Grasso - l'esigenza di una legge
che disciplini, in maniera chiara e trasparente, l'attività lobbistica che al
momento, seppur sempre presente, si muove in maniera nascosta».
LA LOBBY DEI DENTISTI E LA
MAFIA ODONTOIATRICA.
In una sequela di corpi nudi,
da quale particolare tra loro riconosceresti un indigente? Dai denti,
naturalmente! Guardalo in bocca quando ride e quando parla e vedrai una
dentatura incompleta, cariata e sporca.
In fatto di salute dentale gli
italiani non si rivolgono alla ASL. I dentisti della ASL ci sono, eppure è solo
l'8% degli italiani ad avvalersi dei dentisti pubblici. Nel 92% dei casi gli
italiani scelgono un dentista privato. Più che altro ad influenzare la scelta
per accedere a questa prestazione medica è perché alla stessa non è riconosciuta
l’esenzione del Ticket. Ci si mette anche la macchinosità burocratica
distribuita in più tempi: ricetta medica; prenotazione, pagamento ticket e
finalmente la visita medica lontana nel tempo e spesso a decine di km di
distanza, che si protrae in più fasi con rinnovo perpetuo di ricetta,
prenotazione e pagamento ticket. La maggiore disponibilità del privato sotto
casa a fissare appuntamenti in tempi brevi, poi, è la carta vincente ed alla
fine dei conti, anche, la più conveniente. Ciononostante la cura dei denti ci
impone di aprire un mutuo alla nostra Banca di fiducia.
Il diritto alla salute dei
denti, in questo stato di cose, in Italia, è un privilegio negato agli
svantaggiati sociali ed economici.
LA VULNERABILITA’ SOCIALE. Può
essere definita come quella condizione di svantaggio sociale ed economico,
correlata di norma a condizioni di marginalità e/o esclusione sociale, che
impedisce di fatto l’accesso alle cure odontoiatriche oltre che per una scarsa
sensibilità ai problemi di prevenzione e cura dei propri denti, anche e
soprattutto per gli elevati costi da sostenere presso le strutture
odontoiatriche private. L’elevato costo delle cure presso i privati, unica
alternativa oggi per la grande maggioranza della popolazione, è motivo di
ridotto accesso alle cure stesse anche per le famiglie a reddito medio - basso;
ciò, di fatto, limita l’accesso alle cure odontoiatriche di ampie fasce di
popolazione o impone elevati sacrifici economici qualora siano indispensabili
determinati interventi.
Pertanto, tra le condizioni di
vulnerabilità sociale si possono individuare tre distinte situazioni nelle quali
l’accesso alle cure è ostacolato o impedito:
a) situazioni di esclusione
sociale (indigenza);
b) situazioni di povertà:
c) situazioni di reddito medio
– basso.
Perché il Servizio Sanitario
Nazionale e di rimando quello regionale e locale non garantisce il paritetico
accesso alle cure dentali? Perché a coloro che beneficiano dell’esenzione al
pagamento del Ticket, questo non è applicato alla prestazione odontoiatrica
pubblica?
Andare dal dentista gratis
è forse il sogno di tutti, visti i conti che ci troviamo periodicamente a
pagare e che non di rado sono la ragione per cui si rimandano le visite
odontoiatriche, a tutto discapito della salute dentale. Come avrete capito,
insomma, non è così semplice avere le cure dentistiche gratis e spesso, per
averle, si devono avere degli svantaggi molto forti, al cui confronto la
parcella del dentista, anche la più cara, non è nulla. E' però importante sapere
e far sapere che, chi vive condizioni di disagio economico o ha malattie gravi,
può godere, ma solo in rare Regioni, di cure dentistiche gratuite a totale
carico del Sistema Sanitario Nazionale. Diciamo subito che non tutti possono
avere questo diritto: le spese odontoiatriche non sono assimilabili a quelle di
altre prestazioni mediche offerte nelle ASL, negli ospedali e nelle cliniche
convenzionate di tutta Italia. Inoltre, qualora si rendano necessarie protesi
dentarie o apparecchi ortodontici, questi sono a carico del paziente: vi sono
però alcune condizioni particolari che permettono, a seconda dei regolamenti
regionali, di ottenere protesi dentali gratuite e apparecchi a costo zero o
quasi. Le regioni amministrano la sanità, e dunque anche le cure dentistiche,
con larghe autonomie che a loro volta portano a differenze anche sostanziali da
un luogo all'altro. Bisogna, quando si nasce, scegliersi il posto!
Alla fine del racconto, la
morale che se ne trae è una. E’ possibile che la lobby dei dentisti sia così
forte da influenzare le prestazioni sanitarie delle Asl italiane e gli indirizzi
legislativi del Parlamento? In tempo di crisi ci si deve aspettare un popolo di
sgangati senza denti, obbligati al broncio ed impediti al sorriso da una
ignobile dentatura?
«Siamo un paese di gente che,
presi uno ad uno, si definisce onesta. Per ogni male che attanaglia questa
Italia, non si riesce mai a trovare il responsabile. Tanto, la colpa è sempre
degli altri!». Così afferma il dr Antonio Giangrande, noto saggista di fama
mondiale e presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, sodalizio
antimafia riconosciuto dal Ministero dell’Interno. Associazione fuori dal coro e
fuori dai circuiti foraggiati dai finanziamenti pubblici.
«Quando ho trattato il tema
dell’odontoiatria, parlando di un servizio non usufruibile per tutti, non ho
affrontato l’argomento sulla selezione degli odontoiatri. Non ho detto, per
esempio, che saranno processati a partire dal prossimo 6 marzo 2014 i 26
imputati rinviati a giudizio dal gup del Tribunale di Bari Michele Parisi
nell'ambito del procedimento per i presunti test di ingresso truccati per
l'ammissione alle facoltà di odontoiatria e protesi dentaria delle Università di
Bari, Napoli, Foggia e Verona, negli anni 2008-2009. Ho scritto solo un articolo
asettico dal titolo eclatante.»
Questo articolo è stato
pubblicato da decine di testate di informazione. E la reazione dei dentisti non
si è fatta attendere, anche con toni minacciosi. Oggetto degli strali polemici è
stato, oltre che Antonio Giangrande, il direttore di “Oggi”.
«I Dentisti non sono mafiosi
bensì gli unici che si prendono cura dei cittadini». ANDI protesta con Oggi per
una delirante lettera pubblicata. Così viene definito l’articolo. Il 14 gennaio
2014 sul sito del settimanale Oggi, nella rubrica “C’è posta per noi”, è stata
pubblicata una missiva del dott. Antonio Giangrande presidente dell’Associazione
Contro Tutte le Mafie dal titolo “La lobby dei dentisti e la mafia
odontoiatrica”. Nella nota Giangrande analizza il bisogno di salute orale e le
difficoltà del servizio pubblico di dare le risposte necessarie chiedendosi se
tutto questo non è frutto del lavoro della lobby dei dentisti talmente potente
da influenzare le prestazioni sanitarie delle Asl e le decisioni del Parlamento.
ANDI, per tutelare l’immagine dei dentisti liberi professionisti italiani, sta
valutando se intraprendere azioni legali nei confronti dell’autore della lettera
e del giornale. Intanto ha chiesto di pubblicare la nota che riportiamo sotto.
La Redazione di Oggi ha scritto il 24.1.2014 alle 16:59, Il precedente titolo
della lettera del Dottor Giangrande era fuorviante e di questo ci scusiamo con
gli interessati. Qui di seguito l’intervento dell’Associazione Nazionale
Dentisti italiani, a nome del Presidente Dott. Gianfranco Prada, in risposta
allo stesso Dottor Giangrande. «A nome dei 23 mila dentisti italiani Associati
ad ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) che mi onoro di presiedere
vorrei rispondere alla domanda che il dott. Antonio Giangrande, presidente
dell’Associazione Contro tutte le Mafie ha posto sul suo giornale il 14 gennaio.
“E’ possibile che la lobby dei dentisti sia così forte da influenzare le
prestazioni sanitarie delle Asl italiane e gli indirizzi legislativi del
Parlamento? In tempo di crisi ci si deve aspettare un popolo di sgangati senza
denti, obbligati al broncio ed impediti al sorriso da una ignobile dentatura?”
La risposta è no. No, dott. Giangrande non c’è una lobby di dentisti così forte
da influenzare le scelte della sanità pubblica. La causa di quanto lei scrive si
chiama spending review o se vogliamo utilizzare un termine italiano dovremmo
dire tagli: oltre 30 miliardi negli ultimi due anni quelli per la sanità. Poi io
aggiungerei anche disinteresse della politica verso la salute orale che non ha
portato, mai, il nostro SSN ad interessarsi del problema. Vede dott. Giangrande
lei ha ragione quando sostiene che un sorriso in salute è una discriminante
sociale, ma non da oggi, da sempre. Ma questo non per ragioni economiche, bensì
culturali. Chi fa prevenzione non si ammala e non ha bisogno di cure. Mantenere
sotto controllo la propria salute orale costa all’anno quanto una signora spende
alla settimana dalla propria parrucchiera. Ed ha anche ragione quando “scopre”
che le cure odontoiatriche sono costose, ma non care come dice lei. Fare una
buona odontoiatria costa e costa sia al dentista privato che alla struttura
pubblica, che infatti non riesce ad attivare un servizio che riesca a soddisfare
le richieste dei cittadini. Inoltre, oggi, lo stato del SSN quasi al collasso,
non consente investimenti nell’odontoiatria: chiudono i pronto soccorso o
vengono negati prestazioni salva vita. Ma le carenze del pubblico
nell’assistenza odontoiatrica non è neppure di finanziamenti, è di come questi
soldi vengono investiti. Qualche anno fa il Ministero della Salute ha effettuato
un censimento per capire le attrezzature ed il personale impiegato da Ospedali
ed Asl nell’assistenza odontoiatrica e da questo è emerso che i dentisti
impiegati utilizzano gli ambulatori pubblici in media per sole 3 ore al giorno.
Ma non pensi sia per negligenza degli operatori, molto spesso è la stessa Asl
che non può permettersi di attivare il servizio per più tempo. Non ha i soldi.
Però poi succede anche che utilizzi le strutture pubbliche per dare assistenza
odontoiatrica a pagamento e quindi per rimpinguare i propri bilanci. Come mai
non ci indigna per questo? Il problema non è di carenza di attrezzature
(mediamente quelle ci sono) sono i costi per le cure. Una visita odontoiatria è
molto più costosa di una visita di qualsiasi altra branca della medicina. Pensi
quando il suo dermatologo o cardiologo la visita e poi allo studio del suo
dentista in termini di strumenti, attrezzature e materiali utilizzati. Anche con
i pazienti che pagano il ticket l’Asl non riesce a coprire neppure una piccola
parte dei costi sostenuti per effettuare la cure. Da tempo chiediamo ai vari
Ministri che negli anni hanno trascurato l’assistenza odontoiatrica di dirottare
quegli investimenti in un progetto di prevenzione odontoiatrica verso la fasce
sociali deboli e i ragazzi. Una seria campagna di prevenzione permetterebbe di
abbattere drasticamente le malattie del cavo orale, carie e malattia
parodontale, diminuendo drasticamente la necessità di interventi costosi futuri
come quelli protesici. Invece nelle nostre Asl e negli ospedali non si previene
e non si cura neppure, perché costa troppo curare, così si estraggono solo
denti… creando degli “sdentati” che avranno bisogno di protesi. Dispositivo che
il nostro SSN non può erogare. Ma molto spesso lo fa a pagamento. Pensi, dott.
Giangrande, siamo talmente lobbie che l’unico progetto di prevenzione pubblica
gratuito attivo su tutto il territorio nazionale è reso possibile da 35 anni dai
dentisti privati aderenti all’ANDI. Stesso discorso per l’unico progetto di
prevenzione del tumore del cavo orale, 6 mila morti all’anno per mancata
prevenzione. Per aiutare gli italiani a tutelare la propria salute orale
nell’immediato basterebbe aumentare le detrazioni fiscali della fattura del
dentista (oggi è possibile detrarre solo il 19%) ma questo il Ministero
dell’Economia dice che non è possibile. Però da anni si permette ai cittadini di
detrarre oltre il 50% di quanto spendono per ristrutturare casa o per comprare
la cucina. Come vede, caro dott. Giangrande, il problema della salute orale è
molto serio così come molto serio il problema della mafia. Ma proprio perché
sono problemi seri, per occuparsene con competenza bisogna sforzarsi di
analizzare il problema con serietà e non fare le proprie considerazioni
utilizzando banali lunghi comuni. In questo modo insulta solo i dentisti
italiani che sono seri professionisti e non truffatori o peggio ancora mafiosi.
Fortunatamente questo i nostri pazienti lo sanno, ecco perché il 90% sceglie il
dentista privato e non altre strutture come quelle pubbliche o i low cost.
Perché si fida di noi, perché siamo seri professionisti che lavorano per
mantenerli sani. Aspettiamo le sue scuse. Il Presidente Nazionale ANDI, Dott.
Gianfranco Prada».
Antonio Giangrande, come sua
consuetudine, fa rispondere i fatti per zittire polemiche strumentali e senza
fondamento, oltre che fuorvianti il problema della iniquità sociale imperante.
Palermo. Morire, nel 2014,
perché non si vuole - o non si può - ricorrere alle cure di un dentista.
Da un ospedale
all'altro: muore per un ascesso. Quando il dolore è diventato insopportabile
ha deciso di rivolgersi ai medici, ma la situazione è precipitata, scrive
Valentina Raffa su “Il Giornale”, martedì 11/02/2014. Una storia alla Dickens,
con la differenza però che oggi non siamo più nell'800 e romanzi sociali come
«Oliver Twist», «David Copperfield» e «Tempi difficili» dovrebbero apparire
decisamente anacronistici. Eppure... Eppure succede che ai nostri giorni si
possa ancora morire per un mal di denti. Un dolore a un molare che la
protagonista di questa drammatica vicenda aveva cercato di sopportare. Difficile
rivolgersi a un dentista, perché curare un ascesso avrebbe richiesto una certa
spesa. E Gaetana, 18enne di Palermo, non poteva permettersela. Lei si sarebbe
dovuta recare immediatamente in Pronto soccorso. Quando lo ha fatto, ossia
quando il dolore era divenuto lancinante al punto da farle perdere i sensi, per
lei non c'era più nulla da fare. È stata accompagnata dalla famiglia
all'ospedale Buccheri La Ferla, di Palermo, dove avrebbe risposto bene alla
terapia antibiotica, ma purtroppo il nosocomio (a differenza del Policlinico)
non dispone di un reparto specializzato. Quando quindi la situazione si è
aggravata, la donna è stata portata all'ospedale Civico. Ricoverata in 2^
Rianimazione, i medici hanno tentato il possibile per salvarle la vita. A quel
punto, però, l'infezione aveva invaso il collo e raggiunto i polmoni. L'ascesso
al molare era divenuto fascite polmonare. L'agonia è durata giorni. La vita di
Gaetana era appesa a un filo. Poi è sopraggiunto il decesso. Le cause della
morte sono chiare, per cui non è stata disposta l'autopsia. Nel 2014 si muore
ancora così. E pensare che esiste la «mutua». Ma Gaetana forse non lo sapeva.
Sarebbe bastato recarsi in ospedale con l'impegnativa del medico di base. è una
storia di degrado, non di malasanità: ci sono 4 ospedali a Palermo con servizio
odontoiatrico. Ma nella periferia tristemente famosa dello Zen questa non è
un'ovvietà.
Morire di povertà. Gaetana
Priola, 18 anni, non aveva i soldi per andare dal dentista scrive “Libero
Quotidiano”. La giovane si è spenta all'ospedale civico di Palermo, dove era
ricoverata dai primi giorni di febbraio 2014. A ucciderla, un infezione
polmonare causata da un ascesso dentale mai curato. All'inizio del mese,
la giovane era svenuta in casa senza più dare segni di vita. I medici le avevano
diagnosticato uno choc settico polmonare, condizione che si verifica in
seguito a un improvviso abbassamento della pressione sanguigna. Inizialmente,
Gaetana era stata trasportata al Bucchieri La Ferla e, in seguito, era
stata trasferita nel reparto di rianimazione del Civico. Le sue condizioni sono
apparse da subito come gravi. I medici hanno provato a rianimarla ma, dopo una
settimana di cure disperate, ne hanno dovuto registrare il decesso.
Disperazione e dolore nel quartiere Zen della città, dove la vittima risiedeva
insieme alla famiglia.
All'inizio era un semplice mal
di denti, scrive “Il Corriere della Sera”. Sembrava un dolore da sopportare
senza drammatizzare troppo. Eppure in seguito si è trasformato in un ascesso poi
degenerato in infezione. Una patologia trascurata, forse anche per motivi
economici, che ha provocato la morte di una ragazza di 18 anni, Gaetana Priolo.
La giovane, che abitava a Palermo nel quartiere Brancaccio, non si era curata;
qualcuno dice che non aveva i soldi per pagare il dentista. Un comportamento che
le è stato fatale: è spirata nell'ospedale Civico per uno «shock settico
polmonare». Le condizioni economiche della famiglia della ragazza sono disagiate
ma decorose. Gaetana era la seconda di quattro figli di una coppia separata: il
padre, barista, era andato via un paio di anni fa. Nella casa di via Azolino
Hazon erano rimasti la moglie, la sorella maggiore di Gaetana, il fratello e una
bambina di quasi cinque anni. Per sopravvivere e mantenere la famiglia la madre
lavorava come donna delle pulizie. «È stata sempre presente, attenta, una donna
con gli attributi», dice Mariangela D'Aleo, responsabile delle attività del
Centro Padre Nostro, la struttura creato da don Pino Puglisi, il parroco uccisa
dalla mafia nel '93, per aiutare le famiglie del quartiere in difficoltà.
L'inizio del calvario per Gaetana comincia il 19 gennaio scorso: il dolore è
insopportabile tanto da far perdere i sensi alla diciottenne. La ragazza in
prima battuta viene trasportata al Buccheri La Ferla e visitata al pronto
soccorso per sospetto ascesso dentario. «Dopo due ore circa, in seguito alla
terapia, essendo diminuito il dolore, - afferma una nota della direzione del
nosocomio - è stata dimessa per essere inviata per competenza presso
l'Odontoiatria del Policlinico di Palermo». Dove però Gaetana non è mai andata.
Si è invece fatta ricoverare il 30 gennaio al Civico dove le sue condizioni sono
apparse subito gravi: in seconda rianimazione le viene diagnosticata una
fascite, un'infezione grave che partendo dalla bocca si è già diffusa fino ai
polmoni - dicono all'ospedale -. I medici fanno di tutto per salvarla, ma le
condizioni critiche si aggravano ulteriormente fino al decesso avvenuto la
settimana scorsa. Al momento non c'è nessuna denuncia della famiglia e nessuna
inchiesta è stata aperta. «È un caso rarissimo - spiega una dentista - ma certo
non si può escludere che possa accadere». Soprattutto quando si trascura la cura
dei denti. Ed è questo un fenomeno in crescita. «L'11% degli italiani rinuncia
alle cure perchè non ha le possibilità economiche, e nel caso delle visite
odontoiatriche la percentuale sale al 23% - denuncia il segretario nazionale
Codacons, Francesco Tanasi - In Sicilia la situazione è addirittura peggiore.
Chi non può permettersi un medico privato, si rivolge alla sanità pubblica,
settore dove però le liste d'attesa sono spesso lunghissime, al punto da
spingere un numero crescente di utenti a rinunciare alle cure».
“È un caso rarissimo – spiega
una dentista – ma certo non si può escludere che possa accadere”, scrive
“Canicattiweb”. Soprattutto quando si trascura la cura dei denti. Ed è questo un
fenomeno in crescita. Il Codacons si è schierato subito al fianco dei familiari
e dei cittadini indigenti. “Il caso della 18enne morta a Palermo a causa di un
ascesso non curato per mancanza di soldi, è uno degli effetti della crisi
economica che ha colpito la Sicilia in modo più drammatico rispetto al resto
d’Italia”. “L’11% degli italiani rinuncia alle cure mediche perché non ha le
possibilità economiche per curarsi, e nel caso delle le visite odontoiatriche la
percentuale sale al 23% – denuncia il segretario nazionale Codacons, Francesco
Tanasi – Ed in Sicilia la situazione è addirittura peggiore. Chi non può
permettersi cure private, si rivolge alla sanità pubblica, settore dove però le
liste d’attesa sono spesso lunghissime, al punto da spingere un numero crescente
di utenti a rinunciare alle cure. Tale stato di cose genera emergenze e
situazioni estreme come la morte della ragazza di Palermo. E’ intollerabile che
nel 2014 in Italia si possa morire per mancanza di soldi – prosegue Tanasi – Il
settore della sanità pubblica deve essere potenziato per garantire a tutti le
prestazioni mediche, mentre negli ultimi anni abbiamo assistito a tagli lineari
nella sanità che hanno prodotto solo un peggioramento del servizio e un
allungamento delle liste d’attesa”.
Bene, cari dentisti, gli
avvocati adottano il gratuito patrocinio, ma non mi sembra che voi adottiate il
“Pro Bono Publico” nei confronti degli indigenti. Pro bono publico
(spesso abbreviata in pro bono) è una frase derivata dal latino che
significa "per il bene di tutti". Questa locuzione è spesso usata per descrivere
un fardello professionale di cui ci si fa carico volontariamente e senza la
retribuzione di alcuna somma, come un servizio pubblico. È comune nella
professione legale, in cui - a differenza del concetto di volontariato -
rappresenta la concessione gratuita di servizi o di specifiche competenze
professionali al servizio di coloro che non sono in grado di affrontarne il
costo.
UNIONE EUROPEA: ITALIA 60
MILIARDI DI CORRUZIONE. CHI CAZZO HA FATTO I CONTI?
Il 3 febbraio 2014 Cecile
Malmstrom, commissario europeo per gli affari interni, presenta il primo
rapporto sulla corruzione nell’Unione, stimata in 120 miliardi di euro, scrive
Emilio Casalini su “Il Corriere della Sera” . Nel capitolo dedicato all’Italia
si ricorda che la nostra Corte dei Conti ha valutato la corruzione italiana in
60 miliardi di euro. La maggior parte dei giornali, tg, agenzie di stampa
ribatte a caratteri cubitali la notizia per cui metà della corruzione europea è
in Italia. I due dati però non sono omogenei né sovrapponibili. Il nostro in
particolare lo troviamo nel discorso per l’inaugurazione dell’anno giudiziario
2012, dove a pagina 100 si legge che "Se l’entità monetizzata della corruzione
annuale in Italia è stata correttamente stimata in 60 miliardi di euro dal Saet
"... sarebbe un’esagerazione. Quindi nemmeno la Corte dei Conti ha mai fatto
calcoli di prima mano, ma si riferisce, ritenendolo peraltro esagerato, al
rapporto di un altro organismo, il Saet, ossia il Servizio Anticorruzione e
Trasparenza. Quest'ultimo però, a pagina 10 nel suo rapporto del 2009, ha
scritto esattamente l’opposto, ossia che “le stime che si fanno sulla
corruzione, 50-60 miliardi l’anno, senza un modello scientifico, diventano
opinioni da prendere come tali, ma che complice la superficialità dei
commentatori e dei media, aumenta la confusione e anestetizza qualsiasi slancio
di indignazione e contrasto”. Solo opinioni dunque. Il Servizio Anticorruzione
negli anni successivi continua a spiegare che si tratta di cifre inventate e
cita (a pagina 130) perfino il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban
Ki-moon, il quale “ha confermato l’infondatezza della fantasiosa stima di 60
miliardi di euro quale costo della corruzione ogni anno in Italia". Quella cifra
sembra essere troppo alta perfino per noi! Ma da dove è nata allora questa cifra
che da molti anni tutti ripetono come un mantra? Forse da un semplice calcolo,
magari citato in un convegno. Nel 2004 la Banca Mondiale aveva pubblicato un
rapporto in cui teorizzava che la corruzione del mondo fosse stimabile in mille
miliardi di dollari. Considerato il Pil globale dell’epoca, la corruzione
corrispondeva quindi ad oltre il 3% del Pil mondiale. Applicando la stessa
percentuale al PIL italiano, ecco saltare fuori la cifra tonda di 60 miliardi.
Una cifra inventata ma citata ormai anche dalle istituzioni comunitarie. Ma la
cosa più grave, come dice il primo rapporto della Saet, è che un elemento che
non si misura, non si gestisce, e quindi non si combatte, non si contrasta.
FATTI DI CRONACA, DISFATTI
DI GIUSTIZIA.
Quello che la gente non
capisce……e quello che non si osa dire.
Colloquio con il dr Antonio
Giangrande, scrittore e sociologo storico, noto per i suoi saggi d’inchiesta
letti in tutto il mondo e per i suoi articoli pubblicati in tutta Italia, ma
ignorato dai media generalisti foraggiati dallo Stato.
«Da anni racconto ai posteri
ed agli stranieri quello che in Italia non si osa dire. In tema di Giustizia la
gente si spella le mani ad osannare quelli che certa politica e certa
informazione ha santificato: ossia, i magistrati. Dico questo senza alcun
pregiudizio e, anzi, con il rispetto che devo ad amici e magistrati che stimo ed
ai quali questa percezione, che non credo sia mio esclusivo patrimonio, non
rende il giusto merito. Bene. Io, nei miei testi e nei miei video, parlo di chi,
invece da innocente non ha voce. Racconto le loro storie, affinchè in un’altra
vita venga reso a loro quella giustizia che in questa realtà gli è negata. Un
indennizzo o un risarcimento per quello che gli è stato tolto e mai più gli può
essere reso. La dignità ed ogni diritto. Specialmente se poi le pene sono
scontate nei canili umani. Cosa orrenda se io aborro questa crudeltà e perciò,
addirittura, non ho il mio cane legato alle catene. Ogni città ha le sue storie
di ingiustizie da raccontare che nessuno racconta. La mia missione è farle
conoscere, pur essendo irriconoscenti le vittime. Parlo di loro, vittime
d’ingiustizia, ma parlo anche delle vittime del reato. Parlo soprattutto
dell’ambiente sociale ed istituzionale che tali vicende trattano. Vita morte e
miracoli di chi ha il potere o l’indole di sbagliare e che, con i media
omertosi, invece rimane nell’ombra o luccica di luce riflessa ed immeritata. Sul
delitto di Sarah Scazzi ad Avetrana, il mio paese, ho raccontato quello che in
modo privilegiato ho potuto vedere, ma non è stato raccontato. Ma non solo di
quel delitto mi sono occupato. Nel libro su Perugia mi sono occupato del delitto
di Meredith Kercher. Per esempio.
FIRENZE. 30 gennaio 2014.
Ore 22.00 circa.
Come volevasi dimostrare. Ogni volta che un delitto si basa su indizi aleatori
che si sottopongono a contrastanti interpretazioni, i magistrati condannano, pur
sussistendo gravi dubbi che lasciano sgomenti l'opinione pubblica. Condannano
non al di là del ragionevole dubbio e lo fanno per non recare sgarbo ai colleghi
dell'accusa. I sensitivi hanno delle sensazioni e li palesano, spesso non
creduti. I pubblici ministeri, in assenza di prove, anch’essi hanno delle
sensazioni. Solo che loro vengono creduti dai loro colleghi. Sia mai che venga
lesa l’aurea di infallibilità di chi, con un concorso all’italiana, da un giorno
all’altro diventa un dio in terra. Osannato dagli italici coglioni, che pur
invischiati nelle reti dell’ingiustizia, nulla fanno per ribellarsi.
«Grazie a quei giudici
coscienziosi e privi di animosità politica che spero sempre di trovare - ha
detto Silvio Berlusconi riferendosi ai suoi guai giudiziari - gli italiani
potranno comprendere appieno la vera e propria barbarie giudiziaria in cui
l’Italia è precipitata. Una degenerazione dei principali capisaldi del diritto -
ha, infine, concluso - che ha riservato a me e alle persone che mi stimano e mi
vogliono bene un’umiliazione e, soprattutto, un dolore difficilmente
immaginabili da parte di chi non vive l’incubo di accuse tanto ingiuste quanto
infondate».
Se lo dice lui che è stato
Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana?
Silvio Berlusconi:
«Venti anni di guerra contro di me. In Italia giustizia ingiusta per tutti».
Raffaele Sollecito: «Io
sono innocente. Come mi sento? Vorrei che gli altri si mettessero al mio posto.
E’ così...».
Sabrina Misseri: «Io
non c'entro niente, sono innocente».
Alberto Stasi:
«Io sono innocente».
Queste sono solo alcune delle
migliaia di testimonianze riportate nei miei saggi. Gente innocente condannata.
Gente innocente rinchiusa in carcere. Gente innocente rinchiusa in carcere
addirittura in attesa di un giudizio che arriverà con i tempi italici e
rilasciato da magistrati che intanto si godono le loro ferie trimestrali.
Questo può bastare a
dimostrare la mia cognizione di causa?
Quale altro ruolo
istituzionale prevede l’impunità di fatto per ogni atto compiuto nell’esercizio
del proprio magistero? Quale altro organo dello Stato è il giudice di se stesso?
Di questa sorte meschina
capitata ai più sfortunati, la maggioranza dei beoti italici se ne rallegra. Il
concetto di Schadenfreude potrebbe anche venire parafrasato come "compiacimento
malevolo". Il termine deriva da Schaden (danno) e Freude (gioia).
In tedesco il termine ha sempre una connotazione negativa. Esiste una
distinzione tra la "schadenfreude segreta" (un sentimento privato) e la
"schadenfreude aperta" (Hohn). Un articolo del New York Times del
2002 ha citato una serie di studi scientifici sulla Schadenfreude, che ha
definito come "delizia delle disgrazie altrui".
Ecco perché Antonio
Giangrande è orgoglioso di essere diverso.
In un mondo caposotto
(sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli
ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono
l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I
nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è?
Noi siamo animali. Siamo
diversi dalle altre specie solo perché siamo viziosi e ciò ci aguzza l’ingegno.
Al di là delle questioni
soggettive è il sistema giustizia ed i suoi operatori (Ministri, magistrati,
avvocati e personale amministrativo) che minano la credibilità di un servizio
fondamentale di uno Stato di Diritto.
Noi, miseri umani, prima di
parlare o sparlare dei nostri simili, facciamo come dice il nostro amico
Raffaele Sollecito: “Vorrei che gli altri si mettessero al mio posto”. Quindi,
facciamolo! Solo allora si vedrà che la prospettiva di giudizio cambia e di
conseguenza si possono cambiare le cose. Sempre che facciamo in tempo, prima che
noi stessi possiamo diventare oggetto di giudizio. Ricordiamoci che quello che
capita agli altri può capitare a noi, perché gli altri, spesso, siamo proprio
noi. Oggi facciamo ancora in tempo. Basta solo non essere ignavi!»
LOTTA
ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA. DA QUALE PULPITO ARRIVA LA PREDICA, SE LO
STATO E’ IL PRIMO EVASORE IN ITALIA?
«Siamo un paese di truffatori,
o, magari, qualcuno ha interesse a farci passare come tali». Così afferma il dr
Antonio Giangrande, noto saggista di fama mondiale e presidente
dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, sodalizio antimafia riconosciuto dal
Ministero dell’Interno. Associazione fuori dal coro e fuori dai circuiti
foraggiati dai finanziamenti pubblici.
Evasione
fiscale, buco di 52 miliardi nel 2013.
In base alle indagini delle Fiamme Gialle, l'evasione fiscale italiana del
2013 è pari a 51,9 miliardi di euro, scrive Angelo Scarano su “Il Giornale”.
Le evasioni fiscali in Italia sono all'ordine del giorno: niente
scontrino, niente fatture, insomma, niente di niente. È così, oggi lo Stato
italiano ha scoperto che nelle sue casse c'è un buco di 51,9 miliardi di
euro non versati: colpa delle società italiane, che per non incappare nel Fisco
hanno attuato i tanto famosi "trasferimenti di comodo", spostando le proprie
residenze o le basi delle società nei cosiddetti paradisi fiscali
- Cayman, Svizzera, Andorre -. Quanto agli oltre ottomila evasori totali
scoperti, hanno occultato redditi al fisco per 16,1 miliardi, mentre i ricavi
non contabilizzati e i costi non deducibili riferibili ad altri fenomeni evasivi
- dalle frodi carosello ai reati tributari fino alla piccola evasione -
ammontano a 20,7 miliardi, una cifra più che consistente. Il totale dell'IVA
evasa dagli italiani sarebbe di circa 5 miliardi: un dato che non sorprende, se
si considera che secondo una recente ricerca della Guardia di finanza su 400.000
controlli effettuati, il 32% delle attività almeno un paio di volte hanno emesso
uno scontrino falso, o non lo hanno emesso proprio. Per frodi e reati fiscali,
lo scorso anno sono state denunciate 12.726 persone, con 202 arresti. Nei
confronti dei responsabili delle frodi fiscali, i finanzieri hanno avviato
procedure di sequestro di beni mobili, immobili, valuta e conti correnti per 4,6
miliardi di euro. Oltretutto, in Italia sono presenti 14.220 lavoratori
completamente in nero, scoperti nel 2013, e 13.385 irregolari, impiegati da
5.338 datori di lavoro. Con una media di una su tre società che non emette
scontrini, non sorprende come l'evasione sia arrivata a cifre stellari, e come
tendenzialmente è destinata ad aumentare col tempo.
I datori di
lavoro versano i contributi (altrimenti è un reato). Lo stato il primo evasore
fiscale: INPDAP non versa i contributi come fanno le aziende ordinariamente.
Lo Stato è il primo evasore contributivo. Secondo stime
attendibili (ma non ufficiali) il datore di lavoro di oltre 3 milioni di persone
avrebbe mancato di versare circa 30 miliardi di contributi. Risultato? Un buco
enorme nell'Inpdap che poi è stato scaricato sull'Inps con un'operazione di
fusione alquanto discutibile. Non ha versato all'INPDAP i contributi
previdenziali dei suoi dipendenti...
Cresce il
buco nei conti dell'INPS. Nel 2015 lo Stato dovrà sborsare 100 miliardi per
ripianare l'ammanco dell'istituto. Prendendoli da pensionati e contribuenti.
Inps, Mastrapasqua al governo: "Allarme conti". Ma Saccomanni lo
smentisce, scrive Il Fatto Quotidiano. Il presidente dell'istituto scrive ai
ministri Saccomanni e Giovanni: "Valutare un intervento dello Stato per coprire
i deficit dell'ex Inpdap, altrimenti le passività aumenteranno". L'ultimo
bilancio segnava un rosso di quasi 10 miliardi. E a "La Gabbia" su La7 aveva
detto: "Possiamo sopportare solo 3 anni di disavanzo". Angeletti:
"Avvertimento tardivo" e Bonanni chiede di fare chiarezza.
Lo stato
italiano non ha versato per anni i contributi pensionistici ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni e quindi li ha fatti confluire nell’Inps, ponendoli a
carico di coloro che la sventura pose a lavorare nel comparto produttivo.
Forse
che i pensionati italiani non saranno solidali con i poveri dipendenti delle
pubbliche amministrazioni?
Cerchiamo di
raccontare la questione del
presunto buco dell’Inps come se fossimo dei privati e non mamma Stato,
scrive Nicola Porro su “Il Giornale”. La cosa in fondo è semplice. Un paio di
anni fa il governo Monti ha deciso di fondere nella grande Inps, la più piccola
Inpdap. È il fondo previdenziale che si occupa dei 2,8 milioni di pensionati
pubblici. E ovviamente dei prossimi dipendenti statali che andranno in
quiescenza. Il motivo formale era nobile: ridurre di 100 milioni il costo di
queste burocrazie. In fondo, Inps e Inpdap facevano e fanno lo stesso mestiere:
incassano i contributi sociali da lavoratori e datori di lavoro e pagano le
pensioni. Si è rivelato, dobbiamo presumere senza malizia, come un modo di
annacquare un gigantesco buco di bilancio. Se fossimo dei privati sarebbe una
bancarotta, più o meno fraudolenta. E vi spieghiamo perché. L’Inpdap è nato
nel 1994. Prima lo Stato italiano la faceva semplice e male. Non pagava i
contributi per i propri dipendenti pubblici, ritenendola una partita di giro.
Perché accantonare risorse per le future pensioni pubbliche, si saranno detti i
furbetti della Prima repubblica? Paghiamo il dovuto, cioè apriamo la cassa, solo
quando la pensione sarà maturata. Se volete si tratta di una variazione ancora
peggiore rispetto allo schema Ponzi (dal grande truffatore italo americano) del
metodo retributivo. Quando nel 1994 si crea l’ente previdenziale si pone dunque
il problema. Come facciamo? Semplice, da oggi in poi la Pubblica amministrazione
è costretta a pagare anno per anno i suoi contributi, così come tutti i datori
privati lo fanno ogni mese con l’Inps, al suo fondo di riferimento: l’Inpdap,
appunto. Il sistema diventa così corretto e identico a quello di un’azienda
privata: il costo del personale pubblico, in questo modo, diventa fedele alla
realtà e pari (anche in termini di cassa) a stipendio netto, più tasse e
contributi sociali. Ma restava un problema. Cosa fare con i contributi che si
sarebbero dovuti versare nel passato? La genialata se la inventa il governo
Prodi nel 2006 insieme al ministro del lavoro Damiano. All’Inpdap
(semplifichiamo per farci capire) lo Stato avrebbe dovuto dare più di 8 miliardi
di euro di contributi non versati, ma maturati dai dipendenti pubblici. Una
bella botta. E anche all’epoca avevamo bisogno di fare i fighetti con l’Europa.
Per farla breve, lo Stato non ha trasferito gli 8 miliardi all’Inpdap, ma ha
fatto come lo struzzo: ha anticipato volta per volta ciò che serviva per pagare
i conti. Di modo che alla fine dell’anno i saldi con l’Europa quadrassero. I
nodi vengono al pettine quando Monti decide di fondere l’Inps con l’Inpdap.
Antonio Mastrapasqua, che è il super boss delle pensioni private, sa fare bene i
suoi conti. E appena si accorge che gli hanno mollato il pacco inizia a tremare.
Un imprenditore privato che omettesse di versare i contributi per i propri
dipendenti, pur assumendosi l’impegno di pagare la pensione quando maturasse,
verrebbe trasferito in un secondo a Regina Coeli o a San Vittore. In più, il
medesimo imprenditore privato non dovendo versare ogni anno i contributi
all’Inps, potrebbe fare il fenomeno con le banche o la Borsa, dicendo di avere
molta più cassa di quanto avrebbe se dovesse andare a versare ogni mese il
dovuto. Un mega falso in bilancio da 8 miliardi, questo è ciò che plasticamente
è emerso fondendo l’Inpdap nell’Inps. Mastrapasqua resta un servitore dello
Stato e, secondo il cuoco, non lo ammetterebbe neanche a sua nonna, ma la
fusione dei due enti ha in buona parte compromesso molti degli sforzi fatti per
mettere ordine nel suo carrozzone (che tale in buona parte purtroppo resta). Si
è dovuto sobbarcare un’azienda fallita e non può prendersela più di tanto con il
suo principale creditore: che si chiama Stato Italiano. La morale è sempre
quella. Mentre i privati chiudono, falliscono, si disperano per pagare tasse
e contributi sociali, lo Stato centrale se ne fotte. Come diceva il marchese
del Grillo: «Io so io e voi nun siete un cazzo.»
C'è soltanto
una categoria professionale che invece sta versando molti più contributi di
quanto riceve in termini di assegni pensionistici,
scrive Andrea Telara su “Panorama”. Si tratta degli iscritti alla Gestione
Separata, cioè quel particolare fondo dell'Inps in cui confluiscono i versamenti
previdenziali dei lavoratori precari (come i collaboratori a progetto) e dei
liberi professionisti con la partita iva, non iscritti agli Ordini. Nel 2013, il
bilancio della Gestione Separata sarà in attivo per oltre 8 miliardi di euro. Va
detto che questo risultato ha una ragion d'essere ben precisa: tra i precari
italiani e tra le partite iva senza Ordine, ci sono infatti molti giovani ancora
in attività, mentre i pensionati di questa categoria sono pochissimi (il
rapporto è di 1 a 6). Non si può tuttavia negare che, se non ci fossero i
contributi della Gestione Separata, il bilancio dell'Inps sarebbe in una
situazione ancor peggiore di quella odierna. In altre parole, oggi ci sono in
Italia quasi 2 milioni di lavoratori precari e di partite iva che tengono in
piedi i conti dell'intero sistema previdenziale e che pagano una montagna di
soldi per mantenere le pensioni di altre categorie, compresi gli assegni d'oro
incassati da qualche ex-dirigente d'azienda. tema dei «contributi pensionistici
silenti», che vengono versati dai lavoratori precari, parasubordinati e libero
professionisti privi di un ordine di categoria, alla gestione separata
dell’Inps. Contributi che però non si trasformano in trattamenti previdenziali,
poiché quei cittadini non riescono a maturare i requisiti minimi per la
pensione: e che restano nelle casse dell’ente pubblico per pagare quelle degli
altri. È un assetto che penalizza proprio i giovani e i precari, che con
maggiore difficoltà raggiungono i 35 anni di anzianità, visto che nel mercato
legale del lavoro si entra sempre più tardi e in modo intermittente. Anche
quando si matura il minimo di contribuzione richiesto, la pensione non supera i
400-500 euro. Ad aggravare la condizione di questa fascia di popolazione è anche
l’elevata aliquota dei versamenti, quasi il 27 per cento della retribuzione: una
quota che per la verità fu stabilita nel 2006 dal governo di Romano Prodi su
pressione dei sindacati. Peraltro il problema non tocca esclusivamente i
lavoratori trentenni, sottoposti al regime contributivo, ma anche i più anziani,
soggetti a quello retributivo, che richiede almeno vent’anni di attività per
maturare la pensione.
L’ITALIA, IL PAESE DEI NO.
LA SINDROME DI NIMBY.
Vengo anch'io. No, tu no (1967
- Fo, Jannacci)
Inserita nell'album omonimo
(che contiene una schidionata di brani indimenticabili: si va da "Giovanni,
telegrafista" a "Pedro, Pedreiro", da "Ho visto un re" a "Hai pensato mai",
quest'ultima versione in lingua della stupenda "Gastu mai pensà" di Lino
Toffolo), "Vengo anch'io. No, tu no" (1967) porta Enzo Jannacci in cima alle
classifiche di vendite, con esiti commerciali mai più ripetuti nel corso della
sua lunga carriera. Assai accattivante nell'arrangiamento, attraversato da
elementi circensi, la canzone divenne una sorta di inno di tutti gli esclusi
d'Italia dai grandi rivolgimenti in atto - siamo, ricordiamolo, nel '68 - perchè
snobbati dall'intellighenzia dell'epoca. Grazie a versi beffardi e surreali,
scritti da Jannacci in sostituzione di quelli originariamente vergati perlopiù
da Dario Fo e maggiormente ancorati al reale, il brano s'imprime nella memoria
collettiva, diviene una sorta di tormentone nazionale, contribuisce in larga
misura a far conoscere ad un pubblico più vasto la figura di un artista
inclassificabile quanto geniale.
Si potrebbe andare tutti
quanti allo zoo comunale
Vengo anch'io? No tu no
Per vedere come stanno le
bestie feroci
e gridare "Aiuto aiuto e`
scappato il leone"
e vedere di nascosto l'effetto
che fa
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Ma perché? Perché no
Si potrebbe andare tutti
quanti ora che è primavera
Vengo anch'io? No tu no
Con la bella sottobraccio a
parlare d'amore
e scoprire che va sempre a
finire che piove
e vedere di nascosto l'effetto
che fa
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Ma perché? Perché no
Si potrebbe poi sperare tutti
in un mondo migliore
Vengo anch'io? No tu no
Dove ognuno sia già pronto a
tagliarti una mano
un bel mondo sol con l'odio ma
senza l'amore
e vedere di nascosto l'effetto
che fa
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Ma perché? Perché no
Si potrebbe andare tutti
quanti al tuo funerale
Vengo anch'io? No tu no
per vedere se la gente poi
piange davvero
e scoprire che è per tutti una
cosa normale
e vedere di nascosto l'effetto
che fa
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Ma perché? Perché no
No, no e 354 volte no. La
sindrome Nimby (Not in my back yard, "non nel mio cortile") va ben oltre
il significato originario.
Non solo contestazioni di comitati che non vogliono nei dintorni di casa
infrastrutture o insediamenti industriali: 354, appunto, bloccati solo nel 2012
(fonte Nimby Forum). Ormai siamo in piena emergenza Nimto – Not in my term of
office, "non nel mio mandato" – e cioè quel fenomeno che svela l’inazione
dei decisori pubblici. Nel Paese dei mille feudi è facile rinviare decisioni e
scansare responsabilità. La protesta è un’arte, e gli italiani ne sono
indiscussi maestri. Ecco quindi pareri "non vincolanti" di regioni, province e
comuni diventare veri e propri niet, scrive Alessandro Beulcke su “Panorama”.
Ministeri e governo, in un devastante regime di subalternità perenne, piegano
il capo ai masanielli locali. Tempi decisionali lunghi, scelte rimandate e
burocrazie infinite. Risultato: le multinazionali si tengono alla larga, le
grandi imprese italiane ci pensano due volte prima di aprire uno stabilimento.
Ammonterebbe così a 40 miliardi di euro il "costo del non fare" secondo le
stime di Agici-Bocconi. E di questi tempi, non permettere l’iniezione di
capitali e lavoro nel Paese è una vera follia.
NO TAV, NO dal Molin, NO al
nucleare, NO all’ingresso dei privati nella gestione dell’acqua: negli ultimi
tempi l’Italia è diventata una Repubblica fondata sul NO?
A quanto pare la paura del cambiamento attanaglia una certa parte dell’opinione
pubblica, che costituisce al contempo bacino elettorale nonché cassa di
risonanza mediatica per politici o aspiranti tali (ogni riferimento è puramente
casuale). Ciò che colpisce è la pervicacia con la quale, di volta in volta, una
parte o l’altra del nostro Paese si barrica dietro steccati culturali,
rifiutando tutto ciò che al di fuori dei nostri confini è prassi comune. Le
battaglie tra forze dell’ordine e manifestanti NO TAV non si sono verificate né
in Francia né nel resto d’Europa, nonostante il progetto preveda
l’attraversamento del continente da Lisbona fino a Kiev: è possibile che solo in
Val di Susa si pensi che i benefici dell’alta velocità non siano tali da
compensare l’inevitabile impatto ambientale ed i costi da sostenere? E’
plausibile che sia una convinzione tutta italica quella che vede i treni ad alta
velocità dedicati al traffico commerciale non rappresentare il futuro ma, anzi,
che questi siano andando incontro a un rapido processo di obsolescenza? Certo,
dire sempre NO e lasciare tutto immutato rappresenta una garanzia di
sicurezza,soprattutto per chi continua a beneficiare di rendite di posizione
politica, ma l’Italia ha bisogno di cambiamenti decisi per diventare finalmente
protagonista dell’Europa del futuro. NO?
Il Paese dei "No" a
prescindere. Quando rispettare le regole è (quasi) inutile.
In Italia non basta rispettare
le regole per riuscire ad investire nelle grandi infrastrutture. Perché le
regole non sono una garanzia in un Paese dove ogni decisione è messa in
discussione dai mal di pancia fragili e umorali della piazza. E di chi la
strumentalizza, scrive l’imprenditore Massimiliano Boi. Il fenomeno, ben noto,
si chiama “Nimby”, iniziali dell’inglese Not In My Backyard (non nel mio
cortile), ossia la protesta contro opere di interesse pubblico che si teme
possano avere effetti negativi sul territorio in cui vengono costruite. I veti
locali e l’immobilismo decisionale ostacolano progetti strategici e sono il
primo nemico per lo sviluppo dell’Italia. Le contestazioni promosse dai
cittadini sono “cavalcate” (con perfetta par condicio) dalle opposizioni e dagli
stessi amministratori locali, impegnati a contenere ogni eventuale perdita di
consenso e ad allontanare nel tempo qualsiasi decisione degna di tale nome.
Dimenticandosi che prendere le decisioni è il motivo per il quale, in
definitiva, sono stati eletti. L’Osservatorio del Nimby Forum (nimbyforum.it) ha
verificato che dopo i movimenti dei cittadini (40,7%) i maggiori contestatori
sono gli amministratori pubblici in carica (31,4%) che sopravanzano di oltre 15
punti i rappresentanti delle opposizioni. Il sito nimbyforum.it, progetto di
ricerca sul fenomeno delle contestazioni territoriali ambientali gestito
dall'associazione no profit Aris, rileva alla settima edizione del progetto che
in Italia ci sono 331 le infrastrutture e impianti oggetto di contestazioni (e
quindi bloccati). La fotografia che emerge è quella di un paese vecchio,
conservatore, refrattario ad ogni cambiamento. Che non attrae investimenti
perché è ideologicamente contrario al rischio d’impresa. Il risultato, sotto gli
occhi di tutti, è la tendenza allo stallo. Quella che i sociologi definiscono
“la tirannia dello status quo”, cioè dello stato di fatto, quasi sempre
insoddisfacente e non preferito da nessuno. A forza di "no" a prescindere, veti
politici e pesanti overdosi di burocrazia siamo riusciti (senza grandi sforzi) a
far scappare anche le imprese straniere. La statistica è piuttosto deprimente:
gli investimenti internazionali nella penisola valgono 337 miliardi, la metà di
quelli fatti in Spagna e solo l’1,4% del pil, un terzo in meno di Francia e
Germania. Un caso per tutti, raccontato da Ernesto Galli Della Loggia. L’ex
magistrato Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, città assurta come zimbello
mondiale della mala gestione dei rifiuti, si è insediato come politico “nuovo”,
“diverso”, “portatore della rivoluzione”. Poi, dicendo “no” ai
termovalorizzatori per puntare solo sulla raccolta differenziata, al molo 44
Area Est del porto partenopeo, ha benedetto l’imbarco di 3 mila tonn di
immondizia cittadina sulla nave olandese “Nordstern” che, al prezzo di 112 euro
per tonn, porterà i rifiuti napoletani nel termovalorizzatore di Rotterdam. Dove
saranno bruciati e trasformati in energia termica ed elettrica, a vantaggio
delle sagge collettività locali che il termovalorizzatore hanno voluto. Ma senza
andare lontano De Magistris avrebbe potuto pensare al termovalorizzatore di
Brescia, dove pare che gli abitanti non abbiano l’anello al naso. Scrive Galli
Della Loggia: “Troppo spesso questo è anche il modo in cui, da tempo, una
certa ideologia verde cavalca demagogicamente paure e utopie, senza
offrire alcuna alternativa reale, ma facendosi bella nel proporre soluzioni che
non sono tali”.
«C’è un disegno, che lacera,
scoraggia e divide e quindi è demoniaco, al quale non dobbiamo cedere nonostante
esempi e condotte disoneste, che approfittano del denaro, del potere, della
fiducia della gente, perfino della debolezza e delle paure. E’ quello di
dipingere il nostro Paese come una palude fangosa dove tutto è insidia,
sospetto, raggiro e corruzione. - Aprendo i lavori del parlamentino dei vescovi
italiani del 27-30 gennaio 2014 , il presidente della Cei, Angelo Bagnasco,
rassicura sulla tenuta morale del paese e chiede a tutti – di reagire ad una
visione esasperata e interessata che vorrebbe accrescere lo smarrimento generale
e spingerci a non fidarci più di nessuno. L’Italia non è così - afferma il
cardinale - nulla – scandisce – deve rubarci la speranza nelle nostre forze se
le mettiamo insieme con sincerità. Come Pastori – rileva il porporato – non
possiamo esimerci dal dire una parola sul contesto sociale che viviamo,
consapevoli di dover dare voce a tanti che non hanno voce e volto, ma che sono
il tessuto connettivo del Paese con il loro lavoro, la dedizione, l’onestà.»
L’ITALIA DEI COLPI DI
STATO.
Letta, Renzi e tutti i governi
"non eletti". La "staffetta" non è certo una novità della politica italiana, tra
ribaltoni e svolte di ogni tipo (che durano meno di un anno), scrive Sabino
Labia su “Panorama”. E sono
tre. Stiamo parlando del terzo governo, in tre anni o poco più, non eletto dal
popolo ma creato, senza arte ne parte, nella segreteria di un partito con
l’avallo autorevole del Quirinale. Già, perché con la nascita del governo Renzi
(il sessantesimo della storia Repubblicana) che, a suo dire, mai sarebbe andato
a Palazzo Chigi senza passare dalle urne, ma passando solo dalla sede del Pd,
sembra di aver fatto l’ennesimo tuffo nel passato. E pensare che ci eravamo
convinti che questo tipo di operazione appartenesse a una di quelle mitiche
alchimie politiche che tanto deliziavano i partiti della Prima Repubblica,
quando i governi non nascevano dalle consultazioni elettorali, ma nella
segreteria della DC. E, invece, la Seconda Repubblica e, con ogni probabilità
visti i presupposti, anche la Terza Repubblica si avvarrà della facoltà di
stabilire l’inquilino di Palazzo Chigi sulla fiducia non dei cittadini ma dei
nominati e, per non farci mancare nulla, anche dei non nominati visto che Renzi
è soltanto il sindaco di Firenze. In fondo siamo passati da Piazza del Gesù a
via del Nazareno. Elencare tutte quelle volte che, dal 1948 a oggi, si è
stabilita la fine di un esecutivo, non basterebbe un libro. Per citarne solo
alcuni:
- Governo Letta
(2013) composto da un'ammucchiata di centro destra e centro sinistra, nato dopo
lo sciagurato tentativo di Bersani di coinvolgere l’universo mondo.
- Governo Monti
(2011), nato dopo il Friedman-gate dello spread che inseguiva Berlusconi.
- Governo
D’Alema (1998), nato dopo il boicottaggio/sabotaggio al primo governo Prodi.
- Governo Dini
(1995), nato dopo il ribaltone della Lega, alleata di Berlusconi.
- Governo Ciampi
(1993), dopo il sacco dei conti correnti del governo D’Amato.
- Governo De
Mita (1988), nato come la vera e unica staffetta, quella con il governo Craxi.
- Governi
Rumor/Colombo (1970), Tra l’agosto del 1969 e l’agosto 1970 si ebbe il record di
crisi e governi, ben quattro. Ma quelli erano anni veramente difficili.
- Governo
Tambroni (1960), nato dopo la decisione presa all’interno della segreteria della
Dc di far cadere il governo Segni.
E, proprio in
questa occasione, il 25 febbraio 1960 il presidente del Senato, Cesare
Merzagora, pronunciò a Palazzo Madama un durissimo discorso contro il Parlamento
attaccando i partiti che sostenevano la maggioranza che, nel chiuso delle
segreterie, avevano stabilito di far cadere il secondo Governo presieduto da
Antonio Segni sostituendolo con un esecutivo guidato da Tambroni. Per di più,
Segni, aveva deciso di dimettersi senza fare alcun passaggio dalle Camere.
“Se i partiti politici, all’interno dei loro organi statutari, dovessero
prendere le decisioni più gravi sottraendole ai rappresentanti del popolo, tanto
varrebbe - lo dico, naturalmente, per assurdo – trasformare il Parlamento in un
ristretto comitato esecutivo. Risparmieremmo tempo e denaro…". Se poi
vogliamo aggiungere un po’ di statistica abbinata alla scaramanzia, che come si
sa in Italia non guasta mai, ebbene tutti questi governi non hanno mai avuto una
durata superiore a un anno. Prepariamoci ad aggiornare il pallottoliere.
Il Colpo di
Stato continua: Renzi sarà il 27mo premier non eletto dal Popolo, scrive
Giovanni De Mizio su “Ibtimes”. Mentre continua la sfilata di volti noti e meno
noti della politica italiana nel palazzo del Quirinale per le consultazioni del
presidente della (ancora per poco) Repubblica Giorgio "Primo" Napolitano e
mentre Matteo Renzi, primo ministro in pectore, si riscalda a bordo campo
facendo stretching in Piazza della Signoria a Firenze prima di recarsi (a piedi)
a Roma, la politica al di fuori del Palazzo continua a rimarcare che il futuro
ex-sindaco di Firenze sarà il terzo premier di seguito a non essere stato eletto
dal popolo, e come tale privo di legittimazione democratica. Si tratta di un
argomento, tuttavia, errato: Renzi non sarà il terzo, bensì il ventisettesimo
premier scelto senza mandato popolare a legittimarlo. È un colpo di stato,
senza dubbio alcuno, e, a giudicare dalla storia d'Italia del dopoguerra, si
tratta di un colpo di stato che parte da lontano, con il chiaro intento di
rovesciare la Repubblica per restaurare la Monarchia così come era prima dello
Statuto Albertino, possibilmente completando lo svuotamento del Parlamento in
atto già da diversi anni. Ne è la prova, fra le altre cose, la volontà di
Renzi di mutare il Senato in una camera a parziale nomina regia, pardon,
presidenziale. Il colpo di stato attualmente in atto nasce probabilmente a
metà degli anni Cinquanta quando, nel corso della Seconda legislatura, si
successero ben sei presidenti del Consiglio: De Gasperi, Pella, Fanfani, Scelba,
Segni e Zoli. Curiosità: le elezioni si tennero in base alla legge elettorale
"truffa" del 1953, che la Corte Costituzionale avrebbe potuto censurare (oppure
no), se solo fosse stata istituita (sarebbe "nata" solo nel 1956). Tralasciando
De Gasperi (che fallì nell'ottenere la fiducia a causa delle forze monarchiche,
carbonare e amatriciane), il primo premier della seconda legislatura,
Giuseppe Pella, è dichiaratamente un presidente tecnico, come lo è stato Mario
Monti (entrambi, tra l'altro, sono stati ministri degli Esteri e del
Bilancio ad interim, a confermare che il complotto, come la Storia, si ripete),
e la sua squadra di governo era formata da numerosi ministri altrettanto
tecnici. Siamo nel 1953 e Pella ha più o meno la stessa età che avrebbe avuto
Monti anni più tardi: dubitiamo sia una coincidenza. Nel gennaio 1954 è
Amintore Fanfani ad essere incaricato di formare un governo: anche Fanfani
non aveva vinto le elezioni, neppure le primarie del proprio partito, visto che
sarebbe stato eletto segretario della DC solo nel giugno successivo (peraltro da
un congresso, e non attraverso regolari, libere e democratiche elezioni). Il
tentativo delle forze reazionarie, comunque, non va a buon fine, poiché Fanfani
non riesce a ottenere la fiducia. Un brutto presagio per il governo Renzi? Lo
sapremo nei prossimi giorni. Ciò che avvenne dopo è ancora più disarmante: Mario
Scelba riuscì poi a formare un governo, ma fu sostituito da Mario Segni quando
fu eletto presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, grazie ai voti,
guarda caso, dei monarchici. La Storia si ripeterà, abbastanza simile, anche
in seguito, con il governo Tambroni. Ma gli esempi sono tanti anche nella storia
successiva: le staffette e la nomina di presidenti del Consiglio che non
hanno vinto le elezioni sono state a lungo una regola della Repubblica italiana,
a testimonianza del fatto che si tratta di un tentativo ultradecennale di
spogliare il popolo dei suoi diritti; basti pensare al fatto che in Italia vi
sono stati 62 governi in 18 legislature (una media di 3,44 governi a
legislatura), presieduti da 26 presidenti del consiglio (2,39 governi per
premier). Solo due presidenti del Consiglio sono rimasti in carica (in più
governi) dalle elezioni fino alla scadenza naturale della legislatura: De
Gasperi e
Berlusconi. Ciò dimostra non certo che il ricambio
degli inquilini di palazzo Chigi è fisiologico data la natura del sistema
politico italiano nonché il dettato costituzionale (sempre formalmente
rispettato), bensì che il complotto per il ripristino della Monarchia in
Italia ha più forza di quanto si pensi. Da dove nasce l'equivoco? Nasce dal
fatto che, secondo la Costituzione, il presidente del Consiglio è nominato dal
presidente della Repubblica e deve avere la fiducia delle Camere. Il popolo
elegge il Parlamento ed è questi che decide se una persona può essere o meno il
presidente del Consiglio, e può anche togliergli la fiducia per darla a un'altra
persona, sempre nominata dal Capo dello Stato. I Padri Costituenti hanno
insomma tolto al popolo il diritto di eleggere il proprio presidente del
Consiglio sin dalla nascita della Repubblica: a ben guardare, insomma, la
Repubblica italiana ha avuto ventisei presidenti del Consiglio (su ventisei) non
eletti dal popolo, e Renzi, pertanto, si avvia ad essere non il terzo, bensì il
ventisettesimo perpetuatore di questa ignobile tradizione che ormai da oltre
sessant'anni infanga l'articolo 1 della Costituzione, secondo la quale, al
secondo comma, la sovranità appartiene al Popolo, che viene sottratta ad ogni
legislatura. Il complotto, insomma, continua. Nota per chi non se ne
fosse accorto. Il presente articolo ha un chiaro intento satirico:
l'articolo 1 della Costituzione prevede che la sovranità popolare sia esercitata
nelle forme e nei limiti della Costituzione stessa. La carta fondamentale
prevede che il presidente del Consiglio non abbia legittimazione popolare (non è
eletto dal popolo), poiché l'Italia è una Repubblica parlamentare, ovvero il
popolo è sovrano attraverso il Parlamento e non attraverso altri organi, men che
meno monocratici. Asserire una presunta incostituzionalità (o peggio) delle
nomine di Monti, Letta e (eventualmente) Renzi significa ignorare la storia
d'Italia, la sua Costituzione e spingere (ulteriormente) verso un pericoloso
presidenzialismo populista privo di un adeguato sistema di pesi e contrappesi
che eviti derive ancora peggiori di quelle che l'Italia sta sperimentando da una
trentina di anni, ovvero più o meno da quando il declino del Belpaese ha
impiantato i propri semi nella penisola. Con questo non vogliamo dire che il
presidenzialismo sia un male, ma solo che è necessario modificare l'equilibrio
costituzionale per evitare gravi storture e menomazioni della democrazia
italiana (come avvenute, per altre ragioni, negli ultimi decenni di
quasi-presidenzialismo de facto). In sintesi. Un presidente del Consiglio (nella
pienezza dei propri poteri) è tale se, e solo fin quando, ha la fiducia di una
maggioranza parlamentare: solo per rifarsi alla storia recente,
Berlusconi
è caduto nel novembre 2011 perché ad ottobre, benché non sfiduciato, non aveva
più una maggioranza in Parlamento, tanto che il rendiconto dello Stato fu
approvato solo grazie all'assenza delle opposizioni; stesso discorso per Monti,
che ha perso la fiducia dopo l'uscita dalla maggioranza del PDL, e per Letta,
che ha perso l'appoggio del suo stesso partito, il PD. Queste situazioni sono
state una costante nella storia italiana, se si considera che la prima crisi di
governo scoppiata in Parlamento risale al primo governo Prodi: in tutti gli
altri casi (tranne il Prodi II) la crisi si è sempre consumata fuori dal
Parlamento. Allo stesso modo è stata rispettata la Costituzione nella formazione
dei governi che si sono via via succeduti negli anni. La staffetta può non
piacere, ma ciò che sta accadendo in queste ore è la regola, non l'eccezione, e
che soprattutto si sta rispettando il dettato democratico espresso dalla
Costituzione che tanti difensori all'amatriciana della Carta stessa continuano a
dimenticare (così come non viola la Costituzione il non presentarsi alle
consultazioni del Capo dello Stato). E provoca un senso di vergogna essere
costretti a ripetere l'ovvio per via di una diffusa ignoranza delle regole
costituzionali anche da chi dovrebbe conoscerle a memoria viste le poltrone su
cui sono seduti. L'ignoranza è forza, pare.
Sono giorni che su Internet e
nel Paese reale, il popolo protesta perché Renzi andrà a Palazzo Chigi senza
elezioni, scrive Fabio Brinchi Giusti su “L’Inkiesta”. “Ma il premier non
dovremmo eleggerli noi?” Si domanda la gente mormorando rabbiosa contro la
democrazia scippata. A volte non sono solo le persone comuni, a volte si
uniscono al coro anche coloro che dovrebbero aiutarli a capire come giornalisti
e politici. “No ai premier nominati” “Il popolo deve scegliere” e magari per
gettare benzina sul fuoco, si urla anche al golpe. Il guaio che è spesso le voci
che urlano contro i governi non-eletti sono le stesse che poi urlano “Giù le
mani dalla Costituzione” e “La Costituzione non si tocca”. Ma per difenderla la
Costituzione prima andrebbe perlomeno letta. E capirla. Perché è la Costituzione
ad aver dato all’Italia un sistema dove il Presidente del Consiglio non viene
eletto dal popolo. Il popolo elegge il Parlamento e vota i partiti. Dopo le
elezioni i partiti eletti vanno dal Presidente della Repubblica e il Presidente
della Repubblica sulla base delle indicazioni ricevute nomina il Presidente del
Consiglio. Se quest’ultimo perde il consenso della maggioranza dei parlamentari
cade e il gioco di cui sopra si ripete. I partiti vanno dal Capo dello Stato e
il Capo dello Stato cerca un nuovo nome (oppure lo stesso se quest’ultimo è in
grado di riunire di nuovo una maggioranza). Se non si trova un nome si va ad
elezioni anticipate. In tutto questo sistema il popolo non ha voce in capitolo.
O meglio lo ha indirettamente tramite i suoi rappresentanti, ma non attraverso
votazioni! È così dal 1948, anzi è così da sempre perché a livello nazionale il
nostro Paese non ha mai conosciuto l’elezione diretta del capo del Governo. A
partire dagli anni ’90 una serie di riforme ha introdotto l’elezione diretta dei
sindaci o poi dei leader degli enti locali e il passaggio alla legge elettorale
maggioritaria (il cosiddetto Mattarellum poi abolito nel 2005) ha favorito
questa tendenza anche a livello nazionale dove le coalizioni di centrodestra e
centrosinistra si sono sempre presentate agli elettori guidate da un
leader-candidato che in caso di vittoria è poi andato a Palazzo Chigi. Ma non
essendo cambiata la Costituzione, di fatto, la scelta del Presidente del
Consiglio è rimasto un potere nelle mani del Parlamento e del Presidente della
Repubblica. E gli elettori sulla scheda elettorale hanno continuato a sbarrare
il simbolo di un partito e non il nome di una persona. I governi in Italia si
formano così e dunque è perfettamente costituzionale e legittimo la nascita di
un governo non votato dagli elettori. Lo è anche se si regge su una maggioranza
completamente modificata da cambi di casacca e voltagabbana vari. Se non vi
piace questo sistema, pensateci la prossima volta che urlate: “La Costituzione
non si cambia!”.
PER LA TUTELA DEI DIRITTI
DEGLI INDIGENTI. PRO BONO PUBLICO OBBLIGATORIO.
«Non è possibile che nel 2014
gli indigenti muoiano per i denti o sono detenuti pur innocenti. Se i comunisti
da 70 anni non lo hanno ancora fatto, propongo io la panacea di questi mali.»
Così afferma il dr Antonio
Giangrande, noto saggista di fama mondiale e presidente dell’Associazione Contro
Tutte le Mafie, sodalizio antimafia riconosciuto dal Ministero dell’Interno.
Associazione fuori dal coro e fuori dai circuiti foraggiati dai finanziamenti
pubblici.
«Al fine di rendere effettivo
l’accesso ai servizi sanitari e legali a tutti gli indigenti, senza troppi oneri
per le categorie professionali interessate, presento ai parlamentari, degni di
questo incarico, questa mia proposta di legge:
PER LA TUTELA DEI DIRITTI
DEGLI INDIGENTI
PRO BONO PUBLICO OBBLIGATORIO
“Per tutelare i diritti dei
non abbienti si obbliga, a mo' di PRO BONO PUBLICO, gli esercenti un servizio di
pubblica necessità, ai sensi dell'art.359 c.p., a destinare il 20 % della loro
attività o volume di affari al servizio gratuito a favore degli indigenti.
E' indigente chi percepisce un
reddito netto mensile non maggiore di 1.000 euro, rivalutato annualmente in base
all’inflazione.
L'onere ricade sulla
collettività, quindi, ai fini fiscali e contributivi, ogni attività pro bono
publico, contabilizzata con il minimo della tariffa professionale, è dedotta dal
reddito complessivo.
Le attività professionali
svolte in favore degli indigenti sono esentati da ogni tributo o tassa o
contributo.
Sono abrogate le disposizioni
di legge o di regolamenti incompatibili con la presente legge.”
NON VI REGGO PIU’.
Il testo più esplicito e
diretto di Rino dà il titolo all'album uscito nel 1978.
"Nuntereggaepiù" è un
brillante catalogo dei personaggi che invadono radio, televisioni e giornali.
Clamorosa la coincidenza con quello che succederà nel 1981, quando la
magistratura scopre la lista degli affiliati alla P2 di Licio Gelli, loggia
massonica in cui compaiono alcuni nomi citati nella filastrocca di Rino.
A dispetto del titolo, nel
brano non c'è un briciolo di reggae. Il titolo gioca sull'assonanza fra il
genere musicale giamaicano e la coniugazione romanesca del verbo reggere. Come
già era accaduto in "Mio fratello è figlio unico", il finale è dissonante
rispetto al tema trattato, con l'introduzione di una frase d'amore:
" E allora amore mio ti amo
Che bella sei
Vali per sei
Ci giurerei. "
È uno sfottò come un altro per
dire: "Vabbè, visto che vi ho detto tutte 'ste cose, visto che tanto la canzone
non fa testo politico, la canzone non è un comizio, il cantautore non è
Berlinguer né Pannella, allora a questo punto hanno ragione quelli che fanno
solo canzoni d'amore..". Possiamo immaginare che, oggi, sarebbero entrati di
diritto nella filastrocca Umberto Bossi o Antonio Di Pietro per la politica,
Fabio Fazio e Maria De Filippi o il Grande Fratello per la tivvù, calciatori
super pagati come Totti, Vieri e Del Piero e chissà quante altre invadenti
presenze del nostro quotidiano destinate a ronzarci intorno per altri vent'anni.
Quando incide la versione spagnola, che in ottobre scala le classifiche
spagnole, "Corta el rollo ya" ("Dacci un taglio”), inserisce personaggi di
spicco dell'attualità iberica, come il politico Santiago Carrillo, il calciatore
Pirri (che più avanti sarà vittima di un rapimento), la soubrette Susana Estrada
e altri.
Qui sta la grandezza di Rino Gaetano, se leggete oggi il testo di "Nun te reggae
più" vi accorgerete che i personaggi citati sono quasi tutti ancora sulla
breccia e, se scomparsi o ritirati dalla vita pubblica, hanno lasciato un segno
indelebile nel loro campo, si pensi a Gianni Brera o all'avvocato Agnelli, o a
Enzo Bearzot che, un anno dopo la dipartita del cantautore calabrese, regalerà
con la sua nazionale (Causio, Tardelli, Antognoni) il terzo mondiale di calcio
dopo quarantaquattro anni.
Abbasso e Alè (nun te reggae
più)
Abbasso e Alè (nun te reggae
più)
Abbasso e Alè con le canzoni
senza patria o soluzioni
La castità (Nun te reggae più)
La verginità (Nun te reggae
più)
La sposa in bianco, il maschio
forte,
i ministri puliti, i buffoni
di corte
..Ladri di polli
Super-pensioni (Nun te reggae
più)
Ladri di stato e stupratori
il grasso ventre dei
commendatori,
diete politicizzate,
Evasori legalizzati, (Nun te
reggae più)
Auto blu, sangue blu,
cieli blu, amori blu,
Rock & blues (Nun te reggae
più!)
Eja-eja alalà, (Nun te reggae
più)
DC-PSI (Nun te reggae più)
DC-PCI (Nun te reggae più)
PCI-PSI, PLI-PRI
DC-PCI, DC DC DC DC
Cazzaniga, (nun te reggae più)
avvocato Agnelli,
Umberto Agnelli,
Susanna Agnelli, Monti
Pirelli,
dribbla Causio che passa a
Tardelli
Musiello, Antognoni,
Zaccarelli.. (nun te reggae più)
..Gianni Brera,
Bearzot, (nun te reggae più)
Monzon, Panatta, Rivera,
D'Ambrosio
Lauda, Thoeni, Maurizio
Costanzo, Mike Bongiorno,
Villaggio, Raffà e Guccini..
Onorevole eccellenza
Cavaliere senatore
nobildonna, eminenza
monsignore, vossia
cheri, mon amour!.. (Nun te
reggae più!)
Immunità parlamentare (Nun te
reggae più!)
abbasso e alè!
Il numero cinque sta in
panchina
si e' alzato male stamattina
– mi sia consentito dire: (nun
te reggae più!)
Il nostro è un partito serio..
(certo!)
disponibile al confronto
(..d'accordo)
nella misura in cui
alternativo
alieno a ogni compromess..
Ahi lo stress
Freud e il sess
è tutto un cess
si sarà la ress
Se quest'estate andremo al
mare
soli soldi e tanto amore
e vivremo nel terrore
che ci rubino l'argenteria
è più prosa che poesia...
Dove sei tu? Non m'ami più?
Dove sei tu? Io voglio, tu
Soltanto tu, dove sei tu? (Nun
te reggae più!)
Uè paisà (..Nun te reggae più)
il bricolage,
il '15-18, il prosciutto
cotto,
il '48, il '68, le P38
sulla spiaggia di Capo Cotta
(Cardin Cartier Gucci)
Portobello, illusioni,
lotteria, trecento milioni,
mentre il popolo si gratta,
a dama c'è chi fa la patta
a sette e mezzo c'ho la
matta..
mentre vedo tanta gente
che non ha l'acqua corrente
e nun c'ha niente
ma chi me sente? ma chi me
sente?
E allora amore mio ti amo
che bella sei
vali per sei
ci giurerei
ma è meglio lei
che bella sei
che bella lei
vale per sei
ci giurerei
sei meglio tu
nun te reg più
che bella si
che bella no
nun te reg più!
NUN TE REGGAE PIÙ, NUN TE
REGGAE PIÙ, NUN TE REGGAE PIÙ...
LA LIBERTA' Giorgio Gaber
(1972)
Vorrei essere libero, libero
come un uomo.
Vorrei essere libero come un
uomo.
Come un uomo appena nato che
ha di fronte solamente la natura
e cammina dentro un bosco con
la gioia di inseguire un’avventura,
sempre libero e vitale, fa
l’amore come fosse un animale,
incosciente come un uomo
compiaciuto della propria libertà.
La libertà non è star sopra un
albero,
non è neanche il volo di un
moscone,
la libertà non è uno spazio
libero,
libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero
come un uomo.
Come un uomo che ha bisogno di
spaziare con la propria fantasia
e che trova questo spazio
solamente nella sua democrazia,
che ha il diritto di votare e
che passa la sua vita a delegare
e nel farsi comandare ha
trovato la sua nuova libertà.
La libertà non è star sopra un
albero,
non è neanche avere
un’opinione,
la libertà non è uno spazio
libero,
libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un
albero,
non è neanche il volo di un
moscone,
la libertà non è uno spazio
libero,
libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero
come un uomo.
Come l’uomo più evoluto che si
innalza con la propria intelligenza
e che sfida la natura con la
forza incontrastata della scienza,
con addosso l’entusiasmo di
spaziare senza limiti nel cosmo
e convinto che la forza del
pensiero sia la sola libertà.
La libertà non è star sopra un
albero,
non è neanche un gesto o
un’invenzione,
la libertà non è uno spazio
libero,
libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un
albero,
non è neanche il volo di un
moscone,
la libertà non è uno spazio
libero,
libertà è partecipazione.
“LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE”
– Dal
testo di Gaber alla realtà che ci circonda.
Così cantava il mitico Gaber
in una delle sue canzoni “La libertà non è star sopra un albero, non è
neanche il volo di un moscone, la libertà non è uno spazio libero, libertà è
partecipazione.” Come rispondereste alla domanda “chi è colui che può
definirsi libero?”, certamente molti diranno subito “colui che può
fare ciò che vuole, esprimere le proprie opinioni, manifestare la
propria fede e via discorrendo” … invece non proprio. Non proprio perché
questa sarebbe anarchia o per lo meno la rasenterebbe; per capire meglio il
significato di tale termine, allora, prendiamo in esame la frase di Gaber
libertà è partecipazione: partecipare, filologicamente inteso significa
“essere parte di …” e quindi essere inseriti in un dato contesto. Libertà
non è dunque dove non esistono limitazioni ma bensì dove queste vigono in
maniera armoniosa e, naturalmente, non oppressiva. Posso capire che la cosa
strida a molti ma se analizzata in maniera posata si potrà evincere come una
società senza regole sia l’antitesi di sé stessa. Dove sta la
libertà, allora? Innanzitutto comincerei parlando di rispetto:
rispetto per l’altro, per le sue idee, per la sua persona:
se non ci rispettiamo vicendevolmente non otterremo mai un vivere civile e
quindi alcuna speranza di libertà. La libertà è un diritto innegabile.
Chi ha il diritto di stabilire quali libertà assegnare a chi?
Pensiamo agli schiavi di ieri e , purtroppo, anche di oggi: perché negare loro
le libertà? Per la pigrizia di chi gliele nega, chiaramente; su questo si basa
il rapporto padrone-schiavo (anche quello hegeliano del servo-padrone), sulla
forza ed il terrore, terrore non dell’asservito ma del servito. Dall’Antichità
al Medioevo, dal Rinascimento ad oggi gli uomini hanno sempre tentato di
esercitare la propria egemonia sugli altri, secondo diritti divini, di nobiltà
di natali, tramite l’ostentazione della propria condizione economica e via
discorrendo, falciando così in pieno il diritto alla libertà di alcuni.
“Libertà è partecipazione”, tale frase continua a ronzarmi in testa e mi sprona
ad esortare: rispettiamoci per essere liberi… a tali parole mi sovviene la
seconda strofa del nostro inno nazionale (di cui pochi, ahime, conoscono
l’esistenza, poiché molti ritengono che il nostro inno sia costituito d’una sola
strofa):
“Noi
fummo da secoli
calpesti, derisi,
perché non siam popolo,
perché siam divisi.
Raccolgaci un’unica
bandiera, una speme:
di fonderci insieme
già l’ora suonò.”
e quindi l’invito della terza
strofa: “Uniamoci, amiamoci”
Dignità,
rispetto dell’altro, partecipazione, lievi
seppur necessarie limitazioni: questi sono gli ingredienti per un’ottima
ricetta di libertà, non certo paroloni da politicanti come “lotta alla
criminalità”, “lotta all’evasione fiscale”, “lotta alle cricche”, giusto
per citare le più quotate in questi ultimi tempi. La libertà necessita di
semplicità, non certo di pompose cerimonie: essa è bella come una ragazza a
quindici-sedici anni (o per lo meno, rifacendomi allo Zibaldone
leopardiano), tutta acqua e sapone e sempre con un sorriso gentile pronto
per tutti. Forse è anche per questo che gli uomini raffigurano la Libertà come
una giovane donna…!
IO SE FOSSI DIO di Giorgio
Gaber – 1980
Io se fossi Dio
E io potrei anche esserlo
Se no non vedo chi.
Io se fossi Dio non mi farei
fregare dai modi furbetti della gente
Non sarei mica un dilettante
Sarei sempre presente
Sarei davvero in ogni luogo a
spiare
O meglio ancora a criticare,
appunto
Cosa fa la gente.
Per esempio il cosiddetto uomo
comune
Com'è noioso
Non commette mai peccati
grossi
Non è mai intensamente
peccaminoso.
Del resto poverino è troppo
misero e meschino
E pur sapendo che Dio è il
computer più perfetto
Lui pensa che l'errore
piccolino
Non lo veda o non lo conti
affatto.
Per questo io se fossi Dio
Preferirei il secolo passato
Se fossi Dio rimpiangerei il
furore antico
Dove si amava, e poi si odiava
E si ammazzava il nemico.
Ma io non sono ancora nel
regno dei cieli
Sono troppo invischiato nei
vostri sfaceli.
Io se fossi Dio
Non sarei mica stato a
risparmiare
Avrei fatto un uomo migliore.
Si, vabbè, lo ammetto
non mi è venuto tanto bene
ed è per questo, per predicare
il giusto
che io ogni tanto mando giù
qualcuno
ma poi alla gente piace
interpretare
e fa ancora più casino.
Io se fossi Dio
Non avrei fatto gli errori di
mio figlio
E specialmente sull'amore
Mi sarei spiegato un po'
meglio.
Infatti voi uomini mortali per
le cose banali
Per le cazzate tipo
compassione e finti aiuti
Ci avete proprio una bontà
Da vecchi un po'
rincoglioniti.
Ma come siete buoni voi che il
mondo lo abbracciate
E tutti che ostentate la
vostra carità.
Per le foreste, per i delfini
e i cani
Per le piantine e per i
canarini
Un uomo oggi ha tanto amore di
riserva
Che neanche se lo sogna
Che vien da dire
Ma poi coi suoi simili come fa
ad essere così carogna.
Io se fossi Dio
Direi che la mia rabbia più
bestiale
Che mi fa male e che mi
porta alla pazzia
È il vostro finto impegno
È la vostra ipocrisia.
Ce l'ho che per salvare la
faccia
Per darsi un tono da cittadini
giusti e umani
Fanno passaggi pedonali e poi
servizi strani
E tante altre attenzioni
Per handicappati sordomuti e
nani.
E in queste grandi città
Che scoppiano nel caos e nella
merda
Fa molto effetto un pezzettino
d'erba
E tanto spazio per tutti i
figli degli dèi minori.
Cari assessori, cari furbastri
subdoli altruisti
Che usate gli infelici con
gran prosopopea
Ma io so che dentro il vostro
cuore li vorreste buttare
Dalla rupe Tarpea.
Ma io non sono ancora nel
regno dei cieli
Sono troppo invischiato nei
vostri sfaceli.
Io se fossi Dio maledirei per
primi i giornalisti e specialmente tutti
Che certamente non sono brave
persone
E dove cogli, cogli sempre
bene.
Signori giornalisti, avete
troppa sete
E non sapete approfittare
della libertà che avete
Avete ancora la libertà di
pensare, ma quello non lo fate
E in cambio pretendete
La libertà di scrivere
E di fotografare.
Immagini geniali e
interessanti
Di presidenti solidali e di
mamme piangenti
E in questo mondo pieno di
sgomento
Come siete coraggiosi, voi che
vi buttate senza tremare un momento:
Cannibali, necrofili,
deamicisiani, astuti
E si direbbe proprio
compiaciuti
Voi vi buttate sul disastro
umano
Col gusto della lacrima
In primo piano.
Si, vabbè, lo ammetto
La scomparsa totale della
stampa sarebbe forse una follia
Ma io se fossi Dio di fronte a
tanta deficienza
Non avrei certo la
superstizione
Della democrazia.
Ma io non sono ancora nel
regno dei cieli
Sono troppo invischiato nei
vostri sfaceli.
Io se fossi Dio
Naturalmente io chiuderei la
bocca a tanta gente.
Nel regno dei cieli non vorrei
ministri
Né gente di partito tra le
palle
Perché la politica è schifosa
e fa male alla pelle.
E tutti quelli che fanno
questo gioco
Che poi è un gioco di forze
ributtante e contagioso
Come la febbre e il tifo
E tutti quelli che fanno
questo gioco
C' hanno certe facce
Che a vederle fanno schifo.
Io se fossi Dio dall'alto del
mio trono
Direi che la politica è un
mestiere osceno
E vorrei dire, mi pare a
Platone
Che il politico è sempre meno
filosofo
E sempre più coglione.
È un uomo a tutto tondo
Che senza mai guardarci dentro
scivola sul mondo
Che scivola sulle parole
E poi se le rigira come lui
vuole.
Signori dei partiti
O altri gregari imparentati
Non ho nessuna voglia di
parlarvi
Con toni risentiti.
Ormai le indignazioni son cose
da tromboni
Da guitti un po' stonati.
Quello che dite e fate
Quello che veramente siete
Non merita commenti, non se ne
può parlare
Non riesce più nemmeno a farmi
incazzare.
Sarebbe come fare inutili
duelli con gli imbecilli
Sarebbe come scendere ai
vostri livelli
Un gioco così basso, così
atroce
Per cui il silenzio sarebbe la
risposta più efficace.
Ma io sono un Dio emotivo, un
Dio imperfetto
E mi dispiace ma non son
proprio capace
Di tacere del tutto.
Ci son delle cose
Così tremende, luride e
schifose
Che non è affatto strano
Che anche un Dio
Si lasci prendere la mano.
Io se fossi Dio preferirei
essere truffato
E derubato, e poi deriso e poi
sodomizzato
Preferirei la più tragica
disgrazia
Piuttosto che cadere nelle
mani della giustizia.
Signori magistrati
Un tempo così schivi e
riservati
Ed ora con la smania di essere
popolari
Come cantanti come calciatori.
Vi vedo così audaci che siete
anche capaci
Di metter persino la mamma in
galera
Per la vostra carriera.
Io se fossi Dio
Direi che è anche abbastanza
normale
Che la giustizia si amministri
male
Ma non si tratta solo
Di corruzioni vecchie e nuove
È proprio un elefante che non
si muove
Che giustamente nasce
Sotto un segno zodiacale un
po' pesante
E la bilancia non l'ha neanche
come ascendente.
Io se fossi Dio
Direi che la giustizia è una
macchina infernale
È la follia, la perversione
più totale
A meno che non si tratti di
poveri ma brutti
Allora si che la giustizia è
proprio uguale per tutti.
Io se fossi Dio
Io direi come si fa a non
essere incazzati
Che in ospedale si fa morir la
gente
Accatastata tra gli sputi.
E intanto nel palazzo comunale
C'è una bella mostra sui
costumi dei sanniti
In modo tale che in questa
messa in scena
Tutto si addolcisca, tutto si
confonda
In modo tale che se io fossi
Dio direi che il sociale
È una schifosa facciata
immonda.
Ma io non sono ancora nel
regno dei cieli
Sono troppo invischiato nei
vostri sfaceli.
Io se fossi Dio
Vedrei dall'alto come una
macchia nera
Una specie di paura che forse
è peggio della guerra
Sono i soprusi, le estorsioni
i rapimenti
È la camorra.
È l'impero degli invisibili
avvoltoi
Dei pescecani che non si
sazian mai
Sempre presenti, sempre più
potenti, sempre più schifosi
È l'impero dei mafiosi.
Io se fossi Dio
Io griderei che in questo
momento
Son proprio loro il nostro
sgomento.
Uomini seri e rispettati
Cos'ì normali e al tempo
stesso spudorati
Così sicuri dentro i loro
imperi
Una carezza ai figli, una
carezza al cane
Che se non guardi bene ti
sembrano persone
Persone buone che
quotidianamente
Ammazzano la gente con una tal
freddezza
Che Hitler al confronto mi fa
tenerezza.
Io se fossi Dio
Urlerei che questi terribili
bubboni
Ormai son dentro le nostre
istituzioni
E anzi, il marciume che ho
citato
È maturato tra i consiglieri,
i magistrati, i ministeri
Alla Camera e allo Senato.
Io se fossi Dio
Direi che siamo complici
oppure deficienti
Che questi delinquenti, queste
ignobili carogne
Non nascondono neanche le loro
vergogne
E sono tutti i giorni sui
nostri teleschermi
E mostrano sorridenti le
maschere di cera
E sembrano tutti contro la
sporca macchia nera.
Non ce n'è neanche uno che non
ci sia invischiato
Perché la macchia nera
È lo Stato.
E allora io se fossi Dio
Direi che ci son tutte le
premesse
Per anticipare il giorno
dell'Apocalisse.
Con una deliziosa indifferenza
E la mia solita distanza
Vorrei vedere il mondo e tutta
la sua gente
Sprofondare lentamente nel
niente.
Forse io come Dio, come
Creatore
Queste cose non le dovrei
nemmeno dire
Io come Padreterno non mi
dovrei occupare
Né di violenza né di orrori né
di guerra
Né di tutta l'idiozia di
questa Terra
E cose simili.
Peccato che anche Dio
Ha il proprio inferno
Che è questo amore eterno
Per gli uomini.
IL CONFORMISTA
di Giorgio Gaber – 1996
Io sono un uomo nuovo
talmente nuovo che è da tempo
che non sono neanche più fascista
sono sensibile e altruista
orientalista ed in passato
sono stato un po' sessantottista
da un po’ di tempo
ambientalista
qualche anno fa nell'euforia
mi son sentito come un po' tutti socialista.
Io sono un uomo nuovo
per carità lo dico in senso
letterale
sono progressista al tempo
stesso liberista
antirazzista e sono molto
buono
sono animalista
non sono più assistenzialista
ultimamente sono un po'
controcorrente son federalista.
Il conformista è uno che di
solito sta sempre dalla parte giusta,
il conformista ha tutte le
risposte belle chiare dentro la sua testa
è un concentrato di opinioni
che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani
e quando ha voglia di pensare
pensa per sentito dire
forse da buon opportunista si
adegua senza farci caso
e vive nel suo paradiso.
Il conformista è un uomo a
tutto tondo che si muove senza consistenza,
il conformista s'allena a
scivolare dentro il mare della maggioranza
è un animale assai comune che
vive di parole da conversazione
di notte sogna e vengon fuori
i sogni di altri sognatori
il giorno esplode la sua festa
che è stare in pace con il mondo
e farsi largo galleggiando
il conformista
il conformista.
Io sono un uomo nuovo e con le
donne c'ho un rapporto straordinario
sono femminista
son disponibile e ottimista
europeista
non alzo mai la voce
sono pacifista
ero marxista-leninista e dopo
un po' non so perché mi son trovato cattocomunista.
Il conformista non ha capito
bene che rimbalza meglio di un pallone
il conformista aerostato
evoluto che è gonfiato dall'informazione
è il risultato di una specie
che vola sempre a bassa quota in superficie
poi sfiora il mondo con un
dito e si sente realizzato
vive e questo già gli basta e
devo dire che oramai
somiglia molto a tutti noi
il conformista
il conformista.
Io sono un uomo nuovo
talmente nuovo che si vede a
prima vista
sono il nuovo conformista.
Una canzone molto ironica
quella di Giorgio Gaber, un’analisi su chi sia veramente il
conformista e proprio per questo proviamo prima di tutto a capire noi cosa
sia il conformismo, perchè senza di quello non possiamo comprendere cosa ci
voglia dire Gaber con questa canzone.
Il termine conformismo indica
una tendenza a conformarsi ad opinioni, usi, comportamenti e regole di un
determinato gruppo sociale. Attenzione però qui stiamo parlando di gruppo
sociale qualunque e non per forza quello “dominante” (come in genere molti
pensano) che sarebbe anche piuttosto difficile da identificare visto che la
nostra società è molto grande, complessa ed esistono infinite sfumature. Questo
vuol dire che se apparteniamo ad un gruppo sociale che accettiamo in modo
assoluto allora siamo conformisti rispetto a quel gruppo. Il prete per esempio è
un conformista rispetto al suo gruppo sociale di preti che a loro volta fanno
riferimento al Papa. Chi per esempio appartiene ad una famiglia malavitosa e fa
il bullo a scuola insieme ad altri bulli suoi amici che disturbano, rubano ecc.
è un conformista rispetto al suo gruppo sociale di delinquenti. Molti giovani
pensano ingenuamente che conformismo vuol dire solo mettersi giacca, cravatta e
comportarsi bene, mentre anticonformismo vuol dire mettersi maglietta, jeans e
comportarsi male, ma non è così.
Con questa canzone Gaber
prende in giro il conformista, facendone notare tutte le sue possibili
caratteristiche che lo contraddistinguono e allo stesso tempo ne fa emergere
tutta una serie di contraddizioni: guardiamo per esempio alla prima strofa in
cui il conformista nel giro di pochi anni passa prima ad essere “fascista“,
per poi diventare “orientalista“, ricordandosi però di essere stato un “sessantottista”
e da tempo anche “ambientalista” e pure “socialista“! Da subito quindi
una forte critica implicita all’uomo conformista, che alla fine continuando a
cambiare idea, risulta essere tutto tranne che conformista. Questa
successione di cambio di idee improvvise, seguendo la massa a seconda di cosa
sia più comodo e non secondo ciò in cui si creda veramente, porta Gaber a dare
lui stesso la definizione del conformista moderno:
“Il conformista è uno che
di solito sta sempre dalla parte giusta,
il conformista ha tutte le
risposte belle chiare dentro la sua testa
è un concentrato di
opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani
e quando ha voglia di
pensare pensa per sentito dire
forse da buon opportunista
si adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso”
La critica dunque è forte, un
uomo che non è quasi più in grado di pensare con la sua testa, ma si adegua alle
circostanze creandosi un mondo tutto suo in cui vivere senza problemi e senza
lotte. Ma come è abituato a fare, Gaber lancia una frecciatina a tutti
noi, perchè guardandoci in faccia, probabilmente i primi ad essere conformisti
siamo proprio noi:“e devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi, il
conformista“.
LA DEMOCRAZIA di Giorgio
Gaber – 1997
Dopo anni di riflessione sulle
molteplici possibilità che ha uno stato di organizzarsi ho capito che la
democrazia... è il sistema più democratico che ci sia. Dunque c’è la dittatura,
la democrazia e... basta. Solo due. Credevo di più. La dittatura chi l’ha vista
sa cos’è, gli altri si devono accontentare di aver visto solo la democrazia. lo,
da quando mi ricordo, sono sempre stato democratico, non per scelta, per
nascita. Come uno che appena nasce è cattolico, apostolico, romano. Cattolico
pazienza, apostolico non so cosa sia, ma anche romano... Va be’, del resto come
si fa oggi a non essere democratici? Sul vocabolario c’è scritto che la parola
"democrazia" deriva dal greco e significa "potere al popolo". L’espressione è
poetica e suggestiva. Sì, ma in che senso potere alta popolo? Come si fa? Questo
sul vocabolario non c’è scritto. Però si sa che dal ‘45, dopo il famoso
ventennio, il popolo italiano ha acquistato finalmente il diritto di voto. È
nata così la “Democrazia rappresentativa” nella quale tu deleghi un partito che
sceglie una coalizione che sceglie un candidato che tu non sai chi sia e che tu
deleghi a rappresentarti per cinque anni. E che se io incontri ti dice: “Lei non
sa chi sono io!” Questo è il potere del popolo. Ma non è solo questo. Ci sono
delle forme ancora più partecipative. Per esempio il referendum è addirittura
una pratica di “Democrazia diretta”... non tanto pratica, attraverso la quale
tutti possono esprimere il loro parere su tutto. Solo che se mia nonna deve
decidere sulla Variante di Valico Barberino-Roncobilaccio ha qualche difficoltà.
Anche perché è di Venezia. Per fortuna deve dire un “Sì” se vuoi dire no e un
“No” se vuoi dire sì. In ogni caso ha il 50% di probabilità di azzeccarla.
Comunque il referendum ha più che altro un valore folkloristico, perché dopo
aver discusso a lungo sul significato politico dei risultati tutto resta come
prima. Un altro grande vantaggio che la democrazia offre a mia nonna, cioè al
popolo, è la libertà di stampa. Nei regimi totalitari, per esempio durante il
fascismo, si chiamava propaganda e tu non potevi mai sapere la verità. Da noi si
chiama “informazione”, che per maggior chiarezza ha anche il pregio di esser
pluralista. Sappiamo tutto. Sappiamo tutto, ma anche il contrario di tutto.
Pensa che bello. Sappiamo che l’Italia va benissimo, ma che va anche malissimo.
Sappiamo che l’inflazione è al 3, o al 4, o al 6, o anche al 10%. Che
abbondanza! Sappiamo che i disoccupati sono il 12% e che aumentano o
diminuiscono a piacere, a seconda di chi lo dice. Sappiamo dati, numeri,
statistiche. Alla fine se io voglio sapere quanti italiani ci sono in Italia,
che faccio? Vado sulla Variante di Valico Barberino-Roncobilaccio e li conto:
Zzzz! Chi va al sud. Zzzz! Chi va al nord! Altro che Istat! Comunque è
innegabile che fra un regime totalitario e uno democratico c’è una differenza
abissale. Per esempio, durante il fascismo non ti potevi permettere di essere
antifascista. In democrazia invece si può far tutto, tranne che essere
antidemocratici. Durante il fascismo c’era un partito solo al potere. O quello o
niente. In democrazia invece i partiti al potere sono numerosi e in crescita.
Alle ultime elezioni, fra partiti, liste autonome, liste di area, gruppi misti,
eccetera, ce ne sono stati duecentoquarantotto. Più libertà di cosi si muore!
Del resto una delle caratteristiche della democrazia è che si basa
esclusivamente sui numeri… come il gioco del Lotto, anche se è meno casuale, ma
più redditizio. Più largo è il consenso del popolo, più la democrazia, o chi per
lei, ci guadagna. Quello del popolo è sempre stato un problema, per chi governa.
Se ti dà il suo consenso vuoi dire che ha capito, che è cosciente, consapevole,
e anche intelligente. Se no è scemo. Comunque l’importante è coinvolgere più
gente possibile. Intendiamoci, la democrazia non è nemica della qualità. È la
qualità che è nemica della democrazia. Mettiamo come paradosso che un politico
sia un uomo di qualità. Mettiamo anche che si voglia mantenere a livelli alti.
Quanti lo potranno apprezzare? Pochi, pochi ma buoni. No, in democrazia ci
vogliono i numeri, e che numeri. Bisogna allargare il consenso, scendere alla
portata di tutti. Bisogna adeguarsi. E un’adeguatina oggi, un’adeguatina
domani... e l’uomo di qualità a poco a poco ci prende gusto... e “tac”, un’altra
abbassatina... poi ce n’è un altro che si abbassa di più, e allora anche lui...
“tac”... “tac”... ogni giorno si abbassa di cinque centimetri. E così, quando
saremo tutti scemi allo stesso modo, la democrazia sarà perfetta.
DESTRA-SINISTRA di Giorgio
Gaber – 2001
Destra-Sinistra
è un singolo di Giorgio Gaber, pubblicato nel 2001, tratto dall'album La mia
generazione ha perso.
La canzone vuol mettere
ironicamente in risalto le presunte differenze tra destra e sinistra politiche,
delle quali è una bonaria critica. Tutta la canzone verte infatti su luoghi
comuni anziché sulle differenze di tipo idealistico, ed è lo stesso Gaber a
specificare che, attualmente, le differenze fra le due parti sono ormai minime,
e che chi si definisce di una fazione rispetto ad un'altra lo fa per mera
«ideologia», e per «passione ed ossessione» di una diversità che «al momento
dove è andata non si sa». In altre parole, la differenza fra chi si definisce di
una parte piuttosto che dall'altra è solamente ostentata, ed è nulla per quanto
riguarda il lato pratico.
Tutti noi ce la prendiamo con
la storia
ma io dico che la colpa è
nostra
è evidente che la gente è poco
seria
quando parla di sinistra o
destra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
Fare il bagno nella vasca è di
destra
far la doccia invece è di
sinistra
un pacchetto di Marlboro è di
destra
di contrabbando è di sinistra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
Una bella minestrina è di
destra
il minestrone è sempre di
sinistra
tutti i films che fanno oggi
son di destra
se annoiano son di sinistra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
Le scarpette da ginnastica o
da tennis
hanno ancora un gusto un po'
di destra
ma portarle tutte sporche e un
po' slacciate
è da scemi più che di
sinistra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
I blue-jeans che sono un segno
di sinistra
con la giacca vanno verso
destra
il concerto nello stadio è di
sinistra
i prezzi sono un po' di
destra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
I collant son quasi sempre di
sinistra
il reggicalze è più che mai di
destra
la pisciata in compagnia è di
sinistra
il cesso è sempre in fondo a
destra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
La piscina bella azzurra e
trasparente
è evidente che sia un po' di
destra
mentre i fiumi, tutti i laghi
e anche il mare
sono di merda più che
sinistra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
L'ideologia, l'ideologia
malgrado tutto credo ancora
che ci sia
è la passione, l'ossessione
della tua diversità
che al momento dove è andata
non si sa
dove non si sa, dove non si
sa.
Io direi che il culatello è di
destra
la mortadella è di sinistra
se la cioccolata svizzera è di
destra
la Nutella è ancora di
sinistra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
Il pensiero liberale è di
destra
ora è buono anche per la
sinistra
non si sa se la fortuna sia di
destra
la sfiga è sempre di sinistra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
Il saluto vigoroso a pugno
chiuso
è un antico gesto di sinistra
quello un po' degli anni '20,
un po' romano
è da stronzi oltre che di
destra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
L'ideologia, l'ideologia
malgrado tutto credo ancora
che ci sia
è il continuare ad affermare
un pensiero e il suo perché
con la scusa di un contrasto
che non c'è
se c'è chissà dov'è, se c'é
chissà dov'é.
Tutto il vecchio moralismo è
di sinistra
la mancanza di morale è a
destra
anche il Papa ultimamente
è un po' a sinistra
è il demonio che ora è andato
a destra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
La risposta delle masse è di
sinistra
con un lieve cedimento a
destra
son sicuro che il bastardo è
di sinistra
il figlio di puttana è di
destra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
Una donna emancipata è di
sinistra
riservata è già un po' più di
destra
ma un figone resta sempre
un'attrazione
che va bene per sinistra e
destra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
Tutti noi ce la prendiamo con
la storia
ma io dico che la colpa è
nostra
è evidente che la gente è poco
seria
quando parla di sinistra o
destra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
Destra-sinistra
Destra-sinistra
Destra-sinistra
Destra-sinistra
Destra-sinistra
Basta!
IO NON MI SENTO ITALIANO di
Giorgio Gaber – 2003
La canzone "Io non mi sento
italiano" è tratta dall'omonimo album uscito postumo di Giorgio Gaber, nel
gennaio 2003, titolo che all'apparenza è di forte impatto evocativo che sa di
delusione, di rabbia, di denuncia. Ma poi, per ribilanciare l'affermazione,
basta leggere la frase nel seguito, “Io non mi sento italiano, ma per fortuna o
purtroppo lo sono”, c'è un grande concetto all'interno, quello di appartenenza,
a cui Gaber è legato, che lascia trasparire la sua dolcezza, nonostante il
sentimento di sdegno di cui si fa portavoce. Stupisce, e non poco, a distanza di
anni, la modernità del testo, l'attualità delle situazioni, che già allora
Giorgio Gaber raccontava come quotidianità di quel paese, in quel periodo
storico. Album registrato poco prima della sua scomparsa, fu scritto con Sandro
Luporini, pittore di Viareggio, suo compagno di scrittura in tutte le sue
produzioni più importanti musicali e teatrali. Giorgio Gaber, è il suo nome
d'arte, si chiama in effetti Giorgio Gaberscik e nasce a Milano il 25 gennaio
1939 (scompare a Montemagno di Camaiore il 1º gennaio 2003), da padre di origine
istriane-goriziano slovene e madre veneziania. Inizia a suonare la chitarra da
bambino a 8-9 anni per curare un brutto infortunio ad un braccio. Diventa un
ottimo chitarrista e, con le serate, da grande, si pagherà gli studi
universitari. E' il 1970 l'anno della svolta artistica di Giorgio Gaber. Gaber è
celebre ma si sente “ingabbiato”, costretto a recitare un ruolo nella parte di
cantante e di presentatore televisivo. Rinuncia così alla grandissima notorietà,
si spoglia del ruolo di affabulatore e porta "la canzone a teatro" (creando il
genere del teatro canzone). Gaber si presenta al pubblico così com'è, ricomincia
da capo. Per questo crea un personaggio che non recita più un ruolo, il «Signor
G», recita se stesso. Quindi un signore come tutti, “una persona piena di
contraddizioni e di dolori”.
TESTO - Io non mi sento
italiano - parlato:
Io G. G. sono nato e vivo a
Milano.
Io non mi sento italiano
ma per fortuna o purtroppo lo
sono.
Mi scusi Presidente
non è per colpa mia
ma questa nostra Patria
non so che cosa sia.
Può darsi che mi sbagli
che sia una bella idea
ma temo che diventi
una brutta poesia.
Mi scusi Presidente
non sento un gran bisogno
dell'inno nazionale
di cui un po' mi vergogno.
In quanto ai calciatori
non voglio giudicare
i nostri non lo sanno
o hanno più pudore.
Io non mi sento italiano
ma per fortuna o purtroppo lo
sono.
Mi scusi Presidente
se arrivo all'impudenza
di dire che non sento
alcuna appartenenza.
E tranne Garibaldi
e altri eroi gloriosi
non vedo alcun motivo
per essere orgogliosi.
Mi scusi Presidente
ma ho in mente il fanatismo
delle camicie nere
al tempo del fascismo.
Da cui un bel giorno nacque
questa democrazia
che a farle i complimenti
ci vuole fantasia.
Io non mi sento italiano
ma per fortuna o purtroppo lo
sono.
Questo bel Paese
pieno di poesia
ha tante pretese
ma nel nostro mondo
occidentale
è la periferia.
Mi scusi Presidente
ma questo nostro Stato
che voi rappresentate
mi sembra un po' sfasciato.
E' anche troppo chiaro
agli occhi della gente
che tutto è calcolato
e non funziona niente.
Sarà che gli italiani
per lunga tradizione
son troppo appassionati
di ogni discussione.
Persino in parlamento
c'è un'aria incandescente
si scannano su tutto
e poi non cambia niente.
Io non mi sento italiano
ma per fortuna o purtroppo lo
sono.
Mi scusi Presidente
dovete convenire
che i limiti che abbiamo
ce li dobbiamo dire.
Ma a parte il disfattismo
noi siamo quel che siamo
e abbiamo anche un passato
che non dimentichiamo.
Mi scusi Presidente
ma forse noi italiani
per gli altri siamo solo
spaghetti e mandolini.
Allora qui mi incazzo
son fiero e me ne vanto
gli sbatto sulla faccia
cos'è il Rinascimento.
Io non mi sento italiano
ma per fortuna o purtroppo lo
sono.
Questo bel Paese
forse è poco saggio
ha le idee confuse
ma se fossi nato in altri
luoghi
poteva andarmi peggio.
Mi scusi Presidente
ormai ne ho dette tante
c'è un'altra osservazione
che credo sia importante.
Rispetto agli stranieri
noi ci crediamo meno
ma forse abbiam capito
che il mondo è un teatrino.
Mi scusi Presidente
lo so che non gioite
se il grido "Italia, Italia"
c'è solo alle partite.
Ma un po' per non morire
o forse un po' per celia
abbiam fatto l'Europa
facciamo anche l'Italia.
Io non mi sento italiano
ma per fortuna o purtroppo lo
sono.
Io non mi sento italiano
ma per fortuna o purtroppo
per fortuna o purtroppo
per fortuna
per fortuna lo sono.
Ci sedemmo dalla parte del
torto visto che tutti gli altri posti erano occupati. Ci sono uomini che lottano
un giorno e sono bravi, altri che lottano un anno e sono più bravi, ci sono
quelli che lottano più anni e sono ancora più bravi, però ci sono quelli che
lottano tutta la vita: essi sono gli indispensabili. Citazioni di Bertolt
Brecht.
Povera Italia. Povera
Calabria,
scrive Luciano regolo, direttore de “L’Ora della Calabria”.
Non sono renziano, ma neppure lettiano o berlusconiano o
alfaniano o grillino. Anzi vi confesso che non voto da un bel po', specialmente
da quando, dirigendo un settimanale nazionale popolare a vasta tiratura, ebbi
modo di toccare con mano quali e quanti mali attraversino trasversalmente i
nostri partiti e come difficilmente i vari leader del nostro scenario politico
si tirino indietro dal lobbysmo che domina in Italia. Tuttavia trovo questa
staffetta Letta-Renzi ancora più inquietante. Per mesi abbiamo sentito dire a
destra e manca che Letta doveva restare in sella per emergenze basilari nella
vita del nostro Paese, dalla crisi economica alla riforma elettorale. Ora invece
si cambia registro. Ma non si va a nuove elezioni, la volontà popolare, in tutto
questo, viene sempre più messa da parte. La scusa è che senza nuove regole per
le elezioni si rischierebbe di avere nuovamente una maggioranza troppo risicata
per garantire la stabilità governativa. Ma se non si è avuto fino ad ora quel
certo senso di responsabilità necessario per mettere da parte gli interessi e i
protagonismi personali per arrivare a questo (minimo) obiettivo perché mai le
cose dovrebbero cambiare con Renzi premier? Non sarebbe stato più equo e più
democratico chiedere agli elettori di andare alle urne, magari esercitando il
proprio diritto di voto riflettendo un po' di più, visto quello che stiamo
tuttora vivendo? Napolitano avrà pure le sue buone ragioni, anche se a volte
riesce difficile condividerle. Però, lo spazio non se l'è preso da solo, gli è
dato da tutta una situazione, da tutto un cecchinaggio diffuso e mirato al
proprio tornaconto personale. Il sospetto è che il "cancro" della voglia
sconfinata di poltrone oramai dilaghi e la faccia da padrona fino ad annientare
anche il minimo rispetto per tutte quelle famiglie italiane che stanno versando
in condizioni di gravissime difficoltà. La gente si toglie la vita per i debiti
(di qualche giorno fa la drammatica scelta dell'editore Zanardi), la gente è
disperata. Ma il palazzo continua imperterrito nelle sue logiche. E il male si
riverbera dal centro alla periferia, con le stesse modalità. La Calabria ne è un
esempio eclatante. Guerre intestine nella destra, guerre intestine a sinistra
(difficile che queste sospirate primarie del Pd siano la panacea per vecchie e
croniche conflittualità). Intanto i rifiuti ci sommergono, intanto la
'ndrangheta erode sempre più spazi della società civile, intanto la
disoccupazione lievita, al pari della malasanità. Povera Italia, povera
Calabria.
E poi c’è lei, la fonte di
tutti i mali.
Magistratura, la casta e le
degenerazioni,
scrive Andrea Signini su “Rinascita”. “IMAGISTRATI SONO INCAPACI E CORROTTI, NE
CONOSCO MOLTISSIMI”. Il Presidente Francesco Cossiga (Sassari, 26 Luglio 1928 –
Roma, 17 Agosto 2010), appartenente ad una famiglia di altissimi magistrati e
lui stesso capo del Consiglio Superiore della Magistratura, intervistato dal
giornalista Vittorio Pezzuto, disse: “La maggior parte dei magistrati attuali
sono totalmente ignoranti a cominciare dall’amico Di Pietro che un giorno mi
disse testualmente: “Cosa vuoi, appena mi sarò sbrigato questi processi, mi
leggerò il nuovo codice di procedura penale”. Nel corso della medesima
intervista Cossiga sottolineava le scadenti qualità dei membri della
magistratura, li definiva “incapaci a fare le indagini”. Da Presidente della
Repubblica inviò i carabinieri a Palazzo dei Marescialli. Accadde nel 91, il 14
novembre, quando il presidente-picconatore ritirò la convocazione di una
riunione del plenum nella quale erano state inserite cinque pratiche sui
rapporti tra capi degli uffici e loro sostituti sull’assegnazione degli
incarichi. Cossiga riteneva che la questione non fosse di competenza del plenum
e avvertì che se la riunione avesse avuto luogo avrebbe preso «misure esecutive
per prevenire la consumazione di gravi illegalità». I consiglieri del Csm si
opposero con un documento e si riunirono. In piazza Indipendenza, alla sede del
Csm, affluirono i blindati dei carabinieri e due colonnelli dell’Arma vennero
inviati a seguire la seduta. Ma il caso fu risolto subito, perché il
vicepresidente, Giovanni Galloni, non permise la discussione. Invitato a dare
una spiegazione sull’incredibile ed ingiustificato avanzamento di carriera
toccato ai due magistrati (Lucio di Pietro e Felice di Persia) noti per aver
condannato ed arrestato Enzo Tortora e centinaia di persone innocenti
nell’ambito dello stesso processo (tutti rilasciati dopo mesi di carcere per
imperdonabili errori macroscopici), Cossiga rispose: “Come mi è stato spiegato,
la magistratura deve difendere i suoi, soprattutto se colpevoli”. La sicurezza
di quanto affermava il Presidente Cossiga gli proveniva da una confessione
fattagli da un membro interno di cui non rivelò mai il nome ma risulta evidente
che si tratti di un personaggio di calibro elevatissimo, “Un giovane membro del
Consiglio Superiore della Magistratura, appartenente alla corrente di
magistratura democratica, figlio di un amico mio, il quale mi è ha detto: “Noi
dobbiamo difendere soprattutto quei magistrati che fanno errori e sono colpevoli
perché sennò questa diga che noi magistrati abbiamo eretto per renderci
irresponsabili ed incriticabili crolla”! invitato a dare delle spiegazioni sul
come mai il nostro sistema (comunemente riconosciuto come il migliore al Mondo)
fosse così profondamente percorso da fatali fratture, Cossiga tuonò: “La colpa
di tutto questo è della DC! Lì c’è stato chi, per ingraziarsi la magistratura,
ha varato la famosa “Breganzola” che prevede l’avanzamento di qualifica dei
magistrati senza demerito. Ci pronunciammo contro quella Legge in quattro: uno
era l’Avvocato Riccio, il deputato che poi fu sequestrato ed ucciso in Sardegna;
Giuseppe Gargani, io ed un altro. Fummo convocati alla DC e ci fu detto che
saremmo stati sospesi dal gruppo perché bisognava fare tutto quello che dicevano
di fare i magistrati altrimenti avrebbero messo tutti in galera”. Questo breve
preambolo ci deve servire come metro per misurare, con occhio nuovo, quanto più
da vicino possibile, l’attuale situazione italiana. Dal 1992 (mani pulite), ad
oggi, di acqua sotto ai ponti ne è passata assai. E tutta questa acqua, per
rimanere nel solco dell’allegoria, ha finito con l’erodere i margini di garanzia
della classe politica (vedi perdita delle immunità dei membri del Parlamento –
1993) espandendo quelli dei membri della magistratura. Membri i quali, poco alla
volta, hanno preferito fare il “salto della scimmia” passando da un ramo
all’altro (dal ramo giudiziario a quello legislativo e/o esecutivo) e ce li
siamo ritrovati in politica come missili (di Pietro, de Magistris, Grasso,
Ingroia, Finocchiaro…). Pertanto, quella che da decenni a questa parte viene
rivenduta al popolo italiano come una “stagione di battaglia contro la
corruzione politica”, in realtà nascondeva e tutt’ora nasconde ben altro. Il
potere legislativo (facente capo al Parlamento), quanto il potere esecutivo
(facente capo al governo), si sono ritrovati in uno stato di progressiva
sofferenza indotta dalla crescente ed inarrestabile affermazione del potere
giudiziario (facente capo alla magistratura). Che le cose stiano così, è fuor di
dubbio! E “La cosa brutta è che i giornalisti si prestino alle manovre politiche
dei magistrati” [Cossiga Ibid.]. Ecco spiegato come mai ci si ostini a ritenere
“mani pulite” una battaglia alla corruzione e non già una battaglia tra i tre
poteri dello Stato. Ma, scusate tanto, e il POPOLO?!? No, dico, siamo o non
siamo noi italiani ed italiane – e non altri popoli diversi dal nostro – a
pagare sulla nostra pelle lo scotto generato dalle conseguenze di queste
“scalate al potere”? Non siamo forse noi quelli/e che stanno finendo dritti in
bocca alla rovina totale, alla disperazione ed al suicidio di massa? COSA CI
STANNO FACENDO DI MALE E’ PRESTO DETTO. Innanzi tutto, il riflesso peggiore che
ci tocca subìre è dato dal fatto che, dal precedente (prima di “mani pulite”)
clima culturale in cui eravamo usi vivere sentendoci protetti dalla magistratura
(vedi garanzia di presunzione d’ innocenza), ci siamo ritrovati catapultati in
un clima orrido in cui è “la presunzione di colpevolezza” a dettare il ritmo. E,
di conseguenza, tutto il discorso è andato a gambe all’aria e le nostre libertà,
nonché le nostre sovranità sono andate in fumo. E poi, chi di voi può affermare
di non aver mai sentito ripetere sino alla nausea frasi del tipo “Lo deve
stabilire la magistratura”, oppure “Lo ha stabilito una sentenza” od anche “Lo
ha detto in giudice”; e allora? Forse queste persone (che restano sempre
impiegati statali al servizio dello Stato e di chi vi abita) discendono dallo
Spirito Santo? Sono o non sono esseri umani? E se lo sono allora posso
commettere degli sbagli, sì o no? E se sbaglia un magistrato le conseguenze sono
letali, sì o no? E allora per quale ragione da 22 anni a questa parte si sta
facendo di tutto per collocarli nell’olimpo della saggezza? Perché è possibile
sputtanare un esponente del ramo legislativo o di quello esecutivo e GUAI se si
fa altrettanto con uno del ramo giudiziario? L’ex magistrato ed ex politico
Antonio Di Pietro (definito da Cossiga “Il famoso cretino… che ha nascosto cento
milioni in una scatola delle scarpe” e “Ladro” che si è laureato “Probabilmente
con tutti 18 e si è preso pure l’esaurimento nervoso per prepararsi la Laurea”
quando era a capo dell’IDV ci ha assillato per anni, farcendo all’inverosimile i
suoi discorsi con frasi come quelle succitate. E come lui, ma dall’altro lato
della barricata, Silvio Berlusconi ha infarcito i suoi discorsi contro la
magistratura corrotta e bla bla bla. Ci hanno fatto un vero e proprio lavaggio
del cervello, arrivando a dividere la popolazione in due: una parte garantista
ed una giustizialista. Il vecchio e amatissimo strumento del “dividi et impera”
inventato dai nostri avi latini per esercitare il potere sulla massa ignorante.
Ma se due terzi della medesima torta sono marci e putrescenti (il potere
legislativo e quello esecutivo), possibile che il rimanente terzo (potere
giudiziario) sia l’unico commestibile? Certo che non lo è, è ovvio! La
corruzione, in magistratura è a livelli raccapriccianti, “E’ prassi dividere il
compenso con il magistrato. Tre su quattro sono corrotti” confessa Chiara
Schettini (nomen omen) impiegata statale con la qualifica di giudice presso il
Tribunale dei Fallimenti di Roma, anzi ex, visto che le hanno messo le manette
ai polsi e poi sbattuta in galera con gravissime accuse di corruzione e
peculato. Ricostruiamo quello che la stampa di regime non osa nemmeno sfiorare.
“SONO PIU’ MAFIOSA DEI MAFIOSI” DICE SPAVALDAMENTE IL GIUDICE DI ROMA. La gente
normale, quella che lavora per guadagnare e consegnare il bottino allo Stato
vampiro, lo sa molto bene: se si può, meglio non fare causa! Si perde tempo, si
perdono soldi e non si sa se ti andrà bene. E, stando a quanto sta emergendo da
una prodigiosa inchiesta di cui prima o poi anche la stampa di regime sarà
costretta a parlare, l’impressione poggia su basi solidissime. E sarebbe bene
prendere le distanze da certa gente… più pericolosa dei delinquenti veri. In una
elaborazione di un articolo de Il Fatto Quotidiano del 31 Dicembre 2013 apparsa
l’1 Gennaio 2014 sul sito malagiustiziainitalia.it, si parla di “Perizie
affidate a consulenti dall’ampio potere discrezionale e dai compensi
stratosferici, mazzette spartite anche con i giudici. Un crocevia affaristico in
cui è coinvolto il vertice dell’ufficio [quello di Roma]”, in riferimento alla
vicenda che ha visto coinvolta Chiara Schettini di cui abbiamo appena accennato.
La stessa Schettini, chiama in causa (è il caso di dire) anche la magistratura
umbra, passivamente prona ai desiderata di quella romana: insabbiare gli
esposti, far finta di nulla ed attendere che trascorrano i tempi era l’ordine da
eseguire. Sotto interrogatorio, la Schettini ha confessato al giudice (onesto e
che ringraziamo a nome di tutti i lettori e le lettrici di signoraggio.it): “Si
entrava in camera di consiglio e si diceva questo si fa fallire e questo no”.
Chi si esprime così non è un temibile boss della mala ma è sempre lei, il
veramente temibile giudice Schettini, lei sì appartenente al ramo pulito del
potere, proprio quello!!! Nella sua crassa arroganza venata di ottusa
prosaicità, ella ricorreva sovente ad uscite agghiaccianti, sfornando un gergo
truce da gangster matricolato. Intercettata telefonicamente mentre parlava col
curatore fallimentare Federico Di Lauro (anche lui in galera) minacciava di
farla pagare al suo ex compagno: “Guarda, gli ho detto, sono più mafiosa dei
mafiosi, ci metto niente a telefonare ai calabresi che prendono il treno, te
danno una corcata de botte e se ne vanno” (da Il Fatto, 8 Luglio 2013, R. Di
Giovacchino). Non finisce qui. Sempre questo giudice donna, in un’altra
intercettazione che ha lasciato di stucco gli inquirenti che l’hanno più e più
volte riascoltato il nastro, parlando con un ignoto interlocutore, minacciava il
“povero” Di Lauro in questi termini: “Io a Di Lauro l’avrei investito con la
macchina… Lui lavorava con la banda della Magliana”. Ciliegina sulla torta:
parlando al telefono con un perito del Tribunale, riferendosi all’insistenza di
un Avvocato che non aveva intenzione di piegarsi supinamente al comportamento
della Schettini, commentava: “Il suo amico Massimo [l’Avvocato insistente Ndr.]
ha chiesto la riapertura di due procedimenti. Una rottura senza limiti. Gli dica
di non insistere perché non domani, né dopo domani ma fra 10 anni io lo
ammazzo”. Alla faccia della magistratura a cui tocca attenersi! Alla faccia
delle parole del magistrato “che c’azzecckkhhA” Di Pietro colui il quale, dopo
il salto della scimmia ci ha assillato ripetendo come un disco scassato che
dobbiamo “affidarci alla magistratura”! come no! Si accomodi lei Di Pietro,
prima di noi (senza balbettare come le accadde quando se la vide bruttina a
Milano). Nell’articolo della Di Giovacchino leggiamo inoltre: “L’amico Massimo
è in realtà l’avvocato Vita. Mai ricevuto minacce? “Non da Grisolia, però mi
hanno telefonato persone con accento calabrese, consigli…”. Messaggi? “Mi
dicevano lasci perdere la vecchietta…” La “vecchietta” è Diana Ottini, un tipo
tosto, La giudice le consegnò 500 mila euro stipulando una promessa di vendita
posticipata di 10 anni, affinché acquistasse la sua casa dal Comune. Ma venuto
il momento lei la casa se l’è tenuta e il Tribunale le ha dato ragione. Non è
andata altrettanto bene a Francesca Chiumento, altra cliente dell’avvocato Vita,
che da anni si batte per riconquistare il “suo” attico in via Germanico: 170
metri quadri, terrazza su tre livelli, che il padre aveva acquistato dagli eredi
di Aldo Fabrizi. La casa finì all’asta, nei salotti romani si parla ancora della
polizia arrivata con le camionette. Anche quell’asta porta la firma della
Schettini: la famiglia Chiumento era pronta a pagare, a spuntarla fu un medico
del Bambin Gesù che offrì 50 mila euro di meno. L’appartamento di via Germanico
alla fine fu rivenduto per 1 milione e 800 mila euro a una coppia importante.
Lei figlia di un costruttore, che ha tirato su villaggi turistici tra Terracina
e Sperlonga, lui avvocato della banca che aveva offerto il mutuo ai legittimi
proprietari” [Il Fatto Ibid.]. E pensare che questa sguaiata stipendiata statale
ha campato una vita sulle spalle di noi contribuenti ed ha potuto nascondere le
sue malefatte per anni dietro la protezione del ruolo affidatole dallo Stato e
di persone della sua medesima risma. Tutti suoi colleghi e colleghe.
Allucinante. Semplicemente allucinante. Solamente dopo essersi impaurita a causa
dei giorni trascorsi in prigione, ha confessato che il suo ex compagno
“Trafficava anche con il direttore di una filiale di Unicredit su 900 mila euro
gliene dava 200 mila” come stecca [malagiustizia. Ibid.]. L’organizzazione
funzionava a gonfie vele, il timore di essere scoperti non li sfiorava nemmeno:
‘Non ti preoccupare [la rincuorava il compagno, quello della stecca
all’Unicredit] sarà rimesso tutto perfettamente”. Suscita la ripugnanza leggere
la storia di questa squallida persona la quale, nel frattempo, con lo stipendio
da funzionario statale è riuscita ad accumulare un patrimonio di quasi 5 milioni
di euro (quasi 10 miliardi di Lire) oltre ad attici a Parigi e Miami, ville a
Fregene, un rifugio a Madonna di Campiglio… A proposito: il figlio della
carcerata si è rivelato meno sveglio della mamma ma comunque fatto della
medesima pasta! Infatti, mentre alla madre venivano serrati i polsi con le
manette, lui riceveva l’sms in cui la madre stessa gli ordinava di fare “quello
che sa” (Il Fatto, ibid.). Si avete proprio capito bene. Il figlio diciottenne,
evidentemente al corrente delle attività della madre (e del padre) ed istruito a
dovere su come agire in caso di necessità, si è prontamente attivato rendendosi
complice della vicenda facendo sparire la valigetta col contante, frutto di una
delle corruzioni cui la madre era avvezza. Solo che le sue limitate capacità
hanno consentito, a chi ha effettuato la perquisizione, di ritrovare tutto
all’istante. Ed il Consiglio Superiore della Magistratura dormiva in questi
anni? Certo che no! Provvedeva, come fa spessissimo, a trasferirla presso la
procura di l’Aquila per ragioni di incompatibilità ambientale. Non sarebbe male
saperne di più su questa scelta curiosa. Che questa sia una vicenda riguardante
un pugno di magistrati e non tutti i componenti della magistratura è
lapalissiano, scontato ed evidente. E CI MANCHEREBBE ALTRO! Ma sappiate che il
punto della questione non è arrivare a pronunciare frasi vuote quanto idiote del
genere “Sono tutti uguali. Tra cani non si mordono…” qui c’è solo da fare una
cosa: il POPOLO deve riconoscere il proprio ruolo di SOVRANO! E poi, non resta
che risalire alla fonte del problema e, per farlo, NOI uomini e donne della
cosiddetta “società civile” abbiamo il dovere di emanciparci. Se c’intendessimo
(mi ci metto dentro anch’io – sebbene non sia un tifoso) di finanza e Stato come
di calcio e cucina, con l’aiuto dei nostri veri angeli custodi seri (ed in
magistratura ce ne sono eccome), il nostro futuro sarebbe radioso. Ripartire da
un punto fermo è cogente. Tale punto risiede nella battaglia “persa contro la
magistratura che è stata perduta quando abbiamo abrogato l’immunità
parlamentare, che esistono in tutto il Mondo, ovvero quando Mastella, da me
avvertito, si è abbassato il pantalone ed ha scritto sotto dittatura di
quell’associazione sovversiva e di stampo che è l’Associazione Nazionale
Magistrati” – F. Cossiga, Di Pietro… Ibid.
Non dimentichiamoci che di
magistrati parliamo e delle loro ambizioni.
Il giudice "pagato" con
prostitute di lusso. Quell'ambizione: «Dovevo fare il mafioso».
Il profilo di un
magistrato finito nell'occhio del ciclone per i suoi rapporti molto stretti con
il boss Lampada, già condannato a quattro anni di carcere e sospeso dal
servizio, scrive “Il Quotidiano Web”. Il giudice Giancarlo Giusti, arrestato e
posto ai domiciliari il 14 febbraio 2014 dalla squadra mobile di Reggio
Calabria, era stato condannato dal gup di Milano a 4 anni di reclusione il 27
settembre 2012 ed il giorno successivo aveva tentato il suicidio nel carcere
milanese di Opera in cui era detenuto. Soccorso dalla polizia penitenziaria, era
stato poi ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Successivamente aveva
ottenuto gli arresti domiciliari. Giusti, dal 2001 giudice delle esecuzioni
immobiliari a Reggio Calabria e poi dal 2010 gip a Palmi, era stato arrestato
per corruzione aggravata dalle finalità mafiose il 28 marzo 2012 nell’ambito di
una inchiesta della Dda di Milano sulla presunta cosca dei Valle-Lampada e, in
particolare, in un filone relativo alla cosiddetta "zona grigia". La Dda di
Milano gli ha contestato di essere sostanzialmente a “libro paga” della
'ndrangheta. In particolare, i Lampada, sempre secondo l’accusa, non solo gli
avrebbero offerto ''affari”, ma avrebbero anche appagato quella che il gip di
Milano, nell’ordinanza di custodia cautelare, aveva definito una vera e propria
“ossessione per il sesso”, facendogli trovare prostitute in alberghi di lusso
milanesi. Per il giudice di Palmi il clan organizzava viaggi nel nord Italia e
incontri con alcune escort. Una ventina di fine settimana di piacere al Nord, in
cui gli venivano messe a disposizione prostitute con le quali avrebbe
intrattenuto rapporti in un hotel della zona del quartiere San Siro. L’inchiesta
che scoperchia qualche figura della “zona grigia” che protegge, favorisce, aiuta
o in qualche modo è amica della ‘ndrangheta tra Milano e Reggio Calabria allinea
numerosi episodi, e ovviamente si avvale di alcune intercettazioni telefoniche e
ambientali. Eccone una che riguarda proprio Giancarlo Giusti, invitato a Milano,
all’hotel Brun. La toga non paga mai. Per lui il conto è saldato da un boss del
calibro di Giulio Lampada, per una spesa totale di 27mila euro. Senza parlare di
quanto costavano le ragazze, tutte identificate. C’era la ceca Jana,
quarantenne, le russe Zhanna 36 anni, ballerina al Rayto de Oro, a La Tour, al
Venus, e altri night di Milano e del nord, ed Elena, 41 anni, la kazaca Olga, 34
anni, e la slovena Denisa, 27 anni. Giusti, per telefono, si lascia andare: «...
Dovevo fare il mafioso, non il giudice...» Giusti e Lampada sono ovviamente in
ottimi rapporti, il magistrato gli dice che arriva a Milano «la settimana che
entra o la prossima... Dipende dal cugino del tuo caro amico medico!... di
Giglio!! no?!», e Giglio sta per Vincenzo, il collega magistrato, presidente del
tribunale per le misure di prevenzione del tribunale di Reggio Calabria, come
conferma lo stesso Lampada. Parlando del “medico”, che si chiama pure lui
Vincenzo Giglio. Ecco uno stralcio delle intercettazioni:
LAMPADA (riferendosi al
magistrato Vincenzo Giglio): «...Del nostro Presidente, dobbiamo dire!!... Il
Presidente delle misure di prevenzione di tutta Reggio Calabria! Sai che
dobbiamo fare?.....».
GIUSTI: «... che facciamo, che
facciamo??».
LAMPADA: «lo convochiamo
qualche giorno su a Milano e lo invitiamo... come la vedi tu?».
GIUSTI: «... minchia!!
guarda!! dobbiamo parlarne col medico!!!...(ride)...».
LAMPADA: «Non dirgli nulla che
ti ho detto che è un mese che non ci sentiamo!».
GIUSTI: «... Tu ancora non hai
capito chi sono io... sono una tomba, peggio di.. ma io dovevo fare il mafioso,
non il Giudice... però l’idea di portarci il Presidente a Milano non è male,
sai?!... Lo vorrei vedere di fronte ad una steccona!!».
BELLA ITALIA, SI’. MA
ITALIANI DEL CAZZO!!!
Italiani del Cazzo, sì.
Italiani che, anzichè prender a forconate i potenti impuniti, responsabili della
deriva italica, per codardia le loro ire le rivolgono a meridionali ed
extracomunitari. D’altro canto, per onestà intellettuale, bisogna dire che i
meridionali questi strali razzisti se li tirano, perchè nulla fanno per cambiare
le loro sorti di popolo occupato ed oppresso dalle forze politiche ed economiche
nordiche.
Radio Padania. Radio Vergogna.
Scandali e le mani della giustizia sulla Lega Padania. Come tutti. Più di tutti.
I leghisti continuano a parlare, anziché mettersi una maschera in faccia per la
vergogna. Su di loro io, Antonio Giangrande, ho scritto un libro a parte: “Ecco
a voi i leghisti: violenti, voraci, arraffoni, illiberali, furbacchioni,
aspiranti colonizzatori. Non (ri)conoscono la Costituzione Italiana e la violano
con disprezzo”. Molti di loro, oltretutto, sono dei meridionali rinnegati.
Terroni e polentoni: una litania che stanca. Terrone come ignorante e cafone.
Polentone come mangia polenta o, come dicono da quelle parti, po’ lentone: ossia
lento di comprendonio. Comunque bisognerebbe
premiare per la pazienza il gestore della pagina Facebook “Le perle di Radio
Padania“, ovvero quelli che per fornire una “Raccolta di frasi, aforismi e perle
di saggezza dispensate quotidianamente dall’emittente radiofonica “Radio Padania
Libera” sono costretti a sentirsela tutto il giorno. Una gallery di perle
pubblicate sulla radio comunitaria che prende soldi pubblici per insultare i
meridionali.
Questa è la mia proposta di
riforma costituzionale senza intenti discriminatori.
PRINCIPI COSTITUZIONALI
L'ITALIA E' UNA REPUBBLICA
DEMOCRATICA E FEDERALE FONDATA SULLA LIBERTA'. I CITTADINI SONO TUTTI UGUALI E
SOLIDALI.
I RAPPORTI TRA CITTADINI E TRA
CITTADINI E STATO SONO REGOLATI DA UN NUMERO RAGIONEVOLE DI LEGGI, CHIARE E
COERCITIVE.
LE PENE SONO MIRATE AL
RISARCIMENTO ED ALLA RIEDUCAZIONE, DA SCONTARE CON LA CONFISCA DEI BENI E CON
LAVORI SOCIALMENTE UTILI.
E' LIBERA OGNI ATTIVITA'
ECONOMICA, PROFESSIONALE, SOCIALE, CULTURALE E RELIGIOSA. IL SISTEMA SCOLASTICO
O UNIVERSITARIO ASSICURA L'ADEGUATA COMPETENZA. LE SCUOLE O LE UNIVERSITA' SONO
RAPPRESENTATE DA UN PRESIDE O UN RETTORE ELETTI DAGLI STUDENTI O DAI GENITORI
DEI MINORI. IL PRESIDE O IL RETTORE NOMINA I SUOI COLLABORATORI, RISPONDENDO
DELLE LORO AZIONI PRESSO LA COMMISSIONE DI GARANZIA.
LO STATO ASSICURA AI CITTADINI
OGNI MEZZO PER UNA VITA DIGNITOSA.
IL LAVORO SUBORDINATO PUBBLICO
E PRIVATO E' REMUNERATO SECONDO EFFICIENZA E COMPETENZA. LE COMMISSIONI
DISCIPLINARI SONO COMPOSTE DA 2 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI E PRESIEDUTE DA UN
DIRIGENTE PUBBLICO O AZIENDALE.
LO STATO CHIEDE AI CITTADINI
IL PAGAMENTO DI UN UNICO TRIBUTO, SECONDO IL SUO FABBISOGNO, SULLA BASE DELLA
CONTABILITA' CENTRALIZZATA DESUNTA DAI DATI INCROCIATI FORNITI TELEMATICAMENTE
DAI CONTRIBUENTI, CON DEDUZIONI PROPORZIONALI E DETRAZIONI TOTALI. AGLI EVASORI
SONO CONFISCATI TUTTI I BENI. LO STATO ASSICURA A REGIONI E COMUNI IL
SOSTENTAMENTO E LO SVILUPPO.
E' LIBERA LA PAROLA, CON
DIRITTO DI CRITICA, DI CRONACA, D'INFORMARE E DI ESSERE INFORMARTI.
L'ITALIA E' DIVISA IN 30
REGIONI, COMPRENDENTI I COMUNI CHE IVI SI IDENTIFICANO.
IL POTERE E' DEI CITTADINI. IL
CITTADINO HA IL POTERE DI AUTOTUTELARE I SUOI DIRITTI.
I SENATORI E I DEPUTATI, IL
CAPO DEL GOVERNO, I MAGISTRATI, I DIFENSORI CIVICI SONO ELETTI DAI CITTADINI CON
VINCOLO DI MANDATO. ESSI RAPPRESENTANO, AMMINISTRANO, GIUDICANO E DIFENDONO
SECONDO IMPARZIALITA', LEGALITA' ED EFFICIENZA IN NOME, PER CONTO E
NELL'INTERESSE DEI CITTADINI. ESSI SONO RESPONSABILI DELLE LORO AZIONI E
GIUDICATI DA UNA COMMISSIONE DI GARANZIA CENTRALE E REGIONALE.
GLI AMMINISTRATORI PUBBLICI
NOMINANO I LORO COLLABORATORI, RISPONDENDONE DEL LORO OPERATO.
LA COMMISSIONE DI GARANZIA,
ELETTA DAI CITTADINI, E' COMPOSTA DA UN SENATORE, UN DEPUTATO, UN MAGISTRATO, UN
RETTORE, UN DIFENSORE CIVICO CON INCARICO DI PRESIDENTE. LA COMMISSIONE CENTRALE
GIUDICA IN SECONDO GRADO E IN MODO ESCLUSIVO I MEMBRI DEL GOVERNO. ESSA GIUDICA,
ANCHE, SUI CONTRASTI TRA LEGGI E TRA FUNZIONI.
IL DIFENSORE CIVICO DIFENDE I
CITTADINI DA ABUSI OD OMISSIONI AMMINISTRATIVE, GIUDIZIARIE, SANITARIE O DI
ALTRE MATERIE DI INTERESSE PUBBLICO. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO IN OCCASIONE
DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL CONSIGLIO COMUNALE.
I 150 SENATORI SONO ELETTI
PROPORZIONALMENTE, CON LISTE REGIONALI, TRA I MAGISTRATI, GLI AVVOCATI, I
PROFESSORI UNIVERSITARI, I MEDICI, I GIORNALISTI.
I 300 DEPUTATI SONO ELETTI,
CON LISTE REGIONALI, TRA I RESTANTI RAPPRESENTANTI LA SOCIETA' CIVILE.
IL PARLAMENTO VOTA E PROMULGA
LE LEGGI PROPOSITIVE E ABROGATIVE PROPOSTE DAL GOVERNO, DA UNO O PIÙ
PARLAMENTARI, DA UNA REGIONE, DA UN COMITATO DI CITTADINI. IL GOVERNO, ENTRO 30
GIORNI DALLA LEGGE, EMANA I REGOLAMENTI ATTUATIVI DI CARATTERE FEDERALE. LE
REGIONI, ENTRO 30 GIORNI DALLA LEGGE, EMANANO I REGOLAMENTI ATTUATIVI DI
CARATTERE REGIONALE.
LA PRESENTE COSTITUZIONE SI
MODIFICA CON I 2/3 DEL VOTO DELL’ASSEMBLEA PLENARIA, COMPOSTA DAI MEMBRI DEL
PARLAMENTO, DEL GOVERNO E DAI PRESIDENTI DELLE GIUNTE E DEI CONSIGLI REGIONALI.
ESSA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE DEL SENATO.
Invece c'è chi vuole
solamente i meridionali: föra,o foeura, di ball.
L'Indipendentismo padano,
da
Wikipedia, l'enciclopedia libera. La bandiera della Padania proposta dalla Lega
Nord, con al centro il Sole delle Alpi. L'indipendentismo padano o
secessionismo padano è un'ideologia politica nata negli anni novanta del XX
secolo e promossa storicamente dal partito politico Lega Nord, che cita
testualmente nel proprio statuto l'indipendenza della Padania. L'ideologia è
stata sostenuta o è sostenuta anche da altri partiti, come la Lega Padana,
alternativa alla Lega Nord, da essi considerata filo-romana, e da figure,
afferenti nella loro storia politica alla Lega Nord, come lo scrittore Gilberto
Oneto, il politologo Gianfranco Miglio e Giancarlo Pagliarini. La Padania per
alcuni geografi economici di inizio Novecento, corrispondeva al territorio
italiano sito a nord degli Appennini. Gli indipendentisti padani di fine
Novecento affermano che un territorio comprensivo di gran parte dell'Italia
settentrionale (la Lega Padana teorizza una Padania formata da quattro nazioni:
Subalpina, Lombarda, Serenissima e Cispadana) o centro-settentrionale (la Lega
Nord estende più a sud tale confine), di estensione territoriale differentemente
definita dai partiti stessi, e da essi stessi ribattezzato "Padania" (toponimo
sinonimo di val padana, la valle del fiume Po, in latino Padus), sarebbe
abitato da popoli distinti per lingua, usi, costumi e storia, chiamati nazioni
della Padania e riconducibili, nelle loro differenze, a un unico popolo padano e
che sarebbero stati resi partecipi contro la loro volontà del Risorgimento e,
conseguentemente, dello Stato italiano; pertanto propugnano la secessione di
queste nazioni dalla Repubblica Italiana e la creazione di una repubblica
federale della Padania rispettosa delle peculiarità di ciascuna di esse. A
fronte di alcuni geografi che ad inizio XX secolo solevano dividere il Regno
d'Italia in Padania ed Appenninia, sino agli anni ottanta il termine Padania
era principalmente usato con significato geografico per la pianura Padana, ma
anche con accezione poetica, come dimostra l'opera dello scrittore Gianni Brera
e nell'ambito di studi linguistici ed etnolinguistici nonché socio-economici. Il
termine acquisisce, a cavallo tra gli anni ottanta e novanta, un significato
politico - ovverosia comincia a essere utilizzato per indicare la Padania come,
a seconda delle posizioni, reale o pretesa entità politica -, grazie al suo
utilizzo costante da parte degli esponenti e dei simpatizzanti del partito
politico Lega Nord, nato il 22 novembre 1989 dall'unione di vari partiti
autonomisti dell'Italia settentrionale originatesi nel decennio precedente, tra
i quali la Lega Lombarda, fondata il 10 marzo 1982 da Umberto Bossi, che diviene
guida del nuovo movimento politico. Grazie al successo politico del partito e ai
mezzi di comunicazione di massa, tale accezione politica del termine è entrata
da allora a far parte della lingua corrente e del dibattito politico. La Lega
propose inizialmente un'unione federativa della macro-regione Padania, dotata di
autonomia, con le restanti parti dello Stato italiano, come forma di
riconoscimento e tutela delle peculiarità etnico-linguistiche delle nazioni
della Padania. Fallito il progetto e raggiunto un successo elettorale
considerevole promosse il concetto di secessione della Padania dall'Italia,
proclamata il 15 settembre 1996 a Venezia. La secessione è stata,
successivamente al Congresso di Varese, messa parzialmente da parte a favore
della Devoluzione, ovverosia del trasferimento di parte significativa delle
competenze legislative e amministrative dallo Stato centrale alle regioni, e del
federalismo fiscale. Una prima riforma della costituzione verso una maggiore
autonomia delle regioni è stata approvata nel 2001. Una seconda riforma sempre
in questo senso del 2005 è stata invece bocciata con il referendum
costituzionale del 2006.
« Noi,
popoli della Padania, solennemente proclamiamo: la Padania è una Repubblica
federale indipendente e sovrana. Noi offriamo, gli uni agli altri, a scambievole
pegno, le nostre vite, le nostre fortune e il nostro sacro onore.»
(Umberto Bossi, dichiarazione d'indipendenza della Padania, 15 settembre 1996)
Il 15 settembre 1996 a
Venezia, nel corso di una manifestazione della Lega Nord, Umberto Bossi ha
proclamato, al culmine della politica secessionista del partito, l'indizione di
un referendum per l'indipendenza della Padania e ha battezzato il nuovo soggetto
istituzionale con il nome di Repubblica Federale della Padania. Il 25 maggio
1997 si è svolto il "Referendum per l'Indipendenza della Padania". Oltre al
SI/NO per il referendum, si è votato anche per il Presidente del "Governo
Provvisorio della Repubblica Federale della Padania" e per sei disegni di legge
di iniziativa popolare da presentare al Parlamento italiano. La Lega Nord ha
predisposto i seggi elettorali in tutti i Comuni della supposta Padania. La
Repubblica Federale della Padania non è stata mai riconosciuta formalmente da
alcuno stato sovrano, né dalle altre forze politiche italiane. L'unico supporto
in tal senso è venuto dal partito svizzero della Lega dei Ticinesi. In seguito
alla dichiarazione d'indipendenza furono avviate delle inchieste giudiziarie a
Venezia, Verona, Torino, Mantova e Pordenone per attentato all'unità dello
stato, poi archiviate, e si ebbero scontri tra forze dell'ordine e militanti
leghisti in Via Bellerio a Milano, sede della Lega Nord. Per quanto la
dichiarazione di secessione non abbia comportato la reale separazione della
Padania dall'Italia, la Lega Nord ha da allora promosso e continua a promuovere
attivamente la concezione della Padania come entità politica attraverso la
creazione e il mantenimento di strutture e organi rappresentativi delle
Nazioni della Padania nonché attraverso la promozione di iniziative sportive
e sociali di carattere indipendentista o quantomeno autonomista: ha costituito
un Governo padano con un proprio parlamento, ha designato Milano capitale
della Padania, il Va, pensiero di Giuseppe Verdi suo inno ufficiale, il
Sole delle Alpi verde in campo bianco sua bandiera ufficiale, il verde come
colore nazionale, ha creato le lire padane e i francobolli padani, una propria
Guardia Nazionale, un proprio ente sportivo riconosciuto nel CONI sport
Padania e, come organi di stampa ufficiali, il quotidiano La Padania, il
settimanale Il Sole delle Alpi, l'emittente radiofonica Radio Padania Libera e
l'emittente televisiva TelePadania. Vi fu anche la formazione spontanea,
tra i militanti leghisti, delle cosiddette camicie verdi. La Lega Nord ha
anche creato una Nazionale di calcio della Padania, non riconosciuta né a
livello italiano, né a livello internazionale. Questa selezione Padana ha vinto
per 3 volte consecutive il mondiale per le nazioni non riconosciute, la VIVA
World Cup, battendo la selezione del Samiland (2008), quella del Kurdistan
(2009) e quella della Lapponia (2010). Inoltre il partito padano sponsorizza il
concorso di bellezza Miss Padania, aperto a tutte le giovani donne residenti in
una regione della Padania da almeno 10 anni consecutivi e di età compresa tra i
17 e i 28 anni. Tra i requisiti necessari per partecipare al concorso vi è anche
l'obbligo di non rilasciare dichiarazioni non in linea con gli ideali dei
movimenti che promuovono la Padania. Nel 2009 la Lega Nord, in particolare
tramite Umberto Bossi, promosse la realizzazione del film storico Barbarossa,
coprodotto dalla Rai. Il film, incentrato sulle vicende della Lega Lombarda nel
XII secolo, non ebbe buon riscontro né di critica né di pubblico. Il 2011 ha
visto la prima edizione dell'evento ciclistico Giro di Padania. Il 26 ottobre
1997 la Lega Nord organizzò le prime elezioni per i 210 seggi del Parlamento
Padano. Circa 4 milioni di Italiani residenti nelle regioni settentrionali, 6
secondo il Partito, si recarono ai seggi e scelsero tra diversi partiti padani.
Il Parlamento della Padania, creato nel 1996 e oggi denominato Parlamento del
Nord, ha sede nella Villa Bonin Maestrallo di Vicenza, che ha sostituito
l'originale sede a Bagnolo San Vito in Provincia di Mantova. Si affianca al
Governo della Padania, con sede a Venezia, che, storicamente, è stato guidato
prima da Giancarlo Pagliarini (1996-97), da Roberto Maroni (1997-98), da Manuela
Dal Lago (1998-99) ed è attualmente guidato da Mario Borghezio (dal 1999).
Nell'esecutivo presieduto da Pagliarini, Fabrizio Comencini era Ministro degli
esteri, subito dimessosi fu sostituito da Enrico Cavaliere, Giovanni Fabris
della Giustizia, Alberto Brambilla del Bilancio e Giovanni Robusti, capo dei
Cobas del latte, dell'Agricoltura. Nel governo presieduto da Maroni, il cui vice
era Vito Gnutti, è stato introdotto un Ministero dell'Immigrazione, presieduto
da Farouk Ramadan. L'esecutivo guidato da Manuela Dal Lago comprendeva Giancarlo
Pagliarini come vice presidente e Ministro dell'Economia, Giovanni Fabris alla
Giustizia, Alessandra Guerra agli Esteri, Flavio Rodeghiero alla Cultura e
all'Istruzione, Giovanni Robusti all'Agricoltura, Roberto Castelli ai Trasporti,
Francesco Formenti all'Ambiente, Sonia Viale agli Affari Sociali e della
Famiglia, Alfredo Pollini, presidente della Guardia Nazionale Padana, alla
Protezione Civile, Francesco Tirelli, del CONI sport Padania, allo Sport e
Roberto Faustinelli, presidente di Eridiana Records, allo Spettacolo. Secondo
l'art. 2 dello Statuto 2012, la Lega Nord considera il Movimento come una
Confederazione delle Sezioni delle seguenti Nazioni: La Lega afferma dunque che
il progetto della Padania comprende tutte le otto regioni dell'Italia
settentrionale più le regioni dell'Italia centrale Toscana, Umbria e Marche,
mentre al 2011 la sua attività si è estesa anche in Abruzzo e Sardegna. Il
territorio rivendicato dalla Lega Nord come costituente la Padania comprende
160.908 km² di Italia, ossia il 53,39% del territorio dell'Italia (di 301.340
km²) e il 56,15% della sua popolazione (vedere tabella sottostante). Le
rivendicazioni politiche padane ricomprendono quindi un territorio maggiore di
quello riconducibile al significato geografico del termine Padania, che è
geograficamente riferito alla sola Pianura Padana. La linea apertamente
secessionista fatta propria dalla Lega Nord portò, tra il 1996 e il 2000, a un
isolamento del movimento nel panorama politico italiano, col risultato che,
nelle zone dove il radicamento leghista era minore, i suoi candidati alle
elezioni amministrative erano nettamente svantaggiati rispetto a quelli di
centrodestra e di centrosinistra, generalmente appoggiati da più liste. Per
cercare di rimediare a questa situazione, nel settembre del 1998 Bossi lanciò il
cosiddetto Blocco padano, una coalizione formata dalla Lega Nord con
diverse liste in rappresentanza di varie categorie sociali e produttive del
territorio. Già alle elezioni amministrative dell'aprile 1997 altre liste che si
richiamavano apertamente all'indipendentismo avevano affiancato la Lega Nord:
Agricoltura padana; Lavoratori padani; Padania pensione sicura; Non chiudiamo
per tasse! - Artigianato, commercio, industria. Il risultato di queste liste fu
complessivamente molto modesto, e nella maggior parte dei casi esse non
riuscirono a portare i candidati leghisti al ballottaggio. Le ultime tre liste
ottennero complessivamente l'1,1% al comune di Milano e lo 0,8% al comune di
Torino. L'Agricoltura padana ebbe l'1,9% alla provincia di Pavia e i Lavoratori
padani lo 0,9% alla provincia di Mantova. Un risultato di un certo rilievo fu
però ottenuto dai Lavoratori padani nell'autunno dello stesso anno al comune di
Alessandria, dove con il 4,4% contribuirono alla rielezione del sindaco uscente
Francesca Calvo ed ebbero diritto a tre consiglieri. Nel 1998 il Blocco padano,
di cui il coordinatore doveva essere il parlamentare europeo ed ex sindaco di
Milano Marco Formentini, fu annunciato come costituito fondamentalmente da
cinque partiti, oltre alla Lega: Terra (evoluzione di Agricoltura padana, con a
capo Giovanni Robusti, portavoce dei Cobas del latte); Lavoratori padani;
Pensionati padani (evoluzione di Padania pensione sicura, con a capo Roberto
Bernardelli); Imprenditori padani (evoluzione di Non chiudiamo per tasse!);
Cattolici padani (già presentatosi alle elezioni per il Parlamento della Padania
del 1997, con a capo Giuseppe Leoni). A questi si unirono a seconda dei casi
anche liste civiche di portata locale, che talvolta ebbero maggior fortuna: a
Udine Sergio Cecotti raggiunse il ballottaggio e fu poi eletto sindaco grazie
all'apporto di due liste civiche, senza che i partiti "regolari" del Blocco
padano fossero presenti. La coalizione nel suo complesso risentì del calo di
consensi generalizzato subito dalla Lega Nord, tanto che dopo il 1999 non fu più
ripresentata se non in maniera sporadica, anche perché la Lega Nord, entrando a
pieno titolo nella Casa delle Libertà, trovò alleati di maggiore consistenza
elettorale.
Lega secessionista: ora vuole
il Veneto indipendente, scrive "Globalist". L'1 e il 2 marzo 2014 i gazebo per
la raccolta firme. Dopo oltre vent'anni di lotta per la Padania, ancora in
Italia, ora il Carroccio riparte dal Nord Est.
Che la voglia di secessione della Lega non si sia mai placata, è
cosa nota. A volte viene messa da parte, per lasciare spazio ad altre battaglie
come quella contro l'euro o contro lo ius soli, ma comunque è sempre lì, appesa
alla mente del segretario Matteo Salvini e dei suoi compagni. E così ogni tanto
torna a galla, come in questi giorni. E se tutto il Nord non si può staccare,
almeno ci si può provare con una sua parte. Come il Veneto, ad esempio. "La Lega
corre, la Lega c'è. La voglia d'indipendenza è tanta, sia da Roma, sia da
Bruxelles" ha detto Salvini, intervendo a Verona con i vertici regionali del
Carroccio per presentare la raccolta firme per il referendum per l'indipendenza
del Veneto, che si terrà sabato e domenica in tutta la regione. "L'indipendenza
da Bruxelles - ha aggiunto - è necessaria perchè fuori dall'euro riparte la
speranza, riparte il lavoro, ripartono gli stipendi. L'indipendenza da Roma
perchè sostanzialmente l'Italia ormai è un Paese fallito". Ogni anno, è la
considerazione del segretario, "il Veneto regala 21 miliardi allo stato italiano
ricevendo in cambio servizi da poco o niente". Dopo oltre 20 anni di tentativi
secessionisti, dunque, la Lega riparte dal Nord-Est. Perché magari, potrebbe
essere il pensiero, l'indipendenza si può ottenere a piccoli passi visto che la
Padania, nonostante il loro impegno, continua a restare in Italia. "I veneti
sono uniti da una lingua e da una cultura e hanno diritto alla propria
autodeterminazione - ha detto la senatrice leghista, Emanuela Munerato -. Solo
compatti e votando sì a questo referendum potremo fare scuola e aprire la strada
anche alle altre regioni decretando l'inizio della fine del centralismo romano
che sta uccidendo la nostra cultura e la nostra economia".
Non solo legisti.....
Grillo chiama
gli italiani alla secessione.
Sul suo blog il comico contro «l'arlecchinata» dei mille popoli,
scrive Barbara Ciolli “Lettera 43”. Altro che Lega Nord, anche Beppe Grillo,
leader del Movimento 5 Stelle, archiviate le espulsioni dal partito, grida alla
secessione. Peggio ancora, al big bang, all'«effetto domino di un castello di
carta», alla diaspora dei mille «popoli, lingue e tradizioni che non hanno più
alcuna ragione di stare insieme» e «non possono essere gestiti da Roma».
«Un'arlecchinata» bella e buona, a detta del comico ligure che ha postato sul
suo blog l'ennesima e forse maggiore provocazione: «E se domani l'Italia si
dividesse, alla fine di questa storia, iniziata nel 1861, funestata dalla
partecipazione a due guerre mondiali e a guerre coloniali di ogni tipo, dalla
Libia all'Etiopia» scrive il Beppe, suo malgrado, nazionale, parafrasando
ironicamente - e populisticamente - la canzone di Mina? Sotto, il testo apparso
l'8 marzo 2014 in Rete: «Italia, incubo dove la democrazia è scomparsa. Non può
essere gestita da Roma». «Quella iniziata nel 1861 è una storia brutale, la cui
memoria non ci porta a gonfiare il petto, ma ad abbassare la testa. Percorsa da
atti terroristici inauditi per una democrazia assistiti premurosamente dai
servizi deviati (?) dello Stato. Quale Stato? La parola "Stato" di fronte alla
quale ci si alzava in piedi e si salutava la bandiera è diventata un ignobile
raccoglitore di interessi privati gestito dalle maitresse dei partiti. E
se domani, quello che ci ostiniamo a chiamare Italia e che neppure più alle
partite della Nazionale ci unisce in un sogno, in una speranza, in una qualunque
maledetta cosa che ci spinga a condividere questo territorio che si allunga nel
Mediterraneo, ci apparisse per quello che è diventata, un'arlecchinata di
popoli, di lingue, di tradizioni che non ha più alcuna ragione di stare insieme?
La Bosnia è appena al di là del mare Adriatico. Gli echi della sua guerra civile
non si sono ancora spenti. E se domani i Veneti, i Friulani, i Triestini, i
Siciliani, i Sardi, i Lombardi non sentissero più alcuna necessità di rimanere
all'interno di un incubo dove la democrazia è scomparsa, un signore di
novant'anni decide le sorti della Nazione e un imbarazzante venditore pentole si
atteggia a presidente del Consiglio, massacrata di tasse, di burocrazia che ti
spinge a fuggire all'estero o a suicidarti, senza sovranità monetaria,
territoriale, fiscale, con le imprese che muoiono come mosche. E se domani,
invece di emigrare all'estero come hanno fatto i giovani laureati e diplomati a
centinaia di migliaia in questi anni o di "delocalizzare" le imprese a migliaia,
qualcuno si stancasse e dicesse "Basta!" con questa Italia, al Sud come al Nord?
Ci sarebbe un effetto domino. Il castello di carte costruito su infinite leggi e
istituzioni chiamato Italia scomparirebbe. È ormai chiaro che l'Italia non può
essere gestita da Roma da partiti autoreferenziali e inconcludenti. Le regioni
attuali sono solo fumo negli occhi, poltronifici, uso e abuso di soldi pubblici
che sfuggono al controllo del cittadino. Una pura rappresentazione senza
significato. Per far funzionare l'Italia è necessario decentralizzare poteri e
funzioni a livello di macroregioni, recuperando l'identità di Stati millenari,
come la Repubblica di Venezia o il Regno delle due Sicilie. E se domani fosse
troppo tardi? Se ci fosse un referendum per l'annessione della Lombardia alla
Svizzera, dell'autonomia della Sardegna o del congiungimento della Valle d'Aosta
e dell'Alto Adige alla Francia e all'Austria? Ci sarebbe un plebiscito per
andarsene. E se domani...» Si attendono reazioni.
ADDIO AL SUD.
"Addio al sud" di Angelo
Mellone, scrive Paolo Tripaldi su “Il Corriere Romano”. Verrà un giorno in cui
tutti i meridionali d'Italia, sparsi un po' ovunque, faranno rientro in patria
per sconfiggere definitivamente tutti i mali che hanno affossato per anni il
Sud. "Addio al Sud", poema dello scrittore tarantino Angelo Mellone, non è una
resa bensì una voglia di rinascita, una chiamata alle armi contro il Sud malato
e incapace di riscatto. Un poema che parla al cuore e allo stomaco di ogni
meridionale e che cerca di farla finita con ogni stereotipo, con il piangersi
addosso e con il pensare che le colpe siano sempre degli altri. "Il punto di
vista di questa voce narrante - scrive Andrea Di Consoli nella prefazione di
Addio al Sud - è il punto di vista di chi è scampato a un naufragio, cioè di
chi, senza sapere bene da cosa, si è salvato da un male ineffabile". Mellone ci
ricorda però che anche se lontani il Sud continua a chiamare: "Tu, chiunque
sarai, i vestiti e i profumi e l'accento che saprai sfoggiare, sempre da lì
vieni. Da lì. Lì dove la salsedine non dà tregua e l'umido fa sudare d'inverno e
sconfigge qualsiasi acconciatura e il sole, quando c'è, e si fa tramonto, ti
uccide di bellezza". Lo sapeva bene Leonida di Taranto, poeta del III secolo
a.c., che aveva scelto l'esilio dalla propria patria per non essere schiavo dei
romani e che aveva scritto in un suo celebre epitaffio: "riposo molto lontano
dalla terra d'Italia e di Taranto mia Patria e ciò m'è più amaro della morte".
L'Addio al Sud di Angelo Mellone è un addio ai mali del meridione: alla
criminalità, all'assistenzialismo, alla industrializzazione selvaggia che ha
inquinato i territori, al nuovo fenomeno del turismo predatorio. E' un invito
anche ad abbandonare il 'pensiero meridiano' del sociologo Franco Cassano.
"Smettiamola con la follia del pensiero meridiano - scrive Mellone - questa
scemenza dell'attesa, dell'andare lento, della modernità differente, della
sobrietà della decrescita", tutte scusanti "al difetto meridionale dell'amor
fati". Mellone passa in rassegna tutti gli episodi che negli ultimi anni hanno
affossato ancora di più il Sud: il fenomeno del caporalato, i fatti di Villa
Literno, gli omicidi di camorra. Il racconto ci consegna immagini di una
sottocultura del sud che partendo dall'omicidio di Avetrana giunge fino ai
fenomeni populisti di Luigi de Magistris e Nichi Vendola. "Voglio tornare a Sud
a fare la guerra - scrive Angelo Mellone - senza quartiere, senza paese, senza
tregua, senza compromessi, con le micce del carbonaro di patria folle, con le
ruspe spianando strade a un esercito che si tiene per mano, con la sola divisa
dipinta dell'amore infedele che testardamente continui ad amare”. Addio al Sud,
che nel sottotitolo e’ chiamato “un comizio furioso del disamore”, è in realtà
un atto d’amore per una terra che è sempre nel centro del cuore.
Perché è impossibile dire
addio al Sud.
Il Meridione ha ancora la forza per rialzarsi, scrive Aldo Cazzullo su “Il
Corriere della Sera”. Di Sud, in Italia, si parla tanto e si ragiona
poco. E così le domande che si ponevano i grandi meridionalisti - i Cuoco, i
Salvemini, i Fortunato - da decenni restano senza risposta: perché il Meridione
italiano, terra di assoluta bellezza e di immense potenzialità, continua a
galleggiare nel sottosviluppo e non impedire che i suoi figli migliori, quelli
che Piercamillo Falasca ha definito «Terroni 2.0», facciano la valigia per
emigrare (anche con un pizzico di risentimento)? A questa domanda prova a
rispondere un poema civile scritto da Angelo Mellone, Addio al Sud,
definito nel sottotitolo «un comizio furioso del disamore» (Irradiazioni, pp.
80, 8, prefazione di Andrea Di Consoli), una sorta di orazione civile tecno-pop
congegnata come reading teatrale. Mellone ribalta due cliché dominanti. Il primo
è quello del brigantaggio: qui l'autore trova il coraggio, da meridionale, di
ammettere - in quanto «fottuto nazionalista» - che avrebbe scelto di arruolarsi
con l'esercito italiano per combattere i Carmine Crocco e i Ninco Nanco, per
«piantare tricolori su antiche maledizioni». Il secondo oggetto polemico di
Addio al Sud è il nuovo meridionalismo, ovvero quel «pensiero meridiano»
- sostenuto, ad esempio, dal sociologo Franco Cassano - che vorrebbe un Sud
lento, sobrio, canicolare, che cammina a piedi e ammicca al mito della
decrescita o all'idea del Meridione italiano come avanguardia di un'improbabile
«alternativa allo sviluppo». Al contrario, il Sud di Mellone anela alla
velocità, alla modernità, sia pure a una modernità intrisa di miti antichi e di
antichi caratteri comunitari. Scrive Di Consoli nella prefazione: «Questo
poema è, in definitiva, una dolorosa "possibilità di prendere congedo", ma è
anche una possibilità della rifondazione di un patto "oscuro", ancestrale, e che
dunque può essere tramandato nei tempi come accade in tutte le comunità che
hanno conosciuto la diaspora, o il suo fantasma». Mellone infatti non sigla una
lettera di abbandono dall'identità meridionale, ma rilancia la sfida immaginando
che il Sud migliore - emigrato ovunque negli ultimi anni - a un certo punto
decida di tornare a casa. In quel momento, dice l'autore, il Sud potrà
finalmente essere salutato:
«Finita la guerra prenderò
congedo
e solo allora dirò a mia
figlia
e solo allora dirò a mio
figlio:
tu questo sei.
Anche tu porti cenere,
ulivo e salsedine.
Adesso anche tu vieni da
Sud».
Quasi un congedo militare,
anche se "i fuoriusciti" e i figli saranno chiamati, allorquando terminerà la
fatica di Sisifo dell'eterno rientro - che è quasi un giorno d'attesa biblica -
a una guerra civile contro il male del Sud: il fatalismo, il degrado, l'incuria
del territorio, la dissoluzione del legame sociale, l'accettazione di un modello
predatorio di turismo che rischia di distruggere nel breve periodo le bellezze
meridionali. Difficile da argomentare, ma questo testo è un "addio" ed è
anche un foglio di chiamate alle armi, e in questa contraddizione c'è tutta la
modernità della posizione ineffettuale, e dunque estetizzante, di Mellone, che
alla maniera di Pasolini si considera, rispetto al Sud, «con lui e contro di
lui». Il suo è un appassionato "addio" al Mezzogiorno del rancore, della
malavita, dell'inciviltà, della subcultura televisiva. È però anche un disperato
e struggente ricordo di una giovinezza meridionale, al cui centro c'è Taranto,
della quale Mellone ricorda le icone (il calciatore Erasmo Jacovone), le
tragedie (l'Ilva, la mattanza criminale degli anni '80), gli aspetti più
"privati" (la prematura morte del padre, la vendita della casa di famiglia). La
narrazione scorre per icone, fotogrammi, eventi: dal delitto di Avetrana al
matrimonio di Sofia Coppola, dai nuovi populismi (Vendola, de Magistris) alla
camorra, dal caso Claps alla piaga del caporalato, Mellone attraversa e
scandaglia con straordinaria velocità, e con alternarsi di registro basso e
alto, l'immaginario contemporaneo collettivo del Meridione. Scrive per esempio
su Sarah Scazzi: «Prendete tutta questa pornografia dell'incubo d'amore
simboleggiata dallo scarto incolmabile tra il viso di Sarah Scazzi e il
piercing, ripeto: il piercing, della cugina culona Sabrina Misseri di anni venti
e due che forse a Taranto e nemmeno a Lecce sarà mai andata ma a Uomini e donne
ha conosciuto il piercing che al padre dovrà essere parso roba da bestie
all'aratro e non da esseri umani oggi le borgate di Pasolini sono i paesi del
Sud in entroterra come Avetrana, tuguri dischiusi al mondo solo grazie
all'antenna parabolica». Pugliese trapiantato a Roma, giornalista,
scrittore, ora dirigente Rai, Angelo Mellone fa parte di quella generazione nata
nei primi anni ’70 che da un giorno all’altro si sono ritrovati senza luoghi del
dibattere e del confronto. Caduti i muri e le cortine, con essi sono crollati
anche le sezioni e i partiti, luoghi simbolo del confronto e della sfida
dialettica. E per chi aveva qualcosa da dire o da scrivere la strada è
improvvisamente diventata ripida e scoscesa. Ma impegno e determinazione
premiano sempre e se i luoghi non esistono, chi vuol farcela se li crea. La
notorietà raggiunta nella capitale non gli ha fatto dimenticare le origini
pugliesi, tarantine per la precisione. Una città che negli ultimi anni è balzata
agli onori delle cronache prima per un tremendo dissesto di bilancio, poi per
una sconsiderata gestione degli impianti industriali presenti sul territorio. E
per dimostrare l’amore a l’attaccamento alla sua terra, Mellone ha ideato e
messo in scena due monologhi poetici che andranno a far parte di una trilogia
dedicata a Taranto: “Addio al Sud” e “Acciaiomare”. Quest’ultimo in particolare
è una lunga requisitoria, (J’accuse!, direbbe Zola) nei confronti di un lembo di
terra che oltre ad avergli offerto la vita lo ha costretto troppo presto a fare
i conti con la morte. Ma quello scritto e cantato per la città di Taranto
rimanendo pur sempre un eroico canto d’amore. «Acciaiomare. Il canto
dell’industria che muore» (Marsilio Editore), tributo di amore e rabbia verso la
propria terra martoriata. Un racconto impetuoso e rutilante, dedicato ai 500
caduti del siderurgico di Taranto, che diventa anche l’occasione per un reading
teatrale che, mescolando parole, musica, immagini e rumori industriali, alza il
sipario sull’industria morente del Sud che ha nell’ILVA il suo occhio del
ciclone. Con lui sul palco, Raffaella Zappalà, Dj set Andrea Borgnino e Video di
Marco Zampetti. Dopo il successo di «Addio al Sud. Un comizio furioso del
disamore», Angelo Mellone scrive il secondo capitolo di una trilogia sulla sua
terra, sempre nella forma di monologo poetico, di comizio civile e lirico.
«AcciaioMare» è, in particolare, un canto funebre e peana d’amore, ma anche
requisitoria e arringa al tempo stesso, invettiva ed engagez-vous, per un Sud e
per una città (Taranto) al centro di uno dei più grandi casi
economico-industriali al mondo. Mellone, in un caleidoscopio di immagini e
ricordi, di luoghi e persone, di visioni ed emozioni, «scioglie all’urna un
cantico» che ha la rabbia di una rivendicazione e l’amore di un figlio, il
respiro della planata e la precisione del colpo secco. Perché "acciaio" a
Taranto vuol dire tante, troppe cose, per chi ci vive e per chi da lì proviene.
Lo scrittore (anche giornalista e dirigente di Radio Rai) concluderà la sua
trilogia nel 2014, ma questo suo secondo lavoro è senz’altro quello più
«doloroso»: con queste pagine Mellone si augura, infatti, di risvegliare «un
minimo di coscienza» sul dramma del declino industriale italiano, nell’illusione
di trasformare il Belpaese in una nazione di terziario avanzato, dimenticando
così la Fabbrica e gli operai. Ma ora quei 500 e più eroi e martiri dell’acciaio
(tra i quali c’è anche il papà di Mellone) hanno grazie a questo libro il loro
"canto corale" e un sentito risarcimento alla loro memoria. Pagine toccanti
dedicate soprattutto a suo padre, che Mellone accende di passione e rabbia,
laddove racconta «di quando acciaio chiamava mare e su questa costa di Sparta
nasceva l’industria della navi d’Impero e dei toraci siderurgici. Voglio
raccontarti una storia d’amore. D’amore che muore». Così, che lo scorso mese
d’agosto 2013 Mellone prese subito le difese «di un orgoglio siderurgico
impacchettato in fretta e furia» per far posto «all’ondata
ambientalqualunquista». E trasfromò le sue vacanze in un’indagine del suo
passato. C’era una volta un ragazzino che quando a pranzo c’erano fave e cicoria
restava digiuno. Sua madre voleva a tutti costi che le mangiasse, altrimenti
pancia vuota. Oggi quel ragazzino mangerebbe tutti i giorni a pranzo e a cena il
piatto principe della cucina pugliese. Che cosa è cambiato? Del piatto nulla,
solo che allora gli era imposto oggi è una libera scelta.
Il vero Sud lo riscopri
solo dal finestrino del treno. "Meridione a rotaia".
Angelo Mellone conclude la sua trilogia lirica sul Meridione italiano, giungendo
anche all’ultima fermata di un viaggio che è un canto appassionato e dolente, ma
al tempo stesso un grido di rabbia, per la sua terra.
Un ritorno nella propria terra, che è stata abbandonata anni prima con rabbia.
Un ritorno a Meridione, compiuto con il mezzo che più associamo al viaggio: il
treno. Sui treni sono partiti i primi emigrati meridionali, sulle carrozze di
treni locali scassati, regionali in perenne ritardo, Intercity improbabili,
l’Autore fa macchina indietro e, da Roma, arriva a Taranto. In mezzo a partenza
e arrivo si alternano situazioni grottesche, aneddoti, ricordi, memorie
dolorose, persino una pagina dedicata ai fanti meridionali mandati al massacro
nella Prima guerra mondiale. Tutte queste pagine, che Mellone ci regala con lo
stile consueto delle sue “orazioni civile”, accostano il tema tradizionale del
ritorno a quello, nuovo per l’autore, di una riflessione sull’amore, che viaggia
a ritroso attraverso due figure femminili e una singolare disquisizione sui
tacchi... E dunque, se l’amore è contesto, radici, terra, e «Meridione tiene
sempre i piedi per terra», per trovare amore autentico a Sud bisogna tornare. E
questo fa, Meridione a rotaia, nelle scorribande tra paesini, locomotori diesel,
vagoni stipati di varia umanità, stazioni metropolitane e stazioncine di
montagna. Offrendo, alla fine, un affresco di meridionalità divertente,
surreale, commuovente. Un tempo si
tornava in rotaia per restare, oggi per ripartire. Ma il lento viaggio verso
casa porta alle radici e invita a trovare la propria strada, scrive
Giuseppe De Bellis su "Il Giornale". I treni che vanno a Sud sono diversi.
D'aspetto, d'odore, d'umore. Non hanno niente di professionale. Non hanno
cravatte e collane di perle. Il professionista che dal Nord sale su un treno
verso casa, la vecchia casa del padre, è come Clark Kent che toglie l'abito di
Superman. Via il vestito da lavoro nobile, su quello dell'essere umano così
com'è. Perché è un viaggio nell'anima, quello che si sta per fare. È incredibile
quanto il ritorno a Sud sia ancora nel 2014 legato al treno. Controintuitivo e
persino antistorico. Da Milano a Bari ci vogliono più di otto ore, contro un'ora
e un quarto d'aereo. Da Roma a Reggio Calabria, sei ore di treno contro le...
Eppure chi è del Sud sa che in una conversazione con un altro meridionale
arriverà a questo punto. - «Sai che “vado giù?”? Solo sabato e domenica». -
«Come, ti fai tutto quel viaggio in treno per stare solo due giorni?». Il
viaggio in treno è dato per scontato, perché ancestralmente è ormai sinonimo di
trasferimento Nord-Sud. Puoi «salire» come vuoi, ma sembra che tu debba sempre
«scendere» in treno. Perché è ricordo, memoria, passato che torna, è emigrazione
e immigrazione. Noi terroni siamo legati alla ferrovia anche al di là della
nostra volontà. Angelo Mellone lo sa perché appartiene alla categoria:
professionista meridionale che per obbligo, passione e capacità è stato
costretto a lasciare casa e andare verso Nord. Ha portato la testa e il corpo a
Roma, ha mantenuto l'anima a Taranto. È uno degli intellettuali sudisti che
meglio ha raccontato in questi ultimi anni la nuova questione meridionale,
espressione tanto abusata quanto inevitabile. Lo fa anche ora, con il suo
Meridione a rotaia (Marsilio, pagg. 92, euro 10), che chiude quella che lui
stesso ha definito «trilogia delle radici». Il treno è il mezzo per tornare e
tornando raccontare che cos'è il Sud e soprattutto com'è il rapporto tra quelle
radici e chi le ha dovute lasciare superficialmente e poi scopre di avercele
comunque attaccate al corpo e allo spirito: «Noi meridionali siamo fatti così.
Amiamo la terra che abbiamo abbandonato quando la lasciamo, e la odiamo se ci
costringe a restare o ci rende impossibile partire. In questo ha ragione Mario
Desiati: la letteratura presuppone sempre una partenza. Un momento di
straniamento, un distacco, una mancanza. Nel mio caso un'irrequietezza che è
tutto il mio riassunto di meridionale atipico, innamorato di una terra ma
distante, antropologicamente, dall'“andare lento” meridionalista. Preferisco
viaggiare, consumare suole e bruciare le radici che poi voglio conservare. In
questo sentimento pendolare sta il senso di Meridione a rotaia. Che è, a suo
modo, un ritorno. Un viaggio a ritroso trasognato, surreale, infelice, virile,
spavaldo, intimista, appresso alla memoria, dove si incontrano donne, amici,
nemici, loschi figuri, personaggi improbabili, odori, panorami, sfondi e valigie
di ricordi». Mellone parte da una casa posticcia di Roma per tornare a Taranto,
dove è nato, cresciuto, l'Ilva gli ha tolto il padre, dandogli un dolore che
nessuno potrà mai placare, ma nonostante il quale non ha ceduto all'idea che
quello stabilimento fosse solo morte e non anche vita per tanta gente. È lì che
torna a bordo di questo treno che è reale e onirico allo stesso tempo. Sceglie
la formula del poema per rendere magico e però duro questo viaggio. Cita luoghi,
paesaggi, facce, pensieri che sono familiari a ciascun meridionale che quel
viaggio l'ha fatto davvero o anche con la fantasia. Perché è un dovere tornare,
anche quando non si ha voglia. Perché è inevitabile farlo. Un viaggio che non è
come gli altri, perché non porta a scoprire nulla che non si sappia già, ma è un
modo per trovare la strada. La propria: «Meridione restituisce sempre/ ciò che
avevi smarrito...». «Ritorno a Sud allora/ è condizione necessaria/ polvere a
polvere, sasso a sasso/ tratturo a tratturo, chianca a chianca/ complanare a
complanare, binario a binario specialmente/ al momento in cui il corpo sudato/
in discesa puzza/ e l'alito impasta/ la lingua assetata/ per riacciuffare i
brandelli di tutto quello/ che ho abbandonato». È un libro malinconico, come
dice Mellone, è l'ammissione della sconfitta di chi ha combattuto se stesso
pensando di poter essere meridionale senza fare ritorno al Sud. Ecco, dal Sud
non si può scappare, anche quando si emigra: te lo porti dentro esattamente come
i settentrionali si portano dentro il Nord. Ciò che contraddistingue le nuove
generazioni di fuggiaschi da una terra che non può dare non perché non abbia, ma
perché è schiava dei propri vizi, è un orgoglio differente: prima si tornava per
rimanere, per dire «ce l'ho fatta, ho combattuto lontano, ho vinto, adesso torno
dalla mia amata». Era lo stesso spirito di un soldato mandato al fronte con
l'unico obiettivo di riabbracciare una ragazza diventata donna o bambini
diventati adolescenti. Ora si torna per ripartire, per tenersi agganciati,
emigrati con l'elastico che ti riporta indietro fisicamente o idealmente. La
sconfitta di Mellone è in un certo senso una vittoria. Perché ammettere di non
riuscire a sganciarsi dalle proprie radici è una forza spacciata per debolezza
solo per un gioco di forze che fa leva sulla maledizione della nostalgia. Si
perde se si rincorre il Sud come passato, si vince se il Sud è vissuto oggi come
consapevolezza di non poterne fare a meno. Accettare di essere comunque terrone
a qualunque latitudine. Il treno porta giù, un altro mezzo ti può portare in
qualunque altro luogo senza farti dimenticare chi sei e da dove vieni. A chi
appartieni? Così si dice al Sud quando ti chiedono chi sia la tua famiglia. È
un'espressione meravigliosa: si appartiene a qualcuno, si appartiene anche ai
luoghi che vivono dentro di te. «Amore fatto di terra», dice Mellone. «Amore per
la terra».
Ciononostante i nordisti,
anzichè essere grati al contributo svolto dagli emigrati meridionali per il loro
progresso sociale ed economico, dimostrano tutta la loro ingratitudine.
FENOMENOLOGIA RANCOROSA
DELL’INGRATITUDINE.
“Ingrati. La sindrome
rancorosa del beneficiato”.
Libro di Maria Rita Parsi, Mondadori 2011. Cos'è la "sindrome rancorosa del
beneficato"? Una forma di ingratitudine? Ben di più. L'eccellenza
dell'ingratitudine. Comune, per altro, ai più. Senza che i molti ingrati
"beneficati" abbiano la capacità, la forza, la decisionalità interiore, il
coraggio e, perfino, l'onestà intellettuale ed etica di prenderne atto. La
"sindrome rancorosa del beneficato" è, allora, quel sordo, ingiustificato
rancore (il più delle volte covato inconsapevolmente; altre volte, invece,
cosciente) che coglie come una autentica malattia chi ha ricevuto un beneficio,
poiché tale condizione lo pone in evidente "debito di riconoscenza" nei
confronti del suo benefattore. Un beneficio che egli "dovrebbe" spontaneamente
riconoscere ma che non riesce, fino in fondo, ad accettare di aver ricevuto. Al
punto di arrivare, perfino, a dimenticarlo o a negarlo o a sminuirlo o,
addirittura, a trasformarlo in un peso dal quale liberarsi e a trasformare il
benefattore stesso in una persona da dimenticare se non, addirittura, da
penalizzare e calunniare. Questo nuovo libro di Maria Rita Parsi parla
dell'ingratitudine, quella mancanza di riconoscenza che ognuno di noi ha
incontrato almeno una volta nella vita. Attraverso una serie di storie
esemplari, l'analisi delle tipologie di benefattori e beneficati, il decalogo
del buon benefattore e del beneficato riconoscente e un identikit interattivo,
l'autrice insegna a riconoscere l'ingratitudine e a difendersene, arginare i
danni e usarla addirittura per rafforzarsi.
La culla dell'ingratitudine.
Quand’è che proviamo riconoscenza per qualcuno? A prima vista diremmo che la
proviamo verso tutti coloro che ci hanno aiutato, ma non è così. Quelli che si
amano non la provano, scrive Francesco Alberoni su “Il Giornale”. Quand’è
che proviamo riconoscenza per qualcuno? A prima vista diremmo che la proviamo
verso tutti coloro che ci hanno aiutato, ma non è così. Quelli che si amano non
la provano. Pensate a due innamorati. Ciascuno fa tutto quello che può per
l’amato ma nessuno sente un debito di riconoscenza. Chi si ama non tiene una
contabilità del dare e dell’avere: i conti sono sempre pari. Solo quando l’amore
finisce riappare la contabilità e ciascuno scopre di aver dato più di quanto non
abbia ricevuto. Però anche fra innamorati ci sono dei momenti in cui il tuo
amato ti dona qualcosa di straordinario, qualcosa che non ti saresti mai
aspettato ed allora ti viene voglia di dirgli un «grazie» che è anche
riconoscenza. Insomma la riconoscenza nasce dall’inatteso, da un «di più».
Perciò la proviamo spesso verso persone con cui non abbiamo nessun rapporto ma
che ci fanno del bene spontaneamente. Per esempio a chi si getta in acqua per
salvarci rischiando la vita, a chi ci soccorre in un incidente, a chi ci cura
quando siamo ammalati. Ma anche a chi ci aiuta a scoprire e a mettere a frutto i
nostri talenti nel campo della scienza, dell’arte, della professione per cui,
quando siamo arrivati, gli siamo debitori. La riconoscenza è perciò nello stesso
tempo un grazie e il riconoscimento dell'eccellenza morale della persona che ci
ha aiutato. Quando proviamo questo sentimento, di solito pensiamo che durerà
tutta la vita, invece spesso ce ne dimentichiamo. E se quella persona ci ha
fatto veramente del bene allora la nostra è ingratitudine. Ma la chiamerei una
ingratitudine leggera, perdonabile. Perché purtroppo c’è anche una ingratitudine
cattiva, malvagia. Vi sono delle persone che, dopo essere state veramente
beneficiate, anziché essere riconoscenti, provano del rancore, dell’odio verso i
loro benefattori. Ci sono allievi che diventano i più feroci critici dei loro
maestri e dirigenti che, arrivati al potere diffamano proprio chi li ha
promossi. Da dove nasce questa ingratitudine cattiva? Dal desiderio sfrenato di
eccellere. Costoro pretendono che il loro successo sia esclusivamente merito
della propria bravura e si vergognano ad ammettere di essere stati aiutati. Così
negano l’evidenza, aggrediscono il loro benefattore. E quanti sono! State
attenti: quando sentite qualcuno diffamare qualcun altro, spesso si tratta di
invidia o di ingratitudine malvagia. Guardatevi da questo tipo di persone.
QUALCHE PROVERBIO AFORISMO
Amico beneficato, nemico
dichiarato.
Avuta la grazia, gabbato lo
santo.
Bene per male è carità, male
per bene è crudeltà.
Chi non dà a Cristo, dà al
fisco.
Chi rende male per bene, non
vedrà mai partire da casa sua la sciagura.
Comun servizio ingratitudine
rende.
Dispicca l’impiccato,
impiccherà poi te.
Fate del bene al villano, dirà
che gli fate del male.
Il cane che ho nutrito è quel
che mi morde.
Il cuor cattivo rende
ingratitudine per beneficio.
Il mondo ricompensa come il
caprone che dà cornate al suo padrone.
L’ingratitudine converte in
ghiaccio il caldo sangue.
L’ingratitudine è la mano
sinistra dell’egoismo.
L’ingratitudine è un’amara
radice da cui crescono amari frutti.
L’ingratitudine nuoce anche a
chi non è reo.
L’ingratitudine taglia i nervi
al beneficio.
Maledetto il ventre che del
pan che mangia non si ricorda niente.
Non c’è cosa più triste sulla
terra dell’uomo ingrato.
Non far mai bene, non avrai
mai male.
Nutri il corvo e ti caverà gli
occhi.
Nutri la serpe in seno, ti
renderà veleno.
Quando è finito il raccolto
dei datteri, ciascuno trova da ridire alla palma.
Render nuovi benefici
all’ingratitudine è la virtù di Dio e dei veri uomini grandi.
Tu scherzi col tuo gatto e
l’accarezzi, ma so ben io qual fine avran quei vezzi
Val più un piacere da farsi
che cento di quelli fatti.
In amore, chi più riceve, ne è
seccato: egli prova la noia e l’ingratitudine di tutti i ricchi.
Philippe Gerfaut
L’ingratitudine è sempre una
forma di debolezza. Non ho mai visto che uomini eccellenti fossero ingrati.
Johann Wolfgang Goethe,
Massime e riflessioni, 1833 (postumo)
Spesso l’ingratitudine è del
tutto sproporzionata al beneficio ricevuto.
Karl Kraus,
Di notte, 1918
Ci sono assai meno ingrati di
quanto si creda, perché ci sono assai meno generosi di quanto si pensi.
Charles de Saint-Evremond,
Sugli ingrati, XVII sec.
Il cuore dell’uomo ingrato
somiglia alle botti delle Danaidi; per quanto bene tu vi possa versare dentro,
rimane sempre vuoto.
Luciano di Samosata,
Scritti, II sec.
Un solo ingrato nuoce a tutti
gli infelici.
Publilio Siro,
Sentenze, I sec. a.c.
Quando di un uomo hai detto
che è un ingrato, hai detto tutto il peggio che puoi dire di lui.
Fenomenologia rancorosa
dell'ingratitudine.
La rabbia dell'ignorare il beneficio
ricevuto. Le relazioni d'aiuto contraddistinguono i diversi momenti del ciclo
vitale di una persona e ne favoriscono l'autonomia e l'indipendenza. Esiste
tuttavia la possibilità che nella sottile dinamica di dipendenza/indipendenza,
caratterizzante questo tipo di rapporto, alla gratitudine per un beneficio
ricevuto si sostituisca un sentimento d'ingratitudine, di rancore e di rabbia
verso il "benefattore".
Questo lavoro di Andrea Brundo prende in esame i fenomeni connessi alle
relazioni d'aiuto e i processi collegati alla costruzione della personalità nel
corso dell'età evolutiva (a partire dall'iniziale rapporto diadico
madre-figlio). In base a questa ipotesi, chi prova rancore non ha avuto la
possibilità di sperimentare, aggregare ed elaborare contenuti affettivi
significativi nelle prime fasi della vita. Ignora, quindi, l'esistenza di
autentiche relazioni d'affetto. È incapace di viverle, proprio per la mancanza
di informazioni e per la carenza dei relativi schemi cognitivi. Il "rancoroso",
pur potendo ammettere l'aiuto ricevuto, non è in grado di essere riconoscente
perché ignora i contenuti affettivi che sono dietro la relazione di aiuto.
Non potendoli riconoscere in se stesso non li può trovare neanche negli
altri. L'incapacità di provare gratitudine è sostenuta da una generale
difficoltà a condividere sentimenti e contenuti psichici. Nelle relazioni che
instaura, la condivisione non è mediata dalla sfera affettiva, ma dalle
prevalenti esigenze dell'io. Chi manca delle informazioni atte a soddisfare le
proprie necessità può ricorrere all'aiuto dell'altro che le possiede. Ciò
comporta, sul piano relazionale, il riconoscimento dell’autorevolezza e del
relativo "potere" di chi dispone le conoscenze. Nel momento in cui si deve
predisporre ad accettare le informazioni, il beneficiato, con prevalente
modalità narcisistica va incontro ad una serie di difficoltà legate a:
non
sapere;
essere
in una posizione subordinata di "potere";
fidarsi e considerare giusta l'informazione ricevuta;
disporsi a ridefinire i propri schemi cognitivi e stili comportamentali;
vivere
il disagio provocato dal contenuto affettivo associato all'informazione-aiuto.
Nel
caso in cui le informazioni risultino troppo complesse rispetto alla
rappresentazione della realtà del soggetto, lo sforzo per elaborarle e
integrarle nei propri schemi mentali è eccessivo. A questo punto tale soggetto
preferisce ricorrere a una modalità più semplice, quale è quella antagonista, e
si mette contro la persona che lo sta aiutandolo. E ancora. Quando il divario
tra l'immagine di sé (in termini di sistema di credenze, schemi cognitivi, stili
comportamentali, ecc.) e le implicazioni di mutamento insite nelle
informazioni-aiuto si rivela insostenibile, il beneficiato non può accettare di
cambiare e il peso di questa difficoltà viene proiettato sul beneficiante.
L'informazione donata e non elaborata rimane a livello dell'io, ristagna e
diventa un qualcosa di stantio, di "rancido", di inespresso che risulta
insopportabile. Un qualcosa che alimenta un incessante rimuginio, sostenuto
anche dalla vergogna e dal senso di colpa. Nasce l'esigenza di eliminare il
fastidio e il senso di oppressione, esigenza che conduce all'odio verso la causa
(il beneficiante) di tanto "dolore". Si instaura così un circolo vizioso nel
pensiero a cui solo gli sfoghi rabbiosi possono dare un minimo, seppur
temporaneo, sollievo. Gli eccessi di rabbia costituiscono l'unica soluzione per
tentare una comunicazione (impossibile) attraverso la naturale via
dell'affettività. Pertanto, il rancore trova un’auto giustificazione in quanto
permette di manifestare al mondo e alla persona beneficante contenuti mentali
che non trovano altre modalità espressive.
Altra storica
menzogna è stata sbugiardata da "Mai più terroni. La fine della questione
meridionale" di Pino Aprile. Come abbattere i pregiudizi che rendono il
meridione diverso? Come mettere fine a una questione costruita ad arte sulla
pelle di una parte d'Italia? La risposta sta anche negli strumenti di
comunicazione odierni, capaci di abbattere i confini, veri o fittizi, rompere
l'isolamento, superare le carenze infrastrutturali. E se per non essere più
"meridionali" bastasse un clic? Con la sua solita vis polemica, Pino Aprile ci
apre un mondo per mostrare quanto questo sia vero, potente e dilagante. "Ops...
stanno finendo i terroni. Ma come, già? E così, da un momento all'altro?"
Terroni a
chi? Tre libri sul pregiudizio antimeridionale. Come è nata e come si è
sviluppata la diffidenza verso il Sud. Tre libri ne ricostruiscono le origini e
provano a ipotizzarne gli scenari.
"Negli ormai
centocinquant'anni di unità italiana il Mezzogiorno non ha mai mancato di creare
problemi". D'accordo, la frase è netta e controversa. Sulla questione
meridionale, nell'ultimo secolo e mezzo, si sono sprecati fiumi di inchiostro,
tonnellate di pagine, migliaia di convegni. In gran parte dedicati all'indagine
sociologica, al pregiudizio politico o alla rivendicazione identitaria. Ciò che
colpisce allora di "La palla al piede" di Antonino De Francesco
(Feltrinelli) è lo sguardo realistico e l'approccio empirico. De Francesco è
ordinario di Storia moderna all'Università degli studi di Milano, ma definire il
suo ultimo lavoro essenzialmente storico è quantomeno limitativo. In poco meno
di duecento pagine, l'autore traccia l'identikit di un pregiudizio, quello
antimeridionale appunto, nei suoi aspetti sociali, storici e politici. Lo fa
rincorrendo a una considerevole pubblicistica per niente autoreferenziale, che
non si ostina nel solito recinto storiografico. Il risultato si avvicina a una
controstoria dell'identità italiana e, al tempo stesso, a un'anamnesi dei vizi e
dei tic dell'Italia Unita. Ma per raccontare una storia ci si può ovviamente
mettere sulle tracce di una tradizione e cercare, attraverso le sue strette
maglie, di ricostruire una vicenda che ha il respiro più profondo di una
semplice schermaglia localistica. E' quello che accade nel "Libro napoletano
dei morti" di Francesco Palmieri (Mondadori). Racconta la Napoli eclettica e
umbratile che dall’Unità d'Italia arriva fino alla Prima guerra mondiale. Per
narrarla, si fa scudo della voce del poeta napoletano Ferdinando Russo
ricostruendo con una certa perizia filologica e una sottile verve
narrativa le luci e le smagliature di un'epopea in grado di condizionare la
realtà dei giorni nostri. Ha il respiro del pamphlet provocatorio e spiazzante
invece l'ultimo libro di Pino Aprile, "Mai più terroni" (Piemme), terzo
volume di una trilogia di successo (Terroni e Giù al Sud i titoli
degli altri due volumi). Aprile si domanda se oggi abbia ancora senso dividere
la realtà sulla base di un fantomatico pregiudizio etnico e geografico
che ha la pretesa di tagliare Nord e Sud. E si risponde che no, che in tempi di
iperconnessioni reali (e virtuali), quelli stereotipo è irrimediabilmente
finito. "Il Sud - scrive - è un luogo che non esiste da solo, ma soltanto se
riferito a un altro che lo sovrasta". Nelle nuove realtà virtuali, vecchie
direzioni e punti cardinali non esistono più, relegati come sono a un
armamentario che sa di vecchio e obsoleto.
D'altronde siamo
abituati alle stronzate dette da chi in mala fede parla e le dice a chi, per
ignoranza, non può contro ribattere. Cominciamo a dire: da quale pulpito viene
la predica. Vediamo in Inghilterra cosa succede. I sudditi inglesi snobbano gli
italiani. Ci chiamano mafiosi, ma perché a loro celano la verità. Noi
apprendiamo la notizia dal tg2 delle 13.00 del 2 gennaio 2012. Il loro lavoro è
dar la caccia ai criminali, ma alcuni ladri non sembrano temerle: le forze di
polizia del Regno sono state oggetto di furti per centinaia di migliaia di
sterline, addirittura con volanti, manette, cani ed uniformi tutte sparite sotto
il naso degli agenti. Dalla lista, emersa in seguito ad una richiesta secondo la
legge sulla libertà d'informazione, emerge che la forza di polizia più colpita è
stata quella di Manchester, dove il valore totale degli oggetti rubati arriva a
quasi 87.000 sterline. Qui i ladri sono riusciti a fuggire con una volante da
10.000 sterline e con una vettura privata da 30.000.
E poi. Cosa
sarebbe oggi la Germania se avesse sempre onorato con puntualità il proprio
debito pubblico? Si chiede su “Il Giornale” Antonio Salvi, Preside della
Facoltà di Economia dell’Università Lum "Jean Monnet". Forse non a tutti è
noto, ma il Paese della cancelliera Merkel è stato protagonista di uno dei più
grandi, secondo alcuni il più grande, default del secolo scorso, nonostante non
passi mese senza che Berlino stigmatizzi il comportamento vizioso di alcuni
Stati in materia di conti pubblici. E invece, anche la Germania, la grande e
potente Germania, ha qualche peccatuccio che preferisce tenere nascosto.
Polentoni
(mangia polenta o come dicono loro po' lentoni, ossia lenti di comprendonio) e
terroni (cafoni ignoranti) sono pregiudizi da campagna elettorale inventati ed
alimentati da chi, barbaro, dovrebbe mettersi la maschera in faccia e
nascondersi e tacere per il ladrocinio perpetrato anche a danno delle stesse
loro popolazioni.
Ma si sa parlar
male dell'altro, copre le proprie colpe.
Terroni a chi?
Tre libri sul pregiudizio antimeridionale. Come è nata e come si è sviluppata la
diffidenza verso il Sud. Tre libri ne ricostruiscono le origini e provano a
ipotizzarne gli scenari.
"Negli ormai
centocinquant'anni di unità italiana il Mezzogiorno non ha mai mancato di creare
problemi". D'accordo, la frase è netta e controversa. Sulla questione
meridionale, nell'ultimo secolo e mezzo, si sono sprecati fiumi di inchiostro,
tonnellate di pagine, migliaia di convegni. In gran parte dedicati all'indagine
sociologica, al pregiudizio politico o alla rivendicazione identitaria. Ciò che
colpisce allora di "La palla al piede" di Antonino De Francesco
(Feltrinelli) è lo sguardo realistico e l'approccio empirico. De Francesco è
ordinario di Storia moderna all'Università degli studi di Milano, ma definire il
suo ultimo lavoro essenzialmente storico è quantomeno limitativo. In poco meno
di duecento pagine, l'autore traccia l'identikit di un pregiudizio, quello
antimeridionale appunto, nei suoi aspetti sociali, storici e politici. Lo fa
rincorrendo a una considerevole pubblicistica per niente autoreferenziale, che
non si ostina nel solito recinto storiografico. Il risultato si avvicina a una
controstoria dell'identità italiana e, al tempo stesso, a un'anamnesi dei vizi e
dei tic dell'Italia Unita. Ma per raccontare una storia ci si può ovviamente
mettere sulle tracce di una tradizione e cercare, attraverso le sue strette
maglie, di ricostruire una vicenda che ha il respiro più profondo di una
semplice schermaglia localistica. E' quello che accade nel "Libro napoletano
dei morti" di Francesco Palmieri (Mondadori). Racconta la Napoli eclettica e
umbratile che dall’Unità d'Italia arriva fino alla Prima guerra mondiale. Per
narrarla, si fa scudo della voce del poeta napoletano Ferdinando Russo
ricostruendo con una certa perizia filologica e una sottile verve
narrativa le luci e le smagliature di un'epopea in grado di condizionare la
realtà dei giorni nostri. Ha il respiro del pamphlet provocatorio e spiazzante
invece l'ultimo libro di Pino Aprile, "Mai più terroni" (Piemme), terzo
volume di una trilogia di successo (Terroni e Giù al Sud i titoli
degli altri due volumi). Aprile si domanda se oggi abbia ancora senso dividere
la realtà sulla base di un fantomatico pregiudizio etnico e geografico che ha la
pretesa di tagliare Nord e Sud. E si risponde che no, che in tempi di
iperconnessioni reali (e virtuali), quelli stereotipo è irrimediabilmente
finito. "Il Sud - scrive - è un luogo che non esiste da solo, ma soltanto se
riferito a un altro che lo sovrasta". Nelle nuove realtà virtuali, vecchie
direzioni e punti cardinali non esistono più, relegati come sono a un
armamentario che sa di vecchio e obsoleto.
Il sud? Una
palla al piede? “La palla al piede. Una storia del pregiudizio antimeridionale”
è il libro di Antonino De Francesco. Declinata in negativo, è tornata a essere
un argomento ricorrente nei discorsi sulla crisi della società italiana. Sprechi
di risorse pubbliche, incapacità o corruzione delle classi dirigenti locali,
attitudini piagnone delle collettività, forme diffuse di criminalità sono stati
spesso evocati per suggerire di cambiare registro nei riguardi del Mezzogiorno.
I molti stereotipi e luoghi comuni sono di vecchia data e risalgono agli stessi
anni dell'unità, ma quel che conta è la loro radice propriamente politica. Fu
infatti la delusione per le difficoltà incontrate nel Mezzogiorno all'indomani
dell'unificazione a cancellare presto l'immagine di un Sud autentico vulcano di
patriottismo che nel primo Ottocento aveva dominato il movimento risorgimentale.
Da allora lo sconforto per una realtà molto diversa da quella immaginata avrebbe
finito per fissare e irrobustire un pregiudizio antimeridionale dalle tinte
sempre più livide ogni qual volta le vicende dello stato italiano andarono
incontro a traumatici momenti di snodo. Il libro rilegge la contrapposizione tra
Nord e Sud dal tardo Settecento sino ai giorni nostri. Si capisce così in che
modo il pregiudizio antimeridionale abbia costituito una categoria politica alla
quale far ricorso non appena l'innalzamento del livello dello scontro politico
lo rendesse opportuno. Per il movimento risorgimentale il Mezzogiorno
rappresentò sino al 1848 una terra dal forte potenziale rivoluzionario.
Successivamente, la tragedia di Pisacane a Sapri e le modalità stesse del crollo
delle Due Sicilie trasformarono quel mito in un incubo: le regioni meridionali
parvero, agli occhi della nuova Italia, una terra indistintamente arretrata.
Nacque così un'Africa in casa, la pesante palla al piede che frenava il resto
del paese nel proprio slancio modernizzatore. Nelle accuse si rifletteva una
delusione tutta politica, perché il Sud, anziché un vulcano di patriottismo, si
era rivelato una polveriera reazionaria. Si recuperarono le immagini del
meridionale opportunista e superstizioso, nullafacente e violento, nonché l'idea
di una bassa Italia popolata di lazzaroni e briganti (poi divenuti camorristi e
mafiosi), comunque arretrata, nei confronti della quale una pur nobile minoranza
nulla aveva mai potuto. Lo stereotipo si diffuse rapidamente, anche tramite
opere letterarie, giornalistiche, teatrali e cinematografiche, e servì a
legittimare vuoi la proposta di una paternalistica presa in carico di una
società incapace di governarsi da sé, vuoi la pretesa di liberarsi del fardello
di un mondo reputato improduttivo e parassitario. Il libro ripercorre la storia
largamente inesplorata della natura politica di un pregiudizio che ha
condizionato centocinquant'anni di vita unitaria e che ancora surriscalda il
dibattito in Italia. I meridionali sono allegri e di buon cuore ma anche
«oziosi, molli e sfibrati dalla corruzione». Sono simpatici e affettuosi, è un
altro giudizio sempre sulla gente del Sud, ma pure «cinici, superstiziosi,
pronti a rispondere con la protesta di piazza a chi intende disciplinarli». A
separare il barone di Montesquieu e Giorgio Bocca, (sono dette da loro queste
opinioni sul Mezzogiorno), vi sono circa 250 anni. Eppure nemmeno i secoli
contano e fanno la differenza quando si tratta di sputar sentenze sul meridione.
Così scrive Mirella Serri su “La Stampa”. Già, proprio così. Credevamo di esser
lontani anni luce dall’antimeridionalismo (il suo viaggio nell’Inferno
del Sud, Bocca lo dedica alla memoria di Falcone e di Borsellino), pensavamo di
essere comprensivi e attenti alle diversità? Macché, utilizziamo gli stessi
stereotipi di tantissimi lustri fa: è questa la provocazione lanciata dallo
storico Antonino De Francesco in un lungo excursus in cui esamina tutte le
dolenti note su "La palla al piede.
Una storia del pregiudizio antimeridionale".
La nascita dei pregiudizi sul Sud si verifica, per il professore, nel secolo dei
Lumi, quando numerosi viaggiatori europei esplorarono i nostri siti più
incontaminati e selvaggi. E diedero vita a una serie di luoghi comuni sul
carattere dei meridionali che si radicarono dopo l’Unità d’Italia e che hanno
continuato a crescere e a progredire fino ai nostri giorni. E non basta. A farsi
portavoce e imbonitori di questa antropologia negativa sono stati spesso
artisti, scrittori, registi, giornalisti, ovvero quell’intellighentia anche del
Sud che l’antimeridionalismo l’avrebbe dovuto combattere accanitamente.
Uno dei primi a
intuire questa responsabilità degli intellettuali fu il siciliano Luigi Capuana.
Faceva notare a Verga che loro stessi, i maestri veristi, avevano contribuito
alla raffigurazione del siculo sanguinario con coltello e lupara facile. E che
sulle loro tracce stava prendendo piede il racconto di un Mezzogiorno di fuoco
con lande desolate, sparatorie, sgozzamenti, rapine, potenti privi di scrupoli e
plebi ignare di ordine e legalità. Ad avvalorare questa narrazione che investiva
la parte inferiore dello Stivale dettero il loro apporto anche molti altri
autori, da Matilde Serao, che si accaniva sui concittadini partenopei schiavi
dell’attrazione fatale per il gioco del lotto, a Salvatore di Giacomo, che dava
gran rilievo all’operato della camorra in
Assunta Spina.
Non fu esente dall’antimeridionalismo nemmeno il grande Eduardo De Filippo che
in Napoli milionaria
mise in luce il sottomondo della città, fatto di mercato nero, sotterfugio,
irregolarità. Anche il cinema neorealista versò il suo obolo antisudista con
film come Rocco e i suoi fratelli
di Luchino Visconti, testimonial dei cruenti e insondabili rapporti familiari e
sociali dei meridionali. Pietro Germi, ne
In nome della legge,
e Francesco Rosi, ne Le mani sulla
città, vollero
denunciare i mali del Sud ma paradossalmente finirono per evidenziare i meriti
degli uomini d’onore come agenzia interinale o società onorata nel distribuire
ai più indigenti lavori e mezzi di sussistenza, illegali ovviamente. A rendere
la Sicilia luogo peculiare del trasformismo politico che contaminerà tutto lo
Stivale ci penserà infine il
Gattopardo
di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. In generale prevale il ritratto di un Sud
antimoderno e clientelare, palla al piede del Nord. Milano, per contrasto, si
fregerà dell’etichetta di «capitale morale», condivisa tanto dal meridionalista
Salvemini quanto da Camilla Cederna, non proprio simpatizzante del Sud.
Quest’ultima, per attaccare il presidente della Repubblica Giovanni Leone, reo
di aver fatto lo scaramantico gesto delle corna in pubblico, faceva riferimento
alla sua napoletanità, sinonimo di «maleducazione, smania di spaghetti,
volgarità». «L’antimeridionalismo con cui ancora oggi la società italiana si
confronta non è così diverso da quello del passato», commenta De Francesco. Non
c’è dubbio.
Benvenuti al Sud,
che di questi antichi ma persistenti pregiudizi ha lanciato la parodia, si è
posizionato al quinto posto nella classifica dei maggiori incassi in Italia di
tutti i tempi. Come un vigile che si materializza nell’ora di punta o un
poliziotto che sopraggiunge nel vivo della rissa. Dopo le polemiche sugli afrori
dei napoletani, dopo le dispute sul bidet dei Borbone e sulle fogne dei Savoia,
mai libro è arrivato più puntuale. Edito da Feltrinelli, «La palla al piede» di
Antonino De Francesco è, infatti, come recita il sottotitolo, «una storia del
pregiudizio antimeridionale». E come tale non solo capita a proposito, ma riesce
anche a dare ordine a una materia per molti versi infinita e dunque
inafferrabile. Cos’è del resto l’antimeridionalismo? «È — spiega l’autore a
Marco Demarco su “Il Corriere della Sera” — un giudizio tanto sommario quanto
inconcludente, che nulla toglie e molto (purtroppo) aggiunge ai problemi
dell’Italia unita, perché favorisce il declino nelle deprecazioni e permette
alle rappresentazioni, presto stereotipate, di prendere il sopravvento». Non
solo. «Ed è — aggiunge De Francesco — anche un discorso eversivo, perché corre
sempre a rimettere in discussione il valore stesso dell’unità italiana». Fin qui
la quarta di copertina, ma poi, all’interno, pagina dopo pagina, ecco i testi,
le tesi, i personaggi che hanno affollato la scena dello scontro tra
meridionalisti e antimeridionali: da Boccaccio a Matilde Serao, da Montesquieu a
Prezzolini, passando per Cuoco e Colletta, per Lauro e Compagna, per Mastriani e
Totò. Fino a Indro Montanelli, che commentando il milazzismo picchia duro sui
siciliani e scrive che «se in Italia si compilasse una geografia dell’abbraccio
ci si accorgerebbe che più si procede verso le regioni in cui esso
rigogliosamente fiorisce, e più frequente si fa l’uso del coltello e della
pistola, della lettera anonima e dell’assegno a vuoto»; o a Camilla Cederna, che
addirittura mette in forse la religiosità del presidente Leone: «Tutt’al più —
scrive in piena campagna per le dimissioni — il suo è un cristianesimo di
folclore...». Materiali preziosi, alcuni noti e altri no, ma tutti riletti
all’interno di uno schema molto chiaro. Che è il seguente: negli anni di fuoco a
ridosso dell’unità d’Italia, l’antimeridionalismo nasce molto prima del
meridionalismo, non ha lasciato testimonianze meritevoli di interesse sotto il
profilo culturale, ma, «ha svolto un preciso ruolo normativo nell’immaginario
sociale del mondo». Ha creato, cioè, categorie mentali, visioni e schemi
interpretativi che hanno condizionato politiche e strategie, alleanze e scelte
di campo. In questo senso, l’antimeridionalismo si è rivelato per quello che
davvero è: niente altro che uno strumento della lotta politica.
L’antimeridionalismo appare e scompare, va e viene, morde e fugge, ma sempre
secondo le convenienze del momento storico, del contesto. Così a Masaniello può
accadere una volta di assurgere a simbolo del riscatto meridionale e di essere
messo sullo stesso asse rivoluzionario che porta fino al ’99, quando del Sud
serve l’immagine tutta tesa al riscatto liberatorio; un’altra di precipitare a
testimonianza del velleitarismo plebeo, di un ribellismo pari a quello dei
briganti, quando del Sud bisogna dare invece l’idea di un mostro da abbattere.
Sulla stessa altalena possono salirci anche interi territori, come la Sicilia.
Quella pre-garibaldina immaginata dalle camicie rosse è tutto un ribollire di
passioni civili e di ansie anti borboniche; quella post-garibaldina descritta
dai militari piemontesi è violenta, barbara, incivile. È andata così anche con
il Cilento di Pisacane: prima dello sbarco, era la terra promessa del sogno
risorgimentale; dopo, la culla del tradimento e del popolo imbelle. Perfino la
considerazione della camorra cambia secondo il calcolo politico. Nel 1860 la
stampa piemontese, prova ne è «Mondo illustrato», arriva perfino a elogiarla,
ritenendola capace di dare organizzazione ai lazzaroni favorevoli al cambio di
regime. Ma poi la scena si ribalta. Con Silvio Spaventa comincia l’epurazione
del personale sospetto inserito negli apparati statali e la «Gazzetta del
Popolo» prontamente plaude. Come strumento della battaglia politica,
l’antimeridionalismo non viene usato solo nello scontro tra Cavour e Garibaldi,
ma diventa una costante. Liberali e democratici lo usano per giustificare le
rispettive sconfitte. E come alibi usano sempre il popolo, che di colpo diventa
incolto, superstizioso, asociale, ingovernabile. Ai socialisti succede di
peggio. Negli anni del positivismo, arrivano, sulle orme di Lombroso, a
cristallizzare il razzismo antimeridionale. Niceforo parla di due razze, la
peggiore, la maledetta, è naturalmente quella meridionale; mentre Turati, in
polemica con Crispi, vede un Nord tutto proiettato nella modernità e un Sud che
è «Medio Evo» e «putrefatta barbarie». Prende forma così quel dualismo culturale
che vede ovunque due popoli, uno moderno e l’altro arretrato, dove è chiaro che
il secondo, come già ai tempi di Cuoco, giustifica il primo. Ma questo dualismo
finisce per mettere in trappola anche la produzione culturale. I veristi, ad
esempio, raccontano con passione la vita degli ultimi, della minorità sociale.
Ma come vengono lette a Milano queste storie? Chi fa le dovute differenze? Il
dubbio prende ad esempio Luigi Capuana quando decide di polemizzare con
Franchetti e Sonnino per come hanno descritto la Sicilia. Capuana addebita
addirittura a se stesso, a Federico De Roberto e soprattutto all’amico Giovanni
Verga, la grave responsabilità di aver favorito, con i loro racconti e con i
loro romanzi, la ripresa dei luoghi comuni sull’isola. Credevamo di produrre
schiette opere d’arte — scrive avvilito a Verga — «e non abbiamo mai sospettato
che la nostra sincera produzione, fraintesa o male interpretata, potesse venire
adoperata a ribadire pregiudizi, a fortificare opinioni storte, a provare
insomma il contrario di quel che era nostra sola intenzione rappresentare alla
fantasia dei lettori». E in effetti, commenta De Francesco, l’opera di Verga,
nel corso degli anni Settanta, aveva liquidato l’immagine di una Sicilia esotica
e mediterranea a tutto vantaggio della costruzione di potenti quadri di miseria
e di atavismo. Il libro si chiude con il caso Bocca, forse il più emblematico
degli ultimi anni. Inviato nel Sud sia negli anni Novanta, sia nel 2006.
Racconta sempre la stessa Napoli, persa tra clientele, degrado e violenza
criminale, ma la prima volta piace alla sinistra; la seconda, invece, la stessa
sinistra lo condanna senza appello. La ragione? Prima Bassolino era
all’opposizione, poi era diventato sindaco e governatore.
Ed a proposito
di Napoli. “Il libro napoletano dei morti” di Francesco Palmieri. Bella assai è
Napoli. E non nel senso sciuè sciuè. E’ bella perché sta archiviando una
menzogna: quella di essere costretta allo stereotipo e infatti non ha più
immondizia per le strade. Non ha più quella patina di pittoresco tanto è vero
che il lungomare Caracciolo, chiuso al traffico, è come un ventaglio squadernato
innanzi a Partenope. C’è tutto un brulicare di vita nel senso proprio della
qualità della vita. Ovunque ci sono vigili urbani, tante sono le vigilesse in
bici, sono sempre più pochi quelli che vanno senza casco e quelli che li
indossano, i caschi, anche integrali, non hanno l’aria di chi sta per fare una
rapina. E’ diventata bella d’improvviso Napoli. Sono uno spasso gli ambulanti
abusivi che se ne scappano per ogni dove inseguiti dalla forza pubblica e se
qualcuno crede che il merito sia di De Magistris, il sindaco, si sbaglia. Se
Napoli è tornata capitale – anche a dispetto di quella persecuzione
toponomastica che è la parola “Roma”, messa dappertutto per marchiare a fuoco la
sconfitta dell’amato Regno – il motivo è uno solo: Francesco Palmieri ha scritto
“Il Libro napoletano dei Morti” e le anime di don Ferdinando Russo e quelle dei
difensori di Gaeta hanno preso il sopravvento sui luoghi comuni. Dall'Unità
d'Italia alla Prima guerra mondiale, Napoli vive il suo periodo più splendido e
più buio. Un'epopea di circa sessant'anni non ancora raccontata e che ne ha
segnato il volto attuale. Le vicende avventurose dei capitani stranieri,
arrivati per difendere la causa persa dei Borbone, s'intrecciano con quelle di
camorristi celebri e dei loro oscuri rapporti con il nuovo Stato italiano. L'ex
capitale si avvia verso il Novecento tra contraddizioni storiche e sociali
risolte nel sangue o in un paradossale risveglio culturale. Ma, quando calerà il
sipario sul drammatico processo Cuocolo, un clamoroso assassinio in Galleria
rivelerà che la camorra non è stata sconfitta. E il "prequel" della futura
Gomorra. Narratore dell'intera vicenda è il poeta Ferdinando Russo. Celebre un
tempo e amato dalle donne, da giornalista ha coraggiosamente denunciato la
malavita ma è stato attratto dai codici antichi di coraggio della guapparia.
Russo cerca il fil rouge che collega i racconti dei cantastorie napoletani alla
tragica fine dei capitani borbonici: questo nesso lo ritrova nell'ineffabile
enigma della Sirena Partenope, la Nera, l'anima stessa di Napoli, che si rivela
nel coltello dei camorristi o irretisce incarnata in quelle sciantose di cui fu
vittima egli stesso, prima con un grande amore perso poi sposando un'altra che
invece non amò.
“Il libro
napoletano dei morti” è un viaggio alle radici di Gomorra, scrive Luca Negri su
“L’Occidentale”. Esiste un antico Libro egiziano dei morti, anche uno tibetano.
In poche parole, si tratta di affascinanti manuali di sopravvivenza per l’anima
nei regni dell’oltretomba. La versione italica, universalmente nota per
l’altissimo valore poetico, è la Commedia di Dante. Commedia appunto perché il
finale è lieto: l’anima non si perde negli inferi, fra demoni, ma ascende a Dio,
come pressappoco succede nelle versioni egizia e tibetana. Ora il lettore
italiano ha a disposizione anche “Il libro napoletano dei morti” (Mondadori,
nella collana Strade Blu), che non è un manuale per cittadini partenopei ed
italiani prossimi alla fine. O forse sì, lo è. Soprattutto se consideriamo la
città sotto il Vesuvio come paradigmatica dei nodi irrisolti della nostra
esausta storia patria. Comunque, è un romanzo, un grande romanzo, il migliore
uscito quest’anno, a nostro giudizio. Per lo stile felicissimo che combina
momenti lirici, squarci storici, immagini cinematografiche. E poi riesce a
toccare temi universali, partendo da un luogo e da un tempo ben precisi: Napoli
negli anni che corrono dalla conquista garibaldina all’avvento del fascismo.
L’autore si
chiama Francesco Palmieri, è un maestro di Kung Fu napoletano che nella vita fa
il giornalista e si occupa di economia e Cina. Uno che conosce bene misteri
d’oriente, vicende e canzoni della sua città e come va la vita. Per raccontare
il suo libro dei morti, Palmieri è entrato nell’esistenza e nella lingua di
Ferdinando Russo, poeta, giornalista, romanziere e paroliere di canzoni (la più
nota è “Scetate”) nato ovviamente a Napoli nel 1866 e morto nel 1927. Russo era
amico di d’Annunzio, firma di punta del quotidiano il Mattino, partenopeo verace
che detestava la napoletanità di maniera delle commedie di Eduardo Scarpetta e
nelle cantate di Funiculì funicolà. Per lui, come per l’amico-nemico Libero
Bovio (autore di “Reginella”), le canzoni con il mandolino rappresentavano il
Romanticismo esploso a Napoli con cinquant’anni di ritardo sul resto d’Europa,
non roba da cartolina. Russo era una persona seria ed onorata, un guappo,
cultore di Giordano Bruno e conoscitore di molti camorristi ma sempre
spregiatore della camorra. E con i suoi occhi e le sue parole vere e
immaginarie, in versi e prosa, Palmieri ci racconta proprio la degenerazione
della camorra: dalla confraternita fondata e regolata nel 1842 nella Chiesa di
Santa Caterina a Formello, figlia di “semi spagnoli e nere favole mediterranee”
alle spietate bande di “malavitosi senza norma e senza morale”. Al guappo armato
solo di scudiscio e coltello, talvolta della sola minacciosa presenza, si
sostituiscono “facce patibolari” bramose di soldi e potere, vigliacche al punto
da imbracciare solo armi da fuoco, che male modellano le mani di chi le usa.
Russo, fin da bambino, si ispirava al teatrino dei Pupi, si sentiva un paladino,
un Rinaldo sempre in lotta contro il male: il traditore Gano di Magonza. E vide
gli antichi paladini reincarnati negli stranieri che combatterono per la causa
persa dei Borbone contro i Piemontesi invasori. Non solo per il piacere di
“tirare una sassata sulla faccia di liberali biondi”, ma per difendere “più che
un principe, un principio”. Franceschiello diventava un novello Carlo Magno,
sconfitto, però da un’imponente macchina bellica che nemmeno schifava il
fomentare odi e delazioni e l’ammazzare cristiani appena sospettati di simpatia
per l’insorgenza, per i “briganti”. A proposito, Palmieri e Russo ci ricordano
che lo Stato risorgimentale si servì proprio della camorra per garantire
l’ordine nel regno conquistato ed assicurarsi il successo nel plebiscito del
1860. Il processo di corruzione dell’”Onorata Società” ben s’accompagnò a quello
del neonato Regno d’Italia; anzi, i rapporti si fecero sempre più stretti, i
fili più inestricabili, al di là di tutte le repressioni di facciata e della
professione retorica di antimafia. Sconfitti zuavi e lealisti, non rimarrà che
cercare la “presenza dei paladini nelle notti scugnizze”, fra i guappi non
ancora degenerati in spietati assassini ed avidi imprenditori senza scrupoli e
freni. Ma è sempre più difficile, la cavalleria scompare, i proiettili uccidono
anche gli innocenti. La camorra, circondata da una nazione irrisolta e corrotta,
svela il suo volto, la sua dipendenza dal “perenne problema demoniaco” legato
alla doppia natura della Sirena Partenope che come vuole la tradizione giace
sotto Napoli; creatura bellissima e mostruosa “che fu madre di quei pezzenti
tarantati, di cantanti e sciantose, di camorristi” e poeti come Russo. Siamo
allora sull’orlo del baratro, sotto il vulcano, a Gomorra, come epicentro delle
tensioni italiche. E allora serve più che mai “una mano capace di trasformare
qualsiasi cosa in Durlindana”, in spada da paladino. Con la consapevolezza
evangelica che fare il crociato, “crociarsi”, significa saper portare la propria
croce. Ed aiutare i propri simili in questo “strabiliante Purgatorio umano che
ci avvampa tra merda e sentimenti”.
"Mai più
terroni. La fine della questione meridionale" di Pino Aprile. Come abbattere i
pregiudizi che rendono il meridione diverso? Come mettere fine a una questione
costruita ad arte sulla pelle di una parte d'Italia? La risposta sta anche negli
strumenti di comunicazione odierni, capaci di abbattere i confini, veri o
fittizi, rompere l'isolamento, superare le carenze infrastrutturali. E se per
non essere più "meridionali" bastasse un clic? Con la sua solita vis polemica,
Pino Aprile ci apre un mondo per mostrare quanto questo sia vero, potente e
dilagante. "Ops... stanno finendo i terroni. Ma come, già? E così, da un momento
all'altro?" Così Pino Aprile inizia, nel modo provocatorio che gli è congeniale,
questo suo pamphlet, che affronta l'annosa e scontata Questione meridionale da
un'angolatura completamente diversa. In un mondo che sta cambiando a incredibile
velocità, ha ancora senso definire la realtà in base a criteri geografici, come
quelli di Nord e Sud, che nell'interpretazione dei più portano con sé una
connotazione meritocratica ormai superata? E possibile utilizzare ancora
definizioni di questo tipo quando internet, la Rete, sta tracciando una mappa
che non tiene più conto dei vecchi confini, anzi se ne è liberata per
ridisegnare uno spazio davvero globale, senza Sud e senza Nord, di cui fa parte
la nuova generazione, tutta, figli dei "terroni" compresi? No, dice Aprile,
tutto questo è irrimediabilmente finito, passato, travolto dal vento delle nuove
tecnologie che, spinto da molte volontà, sta creando un futuro comune, un futuro
che unisce, invece di dividere. Forse i padri non se ne sono ancora accorti, ma
i figli sì, lo sanno, così come sanno che quella che hanno imboccato è una
strada di non ritorno. "Il Sud è un luogo che non esiste da solo, ma soltanto se
riferito a un altro che lo sovrasta." Ma nello spazio virtuale, lo spazio dei
giovani di tutti i paesi, le direzioni non esistono più. Boom di vendite, dice
Antonino Cangemi su “Sicilia Informazioni”. E’ quasi una regola: ogni libro di Pino
Aprile scatena un boom di vendite e un mare di polemiche.
Così è accaduto
con “Terroni” e con “Giù al Sud”. Nel primo il giornalista raccontava,
all’anniversario del secolo e mezzo dell’Unità d’Italia, stragi, violenze,
saccheggi, sottaciuti dalla storiografia ufficiale, commessi dal Settentrione
contro il Meridione per accentuarne la subalternità, provocando le ire dei
“nordisti” e le perplessità della maggior parte degli storici accademici. Nel
secondo il meridionalista Aprile ribadiva le denunce contro i soprusi subiti dal
Sud Italia, ma nello stesso tempo individuava nel Meridione le risorse migliori
per “salvare l’Italia”. Nelle librerie “Mai più terroni”, un pamphlet
edito da Piemme che già dal sottotitolo, “La fine della questione
meridionale”, preannuncia dibattiti accesi.
Molti si
chiederanno: come mai Pino Aprile paladino delle ragioni dei “terroni”, che non
ha esitato a denunciare, in modo eclatante, i torti subiti dalla gente del Sud
per opera di governi filosettentrionali, adesso cambia registro sino a sostenere
che la questione meridionale non esiste più? Che cosa è successo nel giro di
pochi anni? Lo si scopre leggendo l’agile saggio. Che sostiene una teoria
piuttosto originale. E, secondo alcuni, azzardata. Nell’era industriale la
distanza tra Nord e Sud si accentuava perché rilevava la posizione geografica
dei luoghi dove si produceva ricchezza. Poiché le fabbriche, o la stragrande
maggioranza di esse, si trovavano nel Settentrione, i meridionali erano
costretti a spostarsi per lavorare e, con l’emigrazione, a vivere in un rapporto
di sudditanza. Tutto è ora cambiato con l’avvento di internet. Nella stagione
che si è da ultimo avviata, definita da Aprile l’era del Web, la geografia dei
territori non assume più rilievo. La rete ha annullato le distanze geografiche,
e non importano più dove sono collocate le imprese, la condizione delle
sovrastrutture, se le autostrade o le ferrovie funzionano nel Nord e sono
dissestate nel Meridione, tanto non occorre percorrerle grazie alla magia
telematica. Almeno per i giovani, che a colpi di clic possono cambiare la
realtà, dare sfogo al proprio estro creativo, inventare nuove fonti di
ricchezza. Non a caso, sostiene l’autore, oggi l’omologazione del web ha fatto
sì che tanta ricchezza sia concentrata in Paesi del Sud del mondo, quali ad
esempio la Cina e l’India. D’altra parte, secondo Aprile “il Sud è un luogo
che non esiste da solo, ma soltanto se riferito a un altro che lo sovrasta”.
Non vi sarà perciò più Sud e non vi saranno più “terroni” per effetto della rete
che permette di viaggiare restando seduti e di superare ogni barriera
geografica. Niente più sopraffazioni e prevaricazioni. Alla fine la spunta,
nella competizione democratica del web, chi è più creativo. Ipse dixit Aprile.
E’ proprio cosi, o le sue analisi peccano di superficialità? La discussione è
aperta. Da "Terroni" a "Mai più terroni", spiega Lino Patruno su “La Gazzetta
del Mezzogiorno”. Dal sottotitolo del primo libro («Tutto quello che è stato
fatto perché gli italiani del Sud diventassero meridionali») al sottotitolo di
questo («La fine della questione meridionale»). È l’itinerario di Pino Aprile:
dalla denuncia di 150 anni ai danni del Sud, alla profezia che fra poco il Sud
non sarà più Sud e che gli italiani del Sud non saranno più figli di una patria
minore. Ci si chiede cosa sia successo in due soli anni. E come il
giornalista-scrittore pugliese dai libri tanto vendutissimi quanto
contestatissimi possa passare dalla rabbia per le verità nascoste sulla
conquista del Sud, alla convinzione che nonostante tutto il Sud è entrato nella
nuova era della parità di condizioni di partenza. Esagerazione ora o prima?La
risposta è nelle stesse parole di Aprile: «Per condannare i meridionali a uno
stato di minorità civile ed economica, sono state necessarie prima le armi e i
massacri, poi è bastato isolarli. Ma il web è viaggiare senza percorrere spazi:
scompare, così, lo svantaggio di ferrovie mai fatte e treni soppressi, di
autostrade e aeroporti mancanti. Il Sud è, da un momento all’altro, alla pari. E
può prendere il largo, su quella pista, perché per la prima volta, dopo 150
anni, è nelle stesse condizioni dei concorrenti». Dire web è dire Internet. Che
annulla le distanze: tu puoi stare in un qualsiasi posto del mondo e lavorare
per qualsiasi altro posto del mondo. E con Internet vale il tuo talento davanti
al computer e basta, anche se stai, chessò, a Matera, unica città italiana senza
il treno delle Ferrovie dello Stato. In questo senso Internet annulla anche le
differenze di opportunità fra i territori. Con un computer un cittadino in
Bangladesh ha le stesse possibilità di lavoro di un cittadino degli Stati Uniti.
Così Internet può cancellare anche l’attuale svantaggio del Sud, la sua
perifericità geografica: che lo Stato in 150 anni ha accentuato invece di
ridurla.
Come? Creando un
divario nelle infrastrutture fra Centro Nord e Sud che supera 1140 per cento. E
non solo infrastrutture materiali (dalle autostrade agli aeroporti, appunto), ma
anche immateriali (ricerca, formazione, sicurezza) e sociali (scuole, ospedali,
assistenza). Ecco perché il terrone per la prima volta in 150 anni potrà cessare
di emigrare. Facendo da casa ciò che finora può fare soltanto andando via. E
dimostrandosi, se lo è, bravo quanto un privilegiato italiano del Centro Nord
che finora ha avuto più possibilità di lui perché la produzione di oggetti e il
lavoro crescono dove ci sono più mezzi a disposizione: a cominciare dalle
infrastrutture. Il «capitale sociale», beni pubblici alla base di qualsiasi
sviluppo. Aprile ci ha abituato allo sguardo lungo. Dopo quello all’indietro
sulle bugie storiche verso il Sud, ecco ora quello immaginifico su un futuro
possibile a favore del Sud. Col superamento di un ritardo tanto tenace e
mortificante quanto mai affrontato con leggi e mezzi necessari. E col sospetto
che si fingesse di cambiare qualcosa per lasciare tutto come prima. In poche
parole: la ricchezza di una parte del Paese basata sulla minore ricchezza
dell’altra. Con Internet oggi si fanno la metà dei lavori del mondo. E se finora
il vantaggio del Nord era sfornare merci, ora il vantaggio del Sud è poter
sfornare idee. E di idee i giovani terroni scoppiano: ecco la grande occasione
comunicata con la perentorietà della rivelazione. Ovvio che non tutto spunti per
magia: anche i computer sono meno al Sud, e non c’è in Italia quella banda larga
che li faccia funzionare da computer e non da catorci. Ma la forza evocativa, la
visione di Aprile è contagiosa e irresistibile anche quando suona più
controversa e forse (stavolta) troppo ottimistica. Ma col pessimismo non si fa
nulla. E poi leggiamo questa sua sorta di libro-testamento: ci sono racconti su
ciò che fanno i giovani sudisti proiettati nel domani tecnologico da convincere
che il futuro d’Italia è proprio qui. Cose entusiasmanti che nessuno avrebbe
potuto immaginare (soprattutto in Puglia), meno che mai chi non guarda,
sentenzia. Come nessuno avrebbe potuto immaginare, conclude Aprile, che ciò che
non è riuscito ai padri, può riuscire ai figli. Cosicché presto sarà solo un
ricordo che per un secolo e mezzo fummo terroni. “Giù al Sud. Perché i
terroni salveranno l’Italia” di Pino Aprile è il racconto di un’Italia
ancora spaccata in due, di rancori non sopiti, di ferite non rimarginate, dove i
ricordi di un passato di sudditanza e soprusi non sono stati cancellati. Ma è
anche la storia di nuove generazioni, colte ed intraprendenti, che fanno
ribaltare atavici pregiudizi. Già autore di "Terroni", l’autore conosce bene la
Storia e si è documentato con serietà e rigore prima di stendere denunce e dare
aggiornamenti sulle nuove risorse. In questo viaggio giù al sud si incontrano
realtà inattese, che stimolano e inorgogliscono. Il libro può essere letto per
capitoli separati, ognuno spunto di riflessione. Lucida ed interessante
l’analisi della nuova generazione di trentenni meridionali, colti,
scaltri e fantasiosi, affamati di storia, di ricostruzione dell’identità
meridionale, avvertita come risorsa economica e personale. Esenti da quel senso
di inferiorità che spesso ha frenato e ancora frena i loro padri, si sentono e
sono cittadini del mondo, un mondo in cui si muovono sicuri. Forte è l’interesse
per l’antropologia in Calabria: è una necessità di sapere di sé, è un
“bisogno di passato”, di recupero di un terreno perduto.
Come l’Odisseo
omerico, il cui futuro è nella sua radice: ha già fatto il viaggio e ora torna a
casa, per essere completo. Hanno desiderio e capacità di riscatto, usano i
problemi come risorse, hanno idee, e le portano avanti con creatività e fiducia.
Sono interessati alla riscoperta di nomi e bellezze, di luoghi e di cose, dalla
toponomastica all’agricoltura, alla produzione di olii, vini, pani; forte
l’orgoglio e il senso di appartenenza, per una terra “ritrovata”, per la forza
fisica e morale delle sue donne, per la musica che si miscela alla poesia di
antichi testi grecanici, che i giovani studiano e tramandano. In questo viaggio
si incontra la Murgia, “giardino di ulivi, ricamo di vigne, regione di
orgoglio” grazie alla tenacia dei suoi abitanti, che dalla sterile roccia
hanno fatto emergere terra grassa e feconda. E poi la Puglia, dove “un
deserto si è fatto un orto” a prezzo di un lavoro disumano. Benessere e
convivenza anche a Riace, altra tappa di questo percorso, dove nel
convivere e condividere di Calabresi ed extra-comunitari integrati, o di
passaggio, si evidenzia un forte senso di ospitalità e umanità, e così a
Sovereto, luogo di accoglienza per stranieri e tossicodipendenti, luogo di
rinascita fisica e morale. Esaltanti le tante storie di giovani coraggiosi,
ricchi di ingegno ed iniziative, che restano nella loro terra, rendendola
migliore. Di contro, altri emigrati sembrano voler prendere le distanze dai
luoghi natii, rinnegando le proprie origini, disprezzando ciò che si è perso e
sopravalutando ciò che si è acquisito, in una sorta di “amputazione della
memoria”.
La minorità del
Calabrese è atavica, è un senso di inferiorità non scalfito dal tempo. Le
privazioni subite, l’espoliazione delle antiche ricchezze, hanno costruito ed
alimentato la minorità meridionale.
Ma bisogna
reagire, esorta l’autore, cercando la solidarietà e l’appoggio di tutti al Nord,
perché tutti sappiano, perché si raggiunga un equilibrio perduto. I testi di
Pino Aprile sono il tentativo di un riscatto storico, quello di un’Italia che
160 anni fa aveva una propria identità di stato e che dopo l’Unità l’ha persa,
col dominio del Nord sul Sud; sono un’esortazione, soprattutto per i giovani, al
recupero di questa identità. Questo testo è una guida, ricca, aggiornata, colta,
che va al di là ed oltre i luoghi e la Storia, è un compendio di storie
personali e familiari, che si intersecano col territorio, sino a trasformarlo,
ad arricchirlo, a renderlo appetibile. Le pagine più belle sono quelle
descrittive, in cui i luoghi fisici si trasformano in luoghi dell’anima; Vieste
e il suo faraglione, la cui sommità uno stilita rubava ad un gabbiano; Aliano,
in Lucania, nella valle dell’Agri, “fra due marce muraglie di terra lebbrosa,
tagliata dal fiume e dai suoi affluenti, disciolta dalla pioggia, butterata dal
sole, che asciuga e svuota gli alveoli di creta.” … e la loro struggente
bellezza si fonde nella malinconia dell’abbandono, mentre l’animo si perde nel
sublime di fronte ai calanchi “orridi, belli e paurosi”. La presenza di
elementi naturali, come il mare, il vento e l’energia che da essi si crea,
conferisce forza e pathos ai movimenti dell’uomo sulla terra, rendendo le
vicende umane grandiose. Lo sguardo dell’autore ha il privilegio della
lontananza, che consente una visione d’insieme, quindi più completa e reale. Le
sue parole trasudano orgoglio di appartenenza, ampiezza di orizzonti, fisici e
mentali. Sono arrivato alla fine del libro, ma non sono riuscito a trovare una
risposta alla domanda che mi ero fatta leggendo il sottotitolo del libro: perché
i terroni dovrebbero salvare l'Italia? Così commenta Rocco Biondi. Non vedo un
motivo plausibile che dovrebbe spingere i meridionali, che per 150 anni sono
stati annientati dalla cultura e dall'economia nordista, ad avere un qualsiasi
interesse ad impegnarsi in un qualche modo per risollevare le sorti dell'Italia
cosiddetta unita. Questa convinzione mi proviene dall'attenta lettura fatta a
suo tempo di "Terroni" ed ora di "Giù al Sud". I due libri di Pino Aprile sono
accomunati dal riuscito tentativo di indicare possibili strade di "guerriglia
culturale" per far uscire i meridionali dalla minorità cui sono stati condannati
dagli artefici della malefica unità. La strada maestra è stata ed è la ricerca
della "propria storia denigrata e taciuta". E questa fame di storia è avvertita
come risorsa economica e personale. Si cercano i documenti, si scrive l'altra
storia, quella della stragrande maggioranza degli abitanti del Sud che dopo il
1860 si sono opposti alla invasione piemontese. Si scoprono i nostri padri
briganti, che hanno lottato e sono morti per la loro terra, le loro famiglie, la
loro patria. Si dà vita a progetti artistici che hanno come protagonista il
proprio passato, del quale non ci si vergogna più. Per andare avanti bisogna
ripartire da quel che eravamo e da quel che sapevamo. I nostri antenati subirono
e si auto-imposero la cancellazione forzosa della verità storica. Bisogna
riscoprirla questa verità se vogliamo diventare quello che meritiamo di essere.
Nel Sud i guai arrivarono con l'Unità. Le tasse divennero feroci per «tenere in
piedi la bilancia dei pagamenti del nuovo Stato e concorsero a finanziare
l'espansione delle infrastrutture nel Nord».A danno del Sud, dove le
infrastrutture esistenti vennero smantellate. Messina, perno commerciale
dell'intera area dello Stretto, perse il privilegio di porto franco, con
scomparsa di molte migliaia di posti di lavoro. La Calabria, che oggi appare
vuota e arretrata, era partecipe di fermenti e traffici della parte più avanzata
d'Europa. In Calabria si producevano bergamotto, seta, gelsomino, lavanda,
agrumi, olio, liquirizia, zucchero di canna. Per favorire l'industria del Nord
si provocò il crollo dell'agricoltura specializzata del Sud, chiudendo i suoi
mercati che esportavano oltralpe. Scrive Pino Aprile: «L'Italia non è solo elmi
cornuti a Pontida, pernacchie padane e bunga bunga».L'Italia è anche la somma di
tantissime singolarità positive esistenti nel Sud. E il suo libro è la
narrazione, quasi resoconto, degli incontri avuti con queste realtà nei suoi
viaggi durati tre anni dopo l'uscita di "Terroni". Pino Aprile si chiede ancora:
«Perché la classe dirigente del Sud non risolve il problema del Sud, visto che
il Nord non ha interesse a farlo?». E risponde: perché la classe dirigente
nazionale è quasi tutta settentrionale, perché il Parlamento è a trazione
nordica, perché le banche sono tutte settentrionali o centrosettentrionali,
perché l'editoria nazionale è quasi esclusivamente del Nord, perché la grande
industria è tutta al Nord e solo il 7,5 per cento della piccola e media
industria è meridionale. E allora che fare? «Finché resterà la condizione
subordinata del Sud al Nord - scrive Pino Aprile -, la classe dirigente del Sud
avrà ruoli generalmente subordinati. Quindi non "risolverà", perché dovrebbe
distruggere la fonte da cui viene il suo potere delegato. Si può fare; ma si
chiama rivoluzione o qualcosa che le somiglia. E può essere un grande, pacifico
momento di acquisizione di consapevolezza, maturità. Succede, volendo».E non ci
si può limitare alla denuncia, bisogna lasciarsi coinvolgere direttamente e
personalmente, per governare questi fenomeni.
Negli Stati
Uniti d'America i persecutori hanno saputo pacificarsi con le loro vittime
indiane, riconoscendo il loro sacrificio ed onorandole. In Italia questo non è
ancora avvenuto, gli invasori piemontesi non hanno ancora riconosciuto le
motivazioni della rivolta contadina e dei briganti. Noi meridionali dobbiamo
pretendere questo riconoscimento. Noi meridionali l'unità l'abbiamo subita, non
vi è stata un'adesione consapevole. Nei fatti essa unità è consistita nel
progressivo ampliamento del Piemonte, con l'applicazione forzata delle sue
leggi, strutture, tasse e burocrazia. Il Sud, ridotto a colonia, doveva smettere
di produrre merci, per consumare quelle del Nord: da concorrente, a cliente. Non
è vero che la mafia esiste solo al Sud. Milano è la principale base operativa
per 'ndrangheta e mafia siciliana, dove si trasforma il potere criminale in
potere economico, finanziario, politico. Stiamo per uscire dalla minorità, dopo
un sonno di un secolo e mezzo, il Sud sembra aprire gli occhi. Lo sconfitto
smette di vergognarsi di aver perso e recupera il rispetto per la propria
storia. L'interesse primario dei meridionali non deve essere quello di salvare
l'Italia, ma quello di valorizzare se stessi. Solo indirettamente e
conseguentemente, forse, potrà avvenire il salvataggio dell'Italia intera.
SE NASCI IN ITALIA…
Quando si nasce nel posto sbagliato e si continua
a far finta di niente.
Steve Jobs è cresciuto a Mountain View, nella
contea di Santa Clara, in California. Qui, con il suo amico Steve Wozniak,
fonda la Apple Computer, il primo aprile del 1976. Per finanziarsi, Jobs vende
il suo pulmino Volkswagen, e Wozniak la propria calcolatrice. La prima sede
della nuova società fu il garage dei genitori: qui lavorarono al loro primo
computer, l’Apple I. Ne vendono qualcuno, sulla carta, solo sulla base
dell’idea, ai membri dell’Homebrew Computer Club. Con l’impegno d’acquisto,
ottengono credito dai fornitori e assemblano i computer, che consegnano in
tempo. Successivamente portano l’idea ad un industriale, Mike Markkula, che
versa, senza garanzie, nelle casse della società la somma di 250.000 dollari,
ottenendo in cambio un terzo di Apple. Con quei soldi Jobs e Wozniak lanciano il
prodotto. Le vendite toccano il milione di dollari. Quattro anni dopo, la Apple
si quota in Borsa.
Io sono Antonio Giangrande, noto autore di saggi
pubblicati su Amazon, che raccontano questa Italia alla rovescia. A tal fine tra
le tante opere da me scritte vi è “Italiopolitania. Italiopoli degli italioti”.
Di questo, sicuramente, non gliene fregherà niente a nessuno. Fatto sta che io
non faccio la cronaca, ma di essa faccio storia, perché la quotidianità la
faccio raccontare ai testimoni del loro tempo. Certo che anche di questo non
gliene può fregar di meno a tutti. Ma una storiella raccontata da Antonio Menna
che spiega perché, tu italiano, devi darti alla fuga dall’Italia, bisogna
proprio leggerla. Mettiamo che Steve Jobs sia nato in Italia. Si chiama Stefano
Lavori. Non va all’università, è uno smanettone. Ha un amico che si chiama
Stefano Vozzini. Sono due appassionati di tecnologia, qualcuno li chiama
ricchioni perchè stanno sempre insieme. I due hanno una idea. Un computer
innovativo. Ma non hanno i soldi per comprare i pezzi e assemblarlo. Si mettono
nel garage e pensano a come fare. Stefano Lavori dice: proviamo a venderli senza
averli ancora prodotti. Con quegli ordini compriamo i pezzi. Mettono un
annuncio, attaccano i volantini, cercano acquirenti. Nessuno si fa vivo. Bussano
alle imprese: “volete sperimentare un nuovo computer?”. Qualcuno è interessato:
“portamelo, ti pago a novanta giorni”. “Veramente non ce l’abbiamo ancora,
avremmo bisogno di un vostro ordine scritto”. Gli fanno un ordine su carta non
intestata. Non si può mai sapere. Con quell’ordine, i due vanno a comprare i
pezzi, voglio darli come garanzia per avere credito. I negozianti li buttano
fuori. “Senza soldi non si cantano messe”. Che fare? Vendiamoci il motorino. Con
quei soldi riescono ad assemblare il primo computer, fanno una sola consegna,
guadagnano qualcosa. Ne fanno un altro. La cosa sembra andare. Ma per decollare
ci vuole un capitale maggiore. “Chiediamo un prestito”. Vanno in banca.
“Mandatemi i vostri genitori, non facciamo credito a chi non ha niente”, gli
dice il direttore della filiale. I due tornano nel garage. Come fare? Mentre ci
pensano bussano alla porta. Sono i vigili urbani. “Ci hanno detto che qui state
facendo un’attività commerciale. Possiamo vedere i documenti?”. “Che documenti?
Stiamo solo sperimentando”. “Ci risulta che avete venduto dei computer”. I
vigili sono stati chiamati da un negozio che sta di fronte. I ragazzi non hanno
documenti, il garage non è a norma, non c’è impianto elettrico salvavita, non ci
sono bagni, l’attività non ha partita Iva. Il verbale è salato. Ma se tirano
fuori qualche soldo di mazzetta, si appara tutto. Gli danno il primo guadagno e
apparano. Ma il giorno dopo arriva la Finanza. Devono apparare pure la Finanza.
E poi l’ispettorato del Lavoro. E l’ufficio Igiene. Il gruzzolo iniziale è
volato via. Se ne sono andati i primi guadagni. Intanto l’idea sta lì. I primi
acquirenti chiamano entusiasti, il computer va alla grande. Bisogna farne altri,
a qualunque costo. Ma dove prendere i soldi? Ci sono i fondi europei, gli
incentivi all’autoimpresa. C’è un commercialista che sa fare benissimo queste
pratiche. “State a posto, avete una idea bellissima. Sicuro possiamo avere un
finanziamento a fondo perduto almeno di 100mila euro”. I due ragazzi pensano che
è fatta. “Ma i soldi vi arrivano a rendicontazione, dovete prima sostenere le
spese. Attrezzate il laboratorio, partire con le attività, e poi avrete i
rimborsi. E comunque solo per fare la domanda dobbiamo aprire la partita Iva,
registrare lo statuto dal notaio, aprire le posizioni previdenziali, aprire una
pratica dal fiscalista, i libri contabili da vidimare, un conto corrente
bancario, che a voi non aprono, lo dovete intestare a un vostro genitore.
Mettetelo in società con voi. Poi qualcosa per la pratica, il mio onorario. E
poi ci vuole qualcosa di soldi per oliare il meccanismo alla regione. C’è un
amico a cui dobbiamo fare un regalo sennò il finanziamento ve lo scordate”. “Ma
noi questi soldi non ce li abbiamo”. “Nemmeno qualcosa per la pratica? E dove vi
avviate?”. I due ragazzi decidono di chiedere aiuto ai genitori. Vendono l’altro
motorino, una collezione di fumetti. Mettono insieme qualcosa. Fanno i
documenti, hanno partita iva, posizione Inps, libri contabili, conto corrente
bancario. Sono una società. Hanno costi fissi. Il commercialista da pagare. La
sede sociale è nel garage, non è a norma, se arrivano di nuovo i vigili, o la
finanza, o l’Inps, o l’ispettorato del lavoro, o l’ufficio tecnico del Comune, o
i vigili sanitari, sono altri soldi. Evitano di mettere l’insegna fuori della
porta per non dare nell’occhio. All’interno del garage lavorano duro: assemblano
i computer con pezzi di fortuna, un po’ comprati usati un po’ a credito. Fanno
dieci computer nuovi, riescono a venderli. La cosa sembra poter andare. Ma un
giorno bussano al garage. E’ la camorra. Sappiamo che state guadagnando, dovete
fare un regalo ai ragazzi che stanno in galera. “Come sarebbe?”. “Pagate, è
meglio per voi”. Se pagano, finiscono i soldi e chiudono. Se non pagano, gli
fanno saltare in aria il garage. Se vanno alla polizia e li denunciano, se ne
devono solo andare perchè hanno finito di campare. Se non li denunciano e
scoprono la cosa, vanno in galera pure loro. Pagano. Ma non hanno più i soldi
per continuare le attività. Il finanziamento dalla Regione non arriva, i libri
contabili costano, bisogna versare l’Iva, pagare le tasse su quello che hanno
venduto, il commercialista preme, i pezzi sono finiti, assemblare computer in
questo modo diventa impossibile, il padre di Stefano Lavori lo prende da parte e
gli dice “guagliò, libera questo garage, ci fittiamo i posti auto, che è
meglio”. I due ragazzi si guardano e decidono di chiudere il loro sogno nel
cassetto. Diventano garagisti. La Apple in Italia non sarebbe nata, perchè
saremo pure affamati e folli, ma se nasci nel posto sbagliato rimani con la fame
e la pazzia, e niente più.
DIRITTO E GIUSTIZIA. I TANTI GRADI DI GIUDIZIO
E L’ISTITUTO DELL’INSABBIAMENTO.
In Italia, spesso, ottenere giustizia è una
chimera. In campo penale, per esempio, vige un istituto non previsto da alcuna
norma, ma, di fatto, è una vera consuetudine. In contrapposizione al Giudizio
Perenne c’è l’Insabbiamento.
Rispetto al concorso esterno all’associazione
mafiosa, un reato penale di stampo togato e non parlamentare, da affibbiare alla
bisogna, si contrappone una norma non scritta in procedura penale:
l’insabbiamento dei reati sconvenienti.
A chi è privo di alcuna conoscenza di diritto,
oltre che fattuale, spieghiamo bene come si forma l’insabbiamento e quanti gradi
di giudizio ci sono in un sistema che a livello scolastico lo si divide con i
fantomatici tre gradi di giudizio.
Partiamo col dire che l’insabbiamento è applicato
su un fatto storico corrispondente ad un accadimento che il codice penale
considera reato.
Per il sistema non è importante la punizione del
reato. E’ essenziale salvaguardare, non tanto la vittima, ma lo stesso soggetto
amico, autore del reato.
A fatto avvenuto la vittima incorre in svariate
circostanze che qui si elencano e che danno modo a più individui di intervenire
sull’esito finale della decisione iniziale.
La vittima, che ha un interesse proprio leso, ha
una crisi di coscienza, consapevole che la sua querela-denuncia può recare
nocumento al responsabile, o a se stessa: per ritorsione o per l’inefficienza
del sistema, con le sue lungaggini ed anomalie. Ciò le impedisce di proseguire.
Se si tratta di reato perseguibile d’ufficio, quindi attinente l’interesse
pubblico, quasi sempre il pubblico ufficiale omette di presentare denuncia o
referto, commettendo egli stesso un reato.
Quando la denuncia o la querela la si vuol
presentare, scatta il disincentivo della polizia giudiziaria.
Ti mandano da un avvocato, che si deve pagare, o
ti chiedono di ritornare in un secondo tempo. Se poi chiedi l’intervento urgente
delle forze dell’ordine con il numero verde, ti diranno che non è loro
competenza, ovvero che non ci sono macchine, ovvero di attendere in linea,
ovvero di aspettare che qualcuno arriverà………
Quando in caserma si redige l’atto, con motu
proprio o tramite avvocato, scatta il consiglio del redigente di cercare di
trovare un accordo e poi eventualmente tornare per la conferma.
Quando l’atto introduttivo al procedimento penale
viene sottoscritto, spesso l’atto stanzia in caserma per giorni o mesi, se
addirittura non viene smarrito o dimenticato…
Quando e se l’atto viene inviato alla procura
presso il Tribunale, è un fascicolo come tanti altri depositato su un tavolo in
attesa di essere valutato. Se e quando….. Se il contenuto è prolisso, non viene
letto. Esso, molte volte, contiene il nome di un magistrato del foro. Non di
rado il nome dello stesso Pubblico Ministero competente sul fascicolo. Il
fascicolo è accompagnato, spesso, da una informativa sul denunciante, noto agli
uffici per aver presentato una o più denunce. In questo caso, anche se fondate
le denunce, le sole presentazioni dipingono l’autore come mitomane o pazzo.
Dopo mesi rimasto a macerare insieme a centinaia
di suoi simili, del fascicolo si chiede l’archiviazione al Giudice per le
Indagini Preliminari. Questo senza aver svolto indagini. Se invece vi è il faro
mediatico, allora scatta la delega delle indagini e la comunicazione di garanzia
alle varie vittime sacrificali. Per giustificare la loro esistenza, gli
operatori, di qualcuno, comunque, ne chiedono il rinvio a giudizio, quantunque
senza prove a carico.
Tutti i fascicoli presenti sul tavolo del Giudice
per l’Udienza Preliminare contengono le richieste del Pubblico Ministero:
archiviazione o rinvio a giudizio. Sono tutte accolte, a prescindere. Quelle di
archiviazione, poi, sono tutte accolte, senza conseguire calunnia per il
denunciante, anche quelle contro i magistrati del foro. Se poi quelle contro i
magistrati vengono inviate ai fori competenti a decidere, hanno anche loro la
stessa sorte: archiviati!!!
Il primo grado si apre con il tentativo di
conciliazione con oneri per l’imputato e l’ammissione di responsabilità, anche
quando la denuncia è infondata, altrimenti la condanna è già scritta da parte
del giudice, collega del PM, salvo che non ci sia un intervento divino, (o
fortemente terrestre sul giudice), o salvo che non interviene la prescrizione
per sanare l’insanabile. La difesa è inadeguata o priva di potere. Ci si tenta
con la ricusazione, (escluso per il pm e solo se il giudice ti ha denunciato e
non viceversa), o con la rimessione per legittimo sospetto che il giudice sia
inadeguato, ma in questo caso la norma è stata sempre disapplicata dalle toghe
della Cassazione.
Il secondo grado si apre con la condanna già
scritta, salvo che non ci sia un intervento divino, (o fortemente terrestre sul
giudice), o salvo che non interviene la prescrizione per sanare l’insanabile. Le
prove essenziali negate in primo grado, sono rinegate.
In terzo grado vi è la Corte di Cassazione,
competente solo sull’applicazione della legge. Spesso le sue sezioni emettono
giudizi antitetici. A mettere ordine ci sono le Sezioni Unite. Non di rado le
Sezioni Unite emettono giudizi antitetici tra loro. Per dire, la certezza del
diritto….
Durante il processo se hai notato anomalie e se
hai avuto il coraggio di denunciare gli abusi dei magistrati, ti sei scontrato
con una dura realtà. I loro colleghi inquirenti hanno archiviato. Il CSM invece
ti ha risposto con una frase standard: “Il CSM ha deliberato l’archiviazione non
essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, trattandosi di
censure ad attività giurisdizionale”.
Quando il processo si crede che sia chiuso, allora
scatta l’istanza al Presidente della Repubblica per la Grazia, ovvero l’istanza
di revisione perchè vi è stato un errore giudiziario. Petizioni quasi sempre
negate.
Alla fine di tutto ciò, nulla è definitivo. Ci si
rivolge alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, che spesso rigetta. Alcune
volte condanna l’Italia per denegata giustizia, ma solo se sei una persona con
una difesa capace. Sai, nella Corte ci sono italiani.
Per i miscredenti vi è un dato, rilevato dal foro
di Milano tratto da un articolo di Stefania Prandi del “Il Fatto Quotidiano”.
“Per le donne che subiscono violenza
spesso non c’è giustizia
e la responsabilità è anche della magistratura”. A lanciare l’accusa sono
avvocate e operatrici
della Casa di accoglienza delle donne
maltrattate di Milano che puntano il dito contro la Procura
della Repubblica di Milano, “colpevole” di non prendere sul serio
le denunce delle donne
maltrattate. Secondo i dati su 1.545
denunce per maltrattamento in famiglia (articolo 572 del Codice penale)
presentate da donne nel 2012 a Milano, dal Pubblico ministero sono arrivate
1.032 richieste di
archiviazione; di queste 842
sono state accolte dal Giudice per le indagini preliminari. Il che significa che
più della metà delle denunce sono
cadute nel vuoto. Una tendenza che si conferma costante nel
tempo: nel 2011 su 1.470 denunce per maltrattamento ci sono state
1.070 richieste di
archiviazione e 958
archiviazioni. Nel 2010 su 1.407 denunce, 542 sono state archiviate.
«La tendenza è di
archiviare, spesso de plano, cioè senza svolgere alcun
atto di indagine, considerando le denunce manifestazioni di
conflittualità familiare – spiega
Francesca Garisto, avvocata
Cadmi – Una definizione, questa, usata troppe volte in modo acritico, che
occulta il fenomeno della violenza
familiare e porta alla
sottovalutazione della credibilità di chi denuncia i
maltrattamenti subiti. Un atteggiamento grave da parte di una procura e di un
tribunale importanti come quelli di Milano». Entrando nel merito della
“leggerezza” con cui vengono affrontati i casi di
violenza, Garisto ricorda un episodio accaduto di recente: «Dopo una denuncia di
violenza anche fisica
subita da una donna da parte del marito, il pubblico ministero ha richiesto l’archiviazione
de plano qualificandola come espressione di conflittualità
familiare e giustificando la violenza fisica come possibile
legittima difesa dell’uomo
durante un litigio».
Scarsa anche la presa in considerazione delle
denunce per il reato di stalking
(articolo 612 bis del codice penale). Su 945 denunce fatte nel 2012, per 512 è
stata richiesta l’archiviazione e 536 sono state archiviate. Per il reato di
stalking quel che impressiona è che le richieste di archiviazione e le
archiviazioni sono aumentate, in proporzione, negli anni. In passato, infatti,
la situazione era migliore: 360
richieste di archiviazione e
324 archiviazioni su
867 denunce nel 2011,
235 richieste di archiviazione e
202 archiviazioni su
783 denunce nel 2010. Come stupirsi, dunque, che ci sia
poca fiducia nella giustizia da
parte delle donne? Manuela Ulivi, presidente Cadmi ricorda che soltanto il
30 per cento delle donne che subiscono violenza denuncia. Una percentuale bassa
dovuta anche al fatto che molte, in attesa di
separazione, non riescono ad andarsene di casa ma sono
costrette a rimanere a vivere con il compagno o il marito che le maltrattata.
Una scelta forzata dettata spesso dalla
presenza dei figli: su 220
situazioni di violenza seguite dal Cadmi nel 2012, il 72 per cento (159) ha
registrato la presenza di minori, per un totale di 259 bambini.
Non ci dobbiamo stupire poi se la gente è
ammazzata per strada od in casa. Chiediamoci quale fine ha fatto la denuncia
presentata dalla vittima. Chiediamoci se chi ha insabbiato non debba essere
considerato concorrente nel reato.
Quando la giustizia è male amministrata, la gente
non denuncia e quindi meno sono i processi, finanche ingiusti. Nonostante ciò vi
è la prescrizione che per i più, spesso innocenti, è una manna dal cielo. In
queste circostanze vien da dire: cosa hanno da fare i magistrati tanto da non
aver tempo per i processi e comunque perché paghiamo le tasse, se non per
mantenerli?
GIUSTIZIA DA MATTI E MOSTRI A PRESCINDERE.
Giustizia da matti.
L'ultima follia delle toghe: un'indagine sul morso di Suarez, scrive Filippo
Facci su “Libero Quotidiano”. Una giornata come un’altra, quella di ieri 8
luglio 2014: assolvono i vertici di una delle prime aziende italiane (Mediaset)
dopo aver però condannato il fondatore, condannano intanto il pluri-governatore
dell’Emilia Romagna che perciò si dimette, aprono un’inchiesta surreale sul
morso di Suarez a Chiellini - non l’inchiesta della Fifa: un'altra inchiesta
tutta italiana - e per finire la magistratura apre, di passaggio, anche
un’indagine sul concorso per magistratura. Questo senza contare le polemiche per
gli sms inviati da un sottosegretario alla giustizia (un magistrato) i quali
invitavano a votare un candidato per le elezioni del Csm, e senza contare,
appunto, le elezioni del Csm, e senza contare, ancora, le dure parole del
procuratore generale milanese Manlio Minale in polemica con l’archiviazione
dell’esposto del procuratore aggiunto Alfredo Robledo contro il procuratore capo
Edmondo Bruti Liberati per presunte irregolarità nelle assegnazioni - prendete
respiro - dopodiché Bruti Liberati ha provveduto a nuove assegnazioni che hanno
portato a un nuovo esposto del procuratore aggiunto Robledo: tutto chiaro, no?
Una giornata come un’altra, quella di ieri: e non dite che la magistratura sia
un potere ormai incontrollabile e irresponsabile, perché potrebbero punirvi e
togliervi i benefici di legge, non dite che la magistratura occupi ormai tutta
la scena e, ormai priva di contrappesi, si stia cannibalizzando e al tempo
stesso respinga qualsiasi riforma che possa farla riassomigliare a qualcosa di
normale: non fate i berlusconiani, non fate i renziani travestiti. Da che cosa
dovremmo incominciare? Quanto dovrebbe essere lungo, questo articolo, se davvero
volessimo approfondire i vari addendi della giornata di ieri? Anche perché è la
somma che lascia storditi. La Procura di Roma ha aperto un’indagine sul morso di
Suarez durante Uruguay-Italia: l’ipotesi è violenza privata. Che dire? Come
commentare? Cioè: davvero in questo preciso momento c’è un pubblico dipendente -
ciò che è un magistrato - che sta occupandosi di questa sciocchezza per via di
una denuncia del Codacons? E che gliene frega, al Codacons, del morso degli
uruguaiani? Ma soprattutto: che ce ne frega, a noi, in un Paese che affoga nelle
cause arretrate e dove gli imprenditori rinunciano ai contenziosi perché
durerebbero 15 anni?
Poi c’è l’indagine della magistratura sul concorso
per magistratura: e qui, invece, che cosa dovremmo pensare? Già è assurdo che
basti un pubblico concorso, subito dopo gli studi universitari, per trascorrere
tutta la vita da magistrato e percorrere automaticamente tutte le tappe di una
lunga carriera: ma - domanda - è solo una battuta chiedersi che razza di
magistrati possano uscire da un concorso truccato? Il concorso è quello del 25 e
26 e 27 giugno scorsi: un candidato ha denunciato una serie di irregolarità, il
solito impiccione di un Codacons ha chiesto l’accesso ai verbali della
commissione, c’è stata un’interrogazione parlamentare bipartisan, su un banco
hanno trovato tre codici vidimati e timbrati dalla commissione nonostante il
regolamento ne vietasse l’utilizzo: non male. Una candidata è stata scoperta
mentre scriveva un tema prima ancora che la traccia venisse dettata: e questa
ragazza, se passerà il concorso, finirà sino alla Cassazione. Stiamo facendo i
brillanti e gli spiritosi? Rischiamo di scivolare, dite, nel qualunquismo
anticasta? Ovunque rischiamo di scivolare, in verità, ci siamo già scivolati: è
da almeno vent’anni che questo Paese è subordinato all’azione sempre più
discrezionale delle magistrature: procure e tribunali avanzano in territori che
appartenevano alla politica e l’imprigionano come i laccetti che imbrigliavano
Gulliver. Quando non ci sarà più nessun mediocre politico con cui prendercela,
forse, sarà a tutti più chiaro.
Strage Borsellino, errori o depistaggi?
Ecco la storia “Dalla parte sbagliata”. In libreria
nei primi giorni di luglio 2014 il volume di Rosalba De Gregorio, legale di
sette imputati ingiustamente condannati nel primo processo su via D'Amelio, e
Dina Lauricella, giornalista di Servizio pubblico. La redazione de “Il Fatto
Quotidiano” ne anticipa un brano. “Chi si nasconde dietro quel tanto vituperato
«terzo livello» che ha legato mafia e pezzi delle Istituzioni attraverso il
«papello», ha verosimilmente lo stesso profilo di chi ha ucciso il giudice
Borsellino e di chi per 22 anni ci ha dato in pasto una storia da due lire, alla
quale abbiamo voluto credere per sedare la diffusa ansia di giustizia che ha
scosso il Paese nell’immediato dopo strage”, scrivono l’avvocato Rosalba Di
Gregorio e la giornalista Dina Lauricella nel libro “Dalla parte sbagliata”,
edito da Castelvecchi, con prefazione del magistrato Domenico Gozzo.Tre
processi, 15 anni di indagini, 11 persone ingiustamente condannate all’ergastolo
e un nuovo processo, il “borsellino quater” che sta rimettendo tutto in
discussione. Che cosa sappiamo oggi della strage di via d’Amelio e della morte
di Paolo Borsellino? Davvero poco se consideriamo che la procura di
Caltanissetta ha chiesto la revisione del vecchio processo. Un nuovo pentito,
Gaspare Spatuzza, ha rimescolato le carte e oggi in aula, chi stava sul banco
degli imputati, siede fra le parti civili. È il caso “dell’avvocato di mafia”
Rosalba Di Gregorio, che da oltre vent’anni grida al vento le anomalie di un
processo che si è basato sulle affermazioni di uno dei pentiti più anomali che i
nostri tribunali abbiano mai visto, Vincenzo Scarantino. Per tutti e tre i gradi
di giudizio ha inutilmente difeso 7 degli imputati condannati all’ergastolo
(oggi tornati in libertà grazie alle dichiarazioni di Spatuzza), e nel libro
racconta, con l’impeto e la passione che le è propria, in una sorta di diario di
bordo, questi lunghi anni di processi e sentenze. Dina Lauricella, inviata di
Servizio Pubblico, riavvolge il nastro di questa oscura storia del nostro Paese
provando a riguardarla da una nuova prospettiva. I due punti di osservazione
speciale sono quelli dell’ex pentito Vincenzo Scarantino e dell’avvocato Di
Gregorio, legale di numerosi boss di Cosa Nostra, tra cui Bernardo Provenzano,
Michele Greco e Vittorio Mangano. “Un racconto che parte dal basso, sicuramente
di parte, dalla parte sbagliata, per costringerci all’esercizio di tornare
indietro nel tempo, per sbarazzarci della confusione accumulata negli anni e,
atti alla mano, rimettere al posto giusto le poche pedine certe”. Le stesse
sulle quali, a 22 anni di distanza, è tornata ad indagare la procura di
Caltanissetta. Seri e rodati cronisti, formati nell’aula bunker di Palermo
durante il maxi processo, arrivati per primi sulle macerie e sui corpi dilaniati
di via d’Amelio, hanno una fitta al cuore al pensiero che nei successivi 15 anni
di vicende giudiziarie hanno visto, sentito e raccontato una storia che è
crollata all’improvviso mostrandosi in tutta la sua fragilità. È stato l’ex
procuratore generale di Caltanissetta Roberto Scarpinato a chiedere che i
processi «Borsellino» e «Borsellino bis» venissero revisionati a seguito delle
rivelazioni del nuovo collaboratore, Gaspare Spatuzza. È per questo che tre anni
fa, undici imputati, di cui sette condannati all’ergastolo, sono tornati in
libertà. Clamoroso errore giudiziario o vile depistaggio che sia, la storia è da
riscrivere e chi ha penna non dovrebbe risparmiare inchiostro. Ne serve molto
per raccontare fedelmente i punti salienti dei tre processi che dal 1996 al 2008
hanno indagato sull’omicidio Borsellino. Sarebbe una semplificazione
giornalistica dire che dobbiamo buttare all’aria tutti questi anni per colpa di
Scarantino o di chi ha creduto in lui. Le sentenze del Borsellino ter, infatti,
sopravvivono al terremoto Spatuzza, ma non è un caso: in questo processo
Scarantino non ha alcun ruolo. Carcere a vita per l’allora latitante Bernardo
Provenzano e per altri 10 imputati di grosso calibro, nessuno dei quali tirato
in ballo da Scarantino. Questo troncone scaturisce infatti dalle dichiarazioni
di mafiosi doc come Giovanni Brusca, Salvatore Cancemi, Giovan Battista Ferrante
o Calogero Ganci. Il processo che la Procura di Catania dovrà revisionare,
quando Caltanissetta stabilirà se Scarantino è o meno un calunniatore, come
emerso dalle dichiarazioni di Spatuzza, è il Borsellino bis. È qui che Enzino fa
da pilastro. Faticherà a distinguere i nomi dei mafiosi che coinvolge, non li
riconoscerà in foto, talvolta si contraddirà, ma a fronte di un’informativa del
Sisde che metteva in luce la sua parentela con il boss Salvatore Profeta, ha
goduto di una fiducia che si è rivelata a dir poco esagerata.
Mostri a prescindere. Misteri e
depistaggi. Finti pentiti e inchieste sballate. La
strage palermitana di via Mariano D’Amelio, dove il 19 luglio 1992 morirono
Paolo Borsellino e 5 agenti di scorta, non è soltanto uno dei peggiori drammi
italiani: è anche uno dei più velenosi ingorghi giudiziari di questo Paese,
scrive Rosalba Di Gregorio su “Panorama”. Tre processi, decine d’imputati, 7
persone ingiustamente condannate all’ergastolo e tenute in carcere 18 anni per
le false verità (incassate senza riscontri dai magistrati) del pentito Vincenzo
Scarantino. Poi una nuova inchiesta, partita nel giugno 2008, ha iniziato a
ribaltare tutto grazie alle rivelazioni (stavolta riscontrate) di Gaspare
Spatuzza. Nel marzo 2013, a Caltanissetta, è iniziato un nuovo procedimento,
con nuovi imputati: il "Borsellino quarter". Da oltre 21 anni Rosalba Di
Gregorio, avvocato di Bernardo Provenzano e altri boss di Cosa nostra, contesta
nei tribunali le anomalie di una giustizia che si è mostrata inaffidabile come
alcuni dei suoi peggiori collaboratori. Con Dina Lauricella, giornalista di
Servizio pubblico, la penalista cerca adesso di riannodare i fili di una delle
vicende più sconcertanti della nostra giustizia e lo fa in un libro difficile e
duro, ma spietatamente onesto: Dalla parte sbagliata (Castelvecchi editore, 190
pagine, 16,50 euro). Per capire la portata del disastro d’illegalità di cui si
occupa il libro, bastano poche righe della prefazione scritta da Domenico Gozzo,
procuratore aggiunto a Caltanissetta: "Non ha funzionato la polizia. Non ha
funzionato la magistratura. Non hanno funzionato i controlli, sia disciplinari
sia penali. Non ha funzionato il Csm (...). Solo un avvocato di mafia ha gridato
le sue urla nel vuoto". Urla che non sono bastate a evitare mostruosi errori
giudiziari, per i quali nessun magistrato pagherà, e sofferenze indicibili per
le vittime di tanta malagiustizia. Panorama pubblica ampi stralci del diario di
una visita dell’avvocato Di Gregorio a un cliente sottoposto al "regime duro"
del 41 bis nel carcere di Pianosa, appena un mese dopo via D’Amelio. Piombino,
agosto 1992. Sotto il sole, all’imbarco, fa caldissimo anche se sono le 8 del
mattino. Consegno i documenti e aspetto, ci sono altri due o tre colleghi e
dobbiamo imbarcarci per Pianosa. Passano due ore di attesa e io cerco di capire
perché mi sento ansiosa: in fondo, al carcere, ci vado da tanti anni. Alcuni
colleghi mi hanno detto di vestirmi con abiti che possono essere buttati via,
perché a Pianosa c’è troppa sporcizia, e ho indossato zoccoletti di legno,
pantaloni di cotone e una maglia: tutto rigorosamente senza parti metalliche e
sufficientemente brutto. Aspettiamo ancora, sotto il sole, e non si capisce
perché. Tutte le autorizzazioni per i colloqui sono in regola e, infastidita
dall’attesa, vado al posto di polizia per capire. "È per colpa sua se ancora
non si parte". Non avevano previsto avvocati donne! Stanno convocando il
personale femminile che si occupa dei colloqui dei detenuti con i parenti. Si
parte. Il panorama è unico e spettacolare. Siamo arrivati a Pianosa e ci
accolgono poliziotti e grossi cani che si lanciano ad annusarci appena scesi da
una traballante passerella di legno. Meno male che non soffro di vertigini e non
ho paura dei cani! Benvenuti a Pianosa. Sbarcati sull’isola, ci informano che è
vietato avvicinarsi al mare, che non potremo acquistare né acqua, né altro:
dovremo stare digiuni e assetati fino alle 17 sotto il sole, perché non c’è
"sala avvocati", né luogo riparato ove attendere, né è consentito andare allo
"spaccio delle guardie". (...) La perquisizione per me non è una novità, penso
per rassicurarmi. E sbaglio. Nella stanzetta lurida, spoglia, vengo controllata
col metal detector. Non suona perché non ho nulla di metallico addosso e allora
sto per andarmene. Mi intimano di fermarmi, bisogna perquisire. Ma che
significa? La perquisizione manuale non ha senso visto che non ho oggetti
metallici. Chiedo a una delle due donne addette alla perquisizione perché ha
indossato i guanti di lattice. Le due si guardano e una bisbiglia: "No, forse a
lei no, perché fa l’avvocato". Ma che vuol dire? Ho imparato subito e ho
sperimentato anche in successive visite, che a Pianosa nessuno sorride, tutti
sembrano incazzati, gli avvocati sono i difensori dei mostri e quindi sembra che
l’ordine sia di trattarli male: loro sono lo Stato e noi i fiancheggiatori
dell’antistato. Questa etichetta, nei processi per le stragi del ’92, ce la
sentiremo addosso, ma in modo diverso, forse più subdolo, certamente più
sfumato: a Pianosa, invece, è proprio disprezzo. (...) Finalmente esco da
quella stanzetta, sudata, anche innervosita, e passo nell’altra stanza a
riprendermi il fascicolo di carte processuali, le sigarette e la penna per
prendere appunti. O, almeno, pensavo di riprendere queste cose, ma la mia penna
è "pericolosa" e mi danno una bic trasparente. Le mie sigarette resteranno lì,
perché, per perquisire il pacchetto, sono state tutte tirate fuori e sparse sul
bancone sporchissimo. Le mie carte processuali vengono lette, giusto per la
sacralità del diritto di difesa. Sono di nuovo con i miei colleghi e sono
nervosissima. Ci fanno salire su una jeep, con due del Gom, il Gruppo operativo
mobile del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che, seduti davanti
a noi, ci puntano i mitra in faccia, lungo tutto il percorso che va dal punto di
approdo alla "Agrippa". Terra battuta, campetti coltivati dai detenuti: gli
altri detenuti di Pianosa, non quelli del 41 bis. (...) Entriamo nella "sala
colloqui", se così può definirsi quella stanza stretta, divisa in due, per
tutta la sua lunghezza, da un muro di cemento ad altezza di tavolino, sormontato
dal famoso "vetro del 41 bis". Come sedile c’è un blocco di cemento, alle
nostre spalle c’è il "blindato" che viene chiuso rumorosamente. I rumori di
Pianosa sono particolari: non senti parlare nessuno, la consegna pare sia il
silenzio, senti solo rumori metallici, forti, sinistri, nel silenzio dell’isola.
Non parlano nemmeno i 5 detenuti che ci portano dall’altro lato del vetro. I
"boss" – fra loro c’erano anche incensurati, ma questo si scoprirà con 19 anni
di ritardo – hanno lo sguardo terrorizzato, si limitano ad abbassare la testa,
entrano già con la testa bassa e alle loro spalle viene rumorosamente chiuso il
"blindato". Provo a chiedere, per educazione, come stiano, ma nessuno risponde.
Io sono uscita da lì senza aver sentito la voce di nessuno di loro. Ma che
succede? Perché, anziché guardare me o ascoltarmi, questi guardano, verso
l’alto, alle mie spalle? Mi giro di scatto e vedo che lo sportellino del
blindato dietro di me, quello che era stato chiuso al mio ingresso, è stato
aperto e una guardia del Gom li osserva. No, forse è più giusto dire che li
terrorizza con lo sguardo. (...) Torno sulla jeep e sono sconvolta. Per pochi
minuti di non-colloquio, sono stata trattata come un delinquente. (...) Ho
parlato con giornalisti, con colleghi, con magistrati, al mio ritorno da Pianosa
e mi sono sentita dire che, in fondo, non ero obbligata ad andarci e che la
mafia aveva fatto le stragi. Inutile ribattere che alcuni di quelli che erano a
Pianosa erano presunti innocenti, persone in attesa di giudizio: in tempo di
guerra le garanzie costituzionali vengono sospese. (...) "In ogni caso" mi ha
detto un avvocato civilista illuminato "se hanno arrestato loro, vuol dire che,
come minimo, si sono messi nelle condizioni di essere sospettati". E già... Un
vantaggio estetico, però, c’è stato sicuramente. Alla mia seconda visita a
Pianosa ho trovato i miei assistiti in forma fisica migliore: tutti magri,
asciutti, quasi ossuti, direi. Il cibo razionato e immangiabile ha la sua
influenza sulla dieta. (...) Nel ’94 sono stati arrestati, grazie a Vincenzo
Scarantino, anche i futuri condannati (oggi scarcerati) del processo Borsellino
bis: tra questi, Gaetano Murana, Cosimo Vernengo, Giuseppe Urso e Antonino
Gambino erano incensurati e furono accusati da Scarantino di concorso nella
strage di via D’Amelio. Di questi solo Nino Gambino sarà assolto dalla grave
accusa d’aver partecipato al massacro del 19 luglio ’92. Gli altri, assolti in
primo grado dopo la ritrattazione di Scarantino, saranno condannati e poi
riarrestati a seguito dell’ulteriore ritrattazione della ritrattazione del
"pentito a corrente alternata". Oggi, dopo Gaspare Spatuzza, sono scarcerati.
Tutti, comunque, erano stati amorevolmente accolti nelle carceri di Pianosa e
Asinara. Uno di questi, a Pianosa, ha subìto una lesione alla retina, per lo
"schiaffo" di una guardia del Gom. A un altro sono state fratturate le costole.
(...) Racconta, oggi, Tanino Murana: "Appena entrato a Pianosa dopo
l’interrogatorio del gip, mi hanno portato alla “discoteca". La discoteca è il
nome che i detenuti hanno dato alle celle dell’isolamento, perché li si balla
per le percosse e per la paura. "Eppure" dice Tanino "so che dal ’92 al ’94, che
è quando arrivai io, si stava peggio. Alcuni detenuti mi hanno detto, poi,
quando li ho incontrati in altre carceri, che all’inizio il trattamento era
peggiore". E perché non glielo hanno raccontato subito, mentre eravate a
Pianosa? "Lì non si poteva parlare: si doveva stare in silenzio nelle celle a
tre, o quattro posti. Le guardie del Gom non ci volevano sentire neppure
bisbigliare. Ma questo vale da quando ci portavano in sezione. Alla discoteca si
stava in cella singola". Era l’isolamento. L’accoglienza al supercarcere
prevedeva, per iniziare, che il detenuto si spogliasse completamente e, nudo,
iniziasse a fare le flessioni sulle gambe... tante, fino a non avere più fiato
e, nel frattempo, veniva preso a botte dalle guardie, cinque, sei, otto... "Non
lo so quanti erano... a un certo punto non capivi più nulla e trascinandoti di
peso, ti portavano, nudo e stremato, fino alla cella, in discoteca,
scaraventandoti dentro la stanzetta spoglia e sporca". Qui iniziava la seconda
parte del trattamento: perquisizioni, flessioni, acqua e brodaglia razionati,
botte, di giorno e di notte, per non farti dormire. "Appena ti addormentavi
entravano le guardie, alcune pure incappucciate, spesso ubriache e davano pugni,
calci, schiaffi... Dopo un po’ di tempo ho chiesto che mi uccidessero, non ce la
facevo più". (...) Ma cosa vi davano da mangiare? "Una pagnotta al giorno, due
tetrapak di acqua e poi se riuscivi a mangiarlo, il piatto del giorno". Cosa
sarebbe? "Una brodaglia in cui, accanto a qualche pezzetto, o filo di pasta,
galleggiava roba di qualunque genere". E cioè? "Io una volta ho trovato pure un
preservativo". Ecco perché erano tutti magri e asciutti. Ecco perché, quando
Scarantino, nel corso del processo Borsellino, il 15 settembre ’98, ha
raccontato il suo trattamento a Pianosa, i detenuti sono rimasti impassibili e
noi avvocati avevamo voglia di vomitare. All’epoca, non volendo prestare fede a
Scarantino, neppure in ritrattazione, ho cercato di documentarmi. Ho trovato una
sentenza del pretore di Livorno10, a carico di due guardie del Gom, processate a
seguito della denuncia di un ex ospite di Pianosa, per fatti accaduti in
quell’isola "dal luglio ’92 all’08/01/94". (...)
La sentenza (...) riporta il racconto del
denunciante, giunto a Pianosa il 20 luglio ’92. "Manganellate, strattoni,
pedate, sputi e schiaffi", sia all’entrata, sia all’uscita per andare all’aria.
E se "all’aria" non ci andavi, il "trattamento" ti veniva fatto in cella. Il
tragitto lungo il corridoio era scivoloso (cera, o detersivo, secondo altre
fonti), così si cadeva a terra, diventando bersaglio del "cordone " di 10 o 20
uomini del Gom, che si schieravano nel corridoio, a dare libero sfogo al
comportamento "animalesco". Racconta il denunciante – ma non è solo lui, oggi,
a riferirlo – che nello shampoo si trovava l’olio, nell’olio si trovava lo
shampoo e la pasta era a volte "condita" con i detersivi. Nessuno all’epoca
denunciava nulla, perché avevano tutti paura di essere uccisi. Preferivano
sopportare le angherie, le botte, gli scherzi, "l’inutile crudeltà" come dice
la sentenza. (...) A cosa serviva tanta violenza? Scarantino, che narra d’averla
subita tutta quella violenza, sostiene d’essersi determinato a fare il "falso"
pentito, perché non era capace più di resistere e non solo alle costrizioni
fisiche. Oggi, e nel tempo, ascoltando i racconti di ex detenuti di Pianosa, ti
accorgi che il ricordo più vivo sembra quello delle torture psicologiche: le
percosse hanno certamente segnato quei corpi, ma te le narrano in modo quasi
distaccato. Le hanno subite e, sembra, ormai quasi metabolizzate.
Presentazione su “La Valle dei Templi di Nico
Gozzo, procuratore aggiunto di Caltanissetta, “Dalla parte sbagliata – La morte
di Paolo Borsellino e i depistaggi di via D’Amelio”. Un boato, sei morti, tanti
misteri. Il 19 luglio del 1992 un’autobomba esplodeva in via D’Amelio uccidendo
Paolo Borsellino e i cinque agenti di scorta. A ventidue anni di distanza,
nonostante le inchieste, i processi, le condanne e le successive assoluzioni,
oggi ne sappiamo tanto quanto prima, tranne che per il fatto di aver preso
coscienza che molto di più, rispetto la strage mafiosa, si cela dietro
quell’evento criminale che ha visto falsi pentiti autori di depistaggi che ci
hanno portati sempre più lontani dalla verità. Fallimenti dell’apparato
investigativo e giudiziario, carenze e incongruenze che emergono sempre più
chiare dalle carte processuali, che ci obbligano a fare i conti con una realtà
che vorremmo inconsciamente ignorare e che ci mettono dinanzi ad una domanda
alla quale non abbiamo una risposta da dare: furono soltanto madornali errori
giudiziari o qualcosa di diverso e molto più grave si cela dietro le tante
anomalie che hanno caratterizzato l’intera vicenda? “Dalla parte sbagliata – La
morte di Paolo Borsellino e i depistaggi di via D’Amelio” è il libro della
giornalista palermitana Dina Lauricella e dell’avvocato Rosalba Di Gregorio che
racconta questi venti anni di indagini e processi, partendo dalle dichiarazioni
del pentito Vincenzo Scarantino, ambigua figura le cui dichiarazioni sono spesso
state smentite, per arrivare ad una certa antimafia parolaia e spesso fine a sé
stessa alla quale forse poco importa che venga una volta per tutte fatta
chiarezza sull’attentato che il 19 luglio del 1992 provocò la morte del Giudice
Paolo Borsellino e di altri cinque innocenti caduti nell’adempimento del loro
dovere. Non avrei mai pensato di dover scrivere dell’ “Avvocato del diavolo” –
come ignominiosamente viene definita Rosalba Di Gregorio – difensore di fiducia
di imputati dai cognomi “pesanti” quali Bontate,Pullarà, Vernengo, Marino
Mannoia, Mangano, per finire con Provenzano, se non fosse stato per questo libro
e per la coltre di silenzio con cui è stata artatamente coperta ogni sua
presentazione. Ho conosciuto personalmente l’Avvocato Rosalba Di Gregorio e l’ho
conosciuta in quelle aule giudiziarie laddove era in corso un processo per
strage contro i vertici di Cosa Nostra. Lei “dalla parte sbagliata”, difensore
di fiducia del boss o ex tale, io per scriverne “dalla parte giusta”, accanto ai
familiari di vittime innocenti di mafia. In quell’aula non c’erano gli
antimafiosi di professione, né, purtroppo, i tanti giornalisti che oggi
artatamente ignorano la Di Gregorio. È facile fare antimafia così. Facile come
porre il marchio di mafiosità a chi per ragioni professionali si trova a
difendere “la parte sbagliata”, il “mostro”. Senza entrare nel merito del
diritto, del codice deontologico della professione e su quel sacrosanto diritto
alla difesa che è consentito ad ogni imputato, dell’Avvocato Di Gregorio ho
avuto modo di apprezzare la professionalità, le doti umane e il contegno
mantenuto durante le udienze che – a differenza di tanti difensori di cosiddette
“persone per bene” che ho avuto modo di incontrare in questi anni – non l’hanno
mai spinta ad andare oltre quella che era la difesa del proprio assistito avendo
rispetto per l’altrui dolore e per il lavoro e la professionalità del
rappresentante legale della controparte. Se questo libro dovesse servire anche a
mettere un solo tassello al posto giusto per cercare di ricostruire quello che
realmente accadde nel ‘92, sarebbe molto più di quanto tanti di coloro che si
professano antimafiosi hanno dato come contributo ad una Verità che forse in
molti vorrebbero venisse taciuta per sempre. Se si è alla ricerca della Verità,
perchè ignorare o censurare chi può dare un contributo? Perchè non conoscere o
voler non fare conoscere le opinioni di chi per ragioni professionali ha seguito
le vicende osservandole da un’ottica diversa ma non per questo meno valida o
totalmente non rispondente a verità? Del resto – piaccia o meno -, ad oggi, la
ricostruzione più verosimile di quei tragici eventi sembra essere proprio quella
che emerge dal libro la cui esistenza si vorrebbe fosse ignorata. La prossima
manifestazione in cui si parlerà del libro si terrà a Trieste il
12 luglio, organizzata da Libera, che da due anni è riuscita a coinvolgere i
parenti di Walter Cosina, morto anche Lui nella strage del 19/7/92. Questi
parenti dimenticati, di Vittime trattate come se fossero di serie” b”, hanno
tanta fame anche Loro di Verità.
Questa la prefazione di Domenico Gozzo,
procuratore aggiunto di Caltanissetta, al libro “Dalla parte sbagliata”, di
Rosalba Di Gregorio e Dina Lauricella, edito da Castelvecchi: “Normalmente chi
scrive la prefazione ha piena conoscenza del libro. Io ammetto di non averla, e
per questo la mia è una «prefazione anomala». Ma conosco le autrici. E di loro
parlerò. Conosco la vicenda, di cui non parlo, ma penso di avere il dovere, dopo
le prime sentenze vicine al giudicato, di stimolare una riflessione che sino ad
oggi è, incredibilmente, mancata. E allora, parlando in primis delle autrici,
dico che Dina Lauricella mi è sembrata una giornalista indipendente e autonoma.
Non fa parte di cordate, e pensa con la sua testa. Qualità rare e importanti.
Quanto all’avvocato Di Gregorio, «l’avvocato del Diavolo», cosa dire? Rosalba è
una persona che ha una faccia sola. Ha sempre detto, ostinatamente, le stesse
cose sul processo di via D’Amelio. Ha sempre detto le stesse cose sui
collaboratori. A viso aperto, sopportando, secondo me, conseguenze che l’hanno
fatta diventare «un avvocato di mafia», del Diavolo, appunto. Rosalba non è un
avvocato di mafia. È un avvocato. E la parola «avvocato» non dovrebbe sopportare
ulteriori specifiche. A meno che non si voglia indicare, con quel termine, che
si occupa soprattutto di processi di mafia. Il che farebbe anche di principi del
Foro antimafia «avvocati di mafia». E a Milano, chi difende i corruttori, come
dovremmo chiamarli? «Avvocati della corruzione»? La verità è che la «colpa» di
Rosalba è di difendere, e bene, i mafiosi. Ma è una colpa questa? E può essere
all’origine di una «messa all’indice» professionale? La verità è che dovremmo
limitarci ad ammettere i nostri errori. Dopo le sentenze già intervenute
sulBorsellino quater, e senza discutere di prove, dobbiamo o no discutere di
questa giustizia, di questa stampa, di questa società, che secondo me, negli
anni Novanta, hanno, almeno in parte, fallito? Dobbiamo discutere di chi ha
consegnato per 17 anni le chiavi della vita di sette persone innocenti per il
reato di strage ad un falso pentito, Scarantino? Dobbiamo avere il coraggio di
discutere di una regola, quella della «frazionabilità» delle dichiarazioni dei
collaboranti, che forse andrebbe ripensata, perché consente a «collaboranti»
scarsamente credibili in via generale di essere utilizzati «per ciò che serve»,
aprendo il fianco a possibili strumentalizzazioni probatorie? Dobbiamo discutere
del fatto che, pur con tutte le considerazioni contenute nelle passate tre
sentenze sulla poca credibilità di Scarantino – il processo basato sulle sue
dichiarazioni è arrivato sino all’ultimo grado, ed è stato approvato anche in
Cassazione? Cosa non ha funzionato? Abbiamo il dovere di chiedercelo. Perché io
penso che in questa triste storia nessuno dei relè dello Stato democratico ha
funzionato a dovere. Non ha funzionato la Polizia. Non ha funzionato la
Magistratura. Non hanno funzionato i controlli, sia disciplinari sia penali. Non
ha funzionato il Csm. Non ha funzionato la cosiddetta Dottrina. Ma, soprattutto,
non ha funzionato la «libera stampa», che dovrebbe essere, e non lo è stata, il
vero cane da guardia di una democrazia. Solo un «avvocato di mafia» ha gridato
le sue urla nel vuoto. Sin quando, fortunatamente, grazie a nuove prove, la
stessa Giustizia ha avuto il coraggio di autoriformarsi. Ma alti sono i prezzi
pagati per questo, soprattutto all’interno delle forze dell’ordine. È
accettabile tutto questo? Sono accettabili questi 17 anni? E, soprattutto,
dobbiamo chiederci con trepidazione: potrebbe nuovamente accadere, magari sta
già riaccadendo, quanto è avvenuto in quella occasione? E allora, per evitarlo,
devono assisterci i principi generali delle democrazie cosiddette «occidentali».
Il diritto di difesa non è un optional. È un principio cardine delle democrazie,
per l’appunto, «di diritto». Il difensore di un mafioso non può divenire, per il
solo fatto di difendere un mafioso, inattendibile e pericoloso. La verità la può
dire un famoso procuratore antimafia, come anche un «avvocato di mafia». Come
tutti e due possono andare dietro ad abbagli. Tutto questo, lo capisco, ci
costringe a una fatica immane: non ragionare per schemi (buono-cattivo;
mafioso-antimafioso) ma ragionare con la nostra testa. Criticando. Leggendo.
Facendoci le nostre personali idee. Ma in questo deve aiutarci una stampa
autenticamente indipendente. Una stampa che non si schieri né a favore «a
priori», né contro «a priori». E necessitiamo di una magistratura aperta ad
essere criticata (se le critiche non sono preconcette), e rispettosa dei diritti
della difesa. Perché il processo, ricordiamocelo, è, come dicevano i romani,
actus trium personarum, è un rito che richiede il necessario intervento di tre
persone: il Giudice, il Pubblico Ministero, e la Difesa. Solo così, tenendo in
debito conto tutti questi attori, si può arrivare ad accertare una «verità
processuale» che assomigli il più possibile alla Verità. In ultimo, qualche
breve considerazione, permettetemi, sul cosiddetto fronte antimafia: ilmovimento
antimafia, che è di importanza basilare in uno Stato democratico, deve però
essere anch’esso democratico, e rispettoso delle opinioni di tutti. «Non
condivido la tua idea, ma darei la vita perché tu la possa esprimere», diceva
qualcuno più saggio di me. Isoliamo gli intolleranti per mestiere. Perché
dobbiamo viverci tutti insieme, in questo nostro Stato. E dobbiamo edificarlo
tutti insieme, su solide basi di verità, anche a costo di ammettere verità
scomode. È un debito, questo della verità, che tutti dobbiamo pagare a chi, in
quegli anni, perse la vita per una idea di Giustizia e di antimafia.
Rosalba Di Gregorio. Si laurea in Giurisprudenza
all’Università di Palermo nel 1979. Nel periodo di praticantato fa esperienza
politica nel Partito radicale. L’esperienza più impegnativa dell’inizio della
professione sarà il primo maxiprocesso di Palermo, dove, assieme all’avv.
Marasà, difenderà una decina di imputati, tra i quali Vittorio Mangano.
Dall’esperienza del maxiprocesso e dall’«incontro» in aula con i primi pentiti
nascerà il libro L’altra faccia dei pentiti (La Bottega di Hefesto,
1990).
Dina Lauricella. Palermitana «doc», vive a Roma da
14 anni. Ha scritto per diversi quotidiani e settimanali. Nel 2007 entra a far
parte della squadra di inviati di Annozero. Per Michele Santoro firma
diversi speciali, tra cui La Mafia che cambia, nella quale parla in tv
per la prima volta Angelo Provenzano, il figlio del super boss. Stato
criminale, la puntata di Servizio Pubblico con ospite Vincenzo
Scarantino, trae spunto da questo libro.
Bombe, omicidi e stragi in Sicilia: ecco
tutte le accuse a “faccia da mostro”. Pentiti lo
additano, quattro procure lo indagano: Giovanni Aiello, ex poliziotto col volto
sfregiato, sarebbe in realtà un sicario per delitti ordinati da pezzi deviati
dello Stato, oltre che dai padrini. Dall'eversione nera degli anni '70
all'uccisione di Falcone e Borsellino: la storia scritta da Attilio Bolzoni e
Salvo Palazzolo su “La Repubblica”. Ci sono almeno quattro uomini e una donna
che l'accusano di avere ucciso poliziotti come Ninni Cassarà e magistrati come
Falcone e Borsellino, di avere fornito telecomandi per le stragi, di avere messo
in giro per l'Italia bombe "su treni e dentro caserme". Qualcuno dice che a
Palermo ha assassinato pure un bambino. Su di lui ormai indagano tutti,
l'Antimafia e l'Antiterrorismo. Sospettano che sia un sicario per delitti su
commissione, ordinati da Cosa Nostra e anche dallo Stato. Lo chiamano "faccia da
mostro" e ha addosso il fiato di un imponente apparato investigativo che vuole
scoprire chi è e che cosa ha fatto, da chi ha preso ordini, se è stato
trascinato in un colossale depistaggio o se è davvero un killer dei servizi
segreti specializzato in "lavori sporchi". Al suo fianco appare di tanto in
tanto anche una misteriosa donna "militarmente addestrata ". Nessuno l'ha mai
identificata. Forse nessuno l'ha mai nemmeno cercata con convinzione. Vi
raccontiamo per la prima volta tutta la storia di Giovanni Aiello, 67 anni,
ufficialmente in servizio al ministero degli Interni fino al 1977 e oggi
plurindagato dai magistrati di Caltanissetta e Palermo, Catania e Reggio
Calabria. Vi riportiamo tutte le testimonianze che l'hanno imprigionato in una
trama che parte dal tentativo di uccidere Giovanni Falcone all'Addaura fino
all'esplosione di via Mariano D'Amelio, in mezzo ci sono segni che portano al
delitto del commissario Cassarà e del suo amico Roberto Antiochia,
all'esecuzione del poliziotto Nino Agostino e di sua moglie Ida, ai suoi
rapporti con la mafia catanese e quella calabrese, con terroristi della destra
eversiva come Pierluigi Concutelli. E con l' intelligence . Anche se,
ufficialmente, "faccia da mostro" non è mai stato nei ranghi degli 007. Negli
atti del nuovo processo contro gli assassini di Capaci — quello che coinvolge i
fedelissimi dei Graviano — che sono stati appena depositati, c'è la
ricostruzione della vita e della carriera di un ex poliziotto dal passato
oscuro. La sua scheda biografica intanto: "Giovanni Pantaleone Aiello, nato a
Montauro, provincia di Catanzaro, il 3 febbraio del 1946, arruolato in polizia
il 28 dicembre 1964, congedato il 12 maggio 1977, residente presso la caserma
Lungaro di Palermo fino al 28 settembre 1981, sposato e separato con l'ex
giudice di pace.., la figlia insegna in un'università della California". Reddito
dichiarato: 22 mila euro l'anno (ma in una recente perquisizione gli hanno
sequestrato titoli per un miliardo e 195 milioni di vecchie lire), ufficialmente
pescatore. Sparisce per lunghi periodi e nessuno sa dove va, racconta a tutti
che la cicatrice sulla guancia destra è "un ricordo di uno scontro a fuoco in
Sardegna durante un sequestro di persona", ma nel suo foglio matricolare è
scritto che "è stata causata da un colpo partito accidentalmente dal suo fucile
il 25 luglio 1967 a Nuoro". Il suo dossier al ministero dell'Interno, allora:
qualche encomio semplice per avere salvato due bagnanti, un paio di punzioni,
per molti anni una valutazione professionale "inferiore alla media", un
certificato sanitario che lo giudicano "non idoneo al servizio per turbe
nevrotiche post traumatiche ". Dopo il congedo è diventato un fantasma fino a
quando, il 10 agosto del 2009, è stato iscritto nel registro degli indagati "in
riferimento all'attentato dell'Addaura e alle stragi di Capaci e di via
D'Amelio". Il 23 novembre del 2012 tutte le accuse contro di lui sono state
archiviate. Ma dopo qualche mese "faccia da mostro" è scivolato un'altra volta
nel gorgo. È sotto inchiesta per una mezza dozzina di delitti eccellenti in
Sicilia e per alcuni massacri, compresi attentati ai treni e postazioni
militari. Le investigazioni — cominciate dalla procura nazionale antimafia di
Pietro Grasso — ogni tanto prendono un'accelerazione e ogni tanto
incomprensibilmente rallentano. Forse troppe prudenze, paura di toccare fili ad
alta tensione. Ma ecco chi sono tutti gli accusatori di Giovanni Aiello e che
cosa hanno detto di lui. Il primo è Vito Lo Forte, picciotto palermitano del
clan Galatolo. La sintesi del suo interrogatorio: "Ho saputo che ci ha fatto
avere il telecomando per l'Addaura, ho saputo che era coinvolto nell'omicidio di
Nino Agostino e che era un terrorista di destra amico di Pierluigi Concutelli,
che ha fatto attentati su treni e caserme, che ha fornito anche il telecomando
per via D'Amelio". Poi Lo Forte parla del clan Galatolo che progettava
intercettazioni sui telefoni del consolato americano di Palermo, ricorda "un
uomo con il bastone" amico di Aiello che è un pezzo grosso dei servizi, che ogni
tanto a "faccia da mostro" regalavano un po' di cocaina. Dice alla fine: "Era un
sanguinario, non aveva paura di uccidere". E racconta che Aiello, il 6 agosto
1985, partecipò anche all'omicidio di Ninni Cassarà e dell'agente Roberto
Antiochia: "Me lo riferì Gaetano Vegna della famiglia dell'Arenella. Dopo,
alcuni uomini d'onore erano andati a brindare al ristorante di piazza Tonnara.
Insieme a loro c'era anche Aiello, che aveva pure sparato al momento
dell'omicidio, da un piano basso dell'edificio". Il secondo accusatore si chiama
Francesco Marullo, consulente finanziario che frequentava Lo Forte e il
sottobosco mafioso dell'Acquasanta. Dichiara: "Ho incontrato un uomo con la
cicatrice in volto nello studio di un avvocato palermitano legato a
Concutelli... Un fanatico di estrema destra... dicevano che quello con la
cicatrice fosse uomo di Contrada (il funzionario del Sisde condannato per
concorso esterno in associazione mafiosa, ndr) ". Il terzo che punta il dito
contro Giovanni Aiello è Consolato Villani, 'ndranghetista di rango della cosca
di Antonino Lo Giudice, boss di Reggio Calabria: "Una volta lo vidi... Mi colpì
per la particolare bruttezza, aveva una sorta di malformazione alla mandibola...
Con lui c'era una donna, aveva capelli lunghi ed era vestita con una certa
eleganza". E poi: "Lo Giudice mi ha parlato di un uomo e una donna che facevano
parte dei servizi deviati, vicini al clan catanese dei Laudani, gente
pericolosa. In particolare, mi diceva che la donna era militarmente addestrata,
anche più pericolosa dell'uomo ". E ancora: "Lo Giudice aggiunse pure che questi
soggetti facevano parte del gruppo di fuoco riservato dei Laudani, e che avevano
commesso anche degli omicidi eclatanti, tra cui quello di un bambino e di un
poliziotto e che erano implicati nella strage di Capaci". Il quarto accusatore,
Giuseppe Di Giacomo, ex esponente del clan catanese dei Laudani, di "faccia da
mostro" ne ha sentito parlare ma non l'ha mai visto: "Il mio capo Gaetano
Laudani aveva amicizie particolari… In particolare con un tale che lui indicava
con l'appellativo di “ vaddia” (guardia, in catanese, ndr). Laudani intendeva
coltivare il rapporto con “ vaddia” in quanto appartenente alle istituzioni ".
Per ultima è arrivata la figlia ribelle di un boss della Cupola, Angela
Galatolo. Qualche settimana fa ha riconosciuto Aiello dietro uno specchio: "È
lui l'uomo che veniva utilizzato come sicario per affari molto riservati, me lo
hanno detto i miei zii Raffaele e Pino". Tutte farneticazioni di pentiti che
vogliono inguaiare un ex agente di polizia? E perché mai un pugno di
collaboratori di giustizia si sarebbero messi d'accordo per incastrarlo? Fra
tanti segreti c'è anche quello di un bambino ucciso a Palermo. Ogni indizio
porta a Claudio Domino, 10 anni, assassinato il 7 ottobre del 1986 con un solo
colpo di pistola in mezzo agli occhi. Fece sapere il mafioso Luigi Ilardo al
colonnello dei carabinieri Michele Riccio: "Quell'uomo dei servizi di sicurezza
con il viso sfigurato era presente quando fecero fuori il piccolo Domino". Poi
uccisero anche il mafioso: qualcuno aveva saputo che voleva pentirsi. La figlia
ribelle di un boss della Cupola ha incastrato l'uomo misterioso che chiamano
"faccia da mostro". L'ha indicato come "un sicario" al servizio delle cosche più
potenti di Palermo. È un ex poliziotto, forse anche un agente dei servizi
segreti. Ed è sospettato di avere fatto stragi e delitti eccellenti in Sicilia.
"Ne sono sicura, è lui", ha confermato Giovanna Galatolo dietro un vetro
blindato. Così le indagini sulla trattativa Stato-mafia, sulle uccisioni di
Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino - ma anche quelle sul fallito attentato
all'Addaura e probabilmente sugli omicidi di tanti altri funzionari dello Stato
avvenuti a Palermo - dopo più di vent'anni di depistaggi stanno decisamente
virando verso un angolo oscuro degli apparati di sicurezza italiani e puntano su
Giovanni Aiello. Ufficialmente è solo un ex graduato della sezione antirapine
della squadra mobile palermitana, per i magistrati è un personaggio chiave
"faccia da mostro" - il volto sfigurato da una fucilata, la pelle butterata -
quello che ormai si ritrova al centro di tutti gli intrighi e di tutte le
investigazioni sulle bombe del 1992. "È lui l'uomo che veniva utilizzato come
sicario per affari che dovevano restare molto riservati, me lo hanno detto i
miei zii Raffaele e Pino", ha confessato Giovanna Galatolo, l'ultima pentita di
Cosa Nostra, figlia di Vincenzo, mafioso del cerchio magico di Totò Riina, uno
dei padrini più influenti di Palermo fra gli anni 80 e 90, padrone del
territorio da dove partirono gli squadroni della morte per uccidere il
consigliere Rocco Chinnici e il segretario regionale del partito comunista Pio
La Torre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e il commissario Ninni Cassarà.
"È lui", ha ripetuto la donna indicando l'ex poliziotto dentro una caserma della
Dia. Un confronto "all'americana", segretissimo, appena qualche giorno fa. Da
una parte lei, dall'altra Giovanni Aiello su una piattaforma di legno in mezzo a
tre attori che si sono camuffati per somigliargli. "È lui, non ci sono dubbi. Si
incontrava sempre in vicolo Pipitone (il quartiere generale dei Galatolo, ndr)
con mio padre, con mio cugino Angelo e con Francesco e Nino Madonia", ha
raccontato la donna davanti ai pubblici ministeri dell'inchiesta-bis sulla
trattativa Stato-mafia Nino Di Matteo, Francesco Del Bene e Roberto Tartaglia.
Un riconoscimento e poi qualche altro ricordo: "Tutti i miei parenti lo
chiamavano "lo sfregiato", sapevo che viaggiava sempre fra Palermo e Milano...
". La figlia del capomafia - che otto mesi fa ha deciso di collaborare con la
giustizia rinnegando tutta la sua famiglia - aveva con certezza identificato
Giovanni Aiello come amico di Cosa Nostra anche in una fotografia vista in una
stanza della procura di Caltanissetta, quella che indaga sulle uccisioni di
Falcone e Borsellino. Dopo tante voci, dopo tanti sospetti, adesso c'è qualcuno
che inchioda lo 007 dal passato impenetrabile, scivolato in un gorgo di
inchieste con le ammissioni di qualche altro pentito e di alcuni testimoni.
Sembra finito in una morsa, da almeno un anno Giovanni Aiello è indagato dai
magistrati di quattro procure italiane - quella di Palermo e quella di
Caltanissetta, quella di Catania e quella di Reggio Calabria - che tentano di
ricostruire chi c'è, oltre ai boss di Cosa Nostra, dietro i massacri dell'estate
siciliana del 1992. E anche dietro molti altri delitti importanti degli anni
Ottanta. Ora, con le nuove rivelazioni di Giovanna Galatolo, la posizione
dell'ex poliziotto è diventata sempre più complicata. Questa donna è la
depositaria di tutti i segreti del suo clan, per ordine del padre faceva la
serva ai mafiosi, cucinava, stirava, spesso lavava anche gli abiti sporchi di
sangue, sentiva tutto quello che dicevano, vedeva entrare e uscire dalla sua
casa i boss. E anche Giovanni Aiello. Giovanna Galatolo parla pure del fallito
attentato dell'Addaura, 56 candelotti di dinamite che il 21 giugno del 1989
dovevano far saltare in aria Giovanni Falcone sugli scogli davanti alla sua
villa. Erano appostati lì gli uomini della sua famiglia, i Galatolo. C'era anche
Giovanni Aiello? E "faccia da mostro" è coinvolto nell'uccisione di Nino
Agostino, il poliziotto assassinato neanche due mesi dopo il fallito attentato
dell'Addaura - il 5 agosto - insieme alla moglie Ida? Il padre di Nino Agostino
ha sempre raccontato che "un uomo con la faccia da cavallo" aveva cercato suo
figlio pochi giorni prima del delitto. Era ancora Giovanni Aiello? La sua
presenza è stata segnalata sui luoghi di tanti altri omicidi palermitani. Tutti
addebitati ai Galatolo e ai Madonia. Lui, l'ex agente della sezione antirapine
(quando il capo della Mobile era quel Bruno Contrada condannato per i suoi
legami con la Cupola) ha sempre respinto naturalmente ogni accusa, affermando
anche di non avere più messo piede in Sicilia dal 1976, anno nel quale si è
congedato dalla polizia. Una dichiarazione che si è trasformata in un passo
falso. Qualche mese fa la sua casa di Montauro in provincia di Catanzaro - dove
Giovanni Aiello è ufficialmente residente - è stata perquisita e gli hanno
trovato biglietti recenti del traghetto che da Villa San Giovanni porta a
Messina, appunti in codice, lettere, titoli per 600 milioni di vecchie lire,
articoli di quotidiani che riportavano notizie su boss come Bernardo Provenzano
e su indagini del pool antimafia palermitano, assegni. Dopo quella
perquisizione, gli hanno notificato a casa un ordine di comparizione per il
confronto con la Galatolo, ha accettato presentandosi con il suo avvocato. Il
riconoscimento di Giovanni Aiello segue di molti anni le confidenze di un
mafioso al colonnello dei carabinieri Michele Riccio. Il confidente si chiamava
Luigi Ilardo e disse: "Noi sapevamo che c'era un agente a Palermo che faceva
cose strane e si trovava sempre in posti strani. Aveva la faccia da mostro". Era
il 1996. Poco dopo quelle rivelazioni Luigi Ilardo - tradito da qualcuno che era
a conoscenza del suo rapporto con il colonnello dei carabinieri - fu ucciso.
Anche lui parlava di Giovanni Aiello? Le confessioni della Galatolo stanno
aprendo una ferita dentro la Cosa Nostra palermitana. Non solo misteri di Stato
e connivenze ma anche un terremoto all'interno di quel che rimane delle famiglie
storiche della mafia siciliana. "Come donna e come persona non posso essere
costretta a stare con uomini indegni, voglio essere libera e non appartenere più
a quel mondo, per questo ho deciso di dire tutto quello che so", così è
cominciata la "liberazione" di Giovanna Galatolo che una mattina dell'autunno
del 2013 si è presentata al piantone della questura di Palermo con una borsa in
mano. Ha chiesto subito di incontrare un magistrato: "Ho 48 anni e la mia vita è
solo mia, non me la possono organizzare loro". Del suo passato, la donna ha
portato con sé solo la figlia. L'uomo del mistero che chiamano "faccia da
mostro" l'abbiamo trovato in un paese della Calabria in riva al mare. È
sospettato di avere fatto omicidi e stragi in Sicilia, come killer di Stato. È
un ex poliziotto di Palermo, ha il volto sfregiato da una fucilata. Vive da
eremita in un capanno, passa le giornate a pescare. Quando c'è mare buono prende
il largo sulla sua barca, "Il Bucaniere". Ogni tanto scompare, dopo qualche mese
torna. Nessuno sa mai dove va. Sul suo conto sono girate per anni le voci più
infami e incontrollate, accusato da pentiti e testimoni "di essere sempre sul
luogo di delitti eccellenti" come ufficiale di collegamento tra cosche e servizi
segreti. È davvero lui il sicario a disposizione di mafia e apparati che avrebbe
ucciso su alto mandato? È davvero lui il personaggio chiave di tanti segreti
siciliani? L'uomo del mistero nega tutto e per la prima volta parla: "Sono qui,
libero, mi addossano cose tanto enormi che non mi sono nemmeno preoccupato di
nominare un avvocato per difendermi". Ha 67 anni, si chiama Giovanni Aiello e
l'abbiamo incontrato ieri mattina. Abita a Montauro, in provincia di Catanzaro.
Da questo piccolo comune ai piedi delle Serre - il punto più stretto d'Italia
dove solo trentacinque chilometri dividono il Tirreno dallo Jonio - sono
ripartite le investigazioni sulle stragi del 1992. L'ex poliziotto trascinato
nel gorgo di Palermo l'abbiamo incontrato ieri mattina, davanti al suo casotto
di legno e pietra sulla spiaggia di contrada Calalunga. Sotto il canneto la sua
vecchia Land Rover, in un cortile le reti e le nasse. "La mia vita è tutta qui,
anche mio padre e mio nonno facevano i pescatori", ricorda mentre comincia a
raccontare chi è e come è scivolato nella trama. È alto, muscoloso, capelli
lunghi e stopposi che una volta erano biondi, grandi mani, una voce roca. Dice
subito: "Se avessi fatto tutto quello di cui mi accusano, lo so che ancora i
miei movimenti e i miei telefoni sono sotto controllo, dovrei avere agganci con
qualcuno al ministero degli Interni, ma io al ministero ci sono andato una sola
volta quando dovevo chiedere la pensione d'invalidità per questa". E si tocca la
lunga cicatrice sul lato destro della sua faccia, il segno di un colpo di
fucile. Tira vento, si chiude il giubbotto rosso e spiega che quello sfregio è
diventata la sua colpa. Inizia dal principio, dal 1963: "In quell'anno mi sono
arruolato in polizia, nel 1966 i sequestratori della banda di Graziano Mesina mi
hanno ridotto così durante un conflitto a fuoco in Sardegna, trasferito a
Cosenza, poi a Palermo". Commissariato Duomo, all'anti-rapine della squadra
mobile, sezione catturandi. Giovanni Aiello fa qualche nome: "All'investigativa
c'era Vittorio Vasquez, anche Vincenzo Speranza, un altro funzionario. Comandava
Bruno Contrada (l'ex capo della Mobile che poi è diventato il numero 3 dei
servizi segreti ed è stato condannato per mafia, ndr) e poi c'era quello
che è morto". Di quello "che è morto", Boris Giuliano, ucciso il 21 luglio del
1979, l'ex poliziotto non pronuncia mai il nome. Giura di non avere più messo
piede a Palermo dal 1976, quando ha lasciato la polizia di Stato. Dice ancora:
"Tutti quegli omicidi e quelle stragi sono venuti dopo, mai più stato a Palermo
neanche a trovare mio fratello". Poliziotto anche lui, congedato nel 1986 dopo
che una bomba carta gli aveva fatto saltare una mano. Giovanni Aiello passeggia
sul lungomare di Montauro e spiega quale è la sua esistenza. Mare, solitudine.
Pochissimi amici, sempre gli stessi. Sarino e Vito. L'ex poliziotto torna alla
Sicilia e ai suoi orrori: "So soltanto che mi hanno messo sott'indagine perché
me l'hanno detto amici che sono stati ascoltati dai procuratori, anche mio
cognato e la mia ex moglie. E poi tutti frastornati a chiedermi: ma che hai
fatto, che c'entri tu con quelle storie? A me non è mai arrivata una carta
giudiziaria, nessuno mi ha interrogato una sola volta". Ha mai conosciuto Luigi
Ilardo, il mafioso confidente che accusa un "uomo dello Stato con il viso
deturpato" di avere partecipato a delitti eccellenti? "Ilardo? Non so chi sia".
Mai conosciuto Vito Lo Forte, il pentito dell'Acquasanta che parla della
presenza di "faccia da mostro" all'attentato all'Addaura del giugno 1989 contro
il giudice Falcone? "Mai visto". Mai conosciuto il poliziotto Nino Agostino,
assassinato nell'agosto di quello stesso 1989? "No". E suo padre Vincenzo, che
dice di avere visto "un poliziotto con i capelli biondi e il volto sfigurato"
che cercava il figlio qualche giorno prima che l'uccidessero? "Non so di cosa
state parlando". L'uomo del mistero si tira su la maglia e fa vedere un'altra
cicatrice. Una coltellata al fianco destro. "Un altro regalo che mi hanno fatto
a Palermo". E ancora: "Tutti parlano di me come faccia da mostro, ma non credo
di essere così brutto". Continua a raccontare, del giorno che passò la visita
per entrare in Polizia: "Pensavo di essere stato scartato, invece una mattina mi
portarono in una caserma fuori Roma e mi accorsi che io, con il mio metro e 83
di altezza, ero il più basso". Estate 1964. "Molto tempo dopo ho saputo che
tutti noi, 320 giovanissimi poliziotti ben piantati, eravamo stati selezionati
come forza di supporto - non so dove - per il golpe del generale Giovanni De
Lorenzo". La famosa estate del "rumore di sciabole" contro il primo governo di
centrosinistra, il "Piano Solo". Il primo intrigo dove è finito Giovanni Aiello.
Forse non l'ultimo. Forse. Di certo è che su di lui oggi indagano, su impulso
della direzione nazionale antimafia, quattro procure italiane. Quelle di Palermo
e Caltanissetta per le bombe e la trattativa, quelle di Reggio Calabria e
Catania per i suoi presunti contatti con ambienti mafiosi. I dubbi su "faccia da
mostro" sono ancora tanti. Non finiscono mai.
Quando di un’inchiesta si appropriano i mass
media, vincono le illazioni, i sospetti, i teoremi su una colpevolezza che viene
data per certa quando ancora nessun giudice si è pronunciato. Il libro diventa
un circostanziato atto d’accusa contro il circuito infernale che da troppi anni
lega parte della magistratura a pezzi dell’informazione. Il dr Antonio
Giangrande, cittadino avetranese, autore di decine di saggi, tra cui i libri su
Sara Scazzi, denuncia in tutta Italia: ora basta questa barbarie !!!
Maurizio Tortorella, vicedirettore di “Panorama”,
discute con tempi.it del rapporto fra procure e redazioni: «Non è dignitoso che
un giornalista faccia “copia e incolla” dei documenti che la procura gli passa
sottobanco». Carcerazione preventiva e giustizia politicizzata. Due argomenti
che nella serata di venerdì, all’incontro “Aspettando giustizia” organizzato da
Tempi a Milano, hanno avuto profonda risonanza. Le testimonianze del
generale Mori, di Renato Farina e di Ottaviano Del Turco sono rappresentative di
una giustizia che si mischia con la stampa, diventando una raffigurazione
inquietante della società italiana. Tempi.it ne parla con Maurizio
Tortorella, vicedirettore di Panorama e autore di un bel libro, La
gogna (Boroli editore).
Quando nascono i primi processi a mezzo stampa?
«Tutto comincia con Tangentopoli. Anzi, ancora
prima, quando nel 1989 una nuova modifica alla procedura penale cambia il
procedimento tradizionale. Mentre prima le indagini erano portate avanti
congiuntamente da due magistrati, il pubblico ministero e il giudice istruttore,
che avanzavano congiuntamente, da quel momento il pm diventava l’unico titolare
dell’azione penale. La polizia giudiziaria inizia a dipendere da lui. Per un
tempo illimitato il pm decide su intercettazioni, perquisizioni e arresti, ecc.
Nella sua azione diventa completamente libero. Ogni atto, poi, passa al vaglio
del giudice preliminare, ma solo successivamente all’azione del pm. Non appena
l’atto va a finire tra le mani dell’avvocato difensore dell’imputato e del
giudice, diventa automaticamente pubblicabile. Spesso i pm hanno “amici” che
lavorano in testate giornalistiche di cui condividono la visione politica.
Questa stampa non aspetta la fine del processo, né tantomeno intervista la
controparte, per gettare fango su imputati di cui non è ancora stabilita la
colpevolezza».
Perché si è modificata la procedura penale?
«Si intendeva migliorare le nostre procedure
penali. Il nostro codice aveva caratteristiche arretrate, ben lontane da quelle
europee, considerate più moderne. Ma la cura è stata peggiore della malattia che
si voleva debellare. Questo meccanismo infernale funziona anche laddove
l’avvocato dell’indagato rifiuti di ritirare l’interrogatorio. È il caso di
Guido Bertolaso. Sono usciti sulla stampa dei virgolettati di un interrogatorio
che non potevano che venire dall’accusa, perché la difesa ha rifiutato il ritiro
dei documenti. A quanto pare, è necessario sentire soltanto l’accusa per
redigere un articolo».
La “gogna” mediatica colpisce tutti
indiscriminatamente o ha una certa predilezione verso un colore politico?
«Il garantismo non è un’idea molto praticata in
Italia. Un tempo, fino agli anni Settanta, era la sinistra a essere garantista,
a fronte di una destra forcaiola che chiedeva più galera, pene pesanti e l’uso
della custodia cautelare. Adesso, le parti si sono invertite. È la sinistra
forcaiola a chiedere misure pesantissime, mentre il centrodestra ha un
orientamento garantista».
Pubblicare stralci di documenti prima della
sentenza segue la deontologia professionale?
«Si dovrebbero ascoltare più voci e diversi punti
di vista prima di toccare temi così delicati. Trovo mortificante che in troppi
casi un pezzo si risolva aspettando che dalla procura arrivino delle carte. Non
è dignitoso che un giornalista faccia “copia e incolla” dei documenti che la
procura gli passa sottobanco. Se consideri che il pm di Palermo, dopo che
Panorama ha pubblicato parte dell’intercettazione tra il presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano e l’ex ministro Nicola Mancino, ha smentito di
aver passato lui stesso le carte, giustificandosi che Panorama non è un
giornale “amico”, ti spaventi. Perché significa che ci sono media “amici” e
media “nemici”. E quelli amici, inevitabilmente, sono dello stesso colore
politico del magistrato in questione».
La carcerazione preventiva e le lungaggini
della giustizia italiana aiutano “la gogna”?
«Certo. Nello Rossi, procuratore aggiunta a Roma e
appartenente a Magistratura democratica, ammette che oggi ha più impatto un
arresto di una sentenza di primo grado. Perché? Sul piano emotivo,
l’immediatezza di un arresto ha più effetto di una sentenza, che impiega anni
prima di essere confermata o smentita. Nessuno più segue i processi – come
quello di Ottaviano Del Turco – perché questi si svolgono sui giornali. Il vero
processo è di carta.
Sbattere il mostro in prima pagina: quando l’orco
è uno di noi, scrive in un suo editoriale Raffaella De Grazia. Massimo e Carlo,
padri di famiglia realizzati e felici. Massimo e Carlo, lavoratori stacanovisti
dalla vita senza ombre. Sono i vicini di casa ideali, i mariti fedeli, coloro ai
quali affidereste volentieri i vostri figli, gli amici di mille bevute al bar,
mentre si guarda l’ennesima partita di calcio. Se è vero ciò che sostiene Goya –
e cioè che “Il sonno della ragione genera mostri” – allora Massimo e Carlo sono
gli esempi più eclatanti di come, spesso, la ricerca dell’esecutore di
crimini tanto efferati quanto immotivati che macchiano di sangue il nostro Bel
Paese debba essere indirizzata poco lontano dalle sempre meno rassicuranti mura
domestiche, più vicino a quella che l’uomo medio, erroneamente, denomina la
“zona sicura”. Il “mostro”, identificato comunemente come lo sconosciuto, lo
“straniero” che porta via la serenità ad una piccola comunità pare essere,
invece, sempre più spesso un componente della stessa. E’ inserito perfettamente
nel tessuto sociale del paese che gli ha dato i natali, contribuisce
all’economia autoctona, conosce tutto di tutti. Nessuno dei suoi parenti o amici
ha però idea del suo “lato oscuro”, delle sue perversioni inconfessabili,
nemmeno nell’attimo stesso in cui il mostro le confessa, lasciando attoniti
persino i più diffidenti tra i suoi conterranei. Il caso di Avetrana ha fatto
tristemente “scuola” in tal senso. Come dimenticare lo sgomento di parenti,
amici e vicini di casa nel conoscere la vera, presunta natura della famiglia
Misseri, umili braccianti fuori le mura domestiche ma, al contempo, spietati
killer di una 15enne, peraltro loro stretta parente? Eventi drammatici come il
caso di Sarah Scazzi hanno catalizzato l’attenzione mediatica, generando
un’ondata di morboso interesse attorno a simili crimini dettati dall’odio. Nello
stesso periodo in cui le indagini sull’omicidio della piccola Sarah proseguivano
– tra dichiarazioni ufficiali e smentite mezzo stampa – un’altra piccola,
innocente creatura spariva, inghiottita dal nulla. Si trattava della 13enne Yara
Gambirasio, grande sorriso e voglia di vivere appieno la sua adolescenza, oramai
alle porte. Il mostro che ha privato la 13enne Yara del suo bene più prezioso –
il diritto alla vita – è stato cercato ovunque. Sin dagli istanti successivi
alla sua sparizione, però, il dito dell’intera comunità di Brembate di Sopra e
non solo era stato puntato solo contro un operaio extracomunitario. Qual era la
sua colpa? Ai compaesani di Yara era forse sembrato più facile “sbattere in
prima pagina” un “corpo estraneo” alla propria comunità? Erano tanti i dubbi che
circolavano attorno ad un caso così complesso, con pochi reperti a disposizione.
Di certo c’è che mai nessun abitante di Brembate avrebbe immaginato di dover
cercare il mostro proprio vicino a casa propria, di identificarlo nelle vesti
dell’ uomo qualunque, sposato, incensurato e papà di tre figli piccoli. Ancora
più cruenta è stata la svolta nel terribile, triplice omicidio di Motta
Visconti. Cristina, Giulia e Gabriele hanno perso la vita per mano di una
persona talmente vicina a loro da risultare assolutamente insospettabile.
Ricordiamo, quasi sempre, più facilmente i nomi dei killer che delle proprie
vittime, quando non dovrebbe essere così. Difficilmente, però, dimenticheremo
quei volti, visibilmente felici nelle foto di rito, la cui esistenza è stata
strappata via per motivi tanto futili quanto squallidi. Voleva un’altra donna il
“papà-mostro” che, nella notte d’esordio “mondiale” della nostra Nazionale, ha
ucciso senza pietà sua moglie ed i suoi due piccoli bimbi, di appena 5 anni e 20
mesi. Una storia raccapricciante che, man mano che il tempo passa, si
arricchisce di orpelli sempre più orridi. Un altro mostro dalla faccia pulita,
che sorride beffardo abbracciando sua moglie. Un altro mostro da sbattere in
prima pagina, per non dimenticare l’orrore perpetrato dall’uomo comune.
Di che ci stupiamo?
Yara, fermato un uomo. E’ già il killer, scrive
“Il Garantista”. Non è detto che sia la fine del giallo iniziato quattro anni
fa ma di sicuro, dopo mesi di stasi apparente nelle indagini, si configura come
una svolta cruciale l’arresto di uomo di quaranta anni accusato di essere
l’assassino di Yara Gambirasio. A riferire della
cattura del presunto colpevole è il ministro dell’Interno in persona:
«Le forze dell’ordine, d’intesa con la magistratura, hanno individuato
l’assassino di Yara Gambirasio. E’ una persona dello stesso paese dove viveva la
vittima»- annuncia Alfano. Ad incastrare l’uomo, un muratore della provincia di
Bergamo, sposato e padre di tre figli, sarebbe stata l’analisi del suo Dna che
è stato ritenuto dagli esperti sovrapponibile con le tracce biologiche ritrovate
sul corpo di Yara ( che era astato rinvenuto il 21 febbraio 2011 dopo quasi un
anno di estenuanti ricerche). Per maggiori dettagli Alfano invita ad essere
pazienti e aspettare le prossime ore. Pazienza di cui però il ministro e
la maggior parte dei media non hanno dato prova additando un uomo che non è
nemmeno ancora stato messo sotto processo come inequivocabilmente colpevole.
Caso Yara, così la stampa sbatte il mostro in
prima pagina, scrive Angela Azzaro su “Il Garantista”.
Un presunto colpevole – al solito – che diventa senza
dubbio l’assassino. Un fermato che viene dato – al solito – in pasto alla rabbia
del popolo. Le indagini sull’omicidio di Yara Gambirasio sono diventate una
brutta pagina di giornalismo e politica, e stavolta non è colpa della
magistratura. Anzi, la procura di Bergamo, a poche ore dal fermo di Massimo
Giuseppe Borsetti, è dovuta intervenire in polemica con il ministro
dell’Interno. Perché Alfano aveva dato la notizia parlando di “assassino”.
Sentenza già emessa. Il procuratore Francesco Dettori si è
sentito obbligato a intervenire, per correggere: «Volevamo il massimo riserbo.
Questo anche a tutela dell’indagato in relazione al quale, rispetto alla
Costituzione, esiste la presunzione di innocenza». Il capo del Viminale – ex
ministro della Giustizia – questi dettagli del diritto non li conosce bene.
Perciò ha tuonato, mettendo da parte ogni dubbio: il popolo italiano «aveva il
diritto di sapere e ha saputo per essere rassicurato». L’intervento di
Alfano ha provocato un vero e proprio linciaggio. Rafforzati
dall’intervento del ministro, quasi tutti i giornali, sia nella versione
cartacea ma soprattutto in quella on line, hanno dato libero sfogo alla caccia
al mostro. Il muratore fermato è diventato immediatamente il reietto, la sua
foto sbattuta in prima pagina. Con facebook ci vogliono pochi secondi, si entra
nei profili, si prende l’immagine e si fa girare con scritto: è lui il killer.
Ma è facile anche prendere altre foto, come quelle con i tre figli, due bambine
e un bambino, o quelle con la moglie, adesso chiusi in casa per paura di
ripercussioni. La caccia al mostro: giornali all’assalto. Tra i titoli
peggiori letti ieri, spicca quello di Repubblica. “E’
lui l’assassino di Yara”, dove le virgolette servono formalmente per riprendere
la dichiarazione di Alfano, sostanzialmente sono un modo per condannare ma
salvandosi la coscienza. Senza ipocrisie, Libero (“Preso l’assassino di
Yara”) e il Giornale che mette insieme Yara e il caso di Motta Visconti
(“Schifezze d’uomini”). Su molti quotidiani campeggiava la foto del “colpevole”
e vicino, quasi citazione di un mondo che fu, la parola “presunto”. A non
mettere in prima pagina la foto del mostro solo pochi giornali, tra cui il
Corriere (che la pubblica all’interno, ma l’aveva pubblicata sull’home-page
dell’on line) e l’Unità. Per il resto un lancio di pietre virtuali e
l’indicazione della via dove abita la famiglia del fermato, fosse mai che
qualcuno voglia provare a farla pagare a loro. Un caso esemplare di gogna
mediatica. Certo, non è la prima volta che assistiamo a
processi sommari di questo tipo. Sempre più spesso in Italia la presunzione di
innocenza è un valore costituzionale di cui vergognarsi. Sono tanti i casi
soprattutto di cronaca che diventano processi pubblici, senza né primo, né
secondo, né terzo grado di giudizio. La sentenza è immediata, la condanna certa.
E poco importa se poi nelle aule di tribunale mancano le prove certe. Questa
volta però è accaduto qualcosa di più grave: un ministro dell’Interno che
dovrebbe far rispettare le regole è stato il primo a “tradirle” in nome del
clamore e della pubblicità personale che avrebbe potuto ricavare dalla vicenda.
Del resto, bisogna dire che non è la prima volta che i giornali annunciano la
cattura dell’assassino di Yara. Con la stessa certezza di oggi descrissero come
mostro un ragazzetto egiziano, arrestato 24 ore dopo l’omicidio, e che – si
seppe dopo un paio di settimane – con l’omicidio non c’entrava niente di niente
ed era stato fermato per un clamoroso errore degli inquirenti. Proprio
un caso come questo, così estremo, ci aiuta a capire ancora meglio come
il rispetto delle regole sia fondamentale. Tutto fa pensare che Massimo
Giuseppe Borsetti sia colpevole, ma proprio per questo dobbiamo essere
cauti, per far sì che il processo si svolga nel migliore dei modi, senza
interferenze e senza decidere al posto dei giudici. Solo così si può garantire
una giustizia giusta e non processi sommari. Ma soprattutto solo in questo modo
possiamo evitare di diventare meno umani, più incivili. Il sangue richiama
sangue. La parola assassino solletica gli istinti peggiori. Dopo l’arresto del
presunto assassino di Yara e dopo la confessione di Carlo Lissi di aver ucciso
lui la moglie e due figli a Motta Visconti, sul web è partita una gara a chi la
sparava più grande. Dall’ergastolo alle pene corporali. Fino alla richiesta di
ripristinare la pena di morte, avanzata da Stefano Pedica, esponente della
direzione del Pd, e dal suo compagno di partito, il senatore Stefano Esposito.
Yara: l'oscenità della giustizia-spettacolo,
scrive Marco Ventura su “Panorama”. La cattura del presunto killer doveva
avvenire senza clamori, proteggendo innocenti e minori. Invece, nel tritacarne,
ci sono finiti tutti. Uno spettacolo immondo, inaccettabile, folle. Senza nulla
di umano, di corretto, di giustificato. È la vicenda-spettacolo della cattura
del presunto assassino di Yara Gambirasio. Una storia terribile, data in pasto
senza le dovute cautele - complici autorità e giornalisti - a una pubblica
opinione insieme respinta e attratta, attonita ma anche, forse, perversamente
golosa dei particolari raccapriccianti, addirittura piccanti, di uno dei più
clamorosi delitti di cronaca degli ultimi anni: Yara, la ragazzina di 13 anni
uccisa il 26 novembre 2010 e ritrovata dopo tre mesi. Questa tragedia è
diventata un thriller, un giallo, uno show, un noir, una gara a chi
annuncia per primo la chiusura del caso (che non c’è). A chi ricama meglio. Sui
giornali, in televisione, su Twitter. Senza ritegno, senza alcun rispetto per le
famiglie coinvolte. Un intreccio sul quale ha improvvidamente alzato il sipario
il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, quando secondo i magistrati non erano
ancora concluse le operazioni di convalida del fermo del presunto assassino,
Massimo Giuseppe Bossetti. Da dove cominciare per dire quanto dovremmo provare
disagio per noi stessi, per questo paese, per chi ha gestito la vicenda? Potrei
cominciare da un’ipotesi che oggi pare assurda ma che troppi errori giudiziari
inducono a non considerare così improbabile: l’ipotesi che l’arrestato sia
innocente. A dispetto delle notizie trapelate sul test del Dna confrontato con
la macchia di sangue rinvenuta sugli slip della vittima. A dispetto delle
convinzioni degli inquirenti (i primi però a invitare alla cautela, perché la
prova del Dna non è certa al mille per mille, parliamo sempre di probabilità).
L’altro elemento è la quantità di vite umane gettate nel tritacarne di una
troppo affrettata divulgazione delle indagini. Adulti e minori, padri e
patrigni, figli e figlie, gemelli, fratelli e fratellastri, madri, amanti,
cugini, suoceri, amici... Ormai sappiamo tutto (dell’accusa). Il carpentiere
sarebbe figlio illegittimo della relazione tra un autista morto (e riesumato) e
una donna sposata. L’autista ha una vedova e tre figli (che non c’entrano nulla
ma si ritrovano sulle prime pagine dei giornali: un imprenditore “di successo”,
una madre “felice” e un idraulico “stimato”). I cronisti di “Repubblica”
scrivono che tacciono, “introvabili dietro i loro citofoni nel centro di
Clusone”. Già. L’assedio è cominciato, chissà quanto dovrà durare. C’è la madre
del presunto assassino, che nega la relazione clandestina ma nessuno le crede e
viene descritta come “la donna dei misteri”, barricata dietro le persiane della
sua casa di Terno d’Isola. Addirittura i giornalisti abbozzano sentenze: lei
assicura che Massimo “è figlio naturale di mio marito”, e così “tenta
di salvarlo dalle accuse che lo hanno travolto”. Ecco i sospetti, nascosti
dietro punti interrogativi. Lei cerca “di difendere anche di fronte all’evidenza
quel segreto inconfessabile che solo gli esami del Dna hanno potuto svelare? E
soprattutto: è stata lei negli ultimi mesi più consapevole del figlio che il
cerchio delle indagini si stava stringendo attorno a Massimo?”. Già, perché
tutti a chiedersi se Massimo sapesse, a sua volta, di essere figlio illegittimo
di un altro padre. E con lui la sorella gemella. Poi c’è il terzo figlio,
fratellastro di Massimo, di nome e di fatto del padre che non sa più se credere
alla moglie e affronta il rovello di un possibile adulterio di oltre
quarant’anni fa. Poi ci sono i figli del presunto omicida. Che sono piccoli,
hanno 13, 10 e 8 anni. Da chi hanno saputo che il padre è accusato di un delitto
così efferato? Come potranno proteggersi se l’altro giorno, durante il primo
interrogatorio di Bossetti, tutti sapevano tutto e qualcuno pensava al
linciaggio? C’è la moglie del presunto assassino, e madre dei tre bambini (la
madre, suocera dell’arrestato, viene fotografata mentre si affaccia a una
finestra col cane). Ovviamente diventa titolo sui giornali che lei non fornisca
un alibi al marito. Dice di non ricordare. “È strano, molto strano”,
osserva il “Corriere della Sera”. “Perché quel 26 novembre del 2010
quando Yara sparì all’improvviso, la notizia circolò velocemente. E già durante
la notte cominciarono le ricerche diventate poi mobilitazione di centinaia di
persone per giorni e giorni”. Fino al 26 febbraio 2011, quando fu ritrovata.
“Possibile che una persona della zona, per di più mamma, non ricordi che cosa
ha fatto quella sera?”. Io dico: è possibile eccome. “Che non abbia
tenuto a mente ogni dettaglio e spostamento del marito, dei figli, degli altri
familiari. Il dubbio è che lei sappia tutto, ma abbia così deciso di marcare la
distanza dall’uomo diventato il mostro”. Ma se sono passati tre anni e
mezzo! Ma come si fa a tranciare sospetti così. Non mi è piaciuto neppure
l’incontro del Procuratore di Brescia, Pier Luigi Maria Dell’Osso, con i
giornalisti, quelle risate sull’adulterio e sulla gemella di Bussetti come
“complicazione” per le indagini. Tutto assurdo, tutto fuori luogo. E dire che
invece il questore di Bergamo, Fortunato Finolli, ha correttamente e
ripetutamente precisato che il caso non è per nulla chiuso, che bisogna ancora
fare accertamenti e che poi dovrà tenersi il processo, “con le dovute risultanze
e il dovuto contraddittorio”. Era tanto difficile mantenere questa linea?
Infine, la parte più tragica, quella dei genitori di Yara, costretti a leggere
dopo tanti anni che nelle tre pagine con cui il pubblico ministero dispone il
fermo di Bossetti ci sono quelle righe che fanno titolo sui giornali: “con
l’aggravante di avere adoperato sevizie e avere agito con crudeltà”. Sì, i
genitori di Yara sono i più cauti e taciturni. Gli unici, quasi, all’altezza di
questo mare di sofferenze. E sono quelli che hanno sofferto (e soffrono) di più.
Non spetta a un ministro condannare un indagato, scrive Riccardo Arena su “Il
Post”. l processo penale si celebra solo nelle aule di giustizia (e non sui
giornali). La sentenza di condanna viene pronunciata solo da un giudice (e non
da un Ministro dell’Interno). Ogni imputato è presunto non colpevole fino a
condanna definitiva. Sono questi concetti ovvi per un Paese che si dice civile.
Concetti che evidentemente non sembrano così ovvi per il Ministro dell’Interno
Angelino Alfano. Ministro che si è affrettato ad emettere la sua condanna
definitiva nei confronti di un indagato. “Le forze dell’ordine” ha sentenziato
Alfano “hanno individuato l’assassino di Yara”. Una frase categorica capace di
superare la necessità di celebrare un processo. Un’affermazione lapidaria che si
è sostituita a tre gradi di giudizio: Corte d’Assise, Corte d’Appello e Corte di
Cassazione. Eppure nessuna norma attribuisce al Ministro dell’Interno il compito
di emettere sentenze né di diffondere notizie che riguardano esclusivamente le
attività istituzionali dei magistrati. Attività dei magistrati che, soprattutto
quando riguardano casi che sono nella fase delle indagini, necessitano del
massimo riserbo. Riserbo che se violato potrebbe nuocere alle indagini stesse.
Ma c’è dell’altro. La gogna politica di Alfano ha prodotto anche una gogna
mediatica su tanti giornali. Una gogna mediatica fatta di titoli in prima pagina
che hanno riportato tra le virgolette la sentenza emessa da Alfano: “Yara, preso
l’assassino”. È la contaminazione dell’errore. È l’epidemia del decadimento.
Resta infine un ultima perplessità: perché il ministro Alfano si è spinto tanto
oltre? Al momento non è dato saperlo, anche se è preferibile non pensare al
peggio. Ovvero che lo abbia fatto per ragioni di visibilità. Approfittare
dell’omicidio di una tredicenne per andare sui giornali sarebbe una condotta
davvero inqualificabile. Forse anche peggiore che fingersi giudice.
Caso Scazzi. La pubblica opinione è la "Cavia" di
chi ha il potere di trasmettere formule retoriche elementari e ripetitive...,
scrive Gilberto Migliorini. Alla fine il topolino partorisce la montagna. Forse
l’opera strapperà il primato À la recherche du temps perdu in sette
volumi di Marcel Proust. Non tanto per la lunghezza quanto per il tema della
rievocazione come oeuvre cathédrale, con quella memoria spontanea e
creativa. Come era del tutto logico prevedere, tutto un sistema di sillogismi
(teoremi) può risultare una corposa esercitazione di verità apodittiche e
dimostrazioni congetturali. Quando ci si avventura sulla strada delle inferenze
induttive, quando si dimenticano i fatti e si introducono interpretazioni senza
metterle al vaglio di altri fatti, quando non si tiene conto che i testimoni
sono suggestionabili dal sistema mediatico e che più ci si allontana nel tempo
da un evento tanto più subentrano fisiologicamente mille cose a inquinare
e deformare la memoria… si finisce per dar credito alle fantasie, alle illazioni
e alle deduzioni senza base empirica, scambiando per prove quelli che sono solo
indizi lacunosi e inconsistenti, ricostruzioni di fantasia. Ne nasce un
mastodontico zibaldone da leggere come una prolissa inventio di
accadimenti, magari anche avvincente, ma priva di quella che si suole chiamare
verosimiglianza. Il caso ricorda il feuilleton, quel romanzo d’appendice
pubblicato a episodi e rivolto a un pubblico di massa, di bocca buona. I
detrattori direbbero di un sottogenere letterario che anticipa certi moderni
rotocalchi o le novelle di riviste prevalentemente femminili. Non a caso
una delle opere più famose è i Misteri di Parigi (Les Mystères de Paris),
di Eugène Sue, romanzo pubblicato a puntate, fra il 1842 e il 1843 su Le Journal
des Débats. Non è da dimenticare che dai Misteri di Parigi trarrà
ispirazione Victor Hugo con la prima versione de I miserabili (intitolata
Les mystères) e Alexandre Dumas (padre), con il suo Edmond Dantès. Il
romanzo d'appendice inaugura quella letteratura di massa che ai giorni
nostri è andata annacquandosi nel genere dei rotocalchi e soprattutto nei format
televisivi nazional-popolari. L’attuale romanzo d’appendice televisivo
ha perso qualsiasi velleità letteraria per diventare soltanto un sistema di
gossip salottiero con divagazioni psico-sociologiche da accatto, connotate da
una sorta di narcisismo retorico da libro cuore (Les Mystères de Paris
conservava invece ispirazione e perfino denuncia dei mali sociali, contro la
società del suo tempo, contro un sistema giudiziario ed economico incapace di
punire i veri colpevoli, anticipando le più complesse e approfondite analisi del
naturalismo dei fratelli Goncourt, di Zola e del verismo italiano). Tutta la
storia relativa al caso di Avetrana è ricca di misteri, cominciando dalle strane
confessioni di Michele, ma nello stesso tempo risulta un caso senza capo né
coda, un insieme di fotogrammi spaiati e senza logica. Nulla che abbia la
parvenza di un mosaico dove le tessere si embricano con naturale
verosimiglianza, sembra piuttosto un collage dove tutto ha l’apparenza di un
quadro surreale, quasi un sogno con un incubo al risveglio. Evidentemente c’è
un’altra verità che sfugge alla comprensione. Solo un’indagine che riparta da
zero può riuscire a mettere insieme le tessere del puzzle senza pregiudizi e
senza teoremi, con esiti che potrebbero risultare del tutto imprevedibili, forse
perfino ribaltando ruoli e status dei personaggi. Di certo e assodato, c’è solo
il corpo della povera ragazza in fondo al pozzo e quelle strane narrazioni di
Michele, con un carattere vagamente onirico, e quei sogni che fanno da
contraltare a una vicenda avvolta in una sorta di fantasia spettrale. Tanti
operatori del settore criminologico (omicidi irrisolti) che affollano gli studi
televisivi dimostrano notevoli capacità dialettiche quando discettano di cold
case. Un florilegio di analisi e di affermazioni fondate su fantasticherie,
dicerie, astruserie, pressapochezze… i classici ragionamenti per assurdo,
sillogismi formulati senza il ben che minimo riscontro, tutto sulle spalle di
poveri cristi messi alla berlina e senza che nessun settore del parlamento
italiano abbia niente da ridire, rappresentanti politici solitamente così pronti
ad attivarsi quando si invocano i diritti inalienabili della difesa per uno di
loro fino al completamento di tutto l’iter giudiziario. Due imputate sono tenute
in galera con motivazioni a dir poco sorprendenti in attesa dei successivi gradi
di giudizio. Ovvio che due donne di estrazione contadina - che tutto un sistema
massmediatico ha provveduto a rappresentare come diaboliche e perverse assassine
- sono in grado con la loro rete di connivenze e di conoscenze non solo di
inquinare le prove servendosi del loro mostruoso sistema di supporto e di
protezione, ma, fidando su relazioni internazionali distribuite in vari paesi,
possono proditoriamente sottrarsi con la fuga in qualche paradiso fiscale dove
hanno accumulato cospicue risorse finanziarie grazie alla loro attività come
bracciante agricola e estetista a tempo perso. Un sistema di linciaggio morale
nei confronti di altri presunti colpevoli di omicidio (fino a sentenza
definitiva), o semplicemente di persone entrate per caso in qualche cold
case, va avanti ormai da anni (salvo qualche meritoria eccezione di
opinionisti garantisti) in trasmissioni televisive che fanno illazioni e
ricavano teoremi non già attraverso inchieste basate su dei fatti - mediante una
meticolosa e obiettiva ricerca di riscontri, magari sul modello della
controinchiesta tesa a sottolineare i dubbi e le incongruenze a favore del più
debole o del meno ‘simpatico e fotogenico’ - ma su delle interpretazioni
capziose con l’unico fine di creare audience indipendentemente da criteri di
verità, obiettività e trasparenza. A questo si aggiungono sedicenti esperti che
forniscono interpretazioni scientifiche senza indicare alcun criterio
epistemologico, ma solo sulla base di considerazioni empiriche o semplicemente
di impressioni soggettive. Semplificazioni che farebbero inorridire qualunque
investigatore serio abituato a esercitare il dubbio e a relativizzare le
conclusioni in ragione della complessità della realtà investigativa (con tutte
le sue implicazioni giuridiche e metodologiche). Si tratta dei limiti di
qualsiasi stereotipo di indagine applicato a situazioni che non sono mai quelle
di laboratorio in cui si possono individuare con assoluta certezza le variabili
(dipendenti e indipendenti) in una situazione controllata. Programmi con
opinionisti che parlano spesso senza cognizione di causa, senza veri strumenti
interpretativi, senza esperienza sul campo… ma influenzando e orientando
un’opinione pubblica educata alla superficialità. Un processo di retroazione che
finisce per determinare una sorta di profezia che si autoadempie attraverso
l’individuazione di colpevoli sulla base esclusivamente di una influenza
mediatica che nei casi più estremi diventa psicosi collettiva e ricerca di un
capro espiatorio. Tutto questo avviene soprattutto in periodi di crisi, quando
le difficoltà socio-economiche delle famiglie e la ricerca di compensazioni alle
frustrazioni e all’angoscia del futuro determinano situazioni di stress e il
bisogno di scaricare tensioni e difficoltà emozionali attraverso identificazioni
proiettive e protagonismi per interposta persona. Da anni si effettua una sorta
di teatro dell’assurdo con giudizi sommari attraverso format ammantati di
approfondimento informativo con un circo di opinionisti dall’aria da Sherlock
Holmes, armati vuoi di un armamentario da detective improvvisato e vuoi con
teorie vagamente neo-lombrosiane, frenologiche, o vuoi semplicemente con il
supporto dell’autorevolezza presenzialista di volti da sempre incorniciati nel
rettangolo del televisore. La locuzione in dubbio pro reo assume un
valore puramente teorico se non entra a far parte dei processi di inferenza
logica già nella fase preliminare delle indagini, come forma mentis, in caso
contrario, una volta presa una strada è come viaggiare sui binari della ferrovia
andando in capo al mondo (un mondo per lo più inventato attraverso teoremi
fantasiosi e prove(tte) abborracciate con molta fantasia e zero riscontri. Il
dubbio investigativo dovrebbe costituire l’abito mentale di qualsiasi ricerca in
qualsiasi ambito. Quel dubbio metodico che consente di tornare continuamente sui
propri passi per verificare che qualche perverso particolare possa aver messo
l’indagine su una strada sbagliata. Con l’avvento delle prove scientifiche, armi
notoriamente a doppio taglio se usate come verifica, e non come falsificatori
potenziali, si possono davvero fare danni notevoli. Alcuni sanno lavorare con
metodo e consapevolezza, ma altri scambiano un indizio per un
passepartout che in quattro e quattr’otto risolve un caso miracolosamente. Siamo
tutti in pericolo di errore giudiziario, e senza voler fare di ogni erba un
fascio, perché il lavoro dell’inquirente e del giudice è duro, difficile e
oneroso (e in qualche caso molto pericoloso quando si ha a che fare con la
delinquenza organizzata come la storia del nostro paese dimostra con veri eroi
che hanno pagato con la vita l’abnegazione e il servizio alla collettività).
Occorre però dire che spesso si ha l’impressione che la categoria si chiuda a
riccio in una autodifesa, a prescindere, quando qualcuno dei suoi rappresentanti
non si dimostra all’altezza...Il caso di Michele Misseri è poi emblematico. Si
tratta di un contadino che in più di un’occasione ha dimostrato di trovarsi in
un grave stato confusionale, che ha accumulato una serie di confessioni
(narrazioni) diverse, contraddittorie e inattendibili, un teste che porta indizi
senza prove, che dichiara cose senza riscontri (nessun elemento che attesti che
nella casa di via Deledda sia avvenuto un delitto, nessun elemento che dimostri
che la sua auto abbia trasportato un cadavere, nessun elemento che provi che lui
abbia infilato il cadavere nel pozzo, nessuna prova che la povera Sarah abbia
raggiunto la casa di via Deledda. L’uomo, in palese stato di sofferenza
psichica, non viene sottoposto a perizia psichiatrica per capire qualcosa di più
della sua personalità, se per caso non sia stato invece semplice testimone di
qualcosa che lo ha sconvolto emotivamente. Tornando ai mass media e alla loro
utilizzazione, occorre dire che l’influenza sull’opinione pubblica è tale da
determinarne l’orientamento e da influenzarne l’interesse puntando sulla
spettacolarizzazione e facendo leva sulla curiosità morbosa e sul giudizio di
pancia, abituando il target a dare valutazioni basate sull’emotività e sul
disimpegno. Tale atteggiamento è tanto più diseducativo quanto più trasforma
l’audience in un modello di elettore sempre meno informato e che offre risposte
pavloviane. Non a caso i cold case, in quanto casi irrisolti e
problematici, rappresentano un test di influenza e un banco di prova su un
target sprovvisto di autonomi e adeguati strumenti interpretativi, sempre più
influenzabile attraverso l’uso di format che ne orientano le scelte e le
modalità di reazione, con input emozionali programmati secondo il vecchio e
inossidabile modello SR. Il caso in parola risulta emblematico, dal punto di
vista mediatico, della facilità con la quale l’opinione pubblica può essere
influenzata utilizzando una comunicazione basata su formule retoriche elementari
e ripetitive e senza mai mettere in dubbio i contenuti espressi
dall’autorevolezza del mezzo televisivo…
Quando la giustizia semina morti si chiama
ingiustizia: Mimino Cosma è uno dei tanti uccisi dalla malagiustizia? Scrive
Massimo Prati sul suo Blog, Volando Controvento. Per tanti di noi è difficile
capire cosa significhi vivere nello stress e cosa lo stress porti in dote al
fisico umano. Parlo in special modo dei giovani, di quelli fortunati che non
hanno mai avuto a che fare con le disgrazie e vivono ancora nella leggerezza
della loro età senza mai essere passati fra quelle brutte esperienze che
cambiano il modo di vedere la vita. Inoltre, non tutte le persone soffrono in
maniera cruenta lo stress: questo perché non siamo tutti uguali, non tutti
reagiamo alla stessa maniera e non tutti siamo costretti a vivere quelle
tragedie familiari che stroncano il pensiero e marciscono la speranza. Eppure i
periodi stressanti esistono e prima o poi toccano a tutti noi. Chi non trova
lavoro e non sa come andare avanti soffre di stress. Chi ha una famiglia e non
sa come mantenerla soffre di stress. Una donna incinta che non si sente pronta a
diventare madre soffre di stress. Suo marito, a cui un figlio cambierà
radicalmente la vita, soffrirà di stress. Chi subisce la morte improvvisa di un
padre o di una madre, perdendo un punto di riferimento importante, soffre di
stress. Chi subisce la morte improvvisa di un figlio, perdendo quanto di più
caro aveva al mondo, soffre di stress. Lo stress è sempre dietro l'angolo,
pronto a colpire chiunque nei momenti meno attesi. Anche le persone a cui pare
andare tutto bene. Per capire a cosa portino i periodi stressanti, possiamo far
riferimento a diversi studi scientifici. Ad esempio il Brain and Mind
Research Institute dell'Università di Sydney, ha pubblicato una ricerca sul
Medical Journal of Australia in cui stabilisce che l'infarto è provocato
dallo stress che eventi diversi possono scatenare nell'uomo. Ma non è lo stress
da lavoro che uccide, non è quello che si prova in ufficio o in una catena di
montaggio. No, a uccidere è quello provocato da fatti imprevisti, straordinari,
e da tragedie familiari. Un altro studio, questa volta dei ricercatori della
Ohio State University, pubblicato sul "Journal of Clinical Investigation"
nell'agosto del 2013, ha cercato di stabilire come i tumori possano svilupparsi
in caso di stress. Da tempo immemore la scienza ha ipotizzato una correlazione
fra stress e cancro, senza però mai individuare un nesso concreto che portasse a
una conferma della supposizione. Ma la ricerca non ha smesso di studiare e
sperimentare, ed ora gli scienziati statunitensi hanno trovato nel gene ATF3 la
possibile chiave per lo sviluppo e la diffusione delle metastasi, con la
conseguente morte per cancro. In particolare si può dire che il gene era già
conosciuto e già si sapeva che si attivava in condizione di stress. Ciò che gli
esperimenti hanno dimostrato è che il gene non solo uccide le cellule sane, ma
agendo in modo irregolare aiuta anche la proliferazione delle metastasi. "Se
il corpo è in perfetto equilibrio - ha affermato lo scienziato Tsonwin Hai -
non è un gran problema. Quando il corpo è sotto stress, però, cambia il
sistema immunitario. E il sistema immunitario è una lama a doppio taglio".
Detto questo c'è da star certi che l'essere indagati in un caso criminale dal
grande profilo pregiudizievole, e dalla grande eco mediatica (essere indagati da
una procura, ormai si è capito, significa anche essere additati dai compaesani a
causa del pregiudizio iniettato nel popolo da giornalisti e opinionisti
sapientoni), porta stress al fisico che più facilmente può subire un infarto o
una malattia incurabile. Per averne conferma si potrebbe cadere nella tentazione
di ricordare sin da subito il compianto Enzo Tortora, morto di tumore dopo anni
di tortura mediatica e pregiudizi. Ma non serve scomodare il caso più eclatante
della nostra stampa, perché tanti più gravi (ma meno pubblicizzati) stanno a
dimostrare che chi viene indagato, se innocente, soffre in maniera esponenziale
di stress, quello stress che può portare alla morte. Prendiamone alcuni e
partiamo da Don Giorgio Govoni, che dal '97 al 2000 fu perseguitato dai
magistrati che lo additavano a pedofilo-satanista. Nell'ultima udienza a cui
assistette, il pubblico ministero lo dipinse come un rifiuto della società, come
capo di una setta perversa, e chiese per lui 14 anni di carcere. Il giorno dopo
Don Giorgio, agitatissimo, si presentò nello studio del suo legale: aveva
bisogno di sfogarsi e di sentire una voce amica. Ma non riuscì a parlargli
perché morì di infarto in sala d'attesa. Fu condannato da morto Don Giorgio. Per
il giudice, dopo 57 udienze e 300 testimoni (un processo costosissimo), era lui
a dire messa nei cimiteri della zona, era lui l'uomo vestito di nero che diceva
"diavolo nostro", invece che Padre nostro, mentre i satanisti in maschera
lanciavano bambini per aria o li sgozzavano gettandoli nel fiume. Ma c'erano
davvero satanisti in quei cimiteri? No, non c'erano satanisti e non c'erano
abusi. Tutto venne allestito da un Pm che si basò su quanto stabilito da una
psicologa dei servizi sociali di Modena. Ma i procuratori si accanirono e quella
brutta storia rovinò la vita anche ad altri. Parlo di una madre che quando le
portarono via il figlio si gettò dalla finestra, parlo anche dei coniugi Covezzi
che nel '98 se ne videro portar via 4 di figli dai magistrati. L'assoluzione
definitiva per loro è giunta nel 2013, ma Delfino Covezzi non se l'è goduta
perché subito dopo è morto senza poter rivedere i quattro figli strappatigli
dalla giustizia e dati in adozione quindici anni prima del verdetto definitivo
(solo in primo grado fu condannato). Storie allucinanti di sofferenza e stress
incessante che portano anzitempo alla morte e crescono solo per il propagarsi
del pregiudizio, lo stesso che ancora oggi fa dire a tanti italiani che Enzo
Tortora qualcosa aveva fatto, altrimenti non sarebbe stato indagato. Storie
allucinanti come quella di Giovanni Mandalà che assieme a Giuseppe Gullotta fu
condannato per aver ucciso due carabinieri (strage di Alcamo Marina). Giovanni
si è sempre proclamato innocente, come Giuseppe a cui la stampa l'anno passato
ha dedicato tante parole perché ha chiesto allo Stato 69 milioni di euro
per aver trascorso 22 anni in carcere da innocente. Ma il signor Mandalà non è
riuscito ad arrivare alla sentenza di assoluzione. Lui è morto nel '98. Morto
dopo aver subito il dolore assoluto, vittima di un tumore. Come in carcere è
morto Michele Perruzza, un uomo incastrato in una storia che ha attinenze con
quella di Avetrana. Forse non la ricorderete, perché contemporanea al delitto di
via Poma (Simonetta Cesaroni) e perché in pochi giorni i magistrati dissero di
aver scoperto la verità: e come sempre i giornalisti si defilarono senza
approfondire né chiedersi se le accuse mosse dalla procura fossero reali.
Michele Perruzza nel 1990 abitava in una piccola frazione di Balsorano,
provincia de L'Aquila, dove viveva anche sua nipote, la piccola Cristina
Capoccitti di soli sette anni. Il 23 agosto, dopo cena, Cristina uscì di casa
per giocare all'esterno. Ma quando sua madre la chiamò perché si stava facendo
buio, la bimba non rispose. Le ricerche si protrassero per tutta la notte, poi
arrivò l'alba e il corpo di Cristina venne visto: la bimba era svestita e aveva
la testa spaccata. Due giorni dopo un ragazzo di 13 anni, Mauro Perruzza (figlio
di Michele e cugino di Cristina), confessò l'omicidio. Stavano facendo un gioco,
disse, quasi erotico. Poi lei cadde sbattendo la testa su una pietra e lui, per
paura, la strangolò. Ma gli inquirenti non gli credettero, non ce lo vedevano ad
uccidere la cugina e così lo interrogarono per ore fino a fargli dire che era
stato suo padre a uccidere e che lui lo aveva visto perché si trovava a 50 metri
dal luogo del crimine. Ma questa fu solo la sua seconda versione, nel tempo ne
fornì 17 e tutte diverse. Però non appena inserì suo padre, un'auto corse fino
alla sua casa per arrestarlo: era l'alba del 26 agosto e nessuno verificò le
parole del ragazzo. Quando in caserma gli passò davanti in manette, i
giornalisti lo sentirono urlare: "Scusami papà, sono stato costretto!". In
effetti il ragazzo, si scoprirà poi, era stato intimidito di brutto. In ogni
caso suo padre non fece più ritorno a casa. Ma mai accusò il figlio per quel
crimine. Così anche sua moglie che mai ha detto qualcosa contro suo figlio. Come
sempre se non ci sono prove si ragiona di pregiudizio usando il solito
ragionamento del: "Perché un figlio dovrebbe incolpare il padre se non è
colpevole?". Che equivale al moderno: "Perché un padre dovrebbe incolpare la
figlia se non è colpevole?". Così, basandosi su un pregiudizio, in un processo
in cui l'avvocato del sempliciotto muratore Perruzza era lo stesso che difendeva
suo figlio, inconcepibile, il 15 marzo del '91 ci fu una prima condanna
all'ergastolo. In paese ormai tutti erano certi della colpevolezza del Perruzza
e quella sera si festeggiò la condanna coi fuochi d'artificio. Il pregiudizio
della gente era nato da un obbrobrio investigativo e giudiziario in cui non
mancava neppure un'audiocassetta scomparsa (era quella di un interrogatorio in
cui, si dice, si sentivano distintamente i colpi di un pestaggio). Alcuni
giornalisti, solo un paio a dire il vero, muovendosi con sapienza cercarono di
entrare nella verità. Ma non era facile e Gennaro De Stefano (uno dei pochi
giornalisti veri, purtroppo morto anni fa) venne anche intimidito grazie a un
poliziotto che mise della droga nella sua auto prima di una perquisizione (sei
mesi dopo il fatto De Gennaro, per nulla intimidito, fu scagionato e risarcito
con tante scuse). Tralasciando il resto di questa infame storia che procurò solo
dolore, arrivo alla fine. Le Perizie stabilirono che il figlio, da dove aveva
detto di trovarsi non poteva vedere il padre uccidere Cristina. Ma sia in
appello che in cassazione le accuse della procura tennero e nel settembre del
'92 la condanna divenne definitiva. Lo sconcerto subentrò poi, quando in un
processo parallelo (celebrato a Sulmona e non a L'Aquila) si scoprì che sulle
mutandine di Cristina c'era il dna del cugino Mauro, non dello zio. Per cui la
giustizia si trovò agli estremi: la cassazione nel '92 aveva stabilito che
Michele era colpevole oltre ogni ragionevole dubbio, ma nel '98 un giudice,
grazie a buone perizie, certificava nelle sue motivazioni l'innocenza di Michele
Perruzza. Si poteva a quel punto rifare il processo, ma la procura del capoluogo
abruzzese si oppose e alla fine vinsero i procuratori (fra l'altro, il giudice
che aveva condannato all'ergastolo il Perruzza in quel periodo era diventato
procuratore generale de L'Aquila). Comunque lo strazio e lo stress accesero in
maniera esponenziale la sofferenza di Michele Perruzza quando questi capì che
nessuno avrebbe fatto nulla per aiutarlo. Morì nel gennaio del 2003 a causa di
un infarto e le sue ultime parole furono: "Dite a tutti che non ho ucciso io
Cristina". Le disse in punto di morte ai medici dell'ambulanza che inutilmente
cercarono di salvargli la vita. Storie di ordinaria follia? Casi rari che non
fanno testo e non gettano ombre su una giustizia da decenni malata? Una
giustizia spesso falsa e coadiuvata dai media che iniettano il pregiudizio delle
procure nelle vene del popolo? In Italia ci sono sacerdoti con le palle. Uno si
chiama Don Mario Neva e col suo gruppo (Impsex) da tempo cerca di salvare le
ragazze costrette a battere sulle strade. Lui dieci anni fa disse: "Nel ’600 si
credeva di combattere la peste uccidendo gli 'untori', innocenti accusati di
spargere unguenti mortiferi. Un rito crudele quanto inutile che solo dopo 200
anni ebbe giustizia e cessò. Oggi sta succedendo lo stesso. In buona fede
allora, in buona fede oggi: ma è una buona fede che mette radici profonde e
diventa madre di ogni inquisizione". Ed è proprio così. Nulla è peggio del
pregiudizio e nulla è peggio dello stress che uccide chi sa di essere vittima di
una ingiustizia giudiziaria. La vergogna non vive in chi non ha cuore, ma si
amplifica in chi il cuore lo ha più grande. Ed arrivo a Cosimo Cosma, morto a
causa di un tumore che nessuno può dire lo avrebbe certamente colpito senza lo
stress dovuto alle accuse della procura di Taranto. Mimino non era un santo, ma
con lui la giustizia si è sbizzarrita e ha dimostrato di avere una doppia
personalità (e una doppia morale), perché mentre veniva condannato a Taranto per
aver occultato il corpo di una ragazzina di 15 anni (Sarah Scazzi), a Brindisi
subiva la medesima sorte per qualcosa che risulta essere l'esatto contrario: per
aver messo le mani addosso a chi aveva violentato una ragazza di 16 anni (questa
è l'accusa a cui la difesa ha risposto chiedendo al giudice di riconoscere che
il violentatore al momento del fatto non era in grado di intendere e volere). Un
po' come dire che per la nostra giustizia un missionario può con una mano dare a
un bimbo un pezzo di pane e con l'altra mollargli uno schiaffo. Non c'è logica
in certe accuse, lo so, ma fin quando non si metteranno paletti e regole vere da
rispettare, tutto e il contrario di tutto potrà essere dimostrato dal potere
giuridico consolidato. Perché a tutt'oggi c'è chi può iniziare indagando A ed
arrivare a condannare C senza alcun problema. Perché se non convince la versione
di A si gira la frittata e si manda in galera B. E e se non è possibile
incastrare solo B si gira la pentola in verticale e si condanna anche C. Basta
volere e con sogni e veggenze alla fine si può anche dire che non era una
frittata ma una paella, così da mettere in atto un gioco di prestigio buono per
condannare chiunque. Il problema è che, tranne i soliti noti (e sono pochi),
nessuno protesta: la maggioranza dei media sparge il pregiudizio e anche grazie
a loro, con nulla in mano se non pochi indizi, c'è chi può indagare e condannare
chiunque e credere, e far credere, di essere nel giusto. E se qualche avvocato
in gamba dimostra che non è zuppa quanto portato dai procuratori in tribunale,
per i pubblici ministeri c'è sempre la possibilità giuridica di cambiare la
formula e le ricostruzioni e far credere zuppa il pan bagnato. Questo perché
quando si entra nella categoria degli indagati, per i magistrati e la pubblica
opinione non si è più persone e il dolore che si prova quando nessuno ti crede
non figura essere dolore per chi accusa: in fondo, possono soffrire i
numeri? L'essere umano per certe istituzioni non esiste e il dolore che una
accusa fondata su congetture lascia in dote, come lo stress che si prova nel
sentirsi già giudicati prima del processo finale, passa in secondo piano. Ma non
solo gli indagati sono numeri. Forse non vi rendete conto che tutti noi siamo
solo stupidi numeri scritti in sequenza su una qualche cartella o documento: sia
per la sanità che per la giustizia che per i comuni e il governo. Numeri da
allevare in provetta per gli scopi altrui, tifosi che vengono plagiati dalle
istituzioni e vogliono solo vincere, nei campi di calcio come nella politica e
nei tribunali, e a cui non importa di come si giochi la partita, se si fanno
entrate oltre il limite, se agli avversari che giocano in inferiorità numerica
saltano caviglia e perone, se l'arbitro non si dimostra imparziale, se qualcuno
muore. Fin quando non toccherà a noi di subire tutto va bene, anche lo sport che
non è più sport, la politica che non è più politica e la giustizia che non è più
giustizia. Tanto la pubblica opinione alla fine darà ragione a chi comanda
preferendo mettere in campo la volgarità dell'offesa. Tanto i media non daranno
risalto alla notizia scomoda e nessuno si indignerà se i carcerati che si
proclamano innocenti si suicidano dopo aver perso la speranza, se gli imputati
che si proclamano innocenti muoiono di infarto o di tumore a causa di uno stress
infinito, se chi ha mandato in carcere gli innocenti, morti e non, invece di
venir cacciato dalla magistratura continua a incassare i suoi 100.000 euro
all'anno e a far carriera...
Nicola Izzo: "Così i pm mi hanno
rovinato". L’intervista di Giacomo Amadori su “Libero
Quotidiano”. In questi giorni in Parlamento si sta discutendo di riforma della
giustizia e responsabilità civile dei magistrati. Sono migliaia in Italia le
persone rovinate dagli errori giudiziari delle toghe. E sicuramente uno dei casi
più celebri è quello del prefetto Nicola Izzo. Da qualche mese è in pensione, ma
sino al novembre 2012 era il vicecapo vicario della Polizia, quasi il comandante
in pectore vista la battaglia contro la malattia che stava conducendo l’allora
numero uno Antonio Manganelli. Un gruppo di agguerriti pm napoletani gli ha
stroncato la carriera indagandolo per turbativa d’asta nell’ambito di
un’inchiesta sull’appalto per il Centro elaborazione dati della Polizia. Lo
scorso maggio il gip di Roma, dove il fascicolo era stato trasferito per
competenza, ha prosciolto Izzo da ogni accusa. Lui ora resta alla finestra, in
attesa che qualcuno lo risarcisca per un danno tanto grande.
Dottor Izzo, quanti milioni di euro dovrebbero
darle per ripagarla di questo clamoroso errore giudiziario?
«Non saprei cosa risponderle. Si parla, ormai da
troppi anni, dei malanni della giustizia senza trovare un rimedio. Io comunque
ho sempre pensato che chi sbaglia deve rispondere: l’irresponsabilità crea i
presupposti per aumentare gli errori e formare il convincimento in chi li
commette di esercitare un potere incontrollato».
Il gip che ha archiviato il procedimento contro
di lei e altri 14 indagati vi ha prosciolti senza ombre. Non fa male avere
questo riconoscimento dopo aver lasciato la Polizia?
«Fa male perché in tutto il procedimento ci sono
una serie di “travisamenti” che avrebbero, se valutati correttamente e con
accertamenti approfonditi, consentito, anziché immaginifiche ricostruzioni
giudiziarie, l’immediata archiviazione del tutto, senza creare danni
irreparabili. L’inesistenza di qualsiasi ipotesi collusiva tra noi indagati era
di un’evidenza solare».
I pm sembra che non abbiano brillato in
precisione. Per esempio siete stati accusati di aver fatto vincere aziende senza
Nos (nullaosta di sicurezza), mentre in realtà tutte ne erano in possesso. Come
è possibile mettere nero su bianco un’accusa del genere senza averla verificata?
«Questa, al pari di alcune altre accuse, è una
delle cose più strabilianti e gravi. Come si fa a riportare tra i capi di
imputazione fatti neanche accertati, ma solo frutto della propria immaginazione?
C’era da fare un semplice accertamento cartaceo, lo stesso che hanno fatto le
difese. Bastava consultare gli archivi degli enti deputati al rilascio del Nos».
L’inchiesta è stata trasferita a Roma per
competenza. Ma non era chiaro sin dall’inizio che quella presunta turbativa
d’asta, se mai ci fosse stata, era stata consumata nella Capitale (dove si tenne
la gara) e non a Napoli?
«Dico solo che dal 20 dicembre del 2012, data in
cui la Procura Generale della Cassazione aveva individuato la competenza della
Procura di Roma, abbiamo dovuto attendere il luglio 2013 per la trasmissione di
tutti gli atti da Napoli, con la conseguenza che la procura di Roma ha dovuto
emettere due distinti decreti di chiusura indagini per la “rateizzazione”, forse
dovuta, mi passi il termine, a “dimenticanze” nella trasmissione dei documenti».
Certi pm sono innamorati dei loro fascicoli e
se ne separano mal volentieri. Non vorrei infierire, ma per il giudice della
Capitale «tutte le condizioni necessarie al regolare svolgimento della gara
erano state seguite». Ma allora perché tenervi sotto processo per tanti anni?
«Non voglio infierire neanche io, credo solo che
in questo clamoroso caso di malagiustizia ci siano, per chi ha la responsabilità
di farlo, sufficienti elementi per accertare l’inconsistenza e la fantasia dei
capi di imputazione e la leggerezza con cui è stata condotta l’indagine».
Pensa che qualcuno risponderà di questo
svarione?
«Spero di scoprirlo presto».
In questa vicenda anche i media hanno
contribuito al suo calvario. Per esempio hanno dato ampio risalto alla lettera
anonima di un “corvo” che collegava il suicidio di un suo stretto collaboratore
alle pressioni gerarchiche che avrebbe subito per alterare le procedure di gara.
Ma la vicenda processuale ha raccontato un’altra verità.
«La morte del collega, anche per l’affetto che
nutrivo per lui, è la vera tragedia nel contesto di questa vicenda. I verbali
delle nostre riunioni di lavoro raccontano una verità molto diversa da quella
immaginata dal “corvo”, verbali da cui emergono le richieste del mio
collaboratore di maggiori risorse economiche per finanziare imprevisti
progettuali e le mie pressanti pretese di giustificazioni per questi nuovi
costi. Nell’ultima riunione il collega ammetteva di non conoscere il progetto a
suo tempo elaborato, ma di essere convinto che avremmo dovuto ricorrere a
inconsueti ampliamenti dei contratti, con l’ utilizzo di ulteriori risorse
economiche».
Di fronte a tale affermazione come ha reagito?
«Nonostante fossi convinto della sua buona fede,
lo richiamai molto fermamente a essere più attento e a documentarsi prima di
reclamare altri fondi, anche perché qualsiasi superficialità poteva causare dei
dispiaceri. È questo in sintesi il prologo della tragedia sulla quale ho sempre
tenuto il più stretto riserbo per non ledere l’immagine di una persona onesta e
perbene».
In questa storia c’è stata anche un’altra morte
prematura. Per qualcuno pure in questo caso si sarebbe trattato di suicidio…
«Questa notizia non è un refuso di stampa, viene
da un’affermazione del Gip di Napoli che a proposito di un dirigente di polizia
ha scritto: «anch’egli recentemente deceduto in circostanze oggetto di
accertamento, come emerso nel corso degli interrogatori». Di questi accertamenti
e interrogatori non ho trovato traccia, se non nell’affermazione falsa, «si è
suicidato», fatta dal pm nel corso dell’interrogatorio di un teste. Il figlio
del compianto funzionario ha dovuto smentire la circostanza «assurda» con due
comunicati in cui dichiarava che il padre era deceduto naturalmente, «stroncato
da un infarto».
Perché secondo lei la lettera del “corvo”
spunta sui giornali 3-4 mesi dopo la sua spedizione? Secondo lei c’era un piano
dietro a quella strana fuga di notizie?
«Il ministro dell’Interno, all’epoca Anna Maria
Cancellieri, non ha ritenuto di disporre alcuna inchiesta per scoprire questi
motivi e quindi non posso avere certezze sul punto. Di certo, però, quell’azione
va contestualizzata: nell’estate del 2012 ci trovavamo in un grave momento di
crisi del vertice della Pubblica Sicurezza e vi erano grandi fermenti per la sua
sostituzione. Gli artefici della lettera non erano dei passanti: hanno potuto
manipolare i documenti sull’attività del Ministero di cui erano in possesso,
falsandone i contenuti, e hanno diffuso la lettera utilizzando tecnologie così
sofisticate da rendere non identificabili i mittenti neanche per i tecnici della
Polizia delle comunicazioni».
Il “corvo” ha trovato anche spazio sui
giornali…
«Quel documento anonimo è stato accolto con favore
in importanti redazioni che hanno così dato risalto mediatico a una realtà
travisata e falsa. Tanto falsa che oggi vi sono tre direttori di testate
nazionali e vari giornalisti rinviati a giudizio per diffamazione, ma questo a
differenza delle farneticazioni di un anonimo sembra che non sia una notizia
degna di nota».
Potremmo definirla una “congiurina” contro la
sua eventuale candidatura forte a Capo della Polizia?
«Certo i malpensanti possono opinare che vi sia
dietro un vile, ma astuto manovratore, qualche puffo incapace di altro che possa
aver ordito un qualche “disegno” per bruciare il mio nome per la successione di
Manganelli, ma io non sono un malpensante e quindi mi ostino a credere che sia
stato il “fato”».
Subito dopo le notizie di stampa che facevano
riferimento al “corvo”, lei ha deciso di presentare le dimissioni. Qualcuno ha
fatto pressioni per ottenere quel suo passo indietro?
«Assolutamente no, tutt’altro. Il ministro
Cancellieri le respinse. Ma io non sono un personaggio da operetta, come ce ne
sono molti in questo Paese, che presenta le dimissioni per incassarne il
rigetto. In quel momento c’era un’ombra su di me ed era giusto fare un passo
indietro. Per senso dello Stato».
Che cosa le ha fatto più male in questa
vicenda, dal punto di vista umano? Di fronte a quelle ricostruzioni fantasiose,
non ha avuto la sensazione di essere prigioniero di un castello kafkiano?
«Ho avuto modo in questo periodo di approfondire
Kafka, e posso risponderle prendendo in prestito una frase “del traduttore”,
Primo Levi: «Si può essere perseguiti e puniti per una colpa non commessa,
ignota, che il “tribunale” non ci rivelerà mai; e tuttavia, di questa colpa si
può portar vergogna, fino alla morte e forse anche oltre». Tutto questo lo sto
provando sulla mia pelle. E nessuno vi potrà porre mai rimedio».
Lo scandalo del Viminale. Il corvo fa dimettere
Izzo, ma la Cancellieri dice no. Il ministro dell'Interno ha respinto le
dimissioni del vice di Manganelli dopo l'esposto anonimo su appalti pilotati,
scrive “Libero Quotidiano”. Il ministro dell'Interno: "Abbiamo preso molto
seriamente la vicenda. Quello che vogliamo è che il Viminale resti una casa di
vetro e un punto di riferimento per il Paese”. Aperta un'inchiesta. Si è dimesso
il vice capo della Polizia, prefetto Nicola Izzo, chiamato in causa dal corvo
nell’inchiesta sui presunti appalti truccati al Viminale. Izzo ha inviato questa
mattina una email al Capo della Polizia, prefetto Antonio Manganelli e al
ministro dell’Interno, Annamaria Cancellieri che però ha ha respinto le
dimissioni, perché "credo, ha detto il ministro, che una persona non possa
essere giudicata sulla base di un esposto anonimo sul quale non abbiamo ancora
riscontri". Intanto la Procura di Roma procede nell'inchiesta partita in seguito
dell’esposto anonimo inviato nei giorni scorsi al ministro dell’Interno dove si
faceva riferimento a presunte violazioni e illeciti nel conferimento di appalti
per l’acquisto di apparecchiature tecnologiche. L'inchiesta è stata avviata dal
procuratore capo, Giuseppe Pignatone, che ha affidato il fascicolo all’aggiunto
Francesco Caporale, che guida da poco il pool dei magistrati per i reati contro
la pubblica amministrazione. L’esposto anonimo, composto da una ventina di
pagine, indica episodi circostanziati e diversi illeciti che sarebbero stati
compiuti dall’ufficio logistico del Viminale, incaricato delle gare d’appalto
per l’acquisto degli impianti tecnologici. Da parte sua, nelle scorse ore, Izzo
si era difeso da ogni accusa:"Diffamato per fatti che mi sono estranei: da
vicecapo vicario non mi occupo della gestione di appalti". In una nota ha
scritto: "Sono citato ignominiosamente in un esposto anonimo, che potrebbe
essere redatto a carico di chiunque e con qualsiasi contenuto - scrive Izzo -
per acquisti di cui ho conoscenza solo per la funzione strategica dei beni e non
delle procedure per la loro materiale acquisizione. Chi ha costruito l’anonimo,
si è nascosto abilmente, dimostrando la sua conoscenza delle tecnologie avanzate
e del settore degli appalti, usando la mail di persone ignare; e tale modalità
forse merita qualche riflessione sui nobili intenti dell’autore". Prosegue Izzo:
"Nello scritto, l’anonimo segnala anomalie sulle procedure amministrative
adottate, procedure per le quali, in alcuni casi e per quanto mi consta, le
stazioni appaltanti, diverse tra loro e non solo interne al dipartimento della
Ps, si sono consultate con gli organi istituzionali preposti e in tutti i casi,
a conclusione degli appalti, sono state sottoposte al vaglio e registrate, senza
alcun rilievo, dalla Corte dei Conti". Izzo conclude che "nonostante la natura
anonima dell’esposto non dovrebbe dare luogo a seguiti e in presenza di un
quadro di sostanziale regolarità, l’Amministrazione ha trasmesso gli atti alla
Procura per gli eventuali approfondimenti. La morte del compianto Saporito per
le sue tragiche modalità merita solo dolore e rispetto e non vili e strumentali
insinuazioni. Per il Cen sono stato interrogato circa due anni e mezzo fa e
attendo fiducioso il giudizio della magistratura". “Il corvo? Ci piacerebbe
conoscerlo, vedere se sono uno, due o quanti sono”, sostiene il ministro
dell’Interno, Anna Maria Cancellieri ribadendo che oltre all’inchiesta della
magistratura, “di cui attendiamo gli esiti” sono in corso accertamenti
all’interno del Viminale: “Abbiamo preso molto seriamente la vicenda -conclude-
perchè non sappiamo chi volesse colpire” il corvo, “forse aveva anche un
interesse personale. Quello che vogliamo è che il Viminale resti una casa di
vetro e un punto di riferimento per il Paese”.
Lo dice anche il capo della polizia. "I magistrati
sono dei cialtroni". Manganelli al telefono col prefetto Izzo: "Vergognoso che
le notizie sui processi vengano passate ai giornali per fare clamore", scrive
“Libero Quotidiano”. "E' una cosa indegna". Veramente mi disgusta il fatto che
io debba leggere sul giornale, momento per momento, 'stanno per chiamare la
dottoressa Tizio, la stanno chiamando...l'hanno interrogato...la posizione si
aggrava'". E ancora: "Perchè se no qua diamo per scontato che tutto viene
raccontato dai giornali, che si fa il clamore mediatico, che si va a massacrare
la gente prima ancora di trovare un elemento di colpevolezza". E poi ancora: "A
me pare molto più grave il fatto che un cialtrone di magistrato dia
indebitamente la notizia in violazione di legge...". Chi parla potrebbe essere
Silvio Berlusconi, che tante volte si è lamentato di come le notizie escano dai
tribunali prima sui giornali che ai diretti interessati. E invece, quelle che
riporta il Corriere della Sera, sono parole pronunciate nel giugno 2010
nientemeno che del capo della polizia Antonio Manganelli, al telefono col
prefetto Nicola Izzo, ex vicario della polizia. Si lamenta, Manganelli, della
fuga di notizie a proposito del caso degli appalti per il centro elettronico e
per gli altri interventi previsti dal patto per la sicurezza, indagine condotta
dalla procura di Napoli e che portò a una serie di provvedimenti tra cui
l'arresto del prefetto Nicola Fioriolii e l'interdizione dai pubblici uffici per
i prefetti Nicola Izzo e Giovanna Iurato.
L’ANTIMAFIA DEI RECORD.
Il pm Antimafia della Procura di Bari Isabella
Ginefra ha chiesto 58 condanne, 35 assoluzioni e un non luogo a procedere per
prescrizione nei confronti dei 103 imputati (gli altri 9 deceduti) nel processo
chiamato «Il canto del cigno» su una presunta associazione mafiosa operante
sulla Murgia barese tra Gravina e Altamura negli anni Novanta, finalizzata a
traffico e spaccio di droga, detenzione di armi ed esplosivi, estorsioni, 8
tentati omicidi, ferimenti e conflitti a fuoco tra clan rivali, scrive “La
Gazzetta del Mezzogiorno”. Il procedimento penale fu avviato nel 1997
dall'allora pm antimafia barese Leonardo Rinella quando, nel corso del processo
alla mafia murgiana denominato «Gravina» nei confronti di oltre 160 persone,
alcuni imputati decisero di collaborare con la giustizia rivelando nuovi
particolari sulle attività illecite dei clan Mangione e Matera-Loglisci,
all'epoca - secondo la Procura - in stretto contatto con i gruppi criminali
baresi di Savino Parisi, Antonio Di Cosola, Giuseppe Mercante, Andrea Montani ed
altri. Tra i capi di questa presunta associazione mafiosa c'erano, secondo
l'accusa, Vincenzo Anemolo, ritenuto un «figlioccio» del boss Savinuccio, e suo
fratello Raffaele, il defunto Francesco Biancoli (il camorrista che avrebbe
battezzato Parisi), Bartolo D'Ambrosio (ucciso nel 2010) e il suo ex alleato,
poi rivale, Giovanni Loiudice (processato e assolto per l'omicidio del boss),
Emilio Mangione e suo nipote Vincenzo, Nunzio Falcicchio, soprannominato «Lo
scheletro». L'indagine, ereditata negli anni successivi dai pm Antimafia Michele
Emiliano ed Elisabetta Pugliese, portò nel marzo 2002 all'arresto di 131
persone. Per oltre 200 fu poi chiesto il rinvio a giudizio ma soltanto 94 sono
ancora imputate per quei fatti. Gli altri sono stati giudicati con riti
alternativi o prosciolti. A quasi vent'anni dai fatti contestati sulla base
degli accertamenti dei Carabinieri di Bari e Altamura, la Procura chiede ora
condanne comprese fra 10 e 4 anni di reclusione per 58 di loro. Tra i reati
ritenuti ormai prescritti ci sono due tentati omicidi del 1994 e del 1997 e
alcuni episodi di spaccio. Stando all'ipotesi accusatoria quella murgiana era
una vera e propria «associazione armata di stampo mafioso-camorristico» promossa
e organizzata da «padrini e figliocci». Agli atti del processo, durato oltre
sette anni, ci sono prove dei «battesimi», le cerimonie di affiliazione, e
l'esatta ricostruzione dei ruoli all'interno del clan sulla base di una precisa
ripartizione territoriale per la gestione delle attività illecite. Le
discussioni dei difensori sono fissate per le udienze del 16 luglio e del 29
settembre, data in cui è prevista la sentenza.
Niente sentenza per 17 anni. Imputati morti e
prescritti. Il pm chiede le condanne per un'inchiesta antimafia del 1997. Ma
alla sbarra di 200 ne restano solo 58, scrive Gianpaolo Iacobini su “Il
Giornale”. A Bari, il processo alla cosca? Dopo 17 anni arrivano le richieste di
condanna in primo grado. L'antimafia dei record è pugliese. Il primato, però,
non è di quelli di cui andar fieri: per un procedimento penale nato da indagini
avviate nel 1997, e relative a fatti verificatisi agli inizi degli anni Novanta
del secolo scorso, soltanto adesso la Procura ha avanzato davanti ai giudici
richiesta di pena nei confronti degli imputati. La storia ha un nome simbolico,
uno di quelli che tanto solleticano le cronache ed i giornalisti quando scattano
i blitz: «Il canto del cigno». È il 2 settembre del 2002: i magistrati della Dda
barese Elisabetta Pugliese e Michele Emiliano (proprio lui: l'ex sindaco di
Bari) chiudono con un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 131 persone il
troncone investigativo fiorito 5 anni prima per gemmazione da un altro
maxi-processo. Nel mirino della Direzione distrettuale finiscono gli
appartenenti ad una presunta organizzazione criminale attiva sull'altopiano
delle Murge, nei Comuni di Altamura e Gravina in Puglia, ed i loro collegamenti
con i clan del capoluogo di regione. All'attivo estorsioni, detenzione d'armi,
traffico di droga e ferimenti. Finalizzati, secondo gli inquirenti,
all'affermazione di un'associazione armata di stampo mafioso-camorristico.
«Quest'operazione dimostra come la criminalità barese, dalla fine degli anni '80
ad oggi, abbia creato dei cloni in tutta la provincia», commenta in quei giorni
coi cronisti Emiliano, esprimendo soddisfazione per il lavoro portato a termine.
Ma i processi sono un'altra cosa. Ed in Tribunale il cigno canterà solo a
settembre 2014. Quando il collegio giudicante si determinerà in primo grado
sulle richieste di pena avanzate l'altro ieri - a quasi vent'anni dall'apertura
dell'inchiesta - dal pm antimafia Isabella Ginefra. Che la sua requisitoria l'ha
conclusa sollecitando condanne oscillanti tra i 10 e i 4 anni di reclusione nei
riguardi di 58 degli oltre 200 imputati: gli altri sono stati prosciolti o
processati con riti alternativi. O sono morti. Alcuni per vecchiaia. Qualcuno
per piombo, come Bartolo D'Ambrosio, crivellato a colpi di fucile e pistola nel
2010. Ed il passar del tempo, oltre agli uomini, ha spazzato via con la ramazza
della prescrizione anche molti dei reati contestati, come un paio di tentati
omicidi risalenti al 1994. Farà notizia? No, a giudicare dagli echi di cronaca
che arrivano da Palermo, dove il presidente del tribunale del riesame, Giacomo
Montalbano, con un'ordinanza ha disposto il rinvio d'ufficio a settembre di
tutti i procedimenti che non riguardino detenuti in carcere o ai domiciliari:
pochi i magistrati in organico, troppi i ricorsi che si prevede arriveranno dopo
l'arresto, il 22 giugno, di 91 persone considerate affiliate ai mandamenti
mafiosi di Resuttana e San Lorenzo. La chiamano giustizia. Pare una
barzelletta.
LA CHIAMANO
GIUSTIZIA, PARE UNA BARZELLETTA. PROCESSI: POCHE PAGINE DA LEGGERE E POCHI
TESTIMONI.
Dopo aver affermato
qualche mese fa che se nel nostro Paese si fanno troppe cause la colpa è del
numero eccessivo di avvocati, ora l’illustre magistrato Giorgio Santacroce,
presidente della Corte di Cassazione, interviene per chiarire (agli avvocati,
ovviamente) come vanno redatti i ricorsi da presentare alla Suprema Corte onde
non incorrere in possibili declaratorie di inammissibilità. Lo ha fatto con una
lettera inviata al Presidente del CNF
Guido Alpa dopo il Convegno “Una rinnovata collaborazione
tra magistratura e avvocatura nel quadro europeo” organizzato dal
Consiglio Consultivo dei Giudici Europei del
Consiglio d’Europa, dal CSM e dal CNF. Prendendo spunto dal
dibattito scaturito in quella circostanza, il
Dott. Santacroce ha preso carta e penna ed ha scritto
una lettera al Consiglio Nazionale Forense per confermare alcune direttive, ora
finalmente rese “ufficiali” dall’organo deputato a riceverle. Richiamando quanto
già espresso in precedenza sia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (la quale ha
previsto tra le indicazioni pratiche relative alla forma e al contenuto del
ricorso di cui all'art. 47 del Regolamento che «nel caso eccezionale in cui il
ricorso ecceda le 10 pagine il ricorrente dovrà presentare un breve riassunto
dello stesso») e dal Consiglio di Stato
(che ha suggerito di contenere nel limite di 20-25 pagine la lunghezza di
memorie e ricorsi, e, nei casi eccedenti, di far precedere l’esposizione da una
distinta sintesi del contenuto dell’atto estesa non più di 50 righe), il primo
Presidente della Corte ha affermato che anche gli atti dei giudizi di cassazione
dovranno trovare applicazione criteri similari. “Ben potrebbe ritenersi
congruo – scrive il Presidente
Santacroce nella lettera indirizzata al CNF - un tetto di 20
pagine, da raccomandare per la redazione di ricorsi, controricorsi e memorie.
Nel caso ciò non fosse possibile, per l'eccezionale complessità della
fattispecie, la raccomandazione potrà ritenersi ugualmente rispettata se l'atto
fosse corredato da un riassunto in non più di 2-3 pagine del relativo contenuto.
Sembra, altresì, raccomandabile che ad ogni atto, quale ne sia l'estensione, sia
premesso un breve sommario che guidi la lettura dell'atto stesso. Allo stesso
modo è raccomandabile che le memorie non riproducano il contenuto dei precedenti
scritti difensivi, ma, limitandosi ad un breve richiamo degli stessi se
necessario, sviluppino eventuali aspetti che si ritengano non posti
adeguatamente in luce precedentemente, così anche da focalizzare su tali punti
la presumibile discussione orale”. Attenendosi a tali criteri di massima si
potrebbe superare, secondo il primo Presidente - in molti casi quello scoglio
che è l’inammissibilità del ricorso “non già per la mancanza di concretezza
dei motivi del ricorso, ma per la modalità con cui questo viene presentato, che
non rispondono ai canoni accettati dalla Cassazione”, tra i quali appunto la
sinteticità degli atti presentati a sostegno della presa in esame del
dibattimento arrivato a sentenza in Appello”. Lo spirito dell’iniziativa
del Dott. Santacroce è certamente propositivo e positivo, così come lo è il
clima di collaborazione che il Magistrato ha auspicato in tal senso. Di certo
però andrà conciliato con un altro principio - quello dell’autosufficienza
dell’atto - che non poco ha turbato il sonno degli avvocati in questi ultimi
mesi, ossia l’esigenza posta a carico del ricorrente di inserire nel ricorso o
nella memoria la specifica indicazione dei fatti e dei mezzi di prova
asseritamente trascurati dal giudice di merito, nonché la descrizione del
contenuto essenziale dei documenti probatori con eventuale trascrizione dei
passi salienti. Un requisito (l’autosufficienza) che i giudici della Corte non
hanno ritenuto affatto assolto mediante la allegazione di semplici fotocopie, e
questo perché, si è detto, non è compito della Corte individuare tra gli atti e
documenti quelli più significativi e in essi le parti più rilevanti, “comportando
una siffatta operazione un'individuazione e valutazione dei fatti estranea alla
funzione del giudizio di legittimità”. Da qui la redazione di atti
complessi ed articolati, e dunque anche lunghi, nel timore di non vedere
considerato dal parte del Giudice un qualche aspetto o un qualche documento
essenziale ai fini del decidere. Ora, insomma, gli avvocati avranno un compito
in più: conciliare il criterio della brevità dell’atto con quello
dell’autosufficienza. Mica roba da poco….
La conseguenza
è.........La Cassazione boccia un ricorso perché "troppo prolisso".Sotto accusa
l'atto degli avvocati dell'Automobile club d'Ivrea contro una sentenza della
Corte d'Appello di Torino:"Tante pagine inutili". Ma diventa un modello: massimo
venti pagine, scrive Ottavia Giustetti su “la Repubblica”. La dura vita del
giudice di Cassazione: presentate pure il ricorso, avvocati, ma fate in modo che
sia sintetico. Altrimenti state pur certo che sarà respinto. Poche pagine per
spiegare i fatti, niente che comporti uno sforzo inutile per chi legge. Insomma
«non costringeteci» a esaminare pagine e pagine se volete avere qualche speranza
di vincere. Nero su bianco, tra le righe del testo di una recente sentenza della
terza sezione sul ricorso contro una decisione della Corte d’appello di Torino,
i giudici supremi hanno vergato il vademecum della sintesi estrema. Altrimenti:
bocciatura assicurata. Qualche tempo fa lo avevano fatto a proposito dei ricorsi
di legittimità legati al fisco. «La pedissequa riproduzione dell’intero,
letterale, contenuto degli atti processuali - scrivono i magistrati al primo
capoverso che illustra le motivazioni del rigetto del ricorso - è del tutto
superfluo ed equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere
tutto (anche quello di cui non occorre che sia informata) la scelta di quanto
rileva. La conseguenza è l’inammissibilità del ricorso per Cassazione». E, a
quanto pare, è solo un esempio dei pronunciamenti di questo tenore che in questi
mesi agitano le acque nell’ambiente degli avvocati. I forum sul diritto sono
zeppi di commenti taglienti sulla «preziosa risorsa» del giudice che va
«salvaguardata a tutti i costi». Tempi sterminati della giustizia, necessità di
smaltire migliaia di procedimenti arretrati, prescrizione sempre in agguato: è
nell’ambito della lotta a questi ormai cronici problemi del Paese il vademecum
del giudice all’avvocato per evitare sbrodolamenti inutili. E non si può dire
che sia nuova la tendenza a inibire il difensore che non si trasformi ogni volta
in un Marcel Proust del diritto quando chiede giustizia. Ma respingere un
ricorso perché un legale non è stato capace di sintesi da bignami appare come
una novità giuridica importante, dicono gli avvocati. Nel caso della terza
sezione civile sulla sentenza della Corte d’appello di Torino l’oggetto del
contendere erano le spese di gestione dell’Automobile club di Ivrea. Una vicenda
relativamente di poco conto. Ma analoghe prescrizioni si fanno strada e
rischiano di diventare obbligo previsto per legge se sarà approvato uno
specifico emendamento del decreto di riforma della giustizia in discussione in
questi mesi in Parlamento. Il punto che è già stato approvato dalla commissione
affari costituzionali della Camera finisce col prevedere la necessità per gli
avvocati amministrativisti di scrivere i ricorsi e gli altri atti difensivi
entro le esatte dimensioni che sono in via di definizione e sono stabilite con
un decreto del Presidente del Consiglio di Stato. Saranno venti pagine al
massimo i ricorsi d’ora in poi, mentre quel che sconfina è destinato per sempre
all’oblio. Brevità della trattazione, che va in direzione opposta all’abitudine
di molti legali che, con il timore di rientrare nei canoni dell’inammissibilità,
finiscono per presentare ricorsi-fiume.
Ed ancora:
“Inammissibile, prolisso e ripetitivo”. Così i giudici del Consiglio di Stato di
Lecce hanno giudicato il ricorso d’appello presentato dai tredici proprietari
dei terreni interessati dai lavori di allargamento della tanto contestata s.s.
275. Oltre a riconfermare quanto rilevato dal Tribunale amministrativo leccese,
il Consiglio di Stato ha deciso di condannare gli appellanti al rimborso delle
spese di lite, con la sanzione prevista per la violazione del principio di
sinteticità degli atti processuali, introdotta dall’art. 3 del nuovo Codice del
processo amministrativo. “Si deve tener conto – si legge in sentenza –
dell’estrema prolissità e ripetitività dell’appello in esame (di 109 pagine)”.
Il rispetto del dovere di sinteticità, ha sottolineato il Giudice, “costituisce
uno dei modi – e forse tra i più importanti – per arrivare ad una giustizia
rapida ed efficace”. Gli appellanti dovranno rimborsare, dunque, le spese alla
Provincia di Lecce, alla Regione Puglia, al Consorzio Asi, alla Prosal, al CIPE,
all’Anas, al Ministero delle Infrastrutture, al Ministero dell’Ambiente e al
Ministero dei Rapporti con la Regione.
Eh, sì! Proprio così :
lo affermano la Suprema Corte con sentenza n. 11199 del 04.07.2012 e, di
recente, il Tribunale di Milano con sentenza del 01.10. 2013, scrive l’Avv.
Luisa Camboni. "Viola il giusto processo l'avvocato che trascrive nel proprio
atto processuale le precedenti difese, le sentenze dei precedenti gradi, le
prove testimoniali, la consulenza tecnica e tutti gli allegati; il giusto
processo richiede trattazioni sintetiche e sobrie, anche se le questioni sono
particolarmente tecniche o economicamente rilevanti". I Giudici di Piazza
Cavour dicono "NO" agli avvocati prolissi. Perché? Perché, a dire dei Giudici
con la toga di ermellino, si violerebbe uno dei principi cardine, uno dei
pilastri fondamentali su cui poggia il nostro sistema giuridico: il principio
del giusto processo, ex art. 111 Cost. "La giurisdizione si attua mediante il
giusto processo regolato dalla legge. [...]". Uno dei tanti significati
insiti nel menzionato principio, difatti, è quello di garantire la celerità del
processo, celerità che si realizza anche attraverso atti brevi, ma chiari e
precisi nel loro contenuto ( c.d. principio di sinteticità). Il caso, su
cui i Giudici si sono pronunciati, riguardava un ricorso di oltre 64 pagine e
una memoria illustrativa di ben 36 pagine, il cui contenuto reiterava quello del
ricorso. Il principio cui hanno fatto riferimento per dare un freno, uno STOP a
Noi Avvocati, molto spesso prolissi, è il principio del giusto processo.
Difatti, hanno precisato che un atto processuale eccessivamente lungo, pur non
violando alcuna norma, non giova alla chiarezza e specificità dello stesso e,
nel contempo, ostacola l'obiettivo di un processo celere. Il cosiddetto giusto
processo, tanto osannato dalla nostra Carta Costituzionale, infatti, richiede da
Noi Avvocati atti sintetici redatti in modo chiaro e sobrio: "nessuna
questione, pur giuridicamente complessa", a dire della Suprema Corte,
"richiede atti processuali prolissi". L'atto processuale, dunque, deve
essere completo e riportare in modo chiaro la descrizione delle circostanze e
degli elementi di fatto, oggetto della controversia. Ancora una volta la Suprema
Corte ha richiamato l'attenzione di Noi Avvocati specificando quali sono i
principi che ogni operatore di diritto, nella specie l'Avvocato, deve tener
presente nel redigere gli atti: specificità, completezza, chiarezza e
precisione. Nel caso, dunque, di violazione del principio di sinteticità, ovvero
di redazione di atti sovrabbondanti, il giudice può tenerne conto, in sede di
liquidazione delle spese processuali, condannando la parte colpevole ai sensi
degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Per Noi Avvocati, sulla base di quanto affermato dai
Giudici di Piazza Cavour, non ha valore alcuno il motto latino "Ripetita
iuvant", in quanto le cose ripetute non giovano alla nostra attività
professionale che si estrinseca, nei giudizi civili, in attività di difesa negli
atti, i quali devono essere chiari, sintetici e precisi. Un'attività di difesa
non dipende dalla lungaggine dell'atto, ma dall'ingegno professionale, ingegno
che consiste nell'individuare la giusta strategia difensiva per ottenere i
migliori risultati sia per il cliente, sia per lo stesso professionista.
"Avvocati siete troppo
prolissi, se volete ottenere giustizia per i vostri assistiti dovete imparare il
dono della sintesi": la Cassazione ormai lo scrive nel testo delle sentenze.
Ecco il parere di un principe del foro torinese, l'avvocato Andrea Galasso,
protagonista nelle battaglie tra Margherita Agnelli e la sua famiglia e nel
processo a Calciopoli.
Avvocato, i suoi
colleghi sono contrari e allarmati, lei cosa ne pensa?
«Da un certo punto di
vista i giudici mi trovano d'accordo perché so che spesso quando ci si dilunga e
si sbrodola volentieri sui fatti è perché si teme di non poter argomentare bene
in punto di diritto. Quindi la Cassazione ha ragione a ritenere che sia
necessaria una buona dote di sintesi anche per non appesantire una attività che
è diventata sempre più pressante».
Quindi, secondo lei,
un bravo avvocato è capace di rimanere nei limiti che la Cassazione considera
legittimi per presentare un ricorso?
«In linea di massima
ritengo di sì. Poi, ovviamente, ci sono casi diversi. La sintesi deve essere una
indicazione generale. poi ogni processo ha la sua storia».
Però sentenze
recenti scrivono proprio nero su bianco che il ricorso può essere respinto
perché è troppo prolisso e costringe la Corte a leggere elementi inutili. Lei
crede che sia corretto?
«No, questo no. Siamo
in un caso di cattiveria intellettuale. Di malcostume alla rovescia».
Tra l'altro queste
indicazioni di brevità estrema condizioneranno sempre di più il lavoro degli
avvocati. È in via di approvazione un emendamento che stabilisce un tetto di
venti pagine per i ricorsi al Tar.
«Questo è un problema
serio che riguarda il rapporto degli avvocati con i consigli dell'Ordine che
evidentemente non sono in grado di far sentire la propria voce quanto
dovrebbero».
Lei crede che la
categoria dovrebbe essere più ascoltata, insomma?
«Beh sì. Quando si
trasformano in legge regole che condizionano così profondamente il nostro lavoro
sarebbe opportuno avere un Ordine degli avvocati capace di proporsi come
interlocutore valido. E invece, evidentemente non è così».
Ma all'inaudito non c'è
mai fine....
Il giudice: "Troppi
testimoni inutili? Pena più alta". E gli avvocati milanesi scioperano. Gli
avvocati si asterranno dalle udienze il 17 luglio 2014 perché ritengono che
siano stati stravolti "alcuni principi cardine del processo accusatorio, ovvero
quelli del contraddittorio nella formazione della prova", scrive “La
Repubblica”. Non sono andate giù agli avvocati penalisti milanesi le parole
pronunciate in aula da un giudice che, in sostanza, di fronte ai legali di un
imputato ha detto che se si insiste per ascoltare testimoni inutili, i
magistrati poi ne tengono conto quando si tratta di calcolare la pena. E così la
Camera penale di Milano, prendendo una decisione clamorosa e dura, anche sulla
base di quel grave "caso processuale" che lede il diritto di difesa, hanno
deciso di proclamare una giornata di astensione nel capoluogo lombardo per il
prossimo 17 luglio. Come si legge in una delibera del consiglio direttivo della
Camera penale,"lo scorso 20 giugno, nell'ambito di un'udienza dibattimentale
celebratasi avanti a una sezione del tribunale di Milano, il presidente del
collegio ha affermato" a proposito dell'esame di testimoni: "Non mi stancherò
mai di ripetere che secondo me quando in un processo si insiste a sentire testi
che si rivelano inutili, ovviamente si può essere assolti, ma se si è condannati
il tribunale ne tiene sicuramente conto ai fini del comportamento processuale"
(che influisce sulla pena). E ha aggiunto: "E mi dispiace che sugli imputati a
volte ricadano le scelte dei difensori". Il giudice che ha usato quelle parole
in udienza sarebbe Filippo Grisolia, presidente dell'undicesima sezione penale.
Il giudice, secondo la Camera penale, ha così violato "l'autonoma determinazione
del difensore nelle scelte processuali, il quale deve essere libero di valutare
l'opportunità o meno di svolgere il proprio controesame". In più il magistrato
ha violato le norme che "riconducono la commisurazione della pena esclusivamente
a fattori ricollegati alla persona dell'imputato", oltre a manifestare "non
curanza per alcuni dei principi cardine del processo accusatorio, ovvero quelli
del contraddittorio nella formazione della prova". I penalisti milanesi, dunque,
preso atto che "le segnalazioni agli uffici giudiziari" fatte in passato "non
hanno ottenuto" lo scopo di "neutralizzare" i comportamenti lesivi del diritto
di difesa, e ritenuta "la gravità del fenomeno che il caso processuale riportato
denuncia", hanno deciso di astenersi dalle udienze e da "ogni attività in ambito
penale" per il 17 luglio prossimo. Con tanto di "assemblea generale" convocata
per quel giorno per discutere "i temi" della protesta. "Questo fenomeno della
violazione del diritto di difesa - ha spiegato il presidente della Camera penale
milanese, Salvatore Scuto - è diffuso ed è emerso con virulenza in questo caso
specifico, ma non va ridotto al singolo giudice che ha detto quello che ha
detto. Questa è una protesta - ha aggiunto - che non va personalizzata, ma che
pone l'indice su un problema diffuso e che riguarda le garanzie dell'imputato e
il ruolo della difesa". La delibera è stata trasmessa anche al presidente della
Repubblica, al presidente del consiglio dei ministri, al ministero della
Giustizia e al Csm, il Consiglio superiore della magistratura.
IL SUD
TARTASSATO.
Sud tartassato: il
Meridione paga più di tutti, scrive Lanfranco Caminiti su “Il Garantista”. Dice
la Svimez che se muori e vuoi un funerale come i cristiani, è meglio che
schiatti a Milano, che a Napoli ti trattano maluccio. E non ti dico a Bari o a
Palermo, una schifezza. A Milano si spende 1.444,23 euro per defunto, a Napoli
988 euro, a Bari 892 euro e 19 centesimi, a Palermo 334 euro. A Palermo, cinque
volte meno che a Milano. Il principe Antonio De Curtis, in arte Totò, si
rivolterà nella tomba, che a quanto pare non c’è nessuna livella, dopo morti. E
checcazzo, e neppure lì terroni e polentoni siamo uguali. E basterebbe solo
questo – il culto dei morti dovrebbe antropologicamente “appartenere” alle
società meridionali, era il Sud la terra delle prefiche, era il Sud la terra
delle donne in nero, era il Sud la terra dei medaglioni con la fotina
dell’estinto che pendono sul petto delle vedove – per dire come questa Italia
sia cambiata e rovesciata sottosopra. Si paga al Sud di più per tutto, per
l’acqua, la monnezza, l’asilo, gli anziani, la luce nelle strade, i trasporti,
insomma per i Lep, come dicono quelli che studiano queste cose: livelli
essenziali delle prestazioni. Essenziali lo sono, al Sud, ma quanto a
prestazioni, zero carbonella. Eppure, Pantalone paga. Paga soprattutto la classe
media meridionale che si era convinta che la civilizzazione passasse per gli
standard nazionali. Paghiamo il mito della modernizzazione. Paghiamo l’epica
della statalizzazione. Paghiamo la retorica della “cosa pubblica”. Paghiamo
l’idea che dobbiamo fare bella figura, ora che i parenti ricchi, quelli del
Nord, vengono in visita e ci dobbiamo comportare come loro: non facciamoci
sempre riconoscere. Paghiamo le tasse, che per questo loro sono avanti e noi
restiamo indietro. Lo Stato siamo noi. Parla per te, dico io. Dove vivo io, un
piccolo paese del Sud, pago più tasse d’acqua di quante ne pagassi prima in una
grande città, e più tasse di spazzatura, e non vi dico com’è ridotto il cimitero
che mi viene pena solo a pensarci. Sono stati i commissari prefettizi – che
avevano sciolto il Comune – a “perequare” i prelievi fiscali. Poi sono andati
via, ma le tasse sono rimaste. Altissime, cose mai viste. In compenso però, la
spazzatura si accumula in piccole montagne. A volte le smantellano, poi si
ricomincia. Non sai mai quando, magari qualcuno dei laureati che stanno a
girarsi i pollici al baretto della piazza potrebbe studiarla, la sinusoide della
raccolta rifiuti. Invece, i bollettini arrivano in linea retta. Con la scadenza
scritta bella grossa. L’unica cosa che è diminuita in questi anni al Sud è il
senso di appartenenza a una qualche comunità più grande del nostro orto privato.
La pervasività dello Stato – e quale maggiore pervasività della sua capacità di
prelievo fiscale – è cresciuta esponenzialmente quanto l’assoluta
privatizzazione di ogni spirito meridionale. Tanto più Stato ha prodotto solo
tanta più cosa privata. E non dico solo verso la comunità nazionale, la Patria o
come diavolo vogliate chiamarla. No, proprio verso la comunità territoriale. Chi
può manda i figli lontano, perché restino lontano. Chi può compra una casa
lontano sperando di andarci il prima possibile a passare gli anni della
vecchiaia. Chi può fa le vacanze lontano, a Pasqua e a Natale, il più esotiche
possibile. Chi non può, emigra. Di nuovo, come sempre. Il Sud è diventato terra
di transito per i suoi stessi abitanti. Come migranti clandestini, non vediamo
l’ora di andarcene. il Sud dismette se stesso, avendo perso ogni identità
storica non si riconosce in quello che ha adesso intorno, che pure ha accettato,
voluto, votato.
C’era una
volta l’assistenzialismo.
Rovesciati come un calzino ci siamo ritrovati contro un federalismo
secessionista della Lega Nord che per più di vent’anni ci ha sbomballato le
palle rubandoci l’unica cosa in cui eravamo maestri, il vittimismo. Siamo stati
vittimisti per più di un secolo, dall’unità d’Italia in poi, e a un certo punto
ci siamo fatti rubare la scena da quelli del Nord – e i trasferimenti di
risorse, e le pensioni, e l’assistenzialismo e la pressione fiscale e le camorre
degli appalti pubblici – e l’unica difesa che abbiamo frapposto è stata lo
Stato. Siamo paradossalmente diventati i grandi difensori dell’unità nazionale
contro il leghismo. Noi, i meridionali, quelli che il federalismo e il
secessionismo l’avevano inventato e provato. Noi, che dello Stato ce ne siamo
sempre bellamente strafottuti. Li abbiamo votati. Partiti nazionali, destra e
sinistra, sindaci cacicchi e governatori, li abbiamo votati. Ci garantivano le
“risorse pubbliche”. Dicevano. Ci promettevano il rinascimento, il risorgimento,
la resistenza. Intanto però pagate. Come quelli del Nord. Facciamogli vedere.
Anzi, di più. La crisi economica del 2007 ha solo aggravato una situazione già
deteriorata. E ormai alla deriva. È stata la classe media meridionale
“democratica” l’artefice di questo disastro, con la sua ideologia statalista.
Spesso, loro che possono, ora che le tasse sono diventate insopportabili, ora
che il Sud è sfregiato, senza più coscienza di sé, ora se ne vanno. O mandano i
loro figli lontano. Chi non può, emigra. Di nuovo, come sempre.
Non solo i cittadini
italiano sono tartassati, ma sono anche soggetti a dei disservizi estenuanti.
ITALIANI. LA CASTA
DEI "COGLIONI". FACCIAMO PARLARE CLAUDIO BISIO.
In molti mi hanno
scritto chiedendomi il testo del mio monologo effettuato durante il Festival di
Sanremo 2013 il 16 Febbraio scorso. Beh, eccolo. Inoltre alcuni di voi,
sull'onda del contenuto di quel monologo hanno creato una pagina facebook
"Quelli che domenica voteranno con un salmone". Come vedete, l'ho fatto
anch'io...
Sono un italiano. Che
emozione... E che paura essere su questo palcoscenico... Per me è la prima
volta. Bello però. Si sta bene… Il problema ora è che cosa dire. Su questo palco
è stato fatto e detto davvero di tutto. E il contrario di tutto. Gorbaciov ha
parlato di perestroika, di libertà, di democrazia… Cutugno ha rimpianto l’Unione
Sovietica. Gorbaciov ha parlato di pace… e Cutugno ha cantato con l’Armata
Rossa… Belen ha fatto vedere la sua farfallina (io potrei farvi vedere il mio
biscione, ma non mi sembra un’ottima idea… è un tatuaggio che ho sulla caviglia,
dopo tanti anni a Mediaset è il minimo…) Ma soprattutto Benigni, vi ricordate
quando è entrato con un cavallo bianco imbracciando il tricolore? Ecco, la
rovina per me è stato proprio Benigni. Lo dico con una sana invidia. Benigni ha
alzato troppo il livello. La Costituzione, l'Inno di Mameli, la Divina
Commedia... Mettetevi nei panni di uno come me. Che è cresciuto leggendo
Topolino... Però, se ci pensate bene, anche Topolino, a modo suo, è un classico.
Con la sua complessità, il suo spessore psicologico, le sue contraddizioni…
Prendete Nonna Papera, che animale è? ... chi ha detto una nonna? Non fate gli
spiritosi anche voi, è una papera. Ma è una papera che dà da mangiare alle
galline. Tiene le mucche nella stalla... Mentre invece Clarabella, che anche lei
è una mucca, non sta nella stalla, sta in una casa con il divano e le tendine. E
soprattutto sta con Orazio, che è un cavallo. Poi si lamentano che non hanno
figli... Avete presente Orazio, che fa il bipede, l’antropomorfo, però ha il
giogo, il morso, il paraocchi. Il paraocchi va bene perché Clarabella è un
cesso, ma il morso?!? Ah, forse quando di notte arriva Clarabella con i tacchi a
spillo, la guêpiere, la frusta: "Fai il Cavallo! Fai il cavallo!" nelle loro
notti sadomaso… una delle cinquanta sfumature di biada. E Qui Quo Qua. Che
parlano in coro. Si dividono una frase in tre, tipo: "ehi ragazzi attenti che
arriva Paperino/ e/ ci porta tutti a Disneyland", oppure: "ehi ragazzi cosa ne
direste di andare tutti/ a/ pescare del pesce che ce lo mangiamo fritto che ci
piace tanto..." ecco, già da queste frasi, pur banali se volete, si può evincere
come a Quo toccassero sempre le preposizioni semplici, le congiunzioni, a volte
solo la virgola: "ehi ragazzi attenti che andando in mezzo al bosco/, /
rischiamo di trovare le vipere col veleno che ci fanno del male" inoltre Quo ha
sempre avuto un problema di ubicazione, di orientamento... non ha mai saputo
dove fosse. Tu chiedi a Qui: "dove sei?" "sono qui!" ... Chiedi a Qua "dove
sei?", e lui: "sono qua!" tu prova a chiederlo a Quo. Cosa ti dice? "sono Quo?"
Cosa vuol dire? Insomma Quo è sempre stato il più sfigato dei tre, il più
insulso: non riusciva né a iniziare né a finire una frase, non era né qui, né
qua... Mario Monti. Mari o Monti? Città o campagna? Carne o Pesce? Lo so. So che
siamo in piena par condicio e non si può parlare di politica. Ma sento alcuni di
voi delusi dirsi: ma come, fra sette giorni ci sono le elezioni. E questo qui ci
parla di mucche e galline... Altri che invece penseranno: basta politica! Io non
voglio nascondermi dietro a un dito, anche perché non ne ho nessuno abbastanza
grosso… decidete voi, volendo posso andare avanti per altri venti minuti a
parlare di fumetti, oppure posso dirvi cosa penso io della situazione politica…
Ve lo dico? Io penso che finché ci sono LORO, non riusciremo mai a cambiare
questo paese. Dicono una cosa e ne fanno un'altra. Non mantengono le promesse.
Sono incompetenti, bugiardi, inaffidabili. Credono di avere tutti diritti e
nessun dovere. Danno sempre la colpa agli altri… A CASA! Tutti a casa!!! (A
parte che quando dici tutti a casa devi stare attento, specificare: a casa di
chi? No perché non vorrei che venissero tutti a casa mia) Vedo facce
spaventate... soprattutto nelle prime file... Lo so, non devo parlare dei
politici, ho firmato fior di contratti, ci sono le penali... Ma chi ha detto che
parlo dei politici? Cosa ve l'ha fatto pensare? Ah, quando ho detto
incompetenti, bugiardi, inaffidabili? Ma siete davvero maliziosi... No, non
parlavo dei politici. Anche perché, scusate, i politici sono in tutto poche
centinaia di persone... cosa volete che cambi, anche se davvero se ne tornassero
tutti a casa (casa loro, ribadisco)? Poco. No, quando dicevo che devono andare
tutti a casa, io non stavo parlando degli eletti. Io stavo parlando degli
elettori... stavo parlando di NOI. Degli italiani. Perché, a fare bene i conti,
la storia ci inchioda: siamo noi i mandanti. Siamo noi che li abbiamo votati. E
se li guardate bene, i politici, ma proprio bene bene bene... è davvero
impressionante come ci assomigliano: I politici italiani… sono Italiani!
Precisi, sputati. Magari, ecco, con qualche accentuazione caricaturale. Come le
maschere della commedia dell'arte, che sono un po' esagerate, rispetto al
modello originale. Ma che ricalcano perfettamente il popolo che rappresentano.
C'è l'imbroglione affarista, tradito dalla sua ingordigia “Aò, e nnamose a
magnà!... A robbin, ‘ndo stai?”; C'è il servitore di due padroni: "orbo da
n'orecia, sordo de n'ocio"… qualche volta anche di tre. Certi cambiano casacca
con la velocità dei razzi… C'è il riccone arrogante...”Guadagno spendo pago
pretendo” C'è la pulzella che cerca di maritarsi a tutti i costi con il riccone,
convinta di avere avuto un'idea originale e che ci rimane male quando scopre che
sono almeno un centinaio le ragazze che hanno avuto la sua stessa identica
idea... C'è il professore dell'università che sa tutto lui e lo spiega agli
altri col suo latino/inglese perfetto: "tananai mingheina buscaret!" Cos’ha
detto? “Choosy firewall spending review” Ah, ecco, ora finalmente ho capito… C'è
quello iracondo, manesco, pronto a menar le mani ad ogni dibattito... “culattoni
raccomandati” Insomma, c'è tutto il campionario di quello che NOI siamo, a
partire dai nostri difetti, tipo l'INCOERENZA. Come quelli che vanno al family
day... ma ci vanno con le loro due famiglie... per forza poi che c'è un sacco di
gente.... E se solo li guardi un po' esterrefatto, ti dicono: "Perché mi guardi
così? Io sono cattolico, ma a modo mio”. A modo tuo? Guarda, forse non te
l'hanno spiegato, ma non si può essere cattolico a modo proprio... Se sei
cattolico non basta che Gesù ti sia simpatico, capisci? Non è un tuo amico,
Gesù. Se sei cattolico devi credere che Gesù sia il figlio di Dio incarnato
nella vergine Maria. Se sei cattolico devi andare in chiesa tutte le domeniche,
confessare tutti i tuoi peccati, fare la penitenza. Devi fare anche le novene,
digiunare al venerdì... ti abbuono giusto il cilicio e le ginocchia sui ceci.
Divorziare: VIETATISSIMO! Hai sposato un farabutto, o una stronza? Capita.
Pazienza. Peggio per te. Se divorzi sono casini… E il discorso sulla coerenza
non vale solo per i cattolici... Sei fascista? Devi invadere l’Abissinia!
Condire tutto con l'olio di ricino, girare con il fez in testa, non devi mai
passare da via Matteotti, anche solo per pudore! Devi dire che Mussolini, a
parte le leggi razziali, ha fatto anche delle cose buone! Sei comunista? Prima
di tutto devi mangiare i bambini, altro che slow food. Poi devi andare a Berlino
a tirare su di nuovo il Muro, mattone su mattone! Uguale a prima! Devi guardare
solo film della Corea… del nord ovviamente. Devi vestirti con la casacca grigia,
tutti uguali come Mao! …mica puoi essere comunista e poi andare a comprarti la
felpa da Abercrumbie Sei moderato? Devi esserlo fino in fondo! Né grasso né
magro, né alto né basso, né buono né cattivo... Né…Da quando ti alzi la mattina
a quando vai a letto la sera devi essere una mediocrissima, inutilissima,
noiosissima via di mezzo! Questo per quanto riguarda la coerenza. Ma vogliamo
parlare dell'ONESTÀ? Ho visto negozianti che si lamentano del governo ladro e
non rilasciano mai lo scontrino, Ho visto fabbriche di scontrini fiscali non
fare gli scontrini dicendo che hanno finito la carta, Ho visto ciechi che
accompagnano al lavoro la moglie in macchina, Ho visto sordi che protestano coi
vicini per la musica troppo alta, Ho visto persone che si lamentano
dell’immigrazione e affittano in nero ai gialli… e a volte anche in giallo ai
neri!, Ho visto quelli che danno la colpa allo stato. Sempre: se cade un
meteorite, se perdono al superenalotto, se la moglie li tradisce, se un piccione
gli caga in testa, se scivolano in casa dopo aver messo la cera: cosa fa lo
stato? Eh? Cosa fa?... Cosa c’entra lo stato. Metti meno cera, idiota! Lo sapete
che nell'inchiesta sulla 'ndrangheta in Lombardia è venuto fuori che c'erano
elettori, centinaia di elettori, che vendevano il proprio voto per cinquanta
euro? Vendere il voto, in democrazia, è come vendere l'anima. E l'anima si vende
a prezzo carissimo, avete presente Faust? Va beh che era tedesco, e i tedeschi
la mettono giù sempre durissima, ma lui l'anima l'ha venduta in cambio
dell'IMMORTALITA'! Capito? Non cinquanta euro. Se il diavolo gli offriva
cinquanta euro, Faust gli cagava in testa. La verità è che ci sono troppi
impresentabili, tra gli elettori. Mica poche decine, come tra i candidati… è
vero, sembrano molti di più, ma perché sono sempre in televisione a sparar
cazzate, la televisione per loro è come il bar per noi... "Ragazzi, offro un
altro giro di spritz" "E io offro un milione di posti di lavoro" e giù a ridere.
"E io rimborso l'imu!” “e io abolisco l'ici!" “Guarda che non c'è più da un
pezzo l'ici" "Allora abolisco l'iva... E anche l'Emy, Evy e Ely!" "E chi sono?
"Le nipotine di Paperina! "Ma va là, beviti un altro grappino e tasi mona!..."
Vedi, saranno anche impresentabili ma per lo meno li conosci, nome e cognome, e
puoi anche prenderli in giro. Invece gli elettori sono protetti dall’anonimato…
alle urne vanno milioni di elettori impresentabili, e nessuno sa chi sono!
Sapete quale potrebbe essere l’unica soluzione possibile? Sostituire
l'elettorato italiano. Al completo. Pensate, per esempio, se incaricassimo di
votare al nostro posto l'elettorato danese, o quello norvegese. Lo prendiamo a
noleggio. Meglio, lo ospitiamo alla pari... Au pair. Carlo, ma chi è quel
signore biondo che dorme a casa tua da due giorni? “Oh, è il mio elettore
norvegese alla pari, domenica vota e poi riparte subito... C'è anche la
moglie”... E per chi votano, scusa? "Mi ha detto che è indeciso tra Aspelünd
Gründblomma e Pysslygar". Ma quelli sono i nomi dell'Ikea!, che tra l’altro è
svedese… "Ma no, si assomigliano… però ora che mi ci fai pensare, effettivamente
ho visto nel suo depliant elettorale che i simboli dei loro partiti sono un
armadio, una lampada, un comodino. Mah. E tu poi, in cambio cosa fai, vai a
votare per le loro elezioni? In Norvegia? "Ah, questo non lo so. Non so se mi
vogliono. Mi hanno detto che prima devo fare un corso. Imparare a non
parcheggiare in doppia fila. A non telefonare parlando ad alta voce in treno. A
pagare le tasse fino all'ultimo centesimo. Poi, forse, mi fanno votare." Si, va
beh, qualche difficoltà logistica la vedo: organizzare tutti quei pullman,
trovare da dormire per tutti... Ma pensate che liberazione, la sera dei
risultati, scoprire che il nostro nuovo premier è un signore o una signora
dall'aria normalissima, che dice cose normalissime, e che va in televisione al
massimo un paio di volte all'anno.
(Lancio di batteria
e poi, sull’aria de “L’italiano”)
Lasciatemi votare
con un salmone in mano
vi salverò il paese
io sono un norvegese…
IL NORD EVADE PIU’ DEL SUD.
Economia Sommersa: Il Nord onesto e
diligente evade più del Sud, scrive Emanuela
Mastrocinque su “Vesuviolive”. Sono queste le notizie che non dovrebbero mai
sfuggire all’attenzione di un buon cittadino del Sud. Per anni ci hanno
raccontato una storia che, a furia di leggerla e studiarla, è finita con il
diventare la nostra storia, l’unica che abbiamo conosciuto. Storia di miseria e
povertà superata dai meridionali grazie all’illegalità o all’emigrazione, le
due uniche alternative rimaste a “quel popolo di straccioni” (come ci definì
quella “simpatica” giornalista in un articolo pubblicato su “Il Tempo” qualche
anno fa) . Eppure negli ultimi anni il revisionismo del risorgimento ci sta
aiutando a comprendere quanto lo stereotipo e il pregiudizio sia stato utile e
funzionale ai vincitori di quella sanguinosa guerra da cui è nata l‘Italia.
Serviva (e serve tutt‘ora) spaccare l’Italia. Da che mondo e mondo le società
hanno avuto bisogno di creare l’antagonista da assurgere a cattivo esempio, così
noi siamo diventati fratellastri, figli di un sentimento settentrionale razzista
e intollerante. Basta però avere l’occhio un po’ più attento per scoprire che
spesso la verità, non è come ce la raccontano. Se vi chiedessimo adesso, ad
esempio, in quale zona d’Italia si concentra il tasso più alto di evasione
fiscale, voi che rispondereste? Il Sud ovviamente. E invece non è così. Dopo
aver letto un post pubblicato sulla pagina Briganti in cui veniva
riassunta perfettamente l’entità del “sommerso economico in Italia derivante
sia da attività legali che presentano profili di irregolarità, come ad esempio
l’evasione fiscale, che dal riciclaggio di denaro sporco proveniente da attività
illecite e mafiose” abbiamo scoperto che in Italia la maggior parte degli
evasori non è al Sud. Secondo i numeri pubblicati (visibili nell‘immagine
sotto), al Nord il grado di evasione si attesta al 14, 5%, al centro al 17,4%
mentre al Sud solo al 7,9%. I dati emersi dal Rapporto Finale del Gruppo
sulla Riforma Fiscale, sono stati diffusi anche dalla Banca d’Italia. Nel
lavoro di Ardizzi, Petraglia, Piacenza e Turati “L’economia
sommersa fra evasione e crimine: una rivisitazione del Currency Demand Approach
con una applicazione al contesto italiano” si legge “dalle stime a
livello territoriale si nota una netta differenza tra il centro-nord e il sud,
sia per quanto attiene al sommerso di natura fiscale che quello di natura
criminale. Per quanto riguarda infine l’evidenza disaggregata per aree
territoriali, è emerso che le province del Centro-Nord, in media, esibiscono
un’incidenza maggiore sia del sommerso da evasione sia di quello associato ad
attività illegali rispetto alle province del Sud, un risultato che pare
contraddire l’opinione diffusa secondo cui il Mezzogiorno sarebbe il principale
responsabile della formazione della nostra shadow economy. Viene meno, di
conseguenza, la rappresentazione del Sud Italia come territorio dove si
concentrerebbe il maggiore tasso di economia sommersa". E ora, come la
mettiamo?
Si evade il fisco più al Nord che al Sud. E’ uno
dei dati che emerge dal rapporto sulla lotta all’evasione redatto dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Secondo Padoan, la somma totale delle principali
imposte evase (Iva, Ires, Irpef e Irap) ammonta a 91 miliardi. Il 52% di questa
cifra si attesta dunque nel Settentrione, contro i 24 miliardi del centro (26%
del totale) e i 19,8 miliardi del Meridione (22%). Il dato è influenzato dal
maggior reddito nazionale del Nord. Soprattutto, scrivono i tecnici del Tesoro,
la rabbrividire la percentuale di verifiche sulle imprese che trova irregolarità
fiscali: è 98,1% tra le grandi, al 98,5% sulle medie e al 96,9% sulle Pmi. Il
record tocca agli enti non commerciali, il 99,2% non è in regola. 100% di
`positività´ i controlli sugli atti soggetti a registrazione. Ad ogni modo,
l’evasione effettiva ‘pizzicata’ dall’Agenzia delle Entrate nel 2013, ha
rilevato il Mef, ammonta a 24,5 miliardi. La maggiore imposta accertata è così
salita dell’87% in sette anni, rispetto ai 13,1 miliardi del 2006. Un numero in
calo rispetto agli anni 2009-2012 e soprattutto rispetto al picco di 30,4
miliardi del 2011.
Ma quale Sud, è il Nord che ha la palma
dell’evasione, scrive Vittorio Daniele su “Il
Garantista”. Al Sud si evade di più che al Nord. Questo è quanto comunemente si
pensa. Non è così, invece, secondo i dati della Guardia di Finanza, analizzati
da Paolo di Caro e Giuseppe Nicotra, dell’Università di Catania, in uno studio
di cui si è occupata anche la stampa (Corriere Economia, del 13 ottobre). I
risultati degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza mostrano come,
nelle regioni meridionali, la quota di reddito evaso, rispetto a quello
dichiarato, sia inferiore che al Nord. E ciò nonostante il numero di
contribuenti meridionali controllati sia stato, in proporzione, maggiore. Alcuni
esempi. In Lombardia, su oltre 7 milioni di contribuenti sono state effettuate
14.313 verifiche che hanno consentito di accertare un reddito evaso pari al 10%
di quello dichiarato. In Calabria, 4.480 controlli, su circa 1.245.000
contribuenti, hanno consentito di scoprire un reddito evaso pari al 3,5% di
quello dichiarato. Si badi bene, in percentuale, le verifiche in Calabria sono
state quasi il doppio di quelle della Lombardia. E ancora, in Veneto il reddito
evaso è stato del 5,3%, in Campania del 4,4% in Puglia, del 3,7% in Sicilia del
2,9%. Tassi di evasione più alti di quelle delle regioni meridionali si
riscontrano anche in Emilia e Toscana. Alcune considerazioni. La prima riguarda
il fatto che nelle regioni del Nord, dove più alta è la quota di evasione, e
dove maggiore è il numero di contribuenti e imprese, si siano fatti, in
proporzione, assai meno accertamenti che nel meridione. Poiché, in Italia, le
tasse le paga chi è controllato, mentre chi non lo è, se può, tende a schivarle,
sarebbe necessario intensificare i controlli là dove la probabilità di evadere è
maggiore. E questa probabilità, secondo i dati della Guardia di Finanza, è
maggiore nelle regioni più ricche. La seconda considerazione è che il luogo
comune di un’Italia divisa in due, con un Nord virtuoso e un Sud di evasori, non
corrisponde al vero. L’Italia è un paese unito dall’evasione fiscale. Il fatto
che in alcune regioni del Nord si sia evaso di più che al Sud non ha nulla a che
vedere né con l’etica, né con l’antropologia. Dipende, più realisticamente, da
ragioni economiche. L’evasione difficilmente può riguardare i salari, più
facilmente i profitti e i redditi d’impresa. E dove è più sviluppata l’attività
d’impresa? Come scrivevano gli economisti Franca Moro e Federico Pica, in un
saggio pubblicato qualche anno fa della Svimez: «Al Sud ci sono tanti evasori
per piccoli importi. Al Nord c’è un’evasione più organizzata e per somme
gigantesche». Quando si parla del Sud, pregiudizi e stereotipi abbondano. Si
pensa, così, che la propensione a evadere, a violare le norme, se non a
delinquere, sia, per così dire, un tratto antropologico caratteristico dei
meridionali. Ma quando si guardano i dati, e si osserva la realtà senza la lente
deformante del pregiudizio, luoghi comuni e stereotipi quasi mai reggono. Di
fronte agli stereotipi e alle accuse – e quella di essere evasori non è certo la
più infamante – che da decenni, ogni giorno e da più parti, si rovesciano contro
i meridionali, non sarebbe certo troppo se si cominciasse a pretendere una
rappresentazione veritiera della realtà. Insieme a pretendere, naturalmente, e
in maniera assai più forte di quanto non si sia fatto finora, che chi, al Sud,
ha responsabilità e compiti di governo, faccia davvero, e fino in fondo, il
proprio dovere.
Quante bugie ci hanno
raccontato sul Mezzogiorno!
Scrive Pino Aprile su “Il Garantista”. L’Italia è il paese più ingiusto e
disuguale dell’Occidente, insieme a Stati Uniti e Gran Bretagna: ha una delle
maggiori e più durature differenze del pianeta (per strade, treni, scuole,
investimenti, reddito…) fra due aree dello stesso paese: il Nord e il Sud;
tutela chi ha già un lavoro o una pensione, non i disoccupati e i giovani; offre
un reddito a chi ha già un lavoro e lo perde, non anche a chi non riesce a
trovarlo; è fra i primi al mondo, per la maggiore distanza fra lo stipendio più
alto e il più basso (alla Fiat si arriva a più di 400 volte); ha i manager di
stato più pagati della Terra, i vecchi più garantiti e i giovani più precari; e
se giovani e donne, pagate ancora meno. È in corso un colossale rastrellamento
di risorse da parte di chi ha più, ai danni di chi ha meno: «una redistribuzione
dal basso verso l’alto». È uscito in questi giorni nelle librerie il nuovo libro
di Pino Aprile («Terroni ’ndernescional», edizioni PIEMME, pagine 251, euro
16,50). Pubblichiamo un brano, per gentile concessione dell’autore. Quante volte
avete letto che la prova dell’ estremo ritardo dell’Italia meridionale rispetto
al Nord era l’alta percentuale di analfabeti? L’idea che questo possa dare ad
altri un diritto di conquista e annessione può suonare irritante. Ma una qualche
giustificazione, nella storia, si può trovare, perché i popoli con l’alfabeto
hanno sottomesso quelli senza; e í popoli che oltre all’alfabeto avevano anche
”il libro” (la Bibbia, il Vangelo, il Corano, Il Capitale, il Ko Gi Ki…) hanno
quasi sempre dominato quelli con alfabeto ma senza libro. Se questo va preso
alla… lettera, la regione italiana che chiunque avrebbe potuto legittimamente
invadere era la Sardegna, dove l’analfabetismo era il più alto nell’Italia di
allora: 89,7 per cento (91,2 secondo altre fonti); quasi inalterato dal giorno
della Grande Fusione con gli stati sabaudi: 93,7. Ma la Sardegna era governata
da Torino, non da Napoli. Le cose migliorarono un po’, 40 anni dopo l’Unità, a
prezzi pesanti, perché si voleva alfabetizzare, ma a spese dei Comuni. Come
dire: noi vi diamo l’istruzione obbligatoria, però ve la pagate da soli (più o
meno come adesso…). Ci furono Comuni che dovettero rinunciare a tutto, strade,
assistenza, per investire solo nella nascita della scuola elementare: sino
all’87 per cento del bilancio, come a Ossi (un secolo dopo l’Unità, il Diario di
una maestrina, citato in Sardegna , dell’Einaudi, riferisce di «un evento
inimmaginabile »: la prima doccia delle scolare, grazie al dono di dieci
saponette da parte della Croce Rossa svizzera). Mentre dal Mezzogiorno non
emigrava nessuno, prima dell’Unità; ed era tanto primitivo il Sud, che partoriva
ed esportava in tutto il mondo facoltà universitarie tuttora studiatissime:
dalla moderna storiografia all’economia politica, e vulcanologia, sismologia,
archeologia… Produzione sorprendente per una popolazione quasi totalmente
analfabeta, no? Che strano. Solo alcune osservazioni su quel discutibile
censimento del 1861 che avrebbe certificato al Sud indici così alti di
analfabetismo: «Nessuno ha mai analizzato la parzialità (i dati sono quelli
relativi solo ad alcune regioni) e la reale attendibilità di quel censimento
realizzato in pieno caos amministrativo, nel passaggio da un regno all’altro e
in piena guerra civile appena scoppiata in tutto il Sud: poco credibile, nel
complesso, l’idea che qualche impiegato potesse andare in giro per tutto il Sud
bussando alle porte per chiedere se gli abitanti sapevano leggere e scrivere»
rileva il professor Gennaro De Crescenzo in Il Sud: dalla Borbonia Felix al
carcere di Penestrelle. Come facevano a spuntare oltre 10.000 studenti
universitari contro i poco più di 5.000 del resto d’Italia, da un tale oceano di
ignoranza? Né si può dire che fossero tutti benestanti, dal momento che nel
Regno delle Due Sicílie i meritevoli non abbienti potevano studiare grazie a
sussidi che furono immediatamente aboliti dai piemontesi, al loro arrivo.
Sull’argomento potrebbero gettare più veritiera luce nuove ricerche: «Documenti
al centro di studi ancora in corso presso gli archivi locali del Sud dimostrano
che nelle Due Sicilie c’erano almeno una scuola pubblica maschile e una scuola
pubblica femminile per ogni Comune oltre a una quantità enorme di scuole private»
si legge ancora nel libro di De Crescenzo, che ha studiato storia risorgimentale
con Alfonso Scirocco ed è specializzato in archivistica. «Oltre 5.000, infatti,
le ”scuole” su un totale di 1.845 Comuni e con picchi spesso elevati e
significativi: 51 i Comuni in Terra di Bari, 351 le scuole nel complesso; 174 i
Comuni di Terra di lavoro, 664 le scuole; 113 i Comuni di Principato Ultra, 325
le scuole; 102 i Comuni di Calabria Citra, 250 le scuole…». Si vuol discutere
della qualità di queste scuole? Certo, di queste e di quella di tutte le altre;
ma «come si conciliano questi dati con quei dati così alti dell’analfabetismo?
». E mentiva il conte e ufficiale piemontese Alessandro Bianco di Saint-Jorioz,
che scese a Sud pieno di pregiudizi, e non li nascondeva, e poi scrisse quel che
vi aveva trovato davvero e lo scempio che ne fu fatto (guadagnandosi
l’ostracismo sabaudo): per esempio, che «la pubblica istruzione era sino al
1859 gratuita; cattedre letterarie e scientifiche in tutte le città principali
di ogni provincia»? Di sicuro, appena giunti a Napoli, i Savoia chiusero
decine di istituti superiori, riferisce Carlo Alianello in La conquista del Sud.
E le leggi del nuovo stato unitario, dal 1876, per combattere l’analfabetismo e
finanziare scuole, furono concepite in modo da favorire il Nord ed escludere o
quasi il Sud. I soliti trucchetti: per esempio, si privilegiavano i Comuni con
meno di mille abitanti. Un aiuto ai più poveri, no? No. A quest’imbroglio si è
ricorsi anche ai nostri tempi, per le norme sul federalismo fiscale regionale.
Basti un dato: i Comuni con meno di 500 abitanti sono 600 in Piemonte e 6 in
Puglia. Capito mi hai? «Mi ero sempre chiesto come mai il mio trisavolo fosse
laureato,» racconta Raffaele Vescera, fertile scrittore di Foggia «il mio
bisnonno diplomato e mio nonno, nato dopo l’Unità, analfabeta». Nessun Sud,
invece, nel 1860, era più Sud dell’isola governata da Torino; e rimase tale
molto a lungo. Nel Regno delle Due Sicilie la ”liberazione” (così la racconta,
da un secolo e mezzo, una storia ufficiale sempre più in difficoltà) portò
all’impoverimento dello stato preunitario che, secondo studi recenti
dell’Università di Bruxelles (in linea con quelli di Banca d’Italia, Consiglio
nazionale delle ricerche e Banca mondiale), era ”la Germania” del tempo, dal
punto di vista economico. La conquista del Sud salvò il Piemonte dalla
bancarotta: lo scrisse il braccio destro di Cavour. Ma la cosa è stata ed è
presentata (con crescente imbarazzo, ormai) come una modernizzazione necessaria,
fraterna, pur se a mano armata. Insomma, ho dovuto farti un po’ di male, ma per
il tuo bene, non sei contento? Per questo serve un continuo confronto fra i dati
”belli” del Nord e quelli ”brutti” del Sud. Senza farsi scrupolo di ricorrere a
dei mezzucci per abbellire gli uni e imbruttire gli altri. E la Sardegna, a
questo punto, diventa un problema: rovina la media. Così, quando si fa il
paragone fra le percentuali di analfabeti del Regno di Sardegna e quelle del
Regno delle Due Sicilie, si prende solo il dato del Piemonte e lo si oppone a
quello del Sud: 54,2 a 87,1. In tabella, poi, leggi, ma a parte: Sardegna, 89,7
per cento. E perché quell’89,7 non viene sommato al 54,2 del Piemonte, il che
porterebbe la percentuale del Regno sardo al 59,3? (Dati dell’Istituto di
Statistica, Istat, citati in 150 anni di statistiche italiane: Nord e Sud
1861-2011, della SVIMEZ, Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno). E si
badi che mentre il dato sulla Sardegna è sicuramente vero (non avendo interesse
il Piemonte a peggiorarlo), non altrettanto si può dire di quello dell’ex Regno
delle Due Sicilie, non solo per le difficoltà che una guerra in corso poneva, ma
perché tutto quel che ci è stato detto di quell’invasione è falsificato: i
Mille? Sì, con l’aggiunta di decine di migliaia di soldati piemontesi
ufficialmente ”disertori”, rientrati nei propri schieramenti a missione
compiuta. I plebisciti per l’annessione? Una pagliacciata che già gli
osservatori stranieri del tempo denunciarono come tale. La partecipazione armata
dell’entusiasta popolo meridionale? E allora che ci faceva con garibaldini e
piemontesi la legione straniera 11 domenica 4 gennaio 2015 ungherese? E chi la
pagava? Devo a un valente archivista, Lorenzo Terzi, la cortesia di poter
anticipare una sua recentissima scoperta sul censimento del 1861, circa gli
analfabeti: i documenti originali sono spariti. Ne ha avuto conferma ufficiale.
Che fine hanno fatto? E quindi, di cosa parliamo? Di citazioni parziali,
replicate. Se è stato fatto con la stessa onestà dei plebisciti e della storia
risorgimentale così come ce l’hanno spacciata, be’…Nei dibattiti sul tema, chi
usa tali dati come prova dell’arretratezza del Sud, dinanzi alla contestazione
sull’attendibilità di quelle percentuali, cita gli altri, meno discutibili, del
censimento del 1871, quando non c’era più la guerra, eccetera. Già e manco gli
originali del censimento del ’71 ci sono più. Spariti pure quelli! Incredibile
come riesca a essere selettiva la distrazione! E a questo punto è legittimo
chiedersi: perché il meglio e il peggio del Regno dí Sardegna vengono separati e
non si offre una media unica, come per gli altri stati preunitari? Con i numeri,
tutto sembra così obiettivo: sono numeri, non opinioni. Eppure, a guardarli
meglio, svelano non solo opinioni, ma pregiudizi e persino razzismo. Di fatto,
accadono due cose, nel modo di presentarli: 1) i dati ”belli” del Nord restano
del Nord; quelli ”brutti”, se del Nord, diventano del Sud. Il Regno sardo era
Piemonte, Liguria, Val d’Aosta e Sardegna. Ma la Sardegna nelle statistiche
viene staccata, messa a parte. Giorgio Bocca, «razzista e antimeridionale »,
parole sue, a riprova dell’arretratezza del Sud, citava il 90 per cento di
analfabeti dell’isola, paragonandolo al 54 del Piemonte. Ma nemmeno essere di
Cuneo e antimerìdionale autorizza a spostare pezzi di storia e di geografia: la
Sardegna era Regno sabaudo, i responsabili del suo disastro culturale stavano a
Torino, non a Napoli;
2) l’esclusione mostra, ce ne
fosse ancora bisogno, che i Savoia non considerarono mai l’isola alla pari con
il resto del loro paese, ma una colonia da cui attingere e a cui non dare; una
terra altra («Gli stati» riassume il professor Pasquale Amato, in Il
Risorgimento oltre i miti e i revisionismi «erano proprietà delle famiglie
regnanti e potevano essere venduti, scambiati, regalati secondo valutazioni
autonome di proprietari». Come fecero i Savoia con la Sicilia, la stessa
Savoia, Nizza… Il principio fu riconfermato con la Restaurazione dell’Ancièn
Regime, nel 1815, in Europa, per volontà del cancelliere austriaco Klemens von
Metternich). E appena fu possibile, con l’Unità, la Sardegna venne allontanata
quale corpo estraneo, come non avesse mai fatto parte del Regno sabaudo. Lo dico
in altro modo: quando un’azienda è da chiudere, ma si vuol cercare di salvare il
salvabile (con Alitalia, per dire, l’han fatto due volte), la si divide in due
società; in una, la ”Bad Company”, si mettono tutti i debiti, il personale in
esubero, le macchine rotte… Nell’altra, tutto il buono, che può ancora fruttare
o rendere appetibile l’impresa a nuovi investitori: la si chiama ”New Company”.
L’Italia è stata fatta così:
al Sud invaso e saccheggiato hanno sottratto fabbriche, oro, banche, poi gli
hanno aggiunto la Sardegna, già ”meridionalizzata”. Nelle statistiche ufficiali,
sin dal 1861, i dati della Sardegna li trovate disgiunti da quelli del Piemonte
e accorpati a quelli della Sicilia, alla voce ”isole”, o sommati a quelli delle
regioni del Sud, alla voce ”Mezzogiorno” (la Bad Company; mentre la New Company
la trovate alla voce ”Centro-Nord”). Poi si chiama qualcuno a spiegare che la
Bad Company è ”rimasta indietro”, per colpa sua (e di chi se no?). Ripeto: la
psicologia spiega che la colpa non può essere distrutta, solo spostata. Quindi,
il percorso segue leggi di potenza: dal più forte al più debole; dall’oppressore
alla vittima. Chi ha generato il male lo allontana da sé e lo identifica con chi
lo ha subito; rimproverandogli di esistere. È quel che si è fatto pure con la
Germania Est e si vuol fare con il Mediterraneo.
MASSONERIA: QUELLO CHE NON
SI OSA DIRE.
Padre Amorth e la
massoneria,
scrive “Affari Italiani”. Continua la rubrica di Affaritaliani.it Padre Mariano,
curata dal Movimento Sacerdotale Mariano. Riflessioni sulle sacre scritture.
Padre Amorth afferma: "la massoneria comanda il mondo" e tra le sue varie
attività di controllo, finanzia anche l'arrivo dell'Islamismo in Europa al fine
della destabilizzazione. Questa affermazione oltre ad essere sostenuta da più
analisti è anche carismatica. Nel caso di padre Amorth presidente degli
esorcisti, è sicuramente la conclusione di ciò che Satana lascia trapelare sotto
il torchio del "Nome di Gesù" quando viene costretto a rivelare la Verità. Don
Gobbi, fondatore del MSM assieme ad altri carismatici su suggerimento della
Madonna afferma la stessa cosa. Questa affermazione ci permette di vedere le
vicende anche attuali, con una sguardo diverso e facilitato nella loro
interpretazione. Cosa si può dedurre? Da questo punto di vista capiamo che la
potente massoneria mondiale riuscirà a realizzare in forma graduale anzitutto un
Unico Governo Mondiale, poi una moneta unica, ed ovviamente una religione unica
che metterebbe -secondo loro - tutti d'accordo rispondendo così alle esigenze di
spiritualità delle persone. Da queste affermazioni dei veggenti comprendiamo
tante cose ed esse ci aiutano a prendere coscienza del dovere di svegliarci e
chiamare col loro nome le cose. Anzitutto ci è consentito di affermare che i
vignettisti di Charlie sono tutti blasfemi. Disegnavano infatti vignette
pornografiche e sacrileghe per irridere Gesù, la Madonna e La SS. ma Trinità.
Non è difficile immaginare da dove Charlie Hebdo riceveva i finanziamenti,
quando si sa che la massoneria ha come primo obbiettivo di porre allo stesso
livello tutte le religioni, per farle apparire tutte antiquate e dogmatiche. Per
chi non lo sapesse è utile ricordare pure che i massoni ai vertici (al 33°
grado) dopo un cammino iniziatico di sempre maggiore obbedienza e sudditanza a
qualunque ordine, sono consacrati tutti a Satana. L'obiettivo finale della
massoneria internazionale - occorre tenerlo presente sempre - è quello di
distruggere la Chiesa Cattolica, infondendo l'idea che tra di essa e l'Islam non
vi è grande differenza. Dietro un falso ecumenismo, una falsa tolleranza e
l'eresia del pauperismo per annientare la Chiesa Cattolica e il Vaticano ecco
che si prepara la strada all'ONU delle religioni. Ovviamente, in quell'ottica,
vi è un progetto orchestrato dalle potenti forze anti cristiche, che non sono
solo di questo mondo. Tutto ciò è già stato profetizzato come dicevamo! Meno
male perché ciò aiuta molto a dipanare la matassa complicata delle forze in
campo. Aggiungiamo pure la vittoria enorme della massoneria - dovuta a una
grandissima capacità di penetrazione nei gangli del potere - quando si trattò di
rinnegare le radici cristiane dell'Europa che pure hanno prodotto quel po' po'
di civiltà da sogno. Pia illusione ora pensare di poter fermare l'avanzata
dell'Islam contrapponendogli una "fede laica nella dea Ragione". Impossibile
comunque sarà e crudele solo pensare di sostituire la civiltà cristiana che in
duemila anni ha reso ricca, bella e libera la nostra Europa nella multiforme
peculiarità e diversità di ogni nazione. Proviamo solo a pensare l' orrore di
uno Stato teocratico peggiore di tutti i regimi totalitari che hanno
sconquassato l'Europa nel secolo scorso! Poiché non dimentichiamo che "Je suis
nigeriano"! Ma ancora ricorriamo alle profezie, che annunziano sì questo tempo
di purificazione, ma come preparazione al trionfo del Cuore Immacolato di Maria.
La cosa del resto è biblica, Dio ha già permesso ai tempi dell'A.T. che si
riversassero popoli infedeli sugli Ebrei per punirli delle loro infedeltà al
Vero Dio. Di cosa si tratta quando si parla del trionfo del Cuore Immacolato di
Maria? Quello lo vedremo un'altra volta. Intanto la profezia di un "castigo",
per avere tolto dal centro dei nostri cuori il Dio Trinitario di Gesù che è
Amore, comincia a divenirci più chiaro.
"Charlie, strage voluta
dalle logge segrete. Ecco perché Obama non è andato a Parigi",
scrive Lorenzo Lamperti su “Affari Italiani”. Il legame tra Massoneria e Chiesa,
l'azione di Papa Francesco, l'ipotesi Jeb Bush alla Casa Bianca, gli attentati
di Parigi, Napolitano, Quirinale, Renzi e il Patto del Nazareno. Sono alcuni dei
temi affrontati da Gioele Magaldi, Gran Maestro del movimento massonico Grande
Oriente Democratico, in un'intervista a tutto campo ad Affaritaliani.it
che anticipa la presentazione del suo libro "Massoni" alla chiesa di Santa Maria
in Portico a Roma.
Dopo il successo del libro
Massoni e delle precedenti presentazioni, nuovo evento a Roma. Che cosa può
dirci di più di questo evento? Chi ci sarà?
«Preferirei
che la curiosità sua e di altri suoi colleghi giornalisti li porti a presenziare
all’evento, che è a lista di invitati chiusa, ma naturalmente accessibile ai
cronisti che vengano a fare il proprio mestiere e a raccontare questo epocale
evento con sopralluogo diretto. Certamente ci saranno alte personalità
ecclesiastiche, politiche, diplomatiche, militari, intellettuali,
imprenditoriali e, in generale, rappresentanti di rilievo della società civile».
Desta stupore il luogo e la
presenza di tanti ecclesiastici. Come mai una presenza così massiccia di
esponenti della Chiesa? Qual è il legame con la Massoneria?
«I
legami tra Chiesa Cattolica e altre chiese e ambienti massonici è sempre stato
intenso e fecondo, a prescindere da formali scomuniche e ufficiali, quanto
ipocrite e insincere, prese di distanza. Comunque, non sempre coloro che, in
ambito ecclesiastico (e dunque essoterico sul piano spirituale) dialogano con
gruppi e singoli esponenti della Libera Muratoria (che in quanto “iniziati
misteriosofici” coltivano una dimensione esoterica della spiritualità,
prediligendo un approccio conoscitivo ad uno fideistico sulle cose umane e
divine) sono per forza di cose massoni. Molto spesso vi sono prelati ed
ecclesiastici cattolici che, pur non essendo mai stati iniziati liberi muratori,
si rapportano con curiosità, apertura mentale ed emotiva, persino simpatia
filosofica e culturale, a determinati ambienti della Massoneria. Diverso il caso
di eminenti pesi massimi illuminati e progressisti della Cattolicità, come
Angelo Roncalli (alias papa Giovanni XXIII) e Carlo Maria Martini, ad esempio.
Costoro, come viene raccontato nel libro “Massoni”, hanno voluto essere
orgogliosamente sia dei grandi pastori cattolici che dei raffinati iniziati
massoni. Cosi come è ancora diverso il caso di un eminente para-massone
conservatore molto vicino alla Ur-Lodge “Three Eyes” (la stessa di Giorgio
Napolitano, per intenderci), Karol Wojtyla (alias papa Giovanni Paolo II), dei
cui legami cripto-latomistici con un “grande fratello” come Zbigniew Brzezinski,
pure si parla nel best-seller di Chiarelettere dal sottotitolo “La scoperta
delle Ur-Lodges”, e di cui si parlerà ancora meglio negli altri volumi della
serie di “Massoni”».
A proposito di Chiesa,
nelle scorse settimane c'è stato chi, nel Parlamento (in particolare un deputato
di Scelta Civica), ha espresso timori per la vita di Papa Francesco avanzando
l'ipotesi che qualcuno possa volergli male per la sua azione di rinnovamento nel
Vaticano. Che cosa ne pensa? Quanto può dare fastidio Bergoglio?
«Dell’attuale
pontificato di Francesco in relazione alla Massoneria si parlerà diffusamente
nel secondo volume di “Massoni”. Intanto posso anticiparle che, per ora, i
propositi di rinnovamento di Bergoglio sono rimasti belle intenzioni e
suggestioni, ma poco di più. Intendiamoci: personalmente ho grande simpatia per
questo papa, che potenzialmente potrebbe fare molto, anche se finora non ha
concretizzato granché. Se Bergoglio intende davvero rinnovare la Chiesa
Cattolica all’alba del XXI secolo, deve fare come il suo grande predecessore
Giovanni XXIII (alias il fratello massone progressista Angelo Roncalli) e indire
un Concilio Vaticano III, che perfezioni e porti a compimento migliorativo
alcune intuizioni benemerite del Concilio Vaticano II (1962-1965)».
Nel suo libro Massoni
afferma che il progetto delle Ur-Lodges reazionarie sia di portare un nuovo Bush
alla Casa Bianca nel 2016. Quanto siamo vicini a che ciò accada?
«La
partita è ancora tutta da giocare. Se si lascerà che l’Isis e gruppi collegati
proseguano la propria opera interna (nei territori occupati di Iraq e Siria) ed
esterna di terrorismo in salsa hollywoodiana, senza che nessuno intervenga
tempestivamente, prima con intervento militare chirurgico ad estirpare tale
Califfato, poi con poderoso intervento civile e politico ad implementare regimi
autenticamente democratici, liberali, libertari, laici, pluralisti e socialmente
equi in territorio siriano e iracheno, questi due anni che ci attendono di caos,
decapitazioni e attentati sanguinari in Occidente, saranno il miglior viatico
per la elezione di Jeb Bush, massone reazionario della Hathor Pentalpha, alla
Casa Bianca. Questo nuovo-vecchio Bush (Jeb era già attivo ai tempi del Pnac,
Project for a New American Century e ai tempi della spregevole tragedia dell’11
settembre 2001) sarà infatti presentato come il nuovo campione di una presunta
riscossa american-occidentale contro gli islamici fondamentalisti e cattivoni in
quanto tali, secondo lo schema pretestuoso dello scontro di civiltà teorizzato
dal massone neo-aristocratico Samuel Huntington già a fine anni ’90. Ma,
naturalmente, Jeb Bush e i suoi non porterebbero in Medio Oriente, in Iraq e in
Siria, democrazia, libertà, pacificazione, pluralismo, laicità e giustizia
sociale, quanto macroscopiche occasioni di lucro economico e politico
(autoritariamente gestito) per amici e amici degli amici del consueto complesso
miltar-industriale-finanziario legato alle Ur-Lodges globali più reazionarie e
spregiudicate. Barack Obama, gli ambienti euro-atlantici e i leader mondiali di
tendenza democratico-progressista o almeno moderata, distanti dai progetti
“hathor-pentalphiani” dei sostenitori del nuovo-vecchio Bush, dovrebbero
intervenire subito, senza perdere tempo, contro l’Isis e a favore delle
popolazioni medio-orientali martoriate da questi masnadieri del sedicente
Califfato. Ma la partita, lo ripeto e lo spiegherò meglio nel secondo volume di
“Massoni”, è estremamente delicata e complessa».
Come vanno interpretati i
tragici fatti di Parigi e dell'attentato a Charlie Hebdo? Quale potrebbe essere
stato il ruolo di Al Qaeda e Isis?
«Lo
ribadisco con molta chiarezza: lo spregevole attentato di Parigi è avvenuto con
la complicità di svariate istituzioni di controllo locali, in combutta con
manovalanza terroristica e mandanti che si muovono nell’area delle Ur-Lodges
Hathor-Pentalpha, Geburah, Amun, Der Ring, ecc.»
C'è chi ipotizza che dietro
gli attentati di Parigi ci sia una mano non islamica. Per lei è possibile?
«Gliel’ho
appena confermato nella risposta alla sua domanda precedente. Ma non si tratta
di ragionare secondo inconsistenti dicotomie del tipo: “si tratta di mani
islamiche e medio-orientali, oppure occidentali”. Si tratta di mani
sovranazionali e apolidi, che utilizzano i pretesti religiosi come instrumentum
regni e armi di manipolazione di massa. Fra coloro che hanno progettato e poi
fatto realizzare eventi come gli attentati di Parigi, e come altri che si
cercherà di effettuare, ci sono sedicenti islamici e però anche non islamici,
cosi come tra i massoni progressisti che cercheranno di prevenire e impedire
tali esecrabili crimini contro l’umanità ci sono sinceri islamici e sinceri
cristiani, ebrei, indù, buddhisti, ecc: persone nate indifferentemente in
Occidente e in Oriente, ma che cominciano a riscoprire l’orgoglio di appartenere
a una tradizione latomistica cosmopolita, universale e autenticamente
democratica».
In molti hanno polemizzato
sull'assenza di Obama a Parigi nell'incontro tra capi di Stato. Secondo lei come
va letta questa assenza?
«Il
fratello massone progressista (moderato) Barack Obama era perfettamente a
conoscenza di quanta ipocrisia si celasse in quell’incontro di capi ed ex- capi
di Stato, alcuni dei quali direttamente coinvolti, in modo diretto o indiretto,
nei presupposti che hanno propiziato gli stessi attentati terroristici di Parigi
e quelli di anni precedenti. Obama ancora non ha trovato il coraggio di
fronteggiare efficacemente personaggi del genere, ma con la sua assenza almeno
ha mandato un segnale inequivocabile di sdegno e presa di distanza».
Dopo le stragi alcune parti
dell'Ue hanno messo in dubbio Schenghen e c'è stato chi ha chiesto a gran voce
la pena di morte. A che cosa ci porteranno queste reazioni estreme?
«Sono
assolutamente favorevole agli Accordi di Schenghen e al principio universale
della libera circolazione delle persone, tanto più in un’Europa che si
pretenderebbe unita e integrata (anche se purtroppo, al momento, non lo è su
basi democratiche, bensì tecnocratiche e oligarchiche) e sono fermamente
contrario al principio della pena di morte applicata da entità statuali su
detenuti ormai inermi e messi in condizione di non nuocere. Il back-ground
dispotico e fascistoide di Marine Le Pen e di altri è chiaramente venuto allo
scoperto proprio con la loro proposta di riattivare la pena di morte. E una
torsione dispotica e autoritaria (vedi, negli Usa, l’implementazione del
liberticida e anti-democratico Patriot Act) è proprio ciò che i mandanti di
questi attentati terroristici vogliono conseguire, anche per il tramite di
personaggi alla Le Pen».
Tornando all'Italia, che
cosa cambia dopo le dimissioni di Napolitano? Quali sono le forze in gioco nella
designazione del successore?
«Altrove,
magari nei prossimi giorni, con più calma, spazio e tempo, e con altra
intervista ad hoc, mi riservo di rispondere ad Affari Italiani e ad altri
operatori mediatici, anche su questo tema, che certamente troverà esaustiva
analisi nel secondo volume di Massoni. Società a responsabilità illimitata,
sottotitolo: “Globalizzazione e massoneria”, non necessariamente edito da
Chiarelettere, e che anzi offrirò pubblicamente alla Casa Editrice (compresa
Chiarelettere, certo) italiana o estera che sia in grado di assicurare le
migliori garanzie a 360° su vari aspetti della pubblicazione e dell’operazione
editoriale e culturale che la sottende. Intanto, posso anticipare che le forze
in gioco per la designazione del successore del fratello Napolitano sono ancora
e sempre terminali italiani di alcune Ur-Lodges sovranazionali».
C'è chi sostiene che
ambienti massonici possano sostenere Amato e portarlo sul Quirinale. Le risulta?
«Certo
che alcuni (tra cui lo stesso confratello libero muratore Napolitano) avrebbero
gradito il massone fintamente progressista (e autentico tecnocratico e
neo-aristocratico) Giuliano Amato al Quirinale, ma si tratta di un candidato
provvidenzialmente indebolito da vari fattori. Anche se, nelle “quirinarie” in
corso, anche i “cavalli azzoppati” hanno virtuali chanches di recuperare
terreno…»
Renzi è riuscito a entrare
nelle grazie (e nella Ur-Lodge) di Draghi oppure il suo potere non è ancora a
quel livello? Quanto pesa ancora oggi il Patto del Nazareno?
«Su
questo tema, la rinvio appunto al secondo volume di Massoni. Società a
responsabilità illimitata, sottotitolo: “Globalizzazione e massoneria”, di
futura pubblicazione, dove si parlerà, tra le moltissime altre cose, in modo
attento e monografico, tanto di Matteo Renzi e delle sue aspirazioni e relazioni
massoniche, quanto delle vere ragioni delle dimissioni di Giorgio Napolitano,
dei nomi e cognomi dei mandanti della strage di Parigi presso Charlie Hebdo, dei
costruttori del Califfato dell’Isis, e dei rapporti passati, presenti e futuri
tra il pontificato di Jorge Mario Bergoglio (alias papa Francesco) e la Libera
Muratoria argentina e sovranazionale».
Tutto quello che avreste
voluto sapere sulla Massoneria,
scrive Aldo Forbice su “Il Giornale di Sicilia”. Un volume di 65o pagine con
dati e nomi di personaggi che hanno fatto parte o avuto rapporti con le logge.
Sulla massoneria esiste una letteratura sterminata ma nessuno finora aveva
cercato di fare chiarezza sulle logge segrete, quelle in chiaroscuro e
soprattutto quelle internazionali che nessuno conosce. Il libro appena uscito (Massoni
- La scoperta delle Ur - Lodges di Gioele Magaldi, con la collaborazione di
Laura Maragnani, Chiarelettere) apre scenari sconvolgenti. Si tratta di un
volume di 650 pagine (cui ne seguiranno altri tre) che pubblica documenti finora
ritenuti segretissimi. Magaldi è uno storico, politologo, massone da lunga data
(ex Maestro Venerabile della loggia «Monte Sion» di Roma, attualmente Maestro
Venerabile del Grande Oriente Democratico). C'è chi dice che abbia stipulato una
polizza milionaria di assicurazione sulla vita, visto il rischio che corre.
Scorrendo le pagine si rimane perplessi e sconcertati ma misteriosamente
«incollati» al testo per la grande ricchezza di notizie controcorrente che si
apprendono sulla storia dell'ultimo secolo. Ovviamente la «lettura» degli
avvenimenti più vicini a noi colpisce particolarmente. Incuriosisce, ad esempio,
che papi, presidenti, uomini di Stato e dell'economia, personaggi importanti di
tutti i sistemi politici (da Giovanni XXIII ai fratelli Kennedy, a Reagan,
Putin, Obama, Deng Xiao Ping, Mandela, Clinton, Blair, Margaret Thatcher, i
nostri Agnelli, Napolitano, Padoan, Draghi ecc - in altre parole tutto il mondo
del potere politico ed economico abbia fatto parte o avuto rapporti con le logge
massoniche, e paramassoniche) del pianeta, distribuito fra quelle
conservatrici-reazionarie e quelle progressiste. La «guerra» fra queste logge ha
condizionato (e spesso influito pesantemente) il corso degli avvenimenti
dell'ultima parte del ’900, sino ad oggi, contendendosi il governo del mondo e
premiando quasi sempre il potente sistema militare-industriale. Non possiamo
giurare sulla veridicità di questa grande massa di documenti, usciti dagli
archivi segreti delle logge. Osserviamo solo che se, anche il dieci per cento
delle notizie rese note fosse certificato come verità indiscussa, si dovrebbe
riscrivere almeno la storia degli ultimi cinque decenni. Di storia veramente
certificata si può parlare col saggio di Emilio Gentile In Italia ai tempi di
Mussolini (Mondadori). L'autore è uno storico di fama internazionale per una
serie di studi di grande originalità e autorevolezza. In questo saggio racconta
un viaggio, cominciato con la Grande Guerra, proseguito con le lotte operaie e
contadine del «biennio rosso, con le violenze squadriste, il fascismo e la
conquista del potere da parte di Mussolini. Appare molto importante l'analisi
dei testi degli osservatori stranieri sui cambiamenti economici e culturali del
regime. Un saggio «globale» sull'Italia del ventennio che fa capire come certi
nodi e difficoltà di ordine politico ed economico risalgano proprio all'epoca
del totalitarismo. A proposito di totalitarismo, un libro di questi giorni getta
nuova luce sul regime comunista dell'Urss. Lo ha scritto Svetlana Aleksievic (Tempo
di seconda mano, Bompiani), giornalista e scrittrice ucraina. Svetlana ha
dato voce a un racconto corale della grande utopia comunista che per 70 anni ha
caratterizzato la vita dell'Urss e della Russia. Si tratta di un affresco a
tinte fosche di vittime (contadini, ma anche intellettuali, studenti, operai,
donne, anziani), di misconosciti eroi sovietici in tempi di pace e di guerra e
di carnefici. È un terribile e sconvolgente spaccato della cosiddetta «civiltà
sovietica» e di ciò che è rimasto, o meglio dello spirito di adattamento a un
«tempo di seconda mano» nella Russia dopo il crollo del comunismo. Infine
segnaliamo due libri importanti sugli orrori del nazismo. Il primo,
Bombardare Auschwitz di Umberto Gentiloni Silveri (Mondadori) analizza la
storica polemica sulla opportunità, da parte degli alleati, di bombardare i
lager nazisti. Ancora oggi gli storici si chiedono: come mai quelle «fabbriche
di morte» non vennero prese di mira dai bombardieri alleati, visto che gli
angloamericani sapevano tutto? L'autore ricostruisce la fitta trama di
incomprensioni, scoprendo molte cose inedite sulla tragedia della Shoah. L'altro
saggio è di Matteo Marani, un noto giornalista sportivo che nel libro Dallo
scudetto ad Auschwitz (Imprimatur editore) ricostruisce la storia di Arpad
Weisz, allenatore ebreo, morto nel 1944 in un lager nazista. L'autore ha
lavorato ben tre anni per scoprire la tragica storia dell'allenatore del
Bologna, vincitore di ben quattro scudetti tra il 1930 e il 1938. Ne è scaturito
un romanzo affascinante che commuove e indigna.
Mafia e massoneria, il
pentito Messina: “Almeno due boss in ogni loggia”.
“Ci sono province impregnate di questa cosa, come Trapani: c’è un potere
alternativo al nostro, dove si racchiude il vero potere, politica, economia,
magistrati, onorevoli” ha detto il pentito deponendo al processo sulla strage
del Rapido 904. Secondo la relazione del pg Scarpinato, Matteo Messina Denaro
sarebbe attualmente impegnato a fondare nuove logge nel trapanese, scrive
Giuseppe Pipitone su “L’Ora Quotidiano”. Due uomini d’onore all’interno di ogni
loggia: così Cosa Nostra e la massoneria hanno unito le rispettive forze nella
medesima strategia criminale. A raccontarlo il collaboratore di giustizia
Leonardo Messina, boss di San Cataldo, ex braccio destro di Piddu Madonia, già
autore di alcune rivelazioni inedite. Era stato Messina il primo a raccontare
dei summit nei dintorni di Enna, alla fine del 1991, per mettere a punto la
strategia stragista della primavera successiva. Oggi il pentito ha deposto al
processo per la strage del Rapido 904, in corso davanti alla corte d’assise di
Firenze che sta processando Totò Riina, accusato di essere il mandante
dell’eccidio che il 23 dicembre 1984 fece 17 vittime. Durante la sua
deposizione, Messina ha descritto nel dettaglio il rapporto tra la mafia e le
logge massoniche. “Cosa Nostra – ha detto il pentito – all’interno di ogni
loggia massonica deve avere due uomini di onore. Ci sono province impregnate di
questa cosa, come Trapani. Bontade per esempio era sia uomo d’onore, sia
massone. Dicevano che anche Madonia era massone. Nella massoneria c’è un potere
alternativo al nostro, dove si racchiude il vero potere, politica, economia,
magistrati, onorevoli”. Un rapporto, quello tra Cosa Nostra e la massoneria,
ancora attualissimo. Il boss di Castelvetrano Matteo Messina Denaro starebbe
puntando sulla creazione di nuove logge nella zona di Mazara del Vallo: un
escamotage per stringere nuovamente alleanze con professionisti e imprenditori.
La nuova strategia di Messina Denaro è descritta nella relazione consegnata dal
procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato al presidente della corte
d’appello in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Un report,
quello di Scarpinato, che s’incrocia con e indagini della procura di Palermo:
Messina Denaro, stando ad un’intercettazione telefonica, “si è rifatto tutte
cose”, e cioè si sarebbe sottoposto ad un intervento di chirurgia estetica per
alterare i suoi connotati. Un interrogativo che da qualche mese impegna gli
inquirenti. Quel che è certo, però, è che l’ultima primula rossa di Cosa Nostra
sta cercando di inserire uomini a lui fidati nelle logge del trapanese. “I
metodi della mafia e della massoneria – ha detto Messina – erano molto simili.
La massoneria è un’amministrazione del potere intelligente: un dottore non va a
sparare per strada, un avvocato, un magistrato, non lo fanno. Il mafioso invece
è il vero potere, é il potere della paura, la gente ci rispettava. In Sicilia
specie negli anni ’70 non c’era quasi controllo e la gente ci temeva”. Un
elemento importante del rapporto tra Cosa Nostra e la massoneria era quello
relativo alle inchieste della magistratura. “Serviva ad aggiustare i processi –
ha spiegato il pentito – nel mio caso, per un mio processo, mi sono rivolto a un
massone che ha parlato con il giudice e si é rivolto anche a un giudice
popolare, qualcuno é andato a parlare con loro. Sono stato assolto. Se ero
colpevole? Si, ma loro non avevano le prove”.
Nella sua rubrica, Guardie o
ladri su “Il Sole “24 ore”, Roberto Galullo parla in tre parti della massoneria.
Storia/1. L’ex Gran Maestro
Giuliano Di Bernardo in esclusiva su questo blog parla di P2, massoneria, legge
Anselmi e deviazioni. Alla fine del 2014, sull’onda di una serie di eventi
che hanno chiamato in causa, più o meno propriamente, la massoneria italiana e
sulla scia di una serie di indagini della magistratura sul ruolo della stessa in
passate o più vicine vicende (dalla Procura di Reggio Calabria a Palermo, da
Roma a Catanzaro) ho (senza tante speranze) contattato l’ex Gran Maestro del Goi
(Grande Oriente d’Italia, dal ’90 al ‘93) e della Gran Loggia Regolare d’Italia
(Glri, successivamente fino al 2002), Giuliano Di Bernardo. Visto il suo profilo
mi incuriosiva conoscere le sue verità e le sue esperienze su alcune vicende
che, nel recente passato, hanno attraversato, incrociato o lambito la
massoneria. Senza passato è impossibile conoscere il presente. E’ Di Bernardo,
infatti, che, nel giro di pochi mesi, nel 2014 è stato prima chiamato dalla
Procura di Reggio Calabria e poi da quella di Palermo, a rispondere alle domande
dei magistrati su alcune delicatissime vicende storiche i cui contorni sono
ancora nebulosi e senza la cui chiarezza è di fatto impossibile capire quanto
sta accadendo oggi in Italia. Di Bernardo, ad esempio, ha attraversato il
periodo delle stragi mafiose in Italia e la fase immediatamente precedente e
successiva, viste da osservatori privilegiati. Con mia sorpresa, a seguito di
una serie di domande inviate alla sua attenzione (non certo esaustive e di fatto
limitate dalla fallibilità di un giornalista lontano anni luce dalla massoneria,
come sempre rigorosamente super partes nel momento in cui scrive) pochi giorni
fa ho ricevuto le risposte definitive, nel corso delle quali scoprirete anche il
suo percorso massonico attuale. Ne è uscita un’intervista credo interessante,
anche se ho l’impressione che alcune cose sono rimaste in punta di risposta
(verosimilmente anche per il doveroso e sacrosanto rispetto delle indagini
giudiziarie), altre, forse per un riflesso incondizionato, appaiono estremamente
generose e assolutorie su un ruolo non sempre condivisibile avuto dalla
massoneria in questi anni, in altre ancora ho la sensazione che la diplomazia
abbia prevalso sull’opportunità di condividere la conoscenza. Ho cercato di
seguire un filo logico nelle domande ma chiedo venia, fin da ora, se qualche
involontaria e inconsapevole deviazione logica c’è stata. L’abbrivio era quasi
obbligato: la P2 di Licio Gelli dietro la quale ancora troppi misteri si celano
che, a mio modesto avviso, mai saranno chiariti nonostante gli straordinari
sforzi di pm che, anche per questo, vengono regolarmente sottoposti al rischio
di delegittimazione da quei poteri marci che costituiscono sangue e linfa dei
sistemi criminali Buona lettura con questa prima puntata.
Cosa rappresentava la P2:
massoneria o altro?
«La
P2 è stata una loggia regolare del Grande Oriente d’Italia. I Gran Maestri
Salvini e Battelli hanno firmato i tesserini che Gelli rilasciava agli
affiliati. Se il Grande Oriente d’Italia è massoneria, allora lo è anche la P2».
E’ vero, come vocifera
qualche autorevole personaggio politico, che la cosiddetta “legge Anselmi” fu
scritta o suggerita da parlamentari e tecnici massoni che riuscirono così a
guidare i propositi dell’inconsapevole onorevole Tina Anselmi? Ed è vero, in
caso di risposta affermativa, che il risultato sul campo è quello dell’
inapplicabilità o della difficile applicabilità da parte di pm e giudici?
«Non
è questa la sede per entrare nel merito della “legge Anselmi”. A me risulta che
alla sua formulazione partecipò il professor Paolo Ungari (trovato
morto a 66 anni il 6 settembre 1999 per la caduta nella tromba dell’ascensore,
avvenuta nel fine settimana precedente, al terzo piano del palazzo in piazza
dell’Ara Coeli a Roma in cui aveva sede una delle riviste cui collaborava; la
Procura di Roma ha proposto decreto di archiviazione dopo le indagini ma questo
non è servito a fugare i sospetti e i dubbi sul decesso, ndr), il quale mi
confidò che tale legge tutelerebbe lo Stato dalle trame delle società segrete
solo in apparenza, poiché la sua applicazione a casi reali è quasi impossibile.
In quegli anni ero Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia e il professor
Ungari era molto vicino a me sia come collega universitario sia come massone».
Commentatori, giornalisti,
politici e classe dirigente distinguono, doverosamente, tra “massoneria” e
“massoneria deviata”. Esiste anche a suo avviso questa differenza e, nel caso di
risposta negativa, come giustifica l’esistenza della distinzione, anche atteso
il fatto che lei, ancora oggi, è un massone di rilevanza internazionale?
Sarebbe, dunque, “deviato” anche lei?
«Sulla
distinzione tra “massoneria” e “massoneria deviata” esiste la più grande
confusione. E’ importante, perciò, definirla. “Deviare”, in tutte le possibili
accezioni, significa “allontanarsi da qualcosa (un fine, un principio, una
norma)”. Riferita alla massoneria, è deviata quella massoneria che si allontana
dal fine da essa dichiarato. Un esempio tipico di massoneria deviata è la loggia
P2, poiché, pur essendo una loggia regolare del Grande Oriente d’Italia, ha
perseguito fini che si sono allontanati (hanno deviato) dai fini del Goi. Da
ciò segue che è lecito e logico parlare di “loggia deviata” se, e solo se, tale
loggia appartiene a una Obbedienza massonica. Al di fuori dell’Obbedienza, non
può esistere una loggia deviata. Parlare di una singola loggia come “loggia
deviata” è semplicemente insensato. Per quel che mi riguarda, è vero che
mantengo relazioni massoniche internazionali, ma la mia missione è quella di
rifondare la massoneria originaria e autentica, al di sopra di tutte le
deviazioni storiche ed esoteriche che sono state prodotte in tempi recenti».
Potrebbe chiarire che cosa
si intende per massoneria ufficiale?
«Definire
la “massoneria ufficiale” in Italia è impresa ardua, poiché dipende dal punto di
vista che assumiamo. Una convenzione, generalmente condivisa e operante fin
dalle origini moderne della massoneria, stabilisce che è regolare e “ufficiale”
in un Paese quella, e soltanto quella, che è stata riconosciuta dalla Gran
Loggia Unita d’Inghilterra. In Italia oggi, l’unica massoneria riconosciuta
dall’Inghilterra è la Gran Loggia Regolare d’Italia, da me fondata nel 1993, di
cui sono stato Gran Maestro fino al 2002. Da ciò segue che tutte le altre
massonerie, inclusa il Grande Oriente d’Italia, non sono regolari. Con questo
punto di vista, che privilegia il riconoscimento inglese, solo la Gran Loggia
Regolare d’Italia è “ufficiale”. Tutte le altre non lo sono. Preciso che
l’Inghilterra, sulla base delle sue Costituzioni, può riconoscere, in Italia e
negli altri paesi del mondo, una sola massoneria».
Il Goi è riconosciuto,
tuttavia, dalle Gran Logge statunitensi, che non riconoscono la Gran Loggia
Regolare d’Italia. Possiamo dire che anche il Goi è massoneria “ufficiale”? E
cosa dire delle altre massonerie che non sono riconosciute né dall’Inghilterra
né dagli Stati Uniti d’America? Sono anche loro massonerie ufficiali? Poiché
ogni Obbedienza cerca di privilegiare il criterio che l’avvantaggia, la
confusione regna sovrana.
«Il
3 novembre il gup di Roma, Paola Della Monica ha rinviato a giudizio il senatore
di Forza Italia Denis Verdini nell’ambito della cosiddetta P3, una presunta
associazione segreta caratterizzata, come hanno scritto i pm, “dalla
segretezza degli scopi, dell’attività e della composizione del sodalizio e volta
a condizionare il funzionamento di organi costituzionali e di rilevanza
costituzionale, nonché apparati della pubblica amministrazione dello Stato e
degli enti locali”. Insieme a Verdini è stato rinviato a giudizio anche l’ex
sottosegretario all’Economia dell’ultimo governo Berlusconi, Nicola Cosentino».
E’ ridicolo parlare di P3,
P4 e via di questo passo, sono insomma invenzioni giornalistiche, oppure è
ancora legittimo e reale il rischio (o la concretezza) di associazioni segrete
che condizionino lo Stato? E quanto è concreto e reale il rischio?
«Ho
presentato la P2 come esempio tipico di loggia deviata. Una caratteristica
essenziale che la distingue è la sua appartenenza al Grande Oriente d’Italia.
Quando si parla di P3 e di P4, è necessario confrontarle con la P2 e chiedersi a
quale obbedienza esse appartengono. Se non si può connetterle a Obbedienze
massoniche, queste lobby non hanno proprio nulla a che fare con la massoneria.
Sono semplicemente un’invenzione giornalistica, accattivante ma insensata. Anche
se i membri di tali presunte logge si riunissero in un tempio, indossassero
grembiuli e recitassero rituali, la loro estraneità alla massoneria sarebbe
ancora più evidente. L’abito non fa il monaco. Che queste lobby rappresentino un
rischio e un pericolo concreto per lo Stato è chiaro ed evidente, a prescindere
dalla loro collocazione, dentro o fuori la massoneria».
Può raccontare perché
decise di lasciare (o lasciò) il vertice del Goi?
«La
risposta presuppone alcune premesse. Io sono stato il primo e forse l’ultimo
Gran Maestro filosofo. Coloro che mi hanno preceduto e seguito avevano altri
interessi. Per me la massoneria significa condividere una concezione dell’uomo e
della vita, come avevo scritto nel mio volume Filosofia della massoneria. Dalla
mia iniziazione avvenuta nel 1961, non ho mai cercato cariche e privilegi. Dopo
la mia elezione a Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia nel 1990, ho cercato
di realizzare quel modello di massoneria in cui credevo. Ero al vertice della
più potente massoneria italiana, ma ne ignoravo l’organizzazione e la qualità
degli uomini. Convinto che il Goi dovesse essere portato fuori dalle nebbie del
passato, diedi inizio all’operazione “trasparenza”, che subito mi portò le prime
delusioni. Molti dei massoni alla mia obbedienza non capivano la necessità del
cambiamento e restavano ancorati a ciò che credevano fossero antichi privilegi.
Il confronto con la massoneria inglese, da me sempre ritenuta la più alta
espressione della regolarità massonica, mi faceva avvertire l’arretratezza del
Goi, almeno per quanto riguarda l’esoterismo e il fondamento iniziatico. La mia
delusione cresceva a mano a mano che ne diventavo sempre più consapevole. Quando
ebbe inizio l’indagine contro la massoneria del procuratore Agostino Cordova nel
1992, mi resi definitivamente conto che la massoneria che governavo era in gran
parte estranea all’idea che di massoneria mi ero fatto nel corso della mia vita.
Incontrai i vertici della massoneria inglese, espressi loro le mie
preoccupazioni e chiesi che cosa avrei dovuto fare. La risposta fu semplice:
dimettiti dal Grande Oriente d’Italia e fonda una nuova massoneria, che noi
riconosceremo. Così è stato. Il resto è storia. Se io mi fossi semplicemente
dimesso, la maggioranza dei massoni del Goi avrebbe salutato la mia uscita con
un sospiro di sollievo. Ma non fu così perché le mie intenzioni non erano quelle
di tornare a insegnare Filosofia della scienza nell’università di Trento. In
realtà, io volevo introdurre in Italia, per la prima volta, il modello della
massoneria inglese. Per fare questo avrei dovuto difendermi dal Goi che non
voleva perdere il riconoscimento inglese. Preciso che la Gran Loggia Unita
d’Inghilterra non può riconoscere, nello stesso paese, due o più massonerie.
Quindi, doveva scegliere tra il Goi e la Glri. Anche questa è storia: l’8 agosto
del 1993 la Gran Loggia Unita d’Inghilterra ritira il riconoscimento al Goi e lo
dà, l’8 dicembre dello stesso anno, alla Gran Loggia Regolare d’Italia, la
massoneria che avevo appena fondato. Il Grande Oriente d’Italia così perdeva il
tanto agognato riconoscimento inglese, che aveva ottenuto nel 1972, 110 anni
dopo che il Gran Maestro Costantino Nigra ne aveva fatto richiesta. Questa è la
sorgente dell’odio che si scatenò contro di me e che ancora perdura».
Oltre e indipendentemente
dalla sua risposta sul punto: alcuni commentatori del blog nel recente passato
hanno fatto riferimento a risvolti poco chiari sulla sua uscita dal Goi. Quali
furono (se ci furono) questi risvolti poco chiari sulla sua uscita dal Goi
secondo la sua ricostruzione dei fatti? Ci furono anche strascichi giudiziari
per la sua uscita?
«Ero
diventato il “traditore” che doveva essere abbattuto con tutti i mezzi, legali e
diffamatori. Sul piano legale fui querelato per diffamazione da Augusto De
Megni, Sovrano Gran Commendatore del Rito Scozzese Antico e Accettato, e da
Licio Gelli. Fui assolto, in entrambi i casi, perché il fatto non sussisteva. Le
diffamazioni, che tendevano a offuscare la mia onorabilità, furono di vario
genere: dall’accusa di essere un emissario dell’Opus Dei all’espulsione
dall’università di Trento per condotta indegna, al ripudio da parte di mia
moglie per infedeltà. Nessuna accusa per traffici vari e tangenti perché non
sarebbero stati credibili. Solo il Goi dichiarò che avevo ricevuto dal suo
Tesoriere una somma non dovuta. Il mio commercialista dimostrò che avrei dovuto
ancora avere dal Goi sette milioni di lire. Li sto ancora aspettando. Ancora
oggi capita che qualcuno, per sentito dire, mi rivolge accuse infamanti. A
costoro io chiedo di accusarmi formalmente e alla luce del sole, così tutti
potranno capire la verità».
In che rapporti è, oggi,
con il Goi e con le altre obbedienze massoniche?
«Con
il Grande Oriente d’Italia, dalle mie dimissioni a oggi, non esistono rapporti
di alcun tipo. Restano i rapporti personali con quei fratelli che avevano
compreso la necessità e l’urgenza della mia riforma della massoneria italiana.
Continuano ancora a sognarla».
Quanti sono i massoni oggi
in Italia delle varie comunioni?
«Le
voci meglio informate dicono che i massoni italiani sono circa 100.000. Per fare
che cosa? La massoneria è entrata in crisi quando, da comunione elitaria, si è
trasformata in società di massa. Se in Italia vi fossero 300 massoni,
espressione delle élite lungimiranti e carismatiche, con il loro indubitabile
sostegno alle istituzioni dello Stato, la vita sociale, economica e culturale
degli italiani sarebbe migliore».
Con quali risorse nacque il
Goi e grazie a quali risorse, che risulterebbero essere ingentissime se non
altro alla luce delle proiezioni persino extraparlamentari che sembrerebbero
aver pervaso alcuni affiliati in determinati periodi storici, vivono e
prosperano oggi le logge massoniche? Chi, parlando in altri termini, ha messo i
soldi per far diventare così grande il Goi e chi continua a metterli nelle
obbedienze?
«Se
riferita al Goi, la domanda prende in considerazione un periodo di tempo di
circa 150 anni (dalle origini ai nostri giorni). Fino all’avvento del Fascismo,
il Goi ha controllato la vita italiana in tutti i suoi più importanti aspetti.
Il problema di chi finanziasse non aveva alcun senso, poiché esso poteva avere
tutto da tutti. Durante il Fascismo (dalle leggi contro le società segrete del
1925 alla sua caduta) il Gran Maestro Domizio Torregiani ha vissuto in esilio e
l’attività delle logge è stata quasi inesistente. Dopo la seconda guerra
mondiale, l’intervento degli Stati Uniti d’America è stato determinante per la
rinascita della massoneria in Italia. La maggior parte dei finanziamenti
proveniva proprio da loro. Con la frantumazione della massoneria in diverse
Obbedienze, iniziano percorsi e finanziamenti particolari, nonostante la volontà
degli americani di riunire tutte le obbedienze in una sola massoneria. Per
quanto riguarda la mia esperienza di Gran Maestro del Goi, dal 1990 al 1993, i
finanziamenti provenivano dalle capitazioni (quote annuali) e da contributi
straordinari di fratelli benestanti. Se il Goi è diventato grande, le ragioni
vanno ricercate nel suo ruolo politico ed economico nella società italiana. Le
risorse e i finanziamenti hanno certamente influito ma non in maniera
determinante. Dalle mie dimissioni del 1993 a oggi, non ho conoscenza di come
avvenga il recupero delle risorse finanziarie, né nel Grande Oriente d’Italia né
nella Gran Loggia Regolare d’Italia».
Cosa è il Dignity Order
il cui vertice Lei presiede? Un enigma, un mistero, una certezza massonica?
Cosa è e quanto potente è la sua influenza? Quali sono le risorse con le quali
esercita la sua missione e quanti e chi sono, se è lecito sapere, gli iscritti?
«Nel
2002 avviene il mio ritiro definitivo dalla massoneria. Alla base di tale
decisione vi è la convinzione che la massoneria, faro luminoso dell’Occidente,
stia perdendo irrimediabilmente la forza propulsiva che ha fatto di essa una
guida saggia dell’umanità. Non perché i suoi principi e il fondamento iniziatico
che li sorregge abbiano perso la loro rilevanza, quanto, piuttosto, per
l’incapacità dei massoni a interpretarli nel senso autentico. La stessa
massoneria inglese, madre di tutte le massonerie regolari del mondo, mostrava
segni di una profonda crisi che preannunciava scismi e conflitti. Abbandonavo
quella massoneria, cui ero stato iniziato nel lontano 1961 e che era stata una
guida sicura della mia vita, per fondare l’Accademia Internazionale degli
Illuminati. Il mio scopo era quello di riformare la massoneria, ritornando alle
sue origini settecentesche, governata dalle élite pensanti. L’Accademia degli
Illuminati si ispira, infatti, alla Royal Society inglese. L’Accademia ha
successo e si diffonde anche all’estero. Intanto comincia a intravedersi una
crisi mondiale non solo economica e finanziaria ma anche morale. La società
reale accusa i primi colpi di questa crisi, che si annuncia lunga e dolorosa.
Gli Illuminati non bastano più. E’ arrivato il tempo degli Operativi, profondi
conoscitori dei livelli concreti della società. Dal connubio tra Illuminati
speculativi e Illuminati operativi, si gettano le fondamenta di un nuovo Tempio
dell’umanità, per affrontare le nuove sfide che già si preannunciano
all’orizzonte. Nasce così nel 2011 “Dignity. Ordine per la difesa della dignità
dell’uomo”. Le principali differenze tra Dignity e la massoneria sono le
seguenti.
1. Dignity è composta da
élite, la massoneria da masse.
2. Dignity ammette le donne,
la massoneria le esclude.
3. Dignity è internazionale,
la massoneria è nazionale. La sede internazionale di Dignity è a Vienna, dove si
riunisce il Consiglio del Gran Maestro. Dignity nasce in Italia e si diffonde
anche all’estero.
4. Il Rituale di Dignity si
ispira alla filosofia, i Rituali della massoneria si ispirano alla religione
(Emulation inglese) o a fatti storici (il Goi).
5. Dignity e la massoneria
hanno in comune il riferimento alla Tradizione esoterica dell’umanità, che
inizia nel VI secolo a.C. in Grecia con i Misteri orfici. Ne fanno anche parte
la Confraternita dei Rosacroce e l’Ordine degli Illuminati.
L’Ordine Dignity nasce e si
sviluppa nella più completa trasparenza. Le Associazioni che la governano sono
state legalmente costituite e registrate secondo le leggi dei Paesi che le
ospitano (Italia e Austria). Essa è, quindi, una certezza esoterica.
Le risorse con cui esercita la
sua missione sono le quote annuali (ordinarie e straordinarie) e le donazioni.
Gli adepti in Italia sono circa cento. Le riunioni dell’Ordine, denominate
“Conventi” (locali, nazionali, internazionali), si svolgono in luoghi non
riservati: il Convento internazionale di Primavera-Estate si è svolto all’Hotel
Miramonti di Cortina d’Ampezzo, mentre il Convento internazionale d’Autunno ha
avuto luogo all’Hotel Royal di San Remo. Ospiti e autorità sono stati invitati
alla cena di gala. Nessuno si è nascosto. Tutti hanno mostrato i simboli
dell’Ordine».
Bene. Ci fermiamo qui ma
domani torno con la seconda puntata.
Storia/2. L’ex Gran Maestro
Giuliano Di Bernardo in esclusiva sul blog parla di trasparenza, affiliazioni e
decadenza della massoneria. Cari amici di blog, se mi avete seguito ieri
sapete che sto pubblicando un’intervista a puntate (vista la complessità delle
materie trattate) all’ex Gran Maestro del Goi (Grande Oriente d’Italia, dal ’90
a al ‘93) e Gran Loggia Regolare d’Italia (Glri, successivamente e fino al 2002)
Giuliano Di Bernardo. Visto il suo profilo mi incuriosiva conoscere le sue
verità e le sue esperienze su alcune vicende che, nel recente passato, hanno
attraversato, incrociato o lambito la massoneria. Senza passato è impossibile
conoscere il presente. E’ Di Bernardo, infatti, che, nel giro di pochi mesi, nel
2014 è stato prima chiamato dalla Procura di Reggio Calabria e poi da quella di
Palermo, a rispondere alle domande dei magistrati su alcune delicatissime
vicende storiche i cui contorni sono ancora nebulosi e senza la cui chiarezza è
di fatto impossibile capire quanto sta accadendo oggi in Italia. Di Bernardo, ad
esempio, ha attraversato il periodo delle stragi mafiose in Italia e la fase
immediatamente precedente e successiva, viste da osservatori privilegiati. Nella
parte dell’intervista di ieri Di Bernardo ha inquadrato il suo profilo, parlando
a 360 gradi di massoneria, delle sue deviazioni, della legge Anselmi, dei suoi
attuali rapporti con le obbedienze massoniche, del Dignity Order che ha fondato
nel 2011 e di altre cose ancora. Premesse necessarie (ma non certo sufficienti)
per affrontare questa seconda puntata in cui si entrerà ancora più nel vivo.
Buona lettura.
A sua diretta conoscenza o
certezza acquisita quali alti vertici dello Stato, della politica,
dell’economia, della finanza vanta oggi la massoneria?
«Per
capire il “peso” della massoneria, è necessario considerarlo nella dimensione
temporale: ieri, oggi, domani. Dall’unità d’Italia fino all’avvento del
Fascismo, la massoneria ha dominato incontrastata la politica, l’economia, la
finanza, le banche, le forze armate, la cultura. Non esisteva allora
l’opposizione del Vaticano e della Chiesa Cattolica. Il Fascismo ha dichiarato
fuorilegge la massoneria e l’ha esiliata. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, è
rinata con il sostegno della massoneria statunitense, che impose alcune
condizioni destinate a pesare molto sugli sviluppi successivi. Nonostante
interventi autorevoli di esponenti di spicco della massoneria statunitense, le
guerre tra le rinate comunioni massoniche (più o meno legittime) sono state
inevitabili ed è cominciato quel gioco al massacro che ha sempre impedito di
avere in Italia una massoneria autorevole e potente. Nell’immediato dopoguerra,
il peso complessivo della massoneria italiana è stato quasi irrilevante.
Crescerà a dismisura con l’avvento di Licio Gelli e della P2. Non è questa la
sede per riconsiderare la natura e il ruolo della loggia P2. Dirò semplicemente
che, grazie alla P2, la massoneria italiana è stata proiettata, almeno
nell’opinione pubblica, ai vertici della massoneria mondiale. Se non vi fosse
stata quell’ intervista di Gelli al Corriere della Sera che rese evidente il
pericolo della P2, egli avrebbe controllato tutti i più importanti “luoghi del
potere” in Italia. Con la crisi della P2, inizia l’inesorabile decadenza del
“potere” massonico, non solo nel Grande Oriente d’Italia che aveva dovuto
“risolvere” al proprio interno i danni della P2, ma anche nelle altre
Obbedienze. Nel 1990 sono stato eletto Gran Maestro del Goi. La prima cosa che
ho fatto è stata quella di “pesare” il suo potere. L’idea che mi son fatto è la
seguente: prima di Gelli c’erano i “sergenti”, con Gelli arrivano i “generali”,
dopo Gelli si passa ai “caporali”. La discesa è inarrestabile».
Perché allora sempre più
persone vogliono iscriversi alla massoneria? Fede o convenienza?
«La
massoneria ha sempre esercitato un profondo fascino fin dalle sue origini agli
inizi del Settecento. Non solo per il potere che essa emanava, ma anche per le
cerimonie di iniziazione, passaggio ed elevazione. Dava, inoltre, un profondo
senso di appartenenza che gratificava i suoi adepti. Ma quella massoneria, nata
sul modello della monarchia inglese, era costituita da élite pensanti e
operanti. Aveva un grande potere che metteva a disposizione dei governanti dello
Stato, come risulta nella storia dei Paesi in cui vi è stata una massoneria.
Quella massoneria non esiste più. Quel che oggi si chiama massoneria non è
massoneria. Dalla fine della seconda guerra mondiale è iniziata una
“controiniziazione” che sta profanando e distruggendo il fondamento esoterico
della massoneria. Nonostante tutto, la massoneria continua ad attrarre. Perché?
Non per le sue cerimonie rituali nel tempio, che ancora vi sono anche se sono
state svuotate del loro significato esoterico. La massoneria attrae per
interesse materiale. Nell’Italia di oggi, essa è l’ultima spiaggia per trovare
un lavoro, per uscire dalla disperazione in cui sono caduti generazioni di
giovani che si son visti privare della speranza per il futuro. Non voglio dire
che questa sia l’esclusiva ragione per bussare alle porte del tempio massonico,
ma ne è oggi la tendenza generale. Nella massoneria italiana, vi sono ancora
autentici massoni, i quali però soffrono per la “controiniziazione” che è in
atto. Io offro loro una “scialuppa di salvataggio” per riunirli nell’afflato
iniziatico. Un esempio tipico, che convalida quanto ho detto sopra, è proprio il
boom di massoni in Calabria in tutte le Obbedienze, da quelle storiche a quelle
appena nate. In città (Reggio Calabria, ndr), si ridicolizza sul
“venerdì massonico”, ma esso è l’espressione più evidente che la massoneria,
almeno in Italia, è morta».
Poco si parla, ma a mio
modesto avviso molto di dovrebbe invece parlare, di affiliazione alla massoneria
di magistrati e alti rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Per la sua
esperienza, passata e presente, quanto massiccia è la loro presenza e a quali
fini?
«Magistrati
e rappresentanti delle Forze dell’Ordine hanno sempre avuto accesso nelle logge
massoniche. In base alle mie esperienze, direi che oggi la loro presenza è molto
limitata. Vorrei riflettere, invece, sull’opportunità della loro appartenenza
alla massoneria. E’ chiaro che, dal momento in cui lo Stato riconosce le
associazioni massoniche, tutti i cittadini italiani hanno il diritto di farne
parte: se magistrati e rappresentanti delle Forze dell’Ordine vogliono diventare
massoni, hanno tutto il diritto di farlo. Il punto in discussione, tuttavia, non
riguarda tanto il diritto, quanto, piuttosto, l’opportunità. Non intendo entrare
nel merito del problema. Cercherò, invece, di chiarirlo con un esempio. Quando
Norberto Bobbio venne a sapere che ero diventato Gran Maestro del Grande Oriente
d’Italia, tramite alcuni colleghi universitari, chiese d’incontrarmi. I miei
rapporti con Bobbio risalivano agli anni Settanta, quando eravamo promotori di
studi e ricerche sulla Filosofia del diritto e sulla Logica deontica. Bobbio,
con la franchezza che lo caratterizzava, mi disse: “Io ho sempre ammirato e in
parte condiviso i principi che ispirano la massoneria, ma non ho mai capito (e
per questo l’avverso) perché si rifiuta di agire alla luce del sole.
Consideriamo il caso in cui tu, io e altri tre professori ordinari siamo in una
commissione per valutare alcuni candidati che aspirano a diventare professori
ordinari. Di quattro commissari tutti sanno a quale concezione della vita fanno
riferimento (laico, cattolico, comunista, liberale) ma di te nessuno sa nulla.
Mi sono sempre chiesto a quale mondo tu appartenga. Adesso so, perché l’ho letto
sui giornali, che sei massone. Io non ti nego il diritto di essere massone. Ti
chiedo però di dirmelo affinchè io possa capire le tue scelte nei concorsi
universitari. Se tu, nei lavori della commissione, nascondi i tuoi riferimenti
valoriali, io posso anche pensare che tu stia perseguendo finalità contrarie
alle istituzioni dello Stato. Posso comprendere che, durante le lotte
risorgimentali, i massoni si dovessero nascondere per salvaguardare la loro
vita, ma oggi viviamo in una società aperta che tutela tutti. La vostra
decisione di continuare a nascondervi fa nascere inevitabilmente timori e
pregiudizi che si rivolgono, in definitiva, contro di voi”. Bobbio aveva
ragione. Dopo la mia elezione a Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, ho
cercato di far uscire la massoneria dalle “catacombe” col progetto denominato
“trasparenza”. Fui sconfitto e, con me, si sconfisse anche la massoneria. Da
questa premessa, discende un’idea che è andata sempre più sviluppandosi nella
mia mente. Oggi io penso che magistrati e rappresentanti delle Forze dell’Ordine
non debbano essere affiliati alla massoneria. Il loro ruolo nella società è
quello di tutori dello Stato, al di sopra delle parti. Questo vale non solo per
la massoneria ma anche per tutte le altre istituzioni. Per la massoneria, almeno
per la ragione addotta da Bobbio, la loro ammissione è ulteriormente
inopportuna. Questo limite vale, purtroppo, per la massoneria italiana. Se
usciamo dall’Italia e andiamo verso Paesi dove la massoneria è trasparente (non
si nasconde) come l’Inghilterra e gli Stati Uniti d’America, troviamo magistrati
e rappresentanti delle Forze dell’Ordine che ostentano con simboli e
atteggiamenti la loro appartenenza alla massoneria. In questi Paesi, non vi
sarebbe mai un Bobbio che esprime dubbi sulla massoneria. Io ho cercato, ma
inutilmente, di riformare la massoneria italiana per renderla, circa il modo di
rapportarsi alla società, simile a quella anglo-americana».
A Suo giudizio qual è e
quanto eventualmente grave è l’affiliazione alla massoneria degli uomini dei
servizi segreti italiani e internazionali?
«Se
ritengo inopportuna l’affiliazione alla massoneria di magistrati e
rappresentanti delle Forze dell’Ordine, a maggior ragione ritengo grave
l’affiliazione di esponenti dei servizi segreti, nazionali e internazionali. La
loggia non può essere il luogo ove avvengono intrighi di ogni tipo. Tanto forte
è stata per me tale convinzione che, dopo la mia elezione a Gran Maestro del
Goi, ho deciso lo scioglimento della famigerata loggia “Colosseum”, ritrovo di
spie di tutto il mondo. La motivazione ufficiale? Non pagavano le capitazioni».
Se davvero massoneria è
sinonimo di oltre che di riservatezza, anche di trasparenza, perché mai non
vengono forniti i nomi degli iscritti alle Prefetture affinché tutti possano
giudicare l’opportunità o meno di certe affiliazioni secondo criteri di buon
senso, oltre che di legge?
«I
nominativi di massoni delle varie Obbedienze non vengono forniti ufficialmente
alle autorità dello Stato (Ministero degli Interni, Prefetture, Questure) poiché
si continua a privilegiare il “gioco a nascondino”, con la motivazione che solo
così si evitano le “persecuzioni”. E’ semplicemente ridicolo parlare di
persecuzioni in uno Stato democratico. Nella realtà, tuttavia, gli elenchi si
trovano in molte Questure, ove zelanti massoni, non autorizzati ufficialmente
dalle autorità massoniche, li hanno consegnati confidenzialmente, forse per
accattivarsi la loro benevolenza. Proprio perché io sono convinto assertore
della trasparenza, dopo aver lasciato il Goi e fondato la Gran loggia Regolare
d’Italia, ho concordato col Ministro degli Interni la consegna ufficiale di
tutti gli iscritti alla Glri: alla fine di gennaio di ogni anno, il Gran
Segretario avrebbe consegnato, con la procedura formale, a due Prefetti nominati
appositamente per tale scopo dal ministro, l’elenco completo (con le relative
generalità) di tutti gli affiliati alla Gran Loggia Regolare d’Italia. L’elenco
sarebbe stato preso in consegna e chiuso in una cassaforte, a disposizione delle
autorità dello Stato che desiderassero visionarlo. Così è stato per tutti gli
anni che ne sono stato Gran Maestro».
Pubblicherebbe dunque i
nomi degli iscritti alla sua obbedienza?
«Finché
sono stato Gran Maestro della Gran Loggia Regolare d’Italia, ho sempre
pubblicato gli elenchi dei massoni alla mia obbedienza, come ho spiegato
precedentemente. L’Ordine Dignity, che ho fondato dopo il mio ritiro definitivo
dalla massoneria mondiale, non è un’Obbedienza massonica, come spiegherò tra
poco. Essa s’ispira ai principi che regolano il percorso esoterico dell’umanità
e svolge le sue attività sotto la luce del sole, in piena trasparenza in Italia
e all’estero. Se per ipotesi si dovesse rendere necessario pubblicizzare i suoi
elenchi, non tarderei un solo istante a farlo».
Ci fermiamo qui ma domani
torno con la terza e ultima puntata.
Storia/3. L’ex Gran Maestro
massone Giuliano Di Bernardo in esclusiva sul blog parla di Cosa nostra,
‘ndrangheta e dei rischi attuali per la democrazia. Cari amici di blog, se
mi avete seguito nei due giorni appena trascorsi, sapete che sto pubblicando
un’intervista a puntate (vista la complessità delle materie trattate) all’ex
Gran Maestro del Goi (Grande Oriente d’Italia, dal ’90 a al ‘93) e Gran Loggia
Regolare d’Italia (Glri, successivamente e fino al 2002) Giuliano Di Bernardo.
Visto il suo profilo mi incuriosiva conoscere le sue verità e le sue esperienze
su alcune vicende che, nel recente passato, hanno attraversato, incrociato o
lambito la massoneria. Senza passato è impossibile conoscere il presente. E’ Di
Bernardo, infatti, che, nel giro di pochi mesi, nel 2014 è stato prima chiamato
dalla Procura di Reggio Calabria e poi da quella di Palermo, a rispondere alle
domande dei magistrati su alcune delicatissime vicende storiche i cui contorni
sono ancora nebulosi e senza la cui chiarezza è di fatto impossibile capire
quanto sta accadendo oggi in Italia. Di Bernardo, ad esempio, ha attraversato il
periodo delle stragi mafiose in Italia e la fase immediatamente precedente e
successiva, viste da osservatori privilegiati (rimando alla prima parte con il
link a fondo pagina). Nella prima parte dell’intervista di lunedì, Di Bernardo
ha inquadrato il suo profilo, parlando a 360 gradi di massoneria, delle sue
deviazioni, della legge Anselmi, dei suoi attuali rapporti con le obbedienze
massoniche, del Dignity Order che ha fondato nel 2011 e di altre cose ancora.
Premesse necessarie (ma non certo sufficienti) per affrontare la seconda puntata
in cui si è entrati nel vivo delle affiliazioni, della necessità di trasparenza
e della sua visione decadente della e nella massoneria. Oggi entriamo ancora più
nel vivo (ripeto: senza alcuna pretesa di esaustività o verità assoluta), con la
lettura di Di Bernardo sul rischio (nella migliore delle ipotesi) di
infiltrazioni mafiose nelle logge massoniche di varie obbedienze. Una lettura
che corre parallela (saranno le indagini a stabilire se si incroceranno in uno o
più punti) ad alcune delicatissime indagini che si stanno svolgendo da Palermo a
Reggio Calabria, da Catania a Caltanissetta (solo per citare alcune procure).
Buona lettura.
Collaboratori di giustizia
(cito per tutti il calabro-milanese Antonino Belnome) e uomini di ‘ndrangheta
(cito tra tutti Pantaleone Mancuso) hanno detto o fatto riferimento al fatto che
oltre la ‘ndrangheta c’è la massoneria. Come interpreta queste affermazioni?
Cosa vogliono dire? Anche alla luce del fatto che già nell’indagine “Sistemi
criminali” del ’98 dell’allora pm Roberto Scarpinato, risultava, da
dichiarazioni di pentiti, che la massoneria calabrese era la più potente del Sud
e tra le più potenti d’Italia.
«Direi
che ‘ndrangheta e massoneria si trovano a condividere una rappresentazione
verticistica del potere, con modalità esoteriche. L’affiliazione alla
‘ndrangheta o l’iniziazione alla massoneria segue un rituale che, oltre le
specificità storiche e contingenti, ha molte analogie. L’affiliato alla
‘ndrangheta è perciò predisposto a essere massone. Questo spiega, al di sopra
degli interessi materiali, l’enorme affluenza nelle logge calabresi. Con questo
non voglio dire che essi siano affiliati della ‘ndrangheta, ma che esiste la
possibilità teorica che lo siano. Il maggior potere della massoneria calabrese,
rispetto alle altre regioni d’Italia, mi sembra un dato acquisito che potrei
confermare».
Recentemente la loggia
Rocco Verduci di Gerace (Reggio Calabria) è stata dapprima “sospesa” per rischio
di infiltrazioni della ‘ndrangheta e poi riammessa dallo stesso Goi nel mese di
giugno. Partendo da questo dato puramente di cronaca, a suo giudizio quanto,
come e perché sono infiltrate le logge massoniche (indipendentemente
dall’obbedienza o comunione alla quale appartengono), della Calabria, della
Sicilia, della Campania e, in genere del Sud?
«Delle
vicende della loggia Rocco Verduci di Gerace so quello che hanno scritto i
giornali. Non avendo una conoscenza diretta e personale non esprimo alcun
giudizio. Sull’infiltrazione nelle logge massoniche, non dovrebbe ormai esistere
alcun dubbio, anche se, nel concreto, è molto difficile documentarne il “peso”».
Esiste una differenza – da
questo punto di vista – tra rischio di una permeabilità criminale al Nord, al
Centro e al Sud?
«Agli
inizi degli anni ’90, tale permeabilità esisteva anche se sporadica e limitata.
L’inchiesta del dott. Agostino Cordova, procuratore di Palmi, ha avuto inizio
con la constatazione che, in molti reati avvenuti in Calabria, erano coinvolti
massoni di diverse Obbedienze. A quel tempo, ero Gran Maestro del Goi. Nel 1992,
ricevetti a Villa Medici del Vascello, sede nazionale del Goi, la richiesta
formale e ufficiale, da parte della Procura di Palmi, di consegnare l’elenco dei
massoni calabresi. Essendo impossibile non adempiere la richiesta del
magistrato, autorizzai la consegna dell’elenco, sperando che tutto finisse lì.
Ma non fu così. Dopo breve tempo, ricevetti un’altra richiesta che riguardava
però la consegna dell’elenco di tutti i massoni italiani del GOI, con la
motivazione che si voleva verificare le relazioni dei massoni calabresi con i
massoni di altre ragioni. Il dott. Cordova sospettava che la massoneria fosse il
tramite per favorire attività vietate dalla legge in tutte le regioni italiane.
Compresi allora che si stava mettendo sotto inchiesta il Goi e le altre
Obbedienze massoniche. Poiché la richiesta non era supportata da un mandato
formale, mi rifiutai di consegnare gli elenchi. Come reazione, la Procura di
Palmi suggellò il computer e vi mise un agente di guardia, in attesa di
procurarsi il mandato per il sequestro. Si parlò dell’”imbavagliamento del
computer”. Con un mandato formale di sequestro, null’altro avrei potuto fare per
impedirlo. La Procura acquisì gli elenchi e iniziò una farsa all’italiana che si
concluse alcuni anni dopo con l’archiviazione dell’inchiesta per decorrenza dei
tempi. L’infiltrazione è continuata in quasi tutte le regioni d’Italia. Da quel
che dicono i mezzi di comunicazione di massa, sembra che essa abbia raggiunto i
vertici delle istituzioni dello Stato. La permeabilità oggi non è un rischio ma
una realtà».
In Calabria, un
procedimento penale in corso, che corre parallelamente anche a Milano
(cosiddetta indagine Breakfast) ipotizza una superloggia calabrese segreta, con
forti addentellamenti e radici oltrefrontiera, in grado di condizionare la vita
amministrativa, organi dello Stato, economia e finanza, in strettissimo legame
con la potente cosca De Stefano. E’ uno scenario possibile a suo giudizio?
«Da
quanto ho detto in precedenza, lo scenario è possibile».
Può raccontare, di
conseguenza, cosa accadde e quali conseguenze ebbe sul Goi e sulla sua personale
vita massonica il viaggio nel Regno Unito a confronto con i vertici della
massoneria, a partire dal Duca di Kent, massima autorità massonica, per
segnalargli il rischio di ingerenze criminali legate a mafia e ‘ndrangheta? Un
incontro, se non erro, che portò quest’ultimo a revocare il riconoscimento al
Grande Oriente d’Italia?
«L’inchiesta
della Procura di Palmi aveva dato l’avvio a una serie di eventi che mi
convinsero a ritenere conclusa la mia esperienza massonica nel Goi. Fu una
decisione sofferta dopo 42 anni di appartenenza. Il dado era tratto. Chiesi un
incontro con i vertici della massoneria inglese ed esposi la situazione così
come l’avevo conosciuta. Chiesi loro cosa avrei dovuto fare. Mi risposero che
erano già a conoscenza di quanto contenuto nel mio rapporto (alla Gran Loggia
Unita d’Inghilterra non mancano le fonti d’informazioni) e mi fecero intendere
la possibile soluzione: dimettermi dal Goi, fondare una nuova Gran Loggia che
avrebbe avuto il loro riconoscimento, dopo averlo ritirato al Goi. Tutto si
compì in otto mesi: le mie dimissioni formali dal Goi (15 aprile 1993), la
fondazione della Gran Loggia Regolare d’Italia (16 aprile 1993), il ritiro del
riconoscimento al Goi (8 agosto 1993), il riconoscimento della Gran Loggia
Regolare d’Italia (8 dicembre 1993). Ancora oggi la Gran Loggia Regolare
d’Italia, di cui sono stato Fondatore e Gran Maestro fino al 2002, detiene il
riconoscimento della Gran Loggia Unita d’Inghilterra. Il Grande Oriente
d’Italia, che l’aveva perso nel 1993, non l’ha più riavuto».
Veniamo all’indagine, che
corre parallela a quella di Reggio Calabria, di Palermo, nella quale, nel
processo sulla trattativa tra Stato e Cosa nostra i pm sono tornati a rievocare
il ruolo della massoneria deviata, della stessa P2, in quel vero o presunto
disegno che voleva portare a un nuovo ordine politico, compresa l’eventuale
secessione o frammentazione dell’Italia in macroregioni: cosa sa di quanto
avvenne in quel periodo ad opera della massoneria deviata in quel progetto folle
e allo stesso tempo ambizioso?
«I
magistrati che indagano sulla trattativa fra Stato e Cosa nostra hanno deciso di
riascoltarmi poiché ritengono che oggi in Italia si stia ripresentando la stessa
situazione del ’92, che io ho vissuto in prima linea. Chiedendomi di spiegare
ulteriormente quegli eventi, essi pensano, per analogia, di comprendere meglio
ciò che sta accadendo ai nostri giorni. Io condivido questa loro impostazione
dell’indagine. Sulla base delle mie esperienze personali e delle conseguenze che
traggo induttivamente dagli eventi, ritengo che oggi la situazione sia più grave
di allora, poiché le deviazioni che in quel tempo esistevano non sono state
corrette, sia in massoneria sia nelle istituzioni statali. Per quanto riguarda
il presunto progetto della P2 per creare un nuovo ordine politico in Italia,
vorrei dire quel che penso. Nella P2, contrariamente a quel che generalmente si
pensa, non vi è stato il progetto di dare un nuovo assetto allo Stato italiano,
semplicemente perché non rientrava nei suoi interessi fondamentali. Gelli,
tuttavia, si era impegnato con il governo statunitense a fare tutto il possibile
per impedire che in Italia si realizzasse il sorpasso dei comunisti. Per
raggiungere questo scopo, esso aveva dato a Gelli aiuti di ogni tipo, che lo
avevano trasformato in un uomo con un potere così grande che nessun altro aveva
mai avuto prima. Si aspettavano da lui un progetto, da attuare in tempi brevi,
che li facesse dormire con sogni tranquilli. Pressato dai vertici del governo
statunitense, Gelli ha improvvisato quel progetto di cui ancora si parla ma
sempre più a sproposito. Quando non si riesce a comprendere le ragioni che
guidano il mondo in cui si vive, si scambiano di sovente le lucciole per
lanterne: così Gelli appare come il Grande vecchio, che tutto vede e tutto
comanda. Se si avesse la volontà e la pazienza di entrare dentro questi eventi
per conoscerli nella loro realtà, si vedrebbe che essi poggiano sulla palude o
sul nulla».
A quanto le risulta c’è il
rischio concreto che si riproponga quella oscura stagione con la presenza,
ancora una volta di ambienti deviati della massoneria?
«Il
rischio c’è ed è grande, ma non solo per l’intervento della massoneria deviata
(da intendere però nel senso che ho già spiegato)».
C’è il rischio concreto che
la vita di pm e giudici, da Palermo a Caltanissetta, da Catania a Reggio
Calabria (solo per citare alcune procure che stanno lavorando sulla stagione
delle strage mafiose) sia legata alle decisioni prese da sistemi criminali nei
quali le cosche e i clan di mafia sono una quota parte e il resto è composto da
pezzi infedeli dello Stato e pezzi deviati della massoneria?
Il rischio che corrono i
difensori della legalità dello Stato è grande, non soltanto per le decisioni
prese da clan della mafia (il significato di questo termine esce sempre più dal
contesto storico e tradizionale per diventare uno “stile di vita”, che ispira i
balordi che stanno occupando i luoghi del potere delle nostre città), dalla
massoneria deviata (nel senso da me specificato), da rappresentanti infedeli
dello Stato. Ma anche per il manifestarsi di un fenomeno sociale nuovo, spesso
sottovalutato ma gravido di tremende conseguenze. Lo scenario “classico” della
criminalità è stato messo in crisi da una dilagante “anarchia” che si manifesta
in tutti i livelli della società italiana. Ne sono coinvolti non solo gli
operatori del denaro ma anche i rappresentanti della cultura. Se ci chiediamo
dove sta andando il nostro paese, la risposta non può che essere una e soltanto
una: verso l’anarchia. Le regole e le leggi che governano la società italiana
vengono sempre più disattese. Si sta scivolando, lentamente ma
inarrestabilmente, verso lo stato sociale di guerra di tutti contro tutti,
descritto dal filosofo Thomas Hobbes nel suo Leviatano. E’ proprio questa
dilagante anarchia che fa emergere e dà potere a un livello di criminalità
“anonima” che sta devastando la nostra società. Essa sfugge a qualsiasi
definizione poiché non ha né regole né un’organizzazione gerarchica del potere.
E’ come una nebbia che sale verso l’alto e offusca tutto. Se lo Stato non
interverrà per reprimere questa nascente anarchia, rischiamo di vivere in una
società senza quei valori che hanno consentito la nascita e lo sviluppo delle
civiltà millenarie. Paradossalmente, in quel tempo sempre più prossimo, le
organizzazioni criminali che oggi ci preoccupano (mafia, ‘ndrangheta, camorra,
massoneria deviata ecc.) potrebbero apparire come aspetti negativi di un sistema
sociale tutto sommato vivibile. E forse ne avremo nostalgia. Eppure non mancano,
nel nostro Paese, autorevoli personalità che preconizzano l’avvento del tiranno.
Se avessero letto Aristotele e analizzato il percorso storico dell’umanità,
avrebbero compreso che il tiranno (leviatano) interviene nella società quando lo
stato di anarchia è al massimo della sua potenza distruttiva, per riportare
l’ordine con tutti i mezzi possibili».
Quanto è alto il rischio di
inquinamento delle prove e di delegittimazione di quanti (pm, giudici,
associazioni, giornalisti) sono alla ricerca della verità senza guardare in
faccia nessuno?
«Coloro
che ricercano la verità, anche mettendo a rischio la propria vita, sono stati da
sempre considerati idealisti da non prendere in considerazione o persone
pericolose da tenere sotto controllo o da eliminare. Nel tempo in cui viviamo,
la seconda possibilità è quella più probabile. Se non vi fosse il loro impegno,
la nebbia dell’anarchia sarebbe ancora più impenetrabile. Il loro impegno,
tuttavia, dovrebbe essere sorretto dalle istituzioni statali per renderlo più
sicuro ed efficace».
Non sarà che quel “Patto
del Nazareno”, che secondo il mio ex direttore Ferruccio de Bortoli,
puzza di massoneria stantia, è un atto (mi dica eventualmente Lei quale) di una
lunga guerra tra obbedienze massoniche per assumere (o dividersi) quel (poco)
potere rimasto oggi in Italia?
«La
massoneria non ha nulla a che fare con il Patto del Nazareno, che è
semplicemente un accordo per far sopravvivere un sistema politico ormai in
decomposizione. Come italiano non posso che sperare nel successo di colui che
oggi guida il paese. Come conoscitore delle arcane cose, vedo le trappole in cui
cercheranno di farlo cadere».
Una domanda finale: ma se
la Massoneria è Fratellanza Universale, perché siete così divisi, parcellizzati
e, spesso e volentieri, l’un contro l’altro armati?
«La
massoneria non è più oggi una Fratellanza Universale. Lo è stata quando in
Inghilterra c’era solo la Gran Loggia Unita d’Inghilterra, in Francia solo Le
Grand Orient de France, in Italia solo Il Grande Oriente d’Italia. Oggi, in
tutti i Paesi ove esiste la massoneria, sono numerose le Obbedienze massoniche.
In Italia, si pensa che siano più di ottanta. Continuano a nascere come funghi
in un’estate piovosa. In Romania, nel 1993, ho fondato la Gran Loggia Nazionale
di Romania: dopo venti anni, le Obbedienze massoniche sono più di dieci, senza
contare un numero imprecisato di Riti e Ordini. Tutte queste massonerie si
combattono senza esclusione di colpi (legali e non). Al riguardo, è stata
coniata la frase, per intendere i massoni: “Fratelli coltelli”. Ribadisco e
continuo a ribadire: questa non è massoneria!!!»
La via femminile della
massoneria italiana.
Il tema è stato al centro di una conferenza organizzata per il 70° della Loggia
Savonarola, scrive Marcello Celeghini su “Estense”. Anche la massoneria italiana
scopre una sua ‘via’ femminile. Il rapporto tra il mondo massonico e quello
femminile è stato al centro, venerdì pomeriggio alla Sala della Musica in San
Paolo, di una conferenza dal titolo “Massoneria del Grande Oriente e Ordine
della Stella d’Oriente: storia, finalità e prospettive”, organizzata dalla
loggia ferrarese ‘Gerolamo Savonarola’ in occasione delle celebrazioni per il
70° anniversario dalla sua fondazione (1945-2015), a cui hanno partecipato in
qualità di relatori Elda Levi, Worthy Grand Matron dell’Ordine della Stella
d’Oriente, e Claudio Bonvecchio, docente all’Università dell’Insubria e Grande
Oratore del Grande Oriente d’Italia, moderati da Stefano Mandrioli venerabile
della Loggia Savonarola. Il tema per il mondo massonico è molto spinoso poiché,
secondo quanto stabilito dal padre della massoneria James Anderson nel
Settecento, le donne non possono entrare nelle varie comunità massoniche anche
se, negli anni, sono state diverse le associazioni massoniche femminili, più o
meno riconosciute, che si sono sviluppate. Tra queste, l’unica riconosciuta
dalla massoneria regolare, è l’Ordine della Stella d’Oriente che accoglie sia
uomini sia donne insieme che testimoniano nella vita un impegno di ricerca
iniziatica per un rinnovamento personale ed interiore. L’Ordine però, nato negli
Stati Uniti d’America nel 1876, consente l’ingresso solo ai maestri massoni e a
donne a loro legate da stretti vincoli di parentela. Le cinque punte della
stella simbolo dell’Ordine indicano i cinque ‘ruoli’ che la donna si trova ad
assumere nel corso della propria vita e che le permettono di fare parte della
massoneria (figlia, sorella, moglie, madre e vedova). Un dibattito, quello
sull’impossibilità per le donne di accedere al mondo massonico se non tramite
strette parentele maschili, che sta facendo discutere ormai da parecchi anni le
comunità massoniche europee. “Ogni giorno oltre cinquanta quotidiani italiani –
rivela il Grande Oratore Claudio Bonvecchio – ci riservano attenzione sia per
criticarci che per scoprirci. Per questo motivo non dobbiamo astrarci dalla
nostra epoca, ma ribadire con forza i nostri valori fondativi basati sulla
libertà, la tolleranza, l’uguaglianza e la fratellanza. Sull’apertura al mondo
femminile, la Massoneria non deve restare indietro in un tempo in cui anche la
più chiusa delle istituzioni, la Chiesa Cattolica, affronta questo tema. Il mio
parere personale è quello di creare fratellanze femminili in piena comunione con
le fratellanze maschili esistenti ma ben distinte da queste. La distinzione è
necessaria per una diversità di genere esistente a livello psicologico e nella
percezione della realtà”. “La mia esperienza all’interno dell’Ordine – racconta
Elda Levi – è iniziata trent’anni fa. Di solito il percorso iniziatico dura tre
anni. Una donna ha il compito, all’interno della fratellanza massonica, di
studiare e indagare l’emozionalità umana in tutte le sue sfaccettature. Mi
immagino il cielo notturno come un soffitto, ornato da qualche ragazzina
romantica con stelle fosforescenti, e una è di sicuro la sua preferita, quella a
cui rivolge lo sguardo sognante prima di addormentarsi”.
La via femminile alla
massoneria.
Sarà l’oggetto del prossimo incontro pubblico alla Sala della Musica con cui la
Loggia Savonarola di Ferrara sta celebrando il suo 70° Anniversario, continua la
redazione di “Estense”. Continuano gli appuntamenti pubblici con i quali la
Loggia “Girolamo Savonarola” di Ferrara si propone di celebrare il suo 70°
anniversario di fondazione (1945-2015). La loggia estense, una delle più antiche
d’Italia e di gran lunga la più longeva fra quelle tuttora in attività in
provincia di Ferrara, si propone con queste iniziative di sintonizzare la
propria ricorrenza con la Storia e l’Attualità della società in cui opera da
così tanto tempo. Così dopo aver toccato nella precedente conferenza (novembre
2014) il tema della guerra e della pace (“Massoneria e Prima Guerra Mondiale”),
per il prossimo incontro, previsto Sabato 24 Gennaio alla Sala della Musica di
Ferrara in via Boccaleone 19 alle ore 16.00, la Loggia Savonarola ha deciso di
affrontare pubblicamente il rapporto fra la stessa Massoneria e le Donne, e più
in particolare “Massoneria del Grande Oriente e Ordine della Stella d’Oriente:
storia, finalità e prospettive”. Da notare che quando la Loggia Savonarola venne
fondata (nel Settembre del 1945) le donna in Italia ancora non avevano diritto
di voto. A quei tempi ancora poche donne avevano la patente di guida, e solo
qualche decennio dopo ci sarebbe stata la prima donna sindaco (guarda caso a
Ferrara, Luisa Balboni dal 1950 al ‘58), le prime donne vigilesse (ancora a
Ferrara), la prima donna conduttrice di autobus (sempre a Ferrara), la prima
donna magistrato (ancora una volta una ferrarese), e così via, fino alle donne
soldato, alle donne astronauta, ed a tante altre donne in tutti gli altri
mestieri e professioni fino ad allora praticati solo da uomini… Il tempo dunque
ha prodotto grandi trasformazioni nel contesto della donna nella nostra società.
Ma non nella massoneria che continua ad escludere la donna dai propri templi,
con la sola eccezione delle “Stelle d’Oriente”, che anche a Ferrara sono
presenti da alcuni anni con un proprio Capitolo intestato alla divinità egizia
“Osiride”. L’argomento sarà introdotto dall’avvocato Giangiacomo Pezzano,
presidente del Collegio dei Maestri Venerabili dell’Emilia Romagna.
Interverranno: Elda Levi, Worthy Grand Matron del Gran Capitolo d’Italia, Ordine
della Stella d’Oriente; ed il filosofo Claudio Bonvecchio, docente
all’Università dell’Insubria e Grande Oratore del Grande Oriente d’Italia.
Modererà il dibattito il dottor Stefano Mandrioli, membro della Loggia
Savonarola (di cui è stato anche Maestro Venerabile) e Gran Rappresentante dello
stesso Grande Oriente. Come si sa le maggiori famiglie massoniche mondiali, fra
queste anche il Grande Oriente d’Italia, per tradizionale secolare, forse
millenaria, non ammettono le donne nelle proprie logge ed ai propri riti.
L’iniziazione femminile è da sempre esclusa. Per varie ragioni: la principale
motivazione per tale interdetto viene fatta risalire alle origini “di mestiere”
della massoneria, intesa come fratellanza di muratori, scultori, carpentieri,
ecc. (i costruttori di cattedrali) da cui appunto deriva la storica definizione
di “liberi muratori” con cui si appellano ancora oggi tutti i massoni. L’altra
più reiterata giustificazione consiste invece nella “Solarità” della ritualità
massonica, prettamente maschile, ritualità che nulla avrebbe a che vedere con
gli aspetti “Lunari” attribuiti alla sfera femminile dell’esistenza. Più
approfonditamente c’è chi rileva come i riti ed i miti della massoneria maschile
siano essenzialmente rivolti al concetto della Morte, ed alle modalità
spirituali per vincerne la paura e “conquistarla”, la Morte, anziché farsene
sopraffare. In tutto questo non affiorerebbe però alcun aspetto fondante
riguardante principi e archetipi tipici della femminilità, quali la Fecondazione
e la Fertilità, in altre parole il rovescio della Morte: la Vita. Questa,
beninteso, è solo una delle tante controverse tesi su cui la Massoneria dibatte
da secoli, su se stessa, sul ruolo della donna nei confronti della Tradizione
Iniziatica, e più in generale nella società. Una questione per molti versi
speculare a quella del Sacerdozio Femminile in campo Cattolico. Nonostante il
perdurare di questa posizione di esclusione della donna da parte della
Massoneria ufficiale (ma non di tutta la Massoneria: nel mondo infatti vi sono
famiglie massoniche che accettano senza problemi le donne al proprio interno,
come ad esempio la Massoneria italiana di Piazza del Gesù, ma che per questo non
vengono più riconosciute dalla Loggia Madre d’Inghilterra e non possono più
essere definite “massoneria regolare”), nonostante questo, dicevamo, qualche
breccia si è aperta da tempo anche per l’iniziazione femminile. La più
importante, e l’unica attualmente riconosciuta dai Grandi Orienti “regolari”, è
quella delle “Stelle d’Oriente”, ordine iniziatico affine alla massoneria di cui
fanno parte “fratelli” e “sorelle”, queste ultime legate da vincoli di parentela
a massoni regolari. In pratica possono far parte delle Stelle d’Oriente solo
mogli, figlie, sorelle ed altre parenti di massoni maschi. Un vincolo che
qualcuno vorrebbe allargare. L’Ordine delle Stelle d’Oriente è nato il secolo
scorso negli Stati Uniti, principalmente ad opera di Robert Morris, Gran Maestro
della Loggia del Kentucky, raccogliendo il ricordo e la tradizione delle
cosiddette “Logge d’Adozione” nate secoli prima in Europa e nella stessa America
al seguito di logge militari francesi che consentivano alle consorti degli
ufficiali e ad altre donne d’elezione del luogo di riunirsi in forma rituale
sotto la direzione di un Maestro Massone. A introdurre le Stelle d’Oriente in
Italia nell’ultimo dopoguerra è stato un altro esercito, non più quello
francese, bensì quello quello americano. I primi nuclei di “Stelle” italiane si
formarono infatti in località vicine a grandi basi militari statunitensi. Il
resto è storia che ha portato questo movimento con un intenso cammino fino al
presente. Un presente che ha visto recentemente la nascita del Gran Capitolo
d’Italia, più autonomo e indipendente. Di tutto questo parlerà ovviamente, nel
prossimo incontro di Ferrara, la Whorty Grand Matron, massima autorità, delle
Stelle d’Oriente Italiane, Elda Levi. Accanto all’importante storia delle Stelle
d’Oriente, in Italia, c’è da dire, esistono, già da prima della Rivoluzione
Francese, diversi altri esempi di approccio femminile alla Massoneria: ci fu
infatti l’esperienza delle “Giardiniere” (corrispettivo femminile dei Carbonari
risorgimentali), seguite dalla società delle “Mopse” creata dalla Contessa
Caracciolo sul finire dell’800, per giungere infine ad una vera e propria Gran
Loggia Femminile d’Italia, retta a lungo da Marisa e Franca Bettoja, madre e
figlia, rispettivamente suocera e moglie di Ugo Tognazzi. Prima dell’attuale
Capitolo Osiride delle Stelle d’Oriente, si ha inoltre notizia, a Ferrara,
dell’esistenza di una Loggia Femminile intitolata ad “Anita Garibaldi” negli
anni immediatamente successivi all’Unità Nazionale, e di un tentativo (generoso,
ma infruttuoso) di creare un nucleo locale di Stelle d’Oriente già fra la fine
degli Anni Cinquanta ed i primi Anni Sessanta, ad opera di membri della stessa
Loggia Savonarola, che oggi dedica ancora una volta alle proprie “Sorelle”
un’importante momento del suo 70ennale. E lo fa con pubblicamente, con la
massima trasparenza ed onestà intellettuale.
IL FENOMENO FEMEN.
Femen a Roma, atti osceni in piazza San
Pietro: scandalo delle Femen, scrive “Contro Campus”.
Non passano mai inosservate: sono il movimento delle Femen che continuano a
far sentire la propria voce e non solo. E’ infatti difficile non venire la
corrente dei gesti compiuti da questo movimento. Come è già spesso accaduto,
anche stavolta la battaglia in questione è contro la Chiesa, in particolare
contro la figura del Papa. Già il 19 dicembre 2013 scorso una Femen aveva
provato a recarsi al Vaticano mostrandosi a seno nudo e con una sola parola
dipinta in rosso sul proprio corpo: abortion. In quel caso, la protesta non andò
totalmente a buon fine in quanto venne fermata dalla polizia ancor prima di
riuscire a recarsi in piazza. Tuttavia, riuscì comunque a creare una certa
agitazione e a far sì che i media parlassero dell’avvenimento. Il 14 novembre
2014, presso la basilica di San Pietro, il movimento delle Femen torna a
manifestare al fine di ribadire il loro pensiero, ove mai non fosse risultato
ancora abbastanza chiaro. Per esprimere la loro volontà di vivere in uno Stato
realmente laico – dove gli abitanti siano realmente tutti uguali tra loro e dove
non vi siano gerarchie o uguaglianze imposte dalla Chiesa. Tre Femen hanno
deciso di recarsi in piazza San Pietro, denudarsi e mostrare innanzitutto le
scritte nere dipinte sui propri corpi. Davanti, era possibile leggere la scritta
Pope is not a politician – il Papa non è un politico – mentre sulla
schiena Keep it inside: tienilo dentro, anteprima del gesto compiuto
successivamente che ha generato ulteriore senso di indignazione e lo scandalo
vero e proprio. Infatti a quel punto le Femen hanno iniziato a mimare
autoerotismo e rapporti sessuali servendosi dei suddetti crocifissi. Immediato è
stato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno provveduto a portare le tre
Femen in commissariato di Borgo di Roma. Ancora una volta l’opinione pubblica è
divisa tra chi sostiene il pensiero delle Femen, chi contrario a priori e chi,
pur condividendo le loro idee creda che siano stati superati certi limiti.
Il fenomeno Femen: non sarebbero
militanti, ma ragazze pagate per fare spettacolo,
scrive Renato Berio su “Il Secolo D’Italia”. Quanto vale il logo FF, il Fenomeno
Femen, lo spettacolo delle attiviste dei blitz a seno nudo contro leader
religiosi e capi di Stato (ultime performance italiane contro Ratzinger e contro
Berlusconi)? Mediaticamente il successo è assicurato ma siamo davvero dinanzi ad
un movimento che ha a cuore la condizione delle donne? Secondo il Venerdì
di Repubblica le “sextremiste” di Femen sono davvero l’ultima provocante
faccia del femminismo 2.0. In Italia non hanno ancora molto seguito, anzi sono
tenute a distanza dalle veterane del femminismo che, del resto, non potevano
prima applaudire la crociata di Lorella Zanardo contro i nudi in tv e poi
benedire il topless delle Femen. Il Foglio ci informa che Femen è
diventato “il club femminista più influente d’Europa, almeno sul piano
dell’immagine. La loro società ha una pagina Facebook con migliaia di contatti,
un account su twitter, un sito internet in tre lingue diverse: lì si trovano
filmati, interviste, magliette (25 euro), colori per il corpo (un kit 70 euro),
felpe, tazze e cappelli (dai 20 ai 60 euro)”. Un marchio, dunque, più che
un’ideologia. Che dietro l’organizzazione girino soldi a palate, del resto, lo
si sapeva. La notizia era rimbalzata anche in Italia tramite i social network
italiani dopo che una giornalista ucraina si era infiltrata nel movimento e
aveva rivelato che le attiviste di Femen sono pagate mille euro al giorno e che
quando vanno in “missione” non si fanno mancare nulla. Chi paga? La giornalista
ipotizza rapporti con due imprenditori tedeschi, Helmut Geier e Beate Schober e
con un uomo d’affari americano, Jed Sunden. Secondo il quotidiano francese
Le Matin a tirare i fili delle attiviste di Femen ci sarebbe ancora un uomo,
Viktor Sviatski, un creativo trentenne che usa le nuove suffragette a seno nudo
per diffondere e rendere più solido il marchio Femen, magari per farne un
partito, o meglio per fare pressione sulla politica e sugli organi di
informazione. La leader ucraina del movimento, Anna Hutsol, che vive ormai tra
Kiev e Parigi dove le Femen sono trattate come star, è un’esperta dei meccanismi
mediatici che amplificano un messaggio veicolato con parole-choc. Già, ma per
conto di chi viene imbastita la messinscena?
Femen, giornalista infiltrata:
"Finanziatori dietro al movimento, ricevono 1.000 dollari al mese a testa",
scrive “Libero Quotidiano”. Una giornalista di un canale televisivo ucraino è
riuscita ad infiltrarsi nel movimento femminista Femen, e ha fatto delle
scoperte che, se confermate, getterebbero nello scandalo il gruppo
rivoluzionario del gentil sesso. Le scoperte vengono riportate dal sito La
voce della Russia. Per settimane la giornalista ucraina è stata addestrata
su come avere un comportamento aggressivo e attrarre l'attenzione dei
giornalisti. L'inviata sotto copertura è poi entrata a far parte
dell'organizzazione nei panni di una convinta sostenitrice delle idee Femen,
partecipando personalmente alle azioni di protesta in topless, registrando tutto
con una telecamera nascosta.
L'inchiesta -
Il debutto in topless della giornalista è avvenuto a Parigi dove Femen ha
recentemente aperto un nuovo ufficio di rappresentanza. Alcune attiviste hanno
organizzato una manifestazione nel loro stile mostrando il seno davanti al
centro culturale islamico parigino. La giornalista era terrorizzata, respirava
l’odio della gente che sentiva derisa la propria fede: "L'azione dimostrativa si
sta svolgendo presso un centro culturale islamico e riteniamo che la folla sia
pronta ad assalirci, ci salvano solo le telecamere dei giornalisti".
Attiviste finanziate
- Durante il periodo sotto copertura, la giornalista ha scoperto che dietro gli
ideali di emancipazione femminile, in realtà, ci sono finanziatori dell’Europa e
degli Stati Uniti, che pagherebbero le ragazze almeno con 1000 dollari al mese,
quasi tre volte il salario medio ucraino. La ragazza, per il viaggio, non ha
dovuto sborsare un euro: il viaggio a Parigi è stato, infatti, interamente
pagato dallo stesso movimento Femen. I biglietti d’aereo, le camere d'albergo,
il taxi e i pasti erano stati quantificati in 1.000 euro al giorno; a parte, ma
sempre rimborsate, anche le spese per gli estetisti e la cosmetica.
Chi è lo sponsor?
- Chi finanzia questo movimento e quale sia lo sponsor che pubblicizzano le
ragazze mostrando il loro seno, rimane avvolto nel mistero. Ma la giornalista
ucraina suggerisce che alcune note persone si sono incontrate con le leader del
movimento. Si tratta del miliardario tedesco Helmut Geier, l’imprenditrice
tedesca Beate Schober e l’uomo d'affari americano Jed Sunden. L’ultimo sponsor
delle Femen, ipotizza la giornalista, forse è Wikipedia.
UN APPROFONDIMENTO, ANCHE LETTERARIO, SULLA
MASSONERIA.
Massoneria, il libro shock di Gioele
Magaldi: "Società a responsabilità illimitata", scrive
“Libero Quotidiano”. Sarà presentato domani a Roma il libro, anticipato ieri dal
sito affaritaliani.it, "Massoni società a responsabilità illimitata" a
cura di Gioele Magaldi. L'opera, che ha tutte le carte in regola per figurare
come il manoscritto più sconcertante, inaspettato e comunque disorientate
dell'anno, esce con il seguente sottotitolo: "La scoperta delle Ur-Lodges", come
recita il font bianco su copertina violacea edita da Chiarelettere Editore. Ma
cosa sono le Ur-lodges? "Superlogge sovranazionali che vantano l'affiliazione di
presidenti, banchieri, industriali" in cui "nessuno sfugge a questi cenacoli"
a dirla con Il Fatto quotidiano di oggi che, proprio sul cartaceo di
questa mattina, mercoledì 19 novembre, analizza l'opera di Magaldi, presentato
dal quotidiano di Antonio Padellaro come "libero muratore di matrice
progressista". "Italiani bambinoni deficienti" - Ad essere particolarmente
interessante è proprio il capitolo finale del libro in cui è presente un
colloquio tra Magaldi e altri confratelli collaboratori con quattro supermassoni
di queste fantomatiche "Ur-Lodges". Uno di loro, racconta: "Per far inghiottire
simili riforme idiote e antipopolari alla cittadinanza, la devi spaventare come
si fa con i bambini. Altrimenti gli italiani, se non fossero stati dei bambinoni
deficienti, non avrebbero accolto con le fanfare i tre commissari dissimulati
che abbiamo inviato loro in successione: il fratello Mario Monti, il
parafratello Enrico Letta, l’aspirante fratello Matteo Renzi".
La lista -
Mario Draghi, governatore della Bce, sarebbe, a sentire quel che dice
Magaldi "affiliato a ben cinque superlogge." Poi nella parte finale del
manoscritto, l'autore snocciola, l'elenco degli italiani inseriti nelle
Ur-Lodges, in cui, oltre al già citato Mario Draghi, figurerebbero "Giorgio
Napolitano, Mario Monti, Fabrizio Saccomanni, Pier Carlo Padoan, Massimo
D’Alema, Gianfelice Rocca, Domenico Siniscalco, Giuseppe Recchi, Marta Dassù,
Corrado Passera, Ignazio Visco, Enrico Tommaso Cucchiani, Alfredo Ambrosetti,
Carlo Secchi, Emma Marcegaglia, Matteo Arpe, Vittorio Grilli, Giampaolo Di
Paola, Federica Guidi. Berlusconi, invece, avrebbe creato una Ur-Lodge
personale, la Loggia del Drago".
"Massoni ambivalenti su Renzi. Il vero
potere? Napolitano-Draghi" è la presentazione del
libro su “Affari Italiani”.
Gioele Magaldi
(14 luglio 1971), storico, politologo e filosofo, ex Maestro Venerabile della
loggia "Monte Sion di Roma" (Goi), già membro della Ur-Lodge "Thomas Paine", è
Gran Maestro del movimento massonico "Grande Oriente Democratico" (God). Fautore
di un impegno solare e progressista della massoneria, ha dato vita anche
a"Democrazia Radical Popolare" (Drp) e al Movimento Roosevelt (Mr). Tra le sue
pubblicazioni: UT PHILOSOPHIA POESIS (Pericle Tangerine) e ALCHIMIA. UN PROBLEMA
STORIOGRAFICO ED ERMENEUTICO (Mimesis). Laura Maragnani, giornalista
("Europeo","Panorama"), ha scritto LE RAGAllE DI BENIN CITY (Melampo), ECCE OMO
(Rizzoli), I RAGAZZI DEL '76 (Utet).
ANTEPRIMA/
Merkel, Putin, Obama,Xi Jimping, Lagarde, Padoan, Gandhi, Reagan, Mandela, Jfk,
Papa Giovanni, Agnelli, Clinton e Blair. Gioele Magaldi, Gran Maestro del Grande
Oriente Democratico rivela le liste delle segretissime Ur-Lodges massoniche.
Sconvolgente la teoria sull'Isis: "Il leader Al-Baghdadi liberato dagli Usa dopo
essere diventato massone. La jihad è eterodiretta per portare un nuovo Bush alla
Casa Bianca e a infinite guerre. E sull'11/9..."
LE TEORIE SU RENZI/ Magaldi: "Il premier vuole entrare nella superloggia
conservatrice Three Eyes, la stessa dei veri potenti Napolitano e Draghi. Ma i
massoni verso di lui sono ambivalenti e non si fidano della sua ambizione.
L'editoriale di De Bortoli? Scritto su richiesta di Draghi..."
Da D'Alema a Passera, da Arpe a Marcegaglia, ecco l'elenco degli italiani
nelle Ur-Lodges.....Esce con Chiarelettere il libro "Massoni" di Gioele
Magaldi (Grande Oriente Democratico). Un libro che sicuramente farà discutere.
Sedetevi e fate un bel respiro: nel libro trovate storia, nomi e obiettivi dei
massoni al potere in Italia e nel mondo, raccontati da autorevolissimi insider
del network massonico internazionale, che per la prima volta aprono gli archivi
riservati delle proprie superlogge (Ur-Lodges). Le liste che leggerete sono
sconvolgenti. Una battaglia per la democrazia. Tra le Ur-Lodges
neoaristocratiche, che vogliono restaurare il potere degli oligarchi, e quelle
progressiste, fedeli al motto "Liberté Égalité Fraternité", è in corso una
guerra feroce. L'ultimo atto è già iniziato, come rivela Magaldi con la rottura
della pax massonica stilata nel 1981: il patto "United freemasons for
globalization". Una rilettura esplosiva del Novecento nei suoi momenti più
drammatici - la guerra fredda, gli omicidi dei fratelli Kennedy e di M. L. King,
gli attentati a Reagan e a Wojtyla - arrivando fino al massacro dell'11
settembre 2001 e all'avanzata dell'Isis. "Massoni. Società a responsabilità
illimitata. La scoperta delle Ur-Lodges" è il primo volume di una trilogia che
offre un'inedita radiografia del potere.
LE LISTE - Le
liste di presunti massoni fatte da Magaldi nel libro è assolutamente
sconvolgente. Si parte dal massone ante litteram Giordano Bruno per arrivare a
Napolitano, Draghi, Berlusconi, Hollande, Merkel, Putin, Gandhi, Papa Giovanni
XXIII, Mozart, Mazzini, Garibaldi, Obama, Chaplin, Lagarde, Blair, Padoan,
Roosevelt e tantissimi altri. Già, perché, afferma Magaldi, "se non sei massone
non hai alcuna chance di arrivare al vero potere". Tra i nomi fatti da Magaldi
c'è anche Silvio Berlusconi, descritto come "un attento cultore di astrologia,
uno studioso di esoterismo egizio, un frequentatore del milieu massonico
internazionale con strette relazioni negli ambienti latomistici angloamericani
più conservatori". Secondo Magaldi il pallino in mano, per quanto riguarda
l'Italia, ce l'hanno in mano Napolitano e Draghi, che per Magaldi sarebbero
massoni, apprezzati e influenti anche a livello internazionale. Discorso diverso
per Renzi. Magaldi descrive Renzi come "un aspirante massone elitario" al quale
"ancor non è stato accordato l'accesso a una almeno delle superlogge
sovranazionali". L'obiettivo di Renzi, secondo Magaldi, sarebbe quello di
entrare "non presso il Grande Oriente d'Italia o presso qualche altra comunione
massonica ordinaria, su base nazionale italiana o estera. No, il premier
italiano punta molto più in alto. Egli vorrebbe essere iniziato presso la
Ur-Lodge Three Eyes, la medesima superloggia cui sin dal 1978 fu affiliato
Giorgio Napolitano. La stessa superloggia cui è affiliato Mario Draghi". (---)
"Il problema è che la sua domanda di affiliazione non è stata ancora accolta
perché i vari Dragji, Napolitano, Merkel, Weidmann, Schauble, Trichet, Rutte,
Sutherland, eccetera non si fidano di Renzi waanabe massone. Considerano Renzi
un narcisista, uno spregiudicato e indisciplinato arrivista. Figuriamoci quanto
poco venga apprezzato da questi ambienti l'asse Berlusconi-Renzi, siglato dal
Patto del Nazareno. Perciò l'atteggiamento dell'establishment massonico
neoaristocratico verso l'attuale premier e segretario Pd è ambivalente. Da un
lato ne apprezzano le politiche sostanzialmente prone al paradigma
dell'austerità, dall'altro ne temono l'indisciplina e i potenziali voltafaccia",
considerandolo smodatamente ambizioso e capace di, persino, se gli convenisse,
di passare un giorno armi e bagagli con il network massonico progressista". In
quest'ottica, secondo Magaldi, va letto il celebre editoriale del direttore del
Corriere della Sera De Bortoli su Renzi e i poteri massonici, scritto proprio in
concomitanza della visita newyorkese di Renzi. Secondo Magaldi l'editoriale
aveva il significato di dire al premier: "Caro Renzi, riallineati ai desiderata
del Venerabilissimo Maestro Mario Draghi, altrimenti comincio a sputtanarti sul
versante massoneria, sia con riferimento ai tuoi inciuci con Berlusconi, sia, se
servirà sparando più in alto".
LE UR-LODGES -
Magaldi dedica il suo libro alle cosiddette superlogge, definite "i cenacoli
massonici protagonisti della storia contemporanea, gruppi e soggetti a
orientamento e vocazione strutturalmente sovranazionale e cosmopolita che hanno
abbondantemente surclassato l'influenza ormai modesta della massoneria
ordinaria". Insomma, coloro che avrebbero in mano il potere vero e il destino
del mondo. Magaldi elenca le diverse superlogge, dalla Edmond Burke alla Joseph
de Maistre alla White Eagle alla Thomas Paine. E Magaldi sostiene che presso
queste Ur-Lodges siano in atto "progetti di involuzione oligarchica,
tecnocratica e antidemocratica", progetti che riguarderebbero "l'Italia,
l'Europa e l'Occidente intero". Tra gli italiani nelle Ur-Lodges, ecco i nomi
citati da Magaldi: mario Draghi, Giorgio Napolitano, Mario Monti, Fabrizio
Saccomanni, Pier Carlo Padoan, Massimo d'Alema, Gianfelice Rocca, Domenico
Siniscalco, Giuseppe Recchi, Marta Dassù, Corrado Passer,a Ignazio Visco, Enrico
Tommaso Cucchiani, Alfredo Ambrosetti, Carlo Secchi, Emma Marcegaglia, Matteo
Arpe, Vittorio GRilli, Giampaolo Di Paola, Federica Guidi. Berlusconi invece
avrebbe creato una Ur-Lodge personale, la Loggia del Drago. Nessun paletto nella
massoneria, né geografico né ideologico. Solo potere. Così Magaldi spiega come
"l'ascesa di Mussolini o Hitler è avvenuta anche grazie allo spregiudicato
sostegno e finanziamento del milieu massonico conservatore angloamericano". Allo
stesso modo i conservatori facevano tranquillamente affari con i fratelli
massoni sovietici. "Pezzi grossi come il segretario generale del Pcus Leonid
Breznev e i suoi successori Andropov e Gorbacev, così come Eltsin, hanno chiesto
e tranquillamente ottenuto l'affiliazione presso alcune Ur-Lodges". Secondo
Magaldi c'è anche un'ala più democratica e progressista all'interno della
massoneria. E il grande esperimento democratico, persino rivoluzionario, fu
fatto all'inizio degli anni '60, con l'elezione del primo Papa, secondo Magaldi,
massone e di Kennedy. Un progetto finito troppo presto. Un altro massone
rivoluzionario sarebbe stato Luther King, anche lui ucciso pochi anni dopo. Da
qui inizia quella che Magaldi definisce una "restaurazione neoaristocratica".
Una restaurazione guidata dalla superloggia Three Eyes, "una creatura del
ricchissimo industriale David Rockefeller, del futuro segretario di Stato Henry
Kissinger e del futuro consigliere per la Sicurezza nazionale Zbigniew
Brzezinski che nel 1978 sarà il principale artefice dell'elezione a pontefice
del polacco Wojtyla". Molti anche gli affiliati italiani, secondo Magaldi, su
tutti Gianni Agnelli ma anche Enrico Cuccia e il principe Borghese. E, secondo
Magaldi, persino Napolitano... Eventi come l'attentato a Reagan e a Wojtyla
rientrano, secondo Magaldi, in lotte di potere tra diverse superlogge. Secondo
Magaldi sono sempre le superlogge, nel 1981 a dare il via alla globalizzazione
con un progetto segretissimo e sovranazionale. Che conterrebbe questi punti
salienti: "Sostegno al fratello Deng Xiaoping e alla sua politica di apertura
della Cina al libero mercato, destrutturazione e liquidazione dell'Urss e del
Patto di Varsavia grazie all'ascesa del fratello Gorbacev e alla rottamazikone
dei vecchi titani del Pcus come il segretario generale Breznev e i suoi più
stretti seguaci e successori. Accelerazione del progresso di integrazione
economica e politica dell'Europa. Riunificazione tedesca, riconferma della
sorella Margaret Thatcher e sabotaggio del Labour Party del Regno Unito, ritorno
dell'Argentina alla democrazia, smantellamento progressivo dell'apartheid ein
Sudafrica e scarcerazione del fratello Nelson Mandela. Alternanza ovunque, a
cominciare dagli Usa, di governi conservatori e progressisti secondo una tabelle
di marcia ben precisa. Ovviamente a un patto: che tutti abbiano il rigoroso
gradimenti dei grembiulini che contano. Secondo Magaldi c'è una ulteriore
superloggia, quella creata da Bush Sr. e altri compagni delle altre superlogge
che si sono sentiti esclusi dal progetto United Freemasons e dalla rielezione di
Clinton. "La chiamano Hathor Pentalpha", sostiene Magaldi, che la definisce una
"loggia della vendetta e della sete di sangue", della quale avrebbe fatto parte
persino Osama Bin Laden. Una superloggia che estenderebbe la sua inquietante
ombra sugli eventi degli ultimi anni, a partire dall'11 settembre 2001. La
risposta progressista è la nuova superloggia "Maat", della quale secondo Magaldi
farebbe parte Obama. Ma ora il disegno delle superlogge è quello di far tornare
al potere l'ala più conservatrice e guerrafondaia, secondo Magaldi. E per farlo
si starebbe servendo della guerra santa dell'Isis. Magaldi sostiene che colui
che proclamato il Califfato islamico farebbe parte della Hathor Pentalpha, vale
a dire Al-Baghdadi, "imprigionato in Iraq nel 2004 come terrorista pericoloso e
che subito dopo l'affiliazione a fil di spada viene liberato". Il tutto mentre
viene "ufficiosamente lanciata la candidatura del fratello Jeb Bush alla Casa
Bianca". "Da qui al 2016", sostiene Magaldi, grazie all'avanzata dell'Isis,
prenderà il via una formidabile campagna planetaria per portare un un nuovo
Buish a Washington. L'ennesimo Bush guerrafondaio. Avremo così nuove guerre
infinite in Medio Oriente". E ora, scrive Magaldi, resta da capire come pensano
di controbattere a questa minaccia i fratelli massoni progressisti...
LEGGI IN ANTEPRIMA LE DEDICHE DI GIOELE
MAGALDI CON LE LISTE DEI NOMI (per gentile concessione di Chiarelettere).
L'intera trilogia di Massoni. Società a responsabilità illimitata, di cui questo
testo rappresenta il primo volume, è dedicata principalmente a Olympe de Gouges
(1748-1793) ed Eleanor Roosevelt (1884-1962), le più grandi e coraggiose fra le
sorelle muratrici che abbiano mai cinto il grembiuli no lato-mistico e operato
con efficacia imperitura al bene e al progresso dell'umanità. Ma come non
menzionare, fra le tantissime altre donne «libere e di buoni costumi»' che
ispirarono le loro vite ai più nobili e alti principi massonici (pur
nell'inevitabile presenza di alcune ombre, frammiste a maggioritarie luci),
anche libere muratrici dello spessore di: Mary Wollstonecraft (1759-1797),
Sophie de Condorcet (1764-1822), Harriet Taylor Mill (1807-1858), Cristina
Trivulzio di Belgiojoso (1808-1871), Marie Adélalde Deraismes (1828-1894), Jesse
White Mario (1832-1906), Lucretia Coffin Mott (1793-1880), Mathilde Franziska
Anneke (1817-1884), Malwida von Meysenbug (1816-1903), Susan Brownell Anthony
(1820-1906), Julia Ward Howe (1819-1910), Elizabeth Cady Stanton (1815-1902),
Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), Annie Besant (1847-1933), Emmeline
Pankhurst (1858-1928), Marie Curie (1867-1934), Martha Beatrice Webb
(1858-1943), Virginia Woolf (1882-1941), Maria Montessori (1870-1952), Golda
Meir (1898-1978), Alva Myrdal (1902-1986), Indira Gandhi (1917- 1984) . Una
peculiare intestazione dedicatoria va rivolta al massone ante litteram e
protomartire della moderna libera muratoria, Giordano Bruno (1548-1600).
Peraltro, una dedica sentita deve per forza di cose andare ai seguenti fratelli
liberi muratori (anch'essi latori di moltissime luci, in mezzo ad assai più
trascurabili opacità): John Locke (1632-1704), Isaac Newton (1642-1727), Jean
«John» Theo¬philus Desaguliers (1683-1744), Montesquieu (1689-1755), Voltaire
(1694-1778), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Giacomo Casa¬nova (1725-1798),
Cagliostro (1743-1795), Cesare Beccaria (1738-1794), Benjamin Franklin
(1706-1790), George Washington (1732-1799), Thomas Jefferson (1743-1826), Thomas
Paine (1737-1809), Nicolas de Condorcet (1743-1794), Honoré Gabriel Riqueti de
Mirabeau (1749-1791), Philippe Egalité (1747-1793), Jacques Brissot (1754-1793),
Camille Desmoulins (1760-1794), Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829), Gilbert du
Motier de La Fayette (1757-1834), Jacques Laffitte (1767-1844), Francisco de
Miranda (1750-1816), Napoleone Bonaparte (1769-1821), nella sua fase
filorepubblicana, Rafael del Riego (1784-1823), George Gordon Byron (1788-1824),
Alessandro Ypsilanti (1792-1828), José de San Martin (1778-1850), Simón Bolívar
(1783-1830), Aleksandr Sergeevic Puskin (1799-1837), Samuel Gridley Howe
(1801-1876), William Lloyd Garrison (1805-1879), Ralph Waldo Emerson
(1803-1882), Thaddeus Stevens (1792-1868), Charles Sumner (1811-1874), Benjamin
Wade (1800-1878), William Cullen Bryant (1794-1878), Carl Schurz (1829-1906),
Aleksandr Ivanovic Herzen (1812-1870), Giuseppe Mazzini (1805-1872), John Stuart
Mill (1806-1873), Giuseppe Garibaldi (1807-1882), Jules Michelet (1798¬1874), il
Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) della maturità, che, pur non abdicando alle
migliori istanze del socialismo, comprese l'importanza del libero mercato, della
proprietà privata e della società civile come altrettanti freni libertari e
pluralisti alla potenziale invadenza autoritaria del potere statuale, Louis
Blanc (1811-1882), Victor Hugo (1802-1885), Lajos Kossuth (1802-1894), Charles
Darwin (1809-1882), José Martí (1853-1895), Lev Nicolàevic Tolstòj (1828-1910),
Giosuè Carducci (1835-1907), Max Weber (1864-1920), John Dewey (1859-1952),
Leonard Hobhouse (1864-1929), Sigmund Freud (1856-1939), Theodore Roosevelt
(1858-1919), Thomas Woodrow Wilson (1856-1924), Eduard Bernstein (1850-1932),
George Bernard Shaw (1856-1950), Mustafa Kemal Ataturk (1881-1938), Gerard Swope
(1872-1957), John Maynard Keynes (1883-1946), Franklin Delano Roosevelt
(1882-1945), Mohandas Karamchand Gandhi detto «il Mahatma» (1869-1948),
Aleksandr Fédorovic Kerenskij (1881-1970), George Orwell (1903-1950), Carl
Gustav Jung (1875-1961), Albert Einstein (1879-1955), George Marshall
(1880-1959), Clement Attlee (1883-1967), Harry Truman (1884-1972), William
Beveridge (1879-1963), Charlie Chaplin (1889-1977), Angelo Giuseppe Roncalli
divenuto Giovanni XXIII (1881-1963), Antonio de Curtis detto Totò (1898-1967),
Martin Luther King (1929-1968), Meuccio Ruini (1877-1970), Federico Caffé
(1914-1987), Karl Popper (1902-1994), Altiero Spinelli (1907-1986), Gunnar
Myrdal (1898-1987), Paul Feyerabend (1924-1994), Harold Wilson (1916-1995),
Thomas Kuhn (1922-1996), Robert William Komer (1922-2000), John Rawls
(1921-2002), John Kenneth Galbraith (1908-2006), James Hillman (1926-2011),
Arthur Schlesinger Jr. (1917-2007), senza dimenticare molti altri, di analoga
sensibilità progressista — contestualmente al tempo in cui vissero —, che pure
saranno menzionati nel corso della trilogia di Massoni. Una dedica speciale e a
parte, al di là di tutte le incomprensioni, le delusioni e i litigi, al di là
del tempo e dello spazio, va a Giuseppe «Pino» Abramo (1933-2014). Inoltre, una
dedica importante va anche a Ivan Mosca (1915-2005), Franco Cuomo (1938-2007),
Ted Kennedy (1932-2009), Antonio Giolitti (1915- 2010), Michele Raffi
(1968-2013), Rosario «Rino» Morbegno (1930-2013), Carlo Maria Martini
(1927-2012), Ernest Borgnine (1917-2012), Rita Levi Montalcini (1909-2012), Hugo
Chavez (1954-2013), Nelson Mandela (1918-2013), Arnoldo Foà (1916-2014), Gabriel
Garda Marquez (192-¬2014), Italo Libri, Enrico Simoni e a tutti quei massoni di
ogni latitudine geografica passati di recente all'Oriente Eterno, i quali, con
il loro pensiero e le loro azioni, hanno incarnato pregi e difetti, grandezze e
miserie, fragilità e punti di forza della via iniziatica libero-muratoria.
Massoneria, libro shock del gran maestro
Magaldi: “Ecco i potenti nelle logge”, scrivono Gianni
Barbacetto e Fabrizio D'Esposito su Il Fatto Quotidiano. Centinaia di nomi, tra
cui Napolitano, Obama, Draghi, Bin Laden e Papa Giovanni XXIII. Tutti "fratelli"
secondo l'autore del volume presentato domani a Roma. Che però dice: "Le prove
le esibiscono soltanto se me le chiede il giudice". Esistono i massoni e i
supermassoni, le logge e le superlogge. Gioele Magaldi, quarantenne libero
muratore di matrice progressista, ha consegnato all’editore Chiarelettere (che
figura tra gli azionisti di questo giornale) un manoscritto sconcertante e che
sarà presentato domani sera alle 21 a Roma, a Fandango Incontro. Il libro,
anticipato ieri dal sito affaritaliani.it, è intitolato Massoni
società a responsabilità illimitata, ma è nel sottotitolo la chiave di
tutto: La scoperta delle Ur-Lodges. Magaldi, che anni fa ha fondato in
Italia il Grande Oriente Democratico, in polemica con il Grande Oriente
d’Italia, la più grande obbedienza massonica del nostro Paese, in 656 pagine
apre ai profani un mondo segreto e invisibile: tutto quello che accade di
importante e decisivo nel potere è da ricondurre a una cupola di superlogge
sovranazionali, le Ur-Lodges, appunto, che vantano l’affiliazione di presidenti,
banchieri, industriali. Non sfugge nessuno a questi cenacoli. Le Ur-Lodges
citate sono 36 e si dividono tra progressiste e conservatrici e da loro
dipendono le associazioni paramassoniche tipo la Trilateral Commission o il
Bilderberg Group. Altra cosa infine sono le varie gran logge nazionali, ma
queste nel racconto del libro occupano un ruolo marginalissimo. Tranne in un
caso, quello della P2 del Venerabile Licio Gelli. I documenti che mancano sono a
Londra, Parigi e New York. Prima però di addentrarci nelle rivelazioni clamorose
di Massoni è d’obbligo precisare, come fa Laura Maragnani, giornalista di
Panorama che ha collaborato con Magaldi e ha scritto una lunga prefazione,
che l’autore non inserisce alcuna prova o documento a sostegno del suo libro,
frutto di un lavoro durato quattro anni, nei quali ha consultato gli archivi di
varie Ur-Lodges. Tuttavia, come scrive l’editore nella nota iniziale, in caso di
“contestazioni” Magaldi si impegna a rendere pubblici gli atti segreti
depositati in studi legali a Londra, Parigi e New York. Detto questo, andiamo al
dunque non senza aver specificato che tra le superlogge progressiste la più
antica e prestigiosa è la Thomas Paine (cui è stato iniziato lo stesso Magaldi)
mentre tra le neoaristocratiche e oligarchiche, vero fulcro del volume, si
segnalano la Edmund Burke, la Compass Star-Rose, la Leviathan, la Three Eyes, la
White Eagle, la Hathor Pentalpha. Tutto il potere del mondo sarebbe contenuto in
queste Ur-Lodges e finanche i vertici della fu Unione Sovietica, a partire da
Lenin per terminare a Breznev, sarebbero stati superfratelli di una loggia
conservatrice, la Joseph de Maistre, creata in Svizzera proprio da Lenin. Può
sembrare una contraddizione, un paradosso, ma nella commedia delle apparenze e
dei doppi e tripli giochi dei grembiulini può finire che il più grande
rivoluzionario comunista della storia fondi un cenacolo in onore di un caposaldo
del pensiero reazionario. In questo filone, secondo Magaldi, s’inserisce pure
l’iniziazione alla Three Eyes, a lungo la più potente Ur-Lodges conservatrice,
di Giorgio Napolitano, attuale presidente della Repubblica e per mezzo secolo
esponente di punta della destra del Pci: “Tale affiliazione avvenne nello stesso
anno il 1978, nel quale divenne apprendista muratore Silvio Berlusconi. E mentre
Berlusconi venne iniziato a Roma in seno alla P2 guidata da Licio Gelli nel
gennaio, Napolitano fu cooptato dalla prestigiosa Ur-Lodge sovranazionale
denominata Three Architects o Three Eyes appunto nell’aprile del 1978, nel corso
del suo primo viaggio negli Stati Uniti”. Altri affiliati: Papa Giovanni XXIII,
Bin Laden e l’Isis, Martin Luther King e i Kennedy. C’è da aggiungere, dettaglio
fondamentale, che nel libro di Magaldi la P2 gelliana è figlia dei progetti
della stessa Three Eyes, quando dopo il ‘68 e il doppio assassinio di Martin
Luther King e Robert Kennedy, le superlogge conservatrici vanno all’attacco con
una strategia universale di destabilizzazione per favorire svolte autoritarie e
un controllo più generale delle democrazie. “Il vero potere è massone”. E
descritto nelle pagine di Magaldi spaventa e fa rizzare i capelli in testa. Dal
fascismo al nazismo, dai colonnelli in Grecia alla tecnocrazia dell’Ue, tutto
sarebbe venuto fuori dagli esperimenti di questi superlaboratori massonici,
persino Giovanni XXIII (“il primo papa massone”), Osama bin Laden e il più
recente fenomeno dell’Isis. In Italia, se abbiamo evitato tre colpi di Stato
avallati da Kissinger lo dobbiamo a Schlesinger jr., massone progressista.
L’elenco di tutti gli italiani attuali spiccano D’Alema, Passera e Padoan. Il
capitolo finale è un colloquio tra Magaldi e altri confratelli collaboratori con
quattro supermassoni delle Ur-Lodges. Racconta uno di loro, a proposito del
patto unitario tra grembiulini per la globalizzazione: “Ma per far inghiottire
simili riforme idiote e antipopolari alla cittadinanza, la devi spaventare come
si fa con i bambini. Altrimenti gli italiani, se non fossero stati dei bambinoni
deficienti, non avrebbero accolto con le fanfare i tre commissari dissimulati
che abbiamo inviato loro in successione: il fratello Mario Monti, il
parafratello Enrico Letta, l’aspirante fratello Matteo Renzi”. Per non parlare
del “venerabilissimo” Mario Draghi, governatore della Bce, affiliato a ben
cinque superlogge. Ecco l’elenco degli italiani nelle Ur-Lodges: Mario Draghi,
Giorgio Napolitano, Mario Monti, Fabrizio Saccomanni, Pier Carlo Padoan, Massimo
D’Alema, Gianfelice Rocca, Domenico Siniscalco, Giuseppe Recchi, Marta Dassù,
Corrado Passera, Ignazio Visco, Enrico Tommaso Cucchiani, Alfredo Ambrosetti,
Carlo Secchi, Emma Marcegaglia, Matteo Arpe, Vittorio Grilli, Giampaolo Di
Paola, Federica Guidi. Berlusconi, invece, avrebbe creato una Ur-Lodge
personale, la Loggia del Drago.
Bisognerà aspettare le Massoneria, che ruolo hanno
le logge sovranazionali?Scrive Alessio Liberati, Magistrato, su “Il Fatto
Quotidiano”. In questo periodo si fa un gran parlare (spesso con confusione) di
massoneria, Trilateral Commission, Club Bilderberg e altri sodalizi più o meno
riservati, cui sono stati “ricondotti” anche alcuni notissimi volti della nostra
politica ed economia attuale. La realtà, però, potrebbe essere più complessa di
quanto appaia dai titoli dei giornali e dai libri di inchiesta usciti negli
ultimi anni ed una giusta analisi del back office dei cosiddetti poteri
forti potrebbe rappresentare la giusta chiave di lettura degli episodi più
rilevanti degli ultimi decenni: dall’11 settembre all’attentato al Papa, dalla
moneta unica alla crisi attuale, dalle grandi alle piccole guerre degli ultimi
anni, e così via. Questa almeno è la prospettiva con cui Gioele Magaldi, il
maestro venerabile e fondatore del Grande Oriente Democratico – un movimento di
pensiero che si ripromette di recuperare la morale e la finalità latomistica
originaria – rilegge nel suo libro gli ultimi cento anni di storia, riscrivendo
episodi ed eventi che hanno in qualche modo segnato la vita di tutti noi e
riconducendoli in un unico filo conduttore. Una fonte attenta e interna a quel
mondo, quasi inaccessibile ai più, e per questo motivo da vagliare con grande
considerazione. Il volume è peraltro il primo di una serie che si ripromette di
illustrare ancor meglio alcuni punti che vengono solo accennati. Sullo sfondo si
muovono i grandi personaggi dell’era moderna e contemporanea (italiani e
stranieri), di cui vengono rivelate appartenenze e obiettivi perseguiti. Una
descrizione sorprendente e interessantissima, che a tratti lascia senza fiato e
che aiuta a leggere con occhi diversi il mondo della massoneria internazionale –
almeno per chi vuole credere alla analitica visione che ne è prospettata – nei
confronti della quale alcuni sodalizi che possono sembrare tanto potenti quanto
influenti appaiono ben piccola cosa, aprendo al contempo gli occhi ad una
impronta sovranazionale. Quali le fonti? Quali i grandi della terra coinvolti?
Quali gli indicibili accordi? Non voglio dire di più, non essendo ancora uscito
in libreria il volume di cui sto parlando e volendo rimettere ogni valutazione a
chi leggerà quelle pagine. Per chi volesse approfondire l’argomento, intanto,
l’appuntamento è per giovedì 20 novembre, a Roma (libreria Fandango, h. 21) con
l’autore del libro Gioele Magaldi, Sabina Guzzanti, alcuni noti giornalisti e
me, o, dal giorno dopo, nelle principali librerie con il libro Massoni: la
scoperta delle UR-lodges.
Massoneria: i deliri del “fratello
democratico” Magaldi, scrive Paolo Signorelli su
“L’Ultima Ribattuta”. Che la Massoneria sia tuttora viva e vegeta non è un
mistero. Che centinaia di logge, soprattutto negli Stati Uniti, in Gran Bretagna
e in Francia, siano attivissime nel condizionare la vita economica e finanziaria
dei cinque continenti, è un altro dato di fatto. E che i “Fratelli” si diano
molto da fare anche in Italia lo ammettono in molti; ne ha fatto cenno in un
editoriale il direttore del “Corriere della Sera”, Ferruccio de Bortoli e lo
aveva ammesso, senza mezzi termini, un banchiere per tutte le stagione come
Cesare Geronzi. Ma che adesso tutto rischi di finire in una sorta di burletta,
dando di massoni a ruota libera e senza fornire uno straccio di prova, non è
accettabile. C’è uno strano personaggio, autonominatosi fondatore del “Grande
Oriente Democratico”, che merita di essere portato via in ambulanza dal 118 e
sottoporsi a un TSO (trattamento sanitario obbligatorio). Si chiama Gioele
Magaldi, poco più che quarantenne. Dopo aver bersagliato per mesi e mesi,
attraverso il sito della sua loggia privata i presunti “massoni deviati”, ora ha
dato addirittura alle stampe un volume nel quale elenca un incredibile serie di
“fratelli illustri”. E dà da pensare che anche un quotidiano serio come “il
Fatto Quotidiano”, pur con tutte le cautele del caso, gli stia dando credito.
Perché in questo caso non si tratta di libertà di stampa, ma di frescacce a
ruota libera. Nell’elenco c’è Papa Giovanni XXIII (il primo “Papa massone”), ma
anche Osama Bin Laden. Poi ci sono i Kennedy, Martin Luther King e i membri
dell’Isis. Presente anche il capo dello Stato Giorgio Napolitano e il premier
Matteo Renzi, i politici italiani Massimo D’Alema, Mario Draghi, Mario Monti.
Enrico Letta, Fabrizio Saccomanni, Pier Carlo Padoan, Gianfelice Rocca, Domenico
Siniscalchi, Giuseppe Recchi, Marta Dassù, Corrado Passera, Ignazio Visco,
Vittorio Grilli, Federica Guidi, Matteo Arpe, Tommaso Cucchiani, Carlo Secchi e
Emma Marcegaglia. Insomma, ci sono proprio tutti. Magaldi affronta poi la
questione delle “logge segrete” tra le quali figurano la “Thomas Paine”, la
“Edmun Burke”, la “Leviathan”, la “White Eagle” e la super loggia conservatrice
la “Joseph de Maistre”, cui avrebbero fatto parte Lenin e Breznev. Un delirio di
onnipotenza e di follia quello di Magaldi. Che qualcuno lo fermi.
LA MASSONERIA TRA CHIESA E 'NDRANGHETA.
La massoneria in Vaticano.
La Biblioteca apostolica ha acquistato un "classico" della letteratura
massonica: il "Purgatorio ragionato" di Francesco Longano, scrive Ignazio Ingrao
su “Panorama”. Siamo in pieno ‘700, un giovane molisano di umili origini,
Francesco Longano decide di intraprendere la carriera del sacerdozio. Come
confesserà candidamente anni dopo nella sua autobiografia, lo fa unicamente per
poter continuare a studiare. Appassionato di filosofia ed etica, succede al suo
maestro Antonio Genovesi, alla cattedra di commercio dell’Università di Napoli
ma i suoi scritti di filosofia morale, influenzati dall’atmosfera illuminista e
anticlericale, gli attirano le ostilità delle gerarchie ecclesiastiche. Longano
prosegue sulla sua strada e si imbatte nella massoneria. Decide di affiliarsi a
ben tre logge, pur essendo sacerdote, nonostante la massoneria sia già fuori
legge nel Regno delle due Sicilie e sia severamente condannata dalla Chiesa. Nel
frattempo un editore austriaco gli chiede di scrivere un saggio sul Purgatorio
che sarebbe dovuto essere pubblicato in tre lingue: italiano, latino e francese.
Nasce così il «Purgatorio ragionato» che non riuscirà a superare i rigori della
censura del tempo ma due secoli e mezzo dopo approderà nel luogo più inatteso:
la Biblioteca apostolica vaticana. Uno studioso appassionato di quel periodo,
Francesco Lepore ha pubblicato un approfondito ed erudito saggio su quel testo
che è stato pubblicato nientemeno che nella «Miscellanea Bibliothecae
Apostolicae Vaticanae», la pubblicazione ufficiale della «biblioteca del Papa».
In occasione dell’uscita di questo studio, la Biblioteca del Grande Oriente
d’Italia ha organizzato una tavola rotonda che si terrà a Roma, presso Casa
Nathan, il 6 novembre con la partecipazione di storici ed esperti di quel
periodo: Ruggiero di Castiglione, Antonio Trampus, Gianni Eugenio Viola e il
giornalista Paolo Rodari.
Un manoscritto che si credeva perduto.
«Nel 2005 un privato offrì alla Biblioteca apostolica
vaticana l’acquisto del manoscritto di Longano che si credeva ormai perduto da
due secoli e mezzo», racconta Lepore. «Il prezzo era molto contenuto: appena
tremila euro. Perciò la Biblioteca decise di procedere all’acquisto e di
inserire l’opera nel fondo “Vaticani Latini”. Si tratta del manoscritto
originale con le correzioni dell’autore». Infatti, «quando nel 1779 un editore
di Vienna propose a Longano di scrivere questo saggio, il sacerdote si mise
subito all’opera e, come racconta nell’autobiografia, terminò la stesura in un
mese. Il testo venne sottoposto al censore ecclesiastico e a quello regio per
ottenere l’imprimatur. Questi chiesero di effettuare dei cambiamenti. Completate
le correzioni, Longano diede via libera alla stampa. Ma quando questa non era
ancora conclusa, uscì un pamphlet dell’ex gesuita Francesco Antonio Zaccaria che
accusava il lavoro di Longano di essere “ereticale” e “infettato di
anticlericalismo”. Il testo perciò venne ritirato e non vide più la luce».
Perché era stato ritenuto tanto pericoloso? «Longano aveva voluto fare un
trattato sul Purgatorio senza ricorrere a riferimenti biblici o dottrinali, ma
solo alla luce della ragione. Anche riguardo alle opere di suffragio per le
anime del purgatorio la posizione dell’autore è originalissima. Anziché
raccomandare Messe, Rosari e indulgenze, propone azioni di impronta etica:
abbattere le differenze sociali, promuovere le virtù sociali, difendere la
giustizia e l’uguaglianza. Sono elementi di chiara derivazione dal catechismo
massonico a cui si rifà Longano e che, naturalmente, gli procurano l’ostilità
ecclesiastica». Oggi però il frutto delle sue fatiche riposa proprio nel cuore
del Vaticano.
"Io, vescovo rimosso dalla Santa Sede per
la mia lotta contro mafia e massoni". Il caso di
Francesco Miccichè, alto prelato di Trapani, rimosso dal suo incarico nonostante
per i magistrati sia "parte lesa". Mentre la curia della città siciliana è al
centro di uno scandalo sulla gestione di fondi e beni ecclesiastici. In una
trama che vede protagonista anche lo Ior, scrive Piero Messina “L’Espresso”. "Il
Vaticano ha sentenziato la mia condanna dipingendomi come un essere immorale da
tenere alla larga, mi ha rottamato come pastore indegno, mi ha classificato
mafioso, truffaldino e inaffidabile, mi ha trattato peggio di un delinquente,
condannato all’inazione come un minus habens, un incapace”. Le parole sgorgano
come pietre dal memoriale di Francesco Miccichè, documento di oltre cento
pagine, redatto del vescovo alla guida della Diocesi di Trapani dal 1998 sino al
16 maggio 2012. Quel giorno la rimozione arriva, a firma di Adriano Bernardini,
Nunzio Apostolico in Italia. E’ l’obbligo alle dimissioni. La nota inviata dalla
Santa Sede – e classificata con il bollo di "segretissima” – ha il sapore della
minaccia: senza l’abbandono immediato della Diocesi, la destituzione si sarebbe
celebrata con la pubblicazione sull’Osservatore Romano, entro 72 ore. Per un
religioso, peggio di una fucilazione. Da quel momento, Monsignor Miccichè
tenterà in tutti modi di aprire un canale con la Santa Sede, prima con Papa
Benedetto XVI e poi con il Santo Padre Francesco. Senza ottenere nulla, se non
un brevissimo incontro, alla fine dello scorso anno con Papa Bergoglio: "Ho
chiesto al Papa udienza per poter raccontare la mia storia – ammette il prelato
– e il Santo Padre mi ha pregato di rivolgere la richiesta al suo segretario
particolare”. Non è successo nulla: Città del Vaticano, sul caso Miccichè, ha
eretto il classico muro di gomma. Ora, in quel memoriale, il vescovo messo ai
margini della comunità religiosa ripercorre la sua via crucis laica. Da oltre
tre anni la Curia di Trapani è l’epicentro di una serie di inchieste giudiziarie
che ruotano attorno alla gestione dei fondi e dei beni ecclesiastici. Sullo
sfondo di quelle carte giudiziarie si intravede la lotta per il potere e per il
controllo delle Diocesi siciliane, l’inviolabilità dello Ior e l’immancabile
ipotesi di inquinamento mafioso. Con in più l’ombra della massoneria deviata.
Dossier anonimi, lettere false, bonifici bancari transitati sui conti dello Ior
e transazioni con firme apocrife sono gli ingredienti di questo plot Vaticano in
salsa siciliana, racchiuso nel dossier del vescovo. Ora che la Procura di
Trapani, guidata da Marcello Viola, si avvia a chiudere le indagini, resta
l’interrogativo di quella rimozione ex abrupto di Monsignor Miccichè dalla
Diocesi. Perché il vescovo siciliano, secondo la ricostruzione dei magistrati, è
considerato, almeno sino ad ora, "parte lesa” in quei procedimenti giudiziari.
Miccichè è convinto di pagare un conto dalla genesi antica. Sin dall’arrivo
nella Diocesi, il vescovo siciliano ha messo nel mirino mafia e grembiulini. Nel
marzo del 2000, attacca così le logge trapanesi e la mafia: ''La massoneria ha
messo radici profonde nella nostra città, condizionandone la vita e lo sviluppo.
Le Diocesi della Sicilia occidentale, tra le quali quella di Trapani, vivono in
un territorio che è storicamente la culla del fenomeno malavitoso tristemente
noto con il nome di mafia”. Scoppia un putiferio, con la massoneria italiana che
accusa il monsignore di oscurantismo. Miccichè sarà minacciato: "mi venne detto
– da un padre della Società religiosa di San Paolo, ndr - che se non mi fossi
convertito e iscritto alla massoneria avrei fatto una brutta fine. Tragica
profezia”. Il vescovo di Trapani chiederà aiuto al Vaticano: "Chiesi udienza al
Cardinale Joseph Ratzinger allora prefetto della Congregazione per la dottrina
della fede e fui ricevuto dall’allora Segretario della stessa congregazione Sua
Eccellenza Mons. Tarcisio Bertone al quale riferii quanto mi era successo e a
lui chiesi lumi su come comportarmi… Alla mia obiezione come mai non si mettesse
un freno ai preti che andavano in tutta Italia a fare conferenze in favore della
massoneria, Bertone mi rispondeva candidamente: Ma cosa vuole, Eccellenza, anche
in Vaticano ci sono cardinali, vescovi e prelati iscritti alla massoneria”.
Schizzi di fango colpiranno l’episcopato di Miccichè a Trapani di nuovo nel
2009, quando un esposto anonimo, il primo di una lunga serie, sarà recapitato
alla Procura nazionale antimafia, allora retta da Piero Grasso, al Cardinale
Bertone e al Cardinale Re. In quel documento si accusa Miccichè di avere al suo
fianco come "segretario vescovile” un esponente di una famiglia della mafia
rurale di Alcamo. In quel documento, per la prima volta, viene citata anche la
Fondazione Auxilium, struttura sanitaria guidata dalla Diocesi di Trapani e
convenzionata con la Regione siciliana. Miccichè respingerà ogni accusa e
dimostrerà che quel "segretario”, era in realtà solo l’autista dalla Diocesi di
Trapani, assunto prima del suo arrivo. Miccichè non nega di avere subito
pressioni dalla mafia: "Anch’io da subito arrivato in Diocesi fui avvicinato da
persone di questo genere che mi chiesero con fare perentorio di interessarmi in
loro favore presso la Procura di Trapani che aveva sequestrato i loro beni,
reputandoli prestanome di potenti mafiosi di Alcamo. Il mio diniego fu secco e
l’atteggiamento e le parole degli interessati suonarono come una minaccia, ma
non mi pento affatto di avere agito come ho agito e di non essermi piegato ai
loro dictat”. Nel mese di febbraio del 2011 la Diocesi di Trapani finisce al
centro di uno scandalo finanziario. Si ipotizza un buco milionario nei conti
della Curia. Sotto la lente delle Fiamme gialle finisce anche la gestione di due
fondazioni della curia siciliana, la Auxilium e la Campanile, già fuse nel 2007.
Auxilium è una struttura sanitaria con oltre 300 dipendenti e conta su una
convenzione dal valore di 5 milioni di euro con la sanità regionale. Miccichè,
nel 2009, ha nominato suo cognato come procuratore della fondazione. La
giustizia italiana e quella vaticana si mettono in moto. Le indagini puntano
anche al direttore degli uffici amministrativi della curia di Trapani, padre
Ninni Treppiedi. Alla fine, nell’inchiesta della Procura di Trapani risulteranno
14 indagati con ipotesi di reato che vanno da diffamazione, calunnia e falso, a
truffa, appropriazione e riciclaggio. Treppiedi avrebbe aperto conti correnti
allo Ior: da semplice sacerdote non li avrebbe potuti tenere. Su quelle
transazioni la Procura di Trapani avvia una rogatoria internazionale, ancora
oggi ferma su un binario morto. Il nome di Treppiedi apparirebbe anche nel
memoriale dell’ex direttore generale dello Ior, Gotti Tedeschi. Sulla base di
quelle indagini "laiche” Miccichè sospende a divinis don Treppiedi. La procedura
verrà confermata e rafforzata da un decreto della Congregazione del Clero del
Vaticano. Tra le spese di quella gestione anche l’acquisto di auto di lusso,
donate a cardinali delle alte sfere vaticane. Alla fine, Treppiede – legato un
tempo a personaggi della politica siciliana come l’ex sottosegretario
all’Interno Antonio D’Alì – deciderà di collaborare con la giustizia. Un
contributo, affermano dalla Procura di Trapani, "di assoluto valore”. Ma intanto
contro Miccichè si scatena l’inferno. Treppiedi , dopo la sospensione a divinis,
sporge denuncia contro il vescovo Miccichè, accusato di avere svuotato i conti
della curia. Il Vaticano invia un visitatore apostolico, Monsignor Domenico
Mogavero. Miccichè non potrà mai leggere il contenuto della relazione che
porterà alla sua rimozione. Accusato di aver depredato la Curia, Miccichè si
difende e mostra gli estratti bancari: "altro che senza un soldo, quando ho
lasciato la Diocesi di Trapani sul conto c’era più di un milione di euro, mentre
la Fondazione Auxilium disponeva di oltre otto milioni di euro”. Sempre in quel
periodo, il vescovo deve difendersi da una campagna denigratoria costruita ad
arte. Viene diffusa una lettera su carta intestata della Diocesi di Trapani. E’
indirizzata a Luigi Bisignani, l’uomo al centro dello scandalo P4. Nella missiva
che reca la firma di Miccichè, si chiede l’intercessione in Vaticano da parte di
Bisignani perché "il Papa - a quel tempo Benedetto XVI, ndr - non è in grado di
decidere più nulla e il potere è demandato nelle mani dei Salesiani e in
particolare del Cardinale Bertone che lo esercita in modo delinquenziale e
spregiudicato”. Quella lettera – lo dimostreranno i magistrati - è un falso.
Monsignor Miccichè tenta la difesa e veste i panni dell’investigatore: si mette
sulle tracce dell’attività svolta da Treppiedi allo Ior. In più, aiuta i
magistrati ad accedere nei luoghi di culto coinvolti nell’indagine per
transazioni immobiliari sospette. Per la Santa Sede sono peccati mortali. Nel
memoriale del vescovo siciliano appiedato dal Vaticano si legge: "Io stesso mi
sono recato allo Ior per conoscere se in qualche modo la stessa Diocesi di
Trapani o la mia persona fossero stati coinvolti, a mia insaputa, in operazioni
di riciclaggio. Allo Ior non ho ottenuto alcuna informazione. Sono stato
indirizzato dal Sostituto della Segreteria di Stato, Sua Eccellenza Mons.
Giovanni Angelo Becciu, il quale non ha reputato opportuno ricevermi. Dalla mia
visita presso lo Ior ho potuto accertare, però, che molti presso questo istituto
conoscevano don Treppiedi. Per loro era capo ufficio alla Congregazione di
Propaganda Fide”.
'Ndrangheta, massoneria e il "salto di
qualità": che cos'è la Santa? Scrive IBTimes Italia.
Tra le mafie storiche che operano in Italia da più di un secolo la 'ndrangheta è
quella meno raccontata e, di riflesso, meno capita. Il video registrato dai
Carabinieri del ROS, in cui durante un rito di affiliazione si citano Garibaldi,
Mazzini e Lamarmora, descritto quasi fosse una novità assoluta, in effetti non
lo è. Essendo le 'ndrine diventate mediaticamente famose solo negli ultimi anni,
mentre sono state ignorate, catalogate sotto la voce mafia di serie b , per
tanto, troppo tempo, ci si è persi qualche passaggio. In questo modo l'opinione
pubblica resta all'oscuro di 'concetti' come la Santa o del motivo per cui
protagonisti del Risorgimento italiano vengano inseriti nei riti della
criminalità organizzata. La prima volta che fu sequestrato un codice in cui si
fa riferimento ai tre risale al 1989, nel covo del latitante Giuseppe Chilà a
Pellaro (Reggio Calabria). Lo ricorda Roberto Galullo sul Sole 24 Ore
che, non a caso, cita la bibliografia prodotta in questi anni da Nicola
Gratteri, il procuratore aggiunto della DDA reggina, e Antonio Nicaso, storico
delle organizzazioni criminali e ritenuto uno dei massimi esperti mondiali della
criminalità organizzata calabrese che IBTimes ebbe modo di intervistare
lo scorso anno. Libri come
Fratelli di sangue che ripercorrono la storia della 'ndrangheta, ma
soprattutto spiegano riti e codici di quella che è da tempo la mafia più potente
e ricca che opera oggi in Italia, cresciuta nel disinteresse dei media,
coltivando rapporti con politica, imprenditoria e 'poteri forti' fin dagli anni
Settanta. In merito al video diffuso ieri, Nicaso ha commentato su Facebook:
"Sono conformi al rituale. Nessuno strappo alla regola a conferma della grande
capacità della 'ndrangheta di coniugare vecchio e nuovo, tradizione e
innovazione". Garibaldi, Mazzini e Lamarmora sono riferimenti massoni,
utilizzati nel codice di affiliazione alla Santa, a Osso, Mastrosso e
Carcagnosso, i cavalieri spagnoli che secondo la leggenda hanno fondato le tre
principali organizzazioni criminali in Italia.
LA SANTA
Il giuramento che si
ascolta nel video è relativo al grado di santista. Cos'è la Santa? È dove la
mafia calabrese incontra i poteri forti, citati a sproposito quando non
c'entrano nulla e dimenticati se invece operano davvero sul campo. Fino agli
anni Settanta la 'ndrangheta è subalterna alle altre organizzazioni criminali:
opera soprattutto sul territorio calabrese, ha un raggio di azione limitato. Poi
ecco il salto di qualità. "La mafia calabrese è stata spesso subalterna alla
politica, utilizzata da essa per raccogliere e organizzare il voto - spiega
Nicaso - Negli anni Settanta è riuscita a ribaltare questa subordinazione con
l'introduzione del grado della Santa, una zona d'élite che permetteva una doppia
affiliazione, quella alle 'ndrine e quella alla massoneria deviata. Con essa la
'ndrangheta ha iniziato a votare e far votare, a selezionare i candidati, a
gestire consenso, ad entrare nel giro di appalti e subappalti e gestire risorse
pubbliche". Gli stessi concetti sono stati espressi lo scorso aprile da
Nicola Gratteri, sentito in audizione davanti alla Commissione Parlamentare
Antimafia: "L'evoluzione della 'ndrangheta è avvenuta nel 1969 ,
quando c'è stata una rivoluzione interna alla 'ndrangheta con la creazione della
Santa. La Santa consiste nella possibilità per uno 'ndranghetista di essere
affiliato anche alla massoneria deviata. Questo è servito alla 'ndrangheta per
avere contatti con i quadri della pubblica amministrazione e, quindi, con
medici, ingegneri e avvocati. Un collaboratore di giustizia ci ha spiegato che
«all'orecchio del Gran Maestro» possono essere affiliati tre incappucciati. Ciò
vuol dire che questi sono conosciuti solo al Gran Maestro. Lo stesso
collaboratore ci ha spiegato che anche alcuni magistrati hanno partecipato a
riunioni della Santa. Su questo, però, non siamo riusciti ad avere riscontri". Anche
alla luce di questa svolta, si spiega il successo delle 'ndrine negli anni
successivi: l'espansione in tutta Italia, compreso il ricco Nord che ha scoperto
di essere stato colonizzato con 20 anni di ritardo. Mentre gli occhi
dell'opinione pubblica erano puntati altrove, soprattutto su Cosa nostra che
faceva saltare in aria magistrati e scorte, la 'ndrangheta prosperava in
silenzio e, grazie alla sua struttura (i vincoli di sangue che rendono difficile
il fenomeno del pentitismo, ma hanno favorito lo stringere rapporti con i
cartelli della droga sudamericani) è diventata il punto di riferimento del
traffico di stupefacenti in Europa, accumulando capitali da capogiro, poi
investiti nel grande gioco degli appalti pubblici.
Durante
il giuramento per il conferimento della Santa, registrato dai
Carabinieri nell’operazione della Dda di Milano in Lombardia che ha portato
all’arresto di 40 presunti ‘ndranghetisti, si fa riferimento a
Mazzini, Garibaldi e
La Marmora. Garibaldi, nella
ricostruzione degli investigatori, rappresenta il
capo del Locale di ‘ndrangheta
(l’organizzazione locale), Mazzini il contabile e La Marmora riveste invece la
carica di “236 mastro di giornata”, tra le più alte dell’associazione.
Nei video i segreti del giuramento alla ‘ndrangheta,
ma anche le soluzioni estreme in caso di “errori” di grande entità. Recitati
parte in italiano e parte in dialetto le parole sono comunque raccapriccianti.
Nel video, registrato dagli investigatori a
Castello di Brianza, in
provincia di Lecco, si sente e si vede: “Buon Vespero e Santa sera
ai Santisti”, iniziano a recitare, “Giustappunto questa santa sera nel silenzio
della notte e sotto la luce delle stelle e lo splendore della luna, formo la
santa catena! Nel nome di Garibaldi, Mazzini e Lamarmora con parole di umiltà
formo la santa società. Dite dopo di me: Giuro di rinnegare tutto fino alla
settima generazione, tutta la società criminale da me fino ad oggi riconosciuta
per salvaguardare l’onore dei miei saggi fratelli. Nel nome di Garibaldi,
Mazzini e Lamarmora, passo la mia prima, seconda, e terza votazione su … Se
prima lo conoscevo come un saggio fratello fatto e non fidelizzato, da questo
momento lo conosco per un mio saggio fratello. Sotto la luce delle stelle e lo
splendore della luna sformo la santa catena. Nel nome di Garibaldi, Mazzini e
Lamarmora con parole di umiltà è sformata la santa società”.
MAGISTRATI MASSONI, GIU' IL
CAPPUCCIO!!!!
Magistrati massoni, giù il
cappuccio,
scrive “Karakteria”. In Basilicata e in particolar modo nel tribunale di
Matera esiste la presenza di un forte gruppo di avvocati e magistrati iscritti
alla stessa loggia massonica? Non sono in pochi a rispondere affermativamente a
questa domanda, altri lo negano perentoriamente. Alcuni altri sono disposti a
mettere la mano sul fuoco, mentre altri ancora semplicemente lo sospettano sulla
base di ricostruzioni di fatti e documentazioni, ma non avendone certezza
chiedono alle autorità competenti di soddisfare il diritto dei cittadini a
sapere se esiste un gruppo di massoni nei tribunali di Basilicata. Fino ad ora
questa elementare richiesta non è stata soddisfatta, nonostante le pressioni
dell'Indipendente Lucano e di Nicola Piccenna in particolare. L'unico elenco di
lucani iscritti alla massoneria di cui disponiamo risale ad un'inchiesta del
1992: Elenco dei residenti in Basilicata iscritti nella "Lista dei Massoni
dell'inchiesta Cordova 1992".
Magistrati italiani
appartenenti alla Massoneria - Petizione al Capo dello Stato, nella sua veste di
Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura - chiediamo a tutti i
magistrati Italiani se sono affiliati alla Massoneria: Ecc.mi Presidente e
Vice-Presidente del CSM, Le domanda circa l'appartenenza alla Massoneria non può
mai ottenere risposta affermativa. Il perché è ben spiegato dalle parole stesse
del giuramento che gli aspiranti Massoni pronunciano durante il rito
d'iniziazione: «prometto e giuro di non palesare giammai i segreti della
Massoneria, di non far conoscere ad alcuno ciò che mi verrà svelato, sotto pena
di aver tagliata la gola, strappato il cuore e la lingua, le viscere lacere,
fatto il mio corpo cadavere e in pezzi, indi bruciato e ridotto in polvere,
questa sparsa al vento per esecrata memoria di infamia eterna. Prometto e giuro
di prestare aiuto e assistenza a tutti i fratelli liberi muratori su tutta la
superficie della terra». Pertanto risulta quantomeno improbabile che un
magistrato Massone si adoperi "motu proprio" nel dichiarare un'appartenenza che
lo espone alle terribili conseguenze che quella dichiarazione comporta. D'altro
canto, però, Come la mettiamo, con quei confratelli Massoni che sono magistrati?
Basta insomma, per fare un esempio: come si comporterà il magistrato libero
muratore in Tribunale se l’imputato – o, più spesso, l’avvocato di quest’ultimo
– è un grembiulino come lui? Il Consiglio Superiore della Magistratura, ha il
dovere di garantire la intangibilità della fiducia dei cittadini
nell'istituzione giudiziaria e quindi di rendere disponibile un'informazione
pubblica sui magistrati appartenenti alla Massoneria poiché lo stringente
giuramento innanzi riportato comporta la promessa "di prestare aiuto e
assistenza a tutti i fratelli liberi muratori su tutta la superficie della
terra" potrebbe far dubitare dell'imparzialità del magistrato massone
qualora, in un procedimento giudiziario, fra tutti i liberi muratori della
terra, ve ne fosse uno coinvolto direttamente o indirettamente nei fatti
soggetti al suo giudizio. Per quanto innanzi, invitiamo il Presidente ed il
Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura a disporre un formale
atto d'interpello da notificare a tutti i magistrati Italiani attualmente in
servizio del seguente tenore: "Ill.mo Dr./Ill.ma D.ssa, Lei ha aderito alla
Massoneria? Se risponde affermativamente, può indicare lo stato attuale della
sua appartenenza e la documentazione che lo comprova? Per completezza si allega
un estratto di sentenza del COnsiglio di Stato che esclude l'esimente della
riservatezza in tema di appartenenza alla Massoneria del Pubblico Ufficiale o
Pubblico Incaricato: Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 06.10.2003 n° 5881.
Il Consiglio di Stato ha stabilito che è legittima una legge regionale che
impone ad un soggetto l'obbligo di comunicare l'appartenenza ad una loggia
massonica ai fini del conferimento di un incarico pubblico. Con la sentenza n.
5881 del 6 ottobre 2003 i giudici di Palazzo Spada affermano che tale obbligo
non viola il diritto di riservatenza in quanto è correlato alla particolare
posizione funzionale rivestita dal soggetto designato o nominato ad una pubblica
funzione ed è giustificato da preminenti interessi pubblici e generali
direttamente assistiti da garanzia costituzionale. Nella motivazione della
sentenza il giudice amministrativo precisa inoltre che il diritto alla
riservatezza, pur integrando un aspetto di non secondaria rilevanza della
proiezione della persona, non è un valore assoluto che trova diretta tutela
nella Carta costituzionale vigente come bene primario ed inviolabile ed è
destinato perciò a soccombere di fronte al principio di buon andamento
dell'amministrazione, postulato a livello costituzionale dell'art. 97".
Magistrati massoni: ecco 21
nomi al CSM.
Giovanni Conso chiede provvedimenti disciplinari per 19 magistrati e propone
trasferimenti d' ufficio per i legami con associazioni segrete e logge
massoniche. la strenna: un volume coi segreti dei " fratelli ",
scrive “Il Corriere della Sera”. Giudici affiliati alla massoneria: ecco i nomi.
Il Guardasigilli Giovanni Conso ha inviato le carte al Consiglio Superiore della
magistratura: chiede provvedimenti disciplinari per 19 magistrati. E propone tre
trasferimenti d'ufficio per incompatibilità ambientale. A Palazzo dei
Marescialli si precisa che per gli altri 53 nominativi contenuti negli elenchi
forniti dalla procura di Palmi, il ministro di Grazia e Giustizia ha chiesto
"soluzioni liberatorie": non risultano accertati nei loro confronti legami con
logge massoniche. La parola passa ora al procuratore generale della Cassazione
Sgroi, cui spetta attivare il "Tribunale dei giudici" del Consiglio per il
gruppo dei 19. La prima commissione referente del Csm si occuperà dei tre per i
quali Conso chiede il trasferimento. All'elenco dei 19 appartengono Angelo
Massimo Maestri (giudice del tribunale di La Spezia), Salvatore Di Blasi
(giudice del Tribunale di Milano), Riccardo Romagnoli (giudice del tribunale di
Roma), Massimo Vitali (pretore di Milano), Vincenzo Tessa (procuratore della
Repubblica di Sanremo), Mauro Monti (sostituto procuratore di Bologna), David
Monti (sostituto procuratore circondariale di Firenze), Stefano Scarafoni
(giudice del Tribunale di Tolmezzo), Vincenzo Serianni (presidente di sezione
della corte d'appello di Torino), Nicolò Franciosi (consigliere della corte
d'appello di Milano), Renato La Serra (pretore di Trani), Giuseppe Armani
(consigliere di corte d'appello di Bologna), Alfredo Arioti (sostituto
procuratore generale a Perugia), Francesco Pinello (presidente del tribunale di
sorveglianza di Palermo), Antonio Spina (pretore dirigente di Sciacca), Luciano
D'Agostino (sostituto procuratore di Lamezia Terme), Fabio Mondello (giudice del
tribunale di Roma), Salvatore Marino (presidente di sezione del tribunale di
Mistretta) e Paolo Nannarone (presidente di sezione del tribunale di Perugia).
Paolo Nannarone è anche uno dei tre magistrati per i quali il ministro di Grazia
e Giustizia ha chiesto l'avvio di un procedimento per il trasferimento d'ufficio
in base all'articolo 2 della legge sulle guarentigie dei giudici. Gli altri due
che dovrebbero essere sottoposti a tale procedimento sono Antonino Giubilaro
(giudice del tribunale di Pesaro) e Nicola Restivo (procuratore della Repubblica
di Perugia). Il consigliere laico del Pds Franco Coccia ha osservato che "la
relazione ispettiva licenziata dal ministro fa propria interamente
l'impostazione e l'analisi della delibera del Csm e su questa base è stata
eseguita una complessa e laboriosa indagine sui magistrati, risultanti dagli
elenchi, al fine di accertare la configurazione di concreti indizi di iscrizione
di magistrati ad associazioni segrete". Sulla vicenda interviene il Grande
Oriente d'Italia. Secondo il "Grande Oriente" Gustavo Raffi la relazione di
Conso al Csm sui magistrati massoni "circoscrive la richiesta di provvedimenti
disciplinari a quanti sono risultati iscritti a "logge coperte". Viene,
pertanto, confermata l'assoluta estraneità di affiliati al Grande Oriente d'
Italia, dal momento che simili strutture non solo sono bandite, ma inesistenti
nell'ambito della massoneria regolare di Palazzo Giustiniani".
MASSONERIA – I MAGISTRATI
DALLA A ALLA ZETA
di Rita Pennarola (pubblicato
il 7 gennaio 2010).
Può un magistrato venir meno
al vincolo di fedeltà giurato, pena la morte, per entrare in massoneria? E quali
prove possono addurre quei giudici o PM che affermano di esserne usciti? Qui
sentiamo alcuni esperti e passiamo in rassegna le carriere di tante toghe che
sicuramente quel patto di sangue lo avevano sottoscritto. Molti sono ancora in
servizio. E rivestono ruoli apicali. Gli italiani lo hanno capito da tempo, a
reggere davvero le sorti del Paese non sono né le banche né le istituzioni
democratiche e nemmeno la magistratura: sono i massoni – regolari o, quasi
sempre, appartenenti a logge coperte – che proprio in quei tre ambiti sono
capillarmente infiltrati. A confermare questa consapevolezza arriva, da ultimo,
il sondaggio lanciato sul sito della Voce, al quale hanno partecipato 466
lettori: un piccolo ma significativo campione, secondo il quale (56,8%) sono
sempre loro, i confratelli, a detenere saldamente le leve del potere. E tutto
attraverso quel vincolo di segretezza che, dopo l’iniziazione, si può cancellare
solo con la morte. Lo dicono, chiaro e tondo, le parole stesse del giuramento:
«prometto e giuro di non palesare giammai i segreti della Massoneria, di non far
conoscere ad alcuno ciò che mi verrà svelato, sotto pena di aver tagliata la
gola, strappato il cuore e la lingua, le viscere lacere, fatto il mio corpo
cadavere e in pezzi, indi bruciato e ridotto in polvere, questa sparsa al vento
per esecrata memoria di infamia eterna. Prometto e giuro di prestare aiuto e
assistenza a tutti i fratelli liberi muratori su tutta la superficie della
terra». Chiaro, no? Come la mettiamo, allora, con quei confratelli che rivestono
ruoli apicali in settori nei quali è richiesta la loro facoltà decisionale?
Basta insomma, per fare un esempio, che qualche magistrato se la cavi dicendo
frasi del tipo «La massoneria? Io l’ho lasciata da tempo…», senza poterlo in
alcun modo provare? E come si comporterà se l’imputato – o, più spesso,
l’avvocato di quest’ultimo – è un grembiulino come lui? Cominciamo dal primo
quesito. Giuseppe De Lutiis, uno fra i più autorevoli studiosi di eversione e di
poteri occulti, consulente di numerose Procure della Repubblica, non ha dubbi:
«dalla Massoneria si esce solo nel caso in cui si venga espulsi. Altrimenti si
rimane “in sonno”, una condizione comunque revocabile in qualsiasi momento».
Aggiunge un altro consulente, più volte fin dagli anni ‘80 al fianco dei PM in
indagini sulle Logge segrete: «accade con una certa frequenza che un massone in
sonno decida di rientrare tra i confratelli attivi, anche perché spesso la
scelta dell’“assonnamento” è dovuta all’assunzione di cariche pubbliche. Il suo
ritorno viene vissuto come una festa: non solo non occorre rifare tutti i
complessi rituali dell’iniziazione, ma spesso riceve in dono il passaggio ad un
grado superiore rispetto a quello che aveva lasciato. Questo indica che dalla
massoneria non ci si può “dimettere”: loro lo vivono come un battesimo, che non
prevede alcuna possibilità di “sbattezzarsi”». Tutto ciò riguarda le Logge
regolari, con tanto di elenchi depositati, mentre sulle eventuali “norme”
vigenti fra i massoni coperti non è possibile azzardare ipotesi. Di sicuro, il
giuramento non viene meno né potrà essere mai svelata l’identità dei
confratelli. Quali siano le “punizioni” per chi trasgredisce, si può a questo
punto solo immaginarlo. È sulla base di questa premessa che siamo andati a
cercare chi sono, dove sono ora e cosa fanno alcuni magistrati sulla cui
originaria affiliazione massonica non ci sono dubbi. I 37 nomi che qui di
seguito proponiamo, infatti, sono presi per buona parte dagli unici elenchi
(comprensivi delle Logge coperte) che siano mai venuti alla luce: quelli
sequestrati nel ‘92 dall’allora procuratore capo di Palmi Agostino Cordova.
Altri nomi li abbiamo invece ricavati dall’elenco ufficiale dei massoni
pubblicato nel 2008 dalla Voce, che non include la consistente fascia di vip
affiliati ad obbedienze cosiddette “non regolari”, ma assai più potenti e
generalmente riconosciute da Logge estere. Sulla cima della piramide ci sarebbe
in questo periodo, per fare un esempio, la “Gran Loggia Italiana Massonica”, i
cui adepti, che si definiscono «un gruppo di Fratelli Massoni provenienti da
varie Obbedienze, (G.O.I., Piazza del Gesù, Gran Loggia Regolare d’Italia, Gran
Loggia Massonica Italiana, Logge di San Giovanni, Gran Loggia della Repubblica
di San Marino)», adducono a fondamento della loro scelta la risibile motivazione
di poter affiliare anche le esponenti del gentil sesso (facoltà ampiamente
prevista da una delle due principali obbedienze regolari, vale a dire la Gran
Loggia d’Italia di Palazzo Vitelleschi). Fondata ad Arezzo nel marzo 2002, la
nuova compagine non poteva che essere benedetta da Licio Gelli in persona.
Nessun problema, se non fosse per un piccolo particolare venuto a galla in un
articolo della Nazione di fine 2006: la donazione fatta dal venerabile e dai
suoi confratelli ai poveri del Sacro Cuore di Arezzo. Racconta al quotidiano il
parroco, don Angelo Chiasserini: «Quello che valuto è la finalità
dell’iniziativa, che è di beneficenza. È stato Tiberio Terzuoli, gran maestro
della Serenissima Gran Loggia Nazionale, a contattarmi, spiegandomi
successivamente che all’iniziativa avevano contribuito anche Gelli e Giuseppe
Sabato, sovrano della Gran Loggia Massonica Italiana». Che di lì a poco si
sarebbe invece ribattezzata Gran Loggia Italiana Massonica. Ma chi è Giuseppe
Sabato il “sovrano”? Non sarà per caso lo stesso rampante manager di Banca
Esperia, la holding finanziaria che fa capo a Silvio Berlusconi? Impossibile
affermarlo con certezza, visto il segreto assoluto che vige nella neo-Loggia
aretina. Di sicuro, però, oggi a dominar la scena sotto i cappucci sono i maghi
dell’alta finanza. Come accade a Napoli, dove dominus incontrastato della Loggia
Bovio è il commercialista Giovanni Esposito, assurto nell’olimpo supermassonico
dell’Arco Reale, rito di York. «Il baricentro – dice ancora il nostro esperto –
ai livelli medio-alti si sta spostando dalle Logge coperte a queste consorterie
non riconosciute dalle obbedienze tradizionali, ma gemellate con compagini
estere come la Loggia Montecarlo, che ha sede nel Principato di Monaco». Se
questi sono ora gli assetti finanziari “globalizzati” dei confratelli, non meno
interessante sarebbe definire quali e quanti magistrati vestono oggi il
grembiule sotto la toga. Missione quasi impossibile, dal momento che a scoprire
le carte dovrebbero essere i loro stessi colleghi, come in perfetto isolamento
fece Cordova nel ‘92 e come, intorno al 2000, aveva provato a fare a Napoli un
altro PM-coraggio, Luigi De Ficchy, attuale procuratore capo a Tivoli e
all’epoca impegnato nell’inchiesta sulla Loggia deviata Spinello, naufragata
nelle nebbie della Procura capitolina. Mentre i circa mille faldoni
dell’inchiesta Cordova marciscono ancora nei sotterranei di piazzale Clodio, a
Roma. Eppure, provando a scorrere le carriere delle toghe messe a nudo dal
mastino di Palmi, più qualche nome venuto fuori in elenchi recenti, le sorprese
non mancano. Ecco allora qui di seguito, in ordine alfabetico, alcuni esempi
significativi fra i tanti magistrati che avevano giurato fedeltà alla
massoneria.
ABBADESSA Lorenzo – Classe
1939, nato a Napoli (dove gli Abbadessa sono conosciuti come influente famiglia
di medici), dal 2006 si è iscritto all’albo degli avvocati e risulta avere lo
studio a Soverato, perla costiera della provincia di Catanzaro. Con la qualifica
di “Magistrato” lo si ritrova invece negli elenchi dei massoni aggiornati a
tutto dicembre 2007 e pubblicati dalla Voce nel 2008. Lorenzo Abbadessa è
attualmente responsabile, proprio a Catanzaro, della Procura Generale della
Repubblica presso la Corte d’Appello, in via Falcone e Borsellino.
ALIBRANDI Tommaso – Nato a
Roma l’8 agosto del 1933, è iscritto negli elenchi ufficiali della massoneria
aggiornati a tutto il 2007 con la qualifica di “Magistrato al Consiglio di
Stato”. Negli anni ‘90 era stato invece attivo presso la Corte dei Conti. Nel
‘93 il suo nome è fra gli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla telefonia
dal PM della capitale Guglielmo Muntoni (giudice Maria Cordova) insieme – fra
gli altri – a Carlo De Benedetti, al costruttore Mario Lodigiani e all’ex
ministro Paolo Cirino Pomicino. In quegli anni Alibrandi era stato capo
dell’ufficio legislativo del Ministero dei Beni Culturali, presidente del TAR
della Val D’Aosta nonché ex “uomo ombra” dell’allora ministro repubblicano delle
Poste Oscar Mammì. Di provata fede PRI è anche Alibrandi (già senatore del
partito di Giorgio La Malfa), che nel 2003 ritroviamo in pista fra i promotori
della resuscitata Voce Repubblicana. Dal 2008 esercita la professione di
conciliatore bancario.
ARIOTI Alfredo – Un Alfredo
Arioti nato a novembre del 1941 compare con la dicitura esplicita di
“magistrato” negli elenchi ufficiali degli iscritti alla massoneria di Perugia a
tutto dicembre 2007. Si tratta dello stesso Alfredo Arioti Branciforti presente
nell’organico della magistratura italiana come “nato a Palermo il 26 novembre
1941”. Il che risulta fra l’altro dal suo curriculum pubblicato da E-Campus,
formazione universitaria a distanza, nel quale viene specificato che «dopo
essere stato uditore presso la Procura della Repubblica ed il Tribunale di Roma,
veniva nominato pretore in Valle D’Aosta a Donnaz». Nel 1969 «si trasferiva a
Perugia, dove svolgeva le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale». Dal 1981 Arioti è «sostituto procuratore generale presso
la Corte di Appello di Perugia. In tali funzioni esplicava numerose e
delicatissime inchieste anche nei confronti di varie organizzazioni
terroristiche quali Brigate Rosse, NAR, Prima Linea, Ordine Nuovo, talché subiva
un attentato terroristico, perpetrato da una organizzazione eversiva,
concretizzatosi in esplosioni di colpi di arma da fuoco nei confronti della sua
abitazione». Al CSM Arioti aveva dichiarato di essersi allontanato dalla
Massoneria fin dal 1992, dopo che per ben due volte l’organo di autogoverno lo
aveva dichiarato non idoneo a funzioni superiori proprio a causa di quella
affiliazione, che gli aveva fra l’altro fatto meritare consistenti avanzamenti
all’interno del sodalizio muratorio. Ne dava notizia, nel 2004, il bollettino di
Magistratura Democratica, senza peraltro precisare quali prove avesse addotto il
magistrato a riprova del suo allontanamento dalla massoneria, visto che il nome
compare ancora negli elenchi 2007. Di Alfredo Arioti si sono comunque più
recentemente occupate le cronache locali. È accaduto nel 2008, quando il
coordinatore PdL Fabrizio Cicchitto (piduista) lo voleva come candidato a
sindaco di Perugia; poi il diretto interessato preferì restare in magistratura –
ci informa la Nazione il 19 novembre – e non se ne fece nulla.
ARMANI Giuseppe – Classe 1937,
nato a Reggio Emilia, Armani è ancora presente in quanto “Magistrato” negli
elenchi degli affiliati 2007, benché abbia da tempo lasciato la toga. Il suo
nome venne alla luce già col sequestro Cordova nei primi anni ‘90 insieme a
quelli di una ventina fra giudici, pretori e pubblici ministeri, tutti poi
sottoposti al giudizio del CSM. Dedicatosi in seguito prevalentemente agli studi
giuridici, Armani è autore di libri sulla Costituzione in uso negli istituti
superiori. Nel 2006 ha pubblicato a Bologna un volume nel quale vagheggia l’idea
di un’Italia laica e liberale.
CASOLI Giorgio – Compare negli
elenchi 2007 pure Giorgio Casoli di Perugia, nato il 12 settembre del 1928.
Anche il suo nome era rimbalzato alle cronache (e al Consiglio Superiore della
Magistratura) dopo i sequestri del ‘92. Intrapresa la carriera come pretore ad
Assisi e a Perugia, è a Milano come giudice di Corte d’Appello negli anni del
terrorismo; passa poi in Cassazione dove diventa presidente di sezione. Di qui
comincia anche la carriera politica: sindaco di Perugia dall’80 all’87, lo
stesso anno entra a Palazzo Madama col PSI, dove siede nella giunta delle
immunità parlamentari e nella commissione giustizia; sarà poi sottosegretario
alle Poste nel governo presieduto da Giuliano Amato. Casoli torna alla ribalta
nel 1996, quando conferma ai PM milanesi molte delle accuse lanciate dalla
superteste Stefania Ariosto, cui è legato da antica amicizia. Soprannominato
dagli amici “il Pertini dell’Umbria”, è considerato oggi in area PD, dopo
l’avvicinamento di qualche anno fa al Partito Popolare.
D’AGOSTINO Luciano – La sua
affiliazione esplode come una bomba nel ‘92, quando il napoletano D’Agostino,
classe 1955, è PM a Locri. «Sono sconcertato – dichiara ai giornali – queste
fughe di notizie sono inammissibili». Il vero problema era che il suo nome
compariva negli elenchi di una Loggia coperta, la Luigi Ferrer del capoluogo
partenopeo. Anche nel caso di D’Agostino assistiamo alle affermazioni – peraltro
senza prove – su una presunta uscita dalla massoneria, proprio come si fa per
dimettersi da un Cral: «prima di prendere servizio a Lamezia Terme avevo scritto
alla loggia Luigi Ferrer di Napoli, regolare del Grande Oriente d’Italia, per
segnalare che ritenevo l’esercizio di funzioni giurisdizionali non compatibile
con l’appartenenza alla massoneria. Da allora non ho avuto alcun rapporto con i
massoni». Basta la parola. Sapeva che era una Loggia coperta?, gli chiede il
cronista del Corriere della Sera. E lui: «Un grande oratore del GOI ha detto che
è una loggia coperta. Nel breve periodo in cui ne ho fatto parte, non lo era».
Non riesce a convincere il CSM, che nel ‘95 gli infligge una sanzione
disciplinare, dichiarando che l’appartenenza alla massoneria è lesiva
dell’imparzialità dell’ordine giudiziario. Fino a inizio anni 2000 D’Agostino è
sostituto procuratore a Catanzaro (dove si occupa, fra l’altro, della delicata
questione del testimone di giustizia Pino Masciari), nel 2002 passa alle sezioni
giudicanti dello stesso Tribunale. Dal 2007 è tornato a Locri, dove attualmente
è giudice per l’udienza preliminare. Nel frattempo era stato alle prese come
imputato in un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Salerno. L’accusa
(condanna in primo grado per peculato e assoluzione in appello) riguardava
l’affidamento ad una ditta dell’incarico di eseguire intercettazioni
telefoniche, quando D’Agostino era in servizio alla DDA di Catanzaro.
DI BLASI Salvatore –
Attualmente giudice al Tribunale civile di Milano, Di Blasi era fra le toghe
iscritte alla massoneria dell’elenco Cordova. Nel 2001 aveva assunto anche il
delicato incarico di presidente di sezione in seno alla Commissione Tributaria
della Lombardia. In questo periodo il giudice Di Blasi si sta occupando invece
della vicenda INNSE, la fabbrica milanese del legno a rischio chiusura.
FRANCIOSI Nicolò – Anche lui
presente negli elenchi Cordova del lontano ‘92, oggi il giudice Franciosi,
napoletano, classe 1942, è consigliere della Corte d’Appello a Milano. Nel 2003
fa parte della terna giudicante che respinge la richiesta avanzata dai legali di
Cesare Previti di ricusazione dei giudici nel processo IMI-SIR. Turbolente le
vicissitudini del giudice Franciosi dinanzi al CSM per quell’antica
affiliazione: dopo la sanzione disciplinare fa ricorso alla Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo. Strasburgo condanna al risarcimento in favore di Franciosi
non il CSM ma lo Stato italiano, reo di scarsa chiarezza sulle norme che
regolano l’appartenenza alla massoneria nel caso di un magistrato. Il Consiglio
Superiore, però, nel 2002 respinge la richiesta avanzata da Franciosi di
revisione della sentenza di sanzione e, due anni dopo, dice no anche
all’inserimento della sentenza europea nel suo fascicolo personale.
LA SERRA Renato – Ecco un
magistrato-confratello di cui si sono praticamente perse le tracce. Le ultime
notizie che lo riguardano risalgono al 1998 quando, nell’ambito dell’inchiesta a
carico dell’ex procuratore generale di Roma Vittorio Mele e del ras della sanità
pugliese Francesco Cavallari, vennero a galla i viaggi generosamente offerti
dall’imprenditore agli amici in toga, compresa la leggendaria trasferta a Parigi
cui prese parte anche l’allora pretore di Trani Renato La Serra. La sua
affiliazione alle Logge, emersa negli elenchi Cordova del ‘92, gli era costata,
due anni dopo, una sanzione disciplinare dinanzi al CSM.
MAESTRI Angelo Massimo –
Classe 1944, originario della provincia milanese, è in servizio alla Corte
d’Appello del Tribunale di Palermo. Un caso, il suo, analogo a quello di Nicolò
Franciosi: dopo la scoperta dell’affiliazione attraverso il sequestro Cordova,
riceve la sanzione disciplinare dal CSM, che sarà confermata anche in
Cassazione. Nel 2004 la Corte di Strasburgo condanna lo Stato italiano a
risarcire Maestri con 10.000 euro. I problemi, nella carriera di Maestri, però,
sono stati anche altri: il suo trasferimento da La Spezia (dove era stato per
lunghi anni pretore) a Palermo, era stato infatti disposto nel 2001 dal CSM, che
lo accusava di aver ricevuto fidi bancari di consistente importo senza garanzie.
Situazione che, sommata alle contestazioni per la affiliazione massonica, non
solo determinò il trasferimento, ma anche la destinazione dell’ex pretore “ad un
organo collegiale”.
MARSILI Mario – Carriera
brillantissima per il genero del Venerabile Licio Gelli, del quale aveva sposato
la figlia Maria Grazia. Venuto allo scoperto come massone in sonno nella P2 dopo
il sequestro di Castiglion Fibocchi, il dottor Marsili si è gettato alle spalle
l’onta di quello scandalo, ottenendo perfino una promozione dal CSM (nell’89),
fino a balzare nel ruolo apicale che riveste oggi: sostituto procuratore
generale al Tribunale di Roma. Una Procura del resto, quella di piazzale Clodio,
che per anni aveva visto al vertice un altro piduista di fama, il massone
Carmelo Spagnuolo. Prima giudice istruttore ad Arezzo, poi alle sezioni
giudicanti del Tribunale di Perugia, Marsili ebbe solo un piccolo incidente di
percorso nell’84, quando fu sottoposto a procedimento penale dinanzi al
Tribunale di Verona (per accuse relative alla sua carriera di piduista) e, per
questo, gli fu sospeso lo stipendio. In seguito all’assoluzione, riprese la sua
escalation nei ranghi della giustizia italiana. Tanto che furono affidate
proprio a Marsili le indagini sull’eversione nera di stampo neofascista,
comprese quelle a carico di Mario Tuti e l’inchiesta sulla strage dell’Italicus.
Come sono andate a finire, lo sappiamo.
MEZZATESTA Michele – No, non
era un’affiliazione massonica qualsiasi, quella del magistrato Michele
Mezzatesta, nei primi anni ‘90 presidente del Tribunale fallimentare di Palermo.
Perché alla stessa Loggia del capoluogo siciliano facevano capo anche fior di
mafiosi (fra cui il “ragioniere” di Cosa Nostra Pino Mandalari e Salvatore
Greco, fratello del “papa” Michele Greco), politici ed affaristi. “La pietra
entra grezza ed esce levigata”, si leggeva all’ingresso di quel tempio, cui gli
inquirenti erano arrivati seguendo le tracce di un narcotrafficante agrigentino.
La questione si è riaperta in qualche modo nei mesi scorsi, dopo che i pubblici
ministeri di Caltanissetta hanno chiesto all’AISI, attuale sancta sanctorum dei
servizi segreti italiani, di visionare gli archivi sulla strage di Capaci. In
compenso Mezzatesta non figura più nei ranghi della magistratura italiana.
MONDELLO Fabio – Consigliere
di Corte d’Appello a Roma, dopo il clamore seguito al ritrovamento del suo nome
fra i massoni del sequestro Cordova, nel ‘96 Mondello finisce nuovamente nei
guai a causa di un processo che lo vede imputato insieme all’allora presidente
di Cassazione Filippo Verde per aver usufruito di viaggi offerti dalla Canon ad
alti esponenti del Ministero di via Arenula, dove i due magistrati avevano
prestato servizio nei primi anni ‘90. Il nome di Mondello rimbalzò
contemporaneamente anche nell’ambito di un altro scottante procedimento, quello
che vide coinvolto il gip della capitale Renato Squillante e l’avvocato Attilio
Pacifico. In seguito alla condanna in primo grado riportata a Perugia per la
vicenda Canon, Mondello ha lasciato la magistratura.
MONTI David – Un caso davvero
spinoso, quello di David Monti, il cui nome è legato all’inchiesta, condotta
quando era PM ad Aosta, denominata Phoney Money ed incentrata su traffici
internazionali che coinvolgevano massoni, alti prelati e pezzi dello Stato.
Correva l’anno 1996 e nessuno si ricordava più che il nome di David Monti era
negli elenchi sequestrati da Agostino Cordova. Anche Monti, all’epoca, aveva
fatto ricorso alla solita scusa: «la mia iscrizione alla massoneria? Una
semplice curiosità giovanile». Sarebbe interessante sapere come ha fatto il
magistrato (e con lui diversi altri colleghi) a cancellare il complesso rituale
dell’affiliazione ma, soprattutto, a rinnegare il giuramento di sangue fatto
dinanzi ai confratelli. Una bella letterina di dimissioni, come al circolo del
golf? Di sicuro Monti ha proseguito senza impedimenti la sua carriera
nell’ordinamento della magistratura italiana. Ed oggi è GIP a Firenze.
MONTI Mauro – Classe 1947,
riveste attualmente l’alta carica di sostituto procuratore aggiunto al Tribunale
di Bologna, la città dove è nato. Dopo la scoperta del suo nome negli elenchi
sequestrati da Cordova, di Mauro Monti le cronache non si erano più occupate.
Tornano a farlo ad agosto 2009 quando, su richiesta dello stesso Monti, il
Tribunale accoglie le istanze avanzate in appello dai difensori di Saverio
Masellis e Francesco Cardamone, esponenti del clan dei casalesi accusati per
aver gestito bische clandestine nel riminese. Risultato: per i due la sentenza
di condanna è stata annullata e gli atti tornano al GUP.
NANNARONE Paolo – I problemi
cominciano fin dall’83, perché il nome di Nannarone è già lì, negli elenchi
della Loggia Propaganda 2, insieme a quelli di altri magistrati. A differenza
dei colleghi, Nannarone viene assolto dal CSM. E benché lo si ritrovi nuovamente
negli elenchi Cordova del ‘92, il magistrato continua la sua carriera senza
problemi; quello stesso anno presiede al Tribunale di Perugia (dove ha svolto la
gran parte della sua attività) la Corte d’Appello che proscioglie il finanziere
“a un passo da Dio” Pierfrancesco Pacini Battaglia, difeso dall’attuale
parlamentare di AN Giulia Bongiorno. Nel ‘96 ritroviamo Nannarone a capo della
Corte d’Assise chiamata a pronunciarsi sul delitto del giornalista Mino
Pecorelli. Ritenuto incompatibile, sarà sostituito dal collega Giancarlo
Orzella. Nel 2000, sempre a Perugia, pronuncia una storica sentenza: i clienti
delle prostitute non sono punibili per favoreggiamento. Classe 1939, lasciata la
magistratura Nannarone è oggi nell’organigramma di vertice della Banca Popolare
di Cortona.
PINELLO Francesco – Classe
1932, presidente del Tribunale di sorveglianza di Palermo, nel 2005 fa parlare
di sé per il regime di semilibertà concesso al pluriomicida del Circeo Angelo
Izzo, tanto che l’allora guardasigilli Roberto Castelli decise di inviare gli
ispettori in Sicilia. In precedenza il nome di Pinello era balzato alle cronache
negli elenchi massonici del ‘92, che gli costarono un procedimento disciplinare
del CSM a suo carico.
PONE Domenico – In quegli
elenchi del ‘92 c’era anche Domenico Pone: una cosa da poco rispetto alla
scoperta, avvenuta nel lontano 1983, della sua contemporanea affiliazione alla
P2, proprio mentre prestava servizio alla suprema Corte di Cassazione.
Segretario, all’epoca, di Magistratura Indipendente, la corrente moderata delle
toghe, Pone rappresenta uno fra i pochissimi casi di magistrati rimossi
dall’ordinamento giudiziario per appartenenza alla Loggia fondata da Licio
Gelli.
RESTIVO Nicola – È giudice per
le indagini preliminari a Perugia, Nicola Restivo. Una delle ultime operazioni
che portano la sua firma risale a maggio 2009, quando convalida il sequestro di
biomasse trasportate illecitamente nelle campagne umbre. Nel 2007 un altro
blitz, questa volta a carico di operatori assenteisti nella locale azienda
ospedaliera. Nel ‘92, quando era procuratore capo a Perugia, il suo nome
rimbalzò fra quelli dei massoni nelle liste Cordova. Il che, come abbiamo visto,
non ha intralciato la sua brillante carriera.
RINAUDO Antonio – Anche la
iscrizione di Rinaudo alla massoneria viene a galla con gli elenchi del ‘92.
Attualmente in servizio a Torino (la città in cui è nato nel 1948) come pubblico
ministero, si è recentemente occupato dell’ex giocatore della Juve Michele
Padovano, sotto accusa per un presunto traffico di droga col Marocco. Nel 2006
le intercettazioni a carico di Luciano Moggi disposte dalla Procura partenopea
portano alla luce la frequentazione assidua fra l’ex plenipotenziario del calcio
italiano ed il PM Rinaudo, fra cene con signore e scambi di regali natalizi. Ai
magistrati napoletani che lo interrogano sulla sua possibile affiliazione alle
Logge, Moggi risponderà: «Massone io? Mai»…
ROMAGNOLI Riccardo – È in
servizio al Tribunale civile di Roma il dottor Romagnoli, che a gennaio dello
scorso anno ha pronunciato una storica sentenza riguardante Poste Italiane. Nel
1996, a seguito del ritrovamento del suo nome negli elenchi massonici del ‘92, a
Riccardo Romagnoli il CSM inflisse la perdita di due anni d’anzianità. Il che
scatenò la vibrata protesta del Grande Oriente d’Italia.
ROMANO Guido – È presidente
del TAR della Calabria, il magistrato Guido Romano. La sua affiliazione – il
nome era presente negli elenchi del ‘92 – non ha dunque turbato una carriera
piena di soddisfazioni professionali. La decisione dell’allora guardasigilli
Giovanni Conso di deferire al CSM i magistrati massoni, fra i quali Romano, fu
aspramente criticata dal gran maestro Eraldo Ghinoi.
SALEMI Guido – Consigliere di
Stato, giudice al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e componente della
Commissione Tributaria Centrale. Queste le attuali qualifiche di Guido Salemi,
che al Consiglio di Stato ha pronunciato nel corso degli anni numerose e
rilevanti sentenze. La sua iscrizione in massoneria venne alla luce con gli
elenchi del ‘92.
SCARAFONI Stefano – Fra quelle
carte c’era anche il nome di Stefano Scarafoni. Romano, classe 1961, all’epoca
giudice al Tribunale di Tolmezzo, Scarafoni doveva essersi iscritto giovanissimo
alla massoneria. Oggi è in servizio come magistrato fra i più attivi alla
sezione fallimentare del Tribunale di Tivoli.
SERGIO Ferdinando – Il suo
nome – al pari di quelli dei colleghi Domenico Pone, Guido Romano e Paolo Tonini
– venne fuori in una lettera sequestrata nella villa di Licio Gelli in Uruguay.
Dalla missiva emergeva che il venerabile avrebbe finanziato con 25 milioni di
vecchie lire la campagna elettorale di quei quattro magistrati, quando nel ‘77
erano stati eletti ai vertici della ANM.
SERIANNI Vincenzo – Originario
di Motta Santa Lucia, in provincia di Catanzaro, fino al 2001 è stato presidente
di Corte d’Appello a Milano. Presente negli elenchi del ‘92 (quando presiedeva
una sezione giudicante al Tribunale di Torino), l’anziano magistrato calabrese,
classe 1929, risiede da anni nella zona di Casale Monferrato, dove frequenta il
locale Rotary e presiede la Giunta esecutiva alla Camera di Commercio.
SPINA Antonio – Ad aprile ‘95
il CSM gli commina la sanzione disciplinare per l’affiliazione alla massoneria,
venuta alla luce con gli elenchi del ‘92, mentre Spina esercitava la funzione di
pretore a Sciacca, in Sicilia. Attualmente non risulta presente nei ranghi della
magistratura.
TONINI Paolo – Il nome di
Tonini era compreso nella lista dei magistrati trovata nella villa sudamericana
di Gelli (vedi Ferdinando Sergio). Da tempo Tonini è passato nei ranghi
accademici come docente di diritto processuale penale, che insegna
all’Università di Firenze. In tale veste organizza incontri patrocinati dal CSM
per la formazione e il tirocinio delle nuove leve in magistratura.
TRAPANESE Mario – A lungo
presidente di sezione al Tribunale di Ancona, dopo il ritrovamento del suo nome
negli elenchi del ‘92 fu deferito – insieme ai colleghi-confratelli – alla
sezione disciplinare del CSM dall’allora ministro Conso. Origini napoletane,
l’anziano magistrato si dedica oggi, sempre ad Ancona, a sostenere le sorti di
un’associazione benefica, la Lega del Filo d’Oro.
VELLA Angelo – Ha fatto epoca,
nel 1990, la decisione di Palazzo dei Marescialli, che aveva bloccato la
promozione di Vella a presidente di sezione del Tribunale felsineo per la sua
dichiarata appartenenza alla massoneria. Un parere che scatenò le ire di
Francesco Cossiga. Nel 1974 il giudice Vella si era occupato della strage
dell’Italicus. In anni più recenti, almeno fino al 2001, è stato membro della
Corte di Cassazione.
VITALI Massimo – Era sostituto
procuratore a Brescia ai tempi della strage di Piazza della Loggia e proprio a
lui, insieme ad altri due colleghi, furono affidate le indagini su una tragica
vicenda della quale ancor oggi si cerca una verità. La affiliazione di Vitali
alla Massoneria verrà alla luce solo con gli elenchi del ‘92. Cosa fa ora?
Classe 1946, originario di Grosseto, Vitali è in servizio. Sempre a Brescia.
Come consigliere di Corte d’Appello.
Una annotazione finale: diamo
per scontato che tutti i magistrati qui elencati e le centinaia di colleghi
iscritti alla massoneria svolgano il loro lavoro con diligenza e
professionalità. Quello che il cittadino (vittima, imputato, parte offesa,
imprenditore a rischio fallimento) ha il diritto di sapere è che restano legati
fino alla morte a quel giuramento. Che la massoneria non è un gioco di società
dal quale si esce a piacimento. E che violare quel patto ha significato, per
molti, perdere la vita.
Premesso che appartenere alla massoneria non è
sgradevole ed affermare ciò riferito ad una persona non è diffamatorio, con la
presente rettifica ci accingiamo a soddisfare la pretesa dell’istante.
Correzione dalla Voce delle Voci dell’articolo su
magistrati e massoneria. Dalla Voce delle Voci in edicola.
C’è un caso di omonimia nella nostra inchiesta di
gennaio 2010 sui “Magistrati Massoni”. A seguito della lettera che qui di
seguito pubblichiamo integralmente, precisiamo che il dottor Guido Romano,
attualmente consigliere di Stato e già presidente di sezione al Tar della
Calabria, NON E’ l’omonimo magistrato ordinario Guido Romano il cui nome fu
ritrovato, insieme a quelli di altri magistrati, fra le carte sequestrate nella
villa di Licio Gelli in Uruguay. Il dottor Guido Romano consigliere di Stato,
residente a Roma, non ha mai fatto parte della massoneria ne’, come ipotizzavamo
nell’articolo, e’ mai passato dai ranghi della magistratura ordinaria a quelli
della magistratura amministrativa, dal momento che ha prestato servizio sempre e
solo nella magistratura amministrativa. Ce
ne scusiamo col diretto interessato, pregando i colleghi dei siti internet che
avessero ripreso il nostro articolo di apportare al più presto – come già
abbiamo fatto noi – la correzione e la rettifica.
Oggetto: richiesta di smentita ai sensi e per gli
effetti della legge n. 47 del 8 febbraio 1948, nel testo vigente.
Lo scrivente Guido Romano, nato ad Aversa
(Caserta) l’11 luglio 1945 e residente a Roma, via Nepi n. 28, nominato Giudice
Amministrativo nel settembre 1984, quale vincitore di pubblico concorso, ha
svolto le relative funzioni nei TT.AA.RR. della Lombardia, sede di Brescia,
dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, della Campania, sede di Napoli, del Lazio,
sede di Roma, e della Calabria, sede di Catanzaro, nonchè dal settembre 2007
presso il Consiglio di Stato ove tuttora esercita le funzioni giurisdizionali.
Esso scrivente è venuto a conoscenza che nel n,1 dell’anno 2010 della versione
cartacea del mensile “La Voce delle Voci” appare, in copertina, a lettere
cubitali, il titolo “Magistrati Massoni” ed all’interno e’ inserito articolo a
firma del condirettore Rita Pennarola nel quale vengono elencati, in ordine
alfabetico, i nomi di magistrati che, per affermazione dell’articolista,
sarebbero affiliati alla massoneria. In detto articolo è inserito il nome di
“Romano Guido” che, essendo immediatamente seguito dalla precisazione “… è
Presidente del Tar della Calabria…”, non può che riferirsi alla persona dello
scrivente, tenuto conto che in tale sede giudiziaria amministrativa lo stesso
scrivente ha prestato servizio per circa due anni, esercitando la funzione di
Presidente della Seconda Sezione (e non anche di Presidente dell’intero TAR,
come invece è affermato nell’articolo) e che nella storia del TAR Calabro nessun
altro magistrato amministrativo, avente nome e cognome identico allo scrivente,
vi ha mai prestato servizio fino ad oggi. Peraltro, tale oggettivo, quanto
falso, riferimento alla persona dello scrivente ha trovato conferma anche nel
fatto che numerosi colleghi, amici e conoscenti, specialmente nelle Regioni
Campania e Calabria, hanno immediatamente manifestato allarme, incredulità e
stupore per la notizia appresa nella lettura dell’articolo in questione,
pubblicato anche sul sito Internet della “Voce delle Voci” e ripreso da altri
siti Internet quali, per quel che allo stato consta, “Facebook” e “Terracina
Social Forum”.
Ciò premesso, lo scrivente precisa al riguardo,
innanzi tutto, che:
1) non è stato mai affiliato alla massoneria (ne’
coperta ne’ scoperta) e non lo è tuttora:
2) non ha mai fatto parte della Magistratura
Ordinaria, ma soltanto della (distinta e autonoma) Magistratura Amministrativa,
nei cui ruoli è iscritto dal 1984 a seguito di pubblico concorso;
3) ha esercitato dal 1968 l’attività di
“praticante procuratore legale”, prima di accedere, dal 16 gennaio 1972, sempre
a seguito di pubblico concorso, al ruolo dei “funzionari direttivi” del
Ministero della Pubblica Istruzione, dal quale è, poi, transitato nella
magistratura amministrativa (TAR).
Contesta, conseguentemente, ad ogni effetto di
legge, che il riferimento alla propria persona, così come operato nell’articolo
in questione, quale iscritto nell’elenco dei magistrati massoni, e’ certamente
falsa ed è frutto del comportamento del tutto poco accorto e non diligente
dell’autore dell’articolo predetto, tenuto conto che l’autrice non si è
preoccupata, evidentemente, di operare alcuna verifica degli elementi
utilizzati.
Infatti sarebbe stato sufficiente verificare se il
nominativo “Guido Romano” – che si afferma nello stesso articolo essere
contenuto, come gli altri nominativi di magistrati, negli “… unii elenchi
(comprensivi delle logge coperte) che siano mai venuti alla luce: quelli
sequestrati nel ’92 dall’allora Procuratore Capo di Palmi Agostino Cordova…” –
fosse l’unico esistente nei distinti ruoli delle varie Magistrature, per cui non
poteva non essere quello del magistrato amministrativo individuato nell’articolo
in questione come “…Presidente del TAR della Calabria…”, ovvero esistesse nel
1977 (data riportata nella lettera ritrovata nella villa uruguaiana di Licio
Gelli e riferita al presunto finanziamento per l’elezione della A.N.M.) e nello
stesso 1992 (data di redazione dei citati elenchi Cordova) altro magistrato
ordinario con lo stesso nome e cognome; sarebbe stato sufficiente, altresì,
ricorrere a nozioni di comune conoscenza quale la notoria distinzione dei
magistrati amministrativi del TAR (quale lo scrivente dal 1984 e nel 1992) dai
magistrati ordinari (civili e penali), amministrati da distinti organi di
autogoverno (C.P.G.A. per i giudici amministrativi e C.S.M. per i magistrati
ordinari). Inoltre, l’autrice dell’articolo non si è evidentemente preoccupata
neppure di leggere il contenuto complessivo del proprio scritto poichè,
diversamente, si sarebbe resa conto che il riferimento operato alla mia persona,
attraverso lo specifico e qualificante richiamo alle funzioni di “…Presidente
del TAR della Calabria…” contraddiceva, in maniera del tutto oggettiva, le altre
notizie ed affermazioni contenute nello stesso articolo e cioe’, sia il
successivo riferimento, operato sempre nello stesso contesto descrittivo della
mia persona, al fatto che “… la decisione dell’allora Guardasigilli Giovanni
Conso di deferire al CSM i magistrati massoni, fra i quali Romano, fu aspramente
criticata dal gran maestro Eraldo Ghinoi…”, essendo notoriamente competente il
predetto Guardasigilli soltanto per i magistrati ordinari, e non anche per
quelli amministrativi, diversamente governati dal citato apposito organo di
autonomia, sia l’affermazione, questa volta operata nel contesto del profilo
descrittivo di altro magistrato ordinario citato dallo stesso articolista
nell’elenco (Sergio Ferdinando), che quest’ultimo, “… al pari di quelli dei
colleghi Domenico Pone, Guido Romano e Paolo Tonini… (omissis) … venne fuori in
una lettera sequestrata nella villa di Licio Gelli in Uruguay. Dalla missiva
emergeva che il venerabile avrebbe finanziato con 25 milioni di vecchie lire la
campagna elettorale di quei quattro magistrati quando nel ’77 erano stati eletti
ai vertici dell’ANM…”.
E’ evidente, in sintesi, che nel 1977 lo
scrivente, in quanto funzionario direttivo dei ruoli del Ministero della
Pubblica Istruzione, non apparteneva (come non ha mai appartenuto) alla
magistratura ordinaria e, quindi, non poteva ne’ candidarsi, ne’ essere eletto
nel direttivo dell’Associazione Nazionale Magistrati, del quale ha, invece,
fatto parte l’omonimo “… magistrato ordinario Guido Romano”, citato nella
lettera ritrovata nella villa di Gelli in Uruguay ed inserito negli elenchi “…
sequestrati nel ’92 dall’allora Procuratore Capo di Palmi Agostino Cordova”.
Orbene, per tutto quanti sin qui precisato, lo
scrivente chiede che venga, immediatamente, effettuata puntuale ed adeguata
smentita – con le modalità prescritte dall’art. 8 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47, nel testo vigente – della notizia contenuta nell’articolo di stampa in
questione, concernente la mia persona, con la quale dovrà essere chiarito, con
tutte le necessarie puntualizzazioni e senza alcuna possibilità di equivoco, che
il nome del magistrato Guido Romano che appare nell’elenco riportato in detto
articolo (pubblicato sia sul mensile cartaceo La Voce delle Voci n. 1 del 2010 e
sia sul corrispondente sito Internet www.lavocedellevoci.it) non e’ in alcun
modo riferibile al dottor Guido Romano, nato ad Aversa l’11 luglio 1945 e
residente a Roma, via Nepi n. 28, già Presidente della Seconda Sezione del TAR
Calabria ed attuale Consigliere di Stato, trattandosi all’evidenza di caso di
mera omonimia con altro magistrato ordinario.
Alla rettifica, così come impone la citata norma
di legge, dovrà essere dato il dovuto risalto. Attraverso collocazione,
caratteri e dimensioni grafiche eguali a quelli utilizzati per la redazione
dell’articolo in questione, e dovrà essere pubblicata non soltanto nel numero
cartaceo del mensile La Voce delle Voci di febbraio 2010, ma anche, ed
immediatamente, sul sito Internet sopra indicato, con speciale avvertenza degli
effetti della citata legge, risultando esso, allo stato, certamente ripreso,
come già segnalato più innanzi, da altri siti Internet quali “Facebook” e
“Terracina Social Forum”. Lo scrivente, infine, resta in attesa di un pronto
riscontro che assicuri l’immediata pubblicazione della rettifica richiesta,
salvo e riservato ogni altro diritto ed azione a tutela della propria dignità ed
onorabilità. Guido Romano.
Diffamazione, chiude “la Voce delle
Voci”. Ma scatta indagine sul giudice che l’ha condannata. Nel
2008 i giornalisti del mensile campano scrivono un articolo sull'insegnante di
Di Pietro Junior, poi diventata coordinatrice dell'Idv. Nel 2013 vengono
condannati in primo grado a un maxi risarcimento che costringe la testata a
chiudere dopo 30 anni. Inutili gli appelli al Quirinale (che salvò Sallusti). I
giornalisti però nel 2014 denunciano il giudice che li ha condannati, ora
indagato per abuso d'ufficio ed omissione di atti d’ufficio ai loro danni. La
decisione del Gip a giorni. E il caso rilancia il tema della censura
dell'informazione attraverso il ricatto economico, scrive Thomas Mackinson il
14 luglio 2015 su “Il Fatto Quotidiano”. In Parlamento torna una gran voglia di
“legge bavaglio”, pochi però si preoccupano delle manette che bloccano le
rotative della libera informazione. Brandendo come una clava l’istituto della
diffamazione. A farne le spese, in ultimo, è il mensile campano
“la Voce delle Voci” che è in edicola da trent’anni e si è fatto largo
nel panorama delle notizie con inchieste scomode su vari fronti, dalle
infiltrazioni della camorra negli uffici pubblici ai fatti di corruzione e fino
al coinvolgimento di logge massoniche in affari poco chiari. La storia è
ingarbugliata ma emblematica. Al cuore di tutto c’è una
sentenza emessa a
marzo 2013 dal Tribunale di
Sulmona che ha
imposto un risarcimento danni di 69 mila euro (più gli interessi) a favore
dell’attuale coordinatrice dell’IdV del capoluogo abruzzese,
Annita Zinni. La Zinni voleva avere soddisfazione per un
articolo scritto nel 2008 e successivamente parzialmente rettificato, che
riguardava il suo ruolo per la formazione del figlio
di Antonio di Pietro, Cristiano. La condanna emessa cinque anni
dopo ha avuto conseguenze catastrofiche per il giornale, ridotto sul lastrico:
per riscuotere la somma i legali della signora Zinni hanno pignorato i conti
personali dei giornalisti e anche i contributi dello Stato, pari a 21mila euro,
che la cooperativa editrice doveva ancora riscuotere. Il legale della Voce,
l’avvocato Michele
Bonetti, si era opposto affermando che quelli sequestrati sono
fondi pubblici che lo Stato eroga per garantire un bene comune prezioso: il
diritto ad essere informati andando oltre ciò che diffondono le veline dei
Palazzi. Niente da fare. E alla fine è stata pignorata anche
la testata giornalistica, costringendo il mensile a sospendere le pubblicazioni.
Ma c’è di più. I giornalisti, in attesa che si celebri l’appello all’Aquila,
hanno sporto denuncia contro Massimo
Marasca, il magistrato di Sulmona che il 25 marzo 2013 ha
pronunciato la sentenza di morte del mensile. Alla Procura generale della
Cassazione, al ministero della Giustizia, al Csm e alla Procura di Campobasso
hanno denunciato l’inerzia investigativa degli uffici giudiziari che fanno capo
al magistrato sul cui tavolo era finita la vicenda Zinni. Marasca è ora indagato
per abuso
d’ufficio ed
omissione di atti d’ufficio ai danni dei giornalisti Andrea
Cinquegrani e Rita
Pennarola. Tocca ora a un giudice del Tribunale di Campobasso, Maria
Rosaria Rinaldi, il delicato compito di pronunciarsi sulla
condotta di un collega e stabilire se le indagini a suo carico debbano
proseguire. Al termine della camera di consiglio del 7 luglio scorso, il Gip ha
rinviato la decisione ai prossimi giorni. Così l’esistenza del mensile resta
appesa a un filo, nel silenzio generale. Poche infatti sono le voci che si sono
levate per rilevare l’evidente “sproporzione” tra l’errore contestato ai
giornalisti, le dimensioni della testata, la capacità economica dei condannati
la condanna a morte della loro testata. Non ha prodotto i frutti sperati, ad
esempio, il tentativo di interessare della vicenda Giorgio
Napolitano, all’epoca Presidente della Repubblica e del
Consiglio superiore della Magistratura, l’organo competente a valutare le
condotte dei singoli magistrati”. Al Capo dello Stato si erano rivolti i
giornalisti de la Voce delle Voci il
22 aprile 2014. Con una lettera gli chiedevano di correggere gli effetti di una
sentenza abnorme che determinava la cessazione delle pubblicazioni della
testata. Infondo, avranno pensato, Napolitano si era dimostrato attento al
delicato rapporto tra stampa e giustizia: non erano passati due anni da ché
aveva commutato il carcere in sanzione pecuniaria per Sallusti.
Ma Napolitano non rispose mai direttamente. Lo fece il direttore dell’Ufficio
per gli Affari dell’Amministrazione della Giustizia del Quirinale, Ernesto
Lupo: “Pur nella migliore comprensione, non rientra tra le
attribuzioni costituzionali del Capo dello Stato l’intervento su questioni
appartenenti alla competenza dell’autorità giudiziaria”. L’esposto finì sul
tavolo del Csm, e lì è rimasto. A tenere viva l’attenzione sul caso, invece, è
l’Osservatorio “Ossigeno per
l’Informazione”, promosso dalla Federazione Nazionale della
Stampa e dall’Ordine dei giornalisti per monitorare casi di censura e minaccia a
danni dei giornalisti. “Attendiamo con vivo interesse la decisione del gip” ha
dichiarato il direttore Alberto
Spampinato. “L’iter di questo processo – aggiunge – dimostra in
modo plateale che le norme vigenti in Italia in materia di diffamazione a mezzo
stampa consentono punizioni e censure che vanno ben oltre la previsione della
pena detentiva e che non hanno nulla a che vedere con la difesa della
reputazione personale. Ci dice poi che queste norme consentono di fare sparire
un giornale dalle edicole e di ridurre sul lastrico chi è ritenuto colpevole di
aver sbagliato. Il nostro interesse al caso della Voce delle voci è
accresciuto dall’emergere dell’ipotesi di condotta scorretta del giudice che ha
pronunciato siffatta sentenza. Penso perciò che il giudice per le indagini
preliminari di Campobasso abbia fatto bene a riservarsi la decisione che deve
dimostrare che la magistratura è capace di indagare sulla correttezza dei suoi
stessi membri e di giudicare i loro comportamenti con la stessa severità con cui
giudica quelli degli altri cittadini. Egregio giudice, faccia con calma, prenda
il tempo che le serve per fare la cosa giusta”. Infine il messaggio
a Parlamento e
Governo: “Se la magistratura deve impedire le conseguenze ultronee delle sue
sentenze, Parlamento e Governo devono correggere senza ulteriori indugi le norme
sulla diffamazione che tuttora prevedono il carcere per i giornalisti per
evitare che esse limitino il diritto di informare e di essere informati. Se un
giornalista e il suo giornale devono mettere in palio tutto ciò possiedono, e
anche la possibilità di proseguire la loro attività, ogni volta che pubblicano
una notizia controversa, in questo paese non c’è più spazio per l’informazione
giornalistica”.
Basilicata: magistrati e
avvocati massoni?
Si chiede Franco Venerabile su Indipendente Lucano riportato da “Karakteria”.
Non ci sarebbe nulla di male, sia beninteso. Lo stesso presidente Napolitano usa
esprimere familiari auguri e sentimenti cordiali al Gran Maestro di turno. Ma
sarebbe utile capire, avere qualche risposta a questioni che aleggiano da alcuni
anni. Almeno dal 2007, da quando, in una telefonata intercettata tra un
giornalista di cui il PM Annunziata Cazzetta ed il Gip Angelo Onorati erano
all'affannosa ricerca delle fonti, qualcuno disse che Vincenzo Autera
(magistrato della Corte d'Appello di Potenza) ed Emilio Nicola Buccico (avvocato
materano) erano in forza ad una loggia estera. La fonte, in quel caso, era un
appartenente alla Massoneria noto per questa sua legittima adesione, ma nessuno
ritenne di approfondire la questione e tutto rimase in un nastro ed in qualche
foglio di trascrizione. Sembra che solo a nominarla, la Massoneria crei
imbarazzo. Poi, molto poi, si accertò che tutte quelle intercettazioni, Cazzetta
ed Onorati le avevano disposte e tenute illecitamente e nel giugno 2012 un
giudice stabilì di trasferire il procedimento a Catanzaro. Anche lì, Vincenzo
Autera aveva un precedente: indagato per associazione mafiosa dal 2007 al 2009
(ma l'iscrizione originaria, a Firenze, era del 2005), procedimento archiviato.
In quei quattro anni, nessuno aveva comunicato l'iscrizione di una ipotesi di
reato così grave alla Procura presso la Corte di Cassazione. Il che è
gravissimo, pare! Anche Cazzetta era ben nota a Catanzaro, alcune decine di
procedimenti la vedevano indagata per reati anche gravissimi. Quasi tutti
definiti con archiviazione, alcuni pendenti. Ma tutti senza alcuna attività
d'indagine, almeno tutti quelli tenuti dal PM Paolo Petrolo: più che un
magistrato inquirente si potrebbe definire un magistrato paragnosta. Tranne che
per l'identità degli indagati (se magistrati), che suole iscrivere
nell'imminenza della formulazione della richiesta di archiviazione, per il resto
i fascicoli appaiono scevri di qualsivoglia attività ma motivati da potenti
precognizioni. Significativo il caso in cui si accertò la mancanza di oltre
cento faldoni che, secondo il Gip, non avrebbero potuto contenere alcun elemento
utile a modificare la decisione di archiviare. Quasi che quegli atti d'indagine
che nessuno aveva potuto visionare fossero carta straccia. Che a Catanzaro la
preveggenza non sia una virtù, lo si scopre attraverso una recentissima
inchiesta della Procura di Salerno. "La 'ndrangheta non esiste più, fa parte
della massoneria. Abbiamo amicizie: medici, avvocati, politici, giudici,
commissari", la frase è di un noto boss della 'ndrangheta ed è intercettata
dalle microspie dei Carabinieri del ROS di Salerno. Il collante è proprio
l'appartenenza alla massoneria. Massone è anche il magistrato /Gip) Giancarlo
Bianchi che di favori, secondo la Procura di Salerno, ne distribuisce più d'uno.
E qui ritroviamo il PM Paolo Petrolo, parte de "l'ingranaggio" a disposizione
della 'ndrangheta. Un sistema di contatti, che ruota attorno al giudice Bianchi
e a due sostituti procuratori della Dda di Catanzaro: Giampaolo Boninsegna e
Paolo Petrolo. Per questi tre magistrati, il PM di Salerno aveva chiesto
l'interdizione: negata! Se fossero stati semplici poliziotti sarebbero stati
arrestati ma non tutti nascono col cappuccio. Resta un'ultima domanda, questa al
Dr. Paolo Petrolo: scusi, lei è massone?
Potenza, le accuse del
giudice: «Processi lenti, patti con avvocati».
Indagato il procuratore generale, scrive Carlo Vulpio su “Il Corriere della
Sera”. Qui non si parla di intercettazioni, o di racconti di «pentiti». Qui si
parla di magistrati che davanti al Csm e poi davanti a un altro magistrato
denunciano fatti che oggi riguardano la Basilicata, ma che domani (o già oggi,
com' è accaduto in Umbria) potrebbero toccare gran parte della magistratura
italiana e costringerla a «guardarsi dentro». Ma non allontaniamoci dalla
Basilicata, dove la domanda è: c' è o no un «comitato», una «cabina di regia»
che gestisce i processi e ne determina l'esito? Sì, secondo il gip di Potenza,
Rocco Pavese, le cui dichiarazioni hanno contribuito a fare iscrivere nel
registro degli indagati presso la procura di Catanzaro anche il procuratore
generale di Potenza, Vincenzo Tufano. Ecco come funzionerebbe il presunto
«comitato». «I magistrati della Dda - dice Pavese - devono essere addetti ai
procedimenti di mafia, lo dice il Csm, salvo eccezionali esigenze da motivare
caso per caso. A Potenza questo invece non avveniva. Numerosi fascicoli relativi
a reati di pubblica amministrazione o reati commessi da pubblici ufficiali, sono
sempre stati trattati, oltre che da altri magistrati, anche da Giuseppe Galante
e Felicia Genovese (capo e vicario della procura antimafia di Potenza, ndr)
spesso in co-delega. Insomma, quando si tratta di fare il lavoro duro,
ordinario, per esempio andare in applicazione a Lagonegro, si eccepiva questa
riserva a favore della Dda. Quando invece si trattava di fare procedimenti,
guarda caso sempre e sistematicamente di pubblica amministrazione, lì questa
riserva non veniva fatta valere». Il procuratore generale, Vincenzo Tufano,
sarebbe dovuto intervenire. Invece, «nemmeno un rilievo o un appunto». «Il pg
contro i magistrati» Secondo il gip Pavese, Tufano «in consonanza con una parte
dell' avvocatura, ha come bersaglio i magistrati che fanno il proprio dovere
senza guardare in faccia nessuno». Un esempio è il procedimento «Iena« (il primo
grosso procedimento in Basilicata che ha visto coinvolti numerosi politici,
ndr), che provocò «una serie di polemiche molto virulente, anche sulla stampa
locale, che si schierò pressoché unanimemente contro la magistratura e a favore
della classe politica. In realtà non è che la classe politica lucana era tutta
sotto accusa in quel procedimento. C'erano singole persone indagate: colletti
bianchi, imprenditori, delinquenti di strada e anche Renato Martorano, forse il
più importante esponente della mafia lucana, vicino alla 'ndrangheta, che ha una
condanna per associazione mafiosa passata in giudicato. Emergevano insomma
chiaramente collegamenti tra il Martorano e i suoi accoliti con questi colletti
bianchi e imprenditori». Il club degli avvocati Gli avvocati con i quali il
procuratore generale Tufano sarebbe «in consonanza», al punto da consigliarli
come difensori anche a imputati di gravi reati, sono gli stessi che hanno
prodotto un «libro bianco» contro i magistrati che Tufano non mancava di
«rampognare». Questo «club» tra avvocati e procuratore generale, «il quale più
volte, anche pubblicamente, ha preso le parti dei suoi amici avvocati contro
alcuni magistrati», ha poi portato alla nascita a Potenza, caso forse unico in
Italia, di una seconda Camera penale. Eppure, dice Pavese, «Tufano non ha mai
avuto nulla da ridire sulla spropositata durata dei dibattimenti collegiali,
com' è accaduto nel processo per mafia detto I Basilischi». Continua Pavese:
«Decine di persone arrestate ad aprile 1999, cinquanta rinvii a giudizio a marzo
2000 e un dibattimento che oggi non è ancora finito! Con danni erariali
gravissimi: spese di traduzione, verbalizzazione, videoconferenza, oneri per i
gratuiti patrocini e così via. E poi inevitabilmente, alla fine, a prescindere
dal merito processuale, ci saranno gli indennizzi per eccessiva durata del
processo ai sensi della legge Pinto. E questo è un problema che è sotto gli
occhi di tutti. Devo ritenere che faccia comodo. Il dottor Tufano, questo, non
lo ha mai rilevato». I brogli elettorali Un caso importante di cui si è occupato
il gip Rocco Pavese riguarda i brogli elettorali alle elezioni amministrative
del 2005, comunali e regionali, di Scanzano Jonico. In quella vicenda, ricorda
il gip, il pm era Felicia Genovese. Ci furono arresti, «ma non per quelli che
avevano attivamente preso parte alla designazione dei presidenti di seggio
compiacenti, nonostante le intercettazioni, che io ricordo bene, in cui era
coinvolto anche un cancelliere della corte di Appello di Potenza, e in cui si
diceva: "Nomina questo, nomina quell' altro", e si facevano nomi e cognomi.
Insomma, non ci fu richiesta cautelare a carico di coloro che avevano avuto un
ruolo importante in tutta la vicenda». E ancora: «Uno degli interlocutori era
proprio l' avvocato Labriola, che notoriamente è assai vicino, a Matera e in
tutta la Basilicata, all' avvocato Buccico, importante esponente di An. È chiaro
che io intesi questo fatto come un atto di riguardo nei confronti di un livello
politico amministrativo, del notabilato di un livello superiore che non era il
caso di toccare. Questo, senza volere fare illazioni, mi pare che sia proprio in
re ipsa». Non manca la massoneria deviata, che in Basilicata sembra aver messo
le zampe nelle vicende più oscure. «A giudicare da come funzionano giustizia e
amministrazione della politica - sostiene Pavese - sembra che chi ha degli
agganci riesce a risolvere i propri problemi, chi non li ha, pur avendo ragione
da vendere, non li risolve. Si potrebbe dire che la vicenda "Iena" è uno dei
casi in cui questi legami, amicizie, vicinanze, si sono poi estrinsecate in
condotte concrete, perché ci fu all' unisono una reazione della stampa contro la
magistratura che procedeva, sia inquirente sia giudicante». Il caso di Elisa
Claps. Quando in Basilicata si parla di legami massonici, si parla di '
ndrangheta e di almeno di una decina di omicidi insoluti negli ultimi vent'
anni. Tra i quali, la misteriosa scomparsa, nel 1993, della studentessa
sedicenne Elisa Claps. Del caso Claps si occupò anche il pm Genovese, cioè la
moglie di Michele Cannizzaro. Questi, poi diventato direttore generale dell'
ospedale di Potenza, era stato sospettato di aver aiutato a «coprire» Danilo
Restivo, il giovane accusato di aver fatto sparire Elisa. Al di là dei tanti
altri buchi neri di quella scomparsa, il gip Pavese si sofferma su un punto in
particolare: l' insistenza del pm Genovese di imputare Danilo Restivo, nei cui
confronti l' accusa di omicidio venne archiviata, per false dichiarazioni rese
al pm. Così il presunto omicida sarebbe diventato un presunto falso testimone.
Una vicenda che fa dire a Pavese: «È assolutamente non condivisibile che colui
che è il principale sospettato di essere l' autore dei reati nella scomparsa
della ragazza venga ad essere imputato di false dichiarazioni al pm. Questa è
una cosa concettualmente incompatibile con la partecipazione, o meglio, con gli
indizi di partecipazione al reato principale. Perché se io dico una persona è
sospettata di aver commesso un reato, e ci sono degli indizi, va trattata quale
indagato, non lo si può sentire quale informatore». Il pm Genovese sembrava
anche molto attiva nell' archiviare denunce per reati contro la pubblica
amministrazione. «A me sono capitate quasi tutte le richieste di archiviazione
del pm Genovese - dice Pavese -. Ne ricordo una per un procedimento contro
Filippo Bubbico (Ds), presidente della giunta regionale, per una questione di
finanziamenti a un Comune. Una per Antonino Imbesi (FI), consigliere comunale a
Potenza, in questo caso pm era anche Galante. Per Roberto Schettini, capo dell'
Ufficio tecnico di Tramutola, in provincia di Potenza, ci furono varie richieste
di archiviazione per abusi edilizi, che io non accolsi, e sfociarono in un'
imputazione coattiva da parte mia. Il pm era ancora la Genovese. E ancora, una
richiesta di archiviazione per quattro vigili urbani di Potenza accusati di
falso per non aver fotografato una costruzione abusiva. Anche in questo caso, io
non ho accolto la richiesta di archiviazione e ho formulato l' imputazione
coattiva». Un altro esempio è il processo a carico della giunta regionale per il
siluramento del direttore generale della Asl di Venosa, Giuseppe Panio,
sostituito da Giancarlo Vainieri, «sponsorizzato» da Bubbico e Vito De Filippo
(Margherita), cioè l' ex «governatore» e quello in carica. «Le richieste di
archiviazione proposte dal tandem Galante-Genovese non sono state accolte». Le
archiviazioni del procuratore Infine, il caso del «pentito» Gennaro Cappiello.
«Esemplare», dice Pavese. Cappiello accusa Cannizzaro di essere il mandante del
duplice omicidio dei coniugi Gianfredi-Santarsiero (avvenuto nel 1997) e poi
viene arrestato (nel 2004) con l' accusa di essere lui l' omicida. Cannizzaro
nel ' 99 aveva denunciato per calunnia Cappiello, che aveva da poco cominciato a
collaborare con la giustizia. «Eppure questo procedimento per calunnia rimase a
carico di persona non identificata - dice Pavese -. Una cosa molto strana,
perché di Cappiello Gennaro che collabora con l'autorità giudiziaria, non solo a
Potenza ma in tutta Italia, ce n'è uno solo. Invece Cappiello fu identificato
soltanto alla fine di giugno 2004». Cioè solo quando venne arrestato. Ci sarebbe
anche Galante, che dopo questo terremoto ha preferito lasciare il posto di capo
della procura di Potenza. Per lui, le parole di Pavese suonano come un
epitaffio. «Il suo lavoro era prevalentemente quello di archiviazione contro
ignoti». La studentessa sedicenne Elisa Clapsscomparve misteriosamente a Potenza
il 12 settembre del 1993. Non venne mai più ritrovata Del caso Claps, tuttora
insoluto, si occupò anche il pm Felicia Genovese. Il marito della Genovese,
Michele Cannizzaro, venne sospettato di aver aiutato a «coprire» Danilo Restivo,
il giovane accusato di aver fatto sparire Elisa, con la quale aveva appuntamento
il giorno della scomparsa. Secondo il gip Rocco Pavese sarebbe sospetta l'
insistenza del pm Genovese di imputare Danilo Restivo per false dichiarazioni,
trasformando così il presunto omicida in un presunto falso testimone.
Il presidente del Tar? E'
un massone. L'incredibile nomina in Calabria.
Il nuovo presidente del tribunale amministrativo regionale, Guido Salemi, è
stato iscritto per anni a una loggia. E, nonostante la legge vieti espressamente
a un magistrato di indossare il "grembiulino", la promozione è arrivata lo
stesso, scrive Emiliano Fittipaldi su “L’Espresso”. Nella Regione
a maggior densità massonica d’Italia era logico che, come nuovo presidente del
Tar, fosse nominato un massone. Sembra una battuta, ma non è così: a capo del
Tar della Calabria c’è ora un massone “in sonno”. Guido Salemi, ex consigliere
di Stato, è stato iscritto per anni alla loggia “Giustizia e Libertà” facente
parte del Grande Oriente d’Italia. Nel 1996 contro di lui fu aperto pure un
procedimento disciplinare, visto che - nonostante per un magistrato esista il
divieto di indossare grembiuli - aveva mantenuto l’iscrizione fino al 1994. Alla
fine il procedimento fu archiviato, perché la condotta di Salemi fu considerata
«in buona fede». L’affiliazione del magistrato era stata scoperta nel 1992
dall’allora pm Agostino Cordova, che in un’inchiesta choc individuò una
quarantina di togati iscritti a logge coperte e non. Ma il passato massonico di
Salemi è stato tirato fuori anche dal giudice Alessio Liberati, che tre anni fa
denunciò pubblicamente Salemi e un altro consigliere di Stato: Filoreto
D’Agostino, finito in un elenco massonico. Come Salemi, anche D’Agostino ha
fatto carriera: nel 2011 è diventato presidente del Tar Sicilia. Massoni in
sonno, ma svegli a cogliere le occasioni.
Giudici amministrativi:
ancora scandali legati alla massoneria,
scrive Alessio Liberati (magistrato) su “Il Fatto Quotidiano”. Ho da poco
scritto un post sulle infiltrazioni massoniche occulte nella giustizia
amministrativa che mi tocca già scriverne un aggiornamento. Questa volta la
notizia è che un magistrato del TAR Palermo avrebbe (il condizionale è
d’obbligo) addirittura dettato i ricorsi per far vincere le cause ad alcune
parti. Nicolò Marino, assessore all’Energia ed ex magistrato, avrebbe in
proposito affermato che il commissario Ferdinando Buceti era troppo “scomodo” e
che un magistrato del Tar di Palermo, iscritto alla massoneria avrebbe suggerito
alla società ricorrente il testo “vincente” per eliminarne la nomina. Quello che
avrebbe avuto maggiori chance di essere accolto. E il ricorso, effettivamente, è
stato accolto, bloccando i commissariamenti. E costringendo l’assessore a
produrre una nuova direttiva. Il magistrato in questione risulterebbe iscritto
(almeno sino al febbraio 2013) alla massoneria, sempre Marino. Una decisione,
quella del Tar, sempre secondo Marino, dagli effetti devastanti, visto che
avrebbe determinato un vuoto totale nella gestione del Servizio idrico integrato
in tutto il territorio siciliano. Sono state preannunciate anche le dovute
segnalazioni al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa (CPGA,
cioè il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa). È doveroso
allora ricordare che già in passato io stesso chiesi al CPGA di accertare
presunte appartenenze massoniche di alcuni magistrati del Consiglio di Stato,
ricevendo per tutta risposta la proposta di un procedimento disciplinare … a mio
carico! Nulla invece ai massoni (dichiaratisi in sonno) accertati effettivamente
tali, uno dei quali addirittura promosso Presidente di TAR. Di certo tale
decisione “disciplinare” (proposta dalla commissione allora presieduta dal prof.
Nicolò Zanon, cioè lo stesso membro del CSM attuale che ha redatto il parere pro
veritate contrario alla decadenza di Berlusconi e contestualmente ha chiesto
l’apertura di una pratica contro il giudice Esposito, presidente del collegio
che ha preso la decisione sul caso Mediaset) non è davvero un incentivo per i
magistrati a denunciare appartenenze massoniche (che sono vietate per i
giudici). Personalmente condivido le preoccupazioni del gran maestro del Grande
Oriente Democratico, ven. Gioele Magaldi, circa il rischio di compressione della
libertà di associazione (contro la massoneria), ma va anche detto che, come lo
stesso GOD denuncia, le deviazioni dall’ethos massonico sembrano essere davvero
troppe. Non a caso si sente parlare di massoneria, relativamente ai giudici TAR,
solo con riferimento a scandali più o meno gravi. Speriamo allora che il nuovo
CPGA, nel quale sono stati eletti proprio ieri i membri laici (tra cui la moglie
del prof. Zanon, la prof.ssa Maria Elisa D’Amico) cambi orientamento in tema di
massoneria e sanzioni duramente la violazione del divieto di appartenenza e la
mancata dichiarazione di tale status di massone in sonno.
Affari sull'acqua, Marino
accusa: "Un magistrato massone dettava i ricorsi", scrive Accursio Sabella su
“Live Sicilia”. L'assessore all'Energia racconta una vicenda che ha
dell'incredibile: "Un giudice del Tar di Palermo, iscritto alla Massoneria, ha
suggerito alla Sai 8, società che gestisce il servizio idrico in provincia di
Siracusa, il testo del ricorso col quale allontanare un commissario scomodo".
Un magistrato massone. Che ha
suggerito a una società come vincere un ricorso. L'accusa ha del clamoroso. E a
lanciarla è Nicolò Marino, assessore all'Energia e sopratutto ex magistrato. Il
teatro dell'incredibile scontro di poteri è l'Ato idrico di Siracusa, dove una
società ha avanzato ricorso contro il commissariamento dell'Ambito territoriale
deciso dalla Regione. Lì, a Siracusa, secondo Marino, il commissario Ferdinando
Buceti era troppo scomodo. E un magistrato del Tar di Palermo, iscritto alla
massoneria avrebbe suggerito alla società ricorrente il testo “vincente”. Quello
che avrebbe avuto maggiori chance di essere accolto. E il ricorso,
effettivamente, è stato accolto, bloccando i commissariamenti. E costringendo
l'assessore a produrre una nuova direttiva. “Sono stato costretto – racconta
Marino - lo scorso 11 settembre a reiterare la direttiva concernente la nomina
dei Commissari liquidatori degli Ato idrici in Sicilia, eliminati in pochi
minuti da un intervento adottato da un magistrato del Tar di Palermo che in
questa sede ometto di indicare. Il magistrato in questione, - prosegue Marnio -
come riscontro dalla relazione redatta dai legali dell’amministrazione Ato
idrico di Siracusa, risulta avere suggerito alla parte privata, la Società Sai 8
che gestisce il servizio idrico in quella provincia, il percorso giuridico da
seguire al fine di bloccare l’operatività del Commissario dell’Ato idrico
aretuseo. Così, - va avanti l'incredibile racconto dell'assessore - in pochi
minuti, i difensori della citata società, a penna, hanno predisposto e
immediatamente presentato il ricorso secondo le indicazioni ricevute dal
giudice, ricorso naturalmente accolto”. Una decisione, quella del Tar, spiega
Marino, dagli effetti devastanti, visto che ha determinato “un vuoto totale
nella gestione del Servizio idrico integrato in tutto il territorio siciliano”.
Circa la condotta del magistrato – affonda Marino - saranno effettuate le dovute
segnalazioni al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa. Il
magistrato in questione risulta iscritto (almeno sino al febbraio 2013) alla
massoneria; pur potendo ciascun cittadino della Repubblica autodeterminarsi
liberamente, ritengo da uomo delle istituzioni che un appartenente alla
magistratura non possa prestare due giuramenti, uno per la Repubblica italiana
altro per diverse entità. Giova ricordare – aggiunge Marino - che le vicende
della Società SAI 8 si inseriscono in un complesso contesto giudiziario e
amministrativo, caratterizzato da plurime segnalazioni effettuate dal
Commissario liquidatore dell’Ato idrico di Siracusa, Ferdinando Buceti, presso
svariate sedi giudiziarie”. Denunce che avrebbero spinto, sempre secondo il
racconto dell'assessore, la Sai 8 a trovare “un sistema” per allontanare quel
commissario. “Di recente – spiega Marino - la Procura della repubblica di
Siracusa ha già chiesto il rinvio a giudizio dei vertici della predetta società,
penalmente responsabili, secondo le operate contestazioni, di gravissimi fatti
di reato ambientali e di frode nelle pubbliche forniture, nell’ambito della
gestione del servizio. Lo stesso Ufficio di Procura ed il citato commissario
dell’ Ato hanno, inoltre, proposto istanza di fallimento della Società Sai 8,
alla quale è stata ritirata la concessione”. Il Cga inoltre, ricorda Marino, il
30 marzo del 2011 avava già “affermato che l’affidamento del servizio in favore
di Sai 8 era in palese contrasto con l’interesse pubblico e, pertanto non doveva
essere stipulata la relativa convenzione”. E non finisce qua. Marino denuncia
anche una “posizione di favore” nei confronti della Sai, da parte della Banca
Intesa San Paolo: “Il Commissario liquidatore dell’Ato idrico di Siracusa –
attacca Marino - ha chiesto alla Banca Intesa San Paolo, garante della Società
Sai 8, a fronte delle innumerevoli inadempienze contrattuali di quest’ultima, la
restituzione della cauzione (polizza fideiussoria) pari a tre milioni di euro,
richiesta correttamente formulata. La banca, con un comportamento
inqualificabile sul piano dei rapporti bancari e qualificabile sul piano
giuridico – conclude Marino - come palese inadempimento, sta reiteratamente
omettendo di effettuare il pagamento”.
Questa la
replica dell'azienda Sai8 s.p.a in merito alle dichiarazioni dell'assessore
Marino:
"In merito alle dichiarazioni dell’assessore Nicolò Marino, apparse sulla
testata giornalistica La Sicilia in data odierna, Sai8 vuole nuovamente ribadire
quanto già precisato per l’articolo apparso sul sito web livesicilia.it e
sull’edizione di Siracusa del Giornale di Sicilia del 14.9.2013. Gli atti
compiuti dall’assessore Marino e le prime pronunce giurisdizionali intervenute
sugli stessi hanno qualificato, sino ad ieri, l’attuale titolare
dell’assessorato dell’energia e servizi di pubblica utilità come autore di una
serie di provvedimenti amministrativi viziati da gravi violazioni di legge, in
danno, tra l’altro, della nostra società. Le inqualificabili dichiarazioni
diffuse a mezzo stampa il 13 ed il 14 settembre, ove ne fosse confermata la
paternità, aggiungerebbero al quadro, già di per sé sconfortante, sinora emerso
un sovrappiù di inammissibile arroganza e di insofferenza rispetto al controllo
di legittimità esercitato dai Giudici amministrativi. Ci rendiamo conto che il
decreto presidenziale adottato dal TAR Sicilia lo scorso 5 settembre ha avuto
l’effetto – sicuramente devastante per la credibilità dell’azione di governo
dell’assessore, sinora sbandierata come pretesa azione di legalità – di rendere
evidenti, sia pure ancora solo in sede cautelare, le numerose e patenti
violazioni di norme costituzionali e di legge, che inficiano l’azione
amministrativa sinora svolta. Ci rendiamo anche conto che l’essere entrato a
gamba tesa nella gestione del S.I.I., tramite gli atti del dott. Buceti e
personalmente nel corso di una memorabile conferenza stampa a Siracusa,
convocata al dichiarato fine di smascherare presunte illegalità di SAI8 (il cui
accertamento non compete di certo all’assessore regionale), e l’essersi
ritrovato – proprio nel momento in cui è in discussione la conferma del proprio
incarico governativo – solo con l’accertamento di illegittimità proprie, può
sortire un effetto destabilizzante. Ci rendiamo conto, ancora, che la
restaurazione di un quadro di piena legittimità amministrativa non potrà che
coincidere con il pressoché completo azzeramento di un discutibile sistema di
gestione del Servizio Idrico Integrato in Sicilia, messo in piedi dall’assessore
Marino, in ostentato spregio alle norme di legge regolanti la materia. Ma pur
rendendoci conto di quanto sopra, non possiamo esimerci dal rilevare come la
mistificante e distorta prospettazione offerta a mezzo stampa dall’assessore:
a) ignori il
fatto che il ricorso, in relazione al quale il TAR Palermo ha interinalmente
accolto la domanda cautelare avanzata da Sai8, era stato notificato e
depositato, corredato da specifica domanda cautelare, quasi un mese prima della
camera di consiglio del 5 settembre;
b) taccia sul
fatto che, solo nell’approssimarsi della camera di consiglio, la difesa del
Consorzio, all’unico plausibile fine di determinare un rinvio nella trattazione
dell’istanza cautelare avanzata da Sai8, sollevava una strumentale ed infondata
eccezione di incompetenza, in quanto tale poi respinta dal TAR;
c) trascuri di
riferire come il decreto presidenziale rappresentasse, a quel punto, l’unico
strumento processuale invocabile da parte di Sai8 per evitare che le già da
tempo manifestate esigenze di tutela cautelare rimanessero del tutto disattese;
d) ometta di
riferire che l’intero iter procedurale si è svolto nel contraddittorio tra le
parti ed in particolare alla presenza della difesa del Consorzio ATO, in persona
di idoneo sostituto processuale del procuratore costituito, la quale non ha
ritenuto di nulla osservare od eccepire, salvo poi (a quanto risulterebbe dalle
dichiarazioni dell’assessore Marino) prodursi in inattendibili ricostruzioni e
relazioni, postume rispetto al negativo risultato professionale.
Pur nel
turbamento determinato da episodi quale quello registrato, Sai8 conferma la
propria piena fiducia nelle istituzioni, di cui si sente parte in quanto
investita di un pubblico servizio, e segnatamente nell’operato della
Magistratura, che – si confida – una volta ristabilita la verità dei fatti saprà
decidere e valutare serenamente, al riparo da ogni forma di indebito
condizionamento esterno e di velata intimidazione. L’unico intento della Società
rimane quello di poter fornire un servizio di qualità agli utenti della
provincia di Siracusa con il proposito di continuare a migliorarlo e per cui
continua a lavorare proficuamente. Difatti, la concessione è tutt’ora valida,
almeno fino a pronunciamenti giudiziari contrari. Sai8 ha già dato mandato ai
suoi legali al fine di tutelare nelle sedi opportune sia i propri diritti che la
propria immagine".
Sentenze taroccate al Tar.
L'aiutino costa 50mila euro,
scrive Valeria Pacelli da il Fatto quotidiano riportate da “Infonodo”. Vendita
della funzione giudicante, è la definizione degli inquirenti che racconta il
sistema corruttivo che nelle stanze del Tribunale amministrativo Regionale di
Roma, non aveva alcun rispetto di quella giustizia che dovrebbe fare da padrona.
Soldi contanti negli uffici di un giudice, sentenze decise in un ristorante chic
e procedimenti manipolati. È tutto nero su bianco nell'ordinanza di custodia
cautelare emessa nei confronti di 7 persone. In cella ci sono finiti il giudice
del Tar Franco Angelo Maria De Bernardi (già arrestato a maggio scorso a Palermo
nell'ambito di un'inchiesta su un traffico di lingotti d'oro, ma l'ordinanza è
stata annullata e lui è tornato a fare il giudice), l'avvocato amministrativista
Matilde De Paola e l'uomo d'affari Giorgio Cerruti, noto per i suoi legami con
la massoneria e Flavio Carboni. Ai domiciliari invece ci sono finiti l'ex
presidente della Banca Popolare di Spoleto, Giovannino Antonini, insieme ad
altri tre. L’inchiesta è dei magistrati romani Nello Rossi, Stefano Pesci e
Alberto Pioletti, che in un anno di indagine hanno scoperto come un giudice
intervenisse nelle sentenze del Tar, in accordo con un’avvocatessa che seguiva i
casi da trattare e soprattutto dietro lauto compenso. Accordi corruttivi che
sono finiti nei nastri delle intercettazioni ambientali o telefoniche captate
dal Noe, guidato dal colonnello Sergio de Caprio, alias Ultimo, mentre a seguire
direttamente l'indagine è il capitano Pietro Rajola Pescarini. A pagare le
“tangenti”, invece era chi desiderava sentenze favorevoli, tanto che molti sono
finiti iscritti nel registro degli indagati. Come il costruttore Claudio Salini
e due ufficiali, l'ammiraglio di squadra Marcantonio Trevisani, e il suo collega
Luciano Callini, ai vertici dello stato maggiore della Difesa, nei mesi scorsi
consulente del caso dei due marò indagati in India per omicidio. In questi
ultimi due casi, De Bernardi avrebbe curato i ricorsi percependo un compenso di
circa 10mila euro. Ma sono molteplici i casi scoperti dagli inquirenti. Uno di
questi riguarda il ricorso della Spoleto Credito e Servizi, sottoposta a
procedura di amministrazione straordinaria. Per vincere la causa contro il
ministero dell'Economia, che aveva commissariato la banca per un buco di diversi
milioni di euro, però sarebbe servita la promessa di 50 mila euro da parte
dell'ex presidente della Popolare di Spoleto, Antonini. Una vittoria decisa
davanti ad una cacio e pepe del ristorante romano «Il Caminetto», in zona
Parioli. Il 25 febbraio scorso infatti Giorgio Cerruti, che fa da tramite, cena
al ristorante con il giudice un monsignore. Si tratta di Don Manlio Sodi,
presidente della Pontificia Accademia della Teologia, anche questi indagato e
già coinvolto in un’altra inchiesta sul crac dei salesiani. La conversazione al
ristorante viene intercettata. De Bernardi: “non è che gli devi chiedere qualche
centinaio di euro perché fa ridere i polli” Cerruti: “ma non esiste..lascia
perdere. Ma io te lo faccio passare tramite il monsignore” De Bernardi: “quindi
semmai sentiamo quali sono le esigenze del monsignore, no?” Cerruti: “tu non ti
preoccupare,(..) tu mi devi dire, guarda Giorgio qui ci vogliono 50mila euro,
faccio per dire adesso. Poi se monsignore ne aggiunge 10 sopra sono cavoli suoi
(..) Il monsignore che c'ha questa onlus.. ha avuto un contributo dalla
fondazione non dalla banca, a livelli di beneficenza, insomma, gli hanno dato
sessanta mila euro”. Tra gli indagati per aver ricorso al giudice c'è anche
Claudio Salini, azionista con i fratelli e il padre Francesco Saverio della
Salini Costruttori. È anche presidente e ad della Ics Grandi Lavori, la società
da lui fondata nel 2005. Questa società è arrivata seconda alla gara per il
Ponte della Scafa, a Roma. Per questo viene fatto ricorso al fine di annullare
la gara. Anche in questo caso, sarebbe intervenuto il giudice De Bernardi e
“tramite Francesco Clemente, la Ics Grandi Lavori spa avrebbe promesso il
pagamento di imprecisate somme di denaro”, come è scritto nell’ordinanza. Al
vaglio degli inquirenti ci sono finiti anche tre ricorsi per gli esiti del
concorso notarile. Uno di questi è il ricorso “Molinari”. Stavolta le
sollecitazioni, è scritto nelle carte, sarebbero arrivate da “persone legate al
giudice in relazione ad un progetto politico, vale a dire la creazione di un
partito che supportasse Mezzaroma Roberto (ex eurodeputato di Forza Italia, ndr)
nella sua attività politica”. A fare da tramite per questo ricorso, De Santis,
che si reca nell'ufficio del giudice. Nei nastri del Noe, si registra il fruscio
del denaro che viene contato. “Si parla di banconote tutte da 50 -scrive il gip
nell’ordinanza- e, poi, di "40": il che è compatibile sia con il conteggio di 40
banconote da 50 euro (vale a dire 2.000 euro in tutto), sia con la somma di
40.000 euro in banconote da 50 euro. La seconda opzione è quella più credibile,
perché più in linea con le tariff’ generalmente praticate”.
L’occasione buona fa il
giudice ingordo, scrive Chiara Paolin su il Fatto quotidiano. Il giudice De
Bernardi non si sentirà solo nel ruolo dell’accusato, al Tar di Roma. Il collega
presidente della terza sezione, Franco Bianchi, è finito sotto indagine pochi
giorni fa con l’accusa di aver favorito un certo Adolfo Repice quando stava a
Torino, nel 2010. La tesi del gup è semplice: Repice voleva star tranquillo
sull’esito di un ricorso assegnato a Bianchi, il quale aveva invece bisogno di
introdurre il figliolo (di mestiere regista) ad Agostino Saccà, ex dg Rai. Dato
che Repice conosceva Saccà, il colloquio fu combinato, e ora la procura di
Torino dovrà capire se si trattò di corruzione. Peccatucci d’amor paterno se
confrontati agli affari di Pasquale De Lise, per decenni insider nei ministeri
che contano (lavoro, infrastrutture, poste, sanità), poi presidente del Tar del
Lazio e nel 2012 presidente del Consiglio di Stato, cioè l’organo che funge da
corte d’appello per le sentenze del Tar, nonchè gestore supremo di interessi e
conflitti della cosa pubblica. Ebbene, il potente De Lise si ritrovò svergognato
nel 2010 per colpa della famosa cricca. I giornali riportarono le conversazioni
del 2009 con Angelo Balducci, il ras delle opere pubbliche. “Uno di questi
giorni... c’ho una carta che volevo farti vedere... quando ti riesce, ti volevo
vedere cinque minuti” diceva amichevolmente De Lise a Balducci. Aggiungendo, su
un rigetto relativo al Salaria Village: “Quella cosa non stava né in cielo né in
terra... quindi insomma… e appunto… io l’ho seguita un po', quella storia là...
ma non... eh... appunto... assolutamente”. Risposta di Balducci: “Grazie”.
Un’inchiestaccia che sviluppò una protuberanza lombarda: il genero di De Lise,
l’avvocato Patrizio Leozappa, fu beccato in conversazioni hot mentre tentava di
intervenire su un giudizio incardinato al Tar di Milano. In questo caso
l’obiettivo era riassegnare un appalto da 1 miliardo e 800 milioni di euro, per
il quale servì anche una consulenza di Balducci. Ci andò di mezzo il presidente
della corte lombarda, Piermaria Piacentini, indagato per abuso d’ufficio e
corruzione, quasi tenero mentre balbetta: “Tu mi manderai a... ma io ti devo
chiedere di rimandarmi via e-mail... se è possibile subito... l’appunto su... il
modulo di ordinanza perché non so se me lo sono dimenticato a Roma eccetera e
volevo sistemare, ci siamo capiti”. Leozappa, che sovrintende il traffico, è
furibondo: non si può mandare in giro via mail roba così pericolosa, “la pulisco
dai! la pulisco, così evitiamo...”. Storie complicate dai soldi che abbondano
tra appalti, giudizi, ricorsi, sospensioni, pressioni, favori, tangenti,
partiti, nomine, poltrone. Storie incredibili, come quella del presidente del
Tar Marche, Luigi Passanisi, che continua a lavorare nonostante una condanna in
primo grado per aver venduto una sentenza quand’era in Calabria (ci sono voluti
3 mesi per sospenderlo). Storie appena nate, come le indagini per abuso
d’ufficio partire un mese fa sul presidente della sezione leccese del Tar
Puglia, Antonio Cavallari. Storie a lieto fine: Piacentini, mai condannato, fu
nominato nel 2000 presidente della Commissione consultiva per il rilascio del
Soa, certificazione necessaria alle aziende che vogliano partecipare alle gare
pubbliche. L’Autorità per la vigilanza sui contratti della Pa ha avuto fiducia
in lui, ancora una volta.
Quegli intrecci
inconfessabili tra magistrati e massoneria,
scrive Alessio Liberati su Il Fatto Quotidiano. Consiglio di Stato, quanti
massoni ci sono? L’ultimo di cui si è avuta notizia, in ordine di tempo, è
Antonio Maccanico, fratello massone e contestualmente consigliere di Stato,
oltre che segretario generale della Presidenza della Repubblica (incarico
ricoperto peraltro anche da molti altri consiglieri di Stato, come Gaetano
Gifuni, recentemente condannato per peculato e abuso di ufficio e l’attuale
pagatissimo Donato Marra). Ma non è il solo ad aver indossato il grembiulino. La
mia curiosità per i rapporti tra massoneria e Consiglio di Stato – che ha avuto
inizio per caso, quando cioè tre magistrati appartenenti a tale istituzione
(Roberto Giovagnoli, Claudio Contessa e Raffaele Greco) presentarono un esposto
disciplinare nei miei confronti, lamentando che un mio articolo scientifico, ove
facevo tra l’altro affermazioni tanto generiche quanto banali sulla
degenerazione dei concorso pubblici, non mancando di citare i condizionamenti da
parte della massoneria e dell’Opus Dei, fosse offensivo nei confronti della
giustizia amministrativa, per profili che non ho mai compreso – ha portato
infatti a molti riscontri, di cui ho già parlato anche in questo blog. Rinvio,
in proposito, oltre che agli elenchi della P2, ad un mio articolo più in
generale sul presidente Pasquale de Lise, ad altro relativo all’ex consigliere
di Stato Carlo Malinconico (oggi agli arresti domiciliari per gravi fatti
corruttivi) ed anche a quanto richiesto in sede di interrogazione parlamentare
dopo una mia denuncia relativa a quanto accertato nei confronti di uno degli ex
presidenti dell’associazione dei consiglieri di Stato e ad altri magistrati in
servizio nella giustizia amministrativa di appello. Tuttavia, ogni volta che
viene fuori il nome di un ulteriore Consigliere di Stato occultamente
appartenente alla massoneria, mi pongo le stesse domande, che rimangono
inevitabilmente senza risposta. Quanti sono i massoni che indossano grembiulino
e toga da consigliere di Stato? Quanti di questi sono ricattabili (visto che
vige un divieto espresso per i magistrati amministrativi di appartenere a logge
massoniche) da avvocati o terze persone che ne sono a conoscenza? Perché
l’organo di autogoverno della magistratura amministrativa, da me sollecitato più
volte, si è rifiutato di imporre l’obbligo di una dichiarazione espressa di non
appartenenza a logge massoniche, nonostante molti dei suoi componenti avessero
preso un espresso impegno in tal senso (Luca Cestaro, Umberto Maiello, Antonio
Plaisant, Roberto Pupilella, ecc.), poi disatteso? Non sarebbe ora di
costringere i giudici amministrativi (le cui decisioni condizionano pesantemente
la vita economica di questo Paese) a rendere pubbliche queste appartenenze, per
evitare anche il solo rischio o sospetto che possano esservi ricatti a carico di
questi magistrati? Non sarebbe l’ora di affrontare definitivamente,
eventualmente in senso positivo, il tema della compatibilità tra appartenenza
massonica e magistratura, al fine di evitare che si creino appartenenze occulte,
con i rischi sopra descritti? Del tema, emerso nuovamente durante il periodo in
cui era presidente dell’associazione dei consiglieri di Stato Filippo Patroni
Griffi, non si è voluto occupare né quest’ultimo, né il suo successore Roberto
Chieppa, né l’ex presidente Paolo Salvatore, né tanto meno il predetto De Lise.
Speriamo che almeno il nuovo presidente, Giorgio Giovannini, voglia affrontare
il tema, seppur con incomprensibile ritardo…
I segreti dei giudici
amministrativi. Avevo già raccontato la vicenda relativa alla scarsa trasparenza
della Giustizia Amministrativa riguardo ai comportamenti disciplinarmente
rilevanti dei Consiglieri di Stato e dei magistrati del TAR, scrive ancora
Alessio Liberati su Il Fatto Quotidiano. Le attenzioni mediatiche recentemente
rivolte ad alcuni consiglieri di Stato ed ex consiglieri di Stato, quali Filippo
Patroni Griffi, Carlo Malinconico, Pasquale De Lise, Paolo Salvatore , Franco
Frattini , solo per citare i più noti, rendono opportuno un aggiornamento sulla
questione. È bene anche rammentare che il Consiglio di Stato è l’organo deputato
ad assicurare – nella Repubblica Italiana – la trasparenza delle pubbliche
amministrazioni e l’accesso agli atti di queste ultime, in base alle norme
vigenti. L’organo di autogoverno della giustizia amministrativa (il CPGA, cioè
il “CSM” dei giudici TAR e del Consiglio di Stato), invece, è presieduto proprio
dal Presidente del Consiglio di Stato. Orbene, ben tre presidenti di tale
massimo organo giurisdizionale amministrativo (Paolo Salvatore, Pasquale De Lise
e Giancarlo Coraggio) si sono sottratti, quali presidenti del CPGA all’obbligo
di esibire i precedenti disciplinari a carico dei magistrati amministrativi. In
particolare, il TAR del Lazio li ha prima condannati (sentenza n. 13848/2010 )
ad esibire i precedenti disciplinari , posto che il CPGA si rifiutava
illegittimamente di ostenderli e poi, addirittura, è intervenuto per censurare
nuovamente l’organo presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato, perché non
aveva ottemperato alla sentenza, avendola anzi elusa con una artificiosa
distinzione (sconfessata dal TAR) tra procedimenti per i quali era stata
esercitata l’azione disciplinare (consentendone l’accesso … una trentina in
tutto in molti anni!) e procedimenti per i quali non era stata esercitata.
Perché negare l’accesso a procedimenti che, teoricamente, dovrebbero essere meno
gravi? Quali segreti si celeranno mai in quelle carte? E, soprattutto, cambierà
qualcosa con il Governo Monti, visto che il Presidente del Consiglio dei
Ministri (e non il Ministro della Giustizia, come per i magistrati ordinari,
civili e penali) è il responsabile titolare dell’azione disciplinare dei
magistrati amministrativi? Il prossimo appuntamento è per il 7 marzo, data in
cui il TAR del Lazio dovrà addirittura decidere, in caso di perdurante
inadempienza dell’organo presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato, se
“commissariare” (con la nomina di un commissario ad acta) il “CSM” dei giudici
amministrativi, sostituendolo con un soggetto che garantisca il rispetto della
sentenza. Non sarebbe opportuno che il presidente del CPGA e del Consiglio di
Stato, cioè l’organo preposto ad assicurare la trasparenza e l’accesso agli atti
di tutte le amministrazioni della Repubblica, fosse il primo ad adeguarsi
(almeno!) ad una sentenza che già lo condanna per la mancata esibizione agli
atti (fatto che già, di per sé, desta perplessità) e ad una successiva decisione
che ne censura il comportamento per non aver ottemperanza alla pregressa
sentenza di condanna?
LA MASSONERIA DEL
TERZO MILLENNIO. I DELITTI MASSONICI E LE NOTE DI CRONACA. IL MISTERO DELLA
MORTE DI RINO GAETANO, DI MARCO PANTANI E DEGLI ALTRI NOMI NOTI E LO SCANDALO
MOSE.
La Massoneria,
nobile e bistrattata istituzione, scrive Alessandro Ruzzi su “Informarezzo”.
I am a Master Mason. In italiano, sono un Maestro Massone (o un Maestro
Muratore). Non sono in logge italiane: ormai da diversi anni sono solo membro di
logge della UGLoE, la Gran Loggia Unita di Inghilterra, ritenuta la più
importante istituzione massonica, che vanta origini certe sin dal 1717. Deriva
dalla corporazione (craft) dei costruttori di cattedrali gotiche del
medioevo. Non per questo mi definisco un sapiente riguardo ai temi massonici,
poiché è proprio della Massoneria riconoscere che la verità definitiva è un
concetto astratto. Occorre essere consapevoli che il perfezionamento cui tende
il massone è una ricerca senza fine, un percorso individuale che si basa sulla
cautela circa la verità, specie se imposta come il dogma, e sull'incertezza di
un sentiero mutevole come la conoscenza umana. Una forma mentis che gli
attuali ritmi (televisivi) non rispettano: in loggia si parla uno alla volta,
senza interrompere, in rotazione. Quando non si condivide ciò che un fratello
esprime non lo si infama. Essere massoni porta ad uno specifico stato mentale,
in una palestra del pensiero e dell'agire correttamente ed educatamente:
tolleranza alle opinioni senza lasciarsi sopraffare dalle passioni. Talvolta si
sintetizza dicendo che la Massoneria rifugge le parole che iniziano con “pre”:
pre-concetto, pre-giudizio, pre-varicazione etc. Una scuola per individui
maturi, desiderosi di conoscenza, con disponibilità di tempo e di qualche
centinaio di euro: tramite silenzio e studio, giungere ad una crescente
consapevolezza. La mia vita attuale non mi porta più all'estero come prima, vivo
in Italia e ne seguo gli umori sociali, linee di pensiero raccolte attraverso i
vari metodi di comunicazione: mi indispone la superficialità con cui alcuni
individui indicano nella massoneria -generica- la causa di molti mali, la
matrice di episodi oscuri, la nutrice del potere più infido ed infimo.
Bersaglio proprio del complottismo che le si addebita. Leggo anche di bufale
clamorose, illuminati o savi di sion, templari e santo graal,
cui i più sprovveduti, ignoranti ed influenzabili abboccano. Altri le sfruttano
ai loro fini. Nella grande maggioranza dei casi ritengo che taluni individui
parlino senza alcuna conoscenza dei fatti, giudicando dall'esterno sulla base di
sentito dire, luoghi comuni o interesse personale. Oppure parlano individui che
si dichiarano ex-massoni o massoni pentiti, a conferma che una loro eventuale
appartenenza è viziata da gravi errori di fondo o condizionata da ripicche
personali o interessi malcelati. Tuttavia un aspetto richiede una mia netta
asserzione: la Massoneria, sic et simpliciter, unica ed omogenea, non
esiste in tutto il globo poiché ce ne sono vari metodi di individuazione e di
pratica. Me lo confermano anche i miei rapporti massonici internazionali. Le
nazioni in cui questa istituzione ha mantenuto, per cause storico- sociali-
culturali, una identità coerente possono vantare una istituzione massonica
largamente diffusa e univoca. Mi riferisco per esempio ad Inghilterra, Scozia,
Irlanda, Svezia. Monarchie, perlopiù. Ma in quasi tre secoli essa si è
sviluppata molto anche al di fuori dell'alveo originale, con la nascita di
realtà parallele o distorte. Altre nazioni hanno visto crescere massonerie nel
18° e 19° secolo, principalmente sull'onda britannica: Stati Uniti, Italia e
Francia, ad esempio. In questi paesi coesistono massonerie aderenti all'idea
iniziale o altre situazioni (non saprei come definirle meglio) che niente hanno
a che vedere col vero ed intimo significato della Massoneria. Vengono definite
simil-massonerie, para-massonerie, pseudo-massonerie etc. Frequentemente vi
vengono coinvolte persone in assoluta buona-fede. Come troppo spesso accade,
degne persone, ma non preparate sull'argomento, vengono associate: ritengono di
fare parte della massoneria universale. Questa non è semplicemente quella
definita dai rapporti fra le Grandi Logge (cioè quelle strutture amministrative
a cui una loggia fa riferimento), ma da una serie di precetti che permeano la
vita del singolo massone e che lo pongono in sintonia con altro massone, sia
esso in un diverso continente od il vicino della porta accanto. Non ho timore di
ammettere che particolarmente in Italia sono fiorite innumerevoli conventicole
(come le definì un papa, quando scomunicò tutti i massoni o presunti tali) che
si pongono scopi estranei alla tradizione massonica degli albori. Ad Arezzo ne
esistono diverse. Scimmiottano, nel nome e nelle riunioni, temi massonici,
convincono gli aderenti, spesso avvicinati per motivi di convenienza, di essere
parte della massoneria, ma indulgono su temi prosaici, assai terreni, di
interesse economico- politico. Questa non è Massoneria, è associazionismo (senza
offesa per il termine) clientelare. Da questi gruppi possono svilupparsi
infezioni da cui la società civile deve guardarsi. Purtroppo in passato un
focolaio di malattia seria ha interessato anche la più diffusa organizzazione
massonica italiana, che ha dilapidato in pochi anni e per colpa di pochi, un
capitale di serietà ed impegno, espresso nel risorgimento. Dal Canada alla
Norvegia, a spiegare che la P2 non era massoneria, ma un cancro. Che non si deve
ripresentare, infiltrandosi come un germe. Alcuni gruppetti italiani, che
imitano la massoneria, prediligono il mutuo sostegno fra gli aderenti, senza se
e senza ma, anche davanti a situazioni inconciliabili con i cardini della
tradizione anglosassone che ho riportato sotto il titolo. La conoscenza dei
segreti massonici (che riguardano solo i metodi di riconoscimento) non è
sufficiente a rendere massoni. Tanto meno il rispetto di talune consuetudini
massoniche. Li reputo anti-massoni, l'esemplare peggiore del campionario.
Tuttavia, anche in gruppi non regolarmente costituiti possono trovarsi persone
con cui condividere lo spirito massonico. Non giudico semplicemente per
appartenenza, bensì per aderenza all'ideale massonico, per comportamento. Dove
vedo clientelismo, affarismo, interesse non vedo massoneria. In Italia mi sono
trovato in contrasto con queste tendenze ed ho avuto la ventura di approdare nel
porto sicuro costituito dalla Gran Bretagna, dove questi scarrocciamenti non
sono diffusi, dove si opera nei tre gradi tradizionali della Massoneria azzurra.
Tuttavia questi non sono episodi da criminalizzare automaticamente, perché
parimenti le famiglie italiane lo sarebbero per l'affetto che le porta a
sostenere i loro cari. Ma davanti ad una qualsivoglia ingiustizia occorre che il
diritto trionfi, senza favoritismi: ed in ciò l'impegno massonico non ammette
deroghe. Esistono massoni anche al di fuori delle istituzioni massoniche, il
loro comportamento li contraddistingue; esistono non-massoni dentro serie
istituzioni massoniche, purtroppo hanno sbagliato posto ed arrecano danni;
quindi generalizzare è un errore marchiano o doloso. L'impegno massonico prevede
la indiscussa aderenza alle leggi. Richiede la credenza in una entità superiore,
a seconda delle convinzioni individuali, genericamente definita Grande
Architetto. Non tratta di politica o religione in loggia. Non prevede segretezza
se non nei modi di riconoscimento: una società iniziatica con segreti, non una
società segreta. Molte altre associazioni non danno pubblicità alla lista degli
aderenti, purtroppo confondere riservatezza con segreto e malaffare è un errore
doloso diffuso. La compresenza femminile nelle logge regolari è esclusa, secondo
gli antichi principi fondativi: esistono massonerie esclusivamente femminili,
da secoli, ma chi fa polemica si astiene dal sottolinearlo. I massoni non sono
misogini, evitano la promiscuità in loggia. Quando qualcuno blatera
genericamente di massoneria tenga presente questi significativi particolari,
perché diversamente offende persone che si applicano nella ricerca individuale
del perfezionamento, nel perimetro dell'amore fraterno, del sollievo nelle
difficoltà, della verità.
Virtù privata, pubblica prosperità: secondo le parole del primo
presidente statunitense, George Washington, “being persuaded that a just
application of the principles, on which the Masonic Fraternity is founded, must
be promote of private virtue and public prosperity, I shall always be happy to
advance the interests of the Society”.
Persone capaci di un mondo migliore.
Siano Massoni o profani (come usiamo definirli, in quanto non iniziati)
fortunatamente esistono. Umili verso gli ultimi, duri verso i prepotenti,
attenti ai bisogni delle famiglie dei fratelli. Operano silenziosamente, ma
sanno emergere quando occorre. E non meritano di essere confusi da improvvidi
chiaccheroni.
Eppure non mancano
punte di criticità. Molti scrittori sono astiosi, a torto od a ragione, contro
la Massoneria. La rete riporta spesso articoli o libri che preludono a misteri
dietro le più eclatanti note di cronaca. E' doveroso riportare nella storia
anche l'altra faccia della cronaca.
"Leggete i
suoi testi con me, Rino Gaetano era un massone: fatto fuori perché parlava".
L'autore dell'inchiesta sulla morte del cantante ci illustra i presunti messaggi
cifrati del cantautore: "Sapeva tutto sul caso Lockheed e sul delitto Montesi".
Intervista di
Roberto Procaccini su “Libero Quotidiano”.
"Rino
Gaetano era vicino agli ambienti massonici, se non
massone in prima persona. Dai
suoi amici confratelli veniva a conoscenza della verità su alcuni
misteri della storia italiana del '900, che poi inseriva nei testi delle sue
canzoni dietro le mentite spoglie
dell'umorismo o del non sense. Per questo è stato
ucciso. Aveva raccontato troppe
cose, pestando i calli a qualcuno negli
Stati Uniti". Bruno
Mautone, avvocato ed ex sindaco di Agropoli (Salerno), ha
studiato per tre anni i testi delle canzoni di Rino Gaetano. Ha analizzato le
parole e colto dei collegamenti, fino a disegnare uno scenario inedito: il
cantautore calabrese, morto in un incidente stradale nel 1981 all'età di 30
anni, è stato vittima di un complotto.
"Nel mio libro (Rino Gaetano: La tragica scomparsa di un eroe) metto in
evidenza dati che mi sembrano oggettivi - spiega -. Poi le conclusioni possono
essere condivisibili o meno, ma i fatti restano". Mautone fa riferimento ad
Anna Gaetano, la
sorella di Rino, che sul nostro sito aveva definito "sogni" le sue tesi. "Questo
non lo posso accettare", replica Mautone.
Come è
arrivato alla conclusione che Rino Gaetano sarebbe stato un massone?
«Le
sue canzoni sono piene di riferimenti alla cultura e al simbolismo massonico. In
Fiorivi, sfiorivano le viole cita il marchese La Fayette che
ritorna dall'America importando la Rivoluzione e un cappello nuovo, Mameli
che scrive una canzone tutt'ora in voga, e poi ancora Otto von
Bismarck-Shonhausen».
E allora?
«Allora
parla di tre personaggi chiave della massoneria europea del diciottesimo e
diciannovesimo secolo in una canzone d'amore. La rivoluzione importata da
Lafayette era quella americana, cioè quella massonica per eccellenza. La canzone
tutt'ora in voga di Mameli è l'inno nazionale, Fratelli d'Italia,
quando è noto che i massoni sono soliti chiamarsi tra di loro fratelli».
Basta a dire
che Gaetano aderisse a una loggia?
«No,
ma suoi amici strettissimi, che ho intervistato durante il lavoro di ricerca, mi
hanno confermato il suo interesse per la materia. Leggeva molti libri sulla
massoneria e sui suoi personaggi di spicco. E dirò di più: dai titoli dei dischi
del cantautore si capisce anche il suo percorso di vicinanza prima, e
allontanamento poi, dalla massoneria».
Cioè?
«Nel
1973 Gaetano pubblica I love you Marianna. La Marianna è il simbolo
della rivoluzione francese, che è una rivoluzione massonica. Nel 1974 tocca a
Ingresso Libero, intendendo l'apertura delle logge alle nuove
affiliazioni. Poi Gaetano rompe con gli ambienti massonici e nel 1976 incide
Mio fratello è figlio unico, dove l'immagine paradossale rappresenta
l'isolamento nella loggia».
E così Rino
avrebbe avuto agganci nella massoneria.
«Esatto.
Anna Gaetano sostiene che il fratello fosse una persona preparata, che leggeva i
giornali e arrivava a certe intuizioni grazie alla sua preveggenza. Non è così.
Lui poteva anticipare le cose perché le conosceva».
Quanti
riferimenti a casi occulti ha contato nella discografia di Rino Gaetano?
«A
centinaia. Ce ne sono di grossi. In Berta filava, una canzone del
'75-'76, spiega lo scandalo Lockheed (un caso di corruzione affinché
l'aeronautica italiana adottasse veivoli della casa americana, ndr).
Berta sarebbe Robert Gross, detto Bert, presidente della Lockheed. Rino cantava:
"Berta filava con Mario e con Gino", che sarebbero Mario Tanassi e Gino
Gui, due ex ministri della Difesa coinvolti nell'inchiesta. Ma dal rapporto,
prosegue la canzone, nasce un bambino che non era di Mario e non era di Gino.
Cioè Rino sottintendeva che la responsabilità non fosse di Gui e Tavassi,
esattamente come si è scoperto dopo. I due ministri erano dei capri espiatorii
messi lì per coprire responsabilità più alte. Ma non è il solo esempio».
Ne faccia un
altro.
«In
Nun te reggae più Rino Gaetano cita la spiaggia di Capocotta, cioè il
delitto Montesi, e nella stessa canzone canta auto blu, sangue blu, ladri di
Stato e stupratori».
E quindi?
«Per
l'omicidio di Wilma Montesi furono incriminati Piero Piccioni, figlio del
ministro degli Esteri Attilio, e Ugo Montagna, un marchese. Le auto blu, un
riferimento ai palazzi romani del potere. Il sangue blu, la nobiltà. Ladri di
stato, perché le hanno rubato la vita alla ragazza venendo poi clamorosamente
assolti. Stupratori, perché avevano violentato la ragazza. Rino Gaetano tutte
queste cose le sapeva».
Racconta la
sorella Anna che Rino Gaetano avesse inserito un riferimento al caso Montesi
anche in una poesiola infantile. Per dire che il caso di nera, semplicemente,
l'aveva colpito profondamente nell'immaginario.
«Ma
ciò non esclude che più di dieci anni dopo abbia scritto Nun te reggae più
in possesso di elementi nuovi».
E perché le
avrebbe nascoste dietro riferimenti così complessi?
«Perché
le sue canzoni erano cavalli di troia. Se fosse stato più esplicito lo avrebbero
bloccato. Invece nascondeva cose serissime dietro l'umorismo e lo stile non
sense».
Chi è il
responsabile della morte di Rino Gaetano, allora?
«La
massoneria deviata. Direi settori in rapporti con gli Stati Uniti. L'Italia era
diventata una colonia americana, Rino l'aveva scritto in molte canzoni, come in
Ok papà, dove scrive Usa il pugnale. Anche il modo in cui
l'hanno ucciso è un riferimento alla simbologia massonica».
Perché?
«E'
morto il 2 giungo, data scelta dai padri costituenti, tra cui molti fratelli,
per l'unica festa laica del Paese. E poi non mi spiego perché sul luogo
dell'incidente sia arrivata per prima un'ambulanza dei pompieri. Per non parlare
dell'agonia e delle insufficienze ospedaliere che ricalcano la canzone la
Ballata di Renzo».
Mettere insieme
stralci di canzoni non le sembra un po' poco per sostenere una teoria del
genere?
«Lo
so, se avessi il documento che testimonia l'associazione di Rino Gaetano alla
massoneria sarebbe tutto più chiaro. Ma ho messo in fila elementi chiari, per me
oggettivi».
Anna Gaetano
lamenta che l'ha conosciuta, per telefono, solo a libro dato alle stampe.
«Non
avrei potuto contattarla prima. Sapevo che non avrebbe condiviso il mio libro,
che mi avrebbe messo il bastone tra le ruote. Non ho nulla contro di lei, ma se
ha paura non è colpa mia. E capisco anche che non sia d'accordo con le mie
conclusioni, ma non può dire che invento».
La tesi choc
di un avvocato: "Rino Gaetano è stato ucciso dalla massoneria",
scrive Fabio Frabetti su “Affari Italiani”. «Rino Gaetano fu
ucciso dalla massoneria deviata». La dinamica della morte del geniale
cantautore che continua a trascinare vecchie e nuove generazioni potrebbe non
essere così scontata come si è pensato finora. L'avvocato Bruno Mautone, ex
sindaco di Agropoli, sta per dare alle stampe un libro in cui è riuscito a
decriptare nei testi delle canzoni di Gaetano tutti i misteri della sua morte.
Affaritaliani.it lo ha incontrato. Si intitola “Rino Gaetano, assassinio di un
cantautore” ed uscirà nelle prossime settimane per le edizioni Gli occhi di
Argo.
Come è nata
l'idea di scrivere un libro del genere?
«Da tanti anni per
passatempo conduco programmi radiofonici e Rino Gaetano è uno dei miei autori
preferiti. Ascoltando alcuni suoi brani poco conosciuti mi sono accorto che
c'erano dei significati interpretabili in maniera non letterale. Non ritengo di
avere il Vangelo in tasca ma penso di avere individuato, partendo dal lavoro in
passato svolto da Gabriella Carlizzi e Paolo Franceschetti, una serie di canzoni
in cui vengono lanciati degli importanti messaggi sulla storia italiana dal
dopoguerra in poi. La morte di Rino Gaetano non è stata casuale, si trattò di
una macchinazione per metterlo a tacere. In alcuni suoi testi ci sono messaggi
inquietanti ed angoscianti. In altri, frasi di scherno che progressivamente
vengono inseriti di disco in disco. Lui era un vero e proprio genio e la
massoneria è da sempre interessata a fare entrare nuove leve di alto valore
intellettivo. Così probabilmente lui fu fatto entrare molto giovane e così era
venuto a conoscenze di segreti e verità apprese nell'ambito di specifiche
consorterie massoniche. Nei primi dischi sembra esserci entusiasmo nei confronti
di questo mondo, poi pian piano subentrò il disincanto e poi il distacco. Lo
spirito di ideali e di giustizia lo spinse a rivelare con le sue canzoni alcuni
di quei segreti. Messaggi che seppur criptici hanno indotto la massoneria
deviata ad ucciderlo. Ha composto poco più di sessanta canzoni, nel 100% delle
sue composizioni ha sempre messo qualche riferimento a fatti o situazioni
collegabili alla massoneria. In altre ha individuato e rivelato segreti
inquietanti della storia italiana».
«C'è qualcuno
che vuole mettermi il bavaglio! Io non li temo! Non ci riusciranno! Sento che,
in futuro, le mie canzoni saranno cantate dalle prossime generazioni! Che,
grazie alla comunicazione di massa, capiranno cosa voglio dire questa sera!
Capiranno e apriranno gli occhi, anziché averli pieni di sale! E si chiederanno
cosa succedeva sulla spiaggia di Capocotta». Rino Gaetano pronuncia questa
criptica frase in un concerto del 1979. Sta per eseguire uno dei suoi brani più
celebri Nuntereggae più. Proprio nel testo di questa canzone salta di nuovo
fuori la stessa spiaggia: «il pitrentotto sulla spiaggia di Capocotta». In
quella spiaggia si era consumato nel 1953 il delitto di Wilma Montesi...
«Quando avvenne
quell'omicidio, Rino aveva poco più di due anni. Quello che aveva raccontato di
quel tragico evento nei concerti e nelle sue canzoni lo aveva quindi sicuramente
conosciuto nelle frequentazioni di tipo massonico: tramite le sue parole si può
quindi ricostruire cosa avvenne esattamente in quella spiaggia. I segreti che
aveva appreso riguardavano però molti aspetti della cronaca e della politica
italiana. L'aspetto inedito del libro è proprio questo: aver dimostrato che
nelle sue canzoni insieme ad apparenti nonsense si raccontavano i retroscena di
molti scandali: i casi Sindona, banco Ambrosiano, Franklin Bank, vicenda Mattei.
Addirittura Rino Gaetano era arrivato a pronosticare come sarebbe finito il
processo per la bomba a Piazza Fontana a Milano e ad annunciare i reali
colpevoli dello scandalo Lockheed».
Rino Gaetano
morì il 2 giugno 1981 dopo un incidente stradale sulla via Nomentana a Roma. La
sua auto finì addosso ad un camion: perse la vita per le gravi ferite riportate
dopo che ben tre ospedali di fatto rifiutarono il suo ricovero. La cosa
incredibile è che lo stesso cantautore 11 anni prima aveva raccontato la morte
di un uomo dopo essere stato rifiutato da tre ospedali e anche dal cimitero. Nel
brano “La ballata di Renzo” si legge: Quando Renzo morì io ero al bar la strada
era buia si andò al S.Camillo e lì non l'accettarono forse per l'orario si pregò
tutti i Santi ma s'andò al S.Giovanni e li non lo vollero per lo sciopero.
Quando Renzo morì io ero al bar era ormai l'alba e andarono al Policlinico ma lo
si mandò via perché mancava il vicecapo c'era in alto il sole,si disse che Renzo
era morto ma neanche al Verano c'era posto. Una somiglianza notevole con quello
che sarebbe accaduto allo stesso Gaetano.
«I primi tre ospedali
citati nel brano sono proprio quelli che non ebbero la capacità o la volontà di
curarlo in maniera non professionale od idonea dopo l'incidente. Non abbiamo
alcuna prova che il soccorso sia stato tempestivo. I telefonini non esistevano.
Sarebbe interessante capire chi allertò i soccorsi, a che ora e con quale
modalità. Tra le altre cose, lui non fu degente in tre ospedali diversi. Rimase
al Policlinico Umberto I, con motivazioni mai veramente chiarite ed emerse. Non
c'era il reparto di traumatologia cranica funzionante e gli ospedali
disperatamente contattati dal medico di turno facevano quasi a gara a non
prestare soccorso a Rino. Così morì agonizzante al Policlinico per il grave
trauma cranico riportato. Lui aveva avuto un altro strano incidente nel 1979 a
cui era miracolosamente sopravvissuto. Una jeep speronò la Volvo in cui
viaggiava insieme ad un amico. La macchina si distrusse e chi aveva causato
l'incidente riuscì a defilarsi e non si seppe mai chi fosse alla guida. Questo
incidente avviene nello stesso anno in cui Rino Gaetano aveva fatto quelle
rivelazioni su Capocotta. Nelle sue canzoni preconizzava una morte prematura,
sapeva i rischi che stava correndo. Per questo probabilmente non aveva messo al
corrente le persone a lui care delle frequentazioni che aveva avuto. Voleva
preservarle da possibili rischi».
Un altro brano
che fa pensare è “Al compleanno della zia Rosina” in cui si legge: “vedo già la
mia salma portata a spalle da gente che bestemmia che ce l'ha con me”.
«In quella canzone c'è
una emblematica citazione storica di Cleme, che sta per Clemente Rino Gaetano si
voleva riferire ai tre papi (Clemente V, Clemente XII e Clemente XVI) che in
momenti storici diversi emanarono provvedimenti religiosi nei confronti di
movimenti legati alla massoneria. Uno di questi papi emanò il primo editto
contro la massoneria, un altro aveva sciolto la Compagnia di Gesù ed il terzo
sciolse i Templari. Lui in sostanza sta dicendo: me ne frego se verrò portato a
spalla da gente che bestemmierà, evocando queste figure che avevano scomunicato
per prime alcune diramazioni massoniche. Lui consultava enciclopedie, libri di
storia e di cultura. Nel mio lavoro penso di avere colto dei significati che non
era facile afferrare di primo acchito. Rino Gaetano era un generoso ed un
idealista, non riusciva a trattenere nell'ambito dei propri pensieri le tante
porcherie che erano state combinate in Italia dopo la seconda guerra mondiale.
Nelle sue canzoni parla anche di storia, di Risorgimento, di Hitler e di una
miriade di cose. Anche di numerologia. C'è di tutto celato nella sua musica.
Anche il mistero della sua morte».
Rino Gaetano e
i messaggi in bottiglia.
Qualche appunto a margine del vergognoso film della RAI su Rino Gaetano,
scrivono Paolo Franceschetti e Stefania Nicoletti. Come abbiamo
descritto molte volte nel nostro blog, il nostro è un sistema che uccide e
strangola tutti coloro che ne sono al di fuori e non vogliono essere coinvolti
nei giochi illeciti del potere massonico. Il sistema, però, non penalizza solo
chi ne è fuori, ma anche chi ne è dentro e ne riceve i vantaggi. Perché il
problema è che una volta entrati nel sistema, tutto ciò che ti viene dato ti
viene chiesto in restituzione sotto altre forme. Se fai carriera grazie al
sistema, ad un certo punto arriverà qualcuno che ti chiederà il conto; ti
chiederanno di fare uno sgarbo ad un vecchio amico che vogliono rovinare; ti
chiederanno di falsificare un documento o farlo sparire, ti chiederanno di
accollarti una responsabilità penale per salvare altri, di essere condannato ad
un anno con la condizionale e di spendere la tua faccia su tutti i giornali per
fare da capro espiatorio. Ribellarsi al sistema è quasi impossibile per la
perfezione che esso ha. Tanti, troppi, sono caduti nella trappola. Le promesse
che ti fanno sono allettanti: potere, denaro, conoscenza dei meccanismi reali
del potere. Ma il conto è salato, perché non si è più liberi di fare ciò che si
vuole, e si è in costante stato di ricatto. Ritengo, ad esempio, che molti
esponenti della sinistra attuale, a suo tempo, abbiano fatto il cosiddetto
“patto col diavolo”, pensando semplicemente di accettare un compromesso in più
per fare carriera; e si sono poi trovati invischiati in un gioco di potere più
grande di loro, perdendo ogni capacità decisionale reale; ed ecco il motivo per
cui la sinistra di questi ultimi anni ha fatto delle cose senza alcuna logica,
come se volesse realmente perdere le elezioni e consegnare – come hanno fatto di
recente – il paese definitivamente alla destra. In realtà alcuni provano a
ribellarsi. Ribellarsi in modo esplicito, in un attacco frontale, non è
possibile altrimenti si muore (la lista dei morti è lunghissima; Falcone e
Borsellino, Occorsio, Pecorelli, Tobagi, Mauro De Mauro, Cosco, Pasolini,
Cecilia Gatto Trocchi, Ilaria Alapi, Graziella De Palo, e tutti coloro che hanno
provato a testimoniare coraggiosamente in processi importanti, morti suicidi o
in incidenti stradali). Molti però provano a ribellarsi non apertamente,
lanciando una serie di messaggi in bottiglia. Come delle tracce, per chi le
vorrà cogliere un giorno. Ricordo un'archiviazione vergognosa che aveva a che
fare con un soggetto che si era suicidato con "una coltellata sulla schiena". Il
magistrato archiviò dicendo delle cose che li per li mi parvero incomprensibili;
mischiava citazioni di Dante a frasi demenziali del tipo "la prova che si sia
trattato di un suicidio è nel fatto che sul coltello piantato nella schiena
furono trovate le impronte digitali della vittima". Dopo anni di rabbia in cui
non capivo l'assurdità di quel provvedimento, ho capito che la citazione di
Dante era un chiaro riferimento alla legge del contrappasso, utilizzata dalla
Rosa Rossa per i suoi omicidi. Mentre con la frase in cui parlava delle impronte
digitali voleva dire esattamente il contrario.... Tra l'altro fu uno dei
provvedimenti il cui studio e la cui lettura approfondita mi hanno permesso di
arrivare alla regola del contrappasso da noi descritta negli articoli
sull'omicidio massonico. A mio parere si trovano molti messaggi in bottiglia
anche in molti libri, articoli di giornale, e opere attuali, ma evitiamo di
indicarli per non mettere in pericolo le persone coinvolte. Rino Gaetano era una
di queste persone che si erano ribellate al sistema in modo vistoso. Non poteva
denunciare il sistema direttamente, perchè non gli avrebbe dato voce nessuno,
allora lasciò una serie di tracce nelle sue canzoni, che sarebbero state
raccolte dalle generazioni successive. Rino Gaetano ci parla della Rosa Rossa,
dei crimini commessi dai potenti, dei meccanismi segreti di questa associazione
e dei loro metodi. Vediamone qualcuna.
Le
canzoni. C’è un
album di Rino, in particolare, che pare dedicato proprio alla Rosa Rossa. Nello
stesso album, infatti troviamo ben tre canzoni: Rosita, Cogli la mia Rosa
d’amore, e Al compleanno della zia Rosina. Una trilogia a nostro parere non
casuale. In Rosita ci dice che la Rosa Rossa, quanto te la presentano, sembra
bellissima... onori, gloria, soldi, potere... poi però un giorno scopri la
verità. E allora la tua vita cambia completamente perchè sei in trappola.
Ieri ho incontrato
Rosita, perciò questa vita valore non ha,
Come era bella
rosita di bianco vestita più bella che mai.
Nella canzone “Al
compleanno della zia Rosina” ci spiega che nel linguaggio criptato della Rosa
Rossa, Santa Rita è in realtà la Rosa Rossa; e ci spiega che un giorno capiranno
che sta svelando questi messaggi, e quindi lo uccideranno.
La vita la vita, e
Rita s'è sposata, al compleanno della zia Rosina.
Vedo già la mia
salma portata a spalle da gente che bestemmia e che ce l'ha con me.
Questa frase
apparentemente incomprensibile vuole dire probabilmente che gli appartenenti
alla massoneria rosacrociana della Rosa Rossa al suo funerale porteranno a
spalla la sua bara (ai funerali delle vittime i mandanti sono sempre presenti
tra i partecipanti); ma bestemmieranno, perchè in realtà una caratteristica
della massoneria della Rosa Rossa è di stravolgere i simboli e i riti Cristiani
per interpretarli al contrario. Infine, in “Cogli la mia rosa d’amore” lancia un
messaggio molto chiaro:
cogli la mia rosa
d’amore,
regala il suo
profumo alla gente;
cogli la mia rosa
di niente.
Non credo sia un caso anche il titolo del disco: "mio fratello è figlio unico",
perché sapeva che questo scherzetto gli sarebbe costato la vita. Nella canzone
“Nun Te Reggae più” parla della spiaggia di Capocotta. E, ad un concerto, disse:
"C'è qualcuno che
vuole mettermi il bavaglio. Io non li temo. Non ci riusciranno. Sento che in
futuro le mie canzoni saranno cantate dalle prossime generazioni. E che grazie
alla comunicazione di massa, capiranno cosa voglio dire questa sera! Apriranno
gli occhi e si chiederanno cosa succedeva sulla spiaggia di Capocotta".
Vediamo cosa succedeva
nella spiaggia di Capocotta, prendendo le notizie da Wikipedia.
La
spiaggia di Capocotta.
OMICIDIO DI WILMA MONTESI (1953, vigilia di Pasqua). La vicenda coinvolse il
musicista Piero Piccioni, figlio del vicepresidente del consiglio della DC, e
altri noti esponenti della nobiltà, politici e personaggi famosi... Inizialmente
fu presa in considerazione l'ipotesi di un banale incidente, ipotesi che fu
considerata attendibile dalla polizia, e il caso venne chiuso. I giornali,
L'Espresso su tutti, invece si mostravano scettici. Il Roma, quotidiano
monarchico napoletano, il 4 maggio cominciò ad avanzare l'ipotesi di un
complotto per coprire i veri assassini, che sarebbero stati alcuni potenti
personaggi della politica; l'ipotesi presentata nell'articolo Perché la polizia
tace sulla morte di Wilma Montesi? a firma Riccardo Giannini ebbe largo seguito.
A capo di questa campagna stampa, vi erano prestigiose testate nazionali, quali
Corriere della Sera e Paese Sera, e piccole testate scandalistiche, quali
Attualità, ma la notizia si diffuse su quasi tutte le testate locali e
nazionali. Il 24 maggio del 1953 un articolo di Marco Cesarini Sforza pubblicato
sul giornale comunista Vie Nuove creò molto scalpore: uno dei personaggi apparsi
nelle indagini e presumibilmente legati alla politica, sinora definito "il
biondino", venne identificato con Piero Piccioni. Piccioni era un noto musicista
jazz (col nome d'arte Piero Morgan), fidanzato di Alida Valli e figlio di
Attilio Piccioni, il Vicepresidente del Consiglio, Ministro degli Esteri e
massimo esponente della Democrazia Cristiana. Il nome di "biondino" era stato
attribuito al giovane da Paese Sera, in un articolo del 5 maggio, in cui si
raccontava di come il giovane avesse portato in questura gli indumenti mancanti
alla ragazza assassinata. L'identificazione con Piero Piccioni era un fatto noto
a tutti i giornalisti, ma nessuno ne aveva mai svelata l'identità al grande
pubblico. Su Il merlo giallo, testata neofascista, era addirittura apparsa già
ai primi di maggio una vignetta satirica in cui un reggicalze veniva portato in
questura da un piccione, un chiaro riferimento al politico e al delitto. La
notizia suscitò clamore perché venne pubblicata poco prima delle elezioni
politiche del 1953. Piero Piccioni querelò per diffamazione il giornalista e il
direttore del giornale, Fidia Gambetti. Cesarini Sforza venne sottoposto ad un
duro interrogatorio. Lo stesso PCI, movimento di riferimento del giornale e
unico beneficiario dello scandalo, disconobbe il giornalista, che venne accusato
di "sensazionalismo" e minacciato di licenziamento. (QUINDI ANCHE LO STESSO PCI
SEMBRA VOLER COPRIRE E INSABBIARE TUTTO... CHISSA' COME MAI?). Nemmeno sotto
interrogatorio Cesarini Sforza citò mai direttamente il nome della fonte da cui
ufficialmente veniva la notizia, limitandosi ad affermare che provenisse da
"ambienti dei fedeli di De Gasperi". Anche il padre del giornalista, un
influente docente di filosofia all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza",
suggerì al figlio di ritrattare, consiglio vivamente sostenuto anche dal
celeberrimo "principe del foro" Francesco Carnelutti che aveva preso le parti
dell'accusa per conto di Piccioni. L'avvocato di Sforza, Giuseppe Sotgiu (già
presidente dell'Amministrazione provinciale di Roma ed esponente del PCI) si
accordò col collega e il 31 maggio, Cesarini Sforza fu costretto a ritrattare le
sue affermazioni. Come ammenda, versò 50 mila lire in beneficenza alla Casa di
amicizia fraterna per i liberati dal carcere, ed in cambio Piccioni fece cadere
l'accusa. Il 6 ottobre 1953, sul periodico scandalistico Attualità, il
giornalista e direttore della testata Silvano Muto pubblicò un articolo, La
verità sul caso Montesi. Muto aveva condotto un'indagine giornalistica nel "bel
mondo" romano, basandosi sul racconto di una attricetta ventitreenne che
sbarcava il lunario facendo la dattilografa, tal Adriana Concetta Bisaccia. La
ragazza aveva raccontato al giornalista di aver partecipato con Wilma ad
un'orgia, che si sarebbe tenuta a Capocotta, presso Castelporziano e non
distante dal luogo del ritrovamento. In quell'occasione avevano avuto modo di
incontrare alcuni personaggi famosi, principalmente nomi noti della nobiltà
della capitale e figli di politici della giovane Repubblica Italiana. Continuano
ad essere ritrovati corpi di donne su quella spiaggia. Forse è questo che voleva
dire Rino. Non si riferiva solo al caso Montesi, ma a decine di altri casi che
evidentemente continuano a verificarsi a Capocotta... O forse voleva dire che è
una situazione "emblematica" di tutto quello che succede in Italia. Ma sono solo
nostre deduzioni. Potremmo continuare perchè ci sono altre canzoni molto più
significative e piene di messaggi, come Gianna. Ma terminiamo qui perchè per
capire queste canzoni occorre avere una conoscenza specifica di determinati
fatti e situazioni. Forse però non molti sanno che la canzone Nuntereggaepiù,
che nomina molti personaggi della politica, dello spettacolo, dello sport, della
televisione... è stata censurata. Inizialmente infatti l'elenco conteneva, tra
gli altri, i nomi del finanziere Nino Rovelli, del banchiere Ferdinando
Ventriglia, di Camillo Crociani (scandalo Lockheed e loggia P2), di Amintore
Fanfani, di Guido Carli... e persino di Aldo Moro e Michele Sindona. Questi nomi
vennero cancellati dal testo della canzone. Evidentemente perché ancora più
scomodi di quelli che furono lasciati. Un personaggio come Rino non poteva
vivere a lungo, e perse infatti la vita il 2 giugno del 1981 in un incidente
d'auto. Poco tempo prima, come abbiamo già raccontato altrove, aveva avuto un
incidente analogo, ma si era salvato. Aveva ricomprato un’ auto identica ed ebbe
un incidente dello stesso tipo; morì non tanto per l'incidente in sè, quanto per
il ritardo con cui fu curato perchè negli ospedali della zona nessuno volle
accoglierlo. Ben 5 ospedali si rifiutarono di curarlo, così come lui aveva
scritto in una sua canzone, La ballata di Renzo. Cioè, è stata applicata ,nel
suo caso la regola del contrappasso di cui ci siamo occupati in altri articoli.
La ballata di Renzo è un brano inedito, di cui peraltro si scoprì l'esistenza
solo qualche anno fa. Dunque, all'epoca, solo gli "addetti ai lavori" (i
produttori e le persone che lavoravano insieme al cantante) erano a conoscenza
di quel brano. E solo chi conosceva la canzone poteva fare in modo che si
realizzasse nella pratica, e in modo così dettagliato. Quando qualche anno fa
uscì la notizia della scoperta del brano inedito, i media si affrettarono subito
a definirla una "profezia". I giornali scrissero che ne La ballata di Renzo
"Rino aveva previsto e messo in musica, dieci anni prima, la propria morte". Ma
sarebbe invece più oppurtuno affermare il contrario: la morte del cantautore è
avvenuta esattamente come nella sua canzone non perché quel brano fosse una
profezia, ma perché qualcuno l'ha usata per applicare la regola del
contrappasso.
Il film.
Di recente la RAI ha prodotto un film su Rino Gaetano. Vediamo cosa dice la
presentazione ufficiale del film sul sito Rai. "Ci sono film su personaggi
della musica che riescono a descrivere compiutamente lo spirito di un'epoca. È
questo l'obiettivo della fiction Rino Gaetano. Ma il cielo è sempre più blu, una
produzione Rai Fiction realizzata da Claudia Mori per la Ciao Ragazzi.
L'interesse per Rino Gaetano e per la sua musica si è riacceso negli ultimi
anni, soprattutto tra i giovani, al punto di farne una figura di culto oltre la
sua epoca. La fiction, che racconta in due puntate la sua biografia e la genesi
delle canzoni più popolari, è uno spaccato della sua generazione, e trasmette un
messaggio che può valicare i confini nazionali italiani, perché ancora oggi
modernissimo". In realtà guardando il film si capisce che è stato
scritto al solo scopo di infangare l’immagine del cantautore. La sorella di Rino
e la ex fidanzata, intervistate, diranno che il film racconta qualcun altro
rispetto al protagonista. Quello non era Rino, non era la storia d'amore tra lui
e la fidanzata. Vediamo perchè. Anzitutto il film si apre con la scena di lui
che sviene per aver bevuto troppo. E si chiude con le immagini di lui, ubriaco,
che vaga senza meta alla ricerca di amici che oramai lo hanno abbandonato. Il
messaggio è chiaro. Era un ubriacone. Altre scene salienti del film sono queste:
1) Dopo aver chiesto
alla fidanzata di accompagnarlo a Stromboli per scrivere una canzone, dopo
alcuni giorni in cui non combinava nulla tranne trattare male gli amici
musicisti, e ubriacarsi continuamente, inveisce contro la fidanzata e la tratta
male dicendo che non si sente capito
2) Geniale poi come
presentano il suo rapporto con le donne. Si fidanza. Mette le corna alla ragazza
(Irene) con un altra ragazza, stupenda e che lo adora, di nome Chiara. Irene li
scopre a letto e lui che fa? Esce dalla stanza, parla con Irene e le dice “non
preoccuparti, era solo una scopata”. Poi abbandona Chiara senza dirle una parola
nè salutarla, dopo giorni di idillio romantico. Dopo qualche anno incontra
nuovamente Chiara. Mette nuovamente le corna alla fidanzata e abbandona
nuovamente Chiara, ancora una volta senza una spiegazione e senza una parola.
Verso la fine del film, abbrutito dall’alcol e senza una meta, tenta di
recuperare il rapporto con Chiara e con Irene (tutte e due in contemporanea), ma
entrambe lo abbandonano. Per giunta tenta di baciare Chiara proprio un giorno
che lei lo trova ubriaco già al mattino presto. Chiaro è il messaggio: Gaetano
era un superficiale.
3) Altrettanto geniale
poi come viene delineato il suo rapporto col padre. In una delle scene clou del
film lui, all’apice del successo, mostra una casa al padre, ma il padre la
rifiuta, perché non vuole la sua elemosina. E lui risponde arrabbiato “ma come,
finalmente ora possiamo permetterci una casa come la gente normale e non uno
schifoso sottoscala”. Il messaggio qui è molto sottile ed è duplice: la gente
che vive in un sottoscala non è normale. Un sottoscala fa schifo. Ma dietro a
questo messaggio ce n’è un altro, molto più sottile: Gaetano, come tutti, una
volta che ha avuto un po’ di soldi e si è arricchito, non ha più rispetto per le
condizioni della gente più povera che infatti viene definita “non normale”. E
infatti rinfaccia al padre di essere un poveraccio: "io non volevo diventare
come te e ci sono riuscito... non vi voglio più vedere in quel sottoscala
schifoso.. e aggiunge: "sei orgoglioso come tutti gli ignoranti". Dopodichè al
padre prende anche un infarto. Quando il padre uscirà dall'ospedale Rino ancora
una volta lo tratterà malissimo e gli causerà un altro malore. In altre parole,
lo descrivono come un pessimo personaggio, indelicato e ignorante che arriva a
far ammalare il povero padre.
Altro aspetto curioso
del film è che Rino ha una sorella, che nel film però non compare mai. Non
compare mai neanche quando, nella parte finale del film, bussa alla porta di
tutti gli amici, ubriaco e disperato, lasciato solo da tutti. Strano che Rino
quel giorno non abbia pensato di telefonare anche alla sorella no? Come è strana
un'altra circostanza. Rino morì pochi giorni prima del suo matrimonio. Doveva
sposarsi. In questo indegno e vergognoso film, invece, l'ultima scena del film
mostra lui disperato e abbandonato da tutti. Nessun cenno alla figura della
sorella. Nessun cenno al matrimonio, ma anzi, viene presentata una fattispecie
completamente opposta. Insomma, per essere un film che voleva valorizzare la
figura del cantautore, la trama presenta tali e tanti inesattezze, buchi ed
omissioni, che rimane una sola certezza: che il film è stato fatto unicamente
per oscurare le ragioni della sua morte e il valore delle sue canzoni. Per
infangarne la memoria quindi. Chi ha prodotto il film, inoltre, ha appositamente
evitato di inserire la figura della sorella, forse perchè è l'unica della
famiglia rimasta ancora viva, e che avrebbe potuto creare guai giudiziari agli
autori del film se la sua immagine fosse apparsa troppo deformata dalla fiction.
In conclusione, cosa rimane dopo la visione del film? L’idea che fosse un
ubriacone, anche egoista, non troppo intelligente, che ha scritto canzoni
superficiali e senza senso. Così non ci si stupisce se muore in un incidente. E
se un giorno qualcuno dirà che è stato ucciso, la gente dirà: "ucciso? ma come?
Era stato un incidente perchè beveva ed era ubriaco". Come succede per Pantani:
"era un drogato, si è suicidato". Che poi le perizie abbiano dimostrato che il
suo cuore era intatto non conta, per questo mondo dei mass media asservito ad
una criminalità senza scrupoli. E che la sorella e la fidanzata di Rino dicano
che quello non era Rino, che conta? L'obiettivo è riuscito. Milioni di italiani
lo considerano un ubriacone che scriveva canzoni senza senso. Il film è stato
confezionato ad arte probabilmente per screditare la figura di un artista,
proprio in un periodo particolare, ovverosia gli anni in cui, a seguito dei
delitti del mostro di Firenze, si comincia a parlare della Rosa Rossa e dei suoi
delitti. D'altronde, una bella coincidenza che il film sia prodotto dalla Ciao
Ragazzi, società che porta, guarda caso, l'acronimo dei RosaCroce e di Cristian
Rosenkreutz (CR). Di recente poi è uscito un dvd "Figlio unico", uscito insieme
alla raccolta il 02.11.2007. Giorno dei morti e data a somma 13. Un altro bello
scherzetto combinato ai danni di Rino. Tanto per mettere di nuovo una firma, se
ce ne fosse bisogno. Il dvd contiene molti filmati, tra cui quello con Morandi:
Rino a un certo punto dice: "Io conosco anche il profumo dei ministri". Una
frase senza senso per i più. Un non sense, appunto, di quelli tipici di Rino. E
invece no. Infatti Morandi si guarda intorno impaurito e cambia subito discorso,
spostandosi di nuovo sull'ironia. "Qui non possiamo parlare di ministri,
parliamo solo di canzoni. No, ma parliamo della tua ironia". Ma noi che
conosciamo il sistema, riteniamo che il film sia l’ulteriore vittoria di Rino
Gaetano. Rino era così grande e così bello, che hanno cercato di distruggerlo
anche da morto. Perché indubbiamente le sue canzoni, come del resto aveva
predetto anche lui, fanno più paura ora che quando era vivo. Ora infatti le
possiamo capire. E a Venditti che, in questi ultimi tempi, ha affermato che la
causa della morte di Rino è stata la cocaina (se ne è ricordato dopo quasi
trenta anni) possiamo rispondere una cosa. Strano, Antonello, che ti ricordi
dopo tanti anni della cocaina. In realtà la sai bene quale è la verità: lui ha
avuto quel coraggio che pochi hanno, di andare contro il sistema fino a farsi
uccidere per non rinnegare i suoi ideali. Quel coraggio che molti di quelli che
oggi hanno successo certamente non hanno avuto.
La ballata di Renzo
Quel giorno Renzo uscì,
andò lungo quella
strada
quando un’auto veloce
lo investì
quell'uomo lo aiutò
e Renzo allora partì
verso un ospedale che
lo curasse per guarìr.
Quando Renzo morì io
ero al bar
La strada era buia
si andò al San Camillo
e lì non l'accettarono
forse per l'orario
si pregò tutti i Santi
ma s'andò al San
Giovanni
e lì non lo vollero per
lo sciopero
Quando Renzo morì
io ero al bar era ormai
l'alba andarono al policlinico
ma lo si mandò via
perchè mancava il vicecapo
c'era in alto il sole
si disse che Renzo era
morto
ma neanche al Verano
c'era posto
Quando Renzo morì
io ero al bar,
al bar con gli amici
bevevo un caffè.
Anche il delitto di
Marco Pantani si è tinto di giallo.
Giallo, la
morte di Pantani e i misteri della Rosa Rossa.
Strano suicidio, quello di Marco Pantani. Così strano da spingere la
magistratura a riaprire l’inchiesta a dieci anni di distanza da quel 14 febbraio
2004. Più che un suicidio, scrive l’avvocato Paolo Franceschetti, sembra un
omicidio “firmato”, con implacabile precisione, dall’ “Ordine della Rossa
Rossa”. Fantomatica organizzazione segreta internazionale, secondo alcuni
studiosi sarebbe una potentissima cupola eversiva di tipo esoterico, con fini di
potere, dedita anche all’oscura pratica dell’omicidio rituale. «Un’ipotesi
sempre scartata come irrealistica dagli inquirenti», scrive nel suo blog lo
stesso Franceschetti, autore di studi sulla presunta relazione tra crimini e
occultismo iniziatico, incluso il caso del cosiddetto “mostro di Firenze”. Di
matrice rosacrociana, fondata sul simbolismo della Cabala e dell’ebraico antico
come la londinese “Golden Dawn” rinverdita dal “mago” Aleister Crowley, secondo
alcuni saggisti la “Rosa Rossa” sarebbe una sorta di super-massoneria deviata e
criminale. Problema: non esiste una sola prova che questa organizzazione esista
davvero. Solo indizi, benché numerosi. Chi esegue una sentenza rituale di morte,
per “punire” in modo altamente simbolico un presunto “colpevole” o addirittura
perché pensa – magicamente – di “acquisire potere” dall’uccisione “satanica” di
un innocente, secondo Franceschetti ricorre sistematicamente a pratiche sempre
identiche: in particolare la morte per impiccagione (la corda di Giuda,
traditore di Cristo), con la vittima fatta ritrovare inginocchiata, e la morte
per avvelenamento (o overdose di droga). Decine di casi di cronaca, tutti
contrassegnati da circostanze ricorrenti: manca sempre un movente plausibile,
non si trova l’arma del delitto, i nomi delle vittime hanno spesso origine
biblica, la somma dei “numeri” (data di morte, data di nascita) riconduce a
numeri speciali, per la Cabala, come l’11 e i suoi multipli. Oppure il 13, il
numero della morte dei tarocchi. E poi, la “firma”: Pantani fu ritrovato morto a
Rimini all’hotel “Le Rose”. Accanto al corpo, un biglietto in codice dal
significato criptico: “Colori, uno su tutti rosa arancio come contenta, le rose
sono rosa e la rosa rossa è la più contata”. Sul caso Pantani, sono stati
scritti fiumi di parole, reportage, libri. Tra chi non ha mai creduto alla tesi
del suicidio c’è un giornalista come Andrea Scanzi, che sul “Fatto Quotidiano”
scrive: «Troppe incongruenze. La camera era mezza distrutta, c’era sangue sul
divano, c’erano resti di cibo cinese (che Pantani odiava: perché avrebbe dovuto
ordinarlo?)». Inoltre, il campione aveva chiamato per ben due volte la
reception, parlando di «due persone che lo molestavano», ma l’aneddoto è stato
catalogato come “semplici allucinazioni di un uomo ormai pazzo”. In più, Pantani
«fu trovato blindato nella sua camera, i mobili che ne bloccavano la porta,
riverso a terra, con un paio di jeans, il torso nudo, il Rolex fermo e qualche
ferita sospetta (segni strani sul collo, come se fosse stato preso da dietro per
immobilizzarlo, e un taglio sopra l’occhio)». Uniche tracce di cocaina, quelle
ritrovate su palline di mollica di pane. Indagini superficiali: «Non esiste un
verbale delle prime persone che sono entrate all’interno della camera, non è
stato isolato il Dna delle troppe persone che entrarono nella stanza». Dettaglio
macabro e particolarmente strano, il destino del cuore di Pantani: «Venne
trafugato dopo l’autopsia dal medico, che lo portò a casa senza motivo (“Temevo
un furto”) e lo mise nel frigo senza dirlo inizialmente a nessuno», scrive
Scanzi. Prima di morire, a Rimini il ciclista aveva trascorso cinque giorni,
«per nulla lucido, accompagnato da figure equivoche. Avrebbe anche festeggiato
con una squadra di beach volley poco prima di morire: chi erano?». Altre
domande: «Perché il cadavere aveva i suoi boxer un po’ fuori dai jeans, come se
lo avessero trascinato?». Certo, aggiunge Scanzi, Pantani morì per overdose di
cocaina, «ma troppi particolari lasciano pensare (anche) a una messa in scena».
L’autopsia, peraltro, confermò che le tracce di Epo nel suo corpo erano minime,
«segno evidente di come il ciclista non avesse mai fatto un uso costante di
sostanze dopanti». E poi, tutte quelle “incongruenze”, reperibili in
libri-denuncia come “Vie et mort de Marco Pantani” (Grasset, 2007) e “Era mio
figlio” (Mondadori, 2008). E poi, soprattutto: «Che senso aveva quel messaggio
in codice accanto al cadavere?». Colori e rose, “la rosa rossa è la più
contata”. Anche i suoi amici, ricorda Franceschetti, dissero che la morte di
Pantani in quell’hotel non può esser stata casuale: forse Marco voleva «lasciare
un messaggio a qualcuno», perché «era un uomo che non faceva nulla a caso».
Meglio ancora: «Non era lui che voleva lasciare un messaggio, ma chi l’ha
ucciso», chiosa l’avvocato, sempre attento ai possibili “segni invisibili”:
«Probabilmente c’è un significato anche nel fatto che sia morto a San Valentino,
giorno in cui tradizionalmente si regalano rose alla fidanzata». Pantani
“costretto” ad andare in quel preciso albergo affinchè poi il delitto fosse
“firmato”? «Ovviamente, dire che dietro un delitto c’è la “Rosa Rossa” significa
poco: essendo la “Rosa Rossa” un’organizzazione internazionale, e contando
centinaia di affiliati in Italia, è come dire che si tratta di un delitto di
mafia o di camorra». Un’affermazione «talmente generica da essere pressoché
inutile a fini investigativi». Tuttavia, «dovrebbe essere un buon indizio
perlomeno per non archiviare la cosa come suicidio». Franceschetti considera
«evidente» l’origine «massonica» degli attacchi a Pantani, citando l’anomalo
incidente che, anni prima, lo vide protagonista a Torino: fu travolto da un’auto
che era penetrata in un’area interdetta al traffico, lungo la discesa della
collina di Superga, quella dove si schiantò l’aereo del Grande Torino. La
basilica di Superga, sull’altura che domina la città, fu costruita nel 1717,
«anno in cui venne ufficialmente fondata la massoneria». Basta questo,
all’avvocato, per concludere che si tratta di «una firma manifesta, specie alla
luce delle stranezze di quell’incidente». Tra gli “incidenti non casuali”,
Franceschetti inserisce pure quello ai danni del cantante Rino Gaetano: come
anticipato in modo inquietante dal testo di una sua canzone, “La ballata di
Renzo”, peraltro gremita di “rose rosse”, l’artista morì a Roma nella notte del
2 giugno 1981 dopo esser stato rifiutato da 5 diversi ospedali.
«Statisticamente, le probabilità che un cantante descriva la morte di qualcuno
perché viene rifiutato da 5 ospedali, e che poi muoia nello stesso identico modo
sono… nulle». Molto strana, aggiunge Franceschetti, è anche la tragica fine del
ciclista Valentino Fois, della stessa squadra di Pantani: anche lui muore per
cause da accertare, ma alcuni giornali parlano subito di overdose, «e già questo
fa venire qualche sospetto». Premessa: in Italia, muoiono per omicidio circa
2.500 persone all’anno. E altrettante finiscono suicide. Giornali e Tv si
disinteressano della stragrande maggioranza di questi episodi. «Quando però su
un fatto scatta l’attenzione dei media, in genere questo è un segnale che sotto
c’è dell’altro. Quindi viene spontanea la domanda: perché i giornali si
interessano alla morte di un ciclista poco conosciuto come Fois?». Premesso che
nello sport professionistico il doping (entro certi limiti) è pressoché
inevitabile, Franceschetti sospetta che Fois sia morto «per aver “tradito”, come
Pantani». Ovvero, i due avrebbero «pagato con la vita la loro maggiore pulizia e
onestà intellettuale rispetto al resto dell’ambiente in cui vivevano». Secondo
Franceschetti, c’è anche «non il sospetto, ma la certezza» che la verità non
verrà mai a galla. Del resto, «la maggior parte delle famiglie di queste vittime
non saprà mai la verità, la maggior parte muore senza che i familiari sospettino
un omicidio». E racconta: «Io stesso, dopo il primo incidente che mi capitò,
pensai ad un caso. E dopo il secondo pensavo che ce l’avessero con la mia
collega e che avessero manomesso contemporaneamente sia la mia moto che la sua
per maggior sicurezza di fare danni a lei. In altre parole, potevo morire senza
sapere neanche perché, e pochi avrebbero sospettato qualcosa». E aggiunge: «Ogni
volta che prendo l’auto sono consapevole che lo sterzo potrà non funzionare, che
un’auto che viene in senso inverso all’improvviso potrà sbandare e venire verso
di me, o magari che potrò avere un malore nell’anticamera di una Procura come è
successo al capo dei vigili testimone della Thyssen Krupp». La storia italiana,
aggiunge l’avvocato, è troppo gremita di “coincidenze”, depistaggi e collusioni:
le bombe nelle piazze, Ustica, Moby Prince. «In quei casi i familiari delle
vittime ormai hanno capito, ma negli altri?». La storia infinita del “mostro di
Firenze”, ad esempio, sembra il frutto di un “normale” serial killer solitario.
Secondo Franceschetti, invece, tutti quegli omicidi non sono altro che precise
esecuzioni rituali, settarie ed esoteriche, meticolosamente pianificate da un
clan criminale protetto da amicizie potenti. «Ho telefonato ai genitori di
Pantani prima di scrivere questo articolo», scriveva Franceschetti nel 2008.
«Dal loro silenzio successivo al mio fax presumo che abbiano pensato che io sia
un folle, magari un mitomane in cerca di pubblicità. E’ normale che lo pensino,
come è normale che la maggior parte delle persone che leggeranno queste righe le
prendano per un delirio». Continua Franceschetti: «Un mio amico medico legale, a
cui ho raccontato le mie “scoperte”, mi ha lasciato di stucco quando mi ha
detto: “Sì, Paolo, lo sapevo. Tutti quei suicidi in carcere per soffocamento con
buste di plastica sono impossibili dal punto di vista di medico-legale”».
L’esoterismo «è un linguaggio: se non lo conosci è come camminare per le strade
di una nazione straniera, vedi le scritte ma non ti dicono nulla, sembrano segni
innocui e invece sono messaggi precisi”». Difficile parlarne, «perché ti
prendono per matto». E il guaio è che, «quando capisci il sistema», è
problematico «continuare a fare la vita di sempre senza impazzire».
Strano suicidio, quello
di Marco Pantani, scrive “Libreidee”. Così strano da spingere la magistratura a
riaprire l’inchiesta a dieci anni di distanza da quel 14 febbraio 2004. Più che
un suicidio, scrive l’avvocato Paolo Franceschetti, sembra un omicidio
“firmato”, con implacabile precisione, dall’ “Ordine della Rossa Rossa”.
Fantomatica organizzazione segreta internazionale, secondo alcuni studiosi
sarebbe una potentissima cupola eversiva di tipo esoterico, con fini di potere,
dedita anche all’oscura pratica dell’omicidio rituale. «Un’ipotesi sempre
scartata come irrealistica dagli inquirenti», scrive nel suo blog lo stesso
Franceschetti, autore di studi sulla presunta relazione tra crimini e occultismo
iniziatico, incluso il caso del cosiddetto “mostro di Firenze”. Di matrice
rosacrociana, fondata sul simbolismo della Cabala e dell’ebraico antico come la
londinese “Golden Dawn” rinverdita dal “mago” Aleister Crowley, secondo alcuni
saggisti la “Rosa Rossa” sarebbe una sorta di super-massoneria deviata e
criminale. Problema: non esiste una sola prova che questa organizzazione esista
davvero. Solo indizi, benché numerosi. Chi esegue una sentenza rituale di morte,
per “punire” in modo altamente simbolico un presunto “colpevole” o addirittura
perché pensa – magicamente – di “acquisire potere” dall’uccisione “satanica” di
un innocente, secondo Franceschetti ricorre sistematicamente a pratiche sempre
identiche: in particolare la morte per impiccagione (la corda di Giuda,
traditore di Cristo), con la vittima fatta ritrovare inginocchiata, e la morte
per avvelenamento (o overdose di droga). Decine di casi di cronaca, tutti
contrassegnati da circostanze ricorrenti: manca sempre un movente plausibile,
non si trova l’arma del delitto, i nomi delle vittime hanno spesso origine
biblica, la somma dei “numeri” (data di morte, data di nascita) riconduce a
numeri speciali, per la Cabala, come l’11 e i suoi multipli. Oppure il 13, il
numero della morte dei tarocchi. E poi, la “firma”: Pantani fu ritrovato morto a
Rimini all’hotel “Le Rose”. Accanto al corpo, un biglietto in codice dal
significato criptico: “Colori, uno su tutti rosa arancio come contenta, le rose
sono rosa e la rosa rossa è la più contata”.
Sul caso Pantani, sono
stati scritti fiumi di parole, reportage, libri. Tra chi non ha mai creduto alla
tesi del suicidio c’è un giornalista come Andrea Scanzi, che sul “Fatto
Quotidiano” scrive: «Troppe incongruenze. La camera era mezza distrutta, c’era
sangue sul divano, c’erano resti di cibo cinese (che Pantani odiava: perché
avrebbe dovuto ordinarlo?)». Inoltre, il campione aveva chiamato per ben due
volte la reception, parlando di «due persone che lo molestavano», ma l’aneddoto
è stato catalogato come “semplici allucinazioni di un uomo ormai pazzo”. In più,
Pantani «fu trovato blindato nella sua camera, i mobili che ne bloccavano la
porta, riverso a terra, con un paio di jeans, il torso nudo, il Rolex fermo e
qualche ferita sospetta (segni strani sul collo, come se fosse stato preso da
dietro per immobilizzarlo, e un taglio sopra l’occhio)». Uniche tracce di
cocaina, quelle ritrovate su palline di mollica di pane. Indagini superficiali:
«Non esiste un verbale delle prime persone che sono entrate all’interno della
camera, non è stato isolato il Dna delle troppe persone che entrarono nella
stanza». Dettaglio macabro e particolarmente strano, il destino del cuore di
Pantani: «Venne trafugato dopo l’autopsia dal medico, che lo portò a casa senza
motivo (“Temevo un furto”) e lo mise nel frigo senza dirlo inizialmente a
nessuno», scrive Scanzi. Prima di morire, a Rimini il ciclista aveva trascorso
cinque giorni, «per nulla lucido, accompagnato da figure equivoche. Avrebbe
anche festeggiato con una squadra di beach volley poco prima di morire: chi
erano?». Altre domande: «Perché il cadavere aveva i suoi boxer un po’ fuori dai
jeans, come se lo avessero trascinato?». Certo, aggiunge Scanzi, Pantani morì
per overdose di cocaina, «ma troppi particolari lasciano pensare (anche) a una
messa in scena». L’autopsia, peraltro, confermò che le tracce di Epo nel suo
corpo erano minime, «segno evidente di come il ciclista non avesse mai fatto un
uso costante di sostanze dopanti». E poi, tutte quelle “incongruenze”,
reperibili in libri-denuncia come “Vie et mort de Marco Pantani” (Grasset, 2007)
e “Era mio figlio” (Mondadori, 2008). E poi, soprattutto: «Che senso aveva quel
messaggio in codice accanto al cadavere?». Colori e rose, “la rosa rossa è la
più contata”. Anche i suoi amici, ricorda Franceschetti, dissero che la morte di
Pantani in quell’hotel non poteva esser stata casuale: forse Marco voleva
«lasciare un messaggio a qualcuno», perché «era un uomo che non faceva nulla a
caso». Meglio ancora: «Non era lui che voleva lasciare un messaggio, ma chi l’ha
ucciso», chiosa l’avvocato, sempre attento ai possibili “segni invisibili”:
«Probabilmente c’è un significato anche nel fatto che sia morto a San Valentino,
giorno in cui tradizionalmente si regalano rose alla fidanzata». Pantani
“costretto” ad andare in quel preciso albergo affinchè poi il delitto fosse
“firmato”? «Ovviamente, dire che dietro un delitto c’è la “Rosa Rossa” significa
poco: essendo la “Rosa Rossa” un’organizzazione internazionale, e contando
centinaia di affiliati in Italia, è come dire che si tratta di un delitto di
mafia o di camorra». Un’affermazione «talmente generica da essere pressoché
inutile a fini investigativi». Tuttavia, «dovrebbe essere un buon indizio
perlomeno per non archiviare la cosa come suicidio». Franceschetti considera
«evidente» l’origine «massonica» degli attacchi a Pantani, citando l’anomalo
incidente che, anni prima, lo vide protagonista a Torino: fu travolto da un’auto
che era penetrata in un’area interdetta al traffico, lungo la discesa della
collina di Superga, quella dove si schiantò l’aereo del Grande Torino. La
basilica di Superga, sull’altura che domina la città, fu costruita nel 1717,
«anno in cui venne ufficialmente fondata la massoneria». Basta questo,
all’avvocato, per concludere che si tratta di «una firma manifesta, specie alla
luce delle stranezze di quell’incidente». Tra gli “incidenti non casuali”,
Franceschetti inserisce pure quello ai danni del cantante Rino Gaetano: come
anticipato in modo inquietante dal testo di una sua canzone, “La ballata di
Renzo”, peraltro gremita di “rose rosse”, l’artista morì a Roma nella notte del
2 giugno 1981 dopo esser stato rifiutato da 5 diversi ospedali.
«Statisticamente, le probabilità che un cantante descriva la morte di qualcuno
perché viene rifiutato da 5 ospedali, e che poi muoia nello stesso identico modo
sono… nulle». Molto strana, aggiunge Franceschetti, è anche la tragica fine del
ciclista Valentino Fois, della stessa squadra di Pantani: anche lui muore per
cause da accertare, ma alcuni giornali parlano subito di overdose, «e già questo
fa venire qualche sospetto». Premessa: in Italia, muoiono per omicidio circa
2.500 persone all’anno. E altrettante finiscono suicide. Giornali e Tv si
disinteressano della stragrande maggioranza di questi episodi. «Quando però su
un fatto scatta l’attenzione dei media, in genere questo è un segnale che sotto
c’è dell’altro. Quindi viene spontanea la domanda: perché i giornali si
interessano alla morte di un ciclista poco conosciuto come Fois?». Premesso che
nello sport professionistico il doping (entro certi limiti) è pressoché
inevitabile, Franceschetti sospetta che Fois sia morto «per aver “tradito”, come
Pantani». Ovvero, i due avrebbero «pagato con la vita la loro maggiore pulizia e
onestà intellettuale rispetto al resto dell’ambiente in cui vivevano». Secondo
Franceschetti, c’è anche «non il sospetto, ma la certezza» che la verità non
verrà mai a galla. Del resto, «la maggior parte delle famiglie di queste vittime
non saprà mai la verità, la maggior parte muore senza che i familiari sospettino
un omicidio». E racconta: «Io stesso, dopo il primo incidente che mi capitò,
pensai ad un caso. E dopo il secondo pensavo che ce l’avessero con la mia
collega e che avessero manomesso contemporaneamente sia la mia moto che la sua
per maggior sicurezza di fare danni a lei. In altre parole, potevo morire senza
sapere neanche perché, e pochi avrebbero sospettato qualcosa». E aggiunge: «Ogni
volta che prendo l’auto sono consapevole che lo sterzo potrà non funzionare, che
un’auto che viene in senso inverso all’improvviso potrà sbandare e venire verso
di me, o magari che potrò avere un malore nell’anticamera di una Procura come è
successo al capo dei vigili testimone della Thyssen Krupp». La storia italiana,
aggiunge l’avvocato, è troppo gremita di “coincidenze”, depistaggi e collusioni:
le bombe nelle piazze, Ustica, Moby Prince. «In quei casi i familiari delle
vittime ormai hanno capito, ma negli altri?».
La storia infinita del
“mostro di Firenze”, ad esempio, sembra il frutto di un “normale” serial killer
solitario. Secondo Franceschetti, invece, tutti quegli omicidi non sono altro
che precise esecuzioni rituali, settarie ed esoteriche, meticolosamente
pianificate da un clan criminale protetto da amicizie potenti. «Ho telefonato ai
genitori di Pantani prima di scrivere questo articolo», scriveva Franceschetti
nel 2008. «Dal loro silenzio successivo al mio fax presumo che abbiano pensato
che io sia un folle, magari un mitomane in cerca di pubblicità. E’ normale che
lo pensino, come è normale che la maggior parte delle persone che leggeranno
queste righe le prendano per un delirio». Continua Franceschetti: «Un mio amico
medico legale, a cui ho raccontato le mie “scoperte”, mi ha lasciato di stucco
quando mi ha detto: “Sì, Paolo, lo sapevo. Tutti quei suicidi in carcere per
soffocamento con buste di plastica sono impossibili dal punto di vista
medico-legale”». L’esoterismo «è un linguaggio: se non lo conosci è come
camminare per le strade di una nazione straniera, vedi le scritte ma non ti
dicono nulla, sembrano segni innocui e invece sono messaggi precisi». Difficile
parlarne, «perché ti prendono per matto». E il guaio è che, «quando capisci il
sistema», è problematico «continuare a fare la vita di sempre senza impazzire».
Marco Pantani
per Paolo Franceschetti fu ucciso da un complotto,
scrive Sonia Paolin su “Delitti”. E’ la tesi di Paolo Franceschetti, esperto di
massoneria ed esoterismo Marco Pantani aveva dato fastidio a molti poteri forti
che si sono uniti per eliminarlo. La morte di
Marco Pantani? Frutto di un
complotto che pare da lontano e che mescola misteri ed esoterismo, medicina,
poteri forti e massoneria. A sostenerlo è
Paolo Franceschetti, noto
esperto della materia che insieme a
Fabio Frabetti e
Stefania Nicoletti da qualche tempo ha anche aperto un blog
specifico, "Indagine sulla morte di Marco Pantani". Diverse le colpe di cui si
sarebbe macchiato il campione, tutte punite con la sua morte: parlava senza peli
sulla lingua senza aver timore di nessuno, infangando il sistema del doping,
delle case farmaceutiche e delle sponsorizzazioni; vinceva troppo, non voleva
piegarsi alle regole del gioco, e non permetteva a nessuno di dirgli quando e
come vincere; destabilizzava anche gli equilibri geopolitici internazionali.
Ora, intervistato sul blog di Vice,
la trasmissione di approfondimento e inchiesta di
Sky Tg24, Franceschetti ha
chiarito i suoi sospetti: “La stranezza di questo caso è sempre stata
considerare la morte di Marco
come un suicidio e non un omicidio. La morte di Marco è un stato un omicidio
eccellente, con coperture e depistaggi eccellenti. È sempre stato chiaro, a
chiunque, non solo a me. Credo proprio che in questo momento qualcuno stia
tremando. Magari stanno pensando a un cambio di potere, ai vertici, qualcosa
così. I gruppi di potere a cui dava fastidio
Pantani. Basta vedere la sua storia per vederlo. Nella
sua vita si è messo contro un sacco di gente. con battaglie, anche in tribunale.
Pantani era scomodo, sosteneva verità che normalmente nel mondo dello sport non
vengono portate avanti”. E cita fatti già noti, peraltro già accantonati da
molti: “Il declino di Pantani
iniziò quando rifiutò la sponsorizzazione della Fiat (divenne testimonial di
Citroen, ndr). Quella decisione gli è costata cara. C’è la droga poi, il doping,
ma anche altro. Tanto per dirtene una c’è anche la pista americana.
Marco vinceva tutto, forse
troppo. Gli americani tengono parecchio alla loro immagine nel mondo e in quel
momento avrebbero voluto che Armstrong
diventasse il loro nuovo numero uno. Pantani si era messo in mezzo”. E qui si
arriva ai mandanti: “C’è la firma dell’organizzazione che ha commissionato il
fatto, che è l’ordine della Rosa Rossa. E’ uno degli ordini più potenti nel
mondo, e i suoi componenti di grado più elevato sono ai vertici di banche,
multinazionali, istituzioni di alto livello. Non sono teppisti da quattro soldi.
Sono ovunque. Pantani
muore all’hotel Le Rose, di fianco al cadavere, sul comodino, la polizia trova
un bigliettino su cui c’è scritta una sorta di poesia, di filastrocca. “Colori,
uno su tutti rosa arancio come contenta, le rose sono rosa e la rosa rossa è la
più contata.” Poi c’è la data del delitto. Marco muore il giorno di San
Valentino. San Valentino
è il santo dell’amore e quindi delle rose, e se fai la somma dei numeri che
compongono la data, uno per uno, il numero finale è 13. Se guardi i tarocchi il
tredici corrisponde alla morte, e i tarocchi sono ovviamente un’espressione
dell’esoterismo”.
L’omicidio
massonico. Tutti lo vedono, tranne gli inquirenti,
scrive Paolo Franceschetti. Gli omicidi commessi dalla massoneria seguono tutti
un preciso rituale e sono – per così dire - firmati. Dal momento che le
associazioni massoniche sono anche associazioni esoteriche, in ogni omicidio si
ritrovano le simbologie esoteriche proprie dell’associazione che l’ha commesso;
simbologie che possono consistere in simboli sparsi sulla scena del delitto, o
nella modalità dell’omicidio, o nella data di esso. Questo articolo è però
necessariamente incompleto, nel senso che sono riuscito a capire la motivazione
e la tecnica sottesa ad alcuni delitti solo per caso, con l’aiuto di alcuni
amici, giornalisti, magistrati o semplici appassionati di esoterismo. Ma devo
ancora capire molte cose. La mia intenzione è di fornire però uno spunto di
approfondimento a chi vorrà farlo. Evitiamo di ripercorrere i principali
omicidi, perché ne abbiamo accennato nei nostri precedenti articoli
(specialmente ne“Il testimone è servito” e in quello sul mostro di Firenze).
Facciamo invece delle considerazioni di ordine generale. I miei dubbi sul fatto
che ogni omicidio nasconda una firma e una ritualità nacquero quando mi accorsi
di una caratteristica che immediatamente balza agli occhi di qualsiasi
osservatore: tutte le persone che vengono trovate impiccate si impiccano “in
ginocchio”, ovverosia con una modalità compatibile con un suicidio solo in linea
teorica; in pratica infatti, è la statistica che mi porta ad escludere che tutti
si possano essere suicidati con le ginocchia per terra, in quanto si tratta di
una modalità molto difficile da realizzare effettivamente. Così come è la
statistica a dirci che gli incidenti in cui sono capitati i testimoni di Ustica
non sono casuali; ben 4 testimoni moriranno in un incidente aereo, ad esempio,
il che è numericamente impossibile se raffrontiamo questo numero morti con
quello medio delle statistiche di questo settore. L’altra cosa che mi apparve
subito evidente fu la spettacolarità di alcune morti che suscitavano in me
alcune domande. Perché far precipitare un aereo, anziché provocare un semplice
malore (cosa che con le sostanze che esistono oggi, nonché con i mezzi e le
conoscenze dei nostri moderni servizi segreti, è un gioco da ragazzi)? Perché
“suicidare” le persone mettendole in ginocchio, rendendo così evidente a
chiunque che si tratta di un omicidio? (a chiunque tranne agli inquirenti,
sempre pronti ad archiviare come suicidi anche i casi più eclatanti). Perché nei
delitti del Mostro di Firenze una testimone muore con una coltellata sul pube?
(anche questo caso archiviato come “suicidio”). Perché una modalità così
afferrata, ma anche così plateale, tanto da far capire a chiunque il
collegamento con la vicenda del mostro? Perché firmare i delitti con una rosa
rossa, come nel caso dell’omicidio Pantani, in modo da rendere palese a tutti
che quell’omicidio porta la firma di questa associazione? Ricordiamo infatti che
Pantani morì all’hotel Le Rose e che accanto al suo letto venne trovata una
poesia apparentemente senza senso che diceva: “Colori, uno su tutti rosa arancio
come contenta, le rose sono rosa e la rosa rossa è la più contata”. Ricordiamo
anche che Pantani ebbe un incidente (per il quale fece causa alla città di
Torino) proprio nella salita di Superga, ovverosia la salita dove sorge la
famosa cattedrale che fu eretta nel 1717, data in cui la massoneria moderna ebbe
il suo inizio ufficiale. Se questi particolari non dicono nulla ad un
osservatore qualsiasi, per un esperto di esoterismo dicono tutto. Tra l’altro la
collina di Superga è quella ove si schiantò l’aereo del Torino Calcio, ove morì
un’intera squadra di calcio con tutto il personale al seguito. Altra coincidenza
inquietante, a cui pare che gli investigatori non abbiano mai fatto caso. Perché
far morire due testimoni di Ustica in un incidente come quello delle frecce
tricolori a Ramstein, in Germania, destando l’attenzione di tutto il mondo? La
domanda mi venne ancora più forte il giorno in cui con la mia collega Solange
abbiamo avuto un incidente di moto. Con due moto diverse, a me è partito lo
sterzo e sono finito fuori strada; mi sono salvato per un miracolo, in quanto
l’incidente è capitato nel momento in cui stavo rallentando per fermarmi e
rispondere al telefono; Solange, che fortunatamente è stata avvertita in tempo
da me, ha potuto fermarsi prima che perdesse la ruota posteriore. Ora, è ovvio
che un simile incidente – se fossimo morti - avrebbe provocato più di qualche
dubbio. Magari a qualcuno sarebbe tornato in mente il caso dei due fidanzati
morti in un incidente analogo qualche anno fa: Simona Acciai e Mauro Manucci. I
due fidanzati morirono infatti in due incidenti (lui in moto, lei in auto)
contemporanei a Forlì. Nel caso nostro, due amici e colleghi di lavoro morti
nello stesso modo avrebbero insospettito più di una persona e sarebbero stati un
bel segnale per chi è in grado di capire: sono stati puniti. Per un po’ di tempo
pensai che queste modalità servivano per dare un messaggio agli inquirenti:
firmando il delitto tutti quelli che indagano, se appartenenti
all’organizzazione, si accorgono subito che non devono procedere oltre. Inoltre
ho pensato ci fosse anche un altro motivo. Lanciare un messaggio forte e chiaro
di questo tipo: inutile che facciate denunce, tanto possiamo fare quello che
vogliamo, e nessuno indagherà mai realmente. Senz’altro queste due motivazioni
ci sono. Ma ero convinto che ci fosse anche dell’altro, specie nei casi in cui
la firma è meno evidente. La risposta mi è arrivata un po’ più chiara quando ho
scoperto che Dante era un Rosacroce (dico “scoperto” perché non sono e non sono
mai stato un appassionato di esoterismo). Ora la massoneria più potente non è
quella del GOI, ma è costituita dai Templari, dai Rosacroce e dai Cavalieri di
Malta. E allora ecco qui la spiegazione dell’enigma: la regola del contrappasso.
Nell’ottica dei Rosacroce, chi arriva al massimo grado di questa organizzazione,
ha raggiunto la purezza della Rosa. Nella loro ottica denunciare uno di loro, o
perseguirlo, è un peccato. E il peccato deve essere punito applicando la regola
del contrappasso. Quindi: volevi testimoniare in una vicenda riguardante un
aereo caduto? Morirai in un incidente aereo. Volevi testimoniare in un processo
contro il Mostro di Firenze? Morirai con l’asportazione del pube, cioè la stessa
tecnica usata dal Mostro sulle vittime. La regola del contrappasso è evidente
anche ad un profano nel caso di Luciano Petrini, il consulente informatico che
stava facendo una consulenza sull’omicidio di Ferraro, il testimone di Ustica
trovato “impiccato” al portasciugamani del bagno. Petrini morirà infatti colpito
ripetutamente da un portasciugamani. Nel mio caso e quello della mia collega il
“peccato” consiste invece nell’aver denunciato determinate persone appartenenti
alla massoneria (in particolare quella dei Rosacroce). Per colmo di sventura poi
andai a fare l’esposto proprio da un magistrato appartenente all’organizzazione
(cosa che ovviamente ho scoperto solo dopo gli incidenti, decriptando la lettera
che costui mi inviò successivamente). Che è come andare a casa di Provenzano per
denunciare Riina. Nel caso di Fabio Piselli, invece, il perito del Moby Prince
che doveva testimoniare riguardo alla vicenda dell’incendio capitato al
traghetto, costui è stato stordito e messo in un’auto a cui hanno dato fuoco,
forse perché il rogo dell’auto simboleggiava il rogo della nave. Talvolta invece
il simbolismo è più difficile da decodificare e si trova nelle date, o in
collegamenti ancora più arditi, siano essi in casi eclatanti, o in banali fatti
di cronaca. Nel caso del giudice Carlo Palermo che il 02 aprile del 1985
tentarono di uccidere con un’autobomba a Pizzolungo (Trapani). Il giudice
Palermo era stato titolare di un’ampia indagine sul traffico di armi ed aveva
indagato sulla fornitura di armi italiane all’Argentina durante la guerra per le
isole Falkland, guerra scoppiata proprio il 02 aprile 1982 con l’invasione
inglese delle isole. L’autobomba scoppiò quindi nella stessa data, e tre anni
dopo (tre è un numero particolarmente simbolico). Ed ancora per quanto riguarda
l’omicidio di Roberto Calvi. Come ricorda il giudice Carlo Palermo: “Nella
inchiesta della magistratura di Trento un teste (Arrigo Molinari, iscritto alla
P2), dichiarò che Calvi – attraverso le consociate latino-americane del Banco
Ambrosiano – aveva finanziato l’acquisto, da parte dell’Argentina, dei missili
Exocet e in definitiva l’intera operazione delle isole Falkland”. I primi
missili Exocet affondarono due navi inglesi (la Hms Sheffield e Atlantic
Conveyor). Il 18 giugno 1982 Roberto Calvi fu trovato morto impiccato a Londra
sotto il ponte dei frati neri (nome di una loggia massonica inglese). Inoltre il
ponte era dipinto di bianco ed azzurro che sono i colori della bandiera
argentina. Nel caso del delitto Moro la scena del delitto è intrisa di
simbologie, dal fatto che sia stato trovato a via Caetani (e Papa Caetani era
Papa Bonifacio VIII, che simpatizzava per i Templari e a cui mossero le stesse
accuse rivolte a quest’ordine) alla data del ritrovamento, al fatto che sia
stato trovato proprio in una Renault 4 Rossa. Se Renault Rossa sta per Rosa
Rossa, la cifra 4 farebbe riferimento al quatre de chiffre (ma forse anche al
numero di lettere della parola “rosa”). Il mio articolo termina qui. Non voglio
approfondire per vari motivi. In primo luogo perché non sono un appassionato di
esoterismo e scendere ancora più a fondo richiederebbe uno studio approfondito e
molto tempo a disposizione, che io non ho. Il mio articolo è dettato invece
dalla voglia di indurre il lettore ad approfondire. E dalla voglia di dire a
chiunque che molti misteri d’Italia, non sono in realtà dei misteri, se si sa
leggere a fondo nelle pieghe del delitto. La conoscenza approfondita
dell’esoterismo e del modo di procedere delle associazioni massoniche
garantirebbe agli inquirenti, il giorno che prenderanno coscienza del fenomeno,
un notevole miglioramento dal punto di vista dei risultati investigavi. Questo
consentirebbe anche di capire alcuni meccanismi della politica italiana, che
spesso nelle loro simbologie si rifanno a queste organizzazioni. La croce della
democrazia Cristiana, ad esempio, probabilmente non è altro che la Croce
templare; mentre la rosa presente nel simbolo di molti partiti è probabilmente
nient’altro che la rosa dei RosaCroce. Quando dico queste cose mi viene risposto
spesso che la rosa della “Rosa nel pugno” è in realtà il simbolo dei radicali
francesi. E io rispondo: appunto, il simbolo dei RosaCroce, che non è
un’organizzazione italiana, ma internazionale. E che non ricorre solo per i
radicali ma anche per i socialisti e per altri partiti di destra. Questo
consentirebbe di capire, ad esempio, il significato del cacofonico nome “Cosa
Rossa” che si voleva dare alla Sinistra Arcobaleno; un nome così brutto
probabilmente non è un caso. Secondo un mio amico inquirente potrebbe derivare
da Cristian Rosenkreuz, il mitico fondatore dei RosaCroce. Mentre la Rosa Bianca
potrebbe fare riferimento alla guerra delle due rose, in Inghilterra; guerra che
terminò con un matrimonio tra Rosa bianca e Rosa Rossa. Al lettore appassionato
di esoterismo il compito di capire il significato delle varie morti che qui
abbiamo solo accennato. Non ho ancora capito, ad esempio, il perché dei
cosiddetti “suicidi in ginocchio”. Secondo un mio amico le gambe piegate trovano
un parallelismo con l’impiccato del mazzo dei tarocchi, che è sempre raffigurato
con una gamba piegata. Era la punizione riservata un tempo al debitore, che
veniva appeso in quel modo affinchè tutti potessero vedere la sua punizione e
potessero deriderlo. E infatti, tutti quelli che vedono un suicidio in ginocchio
capiscono che si trattava di un testimone scomodo e che si tratta di un
omicidio. Tutti, tranne gli inquirenti. (Io speriamo che non mi suicido).
L’omicidio
massonico - Il caso Pantani e il caso Fois,
scrive ancora Paolo Franceschetti.
Premessa.
In questo articolo approfondiamo alcuni degli argomenti trattati nel precedente
articolo sull’omicidio massonico e chiariamo alcuni dubbi che l’articolo aveva
suscitato specialmente in merito al caso Pantani. In primo luogo l’articolo
precedente terminava con una domanda. Mi chiedevo cioè il motivo dell’immenso
numero di persone “suicidate” (come si dice in gergo) mediante impiccagione, e
facendo toccare alla maggioranza di essere le ginocchia per terra. Voglio poi
rispondere alle molte domande che mi vengono spesso rivolte: come si distingue
l’omicidio massonico? E perché dico che Pantani fu quasi sicuramente ucciso?
Impiccagioni e avvelenamenti, overdose.
In primo luogo un lettore mi ha inviato la sua spiegazione. il "suicidio in
ginocchio" rappresenta "l'omicidio consacrato" cioè la morte per "volere
divino"... cosi come si viene investiti degli onori alla vita, cosi si viene
investiti degli onori alla morte. Mi è pervenuto inoltre uno scritto, tratto dal
libro di un esoterista che ha, appunto, trattato questo argomento che
riportiamo. Il libro è di Lino Lista e si intitola: “Raimondo di Sangro. Il
principe dei veli di pietra”. In forma romanzata vengono rivelati alcuni aspetti
del ritualismo massonico che hanno quindi dato una risposta alla mia domanda sul
motivo dei tanti impiccati. La corda e l’impiccagione sono i simboli di Giuda e
del tradimento di Cristo. Ma il lavoro di Lino Lista svela anche un altro
mistero. Un’altra modalità frequente di uccisione, tanto frequente da gettare
più di un sospetto, ad esempio, è quella dell’avvelenamento da overdose, in cui
sono incappati, per fare qualche nome, il ciclista Pantani, poi di recente un
altro componente della sua squadra, il ciclista Valentino Fois, e a Viterbo il
medico Manca, ovvero il medico che pare abbia curato il boss mafioso Bernardo
Provenzano. Muoiono poi avvelenati anche molti testimoni di processi importanti.
Morì avvelenato in carcere Sindona. E poi molti “malori” improvvisi, talvolta
nell’anticamera di un giudice, in un tribunale, o nella buovette di Montecitorio
come capitò al generale Giorgio Manes. Voglio citare integralmente il passo del
libro di Lino Lista: La corda...(omissis)...è il segno dominante, che mai deve
mancare, di una vendetta massonica. Con riferimento alla leggenda di Hiram,
volendo spandere un maggior numero d’indizi, convenientemente si potrebbero
lasciare accanto al cadavere del giustiziato, seppur di veleno: dell’acqua, in
ricordo della fontana alla quale il Vendicatore smorzò la sete; un osso spezzato
di cane, in onore dell’Incognito che si mutò in tal bestia; un abito nero, in
memoria del lutto per Padre Hiram. Volendo eccedere, ma mai una società segreta
dovrebbe eccedere perchè troppi indizi talvolta sono considerati alla stregua di
una prova, si potrebbe collocare sulla salma del traditore un mattone, simbolo
muratorio. Queste morti da overdose, quindi, non sono un caso. Anche
l’avvelenamento è una modalità “massonica” perché simboleggia la morte per mano
del serpente, simbolo dell’infedeltà e dell’inganno. Ecco quindi perché Pantani
morirà dopo aver ingerito diverse dosi di coca. Perché sostengo che sia un
omicidio? Perché ogni qualvolta l’incidente, o il malore, o il suicidio, sono
provocati, e sono quindi un omicidio, immancabilmente partono, a seguito del
fatto, i depistaggi e gli occultamenti che solo un potere come quello massonico
è in grado di fornire: sparizione dei fascicoli dai tribunali, morte dei
testimoni, la pervicace volontà degli inquirenti nell’ignorare determinate prove
(per collusione, paura, o per la mancata conoscenza del problema), le
irregolarità procedurali, ecc…
Il caso
Pantani.
Esaminiamo il caso Pantani, così come ce lo descrive un giornalista, Philippe
Brunel, in un recente libro “Gli ultimi giorni di Marco Pantani” su cui ci
basiamo per la nostra ricostruzione. E’ noto che Pantani morirà all’hotel Le
rose di Rimini per una presunta overdose da cocaina. Anche qui troviamo tutti
gli elementi di un omicidio massonico, ovverosia le firme, nonchè tutte le
modalità procedurali investigative che gli inquirenti seguono quando il delitto
è massonico.
Ad esempio troveremo:
- testimoni che
cambieranno versione;
- gli inquirenti che
ignorano particolari fondamentali nell’indagine: ad esempio nel cestino dei
rifiuti della stanza dell’hotel verranno rivenuti resti di una cena presa da un
ristorante cinese. Ma Pantani non mangiava cibo cinese. Allora chi c’era con lui
quell’ultima notte?
- Sul corpo compaiono
segni di colluttazione ma nessuno accerterà mai se, ad esempio, sotto le unghie
compaiano o meno dei resti di DNA altrui per verificare se Pantani fu forzato a
ingerire cocaina (v. pag. 278).
- Errori e omissioni
varie nelle autopsie.
- Una volante della
polizia, con due agenti, interverrà sul luogo dell’incidente, ma non redigerà
mai il verbale relativo. Perché questa irregolarità nelle procedure?
- Le varie perizie
medico legali fanno una gran confusione sull’ora della morte che collocano tra
le 11,30 (la perizia del dottor Fortuni) e le 19 (il medico Toni).
Dire esattamente
quanti siano i massoni a Bologna è difficile, per quanto si parli di circa
450 affiliati. Vicino alla massoneria viene indicato il medico
legale Giuseppe Fortuni, che si occupò di alcune perizie sulla
morte del ciclista Marco Pantani, stroncato da un’overdose di
cocaina il 14 febbraio 2001 in un residence di Rimini, scrive Antonella Beccaria
su “Il Fatto Quotidiano”. E lo stesso accade per l’imprenditore Vittorio
Casale, uomo di Massimo D’Alema e che, tra le molte
opere di cui si è occupato, ha partecipato a progetti di ristrutturazione del
patrimonio di Propaganda Fides e di enti religiosi.
- Il medico legale che
dopo l’autopsia si accorge di essere seguito.
- La camera fu trovata
in disordine come se ci fosse stato un corpo a corpo.
Poi ci sono le domande
irrisolte.
- Perché Pantani,
volendosi suicidare, prende una stanza in un albergo a pochi chilometri dalla
casa dove abitava?
- Perché prima di
suicidarsi ci resta qualche giorno? Cosa lo fa rimanere in una stanza di albergo
quando aveva la sua abitazione lì vicino?
- Uno degli inquirenti
dichiara al giornalista di avere avuto pressioni dal Ministero dall’interno per
concludere in fretta l’indagine. Ma il ministero non dovrebbe avere fretta di
concludere; casomai dovrebbe avere la volontà di accertare la verità senza
lasciare dubbi. Curioso poi che il Ministero si disinteressi del fatto che dopo
decenni non sia mai venuta fuori la verità per stragi come Ustica, o per il
sequestro Moro, e improvvisamente abbia fretta di concludere per un personaggio
come Pantani. Difficile pensare che sotto ci sia una voglia di arrivare
velocemente alla verità, dato che l’occultamento della verità è sistematico
nella storia giudiziaria italiana. Mai abbiamo sentito un politico affermare che
nel programma elettorale c’era la volontà di scoprire la verità sulle tante
stragi impunite per dare giustizia alle migliaia di morti e alle decine di
migliaia di famiglie delle vittime delle stragi. Mai. Anzi, in compenso alcuni
degli autori di crimini assurdi, come l’ex terrorista D’Elia, hanno addirittura
avuto incarichi istituzionali (sottosegretario alla camera nel governo Prodi).
Personaggi che hanno avuto pesanti responsabilità in vicende come il sequestro
Moro verranno addirittura fatti presidenti della Repubblica (Cossiga). Nessuna
fretta di scoprire chi ha abbattuto l’aereo di Ustica, nessuna fretta di
arrivare alla verità sul Moby Prince, nessuna fretta di scoprire chi c’è dietro
ai delitti del Mostro di Firenze, dietro ai Georgofili, dietro a Piazza Fontana,
dietro alla strage di Bologna. Ma una gran fretta di chiudere il caso Pantani.
Curioso no? Tutte queste contraddizioni, depistaggi, ecc., sono sempre l’indizio
sicuro della presenza della massoneria. In alternativa può ipotizzarsi che si
tratti di incuria o superficialità nell’indagine. Ma si tratta di incuria e
superficialità troppo ricorrenti per essere casuali. Poi ci sono le firme.
Quelle firme che chi non si è mai occupato di massoneria non riesce a vedere. Ma
immediatamente visibili per chi vive in mezzo a queste vicende. Anzitutto
Pantani muore all’hotel Le Rose, il cui nome potrebbe non essere casuale ma
essere la firma della Rosa Rossa. D’altronde anche i suoi amici diranno che la
morte di Pantani in quell’hotel non deve essere un caso, ma forse voleva
lasciare un messaggio a qualcuno perché lui era un uomo che non faceva nulla a
caso (pag. 52). Forse, aggiungo io, non era lui che voleva lasciare un
messaggio, ma chi l’ha ucciso. E poi viene trovato accanto al corpo un biglietto
con una frase apparentemente senza senso: Colori, uno su tutti rosa arancio come
contenta, le rose sono rosa e la rosa rossa è la più contata. Non sono in grado
di capire il senso di questo biglietto; ci vorrebbe un esperto e pochi in Italia
sono in grado di capire questi messaggi. Ma indubbiamente sembra un messaggio in
codice. Probabilmente c’è un significato anche nel fatto che sia morto a San
Valentino, giorno in cui tradizionalmente si regalano rose alla fidanzata.
Qualcuno ipotizza che abbia un senso anche la data della sua morte: 14/02/2004,
data la cui somma fa 13, che nelle carte dei tarocchi non a caso è la carta
della morte. Nonostante non sia in grado di decodificare tutti i particolari è
evidente però che Pantani fu in qualche modo costretto ad andare in quel preciso
albergo affinchè poi il delitto fosse firmato. Ovviamente dire che dietro un
delitto c’è la Rosa Rossa significa poco. Essendo la Rosa Rossa
un’organizzazione internazionale, e contando centinaia di affiliati in Italia, è
come dire che si tratta di un delitto di mafia o di camorra. Cioè significa
affermare una cosa talmente generica da essere pressocchè inutile a fini
investigativi, e tuttavia dovrebbe essere un buon indizio perlomeno per non
archiviare la cosa come suicidio. D’altronde che gli attacchi a Pantani
provenissero da ambienti massonici risulta evidente dal fatto che qualche anno
prima ebbe un incidente anomalo nella discesa di Superga. Un auto entrò nella
zona vietata al traffico e investì Pantani e altre due persone. Un incidente
casuale? Difficile, da pensarsi, perché sulla collina di Superga sorge quella
cattedrale omonima, che venne costruita nel 1717, anno in cui venne
ufficialmente fondata la massoneria. Una basilica e una collina, insomma, che
hanno un particolare significato per la massoneria. Per chi sa anche solo poche
cose sulla massoneria si tratta di una firma manifesta, specie alla luce delle
stranezze di quell’incidente (inspiegabile ad esempio è come avesse fatto la
macchina a inserirsi nella zona vietata, tanto che Pantani fece causa alla città
di Torino per questo fatto).
La parola
ai testimoni.
Per chi conosce le vicende delle stragi italiane gli incidenti stradali per
rottura dei freni o dello sterzo, non sono una novità, I testimoni di queste
stragi, i personaggi scomodi, muoiono sempre così: non solo impiccati e
avvelenati, ma anche in incidenti banali in cui l’auto (o la moto) escono di
strada all’improvviso per un malfunzionamento. Qualcuno ogni tanto si salva.
Ricordo a memoria – tra gli scampati - il carabiniere Placanica (implicato nei
fatti del G8), il giudice Forleo (ma non così fu per i genitori, che morirono in
un incidente analogo senza ovviamente che gli inquirenti volessero indagare).
Persino il famoso Enrico Berlinguer disse di aver avuto un incidente da cui si
era salvato per miracolo, durante un suo viaggio in Bulgaria nel 1973, in cui
morirono però altre due persone; disse che l’incidente era voluto, ma nessuno
gli credette. Di recente Fabio Piselli, scampato al rogo della sua auto, più
volte nominato nei miei articoli. Ma in tanti hanno avuto “incidenti anomali” e
non si sono salvati. Ne abbiamo parlato in precedenti articoli e non voglio
ripetermi. Voglio invece ricordare alcuni morti del mondo dello sport e dello
spettacolo. Ayrton Senna, cui fu montato male lo sterzo della sua formula 1. Per
non parlare del Torino Calcio; l’aereo ebbe un guasto imprecisato e si schiantò
contro – guarda tu che caso - la collina di Superga. Il cantante Rino Gaetano
che ebbe due incidenti identici, con la stessa auto; nel primo incidente si
salvò; nel secondo morì, anche perché 5 ospedali si rifiutarono
(misteriosamente) di prenderlo in cura. Il cantante morì il 2 giugno 1981 nello
stesso identico modo in cui muore il protagonista di una sua canzone, La ballata
di Renzo. Statisticamente le probabilità che un cantante descriva la morte di
qualcuno perché viene rifiutato da 5 ospedali, e che poi muoia nello stesso
identico modo sono…. nulle. E statisticamente, le probabilità che qualcuno
svolga veramente delle indagini sono le stesse di questi incidenti: nulle.
Mass
Media e delitti.
Molta strana è anche la morte del ciclista Valentino Fois, della squadra di
Pantani. Anche lui muore per cause da accertare, ma alcuni giornali parlano di
overdose. E già questo fa venire qualche sospetto, in quanto probabilmente muore
nello stesso modo del suo ex amico. Occorre a questo punto fare una
considerazione di ordine generale sui mass media in Italia. In Italia muoiono
per omicidio circa 2500 persone all'anno. E altrettante ne muoiono suicide.
Giornali e Tv si disinteressano di questi fatti, selezionando accuratamente solo
le notizie che piacciono e sono funzionali al sistema. Quando però su un fatto
scatta l’attenzione dei media, in genere questo è un segnale che sotto c’è
dell’altro. Quindi viene spontanea la domanda. Perché i giornali si interessano
alla morte di un ciclista poco conosciuto come Fois? E perché poi, nei pochi
secondi che i TG dedicano alla notizia, occorre precisare che era implicato in
un furto di portatili? Quand’anche si voglia dar risalto alla morte di un uomo,
non c’è alcuna necessità di informare il pubblico che costui – forse – aveva
rubato dei PC. In primo luogo perché la notizia è generica e posta in forma
dubitativa. In secondo luogo perché non si capisce quale collegamento possa
sussistere tra un furto di PC e una morte per overdose. Il sospetto che sia un
omicidio, e che la televisione abbia volutamente voluto riportare l’immagine di
una persona drogata e dedita al furto, è molto forte. Il messaggio che si vuole
trasmettere è questo: è morto un ladro e per giunta drogato e depresso. Ma chi
invece ha capito come funziona l’informazione in Italia capisce chiaramente un
altro messaggio: probabilmente si tratta di un omicidio e c’è sotto qualcosa. E
allora il pensiero corre al fatto che qualche prima avesse rilasciato un
intervista alle jene. Aggiungiamo poi una cosa. Chi frequenta a livello
professionistico il mondo dello sport sa che il doping è un fenomeno
assolutamente diffuso, nel senso che probabilmente non è possibile partecipare a
qualsiasi tipo di sport senza doparsi. Nella mia esperienza del passato, per
anni ho praticato Body Building e ho seguito corsi per diventare istruttore di
questa disciplina. E il doping era una materia di studio assolutamente
ufficiale, nel senso che nella preparazione atletica di uno sportivo
professionista non si poteva prescindere dal doping. Il problema era solo come
eludere i controlli, stare attenti ai tempi di eliminazione della sostanza
ecc... C’è quindi il forte sospetto che Fois sia morto in questo modo per aver
“tradito”, come Pantani, e che i due abbiano pagato con la vita la loro maggiore
pulizia e onestà intellettuale rispetto al resto dell’ambiente in cui vivevano.
Considerazioni finali.
C’è anche (non il sospetto ma) la certezza, che la verità non verrà mai a galla.
Anzi, a dire queste cose, purtroppo, si rischia di passare per matti o
visionari. La cosa che mi dà tristezza, in tutta questa vicenda, non è la
gravità delle collusioni istituzionali a tutti i livelli, né la scarsa
preparazione di molti inquirenti in materia che si traduce in una mancata tutela
del cittadino. Questo ho imparato ad accettarlo, perché viviamo in una
democrazia troppo giovane perché sia veramente una democrazia. Le mentalità e i
costumi di secoli non possono cambiare in pochi anni. L’oligarchia mascherata in
cui viviamo, in fondo, un giorno dovrà finire per dare spazio ad una nuova era.
Ciò che mi dà tristezza è pensare che la maggior parte delle famiglie di queste
vittime non saprà mai la verità. La maggior parte muore senza che i familiari
sospettino un omicidio. Io stesso dopo il primo incidente che mi capitò pensai
ad un caso. E dopo il secondo pensavo che ce l’avessero con la mia collega e che
avessero manomesso contemporaneamente sia la mia moto che la sua per maggior
sicurezza di fare danni a lei. In altre parole; potevo morire senza sapere
neanche perché e pochi avrebbero sospettato qualcosa. Solo dopo qualche tempo mi
spiegarono chi ce l’aveva come me e perché. Ora, perlomeno, so che mi potrebbe
succedere qualcosa e so anche il perché. Ogni volta che prendo l’auto sono
consapevole che lo sterzo potrà non funzionare, che un auto che viene in senso
inverso all’improvviso potrà sbandare e venire verso di me, o magari che potrò
avere un malore nell’anticamera di una procura come è successo al capo dei
vigili testimone della Tyssen Krupp. Ma all’epoca dei primi incidenti, non avevo
neanche il sospetto di essere stato “condannato a morte”. Perché non ero
consapevole di quale colpa avessi commesso e di quale peccato mi fossi
macchiato.
Mi domando se Senna sapeva il destino che lo aspettava, se i familiari avranno
capito. I familiari del Torino Calcio cosa penseranno di quell’incidente
terribile? E i genitori di Fois? E la Forleo, cui scrissi “una lettera aperta”
dalle pagine di questo blog… avrà capito esattamente cosa le è successo oppure
penserà che il suo incidente d’auto sia stato casuale? I familiari delle vittime
di via dei Goergofili, di Ustica, del Moby Prince, hanno capito. Lì sono troppo
grosse le collusioni, troppo evidenti gli omicidi e i depistaggi perché qualcuno
non capisca. Ma gli altri? I familiari dei testimoni di processi apparentemente
normali, come quelli della Tyssen Krupp, o del Mostro di Firenze, che
apparentemente sembra un normale caso di un serial Killer? E i familiari di
tutte quelle persone che parevano condurre una vita normale, perché il delitto è
maturato in un luogo ove nessuno sospetterebbe l’ingerenza così pesante dei
cosiddetti poteri occulti, come il mondo sportivo? Ho telefonato ai genitori di
Pantani prima di scrivere questo articolo. Dal loro silenzio successivo al mio
fax presumo che abbiano pensato che io sia un folle, magari un mitomane in cerca
di pubblicità. E’ normale che lo pensino, come è normale che la maggior parte
delle persone che leggeranno queste righe le prendano per un delirio. Allora
voglio ricordare le parole dell’onorevole Falco Accame, a proposito degli
incidenti anomali (come quello capitato ai genitori del giudice Forleo) o dei
suicidi dei vari testimoni di processi importanti. Parlavamo dell’incidente
capitato al giudice Forleo, e mi disse “inizialmente, quando mi occupai di
queste cose, credevo al caso. Non volevo credere che fosse una cosa voluta
perché mi pareva fantascienza. Poi, quando mi accorsi che i testimoni morivano
tutti, sistematicamente, ho capito… E’ una cosa che è difficile da accettare.”
Questo articolo, come il precedente, è scritto per tutti i familiari di persone
suicidate, impiccate, morte in incidenti inspiegabili che hanno sempre capito
che la versione ufficiale data dagli inquirenti non quadrava, affinchè perlomeno
loro sappiano la verità. Oramai sono troppe le vittime sparse per la penisola,
perché non si cominci a sospettare. E sono troppi i sopravvissuti perché
qualcosa prima o poi non venga fuori. Oramai parlo con tante persone esperte e
mi confronto. Molti, tanti, hanno capito. Un mio amico medico legale, a cui ho
raccontato le mie “scoperte” mi ha lasciato di stucco quando mi ha detto “si
Paolo, lo sapevo. Lo sapevo perché da medico legale mi rendo conto quando ci
prendono in giro in TV e sui giornali. Tutti quei suicidi in carcere per
soffocamento con buste di plastica sono impossibili dal punto di vista di medico
legale. Analizzando alcuni dei più importanti casi dal punto di vista medico
legale mi sono accorto che ci prendono in giro. E poi sono un appassionato di
esoterismo, e quindi i loro simboli e messaggi io li vedo. Vedi? L’esoterismo è
un linguaggio. Se non lo conosci è come camminare per strade di una nazione
straniera; vedi la gente, vedi le scritte, ma non ti dicono nulla; in certi casi
potrebbero sembrarti innocui disegnini. Ma se invece lo conosci allora riesci a
leggere oltre la superficie e capire i messaggi profondi che vengono lanciati e
gli innocui disegnino diventano frasi precise. Capisci tutto, ma con la maggior
parte delle persone non puoi parlare perché ti prendono per matto. E il problema
principale, quando capisci il sistema, è continuare a fare la vita di sempre
senza impazzire”. Questo, signori, è il sistema in cui viviamo ma con un po’ di
studio e di intuito si può imparare a capirlo. Il paradosso è che non sono mai
stato un appassionato né di gialli, né di spionaggio, né di esoterismo; ma credo
che neanche la più fervida fantasia di qualsiasi scrittore abbia mai immaginato
un sistema del genere. La realtà, per chi la vuole vedere, supera sempre di gran
lunga la fantasia. Anche quella di Stephen king, che forse non a caso ha scritto
una serie di telefilm che si intitola The Red Rose, e che forse per i suoi libri
non si è ispirato alla sua sola fantasia (ad es. nei “Lupi del Calla”, occorre
proteggere una sola rosa rossa che sta in una Torre nera; e se la Rosa venisse
distrutta per qualche motivo la Torre cadrebbe insieme alla Rosa). Ps finale.
Quando facevo il quarto ginnasio rubai tre biscotti (erano dei Ringo per la
precisione) al mio miglior amico, Daniele. Voglio precisare, in caso di suicidio
da parte mia, che i due fatti non sono collegati, al fine di evitare che i media
mi facciano lo scherzo di Fois e che riportino la notizia facendomi passare per
un ladro di biscotti. Peraltro confessai il mio crimine a Daniele, il quale dopo
25 anni non manca mai di ricordarmelo.
L'omicidio
massonico. L'omicidio rituale e le difficoltà di accertamento,
scrive Paolo Franceschetti.
Il delitto rituale e la giustizia. Cenni al delitto di Cogne e quello di Erba.
1. Premessa. 2. L’omicidio rituale: concetto. 3. Come riconoscere l’omicidio
rituale. 4. Il calcolo della data 5. Due esempi pratici. I Delitti di Cogne ed
Erba. 6. Problematiche di accertamento dell’omicidio rituale. 7. Ragioni
storiche e culturali dell’attuale situazione. 8. Un aneddoto conclusivo.
Premessa.
L’omicidio rituale è uno degli omicidi più diffusi da secoli. Tutt’oggi sono
delitti rituali molti dei delitti “inspiegabili” della nostra cronaca
quotidiana; tali delitti sono inspiegabili e misteriosi infatti solo perché per
una serie di motivi (coperture ad alti livelli, disinformazione da parte della
gente comune, ecc.) vengono trattati come delitti comuni. Da qui le
contraddizioni nelle indagini, gli aspetti oscuri in vicende che sono quasi
quotidianamente all’attenzione dei mass media come i delitti di Cogne, Erba,
Meredith e Garlasco. Inoltre, a parlare di omicidi rituali, si finisce per
essere presi per matti, quindi quei pochi che intravedono la verità spesso
tacciono, mentre quelli che ne parlano apertamente come Gabriella Carlizzi,
vengono considerati dei visionari.
L’omicidio rituale. Concetto.
Vediamo cos’è l’omicidio rituale, per poi capire il motivo dell’apparente
disinteresse degli apparati investigativi e della letteratura scientifica (sia
essa psichiatrica o forense). L’omicidio rituale è quello compiuto non per
motivi contingenti e variabili, ma per una finalità precisa, ulteriore al
delitto stesso, e funzionale agli interessi di un gruppo organizzato (religioso,
sociale, o di altro tipo) o del singolo. Per essere annoverato nella categoria
degli omicidi rituali il fatto deve presentare delle caratteristiche costanti,
funzionali al raggiungimento dello scopo finale. In tal senso sono omicidi
rituali, oltre ai delitti di gruppi satanici, molti delitti di mafia (non
tutti), i delitti di un serial killer, e i delitti massonici. Nei delitti di
mafia, ad esempio, gli omicidi seguono spesso una precisa ritualistica quando si
tratta di eliminare un affiliato che ha parlato troppo o ha tradito. Nel libro
“Gomorra” Roberto Saviano descrive ad esempio l’uccisione da parte della camorra
di un affiliato che si era pentito, che viene ritrovato in mezzo alla strada,
col corpo martoriato in modo terribile e la lingua mozzata. Il traditore, in
altre parole, non può morire in un modo qualsiasi, ma deve morire seguendo un
preciso rituale che serva da deterrente per i delatori futuri, e serva al tempo
stesso da sfoggio di potenza da parte dell’organizzazione. Sono delitti rituali
quelli commessi da organizzazioni sataniche, come le cosiddette Bestie di
Satana, una delle poche sette che sono incappate nella maglie della giustizia
(le altre invece sono libere di agire come a loro pare, grazie alla cospicua
letteratura scientifica di esperti famosi che insistono nel sostenere che il
satanismo sia un fenomeno poco diffuso, in cui al massimo si sgozza qualche
gallina; esperti che però non forniscono mai una risposta alla domanda “che fine
fanno le centinaia di bambini italiani che spariscono nel nulla senza lasciare
traccia, secondo i dati ufficiali della polizia di stato?”). Assolutamente mai
trattato, nella letteratura, è l’omicidio massonico, così come noi lo abbiamo
esposto in articoli precedenti. Eppure l’omicidio massonico vanta una tradizione
secolare, sussurrata, ma mai analizzata a fondo. Una tradizione che vede tra le
vittime illustri persone come Mozart (si pensa che venne avvelenato perché nella
sua opera il Flauto magico aveva rivelato alcuni segreti massonici; e si
racconta che il suo requiem è un’opera incompiuta perché lui la stava scrivendo
per se stesso, sapendo che lo avrebbero ucciso), e imperatori come Ludovico II
di Baviera che non a caso muore in una data ammantata di simbologia rituale
massonica: 13 giugno 1886, data il cui valore numerico è – non a caso – 33
(1+3+6+1+8+8+6). La cosa che colpisce di più è che manca una trattazione degli
omicidi rituali anche in opere specialistiche; ad esempio nel manuale “Crime
Classification Manual”, cioè il manuale dell’FBI sulla classificazione e
investigazione dei crimini violenti, manca totalmente una voce corrispondente a
“omicidio rituale”. Troveremo “omicidio domestico”, “omicidio domestico
spontaneo”, addirittura “omcidio a sfondo sessuale di donna anziana”, ma neanche
un accenno a omicidi rituali di altro tipo. Una dimenticanza non casuale,
probabilmente, dato che il rapporto tra omicidi a sfondo sessuale di donna
anziana, contro gli omicidi rituali satanici nel nostro paese, è di 1:1000.
Mentre digitando in Internet la voce “omicidio rituale”, oppure cercando dei
libri specifici sull’argomento, troverete una marea di libri e informazioni
sull’ “Omicidio rituale ebraico”, con tutte le polemiche recenti sul libro di
Ariel Toaff “Pasqua di sangue”; poi migliaia di pagine sull’omicidio del Piccolo
Simonino da Trento avvenuto nel 1475; ma nulla sull’omicidio rituale dei nostri
giorni. Silenzio assoluto. Non c’è da meravigliarsi poi se le indagini sugli
omicidi rituali, come i dodici omicidi presi in considerazione nell’articolo
precedente a questo, non vengano riconosciuti come tali. Perché delle due l’una:
o chi indaga appartiene all’organizzazione, quindi quando riconosce la
simbologia avrà cura di non rivelarla. Oppure chi indaga non la conosce, e
inevitabilmente gli parrà fantascienza l’idea di trovarsi davanti ad
un’organizzazione tanto complessa da avere collegamenti e radici ovunque, in
grado di bloccare ogni indagine in virtù del giuramento di segretezza che
vincola gli appartenenti a queste organizzazioni in ogni grado.
Come
riconoscere l’omicidio rituale.
L’omicidio rituale si riconosce da alcuni indizi. Un indizio è la data. Poi un
indizio importante, nei delitti della Rosa Rossa, è il mancato ritrovamento
dell’arma del delitto, che viene acquisita per gli scopi esoterici
dell’organizzazione. Un ulteriore indizio è dato dal ritrovamento sulla scena
del delitto di oggetti simbolici, come una rosa, dei cerchi, piramidi (nei
delitti del mostro di Firenze ad es.) e altro ancora. Talvolta il simbolo non è
in un oggetto ritrovato, ma nel luogo del delitto, o addirittura nel nome degli
assassini. Un esempio di luogo simbolico: nel delitto Pantani il ciclista viene
trovato all’hotel “Le Rose”. Un esempio di delitto ove la firma è nel nome:
nell’omicidio di Annalaura Pedron avvenuto nel 1988, gli indagati sono Rosalinda
Bizzo e suo figlio David Rosset (quindi la madre dovrebbe chiamarsi Rosalinda
Rosset, RR, cioè la firma della Rosa Rossa). Una bella coincidenza. E –
ulteriore coincidenza – i due sospettati facevano parte di un’associazione
esoterica denominata “Cenacolo 33”. Ce ne sarebbe a sufficienza, solo leggendo
un semplice articolo con questi dati, per approfondire la pista del delitto
rituale. Poi ci sono ulteriori indizi: i depistaggi, la sistematica eliminazione
dei testimoni, l’appartenenza dei familiari a gruppi esoterici, ecc… Spesso in
alcuni delitti, come quello di Cogne e di Erba, ad es. gli indizi che fanno
concludere per la ritualità dell’omicidio sono ben più che i classici tre indizi
che fanno prova.
Il
calcolo della data.
Ma soffermiamoci sul metodo di calcolo delle date. I numeri utilizzati negli
omicidi sono in genere i seguenti:
- 7, il numero
perfetto. Il numero che, secondo Oswald Wirth ha una particolarità in quanto nel
sigillo di Salomone tutti i numeri opposti riconducono al sette, secondo la
“legge del settenario” (Oswald Wirth, pag. 82);
- 8 (che nella cabala
simboleggia la giustizia, quindi uccidere qualcuno significa fare giustizia);
- 11 (che ha assunto lo
stesso significato dell’8 nella ritualistica rosacrociana della Golden Dawn; fu
infatti la Golden Dawn – ai cui rituali si rifà la Rosa Rossa - che cambiò il
significato di questo numero, attribuendogli quello della giustizia);
- 13 (che simboleggia
la morte e la trasformazione). Il 13 ricorre in particolare, oltre che nei
delitti della Rosa Rossa, anche nei delitti di gruppi satanici organizzati. Nei
delitti satanici talvolta ricorre anche il 18, perché 18 non è altro che 6 per
tre, cioè 666;
- infine quasi tutti i
multipli di 11, in particolare il 33, che oltre ad essere il numero 11
moltiplicato per tre, è anche il numero del massimo grado dell’iniziazione
massonica.
Occorre infine
ricordare che, a parte i multipli dell’ 11 e il numero 13, tutti gli altri
numeri vanno sempre ricondotti a un numero di una cifra (ad esempio se il valore
numerico di una data è 25, occorre poi sommare nuovamente 2 e 5 e il risultato è
7). Alcune date sono poi particolarmente simboliche perché ricorrono due o tre
simboli numerici in contemporanea. I numeri infatti possono essere combinati
anche in modo differente dalla semplice somma aritmetica (Papus, "La scienza dei
numeri"). Ad esempio nell’omicidio di Ludovico II di Baviera (13.6.1886) ricorre
il 13 iniziale, numero della morte, con il 33, numero della più alta iniziazione
massonica; come dire: morte massonica. La sua morte fu archiviata come suicidio
per annegamento, ma in epoca contemporanea si è accertato che è stato vittima di
un complotto. Oppure, facendo un esempio recente, Cecilia Gatto Trocchi (una
delle maggiori esperte di esoterismo italiane, che aveva spesso parlato del
satanismo dei cosiddetti “colletti bianchi” e dei potenti uomini di stato) muore
il 11.7.2005. Sommando solo le ultime cifre, 2 e 5, si ottiene un sette;
cosicché i simboli numerici che si leggono sono 11.77. Cioè: 11: giustizia; e
77, simbolo che troviamo spesso nei delitti satanici. Inoltre il valore numerico
della data nel suo complesso è 7 (1+1+7+2+5 uguale 16 cioè 1-6 che fa 7) simbolo
di perfezione ma anche numero della Rosa Rossa. In altre parole già analizzando
la data, e considerando gli argomenti di cui si occupava la dottoressa, si può
ipotizzare un omicidio e ci sarebbero sufficienti questi spunti per indagare
ancora; ma è inutile dire che il caso è stato archiviato come un suicidio.
Due
esempi pratici. Cogne e Erba.
I delitti di Cogne e di Erba per chi è esperto di esoterismo sono chiaramente
dei delitti rituali. Non sono però riconosciuti e trattati come tali per una
serie di motivi. Vediamo come giungiamo a questa affermazione. Iniziamo dalla
data. Erba: 11.12.2006. Valore numerico 13. Da notare che il giorno è l’11,
altro numero altamente simbolico negli omicidi. Cogne: 30.1.2002. Valore
numerico: 8. Poi abbiamo altri indizi. Le armi del delitto non vengono
ritrovate; ora, se questo è un fatto teoricamente possibile nel delitto di Erba,
dove gli assassini avevano una certa libertà di movimento per far scomparire
l’arma, più difficile è capire come sia possibile che Anna Maria Franzoni abbia
fatto sparire l’arma del delitto in pochi minuti in una località isolata come
quella di Cogne. Altro indizio. La grande quantità di sangue sparsa ovunque. Al
bambino addirittura viene sfondato il cranio, e da un buco fuoriesce materia
cerebrale; considerando che la Rosa Rossa utilizza parti di cadavere per i suoi
riti, viene il dubbio che quella violenza non derivi dalla brutalità della madre
o da quella di un maniaco assassino, quanto dalla volontà di asportare un
feticcio da utilizzare per i riti esoterici successivi. Notevoli poi le
similitudini tra questi delitti e quelli esaminati nell’articolo precedenti,
delle dodici morti romane: oltre al valore numerico delle data, l’assenza
dell’arma del delitto e la grande quantità di sangue persa dalle vittime. Poi ci
sono tanti altri fatti e accadimenti, tutti trascurati dagli inquirenti. Un mese
prima del delitto di Cogne, Gabriella Carlizzi – l’investigatrice che più di
ogni altra si è occupata di questa organizzazione - aveva avvertito alcuni
inquirenti che la Rosa Rossa avrebbe colpito e ucciso un bambino di tre anni dal
nome biblico, in una località che richiama il Paradiso. Questo perchè
l'investigatrice, da anni ha decriptato i codici con cui gli affiliati alla Rosa
Rossa si scambiano i messaggi sui giornali e sulle TV. Quindi aveva previsto con
esattezza il fatto. Ma si sa - si sa - la Carlizzi è pazza, e in tempi moderni
un uomo razionale e intelligente non può credere a queste idiozie da
superstiziosi. Figuriamoci se questa organizzazione può davvero cominciare
tramite giornali e TV!!! Pare fantascienza no????? Però guarda tu che
coincidenza… Il delitto è avvenuto proprio come anticipato e previsto dalla
Carlizzi e la questione è ben raccontata in alcuni articoli apparsi sulla
rivista Disinformazione. Poi abbiamo un’altra coincidenza curiosa, rilevata da
un criminologo, Carmelo Lavorino. Costui è uno dei criminologi più famosi in
Italia, e si è occupato di molti casi importanti, dal mostro di Firenze al
giallo di Arce. Egli, analizzando la scena del delitto, è giunto alla
conclusione che non poteva essere stata la madre a uccidere, ma il delitto è
stato compiuto da qualcuno di esterno. Inoltre la vicenda dei coniugi di Cogne
(dal loro trasferimento in una località di montagna, all’uccisione del bambino)
è stranamente identica a quella narrata nel racconto di un autore francese,
Charles Ramuz, morto nel 1947: due coniugi si trasferiscono in una località di
montagna con i due figli di sette e tre anni; il piccolo, che si chiama Celeste,
muore in modo analogo a Samuele, nel momento in cui la mamma si allontana per un
po’ da casa.. Curiosa coincidenza, vero? Coincidenze che avrebbero meritato ben
altri approfondimenti e – a tacer d’altro – avrebbero dovuto perlomeno portare
ad un’assoluzione della Franzoni per non essere raggiunta la piena prova della
sua colpevolezza. Ma coincidenze sulle quali nessuno ha voluto lavorare, né
lavorerà. Dati questi indizi si tratta di trovare la firma, sia essa la firma
della Rosa Rossa o di un’altra organizzazione. Bene. Nel delitto di Cogne, la
località presenta un particolare curioso; essa sorge nel massiccio del Gran
Paradiso, a poca distanza dal Monte Rosa. Mentre nel delitto di Erba l’omicida
si chiama Rosa Bazzi, coniugata con Olindo Romano. Ovverosia il suo nome è Rosa
Romano. Ancora una volta ricorre RR, senza considerare gli altri riferimenti
simbolici e rituali, come la città (Erba… e l’erba richiama il verde, colore per
eccellenza dei Rosacroce) o il nome di una delle vittime, Valeria Cherubini:
apparentemente un nome come un altro, per chi ritiene l’esoterismo un mucchio di
sciocchezze per superstiziosi. Ma un nome che indica molto di più a chi conosce
la disputa teologica tra Rosacroce e Chiesa Cattolica. Non siamo gli unici
visionari a pensare che il delitto di Cogne sia un delitto rituale, in realtà.
Lo pensa anche Giuseppe Cosco (un investigatore esperto in sette sataniche e
criminali) che in un suo articolo reperibile in Internet sostiene la tesi del
delitto satanico e ritiene che il significato della data consista nel fatto che
il 2 febbraio è la festa della candelora, una festa importante per il calendario
satanico. La tesi, pur essendo plausibile, non mi convince, a fronte di tutti
gli altri indizi, ben più numerosi, che riconducono, appunto, alla Rosa Rossa, a
cominciare dalla data e dal luogo, nonché scorrendo anche i nomi degli affiliati
a questa organizzazione che, negli anni, si sono occupati di questa vicenda in
veste di esperti. La nostra, ovviamente, è solo una tesi, suscettibile di
approfondimento. Alla luce di quello che diciamo, però, si spiegherebbero bene
tutte le contraddizioni apparenti di questa inchiesta. Come mai il padre, pur
sapendo che la madre ha ucciso il figlio, decide di mettere al mondo un altro
figlio e le sta vicino per tutto questo tempo? Come mai la madre non ha mai
ceduto né confessato? Se ha commesso il fatto in un momento di follia, come mai
ha retto psicologicamente senza mai cedere? E se è sana di mente, perché ha
ucciso il figlio? Come mai l’arma del delitto non fu trovata? Queste e altre
domande troverebbero una risposta molto semplice: il padre sa bene la verità e
la conosce anche la Franzoni. Ma se la dicessero, chi crederebbe loro? E se
qualcuno gli credesse, quanto resterebbero al loro posto di lavoro, o
addirittura quanto potrebbero restare in vita gli inquirenti che provassero ad
approfondire la questione? Ma soprattutto… quanti – anche tra coloro che leggono
– sono disposti ad approfondire una simile ipotesi di lavoro, che nessun autore,
neanche Dan Brown o Stephen King hanno mai ipotizzato? Sarebbe interessante poi
notare le similitudini tra questi delitti, i dodici precedenti, e quello di
Meredith ad esempio dove, guarda tu che coincidenza, non viene trovata l’arma
del delitto e il valore numerico della data fa ancora una volta – altra
coincidenza – 13. E dove la Rosa Rossa è stata deposta dal padre, come si può
leggere nell' articolo on line su Repubblica. Ma ovviamente il discorso ci
porterebbe troppo lontano e ai nostri fini è sufficiente fermarci qui.
Problematiche di accertamento dell’omicidio rituale.
A questo punto è chiaro il motivo per cui nessuno, per molti decenni ancora,
tratterà l’omicidio rituale. In primo luogo è un problema pratico. Chi arriva
alla verità muore o viene trasferito. In secondo luogo c’è un problema
culturale. La massoneria - lo si capisce chiaramente anche solo scorrendo
l’elenco delle grandi personalità del passato e del presente appartenenti a
questa istituzione - ha fatto la storia del mondo, abilmente occultando i suoi
segreti più preziosi. Logico quindi che essendo la nostra cultura ufficiale una
cultura massonica, ovverosia influenzata grandemente dalla sapienza massonica, è
stato espunto dai documenti ufficiali tutto ciò che potesse essere ricondotto in
qualche modo a tale associazione e che ne svelasse i segreti. Quindi occorre una
paziente opera di studio del simbolismo massonico per poi vedere chiaramente
tale simbologia non solo nelle architetture degli edifici, nell’arte, nella
cultura, ma anche nei delitti. A chi obietta che la nostra visione è
fantascientifica e sembra opera di un visionario che vuole scrivere un libro di
fantascienza, possiamo rispondere agevolmente come segue. In primo luogo nessun
romanzo ha mai rivelato queste verità perché se qualche romanziere lo facesse
non farebbe in tempo a pubblicare il libro; sarebbe controproducente mettere in
circolazione simili racconti dato che il lettore potrebbe domandarsi “e se fosse
vero?”. Ecco perché i romanzi in genere, anche quelli di Le Carrè o Dan Brown,
sono molto meno fantasiosi della realtà. Seconda obiezione. Prima di bollare
queste ricostruzioni come fantasie, occorre conoscere ciò di cui si parla. Se
una persona senza conoscere la mafia e senza sapere neanche cosa è Cosa Nostra
andasse in Sicilia e trovasse una persona morta e incaprettata, probabilmente
riterrebbe fantasia parlare di un'associazione che controlla addirittura la
Sicilia intera, uccidendo i traditori in quel modo. Oppure, per fare un altro
esempio, se un investigatore che non conosce il Cristianesimo trovasse in alcuni
delitti seriali un riferimento a passi della Bibbia, li archivierebbe come frasi
senza senso e non riuscirebbe a individuare la simbologia cattolica in essi
contenuta. Quindi, magari, non utilizzerebbe quelle frasi per ricostruire la
personalità dell’assassino. Bene. Coloro che si occupano di delitti rituali
senza conoscere la simbologia e la storia massonica, è come se camminassero in
una nazione straniera senza conoscerne la lingua; logico che poi sulla scena di
un delitto non trovino il bandolo della matassa, non riescano a spiegare le
apparenti contraddizioni e trascurino indizi assolutamente evidenti per i non
profani. Se a questo aggiungiamo che i media sono sotto il controllo diretto o
indiretto della massoneria, si spiegano le difficoltà riscontrate
nell’individuazione della verità per la maggior parte – per non dire tutti -
questi delitti. C’è un terzo motivo, ed è quello psicologico. La realtà, così
come la raccontiamo noi, è difficile da accettare e quindi è logico che
istintivamente la gente comune non voglia ammettere che possa esistere una
situazione del genere. Questa realtà, la maggioranza delle persone non vuole
neanche vederla, tanto è intrisa dal razionalismo e dal conformismo della
cultura dominante. Spesso viene negata dagli stessi parenti delle vittime, che
preferiscono pensare alla sfortuna, ad un accanimento di una sorte avversa che
fa capitare loro investigatori incapaci, giornali che per fare scoop riportano
notizie false, piuttosto che credere ad un meccanismo complesso come lo abbiamo
descritto noi. Complesso e preciso come un orologio, perché da secoli certe
realtà sono solo “sussurrate” e raramente venute fuori in modo esplicito.
Infine, c’è un quarto motivo. Ammesso e non concesso che un tribunale volesse
prendere in considerazione l’ipotesi dell’omicidio rituale, ammesso e non
concesso che questo tribunale sia immune da contaminazioni massoniche (ipotesi
praticamente fantascientifica), sorgerebbero delle difficoltà di accertamento
processuale insormontabili. Se con una certa difficoltà si potrebbero
individuare gli esecutori (questo, anche se raramente, talvolta è stato fatto,
come è accaduto nei delitti del Mostro di Firenze e di Erba) è quasi impossibile
individuare i mandanti, trattandosi di un’organizzazione che non comunica certo
per lettera o telefono, ma tramite messaggi veicolati da frasi in codice, con
qualsiasi mezzo di comunicazione, dalle comuni lettere, ai giornali e alle Tv,
ai libri (libri talvolta diffusi in edizione limitata tramite cerchie ristretti
di aderenti ad associazioni o clubs, ecc.), ma comunque sempre tramite una
simbologia e un linguaggio sconosciuti ai non iniziati. Quindi l’ipotesi di un
tribunale che indaghi sui delitti della Rosa Rossa, è assolutamente
fantascientifica perché l’organizzazione non potrebbe mai processare se stessa
essendo essa incardinata fino ai più alti vertici dello Stato.
Ragioni
storiche e culturali dell’attuale situazione.
So che quello che dico e le cose che scrivo in questo articolo faranno sì che la
maggior parte delle persone mi considererà un visionario. E ciò è comprensibile.
Quando avevo vent’anni, ritenevo assurde e deliranti le tesi del difensore di
Pacciani, Fioravanti, che indicava la pista esoterica per quegli omicidi,
cercando di scagionare il suo assistito. E quando, anni dopo, cominciai a capire
“il sistema”, penetrando i suoi segreti più nascosti, o semplicemente
intuendoli, rimasi a lungo perplesso e la mia principale domanda fu: “se non
sono pazzo, e quello che ho scoperto è vero, come è possibile creare un
meccanismo del genere? Come è possibile essere giunti fino a questo punto di
raffinatezza criminale, da parte dei poteri occulti, e di ignoranza da parte di
noi cittadini ignari? Come è possibile una così sistematica presa in giro da
parte di tutti, politici, mass media, inquirenti”? Poi, lentamente, è venuta
fuori la risposta. Il problema dell’omicidio rituale è prima di tutto culturale
e storico. Tutti noi siamo infatti circondati dalla cultura Cattolica (che in
genere conosciamo a sufficienza da saperla riconoscere nei principali fatti
della vita quotidiana); ma siamo anche un popolo circondato dalla cultura
massonica; con la differenza che la cultura massonica non la conosce nessuno se
non gli uomini di potere e di cultura; quindi i suoi simboli e i rituali, il
modus di agire, sono sconosciuti alla maggioranza. Infatti per secoli i
Rosacroce, i Templari e la massoneria in genere si sono nascosti per
sopravvivere alla feroce lotta che la Chiesa e i sovrani muovevano contro di
loro, a causa delle ricerche e delle idee che costoro portavano avanti. Queste
associazioni hanno quindi effettuato in segreto ricerche scientifiche,
tecnologiche, ed esoteriche, perché altrimenti il potere ufficiale di allora non
l’avrebbe permesso. La segretezza attuale dell’associazione Rosa Rossa, quindi,
ma al tempo stesso la sua potenza e onnipresenza nello stato, non deve stupire,
perché è la logica conseguenza storica del comportamento della Chiesa per
secoli. I Rosacroce e le altre associazioni segrete erano spesso collegate tra
loro, e hanno sviluppato una struttura sempre più efficiente. Nei secoli si sono
rafforzate e strutturate sempre più e hanno rovesciato le monarchie. Per secoli
si sono fronteggiati due poteri: la Chiesa (e gli imperatori) e la Massoneria;
la prima in modo visibile, la seconda in modo quasi invisibile. E ci vorranno
ancora parecchi decenni prima che la massoneria esca completamente alla luce e
sia visibile a tutti. Finché non si inizierà a studiare la cultura massonica e
la storia della massoneria (che poi è anche la storia del mondo occidentale
degli ultimi 8 secoli), finché la cultura massonica non sarà studiata anche
dalla gente comune, ma soprattutto da investigatori e giornalisti, tutti i
delitti massonici rimarranno sempre irrisolti. Il mio parallelo con la cultura
cattolica non è casuale. Come dice uno dei massoni più intelligenti e sottili,
cioè il Gran Maestro Di Bernardo (curiosa “coincidenza” che il cognome del
Maestro sia lo stesso di San Bernardo, il monaco che codificò la regola dei
templari): “ci sono due Chiese oggi: La Chiesa Cattolica e la Chiesa Massonica”.
La Chiesa massonica è stata per secoli, come loro giustamente rivendicano, il
tempio del libero pensiero, in contrapposizione alla Chiesa Cattolica, che
voleva imporre il suo credo ovunque bollando come eretico chiunque osasse
mettere in dubbio le scienza ufficiale di allora; quindi si mandava al rogo chi
affermava teorie innovative sulla terra e l'universo (Giordano Bruno), e si
massacrava in massa chiunque, pur aderendo al messaggio Cristiano, non
riconosceva la gerarchia ecclesiastica (i Catari). Oggi la massoneria
rosacrociana e templare, cioè quella più potente e segreta (quella speculativa,
che si rifà veramente alle sue origini e non utilizza la struttura massonica per
finalità di potere), continua ad essere il tempio del libero pensiero, per
quanto riguarda alcuni aspetti della nostra vita spirituale e culturale. Ma
purtroppo utilizza il vincolo di segretezza massonico per proteggere se stessa e
i delitti commessi dai loro associati nonché per eliminare coloro che ne
rivelano i segreti. Inoltre la massoneria continua a tenere per sé molte delle
sue conoscenze acquisite nei secoli, non più per crescere ed elevare
spiritualmente l’uomo come invece faceva nei secoli scorsi ma esclusivamente per
finalità di potere e per tenere soggiogati i cittadini, che credono alla verità
dei giornali e telegiornali, all’oscuro di quel che avviene realmente nelle
stanze del potere.
Un
aneddoto conclusivo.
A proposito delle difficoltà di accertamento dei delitti rituali mi ricordo un
episodio capitatomi personalmente. Un funzionario della Digos ci stava
interrogando sull’avvelenamento di Solange; alcune cose non gli quadravano;
decidemmo allora di aprirci completamente e di raccontargli alcune vicende che
fino a quel momento avevamo omesso.
- Perché non le avete
raccontate prima? – chiese lui un po’ arrabbiato.
- Sa, perché si tratta
di vicende complicate, non tutti sono preparati per affrontarle e non sapevamo
se voi eravate competenti in materia.
– Di che si tratta? –
domandò lui.
- Massoneria – dissi io
– ma non so se siete competenti anche su questo.
- Certo che siamo
competenti in fatti di massoneria – rispose lui – Siamo la Digos, noi, mica
“pizza e fichi”.
- Bene. Cominciamo
dall’inizio. Sa, il padre della mia collega era iniziato al Grande Oriente
d’Italia….
- Cosa è il Grande
Oriente? – chiese il funzionario.
A quel punto capii che
l’interrogatorio si sarebbe risolto come in effetti si risolse: Solange si era
avvelenata da sola, forse si drogava, e io la coprivo perché, abitando nella
stessa casa, non potevamo che essere amanti e io quindi ero suo complice.
Figuriamoci se avessimo spiegato al funzionario il problema della data e dei
simboli. Inutile dire che quando siamo stati vittima di alcuni tentati omicidi,
in epoca successiva non siamo mai più andati alla Digos. Tentati omicidi in date
– guarda tu che coincidenza – dal valore numerico 8 per il primo caso
(17.9.2007) e 13 nel secondo caso (2.1.2008); abbiamo denunciato il fatto ai
carabinieri ove perlomeno non ci hanno trattato come matti, ma, anzi, quando
abbiamo detto che avevamo subito due incidenti di moto nello stesso giorno, il
commento è stato un più professionale “avvocato, avete rotto le scatole a
qualche politico, vero?”. Per la precisione, la denuncia fu fatta solo per i
fatti del 17, che coinvolgevano anche Solange. Quelli del 2 coinvolgevano me in
prima persona, e non andai mai a denunciarli, perché si sa, da quando mi occupo
di queste cose sono suggestionabile e mi allarmo per niente. E poi vedo Rose
Rosse dappertutto. E avendo capito perfettamente come funziona la giustizia,
preferisco affidarmi a quella divina, che mi farà morire non un minuto prima, né
un minuto dopo, rispetto a quello che il destino mi ha preparato. In questo la
massoneria potrebbero avere una parte di ragione: il mondo è fatto di pesi,
numeri e misure, e conoscere il segreto dei numeri significa conoscere il
segreto dell’universo.
L'omicidio
massonico. La legge del contrappasso e le morti in auto,
scrive Paolo Franceschetti. E due cosette che non sapete sulle stragi di Falcone
e Borsellino. 1. Premessa. 2. Gli incidenti di auto e moto. 3. Le stragi di
Capaci e di Via D'Amelio. 4 Ricapitoliamo. Il significato delle stragi e la
trattativa tra stato e mafia. 5. Qualcuno telefona da Roma.
1. Premessa. Nei tre
precedenti articoli sull’omicidio massonico abbiamo analizzato i caratteri
comuni a tutti gli omicidi commessi dalla massoneria. Sinteticamente:
- la maggior parte
degli omicidi massonici sono effettuati dai servizi segreti deviati; dal momento
che tale struttura ha al suo vertice persone affiliate (o comunque dipendenti
da) alla massoneria rosacrociana, e dal momento che i Rosacroce hanno come loro
padre spirituale Dante Alighieri, viene utilizzata la cosiddetta tecnica del
contrappasso. Ovverosia la persona da eliminare morirà secondo la logica di far
patire alla vittima il peccato che questa ha commesso. Ad esempio molti dei
testimoni di Ustica (vicenda che, come è noto, ha a che fare con un incidente
aereo) moriranno in un incidente aereo. Fabio Piselli, testimone della tragedia
del rogo del Moby Prince, viene caricato su un’auto a cui venne dato fuoco
(doveva morire quindi in un rogo). Luciano Petrini, perito che stava facendo una
perizia sulla morte del colonnello Ferraro (che muore impiccato all’asciugamani
del bagno) morirà a colpi di portasciugamani. Oppure ricordiamo il caso
dell’attore Bruce Lee e del figlio Brandon Lee: il primo (che pare morì
avvelenato in una data il cui valore numerico complessivo è 11) aveva girato la
scena di un film in cui moriva sul set, colpito da una pallottola che invece di
essere caricata a salve spara un proiettile vero; il secondo morì proprio in
questo modo, probabilmente perché cercava la verità sulla morte del padre. Ecc…
- Ogni omicidio è
commesso in una data ben precisa, in cui il valore numerico è diverso a seconda
dei casi (ricordiamo che il valore numerico si ottiene sommando tutti i numeri
presenti nella data da calcolare): 7, come firma della Rosa Rossa, ma anche come
simbolo di perfezione chiusura di un ciclo, ecc…
- 8 e 11 come simbolo
di giustizia. E poi ci sono i multipli di 11 in particolare il 33, che indica
anche il massimo grado (ufficiale) della massoneria.
- 13 come simbolo di
morte.
Chi sale troppo in
alto, chi osa troppo, viene gettato dall’alto, come Cecilia Gatto Trocchi. Come
Adamo Bove, il responsabile della security della Telecom morto di recente.
Qualcuno può morire fulminato dalla corrente elettrica come Giuseppe Gatì, morto
in un giorno rituale la cui somma è 7 (la firma della RR), perché il fulmine
simboleggia il fulmine di Zeus che punisce la persona che ha osato troppo.
Insomma, come i dannati dell’inferno dantesco scontano una pena adeguata al
peccato di cui si sono macchiati, chi si mette contro la Rosa Rossa e contro la
massoneria rosacrociana, muore con una morte adeguata al tipo di peccato
commesso contro questa organizzazione.
2. Gli incidenti d’auto
e di moto. Per tanto tempo alcuni conti non mi tornavano. Tanti testimoni, o
persone comunque da eliminare, avevano incidenti di auto o di moto. In realtà
però qualcosa non mi quadrava. Anzitutto non riuscivo a capire dove fosse il
contrappasso in alcuni fatti. Che ci fosse un intento di eliminare il soggetto
era palese… ma i conti non mi tornavano. Vediamo alcuni dei casi di cui ci siamo
occupati fin qua…Alcuni si sono salvati.
- La giudice Forleo.
- Placanica, il
carabiniere implicato nei fatti del G8, accusato di aver sparato a Carlo
Giuliani, la cui auto sbanda improvvisamente.
- Il mio amico Giovanni
M, di Viterbo, che oltre ad avere ben 5 processi penali diversi, uno più falso
dell’altro, ha anche avuto un incidente d’auto.
- La lettrice che ci ha
scritto la lettera che abbiamo pubblicato (Laura Biker), scampata al sabotaggio
della sua moto ai tempi del centro sociale Leoncavallo.
Poi ci sono quelli che
non si sono salvati. Tanti. Una strage infinita, comprendente testimoni di
processi importanti, cittadini che avevano curiosato troppo, giornalisti. Anche
alcuni personaggi famosi, come Rino Gaetano, Fred Buscaglione, James Dean. La
domanda è: posto che i servizi hanno mezzi immensi… posto che non c’è problema a
far morire una persona con un mattone sulla testa, con una fuoriuscita di gas
dalla cucina, con una caduta per terra, ecc…, perché scegliere un mezzo così
insicuro? Perché l’auto o la moto? Me lo domandai per mesi dopo l’incidente di
moto mio e di Solange, avvenuto lo stesso giorno. Due moto diverse sabotate
nello stesso giorno. Perché volevano provocarmi una morte così assurda, con un
mezzo così insicuro, e che avrebbe destato più di un sospetto? La domanda mi
risuonò in mente per mesi. Con i mezzi che ci sono oggi la persona ha buone
probabilità di salvarsi. Le auto sono infatti dotate di airbag e la cintura di
sicurezza è obbligatoria su tutte le vetture. Per quanto riguarda la moto vale
un discorso analogo. Oggi il casco è obbligatorio e spesso le giacche e i
pantaloni da moto hanno delle protezioni che difendono molto in caso di caduta.
Quindi la domanda che mi risuonava era: perché usare un mezzo così fallimentare
dal punto di vista dell’efficacia? Un poliziotto tempo fa mi disse che ciò è
dovuto al fatto che spesso i servizi adottano tecniche antiquate, e continuano
ad eliminare le persone senza tenere conto dell’aggiornamento della tecnica. Lì
per lì confesso che la spiegazione mi piacque tantissimo e mi dette
soddisfazione. Dal momento che io mi sono salvato in due incidenti di moto,
l’idea di essere scampato alla morte perché i servizi segreti sono così stupidi
da usare tecniche antiquate era una cosa divertente… Per diverso tempo io e
Solange scherzavamo su questo dicendo “hai visto… sono così stupidi che
applicano meccanicamente a tutti le stesse tecniche e oggi tra i cittadini in
circolazione abbiamo più scampati alla morte che persone normali…”. Ma la verità
è che questa spiegazione non mi convinceva. Dentro di me sapevo che la
massoneria rosacrociana è sofisticatissima; ai vertici ci sono persone
intelligentissime che non lasciano nulla al caso. In ogni delitto nulla è
lasciato al caso, né il nome della via, né il numero delle vittime. Nulla.
Strano sarebbe che venga lasciato al caso proprio il mezzo per uccidere.
Addirittura, una persona esperta di servizi ci disse, poco tempo fa, che i
nostri servizi segreti sono considerati in assoluto i migliori al mondo per
quanto riguarda proprio… la manomissione di auto e moto. Tanto che tra i servizi
segreti di altri paesi gira voce che i nostri siano così bravi, che basta loro
passare accanto ad un auto, farle una carezza, e questa si va schiantare dopo
qualche chilometro. Purtroppo un giorno la risposta alla mia domanda (perché?)
mi venne chiara. Stavo riflettendo su alcuni omicidi mettendo in fila questi
dati:
Haider; ucciso in
Rosenthalerstrasse, nella sua Volkswagen Phaeton, l’auto venne scelta per il
mito di Fetonte che col suo carro cercò di raggiungere il sole e morì nel sole;
Haider era salito troppo in alto e questo lo ha bruciato.
Mauro Brutto: indagava
sulla morte di Fausto e Jaio del centro sociale Leoncavallo. Morto investito da
una Simca 1100. Chiaro il significato di quell’11 nel numero dell’auto.
Aldo Moro. Trovato
morto in un una Renault Rossa. RR. La firma della Rosa Rossa.
James Dean, morto in
una Porsche 550, che portava il numero 130 (morto quindi per gli stessi motivi
che hanno portato alla morte Rino Gaetano, De Andrè e Lucio Battisti).
Ogni auto ha una sua
logica. Ovverosia anche il tipo di auto con cui uno muore ha una logica precisa,
adatta alla situazione o alla persona. Leggendo un libro di esoterismo la
risposta mi è stata chiara. Macchina… viene dal latino, deus ex machina. Nelle
commedie greche, il Dio veniva a risolvere situazioni intrigate scendendo dal
cielo, appeso ad un congegno di funi che si chiamava mechanè…La macchina quindi
era il congegno da cui veniva il Dio a risolvere i problemi terreni. L’auto è
quindi una punizione che viene dal cielo, dal Dio stesso. Per quanto riguarda la
moto penso (ma potrei sbagliarmi… sto solo formulando ipotesi) che valga lo
stesso discorso dell’auto con una particolarità. Che una moto vista dall’alto
simboleggia una croce. Il soggetto che muore in moto viene quindi simbolicamente
crocifisso. La cosa, che suona quasi ridicola tanto da avermi provocato non
poche risate, non me la sono inventata, ma l’ho trovata su un libro dal titolo
curioso: “Quel che si dice dei ciclisti rosacroce”. Vista dall’alto, infatti, la
moto è una croce, ove le braccia laterali sono costituite dal manubrio. Un
libro, nonostante il titolo dalla logica incomprensibile, scritto da una persona
che di Rosacroce se ne intende.
3. Falcone e
Borsellino. Mi sono per parecchio tempo domandato dove fosse il contrappasso per
le stragi di Capaci e Via D’Amelio. A parte le date rituali (31 per Falcone e 11
per Borsellino: 19.7.1992 infatti è: 1+9+7+1+9+9+2 =38=3+8=11 ) la modalità
della morte doveva senz’altro essere rituale. Falcone infatti poteva essere
ucciso a Roma, dove girava tranquillamente senza scorta. Quindi perché ucciderlo
proprio in Sicilia e proprio con quella modalità che, dal punto di vista logico,
non sta né in cielo né in terra? Riina, per quanto possa dirsi male di lui, era
ed è, una persona intelligente. Una persona che ha l’intelligenza di diventare
il Capo dei Capi di tutta la Sicilia, può commettere una leggerezza del genere?
No. Io credo che Falcone sia stato ucciso in quel modo per vari motivi.
Anzitutto doveva morire in Sicilia perché era in Sicilia che le sue indagini si
erano svolte. La regola del contrappasso esigeva quindi che lui morisse nella
stessa terra ove aveva "peccato". Inoltre doveva saltare in aria in modo
eclatante, perché voleva far saltare il sistema. Falcone aveva capito che il
fulcro del sistema criminale in Italia non è la mafia. E’ lo stato. E sono le
banche. Quindi doveva saltare in aria perchè l'esplosione con cui muore fa da
contrappasso all'esplosione che lui voleva assestare al "sistema". Inoltre è
morto a Capaci, a simboleggiare che chiunque sia capace, deve morire. La cosa
suona terribilmente ridicola, ma prego chi legge di riflettere che stiamo
parlando di un’associazione che non lascia nulla al caso, neanche i nomi delle
persone che vengono messe in determinate posizioni di vertice politico,
finanziario, o amministrativo. La scelta del luogo, nella strage di Capaci, è
dovuta probabilmente anche ad un altro motivo, che risale alle origini del
paese. Si narra che il bellissimo isolotto denominato "Isola delle Femmine"
fosse stato un tempo una prigione occupata solo ed esclusivamente da donne.
Tredici fanciulle turche, essendosi macchiate di gravi colpe, furono dai loro
congiunti imbarcate su una nave priva di nocchiero e lasciate alla deriva.
Vagarono per giorni e giorni in balia dei venti e delle onde finché una tempesta
scaraventò l'imbarcazione su un isolotto della baia di Carini. Qui vissero sole
per sette lunghi anni fin quando i parenti, pentitisi della loro azione, le
ritrovarono dopo molte ricerche. Le famiglie così riunite decisero di non fare
più ritorno in patria e di stabilirsi sulla terraferma. Fondarono quindi una
cittadina che in ricordo della pace fatta, chiamarono Capaci (da "CCa-paci"
ovvero: quì la pace) e battezzarono l'isolotto sul quale avevano dimorato le
donne "Isola delle Femmine". Non a caso, come risulta dalla sentenza sulla
strage di via dei Georgofili (che riuniva in un solo processo ben sette stragi,
commesse a Firenze, Milano e Roma) e dalla sentenza sul Capitano Ultimo, dopo la
strage di Capaci venne avviata la famosa trattativa tra stato e mafia, di cui si
fece portavoce il generale Mori, per raggiungere… la pace. Probabilmente la
morte così eclatante di Falcone segna anche, simbolicamente, uno spartiacque tra
il vecchio metodo di eliminazione dei magistrati (ucciderli) e quello nuovo
(delegittimarli). Non più guerra quindi, ma le cosiddette "armi silenziose per
una guerra tranquilla" di cui abbiamo parlato altrove. La morte di Falcone
simboleggia quindi la Pace. Infatti dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio la
mafia non esiste quasi più. Hanno preso Riina e Provenzano e dopo di loro quasi
solo il silenzio. Addirittura il procuratore Antimafia Grasso qualche mese fa è
andato al Maurizio Costanzo Show a declamare gli immensi successi dello stato
sulla mafia, ridotta - secondo lui - oramai quasi al silenzio. Ricapitolando, il
simbolismo della strage di Capaci è: auto, esplosione, isola delle femmine,
Capaci. Il probabile significato: Falcone voleva far saltare il sistema
(esplosione), quindi dal cielo (auto) arriva la punizione che lo fa saltare in
aria; dopodichè dovrà scendere la pace, tra lo stato e la mafia (Capaci). Così
muoiono le persone capaci di arrivare al cuore del sistema. Inoltre, a firmare
la strage, ci sono due elementi: il gruppo di mafiosi si era posizionato sulla
collina vicino Capaci; e la collina si chiama "Raffo rosso", ove raffo in
ebraico significa "Dio che guarisce". RR, firma della Rosa rossa. Mentre la
moglie di uno degli agenti di scorta, che fece il famoso discorso ai funerali,
si chiama Rosaria Costa. RC quindi. Borsellino fu ucciso nello stesso modo.
Anzitutto perché aveva seguito le orme dell’amico. Poi perché anche lui, col
memoriale Calcara, aveva avuto notizie che erano in grado di far saltare il
sistema. Credo che un aspetto della simbologia della sua morte vada trovata
anche nella via dove avvenne l’esplosione: Via Mariano D’Amelio, un politico che
fece leggi sulla magistratura. Chiaro il messaggio: la magistratura deve essere
azzerata. Ora ricordiamo quel che successe dopo queste stragi. Inizialmente
sembrò che la magistratura acquistasse più poteri, e che lo stato volesse
realmente fare la guerra alla mafia. Nacque lo strumento del 41 bis (il carcere
duro per i mafiosi). Ci furono alcuni ritocchi al codice di procedura penale. Ma
dopo poco tempo iniziarono le leggi che, di fatto, azzerarono il potere della
magistratura riducendolo ad un formalismo vuoto; cosicché oggi l’80 per cento
dei reati cade in prescrizione, e per reati gravissimi vengano comminate pene
ridicole: a titolo di esempio (vado a memoria) la riforma del falso in bilancio,
un reato che oggi praticamente non esiste più; la legge che riforma il reato di
attentato agli organi costituzionali, reato punito prima con l’ergastolo, e oggi
praticamente impunito; l’abolizione dell’abuso di ufficio, e tante altre.
Un’opera sistematica di demolizione dei poteri dei magistrati che è in atto
tuttora (ad esempio con la legge di riforma delle intercettazioni e altre
genialità del genere).
4. Ricapitoliamo. Il
significato delle stragi e la trattativa tra stato e mafia. Leggiamo ora la
successione di leggi nel tempo, dopo le due stragi del 92, alla luce della
simbologia sottesa ad esse. Con Falcone arriva il segnale della pace tra stato e
mafia. Da qui nascono le apparenti leggi contro la mafia, che in realtà servono
a comminare il carcere duro ai mafiosi, probabilmente per togliere di mezzo
Riina e altri capi mafia, che, grazie a questa legge, non potranno più
comunicare con l’esterno. La legge cioè non serve per punire i mafiosi, ma per
impedirgli di continuare a comandare e togliere di mezzo la vecchia guardia,
sostituendola con una nuova, che sia d’accordo con la cosiddetta linea morbida.
Cioè per sostituire i mafiosi che volevano la guerra allo stato, con altri che
vogliano “la pace”. Con la strage di Via D’Amelio invece si dà il via alle leggi
che azzerano i poteri della magistratura.
5. Qualcuno telefona da
Roma. Per far capire che le stragi di Capaci e via D’Amelio sono stragi non di
mafia è sufficiente un documento che Gabriella Pasquali Carlizzi ha citato in un
suo libro. E’ la conversazione che si svolge tra due personaggi, uno romano e
uno siciliano, un magistrato. Eccone la trascrizione.
Telefonata tra Roma e
Sicilia.
- dottore c’è una
telefonata da Roma
- Pronto con chi parlo?
- Oh Presidente mi
dica.
- Dottore sarà lei a
occuparsi della strage di Capaci naturalmente.
- Presidente lei sa
bene che qui quando succedono certe cose noi diciamo è la mafia. Anche in questo
caso noi diremo è la mafia.
- Bravo proprio questo
volevo farle intendere caro dottore. D’ altra parte non a caso l’incidente è
avvenuto lì, in quel preciso punto, altrimenti questa inchiesta poteva finire a
Palermo.
- Meglio cosi
presidente, è meglio così mi creda. La gente di Palermo pensa a fare giustizia
ma al futuro della gente della Sicilia chi ci pensa? Piuttosto presidente
bisogna togliere i sigilli da tutto quel materiale. Io lo conoscevo bene, era
uno che annotava tutto e credo che sia meglio non alzare polveroni, meglio per
tutti.
- Si lei ha ragione
dottore. Ma qualcosa bisognerà pure trovare, quanto basta per dare all’indagine
un’immagine di serietà. Lei mi capisce non è vero? L’Italia in questo momento è
scossa. Non potrebbe sopportare le responsabilità di questo delitto meglio
indagare su fatti avvenuti dal paese ormai sappiamo che il giudice era andato
troppo oltre le sue competenze; aveva un piano da attuare. La amava troppo la
sua terra. Merita di essere ricordato come un eroe.
- Sono d’accordo con
lei presidente in fondo queste stragi di eroi ne hanno fatti molti in questi
anni e la gloria dell’Italia aumenta.
- Domani andrò sul
posto dottore. Ci incontreremo li per coordinare i lavori. Occorre molta
prudenza e sintonia.
I due personaggi
(facilmente riconoscibili) si incontrarono sul posto. Che le stragi di Capaci e
Via D’Amelio non siano stragi di mafia lo ha detto lo stesso Riina, in un
intervista ad Antimafia 2000. Non so se vi ricordate quello che scrissi nel mio
articolo “La massoneria è una Harley Davidson…” infatti, Riina, alla fine, la
verità te la dice. E non ho detto quelle frasi certamente per caso… Volevo dire
esattamente le cose che ho detto.
L'omicidio
massonico. I parenti delle vittime,
scrive Paolo Franceschetti. Nei precedenti articoli sull’omicidio massonico ci
eravamo occupati di alcuni aspetti della simbologia e della tecnica di tali
omicidi. Ora voglio parlare di un aspetto che per lungo tempo non ho mai capito
ma che, ad un certo punto, in questi anni è diventato chiaro. Mi sono sempre
domandato perché i parenti delle vittime non facevano troppo chiasso. Mi spiego.
Perché i parenti delle vittime del Mostro di Firenze non hanno costituito
un’associazione che indagasse per conto proprio e pubblicasse magari in un sito
i propri risultati in autonomia rispetto alle indagini di PG ufficiali (che
notoriamente facevano acqua da tutte le parti)? Perché nessuno dei tanti parenti
della famiglia Franzoni ha mai pensato di difendere Anna Maria aprendo un sito,
portando prove, ecc...? Possibile che, dei tanti omicidi che insanguinano
l’Italia, i parenti non hanno mai alcun sospetto e non si mettono a far casino,
salvo poche eccezioni (ad esempio la famiglia Manca, la signora Gemini mamma di
Niki Aprile Gatti)? Solo in alcuni casi più eclatanti (Ustica, Georgofili, ad
es.) si è costituito una sorta di comitato, anche se, dal punto di vista
pratico, hanno ottenuto dei risultati quasi nulli. Negli anni la risposta mi è
diventata drammaticamente chiara. Per gli omicidi più eclatanti – quelli, per
intenderci, che ammorbano le nostre serate televisive perché ce li propongono in
tutte le salse, con le solite opinioni dei sempre soliti esperti che dicono
sempre le stesse cose giungendo sempre alla conclusione del solito nulla – le
vittime sono scelte all’interno dell’organizzazione, o comunque sono scelte in
modo che la famiglia sia controllata o controllabile. Nel caso delle vittime del
Mostro di Firenze, ad esempio, la maggior parte delle vittime erano in realtà
collegate direttamente o indirettamente all’organizzazione. Innanzitutto le
vittime passavano tutte dal famoso mago Salvatore Indovino. La coppia francese
eliminata, ad esempio, era scesa in Italia perché aveva contattato
un’organizzazione esoterica. La madre di una delle vittime era un amante del
Narducci, il medico trovato morto nel lago Trasimeno e che pare facesse parte
della Rosa Rossa. In un altro caso il padre della ragazza era
nell’organizzazione della RR, tanto che fu definito “Giuda” da Pacciani; il
curioso epiteto gli era stato rivolto non perché Pacciani straparlava, come
molti hanno pensato, ma perché al contrario, sapendo quel che diceva, gli aveva
rivolto “l’accusa” di aver parlato poi troppo con gli inquirenti. In un altro
omicidio la vittima era la sorella di un poliziotto in servizio a Firenze.
Eppure i giornali non fecero cenno alla questione, e il cadavere venne ritrovato
proprio da un poliziotto; e guarda caso il legale di Mario Vanni, Filastò,
sosteneva che alcuni dei delitti del Mostro di Firenze fossero compiuti anche
con la complicità di poliziotti. In uno dei tanti omicidi eclatanti che
ammorbano le nostre serate televisive ho potuto scoprire che non solo la
famiglia coinvolta era collegata ai servizi segreti, ma che i legali dei
familiari (nomi mai divulgati dai media) erano, guarda un po’, proprio gli
stessi legali che avevano difeso le persone incriminate nei delitti del Mostro
di Firenze. La particolarità però è che la famiglia che aveva scelto quel legale
abita a centinaia di chilometri dalla città di Firenze e dunque dal legale
incaricato. Ho sempre ritenuto curioso che Alberto Stasi, coinvolto nel delitto
di Garlasco, fosse preso a lavorare per lo studio legale che lo difendeva. Mi
sono sempre domandato, per fare un altro esempio, come mai Adriano Sofri non si
sia mai interessato alle dichiarazioni di Manlio Grillo, raccolte da Solange in
Nicaragua, in cui si autoaccusava dell’omicidio Calabresi, scagionando di fatto
Sofri che per questo ha scontato parecchi anni di carcere. La risposta appare
drammaticamente chiara solo che si capisca come funziona il nostro “sistema”.
Una mia amica in polizia mi ha raccontato che, il giorno che andò a dare la
notizia del decesso di una persona (uccisa a colpi di accetta) ai familiari,
questi non batterono ciglio e le risposero solo “Grazie. Ora per favore dobbiamo
lavorare”. Un fatto apparentemente inspiegabile, quando non si conosca come
funziona “il sistema”. Una volta dissi ad una ragazza a cui probabilmente
avevano ucciso il padre che forse si trattava di omicidio e non di un malore
come i giornali avevano fatto credere. Lei non si mostrò interessata alla cosa e
parlò d’altro. Dopo pochi mesi infatti ho scoperto che era entrata nella stessa
organizzazione di cui il padre faceva parte. In un altro caso, ritenendo di
avere notizie importanti riguardanti un noto magistrato coinvolto suo malgrado
in fatti in cui – ritenevo – lui non c’entrava nulla, gli telefonai per
fornirgli la mia versione. Da una parte lui non rimase affatto sorpreso.
Dall’altra però non si mostrò interessato alla cosa. Rimanemmo d’accordo che
l’avrei richiamato io, ma poi non mi feci più vivo perché in fondo, mi dissi, se
la cosa non interessa lui, a me interessava ancora meno. Rimasi comunque
sorpreso dal fatto che lui, che pure da anni si batte affinché si sappia la “sua
verità”, non mi richiamò più. E dopo qualche tempo ho capito il perché. Lui fa
semplicemente parte della fazione “perdente”, in un gioco di cui è perfettamente
consapevole, ma che non viene divulgato al grande pubblico. Quando la famiglia
non fa parte dell’organizzazione, per eliminare qualcuno si interviene in due
modi:
1) Si cerca di
comprarla o di cooptarla. Le si dà un posto in politica, in TV, le si dà un
incarico importante. Le si offrono dei soldi e i familiari, rassegnati,
preferiscono una vita tranquilla senza problemi economici ad una infernale in
cui rischieranno anche la vita, avranno difficoltà economiche, e non otterranno
giudiziariamente nulla.
2) Si procura un
incidente che sembri un vero incidente. Un incidente di auto, di moto, un finto
suicidio inscenato discretamente, con un biglietto in cui si chiede “perdono” ai
familiari. In tal modo le famiglie possono evitare di guardare in faccia la
realtà. Possono continuare a dire “è stato un incidente” e continuare a dormire
sonni tranquilli. E nella malaugurata ipotesi in cui i familiari sospettino
qualcosa, in genere non troveranno prove a sostegno di quanto dicono, e verranno
fatti passare per pazzi o visionari.
Esemplare il caso della
signora Gemini, madre di Niki Aprile Gatti, che viene spesso presentata, dai
media, come una mamma che non riesce ad accettare il suicidio del figlio. In una
recente intervista televisiva, ad esempio, invece di analizzare le prove a
sostegno della tesi della mamma, hanno costruito la puntata in modo che il
momento più incisivo della trasmissione fosse quello in cui alla domanda “come
mai sostiene che suo figlio sia stato ucciso?” lei risponde “perché una madre
conosce suo figlio e Niki non si sarebbe mai suicidato”. In altre parole, hanno
trascurato le prove per far leva su un argomento emotivo, e quindi facilmente
smontabile. Le vittime, insomma, vengono in genere scelte all’interno
dell’organizzazione per vari motivi. Uno dei motivi è che solo in questo modo si
riesce a programmare in anticipo e con precisione la data, il luogo e la
modalità dell’omicidio, in modo che simbolicamente rispecchi la ritualità che si
vuole realizzare. Ma credo che la cosa abbia anche un’altra valenza, nel senso
che in tal modo ci si assicura che la vicenda non faccia scalpore, che la gente
non capisca, e dunque che il silenzio regni sovrano. Uccidendo una persona i cui
familiari sono dentro il sistema, infatti, ci si assicura che essi mantengano il
silenzio e accettino supinamente la loro sorte, senza protestare. Pensiamo ad
esempio alla rassegnazione di Stefano Lorenzi, il padre del piccolo Samuele, che
ha perso il figlio ma ha continuato a rimanere in silenzio vicino alla moglie,
con un atteggiamento che è a dir poco contraddittorio per chi osserva
dall’esterno, ma che è perfettamente normale per chi conosce le dinamiche in
seno alla (o attorno alla) Rosa Rossa. Infatti, nei pochi casi in cui la
famiglia non è controllata né direttamente né indirettamente, può scoppiare un
vero casino. E’ sufficiente vedere la forza con cui portano avanti la lotta
Salvatore Borsellino, Ornella Gemini mamma di Niki Gatti, i familiari di Attilio
Manca, per capire che in effetti, colpire qualcuno che non abbia un substrato
familiare compiacente può ripercuotersi come un boomerang contro il sistema, che
sarà costretto a subire un insieme di fastidi non sempre programmabili in
anticipo. Prendiamo ancora come esempio Ornella Gemini. Le hanno ucciso il
figlio, fatto sparire le prove, hanno cercato in modi diversi di piegarla
psicologicamente, ma lei è sempre lì, a scrivere sul blog, a organizzare
manifestazioni, a partecipare a manifestazioni altrui, a leggere, informarsi,
urlare. E quando si ascolta Ornella viene da piangere. Commuove. Smuove le
coscienze. Come commuove e smuove le coscienze Salvatore Borsellino, quando
parla. Lo senti parlare e ti viene voglia di combattere, di dire “ma si
ammazzateci tutti, avete rotto le palle, ma io non me ne sto zitto”. Se i
parenti delle vittime di Ustica, del Mostro di Firenze, e dei molti omicidi
cosiddetti “in famiglia” come quelli di Erba, Cogne, Garlasco, Meredith, ecc.,
urlassero anche solo la metà di quanto urlano Ornella, la famiglia Manca, e
Salvatore Borsellino, l’Italia si sarebbe svegliata da un pezzo.
L'omicidio
massonico. L'omicidio dei bambini.
Alcune considerazioni sul caso Yara e Sarah, scrive Paolo Franceschetti. 1.
Premessa. 2. In nome di Ishmael. I moventi dell'omicidio di minorenni. 3. Alcune
considerazioni sul caso Yara e Sarah. 4. Allegato. Primi appunti sul simbolo
trovato sul corpo di Yara.
1. Premessa. Una delle
domande più frequenti che mi fanno i lettori (ed è per questo che mi decido a
scrivere un articolo come questo) è questa: “Ok, passi che la massoneria uccida
i testimoni di Ustica, che sequestri Moro uccidendone la scorta, ecc., ma che
interesse ha ad uccidere Sarah Scazzi, o Yara Gambirasio? Che interesse ha ad
uccidere una famiglia, nel delitto di Erba?” Con questo articolo rispondo anche
alla domanda “perché non ti occupi di Sarah e Yara?”. La risposta non è semplice
perché non esiste un’unica risposta. La massoneria è un’organizzazione
complessa, e ramificata, e dunque estremamente complessi e ramificati sono i
suoi fini. Faccio spesso il parallelo con la mafia. Alla domanda “che interesse
ha la mafia ad uccidere?” la risposta non potrebbe essere unica. La mafia uccide
per sopprimere testimoni, per uccidere poliziotti o magistrati scomodi, persone
che tradiscono, pericolose, scomode, a fini estorsivi, o anche solo per lotte di
potere interno. Le motivazioni degli omicidi massonici sono ancora più
complesse, e per certi versi incomprensibili secondo la logica comune. Una volta
che relativamente ad un delitto si trovi la simbologia massonica, e una volta
quindi individuato il delitto come “massonico”, ciò non ha alcuna utilità,
perché non serve per individuare esecutori, mandanti e movente. Così come
capiamo che una persona è stata uccisa dalla mafia, se il delitto avviene a
Palermo, in pieno centro, con una raffica di mitra al volto, oppure se troviamo
una persona incaprettata, ma tale comprensione ancora nulla ci dice
dell’assassino e del movente, così trovare simboli massonici sulla scena di un
delitto ha una valenza pratica pari a zero. Quindi, individuare simboli e
numerologia massonica nel delitto di Avetrana e Brembate non serve a nulla. Una
volta spiegato ai lettori, coi precedenti articoli, la simbologia base di un
delitto massonico, infatti, ciascun lettore di questo blog ha potuto capire da
solo che erano delitti firmati dalla Rosa Rossa e non c’era bisogno di un mio
articolo per spiegare ciò che hanno capito tutti. Impossibile, invece, capire
per ora i moventi o anche solo individuare potenziali colpevoli. Un discorso
generale su questi omicidi, però, possiamo farlo.
2. In nome di Ishmael.
I moventi. Da poco mi è capitato di leggere un romanzo di Giuseppe Genna, dal
titolo “In nome di Ishmael”, che parla proprio dell’omicidio dei bambini.
L’autore nel romanzo narra di un’organizzazione internazionale, Ishmael, che è
dietro agli omicidi di molti bambini, e dietro al traffico internazionale
collegato al caso Dutroux, come dietro al delitto di Lady Diana o al delitto
Moro. I delitti dei bambini sono compiuti per propiziarsi forze esoteriche
relative a grandi eventi di portata nazionale o internazionale. In altre parole,
ogni delitto è un sacrificio umano compiuto per collegarlo esotericamente e
simbolicamente, a vicende come il delitto Mattei, il sequestro Moro, ecc.
Leggendolo ho capito che l’autore parlava della Rosa Rossa, e parlava di fatti
reali, non inventati. Il libro è scritto da una persona addentro a queste cose,
essendo stato consulente della commissione P2 e della commissione stragi.
Facciamo quindi parlare uno dei protagonisti del romanzo. Ne trascrivo i
dialoghi più importanti. Alla domanda “perché Ishmael uccide?” il protagonista
risponde: “Con Ishmael il significato si chiarisce a distanza di anni. Bisogna
aspettare. Ci sono altre realtà, superiori al piano politico. Sono realtà
spirituali e queste realtà guidano il piano politico occultamente. Realtà che a
noi sembrano religiose. E’ chiaro uno dei meccanismi rituali di Ishmael: in
vista di ogni attentato importante viene compiuto il sacrificio di un bambino”.
Occorre quindi aspettare anni, spesso aspettare una serie di delitti, per
capirne il significato. Ad esempio, per capire i moventi nella vicenda del
Mostro di Firenze ci sono voluti decenni. Nel delitto di Cogne ci sono voluti
molti anni per capire il significato completo della vicenda (anche se la
Carlizzi c’era arrivata subito; nel mio caso però ho impiegato due anni perché
non riuscivo a leggerne i simboli esoterici che mi sono stati chiari solo dopo
molto tempo).
3. Alcune
considerazioni su Yara e Sarah. Il libro di Genna riassume quindi perfettamente
la logica rituale dietro all’omicidio dei bambini compiuto dalla Rosa Rossa. Per
Sarah e Yara occorrerà aspettare ancora per capire a cosa sono collegati questi
omcidi. Probabilmente occorrerà aspettare una terza vittima, che questa volta,
per i motivi che stiamo per dire, potrebbe essere violentata. Partiamo da queste
considerazioni. La ritualità di questi due omicidi è chiara. L’assonanza dei
nomi Sarah e Yara, accomunate da quell’ara finale, che ricorda la parola altare.
Il loro corpo è, quindi, un altare sacrificale. Il fatto che Sarah sia scomparsa
il 26 agosto; il 26 novembre dopo tre mesi esatti scompare Yara, che verrà
ritrovata il 26 febbraio, ancora una vola dopo te mesi dalla scomparsa. Il 26
che ritorna in questi delitti, è un numero fondamentale per la Cabala, perché
rappresenta la valenza numerica del nome di Dio. Cabalisticamente la parola
Yahvè (YHWH), dà come somma proprio il numero 26. Abbiamo poi il ritrovamento
del corpo di Yara nel campo di proprietà della ditta Rosa & C., mentre le rose
erano in bella mostra anche nel cancello che dava sul cortile di casa Misseri.
Anche il parroco, ai funerali di Yara, ha fatto un’affermazione incomprensibile
ai “non iniziati”, e che tutti i giornali, manco a dirlo, hanno ripreso: Yara è
come Santa Maria Goretti. Non posso dire se il parroco l’abbia fatto apposta o
meno; ma certo non è casuale che questa affermazione abbia fatto il giro dei
mass media, in quanto Santa Maria Goretti ha come simbolo il Giglio. Abbiamo
insomma un’infinità di indizi che fanno capire che si tratta di un delitto
rituale. Gli indizi più importanti poi, oltre quelli simbolici, sono costituiti
dal nome delle persone coinvolte, il livello degli avvocati che si interessano
alla vicenda, assolutamente sproporzionato per un delitto di matrice solo
sessuale, da cui desumiamo che il livello degli interessi in gioco è molto alto.
Occorre considerare che spariscono in Italia oltre 1000 minorenni all’anno. 1033
nel 2009, per la precisione. Queste poi sono solo le cifre ufficiali, che non
tengono conto di tutte le sparizioni dei bambini figli di Rom, quindi non
registrati all’anagrafe, o entrati clandestinamente in Italia, che fanno salire
la cifra almeno al doppio. La Rosa Rossa, e l’internazionale dei pedofili, è
dietro a molte delle sparizioni di bambini, anche di quelle che non compaiono
sui media. La differenza tra un delitto che non fa rumore e uno che assume
rilevanza mediatica, è solo nel tipo di destinatario e nell’importanza del rito.
Molti bambini spariscono per finire nel traffico di organi, nei riti satanici,
negli snuff movies. Quando dietro alla morte di un minorenne invece si solleva
un caos mediatico delle proporzioni di Yara e Sarah, vuol dire che tale evento è
collegato a qualcos’altro di proporzioni nazionali o internazionali. Nel caso di
Yara, per esempio, il cui significato è “primavera”, potrebbe trattarsi di un
evento molto importante che avverrà in primavera (una guerra, una catastrofe,
ecc…); collegando questo nome con quello di Sarah (che nella Bibbia è la sposa
di Abramo e quindi colei che partorisce il popolo eletto), c’è la possibilità
che l’evento avverrà nel Medio Oriente. E’ probabile anche che debba avvenire un
terzo delitto e che il percorso seguito sia, simbolicamente e in codice, nella
“Nascita di Venere” del Botticelli. Sulla destra del quadro infatti c’è la
Primavera, coperta di fiori e piante varie (e Yara è stata trovata ricoperta da
arbusti). Al centro c’è Venere, che assomiglia in modo impressionante a Sarah,
ed è rappresentata nuda dentro una conchiglia, davanti al mare (e ricordiamo che
Sarah stava andando al mare prima di essere uccisa). Se questa ipotesi fosse
vera, mancherebbe un terzo delitto, che dovrebbe simbolicamente ricordare la
figura alla sinistra del quadro. L’ipotesi del collegamento di questi delitti
alla Nascita di Venere è stata formulata da una persona che conosco ed è una
possibilità, non una certezza. Ma la percentuale di probabilità che l’ipotesi
sia plausibile è aumentata il giorno che ho notato che nel libro di Mario Spezi
“Il passo dell’orco”, che parla di due omicidi di due bambini, edito da
Hobby&Work e ancora una volta collegato al Mostro di Firenze e altre vicende
reali, è citato proprio quel quadro. E Mario Spezi è uno che di omicidi di
bambini e Rosa Rossa se ne intende. Resterebbe poi da spiegare esattamente il
significato di questo quadro, ma la spiegazioni ufficiali non mi convincono per
niente, come non mi convincevano quelle relative alla Primavera del Botticelli.
Mi convinsi invece della bontà delle teorie di Lino Lista (che le ricollegava al
canto 28 del Purgatorio di Dante), perché erano le uniche che spiegavano ogni
dettaglio fin nei minimi particolari. Quanto al simbolo esoterico trovato sulla
schiena di Yara, secondo il simbolista Carpeoro questa potrebbe essere la Croce
di Sant’Andrea, che è la firma di una società che si ricollega agli Illuminati.
Potrebbe contemporaneamente rappresentare la firma di colui che ha compiuto il
“capolavoro”, rappresentando le lettere MR secondo la simbologia alfabetica
della Società Guelfa, una delle tante associazioni paramassoniche sorte alla
fine dell’800. Queste però sono solo congetture. Quello che è certo, ancora una
volta, è che i mass media hanno orchestrato un immenso baraccone mediatico,
chiamando sempre i soliti esperti, che sentenziano sempre le stesse cose, come
ai tempi del Mostro di Firenze: un serial killer isolato (per Yara); o al
massimo un contadino (ieri Pacciani, oggi Michele Misseri). Un killer abilissimo
che ieri riusciva ad uccidere sedici vittime, alcune delle quali proprio sotto
il naso degli inquirenti, e facendola sempre franca, mentre oggi riesce a
piazzare un cadavere in un centro abitato, senza lasciare la minima traccia. Il
tutto mentre gli inquirenti commettono un errore dopo l’altro in modo plateale
(oggi non mettendo immediatamente sotto sequestro il garage di Misseri, ad
esempio, oppure non vedendo un cadavere in bella mostra in un campo, per giunta
a poche centinaia di metri da dove partivano le ricerche; ieri mettendo in
galera sempre persone diverse, e tutte immancabilmente poi rivelatesi
innocenti). Un’altra cosa certa è che anche qui la verità si saprà solo tra
molti anni. E l’altra cosa certa è che: “Ishmael non sbaglia mai. Sul lungo
periodo non sbaglia mai. Tutto quello che riusciamo a fare è ritardare i suoi
risultati”. PS. Un giorno poi ci sarebbe da approfondire il motivo per cui
vanno in galera sempre contadini, casalinghe, e spazzini (come Olindo Romano).
Mai avvocati, notai, magistrati, medici, giornalisti, ecc. Nino Filastò nel suo
libro “Storia delle merende infami” dice una cosa giusta (una delle poche,
credo, di tutto il depistante libro). Che i laureati in genere non pagano mai
per i loro delitti e la galera è piena di analfabeti. Uno dei pochi a farsi la
galera (ma solo qualche giorno) fu proprio Mario Spezi, anni fa, per soli 23
giorni. Ma questo sarà oggetto di un altro articolo, in futuro.
4. Allegato. Primi
appunti sul simbolo trovato sul corpo di Yara di Gianfranco Carpeoro. Caro Paolo
ho avuto modo di vedere tanto il tuo post quanto il simbolo inciso sulla schiena
della piccola Yara. Ovviamente mi sono messo subito al lavoro e il mio primo
pensiero è stato quello di verificare tutte le rispondenze letterali della
segnatura. La X è simbolo esoterico in quanto descrive la rotazione del mondo,
in antiche lingue accadiche e mesopotamiche significa protezione, nel
cristianesimo è simbolo del supplizio di Andrea, fratello di Pietro che richiese
di essere crocifisso su una croce che non fosse esattamente uguale a quella del
Cristo. Il simbolo = è invece presente solo in senso numerico, tra i sumeri
veniva usato per indicare il numero due, ma i due simboli non viaggiavano
insieme. Poi ho riflettuto sulla circostanza che il simbolo è stato inciso con
una punta acuminata, credo, sulla schiena della vittima e ciò è una pratica di
cui ho riconosciuto una fonte. Tra le logge di scalpellini e di muratori del
Medioevo che hanno poi dato origine alla Massoneria, nella costruzione delle
grandi cattedrali di quell’epoca, era d’uso che ogni “artista” firmasse la
pietra, specialmente quella d’angolo o la chiave di volta, che aveva levigato e
montato. Questi segni si chiama “lapicidi” e molti studi sono stati effettuati
su di essi. Te ne accludo un esempio, ogni scalpellino sceglieva il suo marchio
tramite una figurazione del tipo che vedi, ma a volte è riscontrabile che siano
state adoperate le iniziali stilizzate. Ne ho esaminati un’infinità, non ne ho
trovato alcuno che possa aiutarci, ma mi sono convinto che la modalità
dell’assassino sia identica. Quindi, a mio avviso, quella è la sua firma, lui ha
firmato il “capolavoro”. Questo mi induce a credere anche che si tratti di un
personaggio isolato, visto che la firma in tal caso sarebbe singola, come era
d’uso, ma non ne sono sicuro, ovviamente. Comunque, poiché la tradizione dei
lapicidi è ben conosciuta tra i massoni, specialmente di alto grado, anzi è
vissuta come tradizione da proseguire con la firma delle “tavole”, interventi
scritti che si presentano in tempio durante le ritualità massoniche a questo
punto mi sono messo a caccia di alfabeti massonici. Ciò anche perché la
tradizione di sovrapporre due simboli separati, facendone uno è tipicamente
massonico o premassonico, squadra compasso, rosa e croce, falce e martello
(simbolo creato da un massone tedesco) ecc. Ne possiedo tanti e c’è voluto del
tempo. Ne ho trovato uno solo, uno solo dove ci sono tanto la X che il = ed è
l’Alfabeto della Società Guelfa, una delle tante associazioni paramassoniche
sorte alla fin dell’Ottocento. Di seguito te lo pubblico intero ma le righe
dell’alfabeto che riportano i simboli che ci interessano sono due e la colonna
che ci interessa è quella dell’alfabeto nuovo. In tale codificazione infatti il
simbolo = risulta corrispondere alla lettera M e il simbolo X risulta
corrispondere alla lettera R. Ma non finisce qui. Nella mia ricerca, secondo le
mie reminiscenze, ho verificato anche la Società Romantica ovvero il 34° grado
della Massoneria. Si tratta degli Illuminati Romantici, associazione che risulta
costituita anche in Italia da un manoscritto, conservato presso l’archivio
Storico di Firenze. Riguardo a tale associazione segreta risulta che i suoi atti
sarebbero stati anche pubblicati molti anni fa ad opera di una non meglio
precisata loggia massonica, guarda caso di Firenze (!) la Concordia. Il testo
del manoscritto, pubblicato un Italia da una casa editrice che non esiste più,
Convivium, nel testo “Rituali e Società Segrete” te lo accludo integralmente
segnalandoti le righe che ti ho evidenziato in rosso e cioè queste: Allorché uno
di essi si trova in un pubblico albergo, incide sopra una tavola, o forma in un
altro luogo visibile, una Croce di Sant'Andrea; doppia X se il trattamento è
stato cattivo; tripla se è stato ben servito. E successivamente Hanno un segno
per riconoscersi e questo consiste nel fare col dito indice della mano sinistra
una Croce di S. Andrea, cioè un X. sopra una tavola, o in qualunque modo che
loro fa comodo, ovvero descriverla in aria. Interessante vero? La Croce di
Sant’Andrea è il simbolo e la firma di questa associazione che evoca gli
Illuminati… Questo è quanto è emerso finora, caro Paolo, nei prossimi giorni
cercherò di andare avanti per vedere se salta ancora fuori qualcosa d’altro.
Tieni presente che la Croce di Sant’Andrea fa parte anche del simbolo di un
grado del Rito Scozzese, ma questi la incidono e poi fanno parte per definizione
della famiglia degli Illuminati… Se vuoi pubblica pure questa ricerca nelle
forme che meglio credi, a mio nome o a tuo, o magari fanne la base per tue
ulteriori ricerche, a me sembra un strada interessante. Un Abbraccio Carpeoro.
L'omicidio
massonico. Come si occulta la verità,
scrive Paolo Franceschetti. E cenni sull’omicidio di Carmela Rea. 1. Premessa.
2. L'omicidio di Carmela Rea. 3. Le tecniche di depistaggio. 4. I periti. 5. Gli
avvocati. 6. I magistrati. 7. Polizia e Carabinieri. 8. I criminologi. 9. I mass
media. 10. Conclusioni.
1. Premessa. E’ ormai
qualche anno che cerco di studiare i delitti rituali della Rosa Rossa e una
delle cose che ho cercato di capire di più era come facessero a depistare
sistematicamente tutte le indagini. Che la Rosa Rossa abbia in mano tutta la
stampa, la magistratura e gli organi di polizia è evidente; ma è altrettanto
evidente che il controllo di questi organi avviene non per cooptazione diretta,
ma indiretta e inconsapevole. Non è possibile, infatti, che tutti gli avvocati,
gli investigatori, e i giornalisti che se ne occupano siano dentro alla Rosa
Rossa, anche perché nella stragrande maggioranza dei casi non hanno né
l'intelligenza né la cultura per far parte di un'organizzazione del genere. In
altre parole, la maggior parte degli inquirenti, dei giornalisti e dei
magistrati ignora cosa sia la Rosa Rossa e in genere non ne sospetta neanche
l'esistenza. Dopo qualche anno, dopo colloqui con carabinieri, poliziotti,
periti, magistrati, giornalisti, cameramen, la risposta mi è chiara e può
tracciarsi una sorta di schema, seguito ogni volta per ogni delitto. Partiamo
dall’esempio di Carmela Rea, morta di recente. Le dichiarazioni dei criminologi
intervenuti sono talmente demenziali che mi hanno ispirato questo articolo per
spiegare i meccanismi di un’indagine, a grandi linee.
2. L’omicidio di
Carmela Rea. In quest’omicidio risultano chiaramente rituali sia la data della
morte, sia il nome della donna, sia i riferimenti e le immagini mandate in TV.
Per i lettori di questo blog tutto ciò è cosa nota quindi mi soffermo su altri
particolari. La cosa che colpisce sono le idiozie dette dai criminologi nei vari
programmi TV. E la domanda è: come è possibile che nessuno ci arrivi? Che
nessuno colleghi? Che nessuno sospetti qualcosa di più? E come è possibile dire
una quantità di idiozie, come quelle che normalmente dicono i criminologi,
puntualmente sempre gli stessi invitati a queste trasmissioni? La donna è
scomparsa nel pomeriggio e il cadavere è stato ritrovato solo in seguito, mentre
la data della morte è quella probabilmente del giorno successivo, tra la
mezzanotte e le due. Il cadavere è stato ritrovato privo del sangue (cosa tipica
di tutti i delitti rituali) il che significa che l’omicidio è avvenuto in zona
diversa dal ritrovamento. La donna ha subito 35 coltellate e sul corpo ci sono
anche dei segni esoterici incisi. A fronte di queste evidenze, c’è da domandarsi
come si fa a sostenere la tesi del serial killer o del delitto passionale.
Carmela infatti stava facendo una gita col marito e si è allontanata per un solo
momento; dovremmo supporre che il presunto amante l’abbia stordita e portata in
un altro luogo, oppure – ipotesi ancora più inverosimile – l’abbia convinto a
seguirla. Lì l’abbia uccisa dopo poche ore e poi abbia portato il cadavere in un
altro luogo, rischiando di essere scoperto, o fermato. Inoltre resterebbe da
capire perché questo presunto amante l’abbia uccisa con 35 coltellate, alcune
sferrate anche dopo la morte. In realtà analizzando i pochi dati che ci hanno
evidenziato i giornali (dati che spesso sono falsi, questo occorre dirlo, ma qui
partiamo dal presupposto abbastanza improbabile che siano veri) risulta chiaro
che la persona è stata uccisa con premeditazione, e probabilmente l’uccisione in
un posto per poi trasportare il cadavere in un altro ha un significato ben
preciso, ben diverso da quello che ha in un delitto seriale o passionale.
Peraltro, ad escludere il delitto passionale dovrebbe bastare la svastica
nazista che - sempre stando a quel che dicono i giornali - sarebbe stata incisa
sul corpo della donna; e sarebbe da prendere in considerazione il fatto che il
corpo è stato ritrovato il 20 aprile, proprio il giorno del compleanno di
Hitler. Ma è ovvio che la verità anche questa volta non verrà mai a galla.
Cercherò di spiegare allora come funziona il meccanismo investigativo in questi
casi, e come sia possibile arrivare a simili livelli di demenzialità nelle
trasmissioni che si occupano della vicenda.
3. Le tecniche di
depistaggio. Per capire come si depistano le indagini in un delitto qualsiasi
occorre tenere presente che l’analisi della scena di un delitto avviene in più
fasi. In un primo momento interviene generalmente la squadra volante della
polizia, che fa un primo sopralluogo, con o senza il magistrato di turno. La
volante fa un primo rapporto (talvolta a seconda delle zone possono intervenire
i carabinieri). Dopodiché il caso passa a chi se ne occuperà realmente; in
polizia la squadra mobile. Oppure se è intervenuta per prima la caserma x dei
carabinieri, il caso può passare ad una stazione diversa. Le indagini poi sono
dirette dal magistrato, e a condurre le indagini non sempre sarà quello di
turno. E poi abbiamo i periti. Ecco quindi che l’analisi della vicenda può
essere fatta da tanti soggetti diversi, con competenze diverse, e idee diverse.
Spesso è sufficiente che un solo elemento di questa vicenda sia nelle mani
dell’organizzazione perché tutta l’inchiesta ne risulti inquinata e sia
nell’impossibilità di proseguire correttamente. In altre parole, non c'è bisogno
di tenere sotto controllo tutti coloro che partecipano a vario titolo alle
indagini, ma è sufficiente assicurarsi una complicità in uno o due punti chiave
di tutta l'operazione.
4. I periti. Il perito
ha un ruolo chiave in tutta la vicenda. Il burattinaio di questi delitti infatti
si assicura sempre che la perizia sia svolta o da un incompetente o da una
persona interna all’organizzazione. Se il perito stabilisce, ad esempio, che è
perfettamente normale che un avvocato di 40 anni si suicidi con una calza da
donna al termosifone, come l’avvocato Silvia Guerra di Macerata, il caso è
chiuso. Se il perito stabilisce, come è capitato, che è perfettamente normale
che una donna si infili un coltello nel torace e non esca una goccia di sangue,
il caso è chiuso. Suicidio. Se il perito stabilisce – come nel caso di Niki
Aprile Gatti – che è possibile suicidarsi con un laccio da scarpe, allora il
caso è chiuso. Suicidio. Se il perito stabilisce che ci si può suicidare con una
balestra, come nel caso di Stefano Anelli, il caso è chiuso. Se il perito
stabilisce che ci si può suicidare in una doccia, come l’avvocato Antonio
Colelli, il caso è chiuso. A formare dei periti incompetenti concorre una
letteratura che spesso è fuorviante; in un manuale di medicina legale, scritto
da un magistrato (e non da un medico legale) e con prefazione di Pier Luigi
Vigna, ad esempio, si trova scritto che è perfettamente normale che una persona
si suicidi con le ginocchia che toccano terra; se poi sul corpo si troveranno
dei lividi, contusioni, botte, ecc., ciò è dovuto al fatto che spesso il suicida
si agita e sbatte ripetutamente contro il muro. In altre parole, i periti che si
berranno acriticamente queste idiozie, se sono poco intelligenti ripeteranno
queste formulette. I periti più bravi verranno comprati. E quelli che non si
adegueranno verranno uccisi (come Luciano Petrini, che stava facendo la perizia
sulla morte del colonnello Ferraro, che si sarebbe impiccato ad un
portasciugamani, a colpi di portasciugamani). Credo ad esempio che almeno la
metà dei periti che quotidianamente ci ammorbano in TV con la loro teorie
assurde siano in buona fede. Molti di essi infatti appena parlano dimostrano di
essere talmente incompetenti che è assai probabile che credano davvero alle
idiozie che dicono. Alcuni, invece, sono dotati di grande intelligenza, come
Francesco Bruno, e sono menti raffinatissime (per usare un termine di falconiana
memoria). Difficile pensare che costoro caschino dal pero e non sappiano come
funziona il sistema. Anzi, probabilmente è tra alcuni di loro che si devono
cercare i mandanti di certe operazioni.
5. Gli avvocati.
L’altro elemento importante per il depistaggio sono gli avvocati. Mi sono sempre
domandato dove prendessero i soldi le famiglie delle vittime per farsi difendere
da avvocati del calibro di Taormina, o, come nel caso di Avetrana, dall’avvocato
Coppi, che è uno dei penalisti più affermati d’Italia, una cui consulenza può
costare come un appartamento. Il punto è questo. Se l’avvocato è bravo dopo un
po’ capisce il sistema e può anche arrivare alla verità. Non a caso nella
categoria degli avvocati c’è un’elevata mortalità e un alto tasso di suicidi.
Tra il 2009 e il 2010 ricordo i nomi di Silvia Guerra, Giuseppe Porfidia,
Antonio Colelli, Monica Anelli, Giacomo Cerqua, Massimo Buffoni, l'onorevole
Fragalà, e molti altri, tutti morti in circostanze talmente assurde che nessuno
crede al suicidio o all’omicidio (nel caso di Monica Anelli sarebbe stata uccisa
dallo zio con una balestra). Negli anni passati invece ricordiamo l'avvocato
Masi, ucciso a Teramo a colpi di mannaia insieme alla moglie, o l'avvocato
Cipolla, ucciso a Palermo a colpi di Roncola. Nella maggior parte dei casi gli
avvocati non riescono a capire il meccanismo in cui sono inseriti. Quando
iniziano ad intuire qualcosa vengono fatti fuori. Non a caso gli incidenti a me
e Solange, e i primi tentativi di eliminarci, sono avvenuti quando iniziavamo ad
avvicinarci alla verità. E i primi tentati omicidi ai nostri danni sono stati
compiuti ad opera probabilmente delle stesse persone che ci facevano il servizio
di protezione, gli agenti della Digos. Se non da loro direttamente, comunque
certamente con il loro aiuto e con la loro complicità, consistita nella
sparizione di documenti, nel voluto depistaggio, nelle omissioni, ecc.
Attualmente nel mio studio legale siamo in 5, e da poco a Solange si è aggiunta
un’altra persona che è scampata alla morte per un pelo sol per aver capito
troppo. Gli avvocati direttamente coinvolti nel sistema e direttamente aderenti
alla Rosa Rossa o organizzazioni simili non sono molti e in genere intervengono
solo in processi di rilevanza nazionale o internazionale. Quei pochi però si
spartiscono la maggior parte dei processi importanti di rilevanza mediatica e
spesso contattano la vittima offrendosi gratuitamente; in genere la vittima e i
familiari non rifiutano, ritenendo in tal modo di essere tutelati e anzi
ritenendosi pure fortunati. In conclusione, gli avvocati in genere non hanno la
preparazione per capire il fenomeno davanti a cui si trovano, il che avviene nel
90 per cento dei casi. Se cominciano a capire vengono uccisi o estromessi dal
processo. E in genere i processi più importanti sono appannaggio di avvocati
interni all'organizzazione.
6. I magistrati. Quanto
ai magistrati il problema è simile a quello degli avvocati; spesso (anzi, quasi
sempre) non hanno alcuna competenza specifica, quindi in genere si fidano degli
ufficiali di PG addetti al loro ufficio. Un magistrato diventa tale solo perché
ha superato un concorso in cui studia tre materie (diritto civile, penale e
amministrativo), senza alcuna attinenza con la realtà, senza aver fatto alcun
corso di investigazione, e senza sapere nulla di ritualità, organizzazioni
esoteriche, ecc. Dopodiché, dopo anni passati a occuparsi di traffico di droga,
furtarelli e altri reati minori, incappa nel delitto rituale. Ecco come possono
prodursi aberrazioni come quelle capitate all’epoca del serial killer Minghella,
uccisore di prostitute, che scriveva la parola “Rose” sulla schiena delle
vittime. La parola fu attribuita ad un maldestro tentativo di attribuire i suoi
delitti alle Brigate Rosse, e gli indizi di carattere rituale, in tal caso
evidenti come un elefante in giardino, non sono stati visti da nessuno. In linea
di massima il 50 per cento dei magistrati non conosce neanche la differenza tra
Massoneria e P2 e fa di tutta l’erba un fascio. Il restante 40 per cento è in
massoneria, quindi conosce la massoneria in sé, ma aderisce alle obbedienze
regolari ed ufficiali, Grande Oriente d’Italia, Gran Loggia Regolare, Cavalieri
di Malta, non conosce la differenza tra Massoneria e organizzazioni esoteriche,
massoniche o paramassoniche; solo un 10 per cento (in genere i magistrati che
rivestono le funzioni più importanti e che si occupano dei casi più importanti
all’interno di un tribunale) conoscono perfettamente il sistema. Ma quelli, per
ovvi motivi, non lo combatteranno mai e sono posti a dirigere procure e
tribunali al fine di assicurare il corretto funzionamento (non della giustizia
ma) del sistema. I pochi magistrati che lavorano davvero per arrivare alla
verità vengono destituiti, trasferiti, o uccisi. Ma si tratta di eccezioni. In
linea di massima è l'ignoranza del magistrato che garantirà la totale impunità
all'organizzazione.
7. Polizia e
Carabinieri. La maggior parte degli ufficiali di Polizia e Carabinieri hanno un
grado di scolarità bassissimo. Mal pagati e mal addestrati, e mal aggiornati,
non sanno nulla di simbolismo, sette segrete ecc. Basti pensare che a Firenze la
sezione antisette ha un organico, se non ricordo male, di due persone o tre. Due
persone che dovrebbero quindi indagare su tutto ciò che ruota attorno all’Ordo
Templi Orientis, Golden Dawn, Rosa Rossa, ecc… Più o meno come combattere la CIA
con una fionda. In alcune città, come Viterbo, non esiste neanche un settore
antisette perché, si sa, le sette non esistono, e se esistono sono innocue, come
garantisce il famoso esoterista Massimo Introvigne (il quale ha la biblioteca
esoterica più grande del mondo, 50.000 volumi; quindi, in sostanza, è uno che si
occupa di un fenomeno che non esiste). Ma l’ignoranza abissale in cui versano
poliziotti e carabinieri è il miglior modo per renderli servi docili del
sistema. I pochi che svolgono indagini serie dopo un po’ vengono allontanati,
uccisi, o mobbizzati. Ricordiamo ad esempio che i poliziotti che avevano
indagato sulla banda della Uno Bianca, individuando i fratelli Savi, furono
trasferiti per punizione. A Viterbo un’ispettrice di polizia troppo ligia al
dovere prima è stata trasferita varie volte; a Natale del 2007 spararono contro
la vetrina del negozio del marito e poi ebbe un incidente in auto
(malfunzionamento improvviso e inspiegabile dei freni) che le causò un forte
stress e che l’ha messa definitivamente fuori gioco. Inutile dire che, anche tra
i suoi colleghi, quelli che vedono la coincidenza tra i vari eventi sono
pochissimi; molti, più che altro per ignoranza, non mettono in collegamento i
fatti e ritengono il tutto frutto di una cattiva manutenzione dell’auto. Il
commissario Giuttari, che era andato un po’ troppo avanti nell’individuazione
del livello ulteriore oltre a Pacciani, nei delitti del Mostro di Firenze, fu
messo ad ammuffire al servizio ispettivo del ministero e anche condannato
penalmente. E così via. Infatti, anche se dopo qualche mese io e Solange ci
accorgemmo che i tentati omicidi ai nostri danni erano effettuati con la
complicità delle persone che dovevano in teoria garantire a Solange un servizio
di “protezione”, abbiamo sempre pensato che abbiano fatto tutto ciò senza sapere
assolutamente cosa facevano e perché. Il funzionario Digos che dopo
l’avvelenamento di Solange interrogò me e Solange cercando di costringerla a
confessare che si era avvelenata o drogata da sola con la mia complicità per
farsi pubblicità, era infatti talmente ignorante che non poteva certamente
sapere cosa stava facendo. Ricordo che durante il colloquio, mentre spiegavo al
funzionario che il padre di Solange era affiliato al Grande Oriente d’Italia, mi
chiese “ma cos’è il Grande Oriente d’Italia?”. Era ovvio cioè che lui stava
facendo il suo lavoro, su mandato di altri, ma era totalmente inconsapevole
dell’ingranaggio in cui era inserito. E non riusciva neanche a capire di cosa
parlassi. Forse, chissà, pensava pure di fare una cosa utile alla nazione,
cercando di smascherare due rompicoglioni come me e Solange, con manie di
protagonismo. Tempo fa ho parlato con un ufficiale dei carabinieri che mi
spiegava come spesso ricevono ordini dall’alto per effettuare questo o
quell’arresto anche in mancanza di prove concrete; e lo hanno allontanato dal
servizio perché in genere cercava di opporsi. Un altro funzionario di polizia,
oggi in pensione, mi disse che gli era stato ordinato di fare una cosa illegale,
per la quale poi fu addirittura additato su vari giornali come un depistatore.
Da quel giorno è andato in pensione e si è ritirato a vita privata. In altre
parole, per polizia e carabinieri vale lo stesso meccanismo dei magistrati e
degli avvocati. L'ignoranza totale sarà l'alleata più fedele
dell'organizzazione. Nell'eventualità che il poliziotto inizi a capire qualcosa,
verrà trasferito o, in casi estremi, ucciso, facendo passare l'omicidio per un
suicidio, ovviamente. La stupidità, la paura, l'ignoranza dei colleghi attorno a
lui, farà sì che nell'ambiente non si avrà il minimo sospetto, e quelli che
sospetteranno staranno zitti perché, in fondo, loro devono sempre mantenere la
famiglia.
8. I criminologi. I
criminologi svolgono un ruolo chiave in tutta la vicenda. La letteratura
criminologica di base, ad esempio, non considera mai il problema delle sette. Le
sette, se ci sono, sono composte da sbandati disorganizzati. Le organizzazione
esoteriche più diffuse non sono neanche menzionate. In molti manuali di
criminologia ho addirittura trovato scritto che veri e propri delitti satanici,
nel mondo, non se ne sono mai registrati (ignorando quindi a bella posta anche
casi famosi e ufficiali come quelli di Sharon Tate o delle Bestie di Satana). Il
delitto esoterico e/o rituale, invece, non è neanche menzionato. Come abbiamo
già evidenziato in passato, il più diffuso manuale di classificazione dei
crimini, ovverosia il manuale ufficiale di studio alla FBI, non conosce la voce
“delitto rituale” (cioè non conosce il delitto più frequente nella nostra
società) ma in compenso conosce quello dell’ “omicidio sessuale di donna
anziana” (che è statisticamente rarissimo). Basti pensare che nei delitti del
Mostro di Firenze molti “esperti” continuano a proporre il profilo steso a suo
tempo dall’FBI, che indicava in un serial killer isolato l’assassino, e ignorano
invece il rapporto che stese Francesco Bruno (che parlava di delitti esoterici).
Se poi qualcuno fa cenno ad elementi esoterici, si prendono in considerazione
falsi elementi; nei delitti del Mostro di Firenze si presero come indici di un
delitto esoterico le famose piramidi tronche trovate sul luogo di alcuni
delitti, e non tutti gli altri indizi più importanti (nomi delle vittime, date,
posizione dei pianeti, nomi dei luoghi, ecc.). Ad esempio nel delitto di Carmela
Rea, se non vado errato, la zona dell'omicidio è vicina al Monte di Rosara e al
Dito del Diavolo, mentre il luogo del ritrovamento credo si chiami "Montagna dei
Fiori". Nella vicenda Rea, uno dei soliti esperti intervistati, Massimo Picozzi,
che finora è l'unico ad aver parlato di un delitto rituale, si è affrettato ad
aggiungere "delitto rituale sì... ma di una sola persona". Una sola persona così
forte da poter rapire da sola Carmela, e poi riportarla da morta in un luogo
distante 18 km da quello del ritrovamento. Un superman insomma. In conclusione,
tra i criminologi le persone davvero ignoranti sono poche, perché, dopo qualche
anno, a meno che il soggetto non sia poco intelligente, comincia a capire che
qualcosa non quadra nelle teorie criminologiche più diffuse, e inizia a farsi
qualche domanda in più. Ho parlato con un medico legale che reputo molto in
gamba, il quale mi ha detto: "vedi Paolo, quando i giornali parlano di un
suicidio con una busta di plastica in testa, è al 100 per cento un omicidio.
Quando parlano di un suicidio e la persona tocca con le ginocchia per terra, è
al 90 per cento un omicidio. Ma la maggior parte dei miei colleghi ha paura,
oppure è stupida, e crede davvero alle stronzate che gli dicono di dire".
9. I mass media. Il
ruolo dei mass media è ovviamente il più delicato. Anche qui però la maggior
parte dei giornalisti o cronisti sono inconsapevoli del reale sistema che c’è
alla base. La maggior parte dei giornali si limita a riportare pedissequamente
le veline che le questure selezionano personalmente. I pochi giornalisti che
fanno realmente un’inchiesta dopo un po’ vengono minacciati, esclusi,
allontanati. La maggior parte dei giornalisti, quindi, scrive solo quel che i
padroni impongono e non rischia più di tanto. La prima volta che un giornalista
si avvicina ad un delitto rituale, poi, non è mai in grado di riconoscerlo, e
neanche le successive. Per farlo dovrebbe essere un esperto di esoterismo, cosa
che la maggior parte dei giornalisti non è. A meno che, ovviamente, non faccia
parte del sistema, nel qual caso non c’è pericolo che scriva davvero la verità.
Le persone coinvolte a pieno titolo nell’organizzazione sono solo i giornalisti
che si occupano in modo sistematico di tali delitti perché, a meno che non siano
poco intelligenti, diventa impossibile dopo anni di giornalismo investigativo
non fiutare una pista diversa e unitaria a fronte di una serie così incredibile
di coincidenze in delitti troppo diversi da loro. Quelle sono spesso le menti
dell’organizzazione stessa o comunque sono tra le persone con gli incarichi più
importanti all’interno della Rosa Rossa. Il risultato finale di questa
combinazione tra ignoranza, paura e complicità, è che i mass media svolgono
l'importantissimo ruolo di depistare l'opinione pubblica, focalizzando tutte le
discussioni su punti secondari, inutili e depistanti delle vicende, e
allontanarla dalle domande reali. Nel caso di Carmela Rea, ad esempio, tra
giornali e telegiornali ho ascoltato le seguenti bestialità:
- pista camorristica.
- pista del serial
killer o del movente passionale, entrambe basate sul nulla più assoluto quanto a
indizi.
Inoltre i giornali
hanno dato i seguenti particolari:
- Carmela Rea aveva
sofferto di depressione post partum (particolare assolutamente ininfluente per
capire il movente di un omicidio);
- era una donna
bellissima; particolare in teoria importante, ma solo dopo che si sia stabilito
che effettivamente abbiamo a che fare con un serial killer, altrimenti il
particolare è rilevante quanto il numero delle scarpe;
- in paese tutti la
stimavano, si giravano a guardarla, e la coppia si voleva molto bene.
In compenso si
trascurano i seguenti particolari:
- i numerosi indizi di
ritualità;
- il fatto che il
marito sia un militare e che il cadavere sia stato ritrovato in una zona
militare; coincidenza non da poco, su cui si è soffermato solo il criminologo
Francesco Bruno, sia pure con una teoria abbastanza inconsistente, all'acqua di
rose (e il doppio senso non è casuale ma voluto);
- il fatto che il
cadavere sia stato trovato in una zona militare; nessuno si domanda se non sia
possibile, ad esempio, acquisire le riprese effettuate dai satelliti militari
che monitorizzano continuamente le zone militari, per vedere se sia possibile
individuare l'assassino (più probabilmente gli assassini) nel momento in cui ha
lasciato il cadavere o addirittura nel momento in cui ha rapito la donna;
- il fatto che il
rapimento sia avvenuto di giorno, e che il cadavere sia stato ritrovato a
diversi km di distanza dal luogo del rapimento, indica la possibilità che
l'operazione sia stata effettuata da un gruppo addestrato e organizzato, essendo
quasi impossibile, e troppo rischioso, compiere tutto ad opera di una sola
persona.
Ma questa ipotesi non è
formulata da nessuno. Perché una simile ipotesi, se fosse formulata
ufficialmente, porterebbe la gente a farsi delle domande troppo scomode e
terribili. Quale gruppo ha un potere del genere, di poter uccidere impunemente
facendola in barba alle autorità? E se questo gruppo fosse dietro anche ad altri
omicidi? Domande che nessuno si deve porre. E a rincintrullire completamente lo
spettatore, oltre alle cazzate dei soliti criminologi e alla musica da film
(come se stessimo assistendo all'ultimo film di Dario Argento, e non ad una
storia vera), oltre agli scenari da grande spettacolo tipico della TV, alle
facce tristemente assorte dei conduttori che in realtà non vedono l'ora che
l'organizzazione dalla quale dipendono, consapevolmente o no, regali loro un
altro omicidio possibilmente più efferato possibile, contribuiscono le
pubblicità e le demenzialità che intervallano questi programmi; Chi l'ha visto,
Quarto Grado, Blu Notte, intervallano demenzialità criminologiche ad anteprime
del prossimo Grande Fratello, pubblicità di prodotti di soia transgenici,
dentifrici rigorosamente al fluoro, e magari anche un mutuo, rigorosamente
Compass, ovviamente. E lo spettatore, completamente rincoglionito, non si
accorge che spesso i mandanti sono quelli che compaiono in TV e che il pubblico
televisivo talvolta adora.
10. Conclusioni. In
conclusione, il sistema della Rosa Rossa e degli omicidi rituali si regge in
piedi non perché la maggior parte dei poliziotti, giornalisti, magistrati,
avvocati, sia effettivamente nella Rosa Rossa. Ma si regge per l'ignoranza, la
stupidità, la paura, i soldi. Ciascuna delle persone chiamate a vario titolo in
un'indagine, spesso conosce solo una minima parte della verità e non ha la
minima idea del sistema in cui è inserito: qualcuno si limita ad insabbiare un
particolare, qualcuno a taroccare una perizia, qualcun altro a seguire una pista
anziché un'altra, senza però avere un quadro complessivo della vicenda.
L'ignoranza e la paura sono le due componenti più importanti del sistema in cui
viviamo.
L'omicidio
massonico. Lo schema generale dei vari delitti,
scrive Paolo Franceschetti.
1) Premessa. Delitti
mediatici e delitti non mediatici. Occupandomi da anni di delitti vari, mi sono
reso conto che spesso sono rituali non solo gli omicidi mediatici, cioè quelli
di cui si occupano quotidianamente i mass media, ma moltissimi omicidi secondari
di cui non parla nessuno. La domanda che mi sono posto è: con quale criterio
vengono scelti e selezionati i delitti che poi saranno dati in pasto ai media?
Ogni delitto rituale ha un suo movente specifico di natura esoterica e umana, ha
poi come è ovvio degli esecutori, e spesso dei mandanti ben precisi. Sono molte
le madri che hanno ucciso i figli, ma nessun altro ha avuto il rilievo del
delitto di Cogne; molti i delitti satanici, ma solo quelli delle Bestie di
Satana sono stati presi in considerazione; molti i genitori uccisi dai figli, ma
solo Erika e Omar e Pietro Maso hanno ammorbato le cronache per anni; molti i
bambini che scompaiono, ma solo Yara Gambirasio e Sarah Scazzi di recente hanno
avuto un tale interesse. Moltissime anche le donne uccise da mariti, fidanzati e
amanti. Solo nel 2008 sono state 113 le vittime, e alcune sono state uccise con
modalità (tagliate a pezzi, uccise a colpi di machete, ecc...) da meritare molta
più attenzione rispetto ai delitti cui i media ci hanno abituato. Ad esempio
pochi anni fa a Nereto venne ucciso a colpi di ascia un noto avvocato insieme a
sua moglie, in casa sua; dal punto di vista oggettivo, per gli appassionati di
gialli, sarebbe molto più interessante indagare su questo caso piuttosto che
sorbirsi continuamente nuove rivelazioni di Michele Misseri, o ascoltare le
ultime news sugli amori di Salvatore Parolisi. A Lodi, ad aprile del 2011, è
stato ritrovato un cadavere a pezzi, completamente mutilato, ed era l’ennesimo
di una lunga serie. Chi uccide queste persone in questo modo e perché? In
Abruzzo, due anni fa circa, ricordo l’omicidio di una ragazza di nome Rosa De
Rosa, trovata sulla riva di un lago. Nessun accenno di interesse da parte dei
media. Nulla di nulla anche sul caso della donna trovata decapitata e priva
degli organi interni di recente, a Roma. La domanda allora è: come vengono
scelti i delitti che poi faranno spettacolo? E perché? Tra l’altro è facile
notare che quando un evento è destinato a catturare l’interesse dei media per
anni, giornali e TV ci si gettano a capofitto in anticipo, ancora prima di
sapere se dietro ad esso ci sia un delitto o meno. Per Yara Gambirasio e Sarah
Scazzi, ad esempio, i media si sono buttati a pesce sulla vicenda quando le due
minorenni erano solo scomparse e in teoria avrebbero potuto anche tornare con un
fidanzato dopo una fuga d’amore; per il delitto di Cogne, quando ancora la madre
non era sospettata e si pensava ad un incidente, già tutti i media nazionali se
ne occupavano; idem per il delitto di Novi Ligure e tutti gli altri. In altre
parole, i media sanno già in anticipo quali sono gli eventi di cui dovranno
occuparsi e tralasciano volutamente gli altri. La domanda è: con quali criteri
vengono scelti i delitti? Osservando lo schema generale dei delitti mediatici se
ne trae un quadro complessivo particolare e si può avere la risposta.
2) Lo schema generale.
Gli assassini. Osservando i delitti mediatici di questi anni si può notare che
lo schema è quello che stiamo per esporre. In primo luogo, gli assassini
appartengono sempre a categorie uniche. Ovvero abbiamo:
- una madre che uccide
il figlio (delitto di Cogne; saranno molte altre le madri ad uccidere i figli,
ma nessuna arriverà agli onori della cronaca con tanta veemenza);
- una figlia che uccide
i genitori (Erika);
- un figlio che uccide
i genitori (Pietro Maso);
- i vicini di casa
(delitto di Erba);
- una setta satanica
(Bestie di Satana);
- uno zio e una cugina
(Michele Misseri e Sabrina Misseri);
- compagni di unversità
(delitto Meredith);
- un fidanzato (Alberto
Stasi nel delitto di Garlasco);
- un marito (Salvatore
Parolisi);
- poliziotti (delitti
della Uno Bianca);
- un serial killer
(Pacciani e i compagni di merende).
Non ricorre mai due
volte la stessa tipologia di assassino, ancorché le cronache minori e locali
siano piene di delitti satanici, di omicidi tra parenti, ecc. Anche i delitti
commessi da appartenenti delle forze dell’ordine sono diversi; si va dal
generale dei carabinieri Ganzer, condannato per traffico di droga, a vicende mai
definite, come quella di Milica Cupic, la cui figlioletta di sei anni è stata
uccisa a botte dal marito, generale dell’esercito. Eppure nulla di nulla compare
nelle cronache (la vicenda di Milica Cupic è stata oggetto di una interrogazione
parlamentare e solo questa settimana ha deciso di occuparsene il settimanale
Cronaca Vera, uno dei pochi giornali ad occuparsi anche di delitti secondari).
Un mio amico ex poliziotto mi ha raccontato di una volta in cui un’intera
caserma della polizia fece irruzione in un’altra caserma, dove stanziavano
decine di poliziotti dediti a traffici di droga e altri delitti; i poliziotti
furono tutti arrestati ma non se ne seppe più nulla e sui giornali non trapelò
alcuna notizia. Occasionalmente arrivano alla cronaca anche delitti come quello
di Via Poma, o di Emanuela Orlandi, o delitti clamorosi come la strage in
Vaticano del 1993; qui però l’importanza dell’evento è data più che altro dalla
valenza politica dell’evento e infatti in questi delitti non esiste un colpevole
definito fin dall’inizio. Al contrario, nei delitti che abbiamo elencato c’è un
colpevole definito sin dalle prime battute dell’inchiesta, e la vicenda segue
sempre la stessa sequenza: iniziale incertezza; individuazione del colpevole;
spesso il colpevole confessa ma poi ritratta; dubbi, contraddizioni, colpi di
scena; sentenza finale.
3) Il perché della
scelta. La valenza sociologica dei delitti. Il messaggio positivo. A questo
punto, riflettendo, si può capire il criterio con cui vengono scelti i delitti.
Dal momento che il bombardamento mediatico è talmente eccessivo che qualsiasi
cittadino non può sfuggire al recepimento della notizia, tali delitti servono
per inoculare inconsciamente la paura. La TV è infatti un enorme mezzo di
manipolazione delle masse, perché manipola la mente. Anche le persone più
evolute, infatti, sotto sotto pensano che i personaggi famosi sono quelli
televisivi; e se una cosa viene veicolata in TV è senz’altro un evento di
rilievo. Va da sé che, al contrario, le notizie che non vengono passate in TV
non sono importanti; ma la mente non si accorge di queste manipolazioni. Il
rilievo dato a queste notizie si instilla nel subconscio, e qui nasce la paura.
Paura del vicino di casa, paura di mandare i figli all’università, paura dei
parenti. Anche tra le persone non interessati a delitti, sangue e gialli vari,
circolano comunque battute standard sui vicini di Erba, quando il coinquilino
del pianerottolo fa troppo casino, o sul delitto di Cogne, se il figlio rompe
troppo le scatole. La paura è sottile, quasi impercettibile; ma essa si aggiunge
a tutte le altre paure che, grazie al sistema in cui viviamo, ci vengono
inculcate fin da piccoli; paura di perdere il posto di lavoro, paura della
tasse, dei controlli della finanza, paura della malattia, ecc. Mi resi conto di
quanto sia potente il condizionamento mediatico a seguito di un evento
capitatomi questa primavera; in quel periodo un lettore mi telefonava dandomi in
anticipo notizia che poi si sarebbero rivelate esatte (come l’uccisione di una
persona di nome Angelo, cosa che poi successe due giorni dopo, quando fu ucciso
con un colpo di fucile al cuore un certo Angelo Lolli; ma anche altre e più
precise furono le notizie che costui mi anticipò). Dopo avermi dato alcune
notizie esatte mi disse che il giovedì successivo avrebbero ucciso anche a me;
quando gli chiesi come e chi, mi disse “saranno degli extracomunitari, che
fingeranno una lite e ti accoltelleranno”. La notte successiva – mi pare fosse
il martedì – i miei vicini di casa (africani) alle tre di notte facevano un
casino inimmaginabile recitando delle formule strane in modo rituale, tanto che
quella notte Stefania non riuscì a dormire. La mattina andai a chiedere ad altre
persone del vicinato chi erano e cosa facessero e rimasi abbastanza stupito di
scoprire che la mia vicina si chiama proprio Rose (sottolineo che nello stabile
dove abito ci sono solo due appartamenti, il mio e il loro). Raccontando la
curiosa coincidenza ai miei amici, il primo commento di tutti fu: “Beh, meglio
che giovedì dormi da un’altra parte; ricordati il caso dei coniugi di Erba”. In
questa occasione, come ho detto, ho preso consapevolezza della potenza della
manipolazione mediatica, perché credo che senza il precedente della strage di
Erba nessuno si sarebbe preoccupato di questa cosa, e io probabilmente avrei
dormito a casa mia in tutta tranquillità, mentre invece scelsi di andare a
dormire da Solange per essere più tranquillo, pur sapendo che la telefonata era
una bufala architettata solo per impressionarmi (essendo già la terza volta che
mi facevano uno scherzo simile). Inutile aggiungere che mi guardai bene
dall’andare a protestare dai vicini per il casino, e ho optato per dei più
pratici tappi alle orecchie. Questi omicidi, insomma, hanno varie valenze e vari
moventi. Ma la ragione per cui la TV è infestata ad ogni ora del giorno con i
particolari più idioti e inutili di alcuni delitti, è che veicolano
nell’inconscio la paura.
4) La valenza
sociologica. Il messaggio negativo. A questo obiettivo (veicolare la paura) se
ne aggiunge un altro. Risulta abbastanza evidente come la tipologia dell’omicida
sia sempre quella di un analfabeta, grezzo e ignorante, salvo i casi in cui
vengano coinvolte persone in giovane età e senza una collocazione lavorativa
particolare. Infatti:
Pacciani era un
contadino ignorante e i suoi compagni di merende erano pure peggio;
Anna Maria Franzoni una
casalinga;
Rosa Bazzi e Olindo
Romano sono rispettivamente una casalinga e un netturbino;
Michele Misseri non
riesce a spiccicare due parole in croce;
Salvatore Parolisi è un
sottufficiale abbastanza ignorante, a giudicare dal modo di parlare;
i ragazzi coinvolti
nella vicenda delle Bestie di Satana erano rockettari senza arte né parte, coi
capelli lunghi e ai margini della società (così ce li hanno presentati).
Le persone un po’ più
istruite, quindi Alberto Stasi, Pietro Maso, ecc., sono tutti privi di un lavoro
e in età scolare. In altre parole, tra gli omicidi non compaiono architetti,
ingegneri, avvocati, magistrati, professori universitari, medici, ecc. Eppure di
delitti commessi dai cosiddetti “colletti bianchi” ne abbiamo diversi; c’è il
caso del professore universitario di Pisa che ha ucciso la moglie (professoressa
universitaria) a martellate, ha confessato, non ha fatto un giorno di galera, e
per giunta, quando è finito il processo che l’ha assolto, ha chiesto anche la
pensione come vedovo (per fortuna il parlamento, ad agosto, ha approvato la
legge 125 2011 che nega la pensione di reversibilità al coniuge omicida). Non un
cenno a questo caso su giornali e TV, e il professore in questione continua ad
insegnare all’università. Così come nessun cenno hanno fatto i TG e i giornali
all’emanazione di questa legge, forse per il timore di dover spiegare, poi, che
oltre ai delitti di Sarah Scazzi e Yara Gambirasio, ci sono in Italia situazioni
altrettanto gravi e che meriterebbero molta più attenzione. Ci fu a suo tempo il
caso del PM Pier Luigi Vigna, indagato per essere tra gli esecutori dei delitti
del Mostro di Firenze, ma il cui individuamento portò allo smantellamento della
SAM, e alla promozione del procuratore a capo della DIA, la direzione
investigativa antimafia. Ma per i media queste categoria di persone non
commettono omicidi. Chi uccide sono solo casalinghe, operai, disoccupati, e al
massimo qualche studente, preferibilmente con la passione dell’hard rock e
meglio ancora se iscritto a Forza Nuova o a qualche gruppo di estrema destra e/o
sinistra. Come abbiamo detto, infatti, la manipolazione mentale effettuata dai
media agisce anche in negativo, nel senso che non ci fa percepire ciò che la TV
e i giornali non dicono. Quindi non abbiamo paura dei magistrati, degli
avvocati, dei medici, ecc. Perché quelli – è il messaggio impresso nel
subconscio – non delinquono. Nella mia attività quotidiana mi capita spesso di
sentir dire “ma come fai a dire questo di Tizio o Caio? E’ un professionista
stimato...”, come se professionista fosse sinonimo di persona perbene. All’opera
di manipolazione mentale effettuata dai media e dai film, contribuiscono anche
il cinema e la fiction in generale, ove regolarmente in telefilm come RIS, La
Squadra, Carabinieri, ecc... vengono presentate forze dell’ordine eccezionali ed
efficientissime, avvocati onesti, medici quasi sempre per bene, ecc. Se fino
agli anni ’80 il cinema era ancora, talvolta, occasione di denuncia (vedi ad
esempio i film di Pasolini, o il famoso “Indagine su un cittadino al di sopra di
ogni sospetto”, o anche “Confessione di un commissario di polizia al procuratore
della Repubblica”), attualmente il cinema si è rammollito attorno stereotipi
convenzionali e, anzi, in alcuni casi presenta delle versioni dei fatti
totalmente edulcorate e depistanti (scandalosi ad esempio, sono i film prodotti
dalla Taodue, come quelli sulla Uno Bianca, su Riina, ecc., dove la realtà è
sempre artefatta ed edulcorata). Questa immensa opera di manipolazione di massa
ha dei risultati a dir poco comici. Qualche giorno fa in una nota trasmissione
TV venivano ipotizzate nuove piste su una serie di delitti di diversi anni fa e
uno degli esperti era proprio uno degli assassini; sempre recentemente, a
proposito del delitto della donna decapitata a Roma, la Rai ha intervistato in
qualità di esperto una delle persone che è al vertice delle sette sataniche
italiane ed europee, considerato una delle persone più pericolose in Italia, il
quale ovviamente ha escluso la pista satanica, dicendo che il satanismo è un
fenomeno marginale e quasi inesistente in Italia. Senza arrivare al paradosso di
un giudice Vigna che indaga sui delitti commessi da lui stesso e dai suoi
compagni, o dei fratelli Savi che intervengono sulla scena degli omicidi
commessi da loro stessi poche ore prima, il vero colpo di genio è quello di far
intervenire gli assassini in qualità di esperti e consulenti; perché, dal
momento che nessun romanziere è mai arrivato a tanto, e in TV una realtà del
genere non è mai stata ipotizzata, la mente di chi guarda la TV non è pronta ad
una cosa così grave.
5) Conclusioni sul
potere dei mass media. Normalmente, infatti, quando dico queste cose,
l’ascoltatore medio trasale e pensa che sia una realtà troppo assurda per poter
essere vera. Inaudito pensare che i colpevoli di certi delitti siano i politici,
i giornalisti, i magistrati famosi. Inaudito, sì. A rifletterci bene, però, non
ci rendiamo conto di una cosa. Molti di noi sono pronti ad accettare che l’11
settembre se lo siano confezionato gli Americani da soli per poi avere il
pretesto di scatenare diverse guerre inutili. In altre parole, sappiamo che
alcune persone ai posti di comando hanno dapprima ucciso deliberatamente
migliaia di persone, per poi ucciderne altri milioni, senza alcun motivo reale.
Sappiamo che le stragi di Stato, da Portella Delle Ginestre ad Ustica, passando
per la strage di Bologna e altre, sono state tutte preparate, commissionate ed
eseguite dai nostri servizi segreti, e quindi da uomini dello Stato, che poi
indagavano sui delitti da loro stessi commessi. Molti di coloro che hanno
commissionato quei delitti, da Andreotti a Cossiga, impunemente hanno poi
governato l’Italia, sono andati ai funerali delle vittime uccise per loro
volontà, hanno rimosso poliziotti e magistrati che indagavano troppo seriamente.
E questo lo sappiamo bene oramai. Sappiamo che degli ex avvocati di mafia
siedono in parlamento e fanno leggi sulla quella stessa mafia che loro hanno
difeso in precedenza per decenni. Pur sapendo tutto questo, ci stupiamo se lo
Stato decide di uccidere Sarah Scazzi, Yara Gambirasio, Carmela Rea, o le
vittime di Firenze, per poi indagare su di loro e non scoprire nulla. Eppure
dovrebbe in realtà essere meno grave il delitto di una singola persona rispetto
allo sterminio sistematico di intere popolazioni. Ciò si deve al lavaggio del
cervello cui siamo sottoposti, che ci fa accettare di buon grado una guerra ma
fa si che non siamo disposti ad accettare la verità sui delitti rituali. Come
diceva Pasolini: “Niente di più feroce della banalissima televisione”. Umberto
Eco scrive nel suo “Il nome della rosa”: “I libri si parlano tra loro, e una
vera indagine poliziesca deve provare che i colpevoli siamo noi”. Quello che
vuole dire Eco, a mio parere, è che i colpevoli sono loro, gli esperti TV, gli
uomini famosi, i romanzieri. Ma questo non verrà mai provato. Perché la vita che
viviamo non è un romanzo ma la realtà.
Massoneria e
Rosa Rossa dietro l'omicidio di Marco Pantani: ipotesi shock nel libro di
Franceschetti,
scrive “L’Infiltrato”. Cosa c’è realmente dietro i delitti più importanti
della storia giudiziaria italiana e internazionale? Dal mostro di Firenze alle
Bestie di Satana per passare da Erba, Cogne e Garlasco. Fino a quello di cui si
parla in questi giorni: l'omicidio, perchè di omicidio si tratta, di Marco
Pantani. Paolo Franceschetti in
questo libro offre un quadro della società in cui viviamo, molto
diverso da quello che ci appare attraverso le fonti ufficiali di informazione.
In particolare si parla
di come i media condizionino e falsifichino vicende giudiziarie importanti, di
omicidi eccellenti, da Pantani a Rino
Gaetano, o Pier Paolo Pasolini, per toccare anche il caso
Moro e altri casi
importanti della storia Italiana, al fine di delineare un quadro sconvolgente
della realtà effettiva, di cui non si parla.
Tra le pagine di questo saggio si sviluppa
un’analisi impeccabile e reale in materia di
massoneria, Chiesa
cattolica, e sistema in cui viviamo. Una particolare attenzione
è dedicata alla potente organizzazione magica fondata ufficialmente da
A. E. Waite: L’Ordine della
Rosa Rossa e della Croce d’Oro, vero responsabile dei casi più
illustri della nostra storia. Si dipana così una matassa intricata ma
affascinante, che ci porta a conoscere una realtà che pare fantascientifica ai più, ma purtroppo
molto più reale e concreta di quella, falsa, edulcorata e
manipolatoria, che ci offrono i giornali, i libri, la Tv e la cultura ufficiale.
L’autore Paolo Franceschetti,
avvocato, docente di materie giuridiche,
ha pubblicato libri e articoli in materia giuridica (diritto civile, diritto
penale e diritto amministrativo), per poi specializzarsi come legale nel settore
dei delitti esoterici e approfondire l’influenza della massoneria e della Chiesa
Cattolica nella storia contemporanea e passata. Occupatosi per ragioni personali
dei delitti del Mostro di Firenze, per poi divenire
legale di Paolo Leoni, indicato dai media come il capo delle cosiddette Bestie
di Satana, insieme a costui (e grazie a costui) ha intrapreso uno studio
approfondito delle dinamiche pratiche, sociali, ed esoteriche di alcuni delitti
di matrice massonica o cattolica.
Il libro è Massoneria
e Ordine della Rosa Rossa: il sistema di controllo in cui viviamo e le
connessioni con il Vaticano.
E non finisce qui.
Massoni nell’inchiesta Mose? Interrogazione M5s su Galan. Richiesta di
chiarimenti ad Alfano: «Chi sono i “fratelli” magistrati e poliziotti» Ieri la
moglie ha visitato in carcere a Opera l’ex ministro e governatore veneto, scrive
Daniele Ferrazza su “Il Mattino di Padova”. Un abbraccio, un lungo silenzio,
molte domande sulla piccola Margherita, la figlia di sette anni per la quale
papà «è in viaggio per lavoro». Sandra Persegato, la moglie di Giancarlo Galan,
ha incontrato in carcere il marito, detenuto nel carcere di Opera, alle porte di
Milano. Si è trattato del primo incontro tra Galan e la moglie dalla sera del
suo traumatico arresto, il 22 luglio scorso, a poche ore dall’autorizzazione
votata dalla Camera. Sandra Persegato si è recata a Opera accompagnata dalla
cognata, Valentina Galan: i magistrati infatti hanno autorizzato alle visite,
oltre alla moglie, solo la sorella e l’anziana madre dell’ex ministro. Per il
politico, dopo lo stop del Tribunale del Riesame alla scarcerazione, si tratta
di attendere l’esito del ricorso in Cassazione che i suoi legali stanno
predisponendo. Ma appare evidente che per l’ex ministro ed ex governatore, che
si muove in stampelle in una stanza della clinica del penitenziario di Opera, le
porte del carcere si riapriranno non prima del prossimo ottobre. Una lunga
carcerazione preventiva, dunque, che rischia di mettere a dura prova lo stato
d’animo dell’ex ministro. L’incontro tra Galan e la moglie si trova in carcere,
è durato poco più di un’ora. Saltano sul caso di Galan iscritto alla massoneria,
invece, i deputati veneti del Movimento 5 stelle Arianna Spessotto, Emanuele
Cozzolino, Francesca Businarolo, Marco Brugnerotto, Federico D’Incà, Diego De
Lorenzis, Marco Da Villa e Silvia Benedetti. In una interrogazione rivolta al
ministro dell’Interno Angelino Alfano, i parlamentari grillini sottolineano come
l’appartenza di Galan alla loggia Florence Nightingale di Padova, sia
circostanza alquanto «curiosa»: «l'inchiesta penale veneziana sul Mose sta
delineando un quadro fosco e preoccupante di intrecci tra funzionari pubblici
corrotti e concussi, politici e imprese corruttrici, uomini di assoluto rilievo
dei servizi segreti e delle forze di polizia, quasi una sorta di polizia
parallela, infedele che ostacolava le indagini dei pubblici ministeri veneziani;
non si può escludere l'esistenza di una rete pervasiva e devastante operante in
Veneto, per la copertura e il depistaggio sulle gravi violazioni penali seriali
condotte per l’affaire Mose; l'appartenenza del Galan alla massoneria non può
non destare molta preoccupazione in relazione all'eventuale appartenenza alle
logge di funzionari pubblici e in particolare appartenenti alle Forze armate,
Guardia di finanza e Arma dei carabinieri, con funzioni di polizia e di polizia
giudiziaria, e inoltre alla magistratura; in effetti l'affiliazione alla
massoneria di un magistrato o di ufficiale di polizia giudiziaria preclude di
per sé l'imparzialità (secondo la Cassazione, «essere iscritti alla massoneria
significa vincolarsi al bene degli adepti, significa fare ad ogni costo un
favore. E l'unico modo nel quale un magistrato può fare un favore è piegandosi
ad interessi individuali nell'emettere sentenze, ordinanze, avvisi di
garanzia»). I deputati del Movimento 5 stelle, pertanto, chiedono al ministro
«se non ritenga opportuno acquisire elementi presso le prefetture per
verificare, presso gli appositi elenchi, se risulti la presenza di affiliati
alle logge massoniche di magistrati e appartenenti alle Forze armate con compiti
di polizia». I grillini sollecitano «iniziative disciplinari urgenti, ove ne
sussistano i presupposti, nei confronti di magistrati e appartenenti alle Forze
armate per i quali si verifichi l'eventuale sovrapposizione di appartenenza a
logge massoniche e di sottoposizione ad avviso di garanzia per reati attinenti
allo scandalo Mose».
Governatore e massone.
«Nessun favore ai fratelli. Ora lo giudichino i veneti». Parla con
Giovanni Viafora su “Il Corriere della Sera”il Gran Maestro Stefano Bisi, 56
anni, toscano, eletto al vertice della fratellanza lo scorso marzo: «Lui si è
autosospeso». Giancarlo Galan è stato per 15 anni un «governatore- massone»
(ma poi, se vogliamo, anche un «ministro-massone). Da una parte governatore del
Veneto (e membro del governo), dall’altra «libero muratore », affiliato a una
delle logge padovane del Grande Oriente di Italia (Goi), l’ordine iniziatico più
antico e più importante del Paese. Solo lo scorso 6 giugno, proprio all’indomani
degli arresti del Mose, ha chiesto ai suoi fratelli di «entrare in sonno», cioè
di allontanarsi dall‘«obbedienza ». Oggi, alla luce di quanto si è appreso, gli
interrogativi e i dubbi ovviamente non mancano. Abbiamo voluto interpellare
direttamente la più alta autorità del Goi, il Gran maestro Stefano Bisi, 56
anni, toscano, eletto al vertice della fratellanza lo scorso marzo. Che ha
concesso di farsi intervistare.
Galan è stato
governatore e allo stesso tempo massone: un cittadino veneto, oggi, cosa
dovrebbe pensare?
«Galan doveva fare
esclusivamente il bene della sua Regione. Se poi l’abbia fatto o meno questo lo
devono giudicare i veneti, non il Gran maestro».
La prima cosa
che si può ritenere, tuttavia, è che nel suo ruolo politico l’ex governatore
potesse favorire uno dei suoi «fratelli». Dalle nomine in sanità agli appalti...
«Favorire l’uno o
l’altro vorrebbe dire violare le leggi e il massone quando viene ammesso
promette fedeltà alla Costituzione. Deve sempre essere premiato colui che ha le
caratteristiche migliori, che sia un primario o un ingegnere. Non dev’essere
favorito quello della tua stessa appartenenza; ma questo discorso dovrebbe
avvenire per tutte le associazioni».
A scanso di
equivoci, non sarebbe meglio che un politico rendesse nota la sua affiliazione
alla massoneria?
«In Toscana c’è già una
legge che va in questo senso. Ma noi riteniamo che sia una legge liberticida ».
Si dice che la
massoneria sia in grado di gestire ancora ampie aree di potere. È così?
«Cosa vuol dire gestire
il potere? Quando un fratello entra non gli si chiede se sia un parlamentare o
un ministro; ma gli si domanda solo di essere libero e di buon costume, di avere
sensibilità. E deve dichiarare di credere ad un essere supremo».
Ma quindi cosa
significa essere massoni?
«Prima di tutto
ascoltare gli altri, nelle nostre logge si impara a parlare uno alla volta. Può
sembrare una banalità, ma nel giorno d’oggi vedere un gruppo di persone che
fanno i lavori più disparati, dal professore all’imbianchino, trovarsi a parlare
uno per volta è una cosa rivoluzionaria. La massoneria è un metodo».
Ma di cosa
parlate?
«Gli argomenti sono i
più disparati, ma soprattutto si studiano i simboli. La finalità è quella di
lavorare per la crescita interiore e per il bene dell’umanità».
Ma perché gli
incontri sono segreti?
«Alle riunioni rituali
partecipano solo i fratelli massoni, ma come fa qualsiasi associazione di
uomini. Per altro, se un profano partecipasse a queste riunioni probabilmente
non capirebbe, gli sembrerebbe di essere in un mondo non suo. Negli ultimi
tempi, comunque, abbiamo deciso di fare incontri anche pubblici: ne ricordo uno
importante per esempio a Padova nel 2011, eravamo al caffè Pedrocchi (in prima
fila quella volta c’era l’ex rettore del Bo Vincenzo Milanesi, ndr)».
Anche Galan
partecipava ai rituali?
«Sono obbligatori, la
nostra fratellanza si basa sui riti». E cosa si fa durante i rituali? «Bisogna
indossare i guanti bianchi, ma poi è difficile spiegarlo. Un attore potrebbe
mimare un rituale perfetto, ma senza che ci sia comprensione il suo gesto non
significa nulla».
L’ex
governatore aveva un grado particolare all’interno dell’«obbedienza»?
«Da noi ci sono tre
gradi di appartenenza: apprendista, compagno d’arte e maestro. Vista l’anzianità
di affiliazione Galan sarà stato maestro. Ma di maestri ce ne sono 14mila su
22mila fratelli...».
In Veneto
quanti siete?
«Ci sono 18 logge, 5
solo a Padova e due ad Abano. In tutto circa 500 fratelli».
E ci sono altri
politici?
«Non chiedo a un mio
fratello a quale partito appartiene».
Cosa succederà
ora a Galan all’interno della massoneria?
«Lui ha deciso di
entrare in sonno, cioè di allontanarsi. Il suo caso verrà esaminato, ma la
questione è già risolta. In un certo senso si è già autosospeso».
La Massoneria
del terzo millennio.
Archiviato il ventennio berlusconiano, gli affiliati alle obbedienze italiane
cercano nuovi referenti politici. Simboli esoterici e vecchi riti rimangono, ma
ci si apre al web, con Twitter e Facebook, guardando con speranza a Papa
Francesco affinché faccia cadere la scomunica sancita nel 1738 da Clemente XII.
Ma a fronte del tentato rinnovamento, restano le ombre sollevate dalle inchieste
della magistratura sul peso avuto dalle logge in alcuni passaggi cruciali della
storia recente d'Italia. Macchie talmente pesanti che stanno spingendo a
rimuovere la memoria del passato massone di un'icona come Giuseppe Garibaldi.
Una inchiesta di Alberto Custadero su “La Repubblica”.
La svolta social delle
Obbedienze. Anche la Massoneria diventa social. I Fratelli han deciso di
uscire dal segreto delle logge e presentarsi nel mondo condiviso del Web. È il
caso, ad esempio, del Grand'Oriente d'Italia, principale "obbedienza" con
ventimila affiliati (riferimento al mondo inglese, porte delle logge aperte per
soli uomini). L'Istituzione ha un sito ufficiale online. Ed è presente su
Twitter con l'account @grandeoriente. Mentre il suo gran maestro, Stefano Bisi,
twitta in prima persona firmandosi @bisisiena. Anche i "cugini" della Gran
Loggia d'Italia degli Alam (riferimento al mondo francese, 520 Officine, 10mila
iniziati sia uomini che donne), non sono meno social. Il sito è granloggia.it,
hanno da un anno una omonima pagina Facebook che ha incassato un migliaio di "mi
piace" e 26 visite (non molte, ma sono solo all'inizio). Mentre il gran maestro
uscente, il massonologo e scrittore Luigi Pruneti, è presente personalmente su
Facebook: la sua foto campeggia su uno sfondo (non casuale) di uno dei 22 arcani
dei Tarocchi: il Sole, simbolo della luminosità. Ma anche della massoneria. La
Gran Loggia è presente anche su Twitter, con un migliaio di follower. Oggi molti
profani che vogliono essere iniziati, contattano questa "obbedienza" attraverso
il sito, inviando alla mail gldi@granloggia.it la richiesta di essere invitati
in loggia. Una autentica rivoluzione, rispetto ai tradizionali riti di
"cooptazione" riservatissimi, fatti quasi di nascosto. Ma sotto le "volte
stellate" delle logge italiane, si sta vivendo un momento di gran fermento
politico e sociale. I temi in gioco, dal punto di vista massonico, sono molti. E
delicati. Dal riposizionamento politico dopo la fine del ventennio berlusconiano
all'arrivo al soglio pontificio di un papa gesuita e "rivoluzionario" che fa
sperare i massoni che venga tolto il divieto secolare, per loro, di ricevere la
comunione. Dall'aumento dei giovani che chiedono di entrare in loggia alla
riflessione da parte delle "obbedienze" di matrice anglosassone se sia ancora
attuale, oggi, in una società che si tinge sempre più di rosa, l'esclusione
delle donne.
Alla ricerca
di un referente politico.
All'inizio del 1900 i massoni in Parlamento erano cento e
prendevano pubblicamente posizione sui temi politici, come avvenne, nel 1908,
sull'ora di religione obbligatoria nelle scuole. Dopo le persecuzioni fasciste,
nel Dopoguerra, tuttavia, la massoneria si mosse a livello politico in modo più
riservato. Se non segreto. Il caso più clamoroso di condizionamento occulto
delle istituzioni da parte dei fratelli fu la loggia di Licio Gelli, "propaganda
due". Gelli di recente si è attribuito addirittura il merito dell'elezione del
presidente della Repubblica Giovanni Leone e la stesura del famoso Piano
Rinascita. In seguito allo scandalo della P2, e passato lo tsunami di
Tangentopoli, nel '94 il riferimento per la massoneria divenne Forza Italia (tra
l'altro con lo stesso Berlusconi iscritto alla P2; con Fabrizio Cicchitto che
aveva presentato la domanda per iscriversi alla P2 come dimostra il documento
che abbiamo ritrovato negli archivi della Commissione Anselmi; e con il
plenipotenziario di Berlusconi, Denis Verdini, che, però, ha sempre smentito la
sua appartenenza ai "Figli della Vedova"). Forza Italia era infatti l'unico
partito che, allora, non vietava l'iscrizione ai fratelli. Qualche fratello, a
onor del vero, figurava anche tre le file del Carroccio: nel 1994 a Palazzo
Madama erano stati eletti tre senatori leghisti col grembiulino, e una senatrice
"sorella". Bossi, poi, quando nei comizi imprecava contro i massoni, si girava
per incrociare lo sguardo del parlamentare Matteo Brigandì, suo avvocato
personale. E fratello del Goi.
Gelli stronca
Renzi. Ma oggi,
concluso il ventennio del berlusconismo, e in pieno terremoto Renzi-Grillo,
tutto il mondo dei partiti è cambiato. Non è facile, per la massoneria, trovare
una nuova collocazione nel momento in cui l'attuale scenario politico è in pieno
assestamento. Dopo il governo dei tecnici di Monti accusato di "collusione" coi
poteri forti, con le banche, e anche con la massoneria, Renzi, con una squadra
di giovanissimi, sembra aver rotto gli schemi di un potere vecchio, ma con
consolidati rapporti con le logge. Il dubbio che il premier abbia un padre
massone, del resto, è troppo poco per giustificare un link col mondo dei
grembiulini. Su questo fronte è lo stesso Gelli a stroncarlo: "Matteo Renzi - ha
detto il Venerabile in una recente intervista - non è un massone, ma solo un
bambinone". Né può essere un riferimento, per i fratelli (perché difficilmente
governabile dallo stesso Beppe Grillo), il M5S, nonostante le insistenti voci -
smentite dal diretto interessato - dell'appartenenza alla massoneria di uno dei
due leader del Movimento, Gianroberto Casaleggio. E così, in attesa che il
potere nuovo di Renzi prenda forma, i massoni vagano alla ricerca di nuovi
interlocutori. "Noi siamo molto attenti ai partiti che vietano ai massoni
l'iscrizione - svela uno dei maestri di grado 33 più influenti della Gran Loggia
d'Italia, Luigi Danesin - è vero che a sinistra, senza tanto clamore, hanno
recentemente tolto l'incompatibilità con l'essere massoni. Di certo, però, i
partiti del centrodestra restano i più amici. Ma i tempi sono cambiati. In
Parlamento non ci appoggiamo tanto a nostri 'fratelli', quanto piuttosto a
deputati o senatori profani 'disponibili'. Con loro, cerchiamo il dialogo".
La battuta di
Andreotti sui presidenti Usa.
Cosa sia stata la massoneria nella storia d'Italia lo spiegava
bene, a modo suo, Andreotti: "Non ho mai capito bene cosa sia - chiosava - ma
quando sono andato in America, ho appreso che solo due presidenti non erano
massoni, Nixon e Kennedy". Nella storia del nostro Paese, ovunque ci sia stato
un intrigo, un mistero, uno scandalo, spesso e volentieri spuntava lo zampino di
qualche fratello. Fa strano perciò che non si sia intravisto neppure un
grembiulino nelle numerose inchieste giudiziarie che hanno scandito le cronache
della fine della Seconda Repubblica, dai rimborsi spese dei consiglieri
regionali al caso "Malagrotta-monnezza a Roma", dall'Ilva di Taranto all'Expo di
Milano, dal Monte dei Paschi di Siena alla Carige di Genova, dal Mose di Venezia
alla vicenda Scajola tra Beirut e Montecarlo. Che i massoni non contino più
niente? O che siano diventati buoni? Pare più probabile, invece, che le
"obbedienze" nostrane abbiano deciso di soprassedere sul fronte interno
(magmatico, in evoluzione, liquido), per dedicarsi alla politica estera, avendo
intuito che il potere politico vero, oggi, è gestito non più a Roma, ma a
Bruxelles. "Attualmente - conferma Luigi Danesin - sono in corso 'lavori'
massonici a livello internazionale per tentare di costituire un Supremo
consiglio europeo. L'obiettivo è istituire un osservatorio permanente al
Consiglio d'Europa, senza diritto di voto o di parola. Ma con la possibilità di
accedere in diretta ai lavori europarlamentari. E di vigilare sugli interessi
della fratellanza europea". Che dopo i francs maçons, stia per nascere sotto le
volte stellate l'euromassone?
La Chiesa e la
scomunica. Ad appena
sei anni dalla fondazione della prima loggia (detta "Degli inglesi") su suolo
italico, a Firenze, nel 1731, la Chiesa cattolica sparò la prima scomunica
contro i massoni. Clemente XII, nella sua lettera apostolica del 24 aprile 1738,
denunciò i "gravissimi danni che tali conventicole" arrecavano "alla salute
spirituale delle anime". Condannò e proibì le "associazioni dei Liberi Muratori
o des Francs Maçons". E ordinò che "gli Inquisitori dell'eretica malvagità
facessero inquisizione contro quei sospetti di eresia". Il primo a farne le
spese fu uno dei fondatori della loggia fiorentina, Tommaso Crudeli: torturato
dal Sant'Uffizio di Firenze, morì per i postumi del carcere. E per questo è
considerato il primo martire della massoneria universale. Ancora oggi, a 283
anni dalla bolla di Clemente XII, la disputa tra fede rivelata (dei cattolici,
che credono nei dogmi) e fede ragionata (dei massoni, che credono in un
principio trascendente senza peraltro specificarlo) arroventa i rapporti tra
massoni e prelati. E la Chiesa non ha cambiato idea. Anzi, ritiene che "il clima
di segretezza" della massoneria comporti per "gli iscritti il rischio di
divenire strumento di strategie ad essi ignote".
La delusione
del 1983. Nel 1983,
con l'approvazione del "nuovo Codice di Diritto Canonico", i massoni sperarono
che la Chiesa avesse tolto quella antica scomunica. Ma si illusero. Fu solo un
equivoco, nulla più. Ecco cosa successe: quel nuovo codice, al canone 1374,
prevedeva la punizione per "chi dà il nome ad una associazione che complotta
contro la Chiesa". Il fatto che non fosse menzionata direttamente la massoneria,
fu interpretato sotto le volte stellate come un'abolizione della scomunica. Ma i
massoni si sbagliarono. Arrivò lo stesso anno una precisazione della Sacra
Congregazione per la Dottrina della Fede (allora presieduta dal cardinal
Ratzinger) a fugare ogni dubbio: il giudizio della Chiesa sulle associazioni
massoniche era rimasto immutato. E, dunque, "l'iscrizione alle Obbedienze
proibita sotto pena di esclusione dai sacramenti". Ma da sempre i massoni,
soprattutto quelli cattolici (la maggioranza, in Italia) tentano di convincere
la Chiesa a ritirare questo anatema. Tentativi di confronto tra fratelli e
monsignori ce ne sono stati, seppure senza grandi risultati.
La comunione
dell'affiliato. Ma
se al vertice scomunicano, a livello periferico sacerdoti e prelati, va detto,
non sempre ubbidiscono agli ordini superiori. E a volte capita che qualche
religioso indossi i paramenti profani della massoneria. I casi di affiliazione
di uomini della Chiesa in loggia sono stati confermati dallo stesso Luigi
Danesin, per sei anni gran maestro della Gran Loggia d'Italia. "Nelle nostre
file - ha confessato - abbiamo qualche sacerdote e qualche prelato. Non molti,
ma ci sono". "Qualche anno fa - ha aggiunto - abbiamo conferito a un sacerdote,
padre Rosario Esposito, il titolo di maestro libero muratore. Un frate, inoltre,
partecipò ai nostri lavori il giorno di Natale indossando sopra il saio le
insegne di maestro. Il mio parroco, infine, sa che sono massone, eppure io mi
accosto alla comunione". Analoga la posizione del Grand'Oriente. "Siamo eretici
nel campo delle idee - ammette il gran maestro Stefano Bisi - in fondo siamo dei
rivoluzionari. Però con la chiesa cattolica i rapporti nel corso degli anni sono
cambiati a livello periferico. L'arciprete di Piombino, ad esempio, tempo fa ad
un convegno si alzò in piedi e, pubblicamente, ci disse: 'Se vi sentite in pace
con la coscienza, se venite in chiesa e volete ricevere la comunione, io non ho
nulla in contrario'". "Il Goi - rivela ancora Bisi - spera oggi in papa
Francesco. S'è dimostrato in certe occasioni come uomo del dubbio, come quando
ha detto 'chi sono io per giudicare un gay?'. È stata una risposta
rivoluzionaria, quella. Ebbene, visto che ha dimostrato questo tipo di apertura,
perché non dialogare anche con la massoneria?".
Ma trame, intrighi e
cospirazioni continuano. Massoneria, trame, intrighi, cospirazioni. La
storia della Repubblica è farcita di gialli nei quali i massoni sono sempre
presenti, quasi a fare da collante tra Stato, mafie, eversione, terrorismo, e
servizi segreti deviati o stranieri. E' il caso, ad esempio, del processo in
corso di dibattimento a Palermo sulla trattativa tra Stato e mafia. Il gup
Piergiorgio Morosini, nel suo decreto che dispone il giudizio contro gli
imputati (tra gli altri i mafiosi Bagarella, Brusca e Riina, il figlio di Vito
Ciancimino, Massimo, l'ex politico di Forza Italia Marcello Dell'Utri, l'ex
ministro dell'Interno Nicola Mancino, l'ex capo dei Ros Mario Mori), ne parla in
modo esplicito.
Trattativa
Stato-mafia e P2. E
non lesina particolari e inquietanti dettagli. Siamo nei primi anni Novanta,
anni della cosiddetta (presunta) trattativa tra Stato e mafia per far cessare
omicidi di personalità politiche della allora Dc, come Salvo Lima, e le stragi
mafiose a colpi di tritolo. "Il primo obiettivo, più ambizioso e di 'lungo
termine' di quell'associazione - annota il gup Morosini nel suo decreto -
consisterebbe nel convergere verso un 'sistema criminale' più ampio capace di
includere in sé altre consorterie di diversa estrazione (massoneria
'deviata'-P2, frange della destra eversiva, gruppi indipendentisti, mafia
calabrese) interessate a sfruttare la crisi politico-istituzionale italiana e ad
acuirla con azioni destabilizzanti ('strategia della tensione') in vista dei
nuovi equilibri". Nonostante il caso P2 sia del 1981, ancora oggi si parla di
quella loggia - e di quelle presunte deviazioni istituzionali - in un processo
tutt'ora in corso sui misteri d'Italia.
Dalle carte
Moro spunta un dossier sul gran maestro di Piazza del Gesù.
Nell'archivio delle carte di Aldo Moro
presso l'Archivio centrale dello Stato di Roma, è conservato un appunto
riservato del Viminale che dimostra due cose. La prima, l'attenzione che lo
statista ucciso dalle Br aveva nel tenere sotto osservazione la massoneria. La
seconda, che il ministero dell'Interno vigilava con estrema attenzione le
obbedienze. Al punto da redigere un documentato dossier nei confronti del più
noto dei gran maestri della massoneria italiana, Giovanni Ghinazzi. Il questore
di Bologna ne fa un ritratto inedito, che noi pubblichiamo integrale, dal quale
emerge una personalità forse poco conosciuta di quello che è stato per anni il
riferimento della massoneria francese al punto che ancora oggi i frateli di
piazza del Gesù vengono soprannominati "ghinazziani". Da allora altre inchieste
hanno coinvolto in qualche modo la massoneria, o i fratelli, al punto da indurre
i magistrati a battezzare le loro inchieste evocando la loggia di Licio Gelli.
Dopo il 2010, ci sono state in particolare le indagini P3 e P4 che hanno in
qualche modo chiamato in causa ancora il ruolo delle "obbedienze". Nella vicenda
P3 erano stati coinvolti anche il parlamentare del Pdl, Denis Verdini e l'ex
senatore Marcello Dell'Utri. Il procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo e il pm
Rodolfo Sabelli ipotizzarono che avevano costituito una "super loggia segreta"
divenuta punto di riferimento di imprenditori e politici per "influenzare
decisioni politiche, a pilotare processi e a decidere le nomine dei componenti
di organi dello Stato di rilievo costituzionale".
Il figlioccio
di Licio Gelli. Il
termine P4 è utilizzato per riferirsi ad una inchiesta giudiziaria su una
presunta associazione a delinquere che avrebbe operato nell'ambito della
pubblica amministrazione e della giustizia. Indagati in tale procedimento
giudiziario furono, tra gli altri, il faccendiere Luigi Bisignani e il deputato
Alfonso Papa (Pdl). La cosiddetta P4 invece avrebbe avuto l'obiettivo di gestire
e manipolare informazioni segrete o coperte da segreto istruttorio, oltre che di
controllare e influenzare l'assegnazione di appalti e nomine, interferendo anche
nelle funzioni di organi costituzionali. L'origine della sigla P4 non fu solo
frutto di immaginazione giornalistica, ma si deve anche al fatto che il nome di
Luigi Bisignani comparisse negli elenchi della loggia Propaganda Due (detta P2)
di Licio Gelli (il quale lo ha recentemente definito "il mio figlioccio"),
benché Bisignani si sia sempre dichiarato estraneo a tale loggia.
"Lobby di potere più
che logge".
Luigi Pruneti,
massonologo ed ex gran maestro della Gran Loggia d'Italia, è dunque lecito
chiedersi: esiste ancora la massoneria deviata tipo la P2?
«Quando
scoppiarono i casi P3 e P4 fu interpellato anche lo studioso Massimo Introvigne,
un curriculum al di sopra del sospetto di essere filomassone. Ebbene, fu proprio
lui a dire che P3 e P4 non c'entravano nulla con la massoneria. Erano
sicuramente lobby di potere più o meno segrete ma non avevano le caratteristiche
minime di base per essere definite massoneria. Se non che uno di quei personaggi
(o più d'uno) erano stati esponenti della P2 o di qualche obbedienza».
Ma cosa ci vuole
allora affinché una lobby segreta sia definibile loggia massonica?
«Perché
si parli oggi di massoneria ci deve essere un minimo di ritualità, di tradizione
massonica, di modo di ritrovarsi massonicamente. Altrimenti anche le 'ndrine
calabresi, che sono società segrete con fini delinquenziali, potrebbero essere
definite logge massoniche».
Ci sono logge
segrete, o deviate?
«Logge
riservate sicuramente sì, ce n'erano diverse prima della P2. Poi, però, dopo la
legge Spadolini-Anselmi, sparirono tutte per paura di incorrere nel reato di
associazione segreta. Gli iscritti segreti, cosiddetti all'orecchio del gran
maestro, o sul fil della spada, sono ancora antecedenti a quel periodo».
Oggi però, fatta la
legge Anselmi, si può aggirare l'ostacolo iscrivendosi ad una loggia all'estero
di una obbedienza italiana, non è così?
«Le
nostre logge all'estero, come quelle di Varsavia, Berlino o Beirut, hanno i loro
piè di lista a Roma. Qualunque magistrato, come peraltro già avvenuto, può avere
gli elenchi».
Ma se un italiano si
iscrive all'estero in una massoneria straniera, che succede: il suo nome figura
in Italia?
«No,
è impossibile saperlo. Questa è l'unica forma possibile di copertura».
"Quelle
deviate restano legate alla mafia".
"Credo che al Sud ci siano talora logge veramente deviate che trovano comodo
chiamarsi massonerie, ma che in realtà nascondono organizzazioni mafiose. Oggi
rimangono aspetti rituali in organizzazioni criminali soprattutto in quelle
cinesi". Massimo Introvigne, sociologo, fondatore del Centro Studi sulle Nuove
Religioni che ha censito 700 religioni in Italia, è un profondo conoscitore del
misterioso mondo dell'esoterismo, dell'occultismo, del satanismo. E dei
collegamenti tra società segrete e organizzazioni criminali.
Quante sono le
massonerie cosiddette di frangia, o spurie?
«Secondo
le nostre stime, tutta l'area esoterica fuori dalla massoneria "ufficiale" conta
15mila affiliati. Di questa area fanno parte ad esempio templari, rosacroce,
illuminati, gnostici, e poi c'è la massoneria egizia di Cagliostro, e quella
dell'antico rito noachita ispirato a Noè. C'è poi anche la gran loggia femminile
d'Italia costituita solo di donne, che gode di riconoscimenti in Francia».
Ma qual è il
rapporto tra obbedienze ufficiali e quelle farlocche?
«Direi
che c'è un contiunuum tra obbedienze massoniche piccole, nate da scismi di
quelle più grandi, e massonerie farlocche che vendono titoli esoterici a
ingenui, e che addirittura coprono organizzazioni mafiose».
Cos'è una loggia
deviata?
«Credo
che nella testa dei nostri giudici la massoneria deviata voglia dire
un'organizzazione massonica che può essere sia all'interno di grandi
organizzazioni, come ad esempio la P2 che fu interna al Grand'Oriente. Sia nei
piccoli e piccolissimi gruppi di persone che utilzzano la comune appartenenza
massonica per commettere reati. In sintesi, per la magistratura la massoneria
deviata è un gruppo di persone che si dicono massoni, a torto o a ragione, e
infrangono le leggi».
C'è un rapporto tra
la P2 e poi la P3, e la P4?
«La
P3 e la P4 sono invenzioni giornalistiche, gruppi di persone (alcune delle quali
affiliate, altre no) costituiti in comitati di affari. E il legame con la
massoneria regolare o non regolare è tenue. Ma non dobbiamo confondere la
massoneria deviata, termine coniato dalla magistratura italiana, con quella che
gli storici chiamano massoneria irregolare».
Cos'è la massoneria
irregolare?
«La
massoneria nacque a Londra. Là c'è quella che viene definita la gran loggia
madre che riconosce le fratellanze nel mondo, definendole regolari sulla base
del rispetto delle Costituzioni di Anderson. Per gli inglesi, ad esempio, in
Italia esiste solo una obbedienza regolare, la gran loggia regolare d'Italia che
conta 3 mila affiliati contro i 20 mila del Goi. Per gli inglesi, le altre, Goi
e Gran Loggia comprese, sono irregolari».
La Chiesa considera
i massoni alla stregua di eretici e gli vieta i sacramenti. Secondo lei papa
Francesco cambierà atteggiamento, come sperano oggi i "fratelli"?
Per
ora le autorità romane mantengono ferme la dichiarazione di condanna del 1983
anche se è stata tolta la parola scomunica per non offendere tanti capi di Stato
massoni. Non credo, però, che con questo Papa ci saranno novità. Bergoglio viene
da una tradizione politica sudamericana peronista che ha sempre visto nella
massoneria la longa manus dei poteri forti statunitensi. Per questo non credo
che ce l'abbia in gran simpatia».
E Caprera
censura il fratello Garibaldi.
Dei suoi quasi 40 anni di vita massonica, non c'è traccia alcuna né nel
"compendio garibaldino", museo nazionale ricavato nella sua dimora privata dove
morì il 2 giugno 1882. Né nel "Memoriale" voluto dalla Presidenza del consiglio
(e inaugurato un anno e mezzo fa) per far rivivere la sua intera esistenza,
dalla nascita a Nizza agli anni che lo videro protagonista delle lotte per la
libertà in Sud America, dal ritorno in Italia per combattere nella prima Guerra
d'Indipendenza alla difesa della Repubblica Romana. "Il ritratto che ne esce
dalla visita del Compendio - spiega lo studioso di Garibaldi Mario Birardi, ex
parlamentare Pci, ex sindaco de la Maddalena - è quello di un soldato un po'
rozzo, un appassionato di agricoltura, un disabile, viste le numerose carrozzine
esposte sulle quali il Generale, colpito in tarda età da una grave forma di
artrosi, si muoveva. Troppo poco, rispetto a quello che è stato". Qui, nella
casa-museo, solo da quest'anno è stata esposta, in un angolo poco visibile del
parco, una corona funebre che la "massoneria sarda" espose ai funerali di Stato.
Ma, da quel che si capisce vista la "reticenza" dei responsabili, s'è trattato
di un piacere ai massoni insulani più che di un omaggio storico al trascorso
massonico del Cavaliere dell'Umanità. Altre due corone funebri dedicate al "suo
Gran Maestro", quella della Massoneria Milanese e quella della Massoneria
Italiana, non sono esposte al pubblico, ma giacciono nascoste nella ex cisterna,
un locale chiuso a chiave. "Oscurato" il passato massonico di Garibaldi anche al
Memoriale, che si trova a qualche chilometro dal Compendio, nei locali del Forte
Arbuticci. Qui il processo, diciamo così, di de-massonificazione del Primo
Massone d'Italia (titolo onorifico che gli fu tributato dalla fratellanza
italiana) salta di più all'occhio in quanto l'estesa esposizione è dedicata
all'intera vita di Garibaldi. Possibile che in una area così vasta non sia stato
dedicato neppure un angolo alla vita di loggia di Garibaldi? Manifestando alla
reception il proprio stupore per questa inaspettata "dimenticanza", si viene
informati dell'esistenza di un solo "documento che richiama la vita massonica
dell'Eroe del Risorgimento". Ma, in mezzo a centinaia di documenti esposti con
tecniche multimediali, è praticamente introvabile. Occorre farsi accompagnare da
un custode per individuarlo, privo di qualsiasi didascalia di spiegazione. Solo
un foglietto con scritto "fondo Mario Birardi". Si tratta di una lettera (che
porta in calce la data del calendario massonico "il 20 del primo mese dell'anno
della Vera Luce 5862"), con la quale i fratelli della loggia Dante Alighieri
della Valle di Torino chiedevano a Garibaldi, in un'ottica di unificazione della
massoneria italiana, di accoglierli nella sua loggia all'Oriente di Palermo
della quale era Gran Maestro. "Trovai quell'eccezionale documento - spiega
Birardi - da un antiquario di Bologna. Lo acquistai, e ora l'ho dato in
comodato d'uso al Memoriale. Mi spiace però che sia stato esposto senza alcun
richiamo. E' come se non ci fosse". Garibaldi acquistò per 35mila lire metà
isola di Caprera (l'altra metà gliela regalarono gli inglesi), costruendo là, in
quella macchia mediterranea spazzata dal vento, il suo quartier generale stile
fazenda sudamericana. Fu uno dei più importanti massoni dell'Ottocento. Si
affiliò tra i "Figli della Vedova" nel 1814, all'età di 37 anni, in America,
nella loggia irregolare "L'asilo della virtù". Si regolarizzò poi il 24 agosto
del 1844 a Montevideo, nell'Obbedienza "Gli amici della Patria", ispirata al
Grand'Oriente di Francia. La vita massonica di Garibaldi è ben tratteggiata in
un recente saggio di Carlo Patrucco ("Documenti su Garibaldi e la Massoneria",
Gherardo Casini editore), che mette a fuoco, documenti alla mano, la
partecipazione a vario titolo delle massonerie ottocentesche alle guerre per
l'indipendenza della Penisola. "Al momento della preparazione dei Mille -
scrive Patrucco - la loggia di Genova ebbe certamente larga parte in favore
della più azzardata delle imprese, e a quella loggia appartenne appunto quel G.
B. Fauché, allora direttore generale della Società di navigazione Raffaele
Rubattino, che, d'accordo con Garibaldi, permise che gli portassero via i due
vapori, destinati alla Sicilia, la notte del 4 maggio 1860". Fu proprio la
Loggia Madre di Palermo a offrire al "Liberatore dell'isola il terzo grado
regolare, salvo più tardi, nel marzo del 1862, il conferimento di tutti i gradi
della gerarchia, compreso il 33esimo, e l'ufficio del Gran Maestro a vita
dell'ordine massonico del Rito scozzese antico e accettato". Da allora
Garibaldi, fino alla morte, divenne il punto di riferimento di tutte le varie
massonerie sparse sulla Penisola, spesso in conflitto una con l'altra. Fu lui a
volere l'unificazione di tutte le logge sotto la volta stellata di un'unica
obbedienza. Ma fallì. E da allora, ancora oggi le massonerie italiane sono
lacerate da continue scissioni, e - a dispetto dei valori di tolleranza che
propugnano - da faide fratricide. Se l'appartenenza di Garibaldi alla
massoneria è più che nota, resta un mistero perché sia stata nascosta nel
Compendio e nel Memoriale a lui dedicato. Forse è ancora oggi in auge la vecchia
formula ottocentesca dell'ex ministro Farini secondo la quale "l'Italia deve
essere stata fatta dagli italiani, e non dalle sette"? (a.c.).
CHI SONO I MAFIOSI?
GUERRA IN PROCURA A TARANTO. PIETRO ARGENTINO E MATTEO DI GIORGIO. PROCURATORI
DELLA REPUBBLICA ACCOMUNATI DALLO STESSO DESTINO?
Trovo molto singolare
che il Procuratore Aggiunto di Taranto Pietro Argentino sarà incriminato di
falsa testimonianza a seguito del processo intentato contro il dott. Matteo Di
Giorgio, scrive Michele Imperio su “Tarastv”. A parte la stima che tutti
riservano per la persona, il dott. Pietro Argentino aveva presentato al CSM
domanda per essere nominato Procuratore Capo proprio della Procura di Potenza e
il CSM tiene congelata questa delicata nomina da diversi anni. L'attuale
Procuratore Capo di Potenza Laura Triassi è solo un facente funzioni e
sicuramente anche lei aspirerà alla carica. Certamente questa denuncia terrà
bloccata per molti anni una eventuale nomina del dott. Pietro Argentino a
Procuratore Capo di una qualsiasi Procura. La sua carriera è stata quindi
stroncata. Laura Triasi è inoltre sorella di Maria Triassi, professoressa
dell'università di Napoli la quale fu incaricata della perizia epidemiologica
nel processo Ilva dal noto Magistrato Patrizia Todisco, la quale è lo stesso
Magistrato che già aveva denunciato alla Procura della Repubblica di Potenza il
collega Giuseppe Tommasino, poi assolto e che aveva invece lei stessa assolto
dal reato di concorso esterno in associazione a delinquere il noto pregiudicato
A. F., mandante - fra l'altro - di un grave attentato dinamitardo a sfondo
poitico, che poteva provocare una strage. Il conflitto Di Giorgio-Loreto lo
conosciamo già. Ma di un altro conflitto che sta dietro questo processo non ha
parlato mai nessuno. Alludiamo al conflitto Di Giorgio-Fitto. Se infatti il
dott. Matteo Di Giorgio fosse stato nominato presidente della provincia di
Taranto sarebbero saltati per aria tanti strani equilibri che stanno molto cari
all'on.le Fitto e non solo a lui. Inoltre trovo molto strano che l'on.le
Raffaele Fitto, il quale fa parte di un partito molto critico nei confronti di
certe iniziative giudiziarie, quanto meno esagerate, non abbia mai detto una
sola parola su questa vicenda, che vedeva peraltro coinvolto un Magistrato
dell'area di centro-destra. Come pure non una sola parola, a parte quelle dopo
l'arresto, è stata mai detta sulla vicenda dall'attuale Procuratore Capo della
Repubblica di Taranto dott. Franco Sebastio. E nel processo sulla malasanità di
Bari compaiono intercettazioni telefoniche fra il dott. Sebastio e il
consigliere regionale dell'area del P.D. ostile al sindaco di Bari Michele
Emiliano, Michele Mazarano nel corso delle quali il dott. Sebastio esprimeva
sfavore per la nomina a Procuratore Aggiunto del dott. Pietro Argentino. Nle
corso di una dichiarazione pubblica il dott. Sebastio espresse invece, in modo
del tutto sorprendente, soddisfazione per l'arresto del dott. Matteo Di Giorgio
e disse che auspicava che anche un secondo Magistrato fosse stato allontanato
dalla Procura della Repubblica di Taranto (Argentino?) Ora - guarda un pò -
anche il dott. Argentino potrebbe essere sospeso dalle funzioni o trasferito di
sede....Notizia dell'ultima ora: il dott. Sebastio e la dott.sa Todisco stanno
litigando fra loro per chi dovrà essere il prossimo candidato del P.D. a sindaco
di Taranto dopo le prossime dimissioni dell'attuale sindaco Ippazio Stefano. Si
sta studiando però una mediazione: Todisco sindaco e Sebastio parlamentare. E
dovere morale di ogni cittadino di Taranto impedire che si verifichi sia una
cosa che l'altra. In quanto entrambe le cose per come si sono maturate FANNO
SCIHFO!!!!!!!!!!!!!!!!!
Voglio raccontare ai
lettori de “La Notte” uno strano caso giudiziario verificatosi qualche giorno fa
presso il Tribunale di Potenza che doveva giudicare un Magistrato di Taranto,
l’ex sostituto Procuratore della Repubblica Matteo Di Giorgio, scrive Michele
Imperio su “La notte on line”. Una storia travagliata quella di Di Giorgio
cominciata nell’ottobre 2010 con la richiesta di un mandato di cattura in
carcere mitigata dal g.i.p. di Potenza in arresti domiciliari eseguito dai
Carabinieri del Comando provinciale di Potenza con accuse infamanti che vanno
dalla concussione alla corruzione all’abuso di ufficio alla minaccia al termine
di un’inchiesta avviata circa due anni prima (2008) e coordinata dalla Procura
della Repubblica di Potenza, competente sui magistrati del Distretto della Corte
di Appello di Taranto. Se tutte le accuse fossero vere c’è da chiedersi dove
stava in quegli anni (2001 – 2008) il suo Procuratore Capo e come mai Di Giorgio
avrebbe subito una strana trasformazione simile a quella descritta nel celebre
romanzo di Robert Louis Stevenson fra Mister Jekill il buono che si tramutava,
grazie all’assunzione di un unguento speciale, nel suo alter ego cattivo mister
Hyde. Ancora alcuni anni fa infatti il giudice Matteo Di Giorgio era ritenuto il
più affidabile sostituto procuratore della Repubblica della Procura della
Repubblica di Taranto tanto da essere insignito della prestigiosa carica di
delegato su Taranto della Procura Distrettuale Antimafia di Lecce. Subì perfino
un attentato alla persona per il suo alacre impegno contro il crimine
organizzato. Poi, del tutto improvvisamente, il cambiamento! Sarà stata
l’aspirazione di candidarsi Presidente della Provincia di Taranto per il
centro-destra, maturata nel 2008 ma – secondo l’accusa – coltivata fin dal 2001
(questa è la data del primo reato per il quale la stessa Procura di Potenza
esclude che abbia preso denaro, mirando egli già da allora cioè dal 2001,
soltanto ai voti, 2001-2008) sarà stato l’antagonismo con il parlamentare del
P.D. del suo paese, Rocco Loreto, fatto sta che da migliore sostituto
procuratore della Repubblica della Procura di Taranto, Di Giorgio si è
trasformato di botto in un incallito concussore e corruttore tanto da essere
arrestato, processato e poi condannato il 30 aprile scorso a ben 15 anni di
reclusione! Quindici anni di reclusione! Avete capito bene! Il Tribunale ha
ritenuto a suo carico tutti i sette capi di imputazione anche quelli annullati
dalla Cassazione, tra cui due concussioni, nemmeno unite dal beneficio della
continuazione (che si da anche ai mafiosi) una in danno di un imprenditore, Di
Battista, il quale sarebbe fallito per causa sua (ma l’imprenditore nega), vari
reati di corruzione e infine anche reati di abuso d’ufficio e di minacce
inseriti in questo castelletto di ben sette capi di imputazioni. Pensate! Sette
capi di imputazione! Però sin poco dopo il mandato di cattura tutti hanno capito
subito che qualcosa non andava in quel processo, perché in sede di giudizio sul
riesame di quei capi di imputazione la Corte di Cassazione ne aveva annullati
ben tre (censure che la Cassazione, in sede di riesame, non muove praticamente
mai!) e il resto della motivazione della Cassazione sembrava un’invocazione
rivolta ai giudici di marito: Non poso entrare nel merito – diceva la Cassazione
– ma siete sicuri che state facendo bene? Tutti i commenti della Rete su questo
caso sono stati estremamente cirtici, quanto meno allarmati. Invece i vari
giornali locali, dopo aver dato la notizia il giorno dopo, non ne hanno parlato
più. Mai sia che si offendesse il nostro equivalente della vacca sacra della
religione Indù: il giudice santificato, che emana sempre condanne e non
somministra mai assoluzioni. Scrive invece sulla Rete – per esempio – il prof.
Mario Guadagnolo, già sindaco di Taranto dal 1985 al 1990: “Premetto che io –
scrive (Guadagnolo) – non conosco il dott. Di Giorgio nè ho alcuna simpatia per
certi magistrati che anzichè amministrare la giustizia la usano per obbiettivi
politici. Ma 15 anni sono troppi se paragonati ai 15 anni di Erika e Omar che
hanno massacrato con sessanta pugnalate la madre e il fratellino di sette anni o
con i 15 anni comminati alla Franzoni che ha massacrato il figlioletto Samuele.
Qui c’è qualcosa che non funziona. Non so cosa ma è certo che c’è qualcosa che
non funziona”. Ma la cosa non finisce qui! Perché al caso, sicuramente clamoroso
del giudice Matteo Di Giorgio, si è aggiunto nello stesso processo un altro caso
altrettanto clamoroso, che riguarda un altro Magistrato della Procura della
Repubblica di Taranto il Procuratore Aggiunto dott. Pietro Argentino. Questi ha
avuto la sventura di essere chiamato come testimone dal dott. Matteo Di Giorgio.
E in base a un dovere civico, abbastanza elementare, si è presentato per
deporre. Ebbene non ci crederete! La sua deposizione insieme a quella di altri
venti testimoni (fra cui cinque eccellenti un vicequestore in forza alla
Questura di Taranto e quattro marescialli!) è stata inviata dal Tribunale di
Potenza ai P.M. di quella Procura affinchè procedano contro il dott. Argentino e
gli altri venti malcapitati per il reato di falsa testimonianza! Pensate! Venti
più uno! L’avv. Giandomenico Caiazza presidente del Comitato Radicale per la
Giustizia “Piero Calamandrei” ha giustamente sottolineato l’assurdità di un
Procuratore Aggiunto (Argentino) che fra pochi giorni dovrà sostenere una
delicatissima requisitoria nel noto processo a carico dei dirigenti dell’Ilva di
Taranto e nello stesso tempo deve apparire al grande pubblico come gravato del
sospetto di una falsa testimonianza che gli proviene da un altro Tribunale della
Repubblica. Ciò che è accaduto al Tribunale di Potenza è quindi, come ben
comprenderete, un fatto di una gravità inaudita e sottintende un conflitto fra
Magistrati per gestioni politiche di casi giudiziari, promozioni e incarichi
apicali, mai arrivato a questi livelli. Voglio fare alcune premesse utili perchè
il lettore capisca che cosa c’è sotto. Sia a Taranto che a Potenza, patria di
Angelo Sanza, sottosegretario ai servizi segreti quando un parte del Sisde
voleva assassinare Giovanni Falcone e un’altra parte del Sisde non era d’accordo
(e lui da che parte stava?), come forse anche in altre città d’Italia, opera da
decenni una centrale dei servizi segreti cosiddetti deviati in realtà
atlantisti, che condiziona anche gli apparati giudiziari e finanche quelli
politici della città. Di sinistra. Così pure altra sede dei servizi segreti
atlantisti questa volta di destra, opera a Brindisi. La sezione di Taranto in
particolare appartiene sicuramente a quell’area politica che Nino Galloni
avrebbe chiamato della Sinistra politica democristiana cioè una delle tre
correenti9 democristiane, in cui si ripartiva la vecchia Sinistra Democristiana
che erano – lo ricordo a me stesso – la Sinistra sociale capeggiata dall’on.le
Carlo Donat Cattin, il cui figlio è stato suicidato-assassinato, la Sinistra
morotea capeggiata dall’on.le Aldo Moro assassinato e poi inutilmente e per
brevissimo tempo riesumata dal Presidente della Regione Sicilia Piersanti
Mattarella anche lui assassinato, la Sinistra politica capeggiata dai vari De
Mita, Mancino, Rognoni, Scalfaro e Prodi, i quali non sono stati mai nemmeno
scalfiti da un petardo. Ebbene quest’ultimo segmento politico della Sinistra
Democristiana nel tempo dapprima ha annichilìto e assorbito la Sinistra Morotea
grazie ai delitti che prima richiamavamo e cioè la strage di via Fani, il
delitto Mattarella, il falso suicidio del figlio dell’on.le Carlo Donat Cattin e
poi ha tentato di egemonizzare tutta la Democrazia Cristiana con le stragi del
1992 e con i noti processi Andreotti e di Tangentopoli. Scalfaro è morto per cui
diciamo pace all’anima sua (che ne ha tanto bisogno;) ma uno dei protagonisti di
quell’epopea il senatore Nicola Mancino oggi risponde di falsa testimonianza nel
noto processo della trattativa perché secondo i valorosi Magistrati di Palermo
nasconderebbe qualcosa ma più di qualcuno pensa che la sua imputazione subirà
nel tempo un aggravio, tecnicamente chiamato contestazione suppletiva. Forse per
strage. Nello schieramento politico italiano hanno sempre operato almeno tre
segmenti ultra atlantisti e quindi alla bisogna stragisti quando qualche altro
segmento politico non si adeguava ai comandi americani. I tre segmenti politici
cavalier serventi erano un piccolo segmento politico interno al Partito
Socialista, un piccolo segmento politico interno al Movimento Sociale poi
divenuto Alleanza Nazionale (in pratica la Destra Neofascista finiana) e infine
un terzo segmento politico costituito dalla cosiddetta Sinistra Politica
Democristiana. Sta di fatto che mentre il segmento atlantista socialista è stato
soppresso, quello finiano si è ridoto all’1%, il segmento politico della
Sinistra Politica Democristiana nel tempo si è espanso sempre di più e adesso
attraverso il renzismo sta cercando di fagocitare anche la vecchia nomenclatura
dell’ex Partito Comunista confluita nel P.D. Ma torniamo a noi e ai giudici
tarantini Pietro Argentino e Matteo Di Giorgio. La cui delegittimazione – per
completezza di informazione – è stata preceduta da un’altra clamorosa
delegittimazione di un altro Giudice dell’area di centro destra il capo dei
g.i.p. del Tribunale di Taranto Giuseppe Tommasino fortunatamente conclusasi con
un’assoluzione e quindi con un nulla di fatto. Potrete trovare maggiori dettagli
su questa vicenda cliccando su Internet “OK Notizie Virgilio Magistrati milanesi
e magistrati di Puglia 7a. puntata. Quindi Tommasino, Di Giorgio, Argentino, a
Taranto dovremmo cominciare a parlare di un vero e proprio stillicidio di
incriminazioni e di delegittimazioni a carico di Magistrati della Procura o del
Tribunale non appartenenti all’area della Sinistra Politica Democristiana o
altra area alleata ovvero all’area della Destra neofascista finiana. L’indagine
a carico del Dott. Matteo Di Giorgio è durata circa due anni ed è stata condotta
da un Maresciallo dei Carabinieri espulso dall’arma e caratterizzata dall’uso di
cimici disseminate in tutti gli uffici del Tribunale di Taranto e della Procura.
E’ capitato personalmente a me di essere invitato dal giudice Giuseppe Di
Sabato, (g.i.p.) un Magistrato che non c’entrava niente con l’inchiesta, di
essere invitato a interloquire con lui al bar del Tribunale anziché nel suo
ufficio perchè anche nel suo ufficio c’erano le cimici di Potenza. Ma c’è di
più! La Sinistra Politica democristiana vuole diventare a Taranto assolutamente
dominante sia in Tribunale che in tutta la città perché corre voce che due
Magistrati uno della Procura l’altro del G.I.P., resi politicamente forti dalla
grande pubblicità e visibilità del processo Ilva, starebbero per passare alla
politica, uno come candidato sindaco l’altro come parlamentare, quando sarà.
Alcuni dicono che io parlo male dei Magistrati. E invece ne parlo bene quando se
ne deve parlare bene. Ne parlo male quando se ne deve parlare male. Il
Procuratore Aggiunto Pietro Argentino è un Magistrato molto valoroso, noto alle
cronache per aver risolto brillantemente molti casi di cui si è occupato tra i
quali quello di Sara Scazzi la ragazzina uccisa per gelosia dalla cugina Sabrina
Misseri, nell’ambito di un delitto cosiddetto familiare. Il delitto familiare è
sempre molto difficile da dipanare per assenza di testimoni diretti (vedi per
esempio i casi di Chiara Poggi e di Yara Gambirasio dove gli inquirenti in
alktre Procure da anni brancolano nel buio o prendono granchi). Ma evidentemente
nella Magistratura italiana il merito ed il valore non contano più. Non ti
assicura nopiù nemmeno un minimo di rispetto e di considerazione. Ciò che conta
è soltanto l’appartenenza politica, in vista di future promozioni, incarichi
apicali, passaggi in politica e vari. Singolare è poi la tempistica della
incriminazione per falsa testimonianza subita dal dott. Pietro Argentino, il
quale dopo essere stato per anni in predicato di diventare Procuratore Capo
proprio della Procura della Repubblica di Potenza, da pochi giorni assegnata ad
altro Magistrato, sicuramente ora sarebbe un temibile concorrente per il
Magistrato a cui la Procura di Taranto è stata già predestinata, un o di destra,
posto che il dott. Franco Sebastio attuale Procuratore Capo della Repubblica di
Taranto fra poco meno di un anno, dovrà lasciare l’incarico per raggiunti limiti
di età. Anche sulla Procura di Potenza quindi aleggia il dubbio che, per lo meno
per il periodo in cui non è stata diretta dal dott. Giovanni Colangelo,
Magistrato eccellentissimo, ora Procuratore Capo della Repubblica di Napoli, sia
e sia stata politicamente orientata. Su questo ci potrei scrivere pure un libro.
La Sinistra politica democristiana pugliese quindi, supportata da altri
organismi giudiziari, tende ormai a espellere da tutto il terriotrio della
Puglia sia gli esponenti politici che i Magistrati, eventualmente anche di
Sinistra, che non sono congeniali al suo progetto politico o che comunque ne
possano impedire la piena attuazione. E’ ormai fatto acclarato che per
conseguire l’obiettivo ormai certa Magistratura non incrimina più e non condanna
più il soggetto mirato in base alla sussistenza di una responsabilità penale
bensì lo incrimina e eventualmente lo condanna in base alla convenienza politica
del momento. Lo strumento maggiormente adoperato per spingere il pollice verso è
la cosiddetta concussione presunta. Cioè io giudice presumo dalle
intercettazioni, dalle mie deduzioni dalle mie elucubrazioni mentali che tu
imputato abbia concusso qualcuno e quindi ti imputo di concussione. Il Tribunale
sulle stesse basi ti condanna anche se la parte asseritamente concussa nega che
vi sia stata mai una concussione. E così per tornare ai casi concreti della
Puglia l’imprenditore Di Battista nel processo Di Giorgio sarebbe stato concusso
– secondo i giudici di Potenza – dal Magistrato Mateo Di Giorgio, il Di Battista
nega di essere mai stato concusso ma Di Giorgio viene ugualmente condannato, il
prof. Giorgio Assennato nel processo Ilva di Taranto sarebbe stato concusso dal
governatore della Puglia Niky Vendola, il prof. Giorgio Assennato nega di essere
mai stato concusso, Niky Vendola viene ugualmente rinviato a giudizio, il
funzionare della provincia di Taranto dott. Luigi Romandini sarebbe stato
concusso dall’ex presidente della provincia di Taranto dott. Gianni Florido
(arrestato per questo motivo), il dott. Luigi Romandini nega di essere mai stato
concusso, Gianni Florido viene ugualmente rinviato a giudizio per concussione.
Cioè la concussione viene utilizzata come strumento per l’eliminazione dell’uomo
politico o del Magistrato scomodo da maciullare. Quando poi qualcuno depone come
tetimone in senso contrario al teorema e quindi potrebbe minare – come si dice
in gergo – l’impianto accusatorio, allora scatta un secondo strumento
distruttivo, la falsa testimonianza anch’essa trasformata in mezzo
politico-giudiziario per conseguire l’obiettivo politico di eliminazione
del’avversario politico. E’ quindi con questo strumento,ossia con la falsa
testimonianza che è stato colpito a affondato come fosse una pedina del gioco
della battaglia navale, il Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica
di Taranto, Pietro Argentino, incauto teste a discarico del dott. Matteo Di
Giorgio. Ma chi è causa del suo mal pianga se stesso Ma come! Non lo sapevano il
dott. Pietro Argentino e gli altri 24 testimoni che il destinatario della loro
testimonianza Matteo Di Giorgio era stato investito da una specie di fatwa da
parte del Tribunale di Potenza e da parte della Sinistra politica democristiana?
Cristo – cari amici – si è fermato a Eboli e questo lo sapevamo. Ma siamo sicuri
che Komeini non stia salendo dalla Sicilia?
Come volevasi
dimostrare nessuno dei giornali italiani nazionali o locali ha più parlato dopo
il primo maggio dei quindici anni di galera inflitti al Magistrato di Taranto
Matteo Di Giorgio e dell’incriminazione per falsa testimonianza inflitta al
Procuratore Aggiunto di Taranto Pietro Argentino, continua Michele Imperio. Ma
“La Notte” no. “La Notte” non ci sta a questa non informazione o a questa
disinformazione. Quando assunsi la direzione di questo glorioso giornale, che
ora sta per riuscire nella sua versione cartacea, dissi che avremmo sempre
raccontato ai nostri lettori tutta la verità, solo la verità, null’altro che la
verità e avremmo quindi sfidato tutte le distorsioni giornalistiche altrui,
tutti i silenzi stampa tutti i veti incrociati dei segmenti peggiori del potere
politico. “Non si può investire della cultura del sospetto tutto e tutti. Perché
la cultura del sospetto non è l’anticamera della verità. La cultura del sospetto
è l’anticamera del komeinismo”. Questo diceva Giovanni Falcone, esasperato,
quando altri colleghi e altri uomini politici (segnatamente Libero Mancuso e
Leoluca Orlando Cascio, ormai è passato tantissimo tempo e dunque possiamo fare
anche i nomi) lo volevano coinvolgere nell’accusa di mafia contro il senatore
Giulio Andreotti. E Giovanni Falcone con quel suo inattaccabile senso del dovere
e del giusto, rispose smontando il falso pentito Pellegriti, che Leoluca Orlando
(politico) e Libero Mancuso (Magistrato) gli avevano propinato e smontò quindi
le sue false accuse contro Salvo Lima (andreottiano) accusato di essere il
mandante occulto dell’omicidio Dalla Chiesa. Non solo! Ma per ulteriore sfregio
dei komeinisti Giovanni Falcone si fece nominare direttore degli affari generali
penali del Ministero di Grazia e Giustizia nell’ultimo governo Andreotti. Si sa
come finì. I komeinisti gli fecero pagare con la vita questo affronto. Però
quello era ancora un komeinismo spietato ma romantico. Perchè quel komeinismo
giudiziario era ispirato da convinzioni ideologiche determinate dai pennivendoli
di “Repubblica” i quali avevano riempito la testa a tutti noi (chissà per quali
recondite ragioni) che Giulio Andreotti e tutti gli andreottiani erano collusi
con Cosa Nostra, convinzioni però poi rientrate. Lo ricordo ancora Leoluca
Orlando Cascio che tuonava in tutti i teatri d’Italia: “Andreotti non è
semplicemente connivente con la mafia! Andreotti è egli stesso mafioso! Lui ha
fatto assassinare Piersanti Mattarela” (l’amico suo) Adesso – dicono – Leoluca
Orlando Cascio non si parla più con Antonio Di Pietro. E le ragioni sono
evidenti. Lo ricordo ancora il komeinista Luciano Violante, grande ispiratore e
suggeritore del processo Andreotti. Al termine del processo lo stesso Luciano
Violante ammise: “E’ vero: il suggeritore sono stato io! Ma se tornassi indietro
nel tempo non lo rifarei più!” Oggi Luciano Violante potrebbe anche essere un
buon presidente della repubblica. Ma nessuno lo candida e i nuovi komeinisti lo
snobbano. Lo ricordo ancora Giancarlo Caselli Procuratore di Palermo dopo che
ignoti gli ammazzarono sotto il naso nella stanza del piano di sopra Luigi
Lombardini, il Magistrato sardo che la cultura komeinista del sospetto indicava
essere il regista di tutti i sequestri di persona in Sardegna. Mentre invece la
verità era che altri Magistrati (non lui, anzi lui li voleva denunciare) vi
avevano lucrato. Nella vicenda Lombardini – disse uno sconsolato Giancarlo
Caselli – sono stato strumentalizzato. Ma da chi e per che cosa? Ma oggi il
komeinismo ideologico-giudiziario dei Caselli dei Violante dei Mancuso, degli
Orlando-Cascio non c’è più, è stato sostituito da un altro komeinismo
giudiziario tutto proteso a costruire e a distruggere carriere di magistrati e
di uomini politici, secondo l’andazzo momentaneo della giostra. Ma voglio
tornare al caso specifico dei magistrati tarantini Matteo Di Giorgio e Pietro
Argentino. Se il dott. Matteo Di Giorgio Magistrato della Procura della
Repubblica di Taranto il quale risiede in un piccolo paese della provincia di
Taranto, Castellaneta, di sole 17.000 anime (dove quindi tutti si conoscono con
tutti) si attiva presso l’amministrazione Comunale perché un poveraccio, suo
conoscente, possa gestire un bar pur non disponendo della relativa licenza, ecco
che questo è chiaramente un gesto di umanità di Di Giorgio nei confornti del
viandante con contenuti – diciamolo pure – non proprio legittimi. Ma è pur
sempre un gesto di umanità e quindi non è un reato. Senonchè che ti fa la
cultura del sospetto? Ti fa pensare che il Magistrato Matteo Di Giorgio nutre
già dal 2001 una grande passione politica e che quindi compia quel gesto non per
un senso di umanità ma per sperare nel futuro voto del viandante e quindi per
costituirsi già da allora (2001) una clientela politica, uno zoccolo duro di
consensi per conseguire e rendere vincente nel 2009 la sua candidatura alla
presidenza della provincia di Taranto. Ecco un caso in cui la cultura del
sospetto applicata al diritto trasforma un fatto giuridicamente irrilevante in
una possibile condotta delittuosa (abuso innominato in atti di ufficio ove il
vantaggio patrimoniale richiesto dalla norma viene – con astrazioni metafisiche
– equiparato al vantaggio politico che si trae dal voto del viandante). Questo è
un caso. Ma esaminiamone anche un altro. Se il dott. Matteo Di Giorgio
Magistrato della Procura della Repubblica di Taranto il quale – lo ripetiamo –
risiede in un piccolo paese della provincia di Taranto Castellaneta di sole
17.000 anime (dove quindi tutti si conoscono con tutti) scopre in un suo
processo a lui assegnato che il genero di un altolocato del paese spaccia droga
in discoteca e quindi sta per andare incontro a otto anni di galera, mosso da
senso di pietà e questa volta anche da quel senso tutto paesano di rispetto
della reciproca conoscenza, ne copre la responsabilità ma tuttavia chiede
all’altolocato per decenza di dimettersi quanto meno dal consiglio comunale di
cui è membro, tutto questo chiaramente viene fatto per pietà, per solidarietà
paesana, per rispetto, per reciproca conoscenza, per quello che volete voi. Ma
anche qui interviene la cultura komeinista del sospetto che fa insinuare che in
realtà Matteo Di Giorgio approfitti della situazione per puntare con quelle
dimissioni a indebolire la maggioranza e quindi a far cadere il piccolo
consiglio comunale di Castellaneta per far si che la sua parte politica prenda
il sopravvento e quindi lo supporti da posizioni di forza nella sua successiva
ascesa al potere (dopo alcuni anni) alla presidenza della provincia di Taranto.
Già, ma a parte il fatto che quindici anni di galera per queste cose fanno
ridere, il problema è: dov’è la prova di questi retropensieri del dott. Matteo
Di Giorgio? Quale norma equipara la speranza anche minima di un vantaggio
politico al vantaggio patrimoniale? Il sospetto se volete ci può anche stare ma
la prova, intendo dire la prova in senso tecnico, l’elemento che appaga la
coscienza del Magistrato che deve affermare una responsabilità penale e che
quindi deve sentenziare la distruzione di un uomo, quella prova – dico – dove
sta? Volete voi lettori la riprova che sia così? Queste sette denunce a carico
del dott. Matteo Di Giorgio, che sarebbero state redatte su ispirazione di un
uomo politico suo antagonista, il senatore Rocco Loreto, sono state diversamente
valutate nel tempo venendo considerate in certi periodi storici del tutto
irrilevanti (perché parliamo del 2001 mica di ieri), in altri periodi storici
accuse addirittura calunniose in altri periodi storici ancora accuse riferite a
fatti di reato gravissimi punibili con una pena al carcere di quindici anni e
passa di reclusione. Che il dott. Matteo De Giorgio abbia manifestato nel 2009
una forte propensione a candidarsi presidente della provincia di Taranto questo
è vero, che l’inchiesta sia partita anzi ripartita in funzione di questa
candidatura questo pure è vero, che Di Giorgio abbia mai concusso qualcuno o
abbia mai strumentalizzato la funzione giudiziaria questo è falso. E’
completamente falso! O meglio è il frutto della cultura del sospetto su qualcosa
che non è provato. Inoltre la cultura giudiziaria del sospetto ha completamente
mutato nel tempo i contenuti del reato più grave fra quelli contestati a Di
Giorgio, ossia la concussione. Una volta per aversi la concussione il pubblico
ufficiale doveva terrorizzare il concusso fino al punto che quello, compulsato
dal pubblico ufficiale violento e malfattore si faceva piccolo piccolo e, ob
torto collo, cedeva alle sue perverse pressioni intimorito dal cosiddetto metus
pubblicae potestatis ossia dal terrore che quello gli incuteva. Oggi invece
basta un “ti cambio di posto” che la concussione è bella che consumata. Conosco
personalmente sia il dott. Matteo Di Giorgio che il dott. Pietro Argentino e
posso dire che sono due ottimi Magistrati, grandi lavoratori, buoni
investigatori, discreti oratori ma soprattutto sono due Magistrati indipendenti,
non agganciati ad alcun segmento del Potere Politico. Argentino aveva un lontano
parente parlamentare di Forza Italia che è morto, Di Giorgio nemmeno quello. Ma
proprio qui sta il problema: proprio perché questi soggetti sono personaggi
valorosi Di Giorgio sicuramente avrebbe fatto una brillante carriera politica,
Argentino sarebbe avanzato ulteriormente in Magistratura: da Procuratore
Aggiunto sarebbe diventato Procuratore Capo. Ma allora che ne sarebbe stato
delle carriere che il Potere Politico aveva già riservato ai predestinati, gente
mediocre e di mala fede? Infatti l’incriminazione per falsa testimonianza di
Argentino cade giusto pochi giorno dopo l’assegnazione a un altro Magistrato
della carica di Procuratore Capo della Repubblica di Potenza, incarico per il
quale anche il dott. Argentino aveva fatto domanda al CSM. Quindi a questo punto
non rimane ad Argentino che ripiegare sulla carica di Procuratore Capo della
Repubblica di Taranto, da affidarsi fra breve e per la quale certamente
Argentino è il Magistrato che ha più titoli. Ma qui parliamo di Taranto! Cioè di
un letamaio istituzionale! Dove i problemi non sono certamente il bar aperto
senza licenza o le false testimonianze di Argentino o le inesistenti concussioni
di Di Giorgio. Un letamaio che invece deve essere gestito da chi necessariamente
ha la capacità e la volontà di adeguarsi al letamaio. Ma per spiegarvi tutto
questo mi serve un altro capitolo.
Dopo tanti anni di
attività professionale ho ormai maturato la convinzione che due segmenti
politici dello intero schieramento politico nazionale e precisamente la destra
neofascista oggi di Mario Monti e di Gianfranco Fini ma ieri anche di altri
soggetti politici e la Sinistra politica democristiana, da non confondersi con
la Sinistra sociale democristiana (Cisl e vecchia corrente di Forze Nuove) e
nemmeno con la sinistra morotea democristiana (Aldo Moro e Piersanti Mattarella
ieri, Dario Franceschini e Giuseppe Gargani oggi) che erano e sono un’altra
cosa, la Sinistra politica democristiana – dicevo – (Prodi Romano, Scalfaro
Oscar Luigi, Mancino Nicola e De Mita Ciriaco ieri Renzi Matteo oggi e il loro
regista di sempre De Benedetti Carlo, questi due segmenti politici – dicevo –
non svolgono semplicemente un’attività politica ma esercitano anche una funzione
di intelligence di tipo deviato, continua Michele Imperio. Forse dispiacerò
qualcuno ma voglio ricordare a me stesso che in seguito alle indagini sulla
strage di Peteano il terrorista neofascista Vincenzo Vinciguerra - reo confesso
per la strage – rivelò che nell’ormai lontano 1982 il segretario del MSI di
allora Giorgio Almirante aveva fatto pervenire la somma di 35.000 dollari a tal
Carlo Cicuttini, dirigente del MSI friulano e coautore della strage, affinché
egli modificasse la sua voce durante la sua latitanza in Spagna mediante un
apposito intervento alle corde vocali. Tale intervento si rendeva necessario
perché Cicuttini, oltre ad aver collocato materialmente la bomba assieme a
Vinciguerra, si era reso autore della telefonata che aveva attirato in trappola
i poveri carabinieri, poi trucidati. La sua voce era stata identificata mediante
successivo confronto con la registrazione di un comizio del MSI da lui tenuto.
Che cosa avevano scoperto quei poveri carabinieri se è vero come è vero che nel
giugno del 1986, a seguito dell’emersione di documenti che provavano il
passaggio del denaro tramite una banca di Lugano, il Banco di Bilbao ed il Banco
Atlantico, Giorgio Almirante e l’avvocato goriziano Eno Pascoli vennero rinviati
a giudizio per il reato di favoreggiamento aggravato verso i due terroristi
neofascisti? Ed è emblematico anche come andò la cosa. Enzo Pascoli venne
condannato; Giorgio Almirante invece, dopo un’iniziale condanna, si fece più
volte scudo dell’immunità parlamentare, all’epoca ancora riconosciuta a deputati
e senatori, si sottrasse perfino agli interrogatori e infine si avvalse di
un’amnistia grazie alla quale uscì definitivamente dal processo. nonostante la
legge ne prevedesse la rinunciabilità. Cicuttini, dirigente del MSI friulano –
mai disconosciuto da Giorgio Almirante ripeto – fuggito in Spagna, venne
catturato a ventisei anni dalla strage, nell’aprile del 1998, quando fu vittima
egli stesso di una trappola: la procura di Venezia gli fece offrire un lavoro a
Tolosa dove, recatosi convinto di intraprendere le trattative contrattuali,
venne arrestato dalla polizia ed estradato dalla Francia. Questi agenti deviati
neofascisti ci sono ancora, probabilmente essi si riconoscono ora nella corrente
politica di Mario Monti (che non a caso fa la guerra al partito di Gianni
Alemanno, Giorgia Meloni, La Russa, Giorgio Crosetto, Adriana Poli Bortone) e
sono infiltrati ovunque, nella classe politica, nei Servizi, nella Polizia, nei
Carabinieri, Ovunque. Ma sono infiltrati anche e sopratutto in alcuni segmenti
della Magistratura associata (Magistratura indipendente). Analogamente avviene
per la Sinistra Politica Democristiana. Ricordo anche qui che quando nel 1978 la
polizia stava per scoprire la prigione di Aldo Moro in via Gradoli sulla Cassia
a Roma, il giovane Romano Prodi si presentò personalmente alla Polizia di Roma
per depistare quelle indagini e spostare le stesse da via Gradoli in Roma in
Gradoli città dell’Abruzzo, e ciò perché Aldo Moro non fosse salvato ma fosse
assassinato. Dopo che qualcuno (Riccardo Misasi Sinistra D.C.?) aveva mobilitato
quindici picciotti della 'nrdina calabrese dei Nirta inducendoli a portarsi il
16 maggio 1978 in via Fani il giorno del rapimento Moro pronti ad intervenire
nel caso le cose non si fossero messe nel verso giusto degli stragisti. La
storia di Vittorio Mangano stalliere di Silvio Berlusconi (finanza laica) negli
anni 70 non viene mai raccontata mai nella sua completezza. Prima del’assunzione
di Mangano come stalliere Silvio Berlusconi fece tenere negli uffici della
Edilnord una riunione cui parteciparono dopo essere appositamente venuti da
Palermo, Stefano Bontade e Mimmo Teresi, all’epoca numeri 1 e n. 2 di Cosa
Nostra Siciliana. Costoro decisero di ingaggiare il Mangano per dare un segnale
alla Ndrangheta calabrese allora eterodiretta da soggetti della Sinistra poltica
democristiana (Nicola Mancino, Riccardo Misasi e company.?) affinchè si
comprendesse che Berlusconi fosse sotto la protezione di Cosa Nostra e quindi
che i figli di Berlusconi (finanza laica) non potevano essere rapiti e
sequestrati. Questo particolare però non viene mai rimarcato. Perché? Perchè
altrimenti si porrebbe in modo naturale il quesito: Perché mai analoghe
attenzioni non furono mai rivolte dalla Ndrangheta nei confronti dei figli di
Carlo De Benedetti o dei figli o dei nipoti di Giovanni Agnelli (finanza ebrea e
finanza cattolica?) Magistrati e politici dell’uno e del’altro segmento politico
(Destra neofascista e Sinistra politica democristiana) hanno sempre provveduto a
clamorose coperture e depistaggi. Ma per farlo essi devono poter accelerare le
proprie carriere. E come accelerare le carriere di questi? Stroncando le
carriere dei loro rivali! Così come certamente è stata accelerata la carriera di
Marco Dinapoli, Magistratura Indipendente, attuale Procuratore Capo della
Repubblica di Brindisi. Chi di noi non si è sentito inorridito dai rapporti di
amorosi sensi emersi dalle indagini fra questo Procuratore della Repubblica di
Brindisi e il terrorista neofascista autore dell’odiosa strage di Brindisi
Giovanni Vantaggiato rapporti di amorosi sensi intesi a far si che Vantaggiato
non fosse imputato dell’aggravante del gesto a scopo terroristico e si
scappottasse quindi la pena dell’ergastolo? Procura della Repubblica di Potenza
e CSM si erano già messi meritoriamente all’opera quando anche i lampioni hanno
compreso che un alto vertice istituzionale (probabilmente proprio il Presidente
della Repubblica) ha bloccato tutto. Ebbene quell’attentato è servito. E’
servito a mandare un messaggio ad alcuni valorosi Magistrati per cui chiunque si
fosse avvicinato troppo alla vera verità sulla strage di Capaci (simboleggiata
dalla scuola brindisina Falcone e Morvillo) era un uomo morto. E proprio in quei
giorni il valoroso Procuratore Capo della Repubblica di Caltanisetta stava
scoprendo interessanti novità in ordine alla strage di Capaci. Dalle indagini
stavano infatti emergendo responsabilità di altri soggetti neofascisti che
avevano materialmente partecipato alla strage e il cui nominativo non era mai
emerso prima di allora nelle indagini stesse. Ebbene anche il valoroso
Procuratore di Caltanisetta Sergio Lari si è fermato e di quelle indagini non si
ha più notizia. Questo caso dimostra che cellule stragiste e criminali sia della
Destra neofascista diciamo così finiana e montiana che anche della Sinistra
Politica Democristiana (oggi renziana) sono presenti anche all’intero della
Magistratura e anzi i Magistrati che vi aderiscono godono di carriere
accelerate. Il caso Di Giorgio (il Magistrato di Taranto condannato a quindici
anni di reclusione) (ma da chiamarsi ora il caso Argentino-Di Giorgio) è stato
finora prospettato come una sorta di lunghissimo qui pro quo fra un Magistrato
della città di Castellaneta (piccolo paese in provincia di Taranto) e un
parlamentare della stessa cittadina pugliese, il senatore del P.D. Rocco Loreto
(nella foto), mentre invece questo caso trascende e di molto questo singolo
aspetto del problema, perché esso è conseguenza del fatto che nella provincia di
Taranto opera da moltissimo tempo una cellula stragista e criminale
istituzionale della Sinistra politica democristiana con presenze attiva ancora
oggi anche all’interno delle Istituzioni e segnatamente nella Magistratura e il
caso Di Giorgio-Argentino è un singolo capitolo di una guerra in corso fra
Magistratura laica e Magistratura cattolica, analogo al conflitto in essere, da
sempre, fra finanza laica e finanza cattolica, se volete anche fra criminalità
laica e criminalità cattolica (laddove il termine cattolico è adoperato
ovviamente in senso lato, molto lato), delle cui prove dirò fra poco.
“Il sospetto non è
l’anticamera della verità, il sospetto è l’anticamera del khomeinismo”. Così
diceva Giovanni Falcone, davanti al CSM che l’accusava. Ma che cosa aveva voluto
dire con quella espressione Giovanni Falcone? Si chiede e continua Michele
Imperio. Quando nel 1978 la rivolta popolare in Iran era ormai esplosa contro lo
scia Reza Pahlavi, costringendolo a fuggire dal paese, l’ayatollah, Khomeyni,
tornato dall’esilio in Iran il 1º febbraio 1979, instaurava nel paese una sorta
di dittatura teocratica il komeinismo appunto ossia una “repubblica islamica”,
basta sulla persecuzione dell’avversario politico e sul terrore. Il komeinismo
dette vita a una durissima repressione contro i collaboratori del deposto scià:
migliaia di essi furono arrestati e fucilati dopo processi sommari; altri furono
mandati in esilio o imprigionati e i rimanenti fuggirono dal paese. In pochi
mesi si considera siano state fucilate circa 5.000 persone e mandate in esilio
altre 10.000. Dunque Giovanni Falcone accusava esplicitamente alcuni suoi
colleghi Magistrati di voler strumentalizzare la funzione giudiziaria per
instaurare un nuovo regime politico simile a quello dell’ayatollah Komeyni. Mi
chiedo: Questo disegno politico sta ora subendo un’accelerazione? I magistrati
tarantini Pietro Argentino e Matteo Di Giorgio fanno parte di
un’epurazione da parte di loro colleghi simile a quella che ci è stata in Iran?
Un fatto è certo: il nuovo strumento della falsa testimonianza di massa non è
stato adoperato solo a Potenza nel corso del processo Di Giorgio ma anche a
Trapani dal Tribunale che ha giudicato il caso Rostagno e che ha mandato sotto
processo per falsa testimonianza dieci testimoni che lì avevano deposto. Il
testimone che non corrobora la tesi dell’accusa è incriminato. Ma il Tribunale
di Trapani ci teneva a far sapere a noi italiani la verità su quel delitto?
Perché Mauro Rostagno il quale era di Torino si trovava a Trapani? Chi ce lo
aveva mandato? E per fare che cosa? Mauro Rostagno aveva a che fare o no con
l’omicidio del commissario Luigi Calabresi? Era stato incriminato per questo
motivo oppure no? Voleva per caso uscirsene dal caso Calabresi ricattando lo
Stato e denunciando i traffici d’armi internazionali che avvenivano tramite
l’aeroporto in disuso di Trapani, di cui lui era uno dei custodi? Perché il suo
socio coofondatore della comunità per il recupero dei tossicodipendenti Saman
Francesco Cardella è vissuto per lungo tempo a Managua in Nicaragua, protetto
dai nostri Servizi Segreti? Chi gli ha fatto avere l’incarico di ambasciatore di
alcuni paesi arabi in Nicaragua? Come faceva Cardella a possedere addirittura un
aereo personale gestendo semplicemente e a distanza una serie di comunità per
tossicodipendenti? Perché all’inizio degli anni ’90, si erano allungati su
Cardella i sospetti che potesse c’entrare con l’omicidio di Mauro Rostagno? Come
mai Fausto Cardella è stato testimone di nozze di quel Claudio Martelli, suocero
del n. 2 del Sisde Michele Finocchi gran gestore di traffici d’armi colossali
che costarono la vita a Giovanni Falcone, giacchè siamo in tema e in date di
anniversari di stragi di stato (23 maggio)? Ed allora domandiamo: Rispondono a
questi interrogativi i magistrati siciliani che hanno giudicato il caso
Rostagno? Ma assolutamente no! Loro concentrano la attenzione solo sugli
esecutori materiali del delitto: Cosa Nostra, quasi in una sorta di ritorsione
per aver rivelato Cosa Nostra i depistaggi sulle stragi dei vari Tinebra la
Barbera Bo Ricciardi e quindi Vincenzo Parisi, il lacchè di Scalfaro e di
Mancino, Michele Finocchi, il suocero di Claudio Martelli e di chi c’era dietro
di loro. E spediscono dieci testimoni (dicasi dieci) sotto processo per falsa
testimonianza! Come a Potenza! Tale e quale! E allora questa falsa testimonianza
di massa è la nuova frontiera del komeynismo giudiziario? Ed è un caso che essa
coinvolga a Potenza non già Ciccio Lapizza ma Il Procuratore Aggiunto di Taranto
Pietro Argentino, Magistrato ripudiato dal regime per aver prestato la sua
testimonianza all’appestato Matteo Di Giorgio? Ormai non v’è più un Magistrato
nell’Italia Meridionale che non cerca di distinguersi per usare le sentenze come
le scimitarre, per incriminare decine di testimoni, per mandare il messaggio
alla gente che sono tutti delinquenti tutti mafiosi, tutti falsi testimoni
quelli che la pensano diversamente da Matteo Renzi, tranne loro i magistrati i
soli a essere buoni bravi e belli in questo paese di corrotti e di uomini del
malaffare. Ma le cose stanno proprio così? Le presunte false testimonianze di
Argentino o i bar aperti senza licenza di Di Giorgio sono i veri casi scandalosi
di una Magistratura tarantina per il resto illibata e integerrima? Un Magistrato
che è stato per lungo tempo presidente di collegio nel Tribunale di Taranto mi
raccontava questo episodio capitatogli una decina di anni fa. Un giorno si
presenta a lui il caso di un pluripregiudicato tarantino trasferitosi nel
casertano, gravato da quattro pagine di precedenti penali (comprensive di quasi
tutti i reati), il quale aveva ricettato assegni per l’importo di 700 milioni
delle vecchie lire provenienti da varie rapine e furti a Roma come nel casertano
e colto con le mani nel sacco (cioè con i soldi in tasca) al valico di
Ventimiglia. Ebbene si presentano a questo presidente del collegio l’avvocato
difensore del ricettatore e il sostituto procuratore d d’udienza. Entrambi
chiedono per questo pluripregiudicato il minimo della pena con tutti i benefici
compresa la sospensione della pena e la diminuzione della pena stessa per il
patteggiamento. Il presidente del collegio allora li prende tutti e due
(avvocato e sostituto procuratore) e li sbatte fuori dalla sua stanza a mali
parole. Qualche giorno dopo il presidente del collegio incontra il sostituto
procuratore e questi gli fa: “Adesso sono cazzi tuoi! Ti sei messo contro il
Procuratore! Il Procuratore ci teneva a quella persona!” Il Procuratore in
questione si chiamava Giovanni Massagli (Sinistra politica democristiana grande
amico di Nicola Mancino) deceduto qualche mese fa. Personaggio controverso
questo Massagli, secondo alcuni un sant’uomo, secondo altri un demone, autore di
un libro sui simboli della Massoneria (che c’entrava lui con la Massoneria?),
noto persecutore di nemici politici, depistatore nel 1991 di una strage
importante, la strage della barberia (1° ottobre 1991) nel corso della quale fu
ucciso (non casualmente come fu detto) tal Giuseppe Ierone, un parente di alcuni
agenti segreti belgi coinvolti nel grande traffico d’armi internazionale e
nell’omicidio di un ex ministro belga. Il pluripregiudicato cui il Procuratore
ci teneva si chiamava invece A. F., esponente del del clan casertano dei
Piccolo-Quaqquaroni, ex assessore dc a Taranto, arrestato per associazione
mafiosa e accusato di reati gravissimi. A. F. avrebbe non solo truccato appalti,
ma sarebbe stato anche il mandante dell’attentato dinamitardo del ‘ 92 contro la
televisione locale «AT6». Secondo il rapporto redatto alla fine degli anni 80
dall’alto comissario anti-mafia Domenico Sica, A. F., terzo degli eletti nella
lista D.C. del Consiglio Comunale di Taranto, era diventato componente della
Commissione elettorale del comune di Taranto e punto di riferimento per un
gruppo, all’interno della Sinistra Politica democristiana, i cui esponenti
ricoprivano incarichi di rilievo. Dalla relazione Antimafia del 1991 risultava
che uno di questi tal Alessio Magistro, era stato denunciato dalla locale
sezione del Coreco all’autorità giudiziaria, in quanto avrebbe falsamente
attestato di non avere mai avuto precedenti penali, al fine di conseguire la
nomina a Presidente della azienda dei rifiuti di Taranto”. Il 3 aprile 1994 A.
F. veniva fermato dalla Guardia di Finanza al valico autostradale di Ventimiglia
e accusato di esportazione di valuta: in realtà era riciclaggio ma quel reato
allora ancora non esisteva. F. aveva con se ben 700 milioni di vecchie lire tra
contanti ed assegni. Alcuni di quei titoli erano assegni circolari della Banca
Nazionale del Lavoro per un ammontare di 135 milioni di lire, che erano stati
indebitamente sottratti all’INPS di Roma, altri erano assegni circolari
dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, rapinati il 4 novembre
1987 a un furgone portavalori sull’autostrada Caserta – Salerno, per un valore
di 305 milioni. Camorra pura quindi! E servizi segreti deviati! Infatti
arrestato A. F.veniva stranamente subito rilasciato. Il fatto più eclatante che
lo riguardava si verificava però nel 1998. Il 2 settembre di quell’anno vengono
assassinati a Brescia due uomini a lui molto vicini originari di Taranto, che
però F. aveva trasferito nel casertano, il già nominato Alessio Magistro e
l’avvocato Stefano Punzi. Per volontà di A. F., Alessio Magistro era stato
alcuni anni prima presidente dell’Azienda municipalizzata dei rifiuti di Taranto
e Stefano Punzi era un avvocato che aveva chiuso il suo studio legale a Taranto
per aprirne un altro a Caserta senza accorsamento! A. F. li aveva infiltrati in
una cosca camorristica casertana quella dei Belforte-Mazzacane in lotta in quel
tempo per il predominio sul territorio con il clan rivale dei
Piccolo-Quaqquaroni. Però poi sia Magistro che Punzi furono assassinati. Secondo
la ricostruzione dell’accusa che fu fatta a processo, Magistro e Punzi avevano
ricevuto il compito di preparare il terreno per assassinare Domenico Belforte,
uno dei capi di questo clan Belforte-Mazzacane, il quale in quel momento si
trovava al soggiorno obbligato nel Bresciano. Belforte avrebbe però giocato
d’anticipo eliminando l’ex direttore dell’AMIU di Taranto e l’avvocato Punzi,
uomini del F. Alessio Magistro venne ucciso a colpi d’arma da fuoco nel piazzale
dell’ipermercato Rondinelle di Roncadelle (Brescia) mentre Stefano Punzi venne
trovato carbonizzato all’interno della sua auto a Brandico, nella Bassa
Bresciana. Resta da capire per quale motivo il Sisde o questa particolare
fazione del Sisde nel 1998 aveva così clamorosamente preso le parti del clan dei
Piccolo Quaqquaroni contro quelle dei Belmonte Mazzacane. C’è anche da dire che
una volta tre esponenti del clan dei Piccolo-Quaqquaroni erano stati arrestati e
nel corso dell’operazione la polizia aveva rinvenuto, in un capannone nella loro
disponibilità, un mitragliatore Uzi in uso all’esercito israeliano. Questo
spiega molto per non dire che spiega tutto. Anche l’amicizia del F. con il
Procuratore di Taranto Giovanni Massagli. il quale si curava che sul piano
giudiziario non gli accadesse mai niente. Infatti non gli succede mai niente.
Anzi dai processi risultava che F. veniva sistematicamente avvertito delle
indagini che c’erano su di lui da un altro agente del Sisde tal Nicola Curia. E
recentemente la manina misteriosa di un Magistrato aveva infiltrato in un
processo a suo carico in Corte di Appello un falso conteggio della prescrizione
per fargli prescrivere i reati. Ancora all’anno 2000 A. F. nonostante
l’attentato dinamitardo ad Antenna Taranto 6, (1992) il riciclaggio dei 700
milioni (1994), il mancato omicidio di Domenico Belforte (1998), A. F. non è
stato mai ancora giudicato da nessun Tribunale (chissà perchè
……….mha…………..lentezze della giustizia ………………….). Mi chiedo: ha senso in questo
contesto andare dietro i bar aperti senza licenza da Di Giorgio o le presunte
false testimonianze di Argentino? Adesso sono cazzi tuoi! Ti sei messo contro il
Procuratore! Il Procuratore ci teneva molto a quella persona!. Mi chiedo: dove
siamo? a Cristo che si è fermato a Eboli? Oppure a Komeini che sta salendo dalla
Sicilia?
GUERRA DI TOGHE.
Non solo Milano. Tribunale di Taranto. Guerra di
toghe.
Cosa è che l’Italia dovrebbe sapere e che la
stampa tarantina tace?
«Se corrispondesse al vero la metà di quanto si
dice, qui parliamo di fatti gravissimi impunemente taciuti», commenta Antonio
Giangrande, autore del libro “Tutto su Taranto, quello che non si osa dire”,
pubblicato su Amazon.
Mio malgrado ho trattato il caso dell’ex Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, Matteo Di Giorgio,
così come altri casi della città di Taranto. Questioni che la stampa locale ha
badato bene di non affrontare. Prima che iniziassero le sue traversie
giudiziarie consideravo il dr. Matteo Di Giorgio uno dei tanti magistrati a me
ostile. Ne è prova alcune richieste di archiviazione su mie denunce penali. Dopo
il suo arresto ho voluto approfondire la questione ed ho seguito in video la sua
conferenza stampa, in cui esplicava la sua posizione nella vicenda giudiziaria,
che fino a quel momento non aveva avuto considerazione sui media. Il contenuto
del video è stato da me tradotto fedelmente in testo. Sia il video, sia il
testo, sono stati pubblicati sui miei canali informativi. Il seguito è fatto
noto: per Matteo Di Giorgio quindici anni di reclusione per concussione e
corruzione semplice. Tre in più rispetto ai dodici chiesti dal pubblico
ministero. Il Tribunale di Potenza (presidente Gubitosi), competente a trattare
procedimenti in cui sono coinvolti magistrati in servizio presso la Corte
d’appello di Lecce, ha inoltre inflitto la pena di tre anni di reclusione all’ex
sindaco di Castellaneta (Taranto) Italo D’Alessandro e all’ex collaboratore di
quest’ultimo, Agostino Pepe; 3 anni e 6 mesi a Giovanni Coccioli, 2 anni a
Francesco Perrone, comandante dei vigili urbani a Castellaneta, 2 anni ad
Antonio Vitale e 8 mesi ad un imputato accusato di diffamazione.
L'ex pm Di Giorgio, sospeso cautelativamente dal
Csm, fu arrestato e posto ai domiciliari nel novembre del 2010. Le contestazioni
riguardano presunte minacce in ambito politico e ai danni di un imprenditore,
altre per proteggere un parente, e azioni dirette a garantire l’attività di un
bar ritenuto dall’accusa completamente abusivo. Il Tribunale di Potenza ha
inoltre disposto la trasmissione degli atti alla procura per valutare la
posizione di diversi testimoni in ordine al reato di falsa testimonianza. Tra
questi vi sono l’ex procuratore di Taranto Aldo Petrucci e l’attuale procuratore
aggiunto di Taranto Pietro Argentino. Complessivamente il Tribunale di Potenza
ha trasmesso alla procura gli atti relativi alle testimonianze di 21 persone,
quasi tutti carabinieri e poliziotti. Tra questi l’ex vicequestore della polizia
di Stato Michelangelo Giusti.
Eppure Pietro Argentino è il numero due della
procura di Taranto. È il procuratore aggiunto che ha firmato, insieme ad altri
colleghi, la richiesta di rinvio a giudizio per i vertici dell’Ilva ed altri 50
imputati.
Pietro Argentino è il pubblico Ministero che con
Mariano Buccoliero ha tenuto il collegio accusatorio nei confronti degli
imputati del delitto di Sarah Scazzi ad Avetrana.
Possibile che sia un bugiardo? I dubbi mi han
portato a fare delle ricerche e scoprire cosa ci fosse sotto. Ed è sconcertante
quello che ho trovato. La questione è delicata. Per dovere-diritto di cronaca,
però, non posso esimermi dal riportare un fatto pubblico, di interesse
pubblico, vero (salvo smentite) e continente. Un fatto pubblicato da altre fonti
e non posto sotto sequestro giudiziario preventivo, in seguito a querela. Un
fatto a cui è doveroso, contro censura ed omertà, dare rilevanza nazionale,
tramite i miei 1500 contati redazionali.
«Come volevasi dimostrare nessuno dei giornali
italiani nazionali o locali ha più parlato dopo il primo maggio 2014 dei
quindici anni di galera inflitti al Magistrato di Taranto Matteo Di Giorgio e
dell’incriminazione per falsa testimonianza inflitta al Procuratore Aggiunto di
Taranto Pietro Argentino - scrive Michele Imperio -. Ma “La Notte” no. “La
Notte” non ci sta a questa non informazione o a questa disinformazione. Quando
assunsi la direzione di questo glorioso giornale, che ora sta per riuscire nella
sua versione cartacea, dissi che avremmo sempre raccontato ai nostri lettori
tutta la verità, solo la verità, null’altro che la verità e avremmo quindi
sfidato tutte le distorsioni giornalistiche altrui, tutti i silenzi stampa,
tutti i veti incrociati dei segmenti peggiori del potere politico. Strano
cambiamento. Sarà stata l’aspirazione di candidarsi Presidente della Provincia
di Taranto per il centro-destra, maturata nel 2008. Ancora alcuni anni fa
infatti il giudice Matteo Di Giorgio era ritenuto il più affidabile sostituto
procuratore della Repubblica della Procura della Repubblica di Taranto, tanto da
essere insignito della prestigiosa carica di delegato su Taranto della Procura
Distrettuale Antimafia di Lecce. Subì perfino un attentato alla persona per il
suo alacre impegno contro il crimine organizzato. Sette capi di imputazione!
Però sin poco dopo il mandato di cattura tutti hanno capito subito che qualcosa
non andava in quel processo, perché in sede di giudizio sul riesame di quei capi
di imputazione la Corte di Cassazione ne aveva annullati ben tre (censure che la
Cassazione, in sede di riesame, non muove praticamente mai!) e il resto della
motivazione della Cassazione sembrava un’invocazione rivolta ai giudici di
marito: Non posso entrare nel merito – diceva la Cassazione – ma siete sicuri
che state facendo bene? Tutti i commenti della Rete su questo caso sono stati
estremamente critici, quanto meno allarmati. Invece i vari giornali locali, dopo
aver dato la notizia il giorno dopo, non ne hanno parlato più. Scrive invece
sulla Rete – per esempio – il prof. Mario Guadagnolo, già sindaco di Taranto dal
1985 al 1990: “Premetto che io – scrive (Guadagnolo) – non conosco il dott. Di
Giorgio nè ho alcuna simpatia per certi magistrati che anzichè amministrare la
giustizia la usano per obbiettivi politici. Ma 15 anni sono troppi se paragonati
ai 15 anni di Erika e Omar che hanno massacrato con sessanta pugnalate la madre
e il fratellino di sette anni o con i 15 anni comminati alla Franzoni che ha
massacrato il figlioletto Samuele. Qui c’è qualcosa che non funziona. Non so
cosa ma è certo che c’è qualcosa che non funziona”.
Trovo molto singolare che il Procuratore Aggiunto di Taranto Pietro Argentino
sarà incriminato di falsa testimonianza a seguito del processo intentato contro
il dott. Matteo Di Giorgio - scrive ancora l’avv. Michele Imperio su “Tarastv” e
su “La Notte on line” - A parte la stima che tutti riservano per la persona, il
dott. Pietro Argentino aveva presentato al CSM domanda per essere nominato
Procuratore Capo proprio della Procura di Potenza e il CSM tiene congelata
questa delicata nomina da diversi anni. L'attuale Procuratore Capo di Potenza
Laura Triassi è solo un facente funzioni e sicuramente anche lei aspirerà alla
carica. Certamente questa denuncia terrà bloccata per molti anni una eventuale
nomina del dott. Pietro Argentino a Procuratore Capo di una qualsiasi Procura.
La sua carriera è stata quindi stroncata. Laura Triassi è inoltre sorella di
Maria Triassi, professoressa dell'università di Napoli la quale fu incaricata
della perizia epidemiologica nel processo Ilva dal noto Magistrato Patrizia
Todisco, la quale è lo stesso Magistrato che già aveva denunciato alla Procura
della Repubblica di Potenza il collega Giuseppe Tommasino, poi assolto e che
aveva invece lei stessa assolto dal reato di concorso esterno in associazione a
delinquere il noto pregiudicato A. F., mandante - fra l'altro - di un grave
attentato dinamitardo a sfondo politico, che poteva provocare una strage. Il
conflitto Di Giorgio-Loreto lo conosciamo già. Ma di un altro conflitto che sta
dietro questo processo non ha parlato mai nessuno. Alludiamo al conflitto Di
Giorgio-Fitto. Se infatti il dott. Matteo Di Giorgio fosse stato nominato
presidente della provincia di Taranto sarebbero saltati per aria tanti strani
equilibri che stanno molto cari all'on.le Fitto e non solo a lui. Inoltre trovo
molto strano che l'on.le Raffaele Fitto, il quale fa parte di un partito molto
critico nei confronti di certe iniziative giudiziarie, quanto meno esagerate,
non abbia mai detto una sola parola su questa vicenda, che vedeva peraltro
coinvolto un Magistrato dell'area di centro-destra. Come pure non una sola
parola, a parte quelle dopo l'arresto, è stata mai detta sulla vicenda
dall'attuale Procuratore Capo della Repubblica di Taranto dott. Franco Sebastio.
E nel processo sulla malasanità di Bari compaiono intercettazioni telefoniche
fra il dott. Sebastio e il consigliere regionale dell'area del P.D. ostile al
sindaco di Bari Michele Emiliano, Michele Mazzarano, nel corso delle quali il
dott. Sebastio esprimeva sfavore per la nomina a Procuratore Aggiunto del dott.
Pietro Argentino. Nel corso di una dichiarazione pubblica il dott. Sebastio
espresse invece, in modo del tutto sorprendente, soddisfazione per l'arresto del
dott. Matteo Di Giorgio e disse che auspicava che anche un secondo Magistrato
fosse stato allontanato dalla Procura della Repubblica di Taranto (Argentino?).
Ora, guarda un pò, anche il dott. Argentino potrebbe essere sospeso dalle
funzioni o trasferito di sede....Ciò che è accaduto al Tribunale di
Potenza è, quindi, come ben comprenderete, un fatto di una gravità inaudita e
sottintende un conflitto fra Magistrati per gestioni politiche di casi
giudiziari, promozioni e incarichi apicali, mai arrivato a questi livelli.
Voglio fare alcune premesse utili perchè il lettore capisca che cosa c’è sotto.
Sia a Taranto che a Potenza, patria di Angelo Sanza, sottosegretario ai servizi
segreti quando un parte del Sisde voleva assassinare Giovanni Falcone e un’altra
parte del Sisde non era d’accordo (e lui da che parte stava?), come forse anche
in altre città d’Italia, opera da decenni una centrale dei servizi segreti
cosiddetti deviati in realtà atlantisti, che condiziona anche gli apparati
giudiziari e finanche quelli politici della città. Di sinistra. Così pure altra
sede dei servizi segreti atlantisti questa volta di destra, opera a Brindisi. La
sezione di Taranto in particolare appartiene sicuramente a quell’area politica
che Nino Galloni avrebbe chiamato della Sinistra politica democristiana cioè una
delle tre correnti democristiane, in cui si ripartiva la vecchia Sinistra
Democristiana che erano – lo ricordo a me stesso – la Sinistra sociale
capeggiata dall’on.le Carlo Donat Cattin, il cui figlio è stato
suicidato-assassinato; la Sinistra morotea capeggiata dall’on.le Aldo Moro,
assassinato, e poi inutilmente e per brevissimo tempo riesumata dal Presidente
della Regione Sicilia Piersanti Mattarella, anche lui assassinato; la Sinistra
politica capeggiata dai vari De Mita, Mancino, Rognoni, Scalfaro e Prodi, i
quali non sono stati mai nemmeno scalfiti da un petardo. Ma torniamo a noi e ai
giudici tarantini Pietro Argentino e Matteo Di Giorgio. La cui delegittimazione
– per completezza di informazione – è stata preceduta da un’altra clamorosa
delegittimazione di un altro Giudice dell’area di centro destra, il capo dei
g.i.p. del Tribunale di Taranto Giuseppe Tommasino, fortunatamente conclusasi
con un’assoluzione e quindi con un nulla di fatto. Quindi Tommasino, Di Giorgio,
Argentino, a Taranto dovremmo cominciare a parlare di un vero e proprio
stillicidio di incriminazioni e di delegittimazioni a carico di Magistrati della
Procura o del Tribunale non appartenenti all’area della Sinistra Politica
Democristiana o altra area alleata, ovvero all’area della Destra neofascista
finiana. L’indagine a carico del Dott. Matteo Di Giorgio è durata circa due anni
ed è stata condotta da un Maresciallo dei Carabinieri espulso dall’arma e
caratterizzata dall’uso di cimici disseminate in tutti gli uffici del Tribunale
di Taranto e della Procura. E’ capitato personalmente a me di essere invitato
dal giudice Giuseppe Di Sabato, (g.i.p.), un Magistrato che non c’entrava niente
con l’inchiesta, di essere invitato a interloquire con lui al bar del Tribunale
anziché nel suo ufficio, perchè anche nel suo ufficio c’erano le cimici di
Potenza. Ma c’è di più! La Sinistra Politica democristiana vuole diventare a
Taranto assolutamente dominante sia in Tribunale che in tutta la città, perché
corre voce che due Magistrati, uno della Procura l’altro del G.I.P., resi
politicamente forti dalla grande pubblicità e visibilità del processo Ilva,
starebbero per passare alla politica, uno come candidato sindaco l’altro come
parlamentare, quando sarà.»
Sembra che il cerchio si chiuda con la scelta del
Partito democratico caduta su Franco Sebastio, procuratore capo al centro
dell’attenzione politica e mediatica per la vicenda Ilva, intervistato da
Francesco Casula su “La Gazzetta del Mezzogiorno”.
Procuratore Sebastio, si può giocare a carte
scoperte: il senatore Alberto Maritati alla Gazzetta ha ammesso di averle
manifestato l’idea del Partito democratico di averla in lista per il Senato...
«Io conosco il senatore Maritati da tempo, da
quando era pretore a Otranto. Siamo amici e c’è un rapporto di affettuosa stima
reciproca. Ci siamo trovati a parlare del più e del meno... É stato un discorso
scherzoso, non ricordo nemmeno bene i termini della questione».
Quello che può ricordare, però, è che lei ha detto
no perché aveva altro da fare...
«Mi sarà capitato di dire, sempre scherzosamente,
all’amico e all’ ex collega che forse ora, dopo tanti anni, sto cominciando a
fare decentemente il mio lavoro. Come faccio a mettermi a fare un’attività le
cui caratteristiche non conosco e che per essere svolta richiede qualità elevate
ed altrettanto elevate capacità? É stato solo un discorso molto cordiale, erano
quasi battute. Sa una cosa? La vita è così triste che se non cerchiamo, per
quanto possibile, di sdrammatizzare un poco le questioni, diventa davvero
difficile».
«Candidare il procuratore Franco Sebastio? Sì, è
stata un'idea del Partito democratico. Ne ho parlato con lui, ma ha detto che
non è il tempo della politica». Il senatore leccese Alberto Maritati,
intervistato da Francesco Casula su “La Gazzetta del Mezzogiorno”, conferma così
la notizia anticipata dalla Gazzetta qualche settimana fa sull’offerta al
magistrato tarantino di un posto in lista per il Senato.
Senatore Maritati, perchè il Pd avrebbe dovuto
puntare su Sebastio?
«Beh, guardi, il procuratore è un uomo dello Stato
che ha dimostrato sul campo la fedeltà alle istituzioni e non solo ora con
l'Ilva. Possiede quei valori che il Pd vuole portare alla massima istituzione
che è il Parlamento. Anche il suo no alla nostra idea è un esempio di
professionalità e attaccamento al lavoro che non sfocia mai in esibizionismo».
Parla la pm Digeronimo con Lorenzo Lamberti su
“Affari Italiani”: "Io isolata, in magistratura comandano le correnti".
Desirèe Digeronimo, 48 anni, è stata a lungo sostituto procuratore della Dda di
Bari, la sua città. Numerose le sue inchieste sulla camorra barese, alla quale
ha inferto duri colpi. Indagando sui rapporti tra politica locale e criminalità
organizzata scoperchia il sistema ruotante intorno all’assessore regionale della
Puglia alla Sanità, l’ex senatore Pd Alberto Tedesco. Digeronimo e il collega
Francesco Bretone, informati dei rapporti di amicizia dei rapporti di amicizia
tra la sorella di Nichi Vendola e il gup Susanna De Felice, si rivolgono agli
organi competenti ma la loro lettera spedita in via riservata ai capi degli
uffici della Procura di Bari e della Procura generale presso la Corte d’appello
finisce sui giornali. De Felice ha poi prosciolto Vendola (a pochi giorni dalle
elezioni dello scorso febbraio Panorama ha pubblicato la foto dove i due
pranzavano insieme ad altre persone). Il Csm ha aperto un procedimento (per
fatto incolpevole) per valutare il trasferimento di Digeronimo per
incompatibilità ambientale. Procedimento poi chiuso dopo che il 26 luglio 2013
il Csm ha deliberato il trasferimento a Roma, come da Digeronimo richiesto.
"Comandano gli apparati. Per fare carriera sai che
devi far parte di una corrente e questo ha creato quella che chiamo
un'oligarchia di magistrati". Desirèe Digeronimo, il pm della Sanitopoli
pugliese appena trasferita da Bari a Roma, racconta la sua vicenda e propone una
riforma del sistema giudiziario in una lunga intervista ad Affaritaliani.it.
“Il trasferimento è stato solo l’ultimo atto di un progressivo isolamento
all’interno della procura di Bari”. Il tutto dopo l’inchiesta sull’ex senatore
Pd Tedesco e la segnalazione dei rapporti tra Vendola e Susanna De Felice, il
gup che doveva decidere sul rinvio a giudizio del governatore della Puglia.
“Persone legate a un gruppo di potere mi hanno delegittimata. Non dovevo essere
credibile così non sarebbero state credibili le mie indagini”. Nel 2009 Vendola
la attaccò con una dura lettera pubblica: “Chi di dovere avrebbe dovuto dare uno
stop e tutelarmi, ma non è successo”. Sui pm in politica: “Il problema non è chi
fa politica spogliandosi della toga ma chi la fa indossandola. Candidarmi a
sindaco di Bari? Per la mia città io ci sarò sempre".
Come mai ha deciso di chiedere il trasferimento
da Bari a Roma?
«Il
trasferimento è stato solo l’ultimo atto di un cammino progressivo di isolamento
all’interno del mio ufficio che io imputo all’azione di personaggi collegati a
un gruppo di potere finalizzata alla mia delegittimazione professionale e
personale. Non dovevo essere credibile così non sarebbero state credibili le
indagini che conducevo. Quando la calunnia si è trasferita dai corridoi alle
sedi istituzionali e da là alla diffusione mediatica non ho potuto più limitarmi
a resistere ma ho dovuto agire a mia tutela. Il trasferimento è stato un atto
consequenziale di rispetto nei confronti dell’istituzione Procura, non potevo
trascinare l’ufficio in una strumentale campagna giornalistica di veleni e corvi
così come è stata definita. Ho preferito pormi il problema del prestigio di una
istituzione assumendomene la responsabilità. Certo, con rammarico devo
constatare che chi in tale vicenda aveva il dovere di porsi a tutela di tale
prestigio già da molti anni ha mancato, ma io faccio il magistrato. Non potevo
non tenerne conto, nemmeno di fronte alle omissioni».
Nell’inchiesta sulla sanità pugliese il nome
dell’ex senatore Tedesco fu inizialmente depennato da alcuni suoi colleghi dalle
utenze da intercettare. Com’è possibile che sia accaduto?
«Sono questioni
di cui non intendo parlare, ci sono sedi competenti in cui è giusto e spero
siano affrontate. Certo, se quelle erano le carte nel 2007 la mia indagine
iniziata nel 2008 non avrebbe dovuto stupire».
Nell’agosto del 2009 lei ha subìto un duro
attacco da parte di Vendola, che scrisse una lettera pubblica contro di lei.
Crede che la vicenda sia stata poco sottolineata?
«Credo che la
vicenda avrebbe dovuto comportare immediate conseguenze a tutela della
giurisdizione da parte di chi era tenuto a farlo. Uno stop duro e fermo a quella
deriva avrebbe cambiato il corso delle cose e non avrebbe consentito quello che
io penso sia avvenuto in questi anni, ovvero una costante e dannosa perdita di
prestigio dell’ufficio di procura di Bari. Ma del senno di poi, come si dice,
sono piene le fosse».
Si è data una spiegazione su come sia avvenuta
la pubblicazione della sua nota riservata sulla vicenda Vendola-De Felice?
«Ho fatto una
denuncia, qualsiasi spiegazione possa dare sarebbe solo un’opinione personale
indimostrabile visto che il relativo procedimento è stato archiviato. Certo chi
l’ha data in mano a un giornalista non aveva a cuore le istituzioni, la
giustizia e l’equilibrio delicatissimo che è alla base del rapporto di fiducia
tra cittadini e istituzioni. Il mito narra che aperto il vaso di Pandora uscì
tutto tranne la speranza ma alla fine fuggì anche quella. Io vivo anche di
speranza, spero che un giorno arrivi la verità, la risposta a tante domande e
soprattutto la giustizia».
Ilda Boccassini ha detto che alcuni pm svolgono
certe inchieste “per altri scopi” rispetto alla giustizia usando magari la
magistratura come trampolino di lancio. E’ d’accordo?
«La
magistratura ormai è un mondo variegato: non siamo tutti uguali, non siamo tutti
idealmente motivati nello stesso modo. Credo che le storie siano personali e che
vadano giudicate dai fatti, dalle circostanze concrete in cui accade che si
arrivi a certe scelte. In genere le indagini serie, fatta salva l’alea del
giudizio che prevede un contraddittorio tra accusa e difesa, approdano a
processi e condanne… già questo esclude un pregiudizio di strumentalità. Il
problema vero non è chi fa politica spogliandosi della toga ma chi la fa
indossando la toga. La magistratura non è scevra da simili fenomeni anche se non
la immagino come attività organizzata e sistemica di supporto politico a questa
o quella parte».
Pensa che il sistema delle correnti interne
alla magistratura andrebbe rivisto? Non rende troppo simile la magistratura alla
politica?
«Il nostro
sistema giudiziario necessita di una radicale riforma. Una riforma che
restituisca efficienza e credibilità alla giustizia e questo passa non solo da
cambiamenti strutturali e innesti di risorse nel servizio giustizia ma anche da
una rivoluzione in termini culturali del sistema di rappresentatività dei
magistrati all’interno del suo organo di autogoverno. Il nostro sistema
giudiziario è specchio del Paese, siamo affetti dalla stessa patologia che
affligge l’intera struttura burocratica amministrativa. Il meccanismo dello
spoil system ormai è regola: nel bene e nel male comandano gli apparati,
vince chi si pone all’interno e a tutela degli apparati. Vince cioè la logica
dell’appartenenza. Il tutto avviene all’interno delle correnti. In una
situazione come questa avere agganciato al merito e non all’anzianità il
criterio per l’attribuzione di incarichi e direttivi, che pure in astratto è
cosa sacrosanta, aumenta la discrezionalità di chi decide e diventa facile
strumento di derive patologiche del sistema. Oggi sai che per fare carriera, per
essere tutelato, per non subire ingiustizie, ma anche per difenderti dalla
giusta assunzione di responsabilità nell’esercizio delle tue funzioni, devi fare
parte di una corrente, ovviamente una corrente forte capace di sedersi al tavolo
della “trattativa” con le altre correnti. In questo meccanismo diventa difficile
sottrarsi alla logica dell’appartenenza. Questo sistema ha portato alla nascita
di quella che io chiamo un’oligarchia di magistrati che percorrono come
cursus honorum i vari steps all’interno dell’Anm e del Csm per fare
carriera. La deriva patologica di questo sistema non fa bene all’autonomia e
all’indipendenza della magistratura perché aumenta il rischio di una
“politicizzazione” di certi meccanismi di autogoverno ma soprattutto non fa bene
al servizio giustizia che noi abbiamo il dovere di assicurare ai cittadini. Le
correnti da luoghi di discussione e crescita culturale e giuridica si sono
trasformati in luoghi di potere».
Serve una riforma della giustizia?
«Questo sistema
va immediatamente bloccato, occorre ridare ossigeno alla magistratura
esattamente come occorre ridare ossigeno al sistema politico e partitico di
questo paese. Questo non può essere rimesso a una sorta di presa di
autocoscienza del singolo, serve una classe dirigente politica capace di fare le
giuste riforme con onestà intellettuale e per il bene della comunità dei
cittadini. Io non voglio rinunciare al criterio del merito per la valutazione
dei magistrati perché il criterio dell’anzianità ha forti limiti in termini di
efficienza del sistema. Un buon criterio per l’individuazione dei magistrati da
delegare all’autogoverno potrebbe essere il sorteggio dei rappresentati togati
del Csm: un sorteggio temperato, per esempio all’interno di una rosa di persone
candidabili scelte secondo criteri oggettivi predeterminati. Questo
indebolirebbe molto il sistema di potere delle correnti. Alla facile obiezione
che abbiamo diritto di sceglierci i nostri rappresentanti perché non siamo tutti
uguali rispondo che il cittadino non ha diritto di scegliersi il suo giudice:
esiste il principio del giudice naturale. Ecco, bisognerebbe studiare una forma
di consigliere togato del Csm scelto secondo gli stessi valori che sono alla
base del principio del giudice naturale. Tuttavia di fronte all’incapacità di
tutta la politica di procedere a una seria riforma della giustizia mi domando se
la nostra classe dirigente abbia veramente a cuore la salvaguardia
dell’autonomia e della indipendenza della magistratura. Una magistratura
controllabile è tranquillizzante, ma chi non ha la lungimiranza di capire che è
giunto il momento delle giuste riforme deve sapere che una magistratura
controllata ha anche un forte potere di ricatto».
La sua vicenda sembra suggerire che fare il
magistrato sia come agire un po’ in un campo minato. Possibile che chi tocca
alcune inchieste venga isolato e messo da parte anche dai suoi stessi colleghi?
«Oggi chi tocca
alcuni fili muore. Fa parte della degenerazione del sistema di cui ho parlato.
Un simile sistema può trasformarsi in una maionese impazzita e non è affatto
detto che a “morire” siano sempre gli stessi. Occorre fermare questa deriva
ancorata solo a forme di esercizio del potere, la giustizia deve tornare a
essere sempre e in tutte le sue forme un servizio a tutela del cittadino, libero
da qualsiasi tipo di condizionamento. La vera democrazia di un Paese nasce da
questo fondamentale presupposto».
Da Berlusconi all’Ilva, si sprecano i casi di
scontro più o meno aperto tra politica e giustizia. Come si può sanare questa
“guerra”?
«Il conflitto
tra politica e giustizia si può risolvere solo intraprendendo il cammino,
difficile ma necessario, che ho descritto prima. Un cammino che può essere
intrapreso però solo da chi ha le mani libere per decidere: per cambiare abbiamo
bisogno di una classe dirigente non ricattabile né ricattatoria».
Che cosa ne pensa dei referendum sulla
giustizia?
«Ho firmato i
referendum, ciò non significa che approvi tutto quello che viene proposto. Ho
sempre sostenuto, per esempio, che il miglior pm è quello che ha fatto il
giudice, ma di fronte all’immobilismo stagnante che ha consentito questa deriva
patologica è necessario uno choc, una scossa che provenga dalla base. Non
abbiamo più tempo da perdere: per il nostro bene di cittadini occorre rimuovere
l’immobilismo della politica con proposte forti. Del resto, con le necessarie
garanzie a salvaguardia dell’esercizio imparziale delle funzioni requirenti,
siamo pronti anche alla separazione delle carriere. Ricostruire in termini di
autonomia e indipendenza reciproca il rapporto tra pubblici ministeri e giudici
non può che fare bene alla giustizia intesa come servizio».
Da pugliese pensa che sull’Ilva politica e
magistratura abbiano la coscienza pulita?
«Il caso
dell’Ilva è emblematico del ruolo di supplenza assunto dalla giustizia rispetto
al silenzio e all’inerzia delle istituzioni deputate a decidere e a controllare
che ci sia la giusta coniugazione tra interesse pubblico e privato. Quando si
giunge a questo punto è già troppo tardi: qualsiasi azione si intraprenda non
sarà mai possibile che nel conflitto tra diritti, in questo caso tra lavoro e
salute, ci sia un contemperamento che garantisca il giusto equilibrio. Ci sarà
sempre un diritto soccombente. Nella vicenda Ilva si è arrivati al punto di non
ritorno e le responsabilità sono diffuse, ma le maggiori responsabilità sono
quelle politiche perché la magistratura una volta imboccata la strada ha un
percorso obbligato».
Da Ingroia a De Magistris ci sono stati alcuni
casi “sfortunati” di pm in politica. Pensa che questo passaggio di ruolo sia
legittimo?
«Candidarsi è
un diritto, ci sono motivazioni complesse che portano un magistrato a farlo,
solo che spesso rimangono confinate all’interno della propria coscienza. Nella
gamma dei magistrati candidati in politica a mio avviso ci sono motivazioni
nobili e meno nobili, dai crediti acquisiti che vengono saldati dagli apparati
di potere alla mera ambizione personale. Ma la motivazione può essere più
profonda, può derivare dalla presa di consapevolezza dei limiti del sistema
giudiziario, della sua patologia. Tale presa di coscienza nasce spesso da
un’esperienza personale che mette in crisi il proprio sistema valoriale e
innesca un processo di allontanamento. E’ come un grande amore tradito, quello
che fa più male, ma anche quello che per autodifesa vuoi rimuovere dal cuore. In
questo caso scegliere di candidarsi unisce la voglia di cambiare il nostro
sistema paese alla necessità di continuare a credere in quegli stessi ideali che
ti hanno fatto amare la toga e alla consapevolezza che per affermarli occorre
andare all’esterno. Giustizia ed equità passano dal cambiamento delle regole e
le regole le cambia la politica. In fondo in questi casi ti candidi perché credi
ancora in qualche cosa e pensi di poterla realizzare, perché non ti vuoi
rassegnare alla logica che il mondo deve andare per forza così. Tuttavia, credo
he se è un diritto candidarsi e poterlo fare senza perdere un posto di lavoro, è
anche un dovere del magistrato e un diritto dei cittadini avere la garanzia
sostanziale e formale di una magistratura terza e imparziale. Occorrerebbe
quindi regolamentare la materia facendo sì che un magistrato che affronti un
impegno politico possa tornare a svolgere le sue funzioni in altri settori della
pubblica amministrazione, in ruoli diversi da quelli giurisdizionali. Ci sono
tanti posti riservati ai magistrati nella pubblica amministrazione… non sarebbe
difficile farlo».
Gira la voce che lei si candiderà a sindaco di
Bari. È una voce che corrisponde a realtà?
«Ho lavorato 15
anni al servizio della mia città producendo risultati importanti e tangibili.
Risultati che sono e saranno alla base della prosecuzione di questo lavoro da
parte dei colleghi che dopo di me prenderanno in mano la situazione del
controllo di legalità e della repressione del fenomeno criminale mafioso nella
città di Bari. Quando hai svolto con tale intensità il tuo ruolo è difficile non
pensare in termini di appartenenza alla tua comunità, è difficile rinunciare a
occuparsi delle persone che hai cercato di proteggere, di difendere rendendo
giustizia. È come una relazione d’amore, in questo caso per di più interrotta
per mano di altri. Ecco, non smetterò mai di amare la mia comunità e di nutrire
lo stesso sentimento di protezione, di ricerca della giustizia e dell’equità,
della costruzione di un tessuto sociale fondato su valori positivi di comunione
e solidarietà. Quando ti misuri con un sentimento e non con le parole tutto il
resto viene da sé. Per la mia città io ci sarò sempre con la stessa
determinazione di fare qualcosa di buono per il bene di tutti. Il resto chissà,
io credo nel destino delle cose che accadono…»
LE CARICHE PUBBLICHE
E LA MASSONERIA. FATTI AMICO UN MASSONE DI SINISTRA.
Ottoemezzo del
7 aprile 2014 su La7. Le cariche pubbliche e la massoneria.
Parte il punto di Paolo Pagliaro, nel quale si sostiene che la massoneria è
molto radicata negli incarichi pubblici e che conti molto più di quanto si
immagini. Bisi sostiene che «non mi risulta che ci siano massoni nel governo
Renzi» e che in caso contrario «non ci sarebbe nulla di male». Per D’agostino vi
sono dei movimenti che operano al di là di quello che vediamo. Bisi invece dice
che alla base delle preoccupazioni vi siano il rispetto della persona, della
cultura, della scuola pubblica. Nega che il Grande Oriente si occupi minimamente
delle nomine pubbliche. Sostiene che durante le riunioni massoniche uno parla e
gli altri ascoltano, cosa che non succede nei partiti. Bisi conclude invitando
di conoscere meglio la massoneria, anche visitando il loro Bisi per essere Gran
Maestro guadagna 129 mila euro lordi all’anno e ogni anno ogi fratello deve
versare circa 400 euro. Bisi pensa che un’esperienza come la P2 non si possa
ripetere perché i controlli da parte del Grande Oriente si sono infittiti.
D’Agostino sostiene che Gelli «uno che vende materassi a Frosinone» fosse una
testa di legno e che non potesse essere davvero lui a «comandare l’Italia» Bisi
sostiene che se dovesse scegliere tra due giornalisti e uno dei due è massone,
sceglierebbe quello più bravo, anche se l’altro è massone. Sostiene che non vi
sono donne nella massoneria per motivi storici «siamo radicati alle tradizioni».
Crede che per cambiare una tradizione ci sono dei percorsi da intraprendere, in
questo caso molto lunghi. Bisi sostiene che tra massoni ci si sostiene «nei
limiti del lecito», raccontando di aver fatto 30 chilometri per anni per
accompagnare un fratello cieco per cui la massoneria era una ragione di vita.
Bisi racconta che nel 77 decise di aderire perché un giornale pubblicò i nomi
dei maestri venerabili. Si incuriosì e dopo aver incontrato un massonE chiedendo
di entrare. Dopo quattro anni venne ammesso. La Gruber chiede come deve chiamare
il gran Maestro, che chiede di essere chiamato “Stefano”, D’Agostino fa
dell’umorismo e interviene con «bellicapelli». Bisi spiega che gli affiliati
della massoneria sono segreti come quelli di altre associazioni. Dice che i
responsabili sono noti, così coem le sedi. Ha detto che Rimini avrebbero potuto
partecipare all’incontro con tutti i fratelli associati alla massoneria.
D’Agostino ha detto che intorno al 2000 aveva deciso di diventare massone, ma la
sua domanda non venne presa in considerazione. Crede che a parte lo scandalo
della P2, la massoneria ha portato all’unità d’Italia. Bisi sostiene che la
massoneria non distribuisce poltrone «il potere della massoneria è quello di far
emozionare». Norberto Bobbio disse che la democrazia non è compatibile con un
potere come la massoneria. Per Bisi la massoneria è una palestra per la laicità
che serve a «migliorare noi stessi e migliorando noi stessi possiamo migliorare
l’umanità». Per D’Agostino la massoneria è qualcosa di più concreto, ma non deve
essere criminalizzata, anche se poi fa un parallelismo con la mafia. D’Agostino
sostiene che al governo si sono susseguite massonerie di destra e sinistra,
mentre per Bisi sta semplificando. Oltre alle grandi riforme Renzi deve
risolvere la nomina dei nuovi vertici della aziende pubbliche. Si dice sempre
che i poteri forti in questi casi si mettono in azione. La Gruber si chiede se
in questo caso «la massoneria è in azione?». La presentatrice ne parlerà insieme
al Gran Maestro del Grande Oriente Stefano Bisi e Roberto D’Agostino, che si è
autodefinito “Gran Bidello”.
Massoneria non significa affarismo e nepotismo,
scrive Alessandro Calabrese su “Italians-Corriere della Sera”. Caro Severgnini,
l’eccezione conferma la regola, dice un vecchio adagio. Quindi devo sperare che
la tua concessione allo scontato luogo comune massoneria = affarismo e nepotismo
sia, appunto, un’eccezione che conferma la tua originalità nei giudizi, mai
banali. Pensi davvero che la libera muratoria italiana (quella che ha
contribuito in maniera decisiva a realizzare quel poco di stato laico che c’è
nel nostro paese, solo per citarne il merito più evidente) possa essere ridotta
solo a sinonimo di affarismo e di ileciti intrallazzi? La massoneria mi ha
insegnato, tra tante altre cose, a non essere né ingenuo né partigiano. Sarei
quindi uno sciocco se negassi che anche in massoneria, come in ogni aggregazione
umana (partiti, aziende, associazioni, chiese, ordini e caste professionali,
club, bocconiani e chi più ne ha, ne metta) ci sono persone che cercano di
trarre benefici dalle relazioni attivate. Tuttavia sono convinto che,
specialmente oggi, la massoneria non sia affatto caratterizzata da queste
attività e sicuramente lo sia infinitamente meno della maggior parte delle altre
forme associative, fermo restando che, purtroppo, è umanamente impossibile
impedire alle persone di cercare vantaggi ingiusti o illegittimi. Quello vissuto
dalla massoneria italiana negli ultimi decenni, specie dopo lo scandalo P2,la
vera antitesi della massoneria, è un percorso di trasparenza e responsabilità,
che ne ha evidenziato il ruolo di agenzia di valori e principi. Ma è più comodo
continuare ad agitare il luogo comune. In fondo siamo anche scomunicati. Con
immutata stima, Alessandro Calabrese.
Massoneria:il dopo P2,
scrive Gian Giacomo William Faillace. Gli anni successivi al falso scandalo che
ha coinvolto la Rispettabile Loggia Propaganda 2, hanno segnato profondamente la
Massoneria italiana: azioni diffamatorie, creazione, da parte di alcuni
giornalisti di pseudo logge definite P3 e P4 che con la Massoneria nulla avevano
o hanno a che fare, azioni antimassoniche clericali o di stampo comunista volte
al tentativo di distruggere l’istituzione massonica, hanno colpito nel segno
ferendo la Massoneria ma il tentativo di cancellarla è mal riuscito. Tanto
concentrati in questo vano tentativo, queste due forze (Chiesa e Comunismo),
che da sempre hanno rappresentato il totalitarismo, il dogmatismo, la demagogia,
hanno perso di vista i problemi, nonché le lotte interne, che le attanagliavano
perdendo talvolta fedeli talvolta “compagni”. Successivamente, mentre la Chiesa
ha avuto timidi atteggiamenti di apertura, la sinistra italiana ha cercato,
talvolta con successo, di infiltrare all’interno delle obbedienze, persone ad
essa vicine seguendo così la regola che se non si può abbattere un nemico
dall’esterno allora si deve colpire dall’interno. Il pregio, ed al contempo il
difetto, della Massoneria è che tutti possono “bussare” ed essere iniziati, a
prescindere dal credo politico o religioso, e proprio questa regola, alla base
della tolleranza, rischia di trasformarsi in un’arma a doppio taglio. Purtroppo,
le infiltrazioni della sinistra italiana, hanno contribuito a trasformare alcune
logge in vere e proprie sezioni di partito. La Massoneria, però, non è politica,
non è un club in cui discorrere di affari, ideologie e tantomeno un luogo in
cui “educare” i neofiti all’avversione verso una dottrina politica o religiosa,
eppure, in alcune logge, seppur isolate, avviene. Ecco il motivo che ha spinto
molti massoni ad entrare in sonno, ossia ad uscire dalle logge volontariamente e
scegliere quindi di non partecipare a tempo indeterminato ai lavori rituali.
Ora, la Massoneria italiana, dovrà impegnarsi e riuscire ad epurare le sue logge
da tutti coloro che hanno intenzione di sostituire la squadra ed il compasso con
la falce ed il martello. Non solo apertura e trasparenza verso il mondo profano,
ma anche scelte coraggiose che vedranno la perdita di numerosi iscritti,
spettano ai Gran Maestri delle Obbedienze massoniche italiane. Solo seguendo la
“Vera Luce” i Gran Maestri potranno riportare la Massoneria in quel “solco
naturale” che vuole che essa sia una strada per un perfezionamento etico
personale: il massone deve imparare, essere sgrossato come una pietra grezza per
divenire una pietra angolare e quindi “esportare” al mondo esterno il suo
perfezionamento etico al fine di rendere migliore tutto ciò che lo circonda.
Guai se avvenisse il contrario! Ma si sa, la Massoneria è composta da uomini, e
gli uomini sono imperfetti, quindi è ovvio che in seno all’Arte Reale si
verifichino”importazioni profane” ma è compito dei Venerabili Maestri vigilare
con perseveranza affinchè fattori esterni non inquinino i lavori delle logge.
Quindi, solo con scelte coraggiose e non dettate da inquinamenti esterni, la
Massoneria italiana potrà essere guida verso la libertà, la laicità e tornare ad
essere quella radiosa luce in fondo al tunnel della superstizione, del
totalitarismo e dei dogmatismi demagogici e tornare ad essere portatrice di
quella modernità che la società tutta richiede. C’era una volta una sinistra
seria. Inattaccabile. Affidabile. “Comunista, ma perbene.” Il paradigma è
saltato ed è ora di guardare in faccia la realtà per quella che è veramente.
Anche la sinistra ruba, inquina, specula, anche la sinistra fa affari sporchi e
attacca la magistratura. Banche, sanità, cooperative, fondazioni,
amministrazioni locali e regionali: scandali e inchieste hanno travolto la
classe dirigente che avrebbe dovuto trasformare l’Italia in un paese “normale”,
persino roccaforti rosse come l’Emilia sono crollate, investite da accuse di
connivenza con mafia e ’ndrangheta. Al posto dell’ideologia il denaro,
l’interesse individuale, il puro potere. Ecco gli scandali del Monte dei Paschi,
la scalata alla Bnl, la Bicamerale, la legge del comunista Sposetti che ha
arricchito i partiti, la metamorfosi di Violante, i soldi dell’Ilva, le accuse
di tangenti a Penati, le convergenze con la destra in materia di giustizia...
Non serve vincere le elezioni se la gestione del potere e le ricette economiche
rimangono uguali a quelle degli avversari berlusconiani. Fatti, non solo parole,
dal Nord al Sud, città per città, regione per regione. Il quadro è inquietante,
più che sufficiente a fotografare una malattia per la quale non sembra esserci
una terapia efficace. E che come un virus inarrestabile non risparmia nemmeno il
nostro capo dello Stato, ultimo difensore di questo sistema, del quale qui si
svela per la prima volta la complessa storia politica, ricca di retroscena
inediti.
Ferruccio Pinotti è autore di molti
libri-inchiesta che hanno smascherato le trame e gli interessi dei poteri forti.
Lavora al “Corriere della Sera” e ha scritto per “MicroMega”, “l’Espresso”, “Il
Sole 24 Ore”, “la Repubblica”, “Il Fatto Quotidiano”. Tra i suoi libri più
importanti vanno ricordati POTERI FORTI (Bur 2005), OPUS DEI SEGRETA (Bur 2006),
FRATELLI D’ITALIA (Bur 2007), COLLETTI SPORCHI (Con Luca Tescaroli, Bur 2008),
L’UNTO DEL SIGNORE (con Udo Gümpel, Bur 2009), FINANZA CATTOLICA (Ponte alle
Grazie 2011), VATICANO MASSONE (con Giacomo Galeazzi, Piemme, 2013). Con
Chiarelettere ha pubblicato LA LOBBY DI DIO (2010) e WOJTYLA SEGRETO (con
Giacomo Galeazzi, 2011). Stefano Santachiara, giornalista d’inchiesta, dal 2009
è corrispondente de “il Fatto Quotidiano”, dalle cui colonne ha svelato il primo
caso accertato di rapporti tra ’ndrangheta e Pd al Nord, nel comune appenninico
di Serramazzoni, una vicenda poi ripresa da REPORT.
Dalle amicizie
pericolose di Bersani a quelle di D'Alema, dalle innovazioni ambigue di Renzi
alle ombre dell'Ilva su Vendola. Fino al "nuovo compromesso storico" di Enrico
Letta e ai segreti di Giorgio Napolitano, scrive
Lorenzo Lamperti su “Affari Italiani”.
Non risparmia nessuno "I panni sporchi della sinistra", il libro di Ferruccio
Pinotti e Stefano Santachiara (edito da Chiarelettere") che mette a nudo le
magagne del centrosinistra. Un lavoro importante e "lungo due anni", come ha
spiegato Santachiara intervistato da Affaritaliani.it, nel quale i due
autori raccolgono e analizzano una serie di inchieste giudiziarie
che riguardano, a vario titolo, il mondo della sinistra. Dalla galassia Bersani
di Penati, Pronzato e Veronesi alla vicenda di Flavio Fasano, referente di
D'Alema invischiato in una storia di mafia. Dallo scandalo Ilva al caso Unipol,
passando per i trasferimenti di due magistrate, Clementina Forleo e Desirée
Digeronimo, che avevano indagato sulle responsabilità di importanti esponenti
politici di sinistra. Pinotti e Santachiara ricostruiscono con dovizia di
particolari tutta una serie di vicende, grandi e piccole, note e sconosciute,
che offrono un ritratto impietoso di una sinistra che ha subìto "una mutazione
genetica". Il libro si apre con un esplosivo capitolo su Giorgio Napolitano, del
quale vengono indicati i rapporti (o presunti tali) con Berlusconi, la
massoneria, la Cia e i poteri atlantici. Un capitolo del quale Affari
pubblica un estratto
e che certamente farà molto
discutere.
Stefano Santachiara, com’è nato il libro “I
panni sporchi della sinistra”?
«Mi sono
occupato a lungo di cronaca giudiziaria per L’Informazione, un giornale
emiliano, e tuttora come corrispondente del Fatto Quotidiano. E' così che mi
sono imbattuto in casi di malaffare, speculazioni edilizie, tangenti mascherate
da reti di favori incrociati, rapporti con la criminalità organizzata. Spesso in
queste vicende era coinvolto il centrosinistra. A Serramazzoni, in provincia di
Modena, ho raccontato le prime contiguità acclarate tra ‘ndrangheta e Pd al
nord, proprio nell’Emilia “rossa”. Quando L’Informazione ha chiuso i battenti
nel febbraio 2012 ho sentito Ferruccio Pinotti e insieme abbiamo deciso di
realizzare un libro-inchiesta: oltre ai casi giudiziari che riteniamo cruciali,
abbiamo scavato sui centri nevralgici del “Potere democratico”, studiato
documenti impolverati e inediti, raccolto nuove testimonianze. Man mano che si
componeva il mosaico abbiamo effettuato collegamenti che ci consentono di
analizzare la mutazione antropologica, etica e culturale, del partito erede del
Pci di Berlinguer.»
Il libro si
apre con una serie di frasi di leader del Pd. Frasi che fino ad alcuni anni fa
sembravano possibili da
attribuire solo a politici del centrodestra. In che modo si è
venuta a creare questa mutazione da voi definita “genetica”?
«Questa
mutazione è evidente, la si evince da molti aspetti a partire dalle politiche
economiche. Ormai il Pd, sia nella classe dirigente che si perpetua da un
ventennio sia nel nuovismo di Renzi, ha la stella polare più vicino al mondo
della finanza che non a quello dei lavoratori. La sinistra moderna, non soltanto
per la fusione con gli ex democristiani, ha cambiato visione di società mettendo
in soffitta le prospettive del socialismo europeo e anche quelle keynesiane: per
sommi capi possiamo ricordare che ha privatizzato reti strategiche nazionali,
aperto al precariato con la legge Treu, ha appoggiato guerre della Nato, non si
è prodigata per estendere i diritti civili, ha finanziato le scuole private
invece di rilanciare l'istruzione pubblica e riportare la cultura (senza
scomodare l'egemonia di gramsciana memoria) al centro dell'azione politica,
infine si è allineata alla “dottrina” dell' austerity imposta dall'Europa dei
tecnocrati. In questo contesto ha sdoganato comportamenti come i conflitti
d'interesse – anche propri, non soltanto quello noto di Berlusconi - e le opache
relazioni con il potere economico e bancario tradendo i principi morali e di
giustizia sociale che avevano animato la sinistra del passato.»
La cosiddetta
superiorità morale della sinistra non esiste più?
«Sulla
base delle inchieste giornalistiche condotte in questi anni e del quadro
organico che abbiamo assemblato ci siamo persuasi che, nei fatti, questa
diversità non esiste più.»
La struttura del
vostro libro sembra suggerire che il padre di questa mutazione della sinistra
sia Giorgio Napolitano. È così?
«Napolitano
è un garante dei poteri forti. È il comunista borghese collaterale al Psi di
Craxi e favorevole, già negli anni Ottanta, ai rapporti con Berlusconi. Trovo
significativa una sua frase, pronunciata quando si insediò al ministro degli
Interni nel primo governo di centrosinistra della Seconda Repubblica, nel 1996.
“Non sono venuto qui per aprire gli armadi del Viminale”, disse Napolitano
facendo intendere di non voler indagare sui tanti segreti italiani irrisolti.
Una dichiarazione che è tutta un programma.»
Nel libro viene
citata tra l’altro una fonte anonima che sostiene l’appartenenza di Napolitano
alla massoneria…
«L’appartenenza
di Napolitano alla massoneria non è provata. E’ l’opinione della nostra fonte,
noto avvocato figlio di un esponente del Pci, il quale riconduce le famiglie
Amendola e Napolitano, interpreti della corrente di pensiero partenopea
“comunista e liberale”, alla massoneria atlantica. Anche l'ex gran maestro del
Grande Oriente d’Italia, Giuliano Di Bernardo, ipotizza per il presidente della
Repubblica l'affiliazione ad ambienti massonici atlantici. Ma siamo nell’ambito
delle opinioni. E' invece emerso da un documento datato 1974, l'Executive
Intelligence Review, che Giorgio Amendola, il mentore di Napolitano, era legato
alla Cia. Napolitano fu il primo dirigente comunista ad essere invitato negli
Stati Uniti. Andò in visita negli Usa al posto di Berlinguer, a tenere
conferenze nelle università più prestigiose: proprio nei giorni del rapimento di
Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. Un episodio che chiarisce quanto
Napolitano fosse, sino da allora, il più affidabile per i poteri atlantici e che
spiega almeno in parte la sua ascesa.»
Insomma,
Napolitano grimaldello degli Usa per portare il Pci a posizioni più allineate al
potere atlantico?
«Napolitano
ha saputo muoversi perfettamente. A livello pubblico e ufficiale è sempre stato
fedele al partito, sostenendo la causa di Togliatti persino nella difesa
dell'invasione sovietica di Budapest nel 1956, poi come “ministro degli Esteri”
del Pci. In maniera sommersa ha coltivato relazioni dall'altra parte della
barricata, accreditandosi a più livelli di potere, italiani e internazionali.»
Alla luce di
quello che scrivete nel libro sui rapporti tra Napolitano e Berlusconi ritieni
credibile che tra i due ci fosse stato un accordo su un qualche tipo di
salvacondotto giudiziario per il leader del centrodestra?
«I
rapporti tra Berlusconi e Napolitano vengono da lontano,dai tempi della Milano
da bere, quando la corrente migliorista del Pci spingeva per lo spostamento del
baricentro dalle posizioni di Berlinguer a quelle di Craxi. Il rampante
Berlusconi finanziava il settimanale della corrente migliorista, Il Moderno.
Negli anni Napolitano si è confermato uomo del dialogo nei confronti di
Berlusconi, contro il quale non ha mai espresso posizioni fortemente critiche.
Ha promulgato senza rinvio lodi e leggi ad personam che sono stati poi bocciati
dalla Corte Costituzionale, in queste settimane ha parlato di amnistia proprio
dopo la condanna definitiva di Berlusconi per frode fiscale nel processo
Mediaset.»
Nel libro parlate
anche delle magagne di tutti gli altri attuali leader della sinistra. In
particolare delle amicizie sbagliate, o quantomeno pericolose, di Bersani e
D’Alema. Per quanto riguarda i rapporti di forza sembra venir fuori che D’Alema
è la serie A e Bersani è la serie B. E' così?
«La
frase su serie A e serie B è riferita a una fase del Penati gate. A un certo
punto Di Caterina, prima finanziatore del partito e poi teste d’accusa nel
processo a Penati, fa riferimento a un affare immobiliare senza rilievo penale.
Un affare che vorrebbe Di Caterina ma che si sblocca solo quando palesa il
proprio interessamento la società Milano Pace del salentino Roberto De Santis,
imprenditore che si autodefinisce “fratello minore di D’Alema”. La galassia dei
dalemiani è molto composita e ben presente anche nel campo degli affari. Nel
libro parliamo anche della vicenda di Flavio Fasano, dimenticata dai quotidiani
nazionali. Fasano era il referente di D’Alema nel quartier generale di
Gallipoli: da sindaco gli ha organizzato regate e incontri decisivi come il
pranzo con l'allora segretario del Ppi Rocco Buttiglione che nel 1994 creò le
condizioni per il ribaltone del governo Berlusconi poi affossato dalla Lega di
Bossi. Un uomo di fiducia, insomma. Ecco, nel 2008 si è scoperto che Fasano
aveva rapporti con Rosario Padovano, un boss della Sacra Corona Unita di cui era
stato avvocato anni addietro. Da una telefonata intercettata emerge che Fasano
gli dispensava consigli pochi giorni dopo che Padovano aveva fatto uccidere il
fratello. Non bisogna esagerare definendo Fasano come il “Dell'Utri di D’Alema”
però la vicinanza di un suo fedelissimo ad un capomafia è un fatto poco noto...»
Nel libro
raccontate le vicende di due magistrate, Clementina Forleo e Desirée Digeronimo.
Entrambe, dopo aver lambito D’Alema e Vendola con le loro inchieste su Unipol e
sulla Sanitopoli pugliese, sono state trasferite per “incompatibilità
ambientale”. Questo significa che in alcune procure chi indaga su leader
politici di sinistra viene isolato e punito?
«Di
certo vi è stata una degenerazione, mi riferisco al peso improprio che le
correnti della magistratura hanno assunto in seno ad Anm e Csm, che in alcuni
casi hanno trasferito, punito e isolato i magistrati non allineati. Se da un
lato si è manifestato un atteggiamento demeritocratico e doppiopesista
dall'altro però non si può affermare come fa Berlusconi che siano tutte toghe
rosse o che la magistratura sia eterodiretta dalla politica. Preferisco restare
ai due casi specifici. Quando il Tar ha annullato il provvedimento di
trasferimento della Forleo a Cremona deciso dal Csm, l’Anm ha criticato la
sentenza. Eppure il sindacato delle toghe, ogni volta che Berlusconi attacca i
giudici, ribadisce giustamente che le sentenze vanno rispettate. Nel
procedimento sulla scalata di Unipol a Bnl D’Alema e Latorre potevano essere
indagati per concorso in aggiotaggio, ma nonostante le indicazioni del gip
Forleo sulla base delle loro scottanti telefonate con Consorte i pm di Milano
non lo hanno fatto... Quanto al secondo caso, il sostituto procuratore di Bari
Digeronimo – che ha scoperto il marcio di un sistema sanitario regionale piegato
a interessi partitici e affaristici - è stata attaccata da Vendola
pubblicamente, in stile berlusconiano, senza ricevere appoggio alcuno. Pochi
mesi fa è finita nel mirino del Csm per aver segnalato insieme al collega
Francesco Bretone i rapporti di amicizia tra la sorella di Vendola e Susanna De
Felice, cioè il gup che ha assolto il governatore della Puglia nel processo
relativo alla nomina di un direttore sanitario grazie alla riapertura dei
termini del concorso. Il Csm ha ottenuto il trasferimento della Digeronimo
accusandola di conflittualità con i colleghi, la stessa accusa mossa a suo tempo
alla Forleo: condizioni fisiologiche in ogni ufficio e slegate dall'attività
giurisdizionale.»
Al di là del caso
di Serramazzoni, sembra che l’interesse del Pd riguardo i temi dell’antimafia
sia piuttosto basso. È così?
«È
così e la prova la si è avuta nella scelta dei candidati per le elezioni del
2013. In Calabria sono state escluse sindache antimafia come Caterina Girasole,
Elisabetta Tripodi e Maria Carmela Lanzetta. In Emilia è stato dimenticato
Roberto Adani, ripetutamente minacciato per aver denunciato presenze mafiose e
colletti sporchi. Nando Dalla Chiesa non è stato più ricandidato dal 2006.
Malgrado i proclami elettorali c’è scarsa attenzione su questi temi. In questi
giorni si parla tanto dei “signori delle tessere” e sembra quasi che ci sia una
guerra tra loro e i maggiorenti del Pd. Ma non è così: i “signori delle tessere”
sono stati candidati dai leader nei listini bloccati per una precisa strategia
che ha invece escluso chi ha rischiato la pelle combattendo le cosche.»
Una volta si
pensava che le mafie fossero politicamente orientate a destra. Oggi guardano
anche a sinistra?
«Anche
se la maggioranza di casi riguarda ancora il centrodestra, come abbiamo visto si
registrano le prime collusioni mafiose dei democratici.»
Sinistra e massoni, i parenti segreti.
Un percorso comune da Garibaldi ad Arturo
Labriola. Poi la grande rimozione, scrive Dario Fertilio su “Il Corriere della
Sera”. Un grembiale di «compagno», il secondo grado gerarchico della massoneria,
e una bandiera operaia della «lega tessile»: stessa cazzuola e uguale compasso,
analoga la pala con l'immancabile livella. E poi due donne guerriere che
marciano insieme verso il bel sol dell'avvenire: la prima, a impersonare i
liberi muratori del Grande Oriente, l'altra nei panni della Comune parigina.
Modi diversi, all'italiana o in stile francese, per dire la stessa cosa: la
sinistra, compresa quella di oggi, è figlia della massoneria. O almeno nipote,
benché abbia preferito potare i rami più antichi dell'albero genealogico,
rimuovere le memorie di famiglia e in qualche caso demonizzare l'appartenenza
stessa dei suoi membri alla mitica associazione vincolata dal segreto. Ma oggi
quella legittima discendenza viene riportata alla luce in uno studio imponente
curato per la Einaudi dal filosofo Gian Mario Cazzaniga: il ventunesimo volume
degli Annali della Storia d'Italia è dedicato interamente al mondo - sconosciuto
ai più - delle logge e dei grembiulini, dei cappucci e dei grandi orienti. Sono
quasi novecento le pagine in cui una trentina di studiosi ritraggono il pianeta
oscuro dalle più svariate angolazioni: riti e musica, religione e giardinaggio,
politica e letteratura, mitologia e antiquariato. La stessa classificazione del
soggetto di studio - la massoneria appunto - non è definibile una volta per
tutte: ci sono buone ragioni per inserirla tra le «scienze occulte» ma anche per
considerarla una «religione», senza dimenticare la definizione anglosassone di
«associazione fraterna» né respingere del tutto la collocazione nello scaffale
della spiritualità teosofica, imparentata con la New Age. Poliedrici, dunque, i
saggi contenuti nell'Annale, quanto sfuggente si conferma la materia. Ma certo
la sorpresa viene soprattutto dalla discendenza, individuata e dichiarata, fra
ordine massonico e sinistra politica. Lo riconosce il curatore Gian Mario
Cazzaniga, anche se precisa che «l'affermazione di per sé è parziale. Possiamo
dire che le logge massoniche del Settecento costituirono il laboratorio in cui
si formarono le grandi correnti del pensiero politico contemporaneo:
liberalismo, repubblicanesimo, democrazia cristiana e socialismo». Anche il
partito cattolico? «Certo, perché il momento forse più importante, quello dei
vescovi che presero parte alla Rivoluzione francese, li vide formarsi durante
gli anni precedenti all'interno delle logge massoniche». Ma per quanto riguarda
la sinistra... «Bisogna distinguere i suoi due filoni anarco-repubblicano e
socialista-marxista. Il primo, nel secondo Ottocento, vide la maggior parte dei
suoi esponenti affiliati alle logge; nel secondo ci fu una presenza massonica
importante, a cominciare dai due generi di Marx: Lafargue e Longuet». Gli esempi
italiani non si contano: da Garibaldi ad Arturo Labriola, passando per Andrea
Costa - accostatosi poi al filone socialista di Turati - ma non si possono
trascurare i celebri esponenti anarco-repubblicani Bakunin e Proudhon. «Nel
campo socialista-marxista - osserva Cazzaniga - il settore riformista e la
direzione del movimento sindacale rimasero massonici fino alla prima guerra
mondiale, e anche oggi lo sono molti dirigenti dell'Internazionale socialista,
soprattutto belgi e francesi». Resta da spiegare il perché della grande
rimozione, quasi un ripudio delle radici. «C'è una spiegazione culturale: la
sinistra, nella sua fase più anticlericale, interpretò l'aspetto spirituale del
rito massonico come un vero e proprio cedimento alla religione. Ma ne esiste
anche una politica: la massoneria è sempre stata un momento associativo della
classe dirigente, in tutto l'arco politico. L'accusa del movimento operaio ai
socialisti massoni si concentrò dunque sulla "collusione con il nemico sociale".
Sarà proprio questo l'oggetto della battaglia di Mussolini al congresso
socialista di Ancona del 1914». La parola d' ordine della sinistra, dunque, fu
«nascondere» il proprio passato? O addirittura «reciderlo?». «Nel mondo
socialista sarà soprattutto la parte radicale a prendere le distanze; in quello
comunista a partire dal 1922 ci sarà la dichiarazione di incompatibilità, il
veto alla doppia appartenenza, per le ragioni politiche già dette. Ma anche per
una considerazione di fondo: l'idea totalizzante di un'organizzazione che non
ammette nient'altro al proprio interno». In parte deve avere influito anche
l'alone misterioso dell'associazione segreta, il sospetto verso altre
obbedienze... «Questo è un punto ambiguo. Nel testo della nostra Costituzione, e
nel dibattito che lo precedette, il divieto di associazione segreta è stato
mantenuto volutamente nel vago. Si vollero colpire naturalmente le finalità
militari eversive, ma non si chiarì fino a che punto il diritto associativo
potesse comportare la tutela della privacy degli iscritti. Negli statuti dei
partiti della sinistra, compresi quelli attuali, ci si attiene in maniera
analoga alla lettera della Costituzione, senza precisare a quali associazioni si
applichi il divieto di appartenenza (benché il suo significato implicito sia
antimassonico)». Un problema, riconosce Cazzaniga, che si ripercuote nella
stessa politica culturale della sinistra di oggi: «Il recupero voluto e attuato
di filoni repubblicani e socialisti all'interno del nuovo partito, i Ds,
complica alquanto le cose, dal momento che si tratta di filoni ricchi di apporti
massonici». Insomma, questa sinistra ha ripudiato la madre... «O almeno una
delle sue madri, dal momento che esiste anche quella del socialismo cristiano».
E se dovesse «riabilitare» qualcuno dei «dimenticati», la sinistra di oggi a chi
potrebbe pensare? «C'è una figura emblematica, quella di Sylvain Maréchal. Fu il
comunista utopista e massone che nella congiura di Babeuf del 1796 scrisse il
primo manifesto del comunismo mondiale, come ricordò lo stesso Marx». È
l'Italia, dunque, il Paese in cui la sinistra ha messo in atto la «rimozione»
più pesante? «Certo l' accusa non vale per la Gran Bretagna o il Nord America.
Da noi invece si basa su aspetti molteplici. Il fascismo, obbedendo al suo
totalitarismo organizzativo, perseguitò le logge e impose ai suoi dirigenti di
scegliere fra partito e massoneria. Tra l'altro, un terzo dei membri del Gran
Consiglio era di origini massoniche. Ma anche nel dopoguerra le due grandi
chiese, Dc e Pci, avevano ragioni comuni per diffidare della massoneria e non
volersi misurare con essa. Né i dirigenti delle logge sono riusciti a trovare
una identità culturale adeguata alla società di massa, anche se mi sembra che il
gruppo dirigente attuale si comporti correttamente. Lo testimonia il fatto che,
negli studi umanistici degli ultimi due secoli, il fenomeno sia stato poco
studiato, quasi per un tacito accordo di esclusione. Non parliamo poi della P2:
fu molto peggio che un incidente di percorso, perché un'organizzazione segreta
con finalità politiche è contraria ai principi della massoneria, che sono di
rispetto per le leggi e di non interferenza. E perché un'organizzazione interna
alla massoneria si è imposta ai suoi organi di governo legittimi». Quanto ai
legami internazionali della P2, non sono stati studiati abbastanza e Gian Mario
Cazzaniga ha una sua teoria: «Credo che le chiavi di spiegazione non si trovino
a Washington, ma in gruppi economici latino-americani figli della rete Odessa
(l'organizzazione neonazista che favoriva l'espatrio dei gerarchi). E questo
spiegherebbe certi strani rapporti con reti arabe e tedesche». Nell'Annale si
toccano altri filoni di pensiero, legati all' idea della politica come
«religione moderna». È giusto definire la massoneria del Settecento «madre delle
idee politiche?». E ci fu la Carboneria ottocentesca all' origine dei partiti di
massa? «Certo, e la prima uscita pubblica di questa religione - conferma
Cazzaniga - è stata la rivoluzione americana, diretta da massoni come Washington
e Franklin». Oltre Atlantico nessuno ha mai considerato il segreto incompatibile
con la democrazia... «La massoneria americana è tuttora la più grande del mondo.
In generale, non esistono società in cui il segreto non venga praticato come
legame sociale, cominciando da quelle cattoliche. Anche i club privé, dopotutto,
non possono essere considerati luoghi semi-segreti? E che dire delle riunioni
degli organi dirigenti di partito o dei consigli di amministrazione delle
imprese?». Il curatore Filosofo e militante Gian Mario Cazzaniga, docente di
Filosofia morale all' Università di Pisa e curatore dell'Annale della «Storia
d'Italia» Einaudi su «La massoneria» (pagine XXXII-850, 85), ha una lunga storia
di militanza a sinistra Dirigente studentesco e poi della Cgil-Scuola, ha fatto
parte della sinistra extraparlamentare tra gli anni Sessanta e Settanta.
Iscrittosi al Pci nel 1975, è passato poi al Pds, della cui direzione nazionale
è stato membro fino al 1997, anno in cui si è ritirato dalla politica attiva.
Con il Papa Il difficile confronto Il curatore dell' Annale Einaudi afferma sui
rapporti tra Chiesa e massoneria: «Dopo il Concilio Vaticano II il dialogo ha
avuto applicazioni diverse all' interno dei vari cleri nazionali: più aperto in
Italia e Francia, meno in Germania. La posizione attuale dipende dal fatto che
l'episcopato tedesco attribuisce alla massoneria una coerenza filosofica che non
ha». E sulla posizione di Joseph Ratzinger: «Non cerca uno scontro, ma la
riaffermazione di una identità teologica che ritiene incompatibile con il
pluralismo filosofico della massoneria».
SILVIO E GIORGIO: AFFINITA’ E FRATELLANZA.
Silvio e Giorgio, affinità e "fratellanza"?
Estratto dal libro "I panni sporchi della sinistra" di Ferruccio Pinotti e
Stefano Santachiara (pubblicato per gentile concessione di Chiarelettere).
Il complesso rapporto creatosi nel corso degli anni tra Berlusconi e Napolitano
suggerisce sintonie che spesso vanno oltre la simpatia personale e il reciproco
rispetto che può esistere tra figure che dovrebbero essere radicalmente lontane,
sia per storia intellettuale e professionale sia per schieramento politico. Di
Berlusconi è nota l’appartenenza massonica, che non si manifesta solo nella
documentata affiliazione alla loggia P2 di Licio Gelli, ma anche nel sistema di
simboli che costellano il cosiddetto mausoleo di Arcore, la tomba che il
Cavaliere ha fatto realizzare per sé e per i propri cari dallo scultore Pietro
Cascella. Ma c’è dell’altro. Il discusso leader del Grande Oriente democratico
Gioele Magaldi, noto per le sue dichiarazioni forti, ha affermato in
un’intervista: «Il fratello Silvio Berlusconi, iniziato apprendista “libero
muratore” nel 1978 presso la loggia P2, e diventato successivamente “maestro” in
questa stessa officina, ha proseguito il suo percorso massonico alla corte del
Gran maestro Armando Corona dal 1982 al 1990. Successivamente, ha ritenuto di
farsi una loggia segreta e sopranazionale autonoma. Uno dei nomi utilizzati per
questa officina era “loggia del Drago”». Magaldi rivela: «L’attività massonica
di Berlusconi e Marcello Dell’Utri è stata essenziale per costruire il consenso
sociale e politico che ha condotto alla vittoria elettorale del 1994. Dell’Utri
e altri fratelli della cerchia massonica di Villa San Martino hanno girato la
penisola in lungo e in largo, come proconsoli massonici di Berlusconi,
intessendo accordi con la maggioranza delle logge del Belpaese in favore della
neonata Forza Italia. In anni successivi, le relazioni massoniche
dell’autoproclamatosi Maestro venerabile di Arcore gli hanno consentito di
risollevarsi in momenti di particolare difficoltà». Dalla conversazione con
Magaldi emergono altri dettagli degni di nota: «Più in generale, Berlusconi
coltiva interessi esoterico-iniziatici da molti decenni. La qual cosa da un lato
ha spinto lui e la sua seconda moglie Veronica Lario a iscrivere i propri figli
a scuole di orientamento pedagogico antroposofico (cioè ispirate agli
insegnamenti spirituali esoterizzanti di Rudolf Steiner), dall’altro ha
determinato la sua ferma volontà di percorrere un sentiero massonico, ancorché
riservato e dissimulato pubblicamente. Ma riservato fino a un certo punto: nella
cerchia intima del padrone di Mediaset sono in molti ad aver praticato e a
praticare officine liberomuratorie o a frequentare circuiti di spiritualità
esoterica». Tra questi, secondo Licio Gelli, l’ex governatore del Veneto ed ex
ministro Giancarlo Galan, ex dipendente di Publitalia e poi tra i fondatori di
Forza Italia, che il capo della P2 ha qualificato come massone. Sul «fratello»
Berlusconi, Magaldi ha aggiunto: «Certamente, la sociabilità massonica è servita
– a lui come ad altri – anche a facilitare obiettivi di potere e lucrosi affari,
ma esiste nel “fratello Silvio” una vocazione autentica e genuina verso
discipline esoteriche come l’astrologia, l’ermetismo egizianeggiante e la magia
sessuale». Un’indicazione, quest’ultima, che richiama alcuni «rituali» delle
notti del bunga bunga. È la massoneria che orienta Berlusconi o Berlusconi che
orienta la massoneria? Secondo Magaldi, «nessuna delle due ipotesi. Berlusconi
ha avuto molto, in passato, in termini di supporto e relazioni significative,
dall’ambiente libero-muratorio. Per converso, sono stati proprio alcuni circuiti
massonici sovranazionali a pretendere e a determinare la caduta politica del
“fratello Silvio” nell’autunno del 2011, imponendo il collocamento del
“fratello” Mario Monti a Palazzo Chigi». Un’affermazione forte, che Magaldi non
ha avuto timore di fare assumendosene la responsabilità. Torniamo a Berlusconi,
che ha rinnegato l’esperienza della P2: una volta affiliati si rimane massoni
per tutta la vita? O essere in sonno significa interrompere ogni rapporto con
l’Obbedienza? Secondo Magaldi, «l’iniziazione massonica è indelebile come quella
sacerdotale: essa presuppone, secondo la Weltanschauung massonica, una
trasmutazione esistenziale e spirituale non reversibile. Mettersi in sonno non
significa cessare di far parte della catena iniziatica libero-muratoria, la
quale va persino oltre le singole “comunioni” o “obbedienze” territoriali,
afferendo a una dimensione planetaria e universale. Spesso, il cosiddetto
“assonnamento” equivale soprattutto a una presa di distanza da una determinata
obbedienza, ma può significare l’avvicinamento ad altri cenacoli massonici più o
meno ufficiali». Molto più complesso il discorso che riguarda Napolitano. È
possibile che le sintonie con Berlusconi siano state facilitate da comuni
vicinanze su questo terreno? Secondo Magaldi – che lo ha affermato in numerose
interviste – non vi sono dubbi sul fatto che il presidente della Repubblica sia
un «fratello». Dichiarazioni certamente insufficienti. Abbiamo perciò voluto
approfondire questa pista. E abbiamo incontrato un’autorevole fonte, che ha
chiesto di rimanere anonima: un avvocato di altissimo livello, cassazionista,
consulente delle più alte cariche istituzionali, massone con solidissimi agganci
internazionali in Israele e negli Stati Uniti, figlio di un dirigente del Pci,
massone, e lui stesso molto vicino al Pd. La prima indicazione che ci offre è
interessante: «Già il padre di Giorgio Napolitano è stato un importante massone,
una delle figure più in vista della massoneria partenopea». Avvocato liberale,
poeta e saggista, Giovanni avrebbe trasmesso al figlio Giorgio (notoriamente
legatissimo al padre, che ammirava profondamente) non solo l’amore per i codici
ma anche quello per la «fratellanza». A rafforzare la connotazione «muratoria»
dell’ambiente in cui è nato Giorgio Napoletano c’è un altro massone, amico
fraterno del padre: Giovanni Amendola, padre di Giorgio, storico dirigente del
Pci e figura fondamentale per la crescita intellettuale e politica dell’attuale
presidente della Repubblica. Va detto che l’appartenenza alla massoneria non è
un reato, anzi, molto spesso figure a essa legate sono diventate protagoniste di
rivoluzioni innovatrici e progressiste. Il fatto indiscutibile, però, è che il
legame massonico rappresenta una modalità di gestione del potere di cui poco si
conosce e che è spesso determinante per capire i fatti più recenti della
politica italiana e internazionale. La nostra fonte ha conosciuto bene e conosce
Napolitano, cui si considera molto vicino. «Tutta la storia familiare di
Napolitano è riconducibile all’esperienza massonica partenopea, che ha radici
antiche e si inquadra nell’alveo di quella francese. Per molti aspetti
Napolitano è assimilabile a Mitterrand, che era anche lui massone. Si può
stabilire un parallelismo tra i due: la visione della république è la stessa,
laica ma anche simbolica. L’appartenenza massonica di Napolitano è molto diversa
da quella di Ciampi, fa riferimento a mondi molto più ampi. Ciampi inoltre è un
cattolico. Napolitano si muove in un contesto più vasto.» La massoneria
italiana, dal canto suo, ha sempre espresso grande simpatia verso il presidente
della Repubblica. Il Gran maestro del Grande Oriente d’Italia (Goi), avvocato
Gustavo Raffi, si è rivolto più volte pubblicamente a Napolitano, esprimendo
simpatia e deferenza. Il 10 maggio 2006, dopo l’elezione alla presidenza della
Repubblica, Raffi esultava indicando la scelta di Giorgio Napolitano come «uno
dei momenti più alti nella vita democratica del paese. A nome dei liberi
muratori del Grande Oriente d’Italia e mio personale desidero manifestare
pubblicamente le nostre vivissime felicitazioni». Nel marzo del 2010 Raffi
esprimeva nuovamente a Napolitano «gratitudine per la sua diuturna, appassionata
e tenace difesa dei valori fondanti la nostra Nazione». E il 13 giugno 2010 si
spingeva sino alla soglia di pesanti rivelazioni, rispondendo a una domanda non
casuale di Lucia Annunziata, nella sua trasmissione Rai In mezz’ora: «Il
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, potrebbe essere un massone
sotto il profilo dei valori?» chiedeva Annunziata. Netta la risposta di Raffi:
«A mio avviso sì, per umanità, distacco, intelligenza, per avere levigato la
pietra, per averla sgrezzata, lo dico in linguaggio muratorio, in questo senso
sì». Anche nel 150° anniversario dell’unità d’Italia si registrano convergenze
tra la spinta celebrativa del Colle e i momenti pubblici organizzati dalla
massoneria italiana, artefice forte del Risorgimento. Il 7 gennaio 2011 Raffi
apre le danze dichiarando: «Come ci ricorda con il suo esempio altissimo il capo
dello Stato Giorgio Napolitano, abbiamo il compito di ritrovare fiducia, unità e
coesione nazionale, capacità di risolvere i problemi, insieme a progetti che
indichino la strada al di là di ogni polemica di parte e del cortile degli
interessi».
CHI NON E’ MASSONE DEVIATO, SCAGLI LA PRIMA
PIETRA: MAGISTRATI, POLITICI, MAFIOSI.
NUOVO ORDINE MASSONICO E CONTROLLO DELLA
MAGISTRATURA. Scrive “La Voce di Robin Hood”.
Insieme a noi, lo aveva già inascoltatamente denunciato l'ex Procuratore Capo di
Palmi Agostino Cordova, nel 1992, prima di venire messo a tacere dal Governo
di centro-sinistra di D'Alema, quando gli impedirono militarmente di
sequestrare gli elenchi degli iscritti alla massoneria, presso la sede del
Grande Oriente d'Italia, a Villa Medici del Vascello, a Roma, in cui avremmo
forse trovato i nomi di illustri ministri, alte cariche dello Stato, alte
gerarchie delle Forze di Polizia e dell'Arma dei Carabinieri, alti magistrati,
industriali, oltre ai soliti avvocati, professori universitari, giornalisti,
faccendieri e malavitosi. L'esistenza di questo "nuovo" ordine massonico (che
tanto nuovo non è), capace di controllare la magistratura e l'alternarsi
dei governi di centro-destra e centro-sinistra, viene oggi
autorevolmente riproposta dall'ex P.M. Luigi De Magistris che, negli ultimi
giorni, abbiamo appreso essersi candidato, da indipendente, nell'Italia dei
Valori, dopo le dimissioni dalla magistratura. In molti avrebbero forse
preferito che De Magistris continuasse la sua battaglia all'interno della
magistratura. Altri che fondasse un movimento completamente nuovo, fatto da
persone pulite, fuori dai giochi e dagli schemi tradizionali della politica.
Comunque sia, al di là della scelta personale di lasciare la magistratura e
degli schieramenti politici, come abbiamo sempre sostenuto, noi riponiamo
fiducia nelle singole persone e il nostro giudizio è commisurato sulla base di
ciò che fanno e non di quello che dicono. A nostro avviso, nel triste
palcoscenico della politica, Luigi De Magistris è una persona nuova degna di
tutta la nostra stima, in quanto ha dimostrato grande integrità morale e
determinazione, pagando di persona un alto prezzo per il suo amore verso la Vera
Giustizia. Qui di seguito proponiamo quindi, oltre all'intervista di Klaus
Davi, un intervento firmato di pugno dall'ex P.M. Luigi De Magistris,
rilasciata a Beppe Grillo, riservandoci di proporre nei prossimi giorni
un'esclusiva intervista sui grandi temi dei poteri forti e delle deviazioni del
sistema, rilasciata alla Voce di Robin Hood (N.d.R.). «Per il 60% - 70%
il Piano di Rinascita democratica è stato già applicato, anzi lo stanno
migliorando nella loro ottica, lo stanno rendendo contemporaneo». Queste
le testuali parole di Luigi De Magistris a Klaus Davi per il programma
web Klauscondicio visibile su YouTube. Il magistrato che avviò l'inchiesta "Why
not" aggiunge con tono pacato e non senza preoccupazione: «Ho sempre
pensato che la mia vita fosse in pericolo. Gli altri hanno sempre sottovalutato
questo aspetto ma da anni sono convinto di essere in pericolo». De
Magistris confida poi: «Tengo da sempre un diario, un'abitudine che ho
consolidato negli ultimi anni». Una bozza di appunti per un lavoro che
un giorno avrà altra forma: «Penso che scriverò un libro sul mio diario.
Assolutamente». La mente corre all'agenda di Paolo Borsellino, a quell'annotare
con precisione ogni spesa avuta. Questo per l'agenda blu; della rossa, dopo la
strage, non se ne seppe più niente. «Tenere un diario è un'abitudine sacrosanta
per un magistrato. Io continuo a farlo. Il diario principale ce l'ho in testa,
nel mio cervello. Quelli più importanti li ho consegnati alla procura di
Salerno, quindi la Procura di Salerno è depositaria degli aspetti d'interesse
per la magistratura penale, tutto ciò che interessa la magistratura penale io
l'ho consegnato all'autorità giudiziaria. Per il resto, ho diari che riguardano
riflessioni sulla vita quotidiana di ogni giorno. I miei diari hanno ad oggetto
soprattutto fatti penalmente rilevanti. Poi, all'interno di fatti penalmente
rilevanti, ho descritto anche riflessioni che riguardano comunque aspetti di
gestione illegale della cosa pubblica». Una riflessione non scevra di
considerazioni morali: «Credo che siamo in piena P2 sotto il profilo di
alcuni passaggi, come il controllo della Magistratura. «Constato che chi ha
negli ultimi tempi, non solo io ma anche altri, fatto investigazioni delicate
sul tema delle collusioni interne alle istituzioni e, soprattutto, dove il
collante è stato quello dei poteri occulti, non credo che abbia avuto un grosso
ausilio da parte di chi dovrebbe istituzionalmente stare vicino». Nemmeno
la magistratura, come istituzione democratica è esule da rapporti con la
massoneria. «Il Consiglio Superiore della Magistratura nel passato, se
pur in casi simbolici ed isolati, è intervenuto su magistrati iscritti alla P2.
Però non entrava con il bisturi nel sistema». Licio Gelli, fondatore e capo
della loggia P2 in una recente intervista spiegava che «in Calabria la
massoneria è forte e può darsi che sia infiltrata un pò da tutte le parti, anche
nella magistratura», De Magistris replica: «Se lo certifica Licio Gelli,
allora...». "Insieme ai miei più stretti collaboratori attraverso la
ricostruzione dei finanziamenti pubblici in Calabria, avevamo scoperto, in modo
esattamente preciso, quella che con gergo giornalistico si potrebbe anche
definire la nuova P2". Il riferimento alla loggia massonica di Licio Gelli si
spiega perche' l'indagine Why Not, che gli e' stata tolta un anno fa dalla
procura di Catanzaro, riguardava "la gestione del denaro pubblico e di alcuni
pezzi delle istituzioni attraverso il tramite dei poteri occulti". "Questo -
scandisce il magistrato - è il cuore del problema e non voglio dire altro.
Perchè fatti, nomi, documenti, li ho consegnati". "Non ho fatto un uso mai
particolarmente impegnativo delle intercettazioni telefoniche", assicura De
Magistris che ricorda: "nell'inchiesta Why Not io non ho fatto nemmeno una
intercettazione telefonica. Nell'inchiesta Poseidone ne ho fatte pochissime.
Nell'inchiesta toghe lucane, se non vado errato anche lì non ho fatto nessuna
intercettazione telefonica. Ho utilizzato strumenti investigativi che hanno dato
molto fastidio agli indagati di questi procedimenti. Che si tratta in
particolare degli accertamenti bancari, accertamenti patrimoniali. Traffico dei
flussi telematici e delle tracce, degli incroci telefonici, le sommarie
informazioni testimoniali, l'esame dei documenti. Le indagini tradizionali".
L'ex pm di Catanzaro definisce infine "curiosa" la vicenda dell'archivio Genchi
anche per il fatto che se ne parla proprio a ridosso della riforma delle
intercettazioni. "Sto vedendo - dice - una serie di coincidenze un po' strane".
Alla domanda: che fine faranno le sue indagini De Magistris risponde che va
chiesto alla Procura di Catanzaro e conclude: "La mia testimonianza, i miei
documenti, il mio sapere doveroso l'ho consegnato all'Autorità giudiziaria di
Salerno. Prendo atto che sono stati fermati i magistrati che stavano conducendo
questa indagine".
Consiglio di Stato, quanti massoni ci sono? Si
chiede Alessio Liberati (magistrato) su “Il Fatto
Quotidiano". L’ultimo di cui si è avuta notizia, in ordine di tempo, è
Antonio Maccanico, fratello
massone e contestualmente consigliere di Stato, oltre che segretario generale
della Presidenza della Repubblica (incarico ricoperto peraltro anche da molti
altri consiglieri di Stato, come Gaetano Gifuni, recentemente condannato per
peculato e abuso di ufficio e l’attuale pagatissimo Donato Marra). Ma non è il
solo ad aver indossato il grembiulino. La mia curiosità per i rapporti tra
massoneria e Consiglio di Stato – che ha avuto inizio per caso, quando cioè tre
magistrati appartenenti a tale istituzione (Roberto Giovagnoli, Claudio Contessa
e Raffaele Greco) presentarono un esposto disciplinare nei miei confronti,
lamentando che un mio articolo scientifico, ove facevo tra l’altro affermazioni
tanto generiche quanto banali sulla degenerazione dei
concorso pubblici, non mancando
di citare i condizionamenti da parte della massoneria e dell’Opus
Dei, fosse offensivo nei confronti della giustizia
amministrativa, per profili che non ho mai compreso – ha portato infatti a molti
riscontri, di cui ho già parlato anche in questo blog. Rinvio, in proposito,
oltre che agli elenchi della P2,
ad un mio articolo più in generale sul presidente Pasquale de Lise, ad altro
relativo all’ex consigliere di Stato Carlo Malinconico (oggi agli arresti
domiciliari per gravi fatti corruttivi) ed anche a quanto richiesto in sede di
interrogazione parlamentare dopo una mia denuncia relativa a quanto accertato
nei confronti di uno degli ex presidenti dell’associazione dei consiglieri di
Stato e ad altri magistrati in servizio nella giustizia amministrativa di
appello. Tuttavia, ogni volta che viene fuori il nome di un ulteriore
Consigliere di Stato occultamente appartenente alla massoneria, mi pongo le
stesse domande, che rimangono inevitabilmente senza risposta. Quanti sono i
massoni che indossano
grembiulino e toga da consigliere di Stato? Quanti di questi sono
ricattabili (visto che vige un
divieto espresso per i magistrati amministrativi di appartenere a logge
massoniche) da avvocati o terze persone che ne sono a conoscenza? Perché
l’organo di autogoverno della magistratura amministrativa, da me sollecitato più
volte, si è rifiutato di imporre l’obbligo di una dichiarazione espressa di non
appartenenza a logge massoniche, nonostante molti dei suoi componenti avessero
preso un espresso impegno in tal senso (Luca Cestaro, Umberto Maiello, Antonio
Plaisant, Roberto Pupilella, ecc.), poi disatteso? Non sarebbe ora di
costringere i giudici amministrativi
(le cui decisioni condizionano pesantemente la vita economica di questo Paese) a
rendere pubbliche
queste appartenenze, per evitare anche il solo rischio o sospetto che possano
esservi ricatti a carico di questi magistrati? Non sarebbe l’ora di affrontare
definitivamente, eventualmente in senso positivo, il tema della
compatibilità tra appartenenza
massonica e magistratura, al fine di evitare che si creino appartenenze occulte,
con i rischi sopra descritti? Del tema, emerso nuovamente durante il periodo in
cui era presidente dell’associazione dei consiglieri di Stato Filippo Patroni
Griffi, non si è voluto occupare né quest’ultimo, né il suo successore Roberto
Chieppa, né l’ex presidente Paolo Salvatore, né tanto meno il predetto De Lise.
Speriamo che almeno il nuovo presidente, Giorgio Giovannini, voglia affrontare
il tema, seppur con incomprensibile ritardo…
Massoneria e magistratura.
Tratto dal libro “La massoneria smascherata” di G. Butindaro.
Innanzi tutto va detto che affiliarsi alla Massoneria non è reato, in quanto la
Massoneria non è tra le associazioni segrete proibite dalla Costituzione
italiana con l’articolo 18 (Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare); tuttavia il Consiglio Superiore della Magistratura ha
affermato con chiarezza l’incompatibilità fra affiliazione massonica e
l’esercizio delle funzioni di magistrato, perchè le caratteristiche delle logge
massoniche sono quelle di «un impegno solenne di obbedienza, solidarietà, e
soggezioni a principi e a persone diverse dalla legge» e determinano perciò
«come conseguenza inevitabile una menomazione grave dell’immagine e del
prestigio del magistrato e dell’intero ordine giudiziario» (I magistrati non
possono essere massoni, Corriere della Sera, 17 gennaio 1995, pag. 1); e secondo
la Cassazione, il giudice massone può essere ricusato dall’imputato, in quanto
l’appartenenza a logge preclude «di per sè l’imparzialità» del magistrato (La
Cassazione, 5a sezione penale n° 1563 / 98), in altre parole, perchè – come ha
detto il giudice Alfonso Amatucci – essere iscritti alla massoneria significa
vincolarsi al bene degli adepti, significa fare ad ogni costo un favore. E
l’unico modo nel quale un magistrato può fare un favore è piegandosi ad
interessi individuali nell’emettere sentenze, ordinanze, avvisi di garanzia.
Esistono allora magistrati che sono massoni? Sì. Per esempio ecco cosa si legge
nell’articolo dal titolo E sui magistrati massoni indagherà anche Conso a firma
di Franco Coppola e apparso su La Repubblica il 15 luglio 1993: Smentiscono,
querelano, minacciano fuoco e fiamme. Ma i loro nomi sono lì, negli atti
giudiziari raccolti dalle procure di Palmi e di Torino. Sono le toghe
incappucciate, i magistrati sparsi per il territorio nazionale che hanno giurato
fedeltà alla Costituzione e al credo massonico, qualcuno addirittura aderendo
alle logge segrete, quelle espressamente vietate anche a chi non fa parte
dell’ordine giudiziario. Per ora sono usciti fuori 36 nomi, due o tre dei quali
appartenenti a personaggi ormai in pensione che hanno appeso nell’armadio dei
ricordi le toghe da magistrati ma forse non i grembiulini e i cappucci da
massoni. E così ora di loro si occupano non più soltanto il Consiglio superiore
della magistratura, che può trasferirli d’ufficio ad altra sede o ad altra
funzione, ma anche il ministro della Giustizia Giovanni Conso e il procuratore
generale della Cassazione Vittorio Sgroi che, come titolari dell’azione
disciplinare, possono avviare un procedimento disciplinare, le cui conseguenze
potranno essere, a seconda dei casi, blande o particolarmente severe. Ma nella
magistratura esistono anche avvocati, cancellieri, docenti di materie
giuridiche, ufficiali giudiziari, e così via, che sono affiliati alla
massoneria. Ed ovviamente tutti costoro, in virtù del loro giuramento massonico
(che recita tra le altre cose: …. prometto e giuro di non palesare giammai i
segreti della Libera Massoneria, di non far conoscere ad alcuno ciò che mi verrà
svelato; prometto e giuro di prestare aiuto ed assistenza a tutti i Fratelli
Liberi Muratori sparsi su tutta la superficie della Terra….), devono anche loro
aiutare i loro fratelli massoni, per cui è ovvio che quando un massone si
troverà indagato o imputato in un processo, egli al momento giusto riceverà una
qualche forma di aiuto dai suoi fratelli che sono nella magistratura (o nella
politica) che si muoveranno come sanno fare loro in questi casi. Un esempio di
inchiesta giudiziaria contro dei massoni affossata è quello dell’inchiesta del
procuratore di Palmi Agostino Cordova da lui avviata nel 1992, a cui abbiamo
accennato prima, che dopo che Agostino Cordova fu trasferito-promosso alla
Procura di Napoli nel 1993 e che le indagini vennero trasferite (per
«incompetenza tecnica» della Procura di Palmi a occuparsi della materia) alla
Procura di Roma nel giugno del 1994, rimase pressoché ferma per quasi sei anni,
e poi nel dicembre 2000, il giudice per le indagini preliminari dispose
l’archiviazione dell’inchiesta, nonostante fossero stati raccolti centinaia di
faldoni e tantissime fonti di prova sulle attività illecite di logge italiane
con decine di indagati, coinvolgenti influenti personaggi del mondo
imprenditoriale, finanziario, politico e istituzionale, nonché della stessa
magistratura, collusi con la ‘ndrangheta con cui avevano costituito delle vere e
proprie società di affari, attraverso le quali si spartivano i proventi
derivanti dagli accordi perversi del sodalizio criminale. Per capire la portata
dell’inchiesta di questo coraggioso magistrato consiglio di leggere Oltre la
cupola: massoneria, mafia, politica, scritto da Francesco Forgione e Paolo
Mondani, pubblicato da Rizzoli Editore nel 1994. Un esempio invece di processo
in cui erano imputati dei massoni con evidenti prove di colpevolezza contro di
essi, e che si è concluso con la loro assoluzione, è quello del golpe Borghese.
Il golpe Borghese fu un colpo di Stato tentato in Italia durante la notte tra il
7 e l’8 dicembre 1970 e organizzato e guidato da Junio Valerio Borghese (ex
comandante della X Mas nella repubblica sociale italiana, e leader
dell’organizzazione neofascista Fronte nazionale), allo scopo di impedire
l’accesso del Partito Comunista al governo. Il nome del colpo di stato aveva
come nome in codice Operazione Tora Tora, in ricordo dell’attacco giapponese a
Pearl Harbor del 7 dicembre 1941. Tra i golpisti c’erano oltre che uomini dei
servizi segreti e fascisti, anche massoni e mafiosi. In vista del golpe Borghese
infatti, la Massoneria aveva chiesto l’aiuto di Cosa nostra e della criminalità
organizzata calabrese per averne un appoggio armato. La sera del 7 dicembre
1970, i congiurati – in gran parte armati, e provenienti da varie regioni
d’Italia – si concentrarono nei vari punti prestabiliti della Capitale. Il piano
eversivo prevedeva tra le altre cose, l’uccisione del capo della polizia Angelo
Vicari, e l’irruzione al Quirinale di una squadra di congiurati armati comandati
da Licio Gelli (capo della loggia massonica segreta P2) per sequestrare il
presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Ma ecco che poco dopo la
mezzanotte ai congiurati arriva improvviso il contrordine: l’azione golpista è
sospesa e rinviata. L’inchiesta giudiziaria che ne seguì non riuscirà a chiarire
le circostanze dell’improvviso contrordine impartito ai congiurati. Secondo
alcuni, la sospensione del golpe è da attribuire alla defezione di un importante
personaggio che avrebbe reso impossibile l’attuazione dell’aspetto strategico
del golpe. Secondo altri, il golpe non fu attuato, benchè avallato dagli USA, a
causa dell’imprevista presenza della flotta russa nel Mediterraneo la notte tra
il 7 e l’8 dicembre. Comunque il tentato golpe ci fu. In merito al procedimento
giudiziario e il processo che si tenne contro coloro che furono coinvolti nel
Golpe Borghese, ecco cosa dice il senatore Sergio Flamigni, che ha fatto parte
della Commissione Parlamentare sulla Loggia P2: ‘Nel procedimento giudiziario
scaturito dal «golpe Borghese» risulteranno coinvolti piduisti di primo piano:
il generale Vito Miceli, promosso capo del Sid per intervento di Licio Gelli
presso il ministro della Difesa Mario Tanassi (il cui segretario particolare,
Bruno Palmiotti, e il cui fratello, Vittorio Tanassi, sono affiliati alla Loggia
segreta); Giuseppe Lo Vecchio, colonnello dell’Aeronautica; Giuseppe Casero,
ufficiale dell’Aeronautica; Giovanni Torrisi, ufficiale di Marina;
Giovambattista Palumbo, Franco Picchiotti e Antonio Calabrese, ufficiali dei
Carabinieri; Giuseppe Santovito, ufficiale dell’Esercito; il banchiere Michele
Sindona; l’alto magistrato Carmelo Spagnuolo; il consigliere regionale
andreottiano Filippo De Jorio (consigliere di Andreotti a Palazzo Chigi anche
dopo il suo coinvolgimento nel tentato golpe). Tutti costoro risulteranno
affiliati alla Loggia P2 nel gruppo Centrale, cioè in diretto collegamento con
Gelli. Nella «Operazione Tora Tora» risulteranno coinvolti anche altri massoni,
tra i quali: Duilio Fanali (capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, che nel
tentato golpe aveva il compito di insediarsi nel ministero della Difesa e
impartire ordini a tutto l’apparato militare); il costruttore romano Remo
Orlandini; Sandro Saccucci (deputato nelle liste del Msi, nel 1972, per
avvalersi dell’immunità parlamentare); Salvatore Drago (ufficiale medico della
Polizia, fedelissimo del piduista Federico Umberto D’Amato); Gavino Matta e
Tommaso Rook Adami (massoni appartenenti alla Comunione di Piazza del Gesù);
Giacomo Micalizio. [....] Benchè nella «Operazione Tora Tora» abbia avuto un
ruolo centrale, Licio Gelli non viene coinvolto nel processo seguito al «golpe
Borghese». Il Venerabile gode infatti di particolari coperture e di ferree
protezioni. Nel luglio 1974, nello studio privato del ministro della Difesa
Giulio Andreotti, si tiene una riunione alla quale partecipano, oltre al
ministro: il nuovo capo del Sid ammiraglio Mario Casardi il comandante dei
Carabinieri generale Enrico Mino, il capo dell’ufficio D del Sid generale
Gianadelio Maletti (piduista), e gli ufficiali del Sid colonnello Sandro
Romagnoli e capitano Antonio Labruna (piduista). Oggetto della riunione è un
dossier compilato dai Servizi sul «golpe Borghese», da inviare alla
magistratura. Il dossier giunto al ministro Andreotti è già stato sottoposto a
numerosi tagli; infatti il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio
Eugenio Henke, ha disposto la cancellazione di ogni riferimento ad alcuni
collaboratori del Sid. Ma a questo punto è Andreotti che suggerisce a Maletti di
«sfrondare il malloppo e di eliminare i dati non riscontrabili». Così dal
rapporto scompare il nome di Gelli [....]. Il processo per il «golpe Borghese»,
celebrato presso il Tribunale di Roma, consentirà di accertare una serie di
gravissimi fatti. Ma tutti gli imputati piduisti, anche grazie al sotterraneo
attivismo di Licio Gelli, verranno assolti. [....]. I gravissimi fatti culminati
nel tentato golpe della notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970 subiranno in fasi
processuale un inopinato ridimensionamento. Benchè si sia trattato di un preciso
piano eversivo sostenuto da ampi settori dei vertici militari in collegamento
con gruppi armati di civili ramificati in tutto il Paese, a conoscenza dei
comandi Nato e con la partecipazione di Cosa nostra e della ‘ndrangheta
calabrese, nel corso dei vari gradi di giudizio il processo si risolverà in un
progressivo insabbiamento, tra proscioglimenti e archiviazioni, fino alla
generale assoluzione degli imputati superstiti da parte della Corte di
Cassazione. [....] Le sentenze della Corte di assise di Roma del 14 novembre
1978 e della Corte di assise d’appello del 27 novembre 1984, affermando
l’insussistenza del delitto di insurrezione armata, predisporranno la Corte di
cassazione a trasformare il tentato golpe in un semplice «complotto di
pensionati», e ad assolvere tutti gli imputati. Molti anni dopo, il giudice
istruttore del Tribunale di Milano Guido Salvini scriverà infatti che «una vasta
e continuativa trama golpista, corroborata sul piano probatorio anche da
numerosi elementi documentati, [è stata] così ridotta ai progetti velleitari di
qualche anziano Ufficiale nostalgico e di poche Guardie forestali. Certamente
non è stato così». Il giudice citerà una serie di documenti e testimonianze,
prove di un’ampia articolazione eversiva di forze: alti ufficiali delle Forze
armate e Massoneria, P2 e servizi segreti, mafia siciliana e ‘ndrangheta
calabrese, strutture clandestine di militari e civili e gruppi della destra
eversiva e neofascista, con sullo sfondo i comandi della Nato (Sergio Flamigni,
Trame Atlantiche, Kaos Edizioni, Seconda Edizione 2005, pag. 45-46, 48, 50,
53,54). A conferma che anche nella magistratura si muove la mano della
Massoneria vi propongo una parte di un interessante scritto dal titolo
«Fratellanza giuridica». I magistrati e la massoneria a cura di Solange
Manfredi, pubblicato sul blog di Paolo Franceschetti il 20 luglio 2010, che
credo renda bene l’idea di questo intreccio, che spiega il perchè certe indagini
che coinvolgono massoni vengono ostacolate o affossate, e dei processi contro
esponenti della massoneria finiscono con l’assoluzione degli imputati. [....].
Quando mio padre (avvocato) morì, 15 anni fa, nella cassaforte di casa trovai,
insieme al suo tesserino di affiliazione alla massoneria, centinaia di documenti
massonici. Tra questi rinvenni un piccolo libricino rilegato che riportava in
copertina: “Fratellanza Giuridica” Statuto. Appena ne lessi il contenuto rimasi
sconvolta, come sconvolti sono rimasti avvocati e giudici (non massoni
ovviamente) a cui l’ho mostrato. L’esistenza di uno Statuto che, all’interno
delle varie logge (e quindi tra massoni già vincolati dal giuramento di
silenzio, assistenza ed aiuto reciproci e dal divieto di denunciare un fratello
al Tribunale profano), univa in una “più fraterna collaborazione” avvocati –
cancellieri – docenti di materie giuridiche – dottori commercialisti –
magistrati – notai – ragionieri ed ufficiali giudiziari, in altri termini tutti
i tasselli “sensibili” di un Tribunale, era sconvolgente. Un legame così stretto
tra i protagonisti delle vicende giudiziarie si prestava veramente a deviazioni
infinite. Il fatto, poi, che gli elenchi di questa “Fratellanza Giuridica”
fossero a disposizione dei massoni iscritti alle varie logge italiane poteva
rendere ogni Tribunale raggiungibile da qualsiasi fratello in cerca di aiuto
massonico.
Nessun rischio a chiedere un “aiutino”: il massone infatti ha giurato sia di
aiutare sia di non denunciare mai un fratello al Tribunale profano. Non a caso
ogni scandalo che ha riguardato magistrati e massoni è sempre stato originato
dalla scoperta di documenti durante una perquisizione o, come in questo caso, da
intercettazioni telefoniche; ma mai in nessun caso un’indagine ha avuto origine
dalla denuncia di un fratello verso un altro fratello. Se all’interno della
stessa loggia, della stessa cittadina, si ritrovano regolarmente per studiare,
lavorare, o altro… avvocati, cancellieri, magistrati e ufficiali giudiziari, si
sa, l’occasione fa l’uomo ladro. La frequentazione, l’amicizia, ma, soprattutto,
il giuramento di reciproco aiuto ed assistenza, fanno sì che in queste “logge”
possa scattare la richiesta di “aiutino”. In fondo, per insabbiare un processo,
per depistare, per creare confusione, basta poco: una notifica sbagliata, un
fascicolo sparito, una nullità non rilevata, ecc.. piccoli errorini, idonei a
deviare il corso di un processo; ma errorini per cui in Italia non si rischia
assolutamente nulla. Certo si parla di possibilità, non è detto che accada però,
come già sottolineato, l’occasione fa l’uomo ladro. Proprio per questo i
magistrati ed avvocati più attenti a livello deontologico (non vi preoccupate, è
una razza ormai quasi estinta) evitano le frequentazioni con avvocati almeno
dello stesso foro in cui esercitano. Il motivo di tale comportamento è chiaro (o
dovrebbe esserlo) il giudizio del magistrato, per non lasciare adito ad alcun
dubbio, deve essere il più possibile scevro da condizionamenti di qualunque
genere. Chi frequenta i Tribunali, invece, spesso si trova a dover costatare
comportamenti ben diversi, e si può incappare in situazioni in cui avvocati e
magistrati dello stesso foro dividono l’affitto di una garconier con cui andare
con le rispettive amanti. Sarà, dunque, forse un caso che più di 7 processi su
dieci saltano per notifiche sbagliate? Sarà forse un caso che spesso le indagini
o processi che vedono coinvolti massoni hanno un iter burrascoso con avocazioni
di indagine (Why not, Toghe Lucane), trasferimenti di sede (Piazza Fontana,
Golpe Sogno, Scandalo loggia P2) od altro? Probabilmente si, non vogliamo in
alcun modo pensar male anche se, come diceva Andreotti, a pensar male si fa
peccato ma, raramente, si sbaglia. Trascrivo qui il contenuto dello Statuto
rinvenuto tra i documenti di mio padre. Ovviamente, e per estrema correttezza,
avverto il lettore che non posso assicurare che detto statuto sia vero, ma, dati
i rapporti che intratteneva mio padre (avvocato), ciò che mi aveva detto
riguardo i magistrati che frequentavano regolarmente la nostra casa e il fatto
di averlo rinvenuto all’interno di una cassaforte insieme a centinaia di
documenti giuridici firmati da “fratelli”, mi fa propendere per il si. Se così
fosse parrebbero esistere “Fratellanze” costituite esclusivamente da magistrati,
avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari, professori universitari, ecc.. le
cui “deviazioni” potrebbero condizionare il sistema giudiziario ostacolando il
corso di processi importanti.
"FRATELLANZA GIURIDICA. I magistrati e la
massoneria. Di Solange Manfredi.
1. Premessa.
Da qualche giorno i giornali riportano la notizia di una inchiesta romana su una
associazione a delinquere, denominata nuova loggia P3, che vedrebbe coinvolti
politici, faccendieri, criminalità organizzata, e magistrati. I magistrati
coinvolti sono persone ai vertici della magistratura, ex Presidenti dell’A.N.M.,
ex Consiglieri del C.S.M. , avvocati generali della Cassazione, ovvero:
- il dr Arcibaldo Miller, Capo degli Ispettori
del Ministero della Giustizia e membro dell’A.N.M;
- il dr Antonio Martone, ex Presidente
dell’A.N.M., ex Avvocato Generale della Corte Suprema di Cassazione ed
oggi capo di una Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche;
- il Sottosegretario di Stato Giacomo
Caliendo, ex Consigliere del C.S.M ed ex Presidente dell’A.N.M;
- il Presidente della Corte di Appello di
Salerno Umberto Marconi, consigliere del CSM ed ex membro dell’ANM;
- il Presidente della Corte di Appello di
Milano Alfonso Marra;
- il Primo Presidente della Corte Suprema di
Cassazione Vincenzo Carbone.
Niente di nuovo, l’intreccio in odor di massoneria
tra magistratura e potere c’è sempre stato. Solo per fare un esempio, da più di
un anno si sta celebrando, nel più assoluto silenzio, un processo sulla
compravendita di sentenze in Cassazione che, visto il coinvolgimento di
personaggi legati dal vincolo massonico, è stato denominato Hiram (figura
allegorica della massoneria, nonchè nome della rivista ufficiale del Grande
Oriente d’Italia). Ed ancora l’intreccio tra magistratura e potere massonico (di
oggi e di ieri) è ben evidenziato nel libro di Gioaccino Genchi “Gioacchino
Genchi. Storia di un uomo in balia dello Stato”. Per non parlare degli
scandali che negli anni ’80 e ’90 videro coinvolti magistrati iscritti alla
loggia P2. Ma, a questo punto, una domanda sorge spontanea: perché nella maggior
parte degli scandali che vede coinvolti magistrati compare sempre anche la
massoneria? Come fanno i massoni a poter sempre contattare il magistrato giusto
al momento giusto?
2. La "Fratellanza Giuridica".
La risposta non è semplice ma forse, in questa sede, si può aggiungere un dato
che potrebbe essere importante per capire gli intrecci di “certo” potere. Quando
mio padre (avvocato) morì, 15 anni fa, nella cassaforte di casa trovai, insieme
al suo tesserino di affiliazione alla massoneria, centinaia di documenti
massonici. Tra questi rinvenni un piccolo libricino rilegato che riportava in
copertina:
“Fratellanza Giuridica" Statuto. Appena ne
lessi il contenuto rimasi sconvolta, come sconvolti sono rimasti avvocati e
giudici (non massoni ovviamente) a cui l’ho mostrato. L'esistenza di uno Statuto
che, all’interno delle varie logge (e quindi tra massoni già vincolati dal
giuramento di silenzio, assistenza ed aiuto reciproci e dal divieto di
denunciare un fratello al Tribunale profano), univa in una “più fraterna
collaborazione” avvocati – cancellieri – docenti di
materie giuridiche – dottori commercialisti – magistrati – notai –
ragionieri ed ufficiali giudiziari, in altri termini tutti i tasselli
“sensibili” di un Tribunale, era sconvolgente. Un legame così stretto tra i
protagonisti delle vicende giudiziarie si prestava veramente a deviazioni
infinite. Il fatto, poi, che gli elenchi di questa “Fratellanza Giuridica”
fossero a disposizione dei massoni iscritti alle varie logge italiane poteva
rendere ogni Tribunale raggiungibile da qualsiasi fratello in cerca di aiuto
massonico. Nessun rischio a chiedere un “aiutino”: il massone infatti ha giurato
sia di aiutare sia di non denunciare mai un fratello al Tribunale profano. Non a
caso ogni scandalo che ha riguardato magistrati e massoni è sempre stato
originato dalla scoperta di documenti durante una perquisizione o, come in
questo caso, da intercettazioni telefoniche; ma mai in nessun caso un'indagine
ha avuto origine dalla denuncia di un fratello verso un altro fratello. Se
all'interno della stessa loggia, della stessa cittadina, si ritrovano
regolarmente per studiare, lavorare, o altro... avvocati, cancellieri,
magistrati e ufficiali giudiziari, si sa, l'occasione fa l'uomo ladro. La
frequentazione, l'amicizia, ma, soprattutto, il giuramento di reciproco aiuto ed
assistenza, fanno sì che in queste "logge" possa scattare la richiesta di
“aiutino”. In fondo, per insabbiare un processo, per depistare, per creare
confusione, basta poco: una notifica sbagliata, un fascicolo sparito, una
nullità non rilevata, ecc.. piccoli errorini, idonei a deviare il corso di un
processo; ma errorini per cui in Italia non si rischia assolutamente nulla.
Certo si parla di possibilità, non è detto che accada però, come già
sottolineato, l'occasione fa l'uomo ladro. Proprio per questo i magistrati ed
avvocati più attenti a livello deontologico (non vi preoccupate, è una razza
ormai quasi estinta) evitano le frequentazioni con avvocati almeno dello stesso
foro in cui esercitano. Il motivo di tale comportamento è chiaro (o dovrebbe
esserlo) il giudizio del magistrato, per non lasciare adito ad alcun dubbio,
deve essere il più possibile scevro da condizionamenti di qualunque genere. Chi
frequenta i Tribunali, invece, spesso si trova a dover costatare comportamenti
ben diversi, e si può incappare in situazioni in cui avvocati e magistrati dello
stesso foro dividono l'affitto di una garconier con cui andare con le rispettive
amanti. Sarà, dunque, forse un caso che più di 7 processi su dieci saltano per
notifiche sbagliate? Sarà forse un caso che spesso le indagini o processi che
vedono coinvolti massoni hanno un iter burrascoso con avocazioni di indagine
(Why not, Toghe Lucane), trasferimenti di sede (Piazza Fontana, Golpe Sogno,
Scandalo loggia P2) od altro? Probabilmente si, non vogliamo in alcun modo
pensar male anche se, come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato ma,
raramente, si sbaglia.
3. Lo Statuto.
Trascrivo qui il contenuto dello Statuto rinvenuto tra i documenti di mio padre.
Ovviamente, e per estrema correttezza, avverto il lettore che non posso
assicurare che detto statuto sia vero, ma, dati i rapporti che intratteneva mio
padre (avvocato), ciò che mi aveva detto riguardo i magistrati che frequentavano
regolarmente la nostra casa e il fatto di averlo rinvenuto all’interno di una
cassaforte insieme a centinaia di documenti giuridici firmati da “fratelli”, mi
fa propendere per il si. Se così fosse parrebbero esistere "Fratellanze"
costituite esclusivamente da magistrati, avvocati, cancellieri, ufficiali
giudiziari, professori universitari, ecc.. le cui "deviazioni" potrebbero
condizionare il sistema giudiziario ostacolando il corso di processi importanti.
A.G.D.G.A.D.U.
GRAN LOGGIA NAZIONALE
DEI LIBERI MURATORI D’ITALIA
“GRANDE ORIENTE D’ITALIA”
*
STATUTO
DELLA “FRATELLANZA GIURIDICA”
(Approvato a Roma, il 21 settembre 1968)
1. La
Fratellanza Giuridica è costituita da Fratelli attivi e quotalizzanti nelle
rispettive Logge della Comunione italiana, appartenenti alle seguenti categorie
professionali, e che ne facciano domanda: avvocati e procuratori legali
–cancellieri – docenti di materie giuridiche – dottori commercialisti –
magistrati – notai – ragionieri – ufficiali giudiziari.
2. La
Fratellanza Giuridica ha come principali finalità:
a) Dare, quando richiestane, pareri giuridici al
Grande Oriente o ai vari Organi massonici, attraverso la Gran Segreteria;
b) Promuovere lo studio dei problemi interessanti
i vari aspetti del diritto, internazionale e nazionale, e quelli delle singole
categorie iscritte alla Fratellanza;
c) Consentire una più fraterna collaborazione,
nell’ambito di ciascuna categoria, per l’esercizio dell’attività degli iscritti;
d) Indicare nominativi di difensori d’ufficio, se
richiestane dai Tribunali massonici;
e) Curare la raccolta della giurisprudenza delle
decisioni degli organi giudiziari massonici, anche comparata con l’opera
giudiziaria delle altre Comunioni regolari;
f) Studiare ed approfondire ogni altra questione
attinente all’esercizio professionale degli iscritti, nel rispetto delle leggi e
delle tradizioni massoniche.
3. La
Fratellanza Giuridica ha sede presso il suo Presidente effettivo. Essa può
essere sciolta in qualunque momento, o per decisione del Gran Maestro, previo il
parere favorevole del Consiglio dell’Ordine, o per decisione dell’Assemblea
degli iscritti. Le elezioni e le decisioni dei vari Organi della Fratellanza
Giuridica sono valide a maggioranza semplice ed impegnano anche gli assenti e,
per il caso di scioglimento, con il voto favorevole di almeno due terzi degli
iscritti. Le cariche non sono rinunciabili ed impegnano gli eletti sino a quando
non siano accettate eventuali loro dimissioni, da inoltrarsi al Consiglio
Direttivo.
4. Sono Organi
della Fratellanza Giuridica:
a) L’Assemblea degli iscritti;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) L’Ufficio di Presidenza;
d) Ufficio di Segreteria e Tesoreria.
5. L’Assemblea
degli iscritti è convocata dall’Ufficio di presidenza almeno una volta l’anno,
entro il 31 marzo, o quando appaia opportuno, ovvero quando gliene faccia
richiesta la maggioranza semplice del Consiglio Direttivo oppure almeno un
quinto degli iscritti. Alla Assemblea sono demandate tutte le decisioni comunque
riguardanti la Fratellanza Giuridica, anche nelle materie di spettanza dei
singoli Organi.
6. Il Consiglio
Direttivo è composto dai Delegati circoscrizionali, che durano in carica tre
anni e sono rieleggibili. I Delegati circoscrizionali vengono eletti, anche
mediante schede inviate per posta, dagli iscritti alla Fratellanza Giuridica,
nell’ambito delle circoscrizioni regionali massoniche. Il Consiglio Direttivo si
riunisce per convocazione dell’Ufficio di Presidenza, almeno due volte l’anno,
ovvero quando ne faccia richiesta, allo stesso Ufficio di Presidenza, almeno un
terzo dei suoi membri.
7. Le riunioni
del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi
componenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
8. Ciascun
delegato circoscrizionale deve promuovere riunioni di iscritti, iniziative e
attività varie, nell’ambito della propria circoscrizione, in armonia con le
leggi massoniche, con le finalità della Fratellanza Giuridica, con le
deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
9. L’Ufficio di
Presidenza è composto:
a) Dal Gran Maestro;
b) Dal presidente effettivo, che viene eletto dal
Consiglio Direttivo;
c) Da un Vice-Presidente.
Al Presidente effettivo (o, in caso di suo
impedimento o assenza, al Vice-Presidente) spettano la rappresentanza, la
direzione, le decisioni di ordinaria amministrazione della Fratellanza
Giuridica.
10. L’Ufficio
di Segreteria è composto:
a) Dal Gran Segretario;
b) Da un Segretario o da un Vice-Segretario,
nominati dal Consiglio Direttivo, ai quali spetta la tenuta degli schedari, dei
verbali, della corrispondenza della Fratellanza Giuridica. L’Ufficio di
Segreteria effettua il controllo annuale della regolare appartenenza alle Logge
della Comunione di tutti gli iscritti della Fratellanza. Il Segretario o il
Vice-Segretario possono essere eletti anche al di fuori del Consiglio Direttivo,
nel qual caso vi partecipano senza diritto di voto.
11. Il
Tesoriere è nominato da Presidente effettivo, anche non fra i Delegati
circoscrizionali, nel qual caso partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto
di voto. Il Tesoriere cura l’amministrazione, la contabilità, la riscossione
delle quote e degli eventuali contributi volontari, e quant’altro attiene alla
economia della Fratellanza Giuridica. Il Tesoriere redige, entro il 31 dicembre
di ciascun anno il bilancio consuntivo degli incassi e delle spese, ed un
bilancio preventivo per l’anno successivo, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea.
12. Per far
fronte alle spese di organizzazione e funzionamento della Fratellanza Giuridica,
tutti gli iscritti devono versare una quota annuale.
13. Entro il 31
maggio di ciascun anno il Consiglio Direttivo:
a) Predispone ed approva bilanci consuntivi e
preventivi redatti dal Tesoriere da sottoporre all’Assemblea;
b) Fissa l’ammontare della quota annuale
obbligatoria a carico degli iscritti;
c) Redige una relazione morale sull’attività
compiuta nell’anno precedente che, se approvata dall’Assemblea, viene inviata
alla Gran Maestranza;
d) Delibera la destinazione delle somme pervenute
per contributi volontari dai vari iscritti.
14. Ogni
notizia relativa agli elenchi degli iscritti potrà essere chiesta e fornita dai
rispettivi Delegati circoscrizionali, a ciascuno dei quali tali elenchi verranno
consegnati, ovvero, in mancanza, dall’Ufficio di Segreteria.
15. Il presente
Statuto potrà essere modificato con delibera di almeno un terzo degli iscritti,
i Assemblea.
16. E’
demandata al Consiglio Direttivo la formulazione del regolamento di attuazione
del presente Statuto.
Note: 1. come rivela una sentenza a sezioni
unite del Tribunale massonico del 28/X/1978, per il principio n. 1 Cap. IV degli
Antichi Doveri” il massone anche se a conoscenza di un reato non può neanche
minacciare di denunciare un fratello a quello che viene definito “Tribunale
Profano”, ovvero l’organo giudiziario previsto dalla Costituzione italiana, pena
l'immediata espulsione dalla loggia.
Carte riservate on line, massoneria in
tribunale. Il caso del
«muratore» allontanato dalla loggia per aver diffuso notizie sui «fratelli» e i
boss, scrive Valeria Di Corrado su “Il Tempo”. Espulso
dal Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani «per averne leso l’immagine,
l’onore e la reputazione», attraverso la pubblicazione su internet «in modo
accessibile ai profani» di un articolo di denuncia sulle infiltrazioni della
’ndrangheta nella massoneria. Amerigo Minnicelli, iscritto dal 1991 alla loggia
di Rossano intitolata all’eroe dei «Mille» Luigi Minnicelli (suo antenato), ha
impugnato il provvedimento di espulsione davanti al Tribunale di Roma,
chiedendone l’immediata sospensione in via cautelare, per potersi candidare alla
carica di Gran Maestro alle elezioni fissate per il 2 marzo 2014. I giudici
della terza sezione civile, lunedì scorso, hanno rigettato il reclamo e
Minnicelli è rimasto tagliato fuori dalla tornata elettorale. A decretarne la
radiazione dalla più antica comunione massonica italiana, costituita nel lontano
1805, sono stati gli organi di disciplina interna. Il primo provvedimento è
stato emesso dal «Tribunale circoscrizionale della Calabria» il 5 aprile 2012 e
poi confermato, in secondo grado, dalla «Corte centrale del Grande Oriente
d'Italia» il 3 ottobre dello stesso anno. L’oratore (omologo del nostro pm)
incolpa Minnicelli di «un’implicita accusa di omessa vigilanza verso i Maestri
Venerabili». L'articolo «incriminato» viene pubblicato sul sito web «Goiseven»
(di cui Minnicelli è direttore) pochi giorni dopo l’arresto, avvenuto il 29
luglio 2011, del massone Domenico Macrì, iscritto presso la loggia di Città di
Castello. Secondo la Procura Macrì avrebbe concorso, come intermediario d’affari
della Banca di Credito Sanmarinese, al riciclaggio di circa 15 milioni di euro
proventi del narcotraffico della cosca calabrese dei Mancuso di Limbadi.
Minnicelli prende spunto da questo fatto di cronaca per riportare su internet la
frase che gli era stata riferita da «un fratello tra i migliori calabresi» nel
corso di una riunione della primavera del 2010. «Siamo seduti su un braciere
ardente - spiega nel suo articolo - significava dire che nei pie' di lista delle
logge vicine ai territori 'ndranghetisti sarebbe entrato di tutto e di più». Nel
passaggio successivo, Minnicelli rimprovera i vertici della massoneria, a
partire dal Gran Maestro Gustavo Raffi, di inerzia nell’osteggiare l’ingresso di
persone legate ai clan. Il massone espulso si è appellato al diritto di critica,
ma secondo l'organo di giustizia interno non doveva «esternarla su un sito web
accessibile ai fratelli compagni e apprendisti e soprattutto ai profani». «Gli
estranei non massoni non devono essere posti nelle condizioni di conoscere le
vicende attinenti la vista associativa», hanno confermato i giudici ordinari.
«L'obbligo alla riservatezza riguarda i lavori in Loggia - precisa l'avvocato
Carlo Paduano, legale di Minnicelli - Altrimenti la massoneria dovrebbe essere
considerata un'associazione segreta».
Filippo Facci su “Libero Quotidiano”: "Quel pm
intralcia le indagini". L’inchiesta Expo è una faida. Ora c'è anche una nota di
Edmondo Bruti Liberati,
inviata al Csm, secondo la quale il procuratore
Alfredo Robledo avrebbe «determinato un reiterato
intralcio alle indagini» su Expo; l'invio di atti al Csm fatto da Robledo,
inoltre, avrebbe «posto a grave rischio il segreto delle stesse». In altre
parole, la miglior difesa è l’attacco: Bruti Liberati contrattacca alle accuse
di Robledo d’aver fatto assegnazioni anomale o sospette e aggiunge peraltro un
carico da novanta: perché intralciare un’indagine sarebbe anche un reato. È
difficile credere che Bruti Liberati voglia incolpare penalmente il suo
sostituto, ma quel che è certo è che a Milano gli stracci volano sul serio: ed è
tutta colpa del caso Expo. Il fascicolo è seguito dai pm anticorruzione
Claudio Gittardi e
Antonio D'Alessio, ed è noto
che Bruti Liberati, durante la conferenza stampa sugli arresti per Expo, aveva
già precisato che Robledo non ne aveva condiviso le conclusioni: ora aggiunge
che avrebbe addirittura intralciato l’inchiesta. Bruti Liberati, nella sua nota
al Csm, cita anche l’episodio di un doppio pedinamento: «Robledo, pur essendo
costantemente informato del fatto che era in corso un’attività di pedinamento e
controllo su uno degli indagati svolta da personale della polizia giudiziaria,
ha disposto analogo servizio delegando ad altra struttura della stessa Guardia
di Finanza», ha scritto il procuratore capo, spiegando poi che «solo la
reciproca conoscenza del personale Gdf che si è incontrato sul terreno ha
consentito di evitare gravi danni alle indagini». Nei fatti, il low profile
della procura di Milano è definitivamente turbato. Lo scontro oltretutto divide
i magistrati. Da una parte il procuratore aggiunto anticorruzione Alfredo
Robledo, l’anarchico, dall’altra il procuratore capo di quel granducato
giudiziario che negli anni ha scosso il Paese con sue inchieste, Edmondo Bruti
Liberati, personaggio più - diciamo così - militante. Intanto il Csm sta
continuando con le audizioni dei magistrati chiamati in causa: si discute di
presunte anomalie nelle assegnazioni, ritardi di iscrizioni nel registro degli
indagati, soprattutto tensioni che covavano da almeno tre anni. Robledo sostiene
che è stata ritardata l’iscrizione di politici come
Roberto Formigoni e
Guido Podestà, che l’azione
penale è stata gravemente ritardata nel caso Sea-Gamberale (il fascicolo era
stato dimenticato in cassaforte, ha ammesso Bruti Liberati) e questo senza
parlare del chiassoso caso Ruby, laddove il fascicolo era curiosamente finito al
dipartimento antimafia guidato da Ilda
Boccassini. Su quest’episodio c’era stata anche l’ammissione,
resa nota nei giorni scorsi, di Ferdinando Pomarici, ex responsabile della Dda
di Milano: quell’assegnazione fu «anomala», ha detto. Il magistrato ha pure
spiegato che scrisse a Bruti Liberati tutte le sue perplessità a proposito, poi
ribadite durante una riunione. Pomarici ha anche segnalato un’anomalia legata al
caso di Alessandro Sallusti,
il direttore del Giornale già condannato al carcere per diffamazione:
secondo Pomarici, Edmondo Bruti Liberati voleva che si facesse una deroga
personalizzata per il direttore. La circostanza peraltro era già stata ammessa
dal procuratore aggiunto Nunzia Gatto,
responsabile dell’Ufficio esecuzione della Procura. Insomma, tutto rispecchia le
storiche divisioni della procura, sinora sottaciute: gli uomini del procuratore
capo - storicamente più legati a Magistratura democratica - contro gli altri. Va
da sé che secondo Francesco Greco,
responsabile del pool sui reati finanziari e legato a Bruti, nell’iscrizione di
Formigoni non ci fu «nessun ritardo». Nessuna irregolarità neanche nel
caso Ruby, ha spiegato anche
Ilda Boccassini (vedi Libero di ieri). Più in generale, lo scontro tra il
procuratore capo e il suo aggiunto è molto più interessante dei resoconti che i
giornali si sforzano di darne; sull’esito dell’esposto di Robledo contro Bruti
Liberati non c’è da attendersi chissà che cosa: stiamo pur sempre parlando di un
magistrato contro un altro magistrato, giudicato da altri magistrati. Pare più
interessante, leggendo gli atti del Csm, il differenziato profilo che si
intravede. Bruti Liberati uomo d’apparato, di corrente, politicizzato, sensibile
agli scenari politici e ai suoi cambiamenti, alle conseguenze delle inchieste
che nascono dai suoi uffici: dunque un abile amministratore. Robledo, invece,
più compiaciuto della propria indipendenza sancita dalla Costituzione, più
immediato, automatico, quasi precipitoso, convinto che una certa ruvidità faccia
parte dei suoi doveri e ufficialmente indifferente alle conseguenze delle sue
indagini. È difficile essere più diretti senza prendere la solita querela: ma
piacerebbe dire che entrambi i profili, se portati all’eccesso, descrivono alla
perfezione il periglioso archetipo del magistrato all’italiana. Sin troppo
responsabile e «politico» il primo, sin troppo anarchico il secondo. Quello che
rimane identico, sempre leggendo gli atti del Csm, è lo scenario enormemente
discrezionale nel quale i due paiono muoversi all’interno della procura: non
quel tappeto di regole inflessibili e rigide che il cittadino magari s’aspetta
(perché il magistrato è soggetto soltanto alla legge, si dice) bensì un
groviglio gommoso di dipartimenti, mezzi dipartimenti, non-dipartimenti,
assegnazioni, coassegnazioni, non assegnazioni, iscrizioni, non iscrizioni, in
generale una discrezionalità dell’azione penale ben travestita. Un potere
smisurato, in altre parole, che si può esercitare in un modo o nell’altro: e
capita che non sempre i magistrati si trovino d’accordo.
Lo scontro tra Robledo, Bruti Liberati e la
Boccassini e la guerra nascosta dentro il Csm, scrive “Libero Quotidiano”. La
battaglia campale all'interno della Procura di Milano, con lo scambio di accuse
tra il procuratore aggiunto Alfredo
Robledo e il procuratore capo
Edmondo Bruti Liberati, è solo
la punta dell'iceberg di quanto sta accadendo all'interno della magistratura
italiana. Robledo lamenta favoritismi nell'assegnazione di processi-manifesto,
dal Rubygate all'ultima inchiesta sull'Expo, che sono finiti indebitamente (è
l'accusa) a Ilda Boccassini
e Francesco Greco.
Secondo Bruti, al contrario, sarebbe stato Robledo ad intralciare le inchieste,
coordinando doppi pedinamenti ai sospettati. Un pasticciaccio finito davanti al
Consiglio superiore della magistratura,
mentre l'Anm ha parlato
di "grave rischio di delegittimazione" e la stessa Procura milanese, per bocca
di molti funzionari, teme una "normalizzazione" della propria attività. Perché
in gioco è in realtà il "potere" in mano al pool coordinato da Bruti. E, come ha
sottolineato sul Foglio il cronista giudiziario Franck Cimini, gli
equilibri stessi nel Csm, cioè l'autogoverno delle toghe italiane. Da qui a
luglio, infatti, i magistrati sono in campagna elettorale. Il
6 e 7 luglio 2014 si rinnoverà
la composizione del loro massimo organo e la corrente di sinistra
Magistratura democratica, di
cui Bruti Liberati è uno storico esponente, potrebbe dopo molti anni non avere
rappresentanti tra i 16 "togati". Le "primarie" per palazzo dei Marescialli,
infatti, sono state vinte da
Magistratura indipendente e il "peso politico" del Csm potrebbe
essere clamorosamente girato verso l'ala moderata. Il massimo esponente di MI, Cosimo
Ferri, è tra l'altro sottosegretario alla Giustizia del governo
Renzi. E dentro MD molti sperano che il Parlamento, a trazione renziana, possa
"riequilibrare" nominando elementi "laici" vicini alla sinistra. Giustizia e
politica, l'intreccio continua.
A Milano la mafia non esiste. Ci sono singole
famiglie mafiose ma la mafia non esiste”. Con questa dichiarazione l’ex Prefetto
di Milano, Gian Valerio Lombardi, apriva l’audizione della Commissione
parlamentare antimafia riunitasi dopo anni di assenza a Milano, il 22 gennaio
2010, per un summit di tre giorni in vista dell’Expo 2015, dei suoi cantieri e
di un allarme legato alle infiltrazioni della ‘ndrangheta denunciato nei giorni
precedenti dall’allora ministro dell’Interno Roberto Maroni e dal capo della
polizia Antonio Manganelli, scrive Domenico Corrado. Il commento aveva provocato
scandalo nel Pd, che aveva parlato di “vergogna”, e nel sindaco Letizia Moratti,
la quale dopo avere dichiarato che “se come è vero che gli emissari delle cosche
calabresi a Milano vivono e lucrano”, precisava tuttavia la sua estraneità
nell’affossamento della commissione comunale antimafia voluta dall’opposizione
per monitorare il grande evento. Dall’entourage del prefetto di Milano, il
giorno successivo, arrivava la garanzia che non era in discussione l’ammettere
la presenza delle organizzazioni criminali, “quanto il loro modo di agire. Un
agire da intendersi più imprenditoriale (appoggi in luoghi di potere, scalate a
società, accumulo di ditte soprattutto dell’edilizia) che esecutivo-criminale”.
La dichiarazione del prefetto oltre ad avere reso evidente la sottovalutazione
del fenomeno, soprattutto in vista della grande quantità di denaro pubblico che
verrà stanziato per l’Expo, ha fatto emergere un ritardo culturale, che a
distanza di tre anni si può dire oggi, forse, ormai colmato, che pensa che
l’Italia della mafia sia solo il meridione. Perché la ‘ndrangheta non ha patria
e si muove silenziosamente all’ombra del grande business laddove esiste la
possibilità di ricavare enormi profitti, e, nonostante abbia sempre cercato di
mantenere un profilo criminale basso – perché gli affari illeciti nel silenzio
si svolgono con più tranquillità – ha dimostrato di possedere un apparato
militare efficiente in grado di piegare qualsiasi resistenza, e che, talvolta,
ha perfino goduto del favoreggiamento di uomini delle forze dell’ordine, come
nel caso dell’ex carabiniere della caserma di Rho, in provincia di Milano,
Michele Berlingeri, condannato a tredici anni e mezzo in seguito alla maxi
operazione Infinito del 13 luglio 2010 contro la ‘ndrangheta in
Lombardia. E infatti la storia della ‘ndrangheta nella regione ha un lungo
corso, che inizia negli anni Cinquanta con i primi malavitosi calabresi mandati
al confino nel nord Italia, e che arriva fino ai giorni nostri, dove ha
acquisito un potere tale da potersi infiltrare in ogni attività economica e
istituzionale rappresentando, spesso, l’avanguardia del capitalismo italiano. La
prima generazione della malavita calabrese crebbe e si sviluppò all’ombra dei
piccoli centri periferici come Buccinasco, San Donato Milanese e San Giuliano
Milanese, mischiandosi con la massa di compaesani partiti alla volta del nord in
cerca di lavoro e fortuna. L’incontro fra queste due realtà diede alla malavita
la possibilità di ‘organizzare il territorio’ attraverso la mentalità e gli
stessi costumi della natia Calabria, riuscendo, così, per mezzo della paura e
dell’intimidazione, a creare una rete sociale spesso connivente. Il primo boss
operante in Lombardia fu Giacomo Zagari. Nativo di San Ferdinando, nella piana
di Gioia Tauro, si trasferì a Gallarate, in provincia di Varese, alla metà degli
anni Cinquanta, diventando presto il punto di riferimento di tutti gli uomini
delle ‘ndrine che giungevano in Lombardia, e boss indiscusso del Varesotto. A
quei tempi gli introiti dei boss venivano ricavati essenzialmente dal pizzo,
ossia dall’estorsione di denaro nei confronti di piccoli e grandi imprenditori.
Questa pratica, fin dagli esordi, dimostrava la dualità del suo scopo: da una
parte il fine economico e finanziario, e dall’altro quello politico-militare
legato al controllo del territorio. Ma siamo ancora lontani dal periodo in cui
la ‘ndrangheta, attraverso la sua forza di persuasione finanziaria e militare,
riusciva a insinuarsi nel tessuto politico ed economico della regione più ricca
e produttiva del Paese, fino a minarne le basi democratiche. Infatti bisognerà
attendere la metà degli anni Settanta e la stagione dei sequestri per vedere
emergere gli ‘uomini nuovi’ che faranno compiere un salto di qualità alla
politica criminale della ‘ndrangheta in Lombardia. Ad aprire la stagione dei
sequestri ci aveva pensato Cosa nostra con il primo rapimento, quello
dell’imprenditore Piero Torielli, prelevato a Vigevano, in provincia di Pavia,
il 18 dicembre 1972, da un commando diretto da Luciano Leggio, e che si concluse
con il pagamento di un riscatto di un miliardo e mezzo di lire. Da quel momento
Milano e la Lombardia si trasformano in una miniera d’oro per tutti i gruppi di
sequestratori, che in dieci anni misero a segno decine di sequestri di persona,
alcuni finiti tragicamente con la morte del rapito. I rappresentanti calabresi
di quella stagione furono i Pesce, i Mazzaferro, i Barbaro, i Paviglianiti, i
Morabito, i Papalia e i Sergi, federati in un patto di alleanza e ideatori del
sequestro di Cesare Casella, l’alleanza Coco Trovato-Flachi e i De Stefano.
Attraverso i sequestri di persona la ‘ndrangheta iniziava ad affinare
l’organizzazione – poiché per gestire un rapimento è necessaria una efficiente
base logistica e un controllo capillare sul territorio in cui si opera – e ad
arricchirsi, allargando cosi il business criminale verso nuovi e più ampi
orizzonti, quello del narcotraffico di eroina e cocaina. All’inizio degli anni
Ottanta, con l’aggressione sovietica dell’Afghanistan, il Paese produttore del
95% dell’oppio del mondo, l’Europa – e quindi anche l’Italia – veniva sommersa
di eroina a buon prezzo, il cui traffico arricchì i cartelli siciliani e
calabresi ridefinendo la cartina tornasole della criminalità organizzata nel
nord Italia. Come per la stagione dei sequestri anche nel business del
narcotraffico i ‘calabresi’ iniziarono al traino delle famiglie siciliane.
Appoggiandosi prima al cartello Ciulla-Uguccione, e successivamente ai Fidanzati
e ai Carollo, i quali negli anni Ottanta detenevano il controllo del mercato
dell’eroina, la ‘ndrangheta riuscì presto a scalzare il ruolo predominante di
Cosa nostra: “I calabresi si misero in proprio molto rapidamente, iniziarono a
trattare con i turchi, che hanno basisti a Milano a cui far arrivare i carichi
di eroina. Cosa nostra, che deteneva il monopolio, non riuscì ad arrestare la
crescita dei calabresi e cosi tentò la via diplomatica, che fu al tempo stesso
un riconoscimento del nuovo status raggiunto dalla ‘ndrangheta”. Da quanto
venuto a galla dalle dichiarazioni rilasciate da Michel Amandini nel merito
dell’inchiesta Nord – Sud condotta nel febbraio del 1994 dal pm di
Milano Alberto Nobili, tra il 1986 e il 1989 si svolsero due summit, uno a
Torino e uno a Milano, coordinati dal boss di Catania Nitto Santapaola e
finalizzati all’elaborazione di una strategia d’azione comune per i clan
siciliani e calabresi operanti in Lombardia e in Piemonte, e che si conclusero
con la regolamentazione delle rispettive zone di influenza e con il
riconoscimento della preminenza della ‘ndrangheta in Lombardia: “Rocco Papalia
mi disse di aver preso parte insieme al fratello Antonio a due summit nei quali
si sarebbe arrivati a una sorta di pax mafiosa o comunque di regolamentazione
delle più importanti organizzazioni criminali [...]. Al summit presero parte
rappresentanti siciliani, calabresi e napoletani. Grazie al Santapaola si decise
una sorta di accordo generale in virtù del quale ogni gruppo criminale avrebbe
operato nelle sue zone d’influenza senza guerre o tentativi di espansione [...]
ai calabresi, era lasciata la supremazia di fatto in Lombardia e il Papalia
Antonio venne indicato come personaggio di primo piano. In caso di contrasti o
conflitti l’ultima e decisiva parola sarebbe spettata proprio ad Antonio
Papalia”. Il processo si concluse nel 1997 con dure condanne che portarono alla
decimazione dei vertici delle famiglie siciliane dei Carollo, dei Ciulla e dei
Fidanzati, e delle famiglie calabresi dei Papalia, dei Sergi, dei Morabito, dei
Coco-Trovato e dei Pavagliniti. Tuttavia, i calabresi riuscirono a mantenere il
controllo delle posizioni raggiunte a discapito di Cosa nostra, la quale in quel
periodo si trovava fortemente indebolita dal fenomeno del pentitismo che nel
1993 avrebbe portato all’arresto di nomi eccellenti come Totò Riina e Nitto
Santapaola: “Ma quel colpo si rivelerà mortale solo per Cosa nostra, già provata
in Sicilia dallo sfaldamento dovuto al fenomeno del pentitismo che in quegli
anni porta in galera centinaia di affiliati sia tra i boss, come Totò Riina e
Nitto Santapaola, che tra i semplici picciotti. Così a Milano, il centro
nevralgico degli affari, Cosa nostra non ha abbastanza soldati sul campo per
mantenere una posizione di rilievo nel traffico di stupefacenti. Il problema
invece non si pone nemmeno per le ‘ndrine, che grazie alle seconde generazioni
prenderanno definitivamente in mano il mercato della droga a Milano e anche nel
resto del nord Italia”. Alla fine degli anni Novanta, dunque, la ‘ndrangheta si
trova, senza concorrenti, a intraprendere i primi passi verso la creazione di
quella rete di alleanze criminali internazionali che l’avrebbe portata, ai
giorni nostri, a dominare in modo incontrastato il mercato della cocaina, e ad
avere a disposizione una grossa massa di capitali da reinvestire in attività
economiche e finanziarie diversificate e da utilizzare come strumento di
persuasione per influenzare la vita politica. Nel tempo, la ‘ndrangheta è
riuscita a creare una rete imprenditoriale che può vantare ramificazioni che
vanno dal business dell’edilizia alle imprese di movimento terra fino alla
fornitura di materiale edile, dalla gestione di imprese ludiche come discoteche,
ristoranti, pub e sale da bingo al controllo della distribuzione del cibo – come
emerso dalle indagini della procura meneghina sulle infiltrazioni della
‘ndrangheta nell’Ortomercato di Milano, che il 2 agosto 2008 hanno portato alla
condanna di Salvatore Morabito e Antonino Palamara – fino alle attività
finanziarie illecite in cui “una grossa massa di liquidità è reinvestita in
strutture societarie o in beni immobili attraverso un’accorta attività di
riciclaggio, realizzata ricorrendo all’esterovestizione mediante l’intervento di
società fiduciarie con Paesi offshore”. Senza esagerazioni, si può dire che
all’alba del nuovo millennio la ‘ndrangheta sia diventata ‘l’impresa’ più
florida del Paese, che vanta ramificazioni criminali internazionali e una
disponibilità di capitali illimitata, capace di spostare tonnellate di cocaina e
di raggiungere milioni di consumatori attraverso il controllo su una fitta e
diversificata rete economica e commerciale. Un’organizzazione criminale
efficiente e spietata, che agli strumenti offerti dalla modernità affianca
elementi arcaici di una mentalità basata sull’onore e sull’omertà, rendendola,
come l’hanno definita Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, la mafia più potente del
mondo. Alla luce degli avvenimenti che hanno portato alla conquista di quella
che era definita la capitale morale d’Italia non stupisce affatto, quindi, il
grande interesse dimostrato dalle ‘ndrine verso l’evento che porterà Milano a
essere al centro del mondo: l’Esposizione universale del 2015, che secondo le
stime dovrebbe ospitare 36 milioni di visitatori e porterà ricavi pari a 1.311
milioni di euro. Come è affiorato dall’inchiesta coordinata dalle Dda di Milano
e di Reggio Calabria in seguito alla maxi operazione Infinito scattata il 13
luglio 2010 e che ha portato a 400 arresti, 160 dei quali in Lombardia, i clan
calabresi avrebbero tentato di infiltrarsi negli appalti per Expo 2015
attraverso la Perego General Contractor. L’azienda edile, formalmente di
proprietà di Ivano Perego, era concretamente manovrata dalle mani di Salvatore
Strangio – Strangio e Perego sono stati anche loro incarcerati in seguito
all’operazione Infinito – che gestiva le infiltrazioni delle imprese calabresi
nell’ambito dei lavori pubblici, e che intendeva assorbire nel gruppo Perego
alcune importanti aziende lombarde del settore edile che versavano in condizione
di difficoltà economiche, allo scopo di costruire apposite attività di impresa
in grado di partecipare direttamente all’affidamento degli appalti. Il piano non
andò in porto nonostante l’appoggio politico di Antonio Oliviero, ex assessore
della giunta provinciale di Filippo Penati passato poi nelle fila del nuovo
presidente, Guido Podestà, indagato e poi rinviato a giudizio per corruzione e
truffa aggravata e per i suoi rapporti con la Perego General Contractor. Nel
capitolo dell’ordinanza di custodia cautelare dedicato a Oliviero, il gip
Giuseppe Gennari ha indicato l’ex assessore come “il capitale sociale della
‘ndrangheta, la persona giusta per le operazioni di lobby e per mettere a frutto
quella rete di relazioni istituzionali e politiche di cui si nutre
l’organizzazione criminale [...] e il cui ruolo appare evidente e di non
trascurabile importanza all’interno dei contatti politico istituzionali che
interessano le vicende della Perego”. Secondo il gip, Oliviero progettava
conquiste e appalti, si vantava di fare parte di una squadra, e rivelava la
stoffa del cinico e del trasformista che vuole conservare a tutti i costi la
poltrona e il suo asservimento agli interessi privati e criminali: “Il politico,
con sovrano cinismo, dice a Perego di non esporsi troppo con Podestà perché poi
magari rivince Penati e lui ancora quattro contatti li ha. Oliviero promette a
Perego di aprirgli tutte le strade. Dice che loro sono una squadra dove Oliviero
è il capo. Parole di questo genere, dette da chi si candida a ricoprire ruoli
istituzionali e di amministrazione della cosa pubblica, non possono che
preoccupare. E preoccupano perché rivelano l’asservimento totale dell’uomo
pubblico a interessi privati. Vogliamo dire che Oliviero poteva non sapere che
Perego avesse la ‘ndrangheta a casa? Ebbene, Oliviero non è raggiunto da
richiesta di custodia cautelare, [...] tuttavia è evidente che sono questi
momenti patologici, di osmosi tra attività istituzionali e interessi
particolari, che rappresentano la via di ingresso della criminalità organizzata
– che già controlla i colletti bianchi – nel mondo economico e politico”. Il
caso Perego ha portato alla luce i legami esistenti tra imprenditoria,
‘ndrangheta e politica istituzionale, e ha messo in evidenza come ormai sia
difficile tracciare una linea di demarcazione tra l’azione dei rappresentanti
dello Stato che dovrebbero operare nella legalità e nell’interesse collettivo, e
quella della criminalità organizzata, in quanto l’intreccio d’interessi
politico-criminali, la zona grigia dove si incontrano gli interessi su cui è
meglio non indagare, sembra ormai essere diventata sistemica, come è stato
dimostrato dall’ultima inchiesta della procura di Milano che ha portato alla
carcerazione di Domenico Zambetti, ex assessore del Pdl alla Regione Lombardia,
per corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa. Dall’inchiesta è
emerso che Zambetti pagò la ‘ndrangheta per ricevere un pacchetto di voti che
gli garantisse l’elezione nel Consiglio regionale lombardo, poi avvenuta
puntualmente. Voti pagati in contanti, a caro prezzo, circa 50 euro l’uno, che
sono costati complessivamente 200 mila euro, versati ai clan in varie rate. A
incassarli, secondo l’accusa, Giuseppe D’Agostino, gestore di locali notturni,
già condannato negli anni scorsi per traffico di droga, appartenente al clan
Morabito-Bruzzaniti, e l’imprenditore Eugenio Costantino, il referente del clan
Mancuso. Insomma, un intreccio di affari sporchi dove mafiosi, politici e
faccendieri si confondono fino a diventare una cosa sola, e anche laddove esiste
una sorta di volontà di resistere alle lusinghe della via mafiosa, alla
fine, spesso, vince la paura o l’omertà, come nel caso di Marco Tizzoni,
coinvolto in una compravendita di voti – non andata in porto – avvenuta alle
elezioni amministrative di Rho del 2011. Marco Tizzoni, leader della lista
civica ‘Gente di Rho’, fu avvicinato da Marco Scalambra, finito agli arresti il
10 ottobre 2012 assieme a Domenico Zambetti, con la scusa di essere il compagno
di ballo di una candidata nella sua lista, Monica Culicchi, che gli propose i
voti della lobby calabrese che Tizzoni rifiutò senza però denunciare
l’accaduto alla magistratura. Mafia, politica e mondo degli affari all’ombra
dell’Expo 2015. Con l’operazione Infinito sono venute a galla le mire dei clan
nei confronti del grande evento e la connivenza di politici disposti a tutto pur
di arricchirsi e mantenere la posizione raggiunta. Nicola Gratteri ne conta ben
tredici di politici lombardi in rapporti più o meno stretti con la ‘ndrangheta.
E dice di più: “Questi politici hanno ricevuto i voti delle cosche”. Accuse
gravi che trovano parziale conferma nelle carte, non però negli avvisi si
garanzia o nelle sentenze. Al di là di tutto, degli sviluppi che seguiranno dai
processi e dalle indagini in corso, con l’operazione Infinito è emerso un dato
inequivocabile che non può essere ignorato neanche dai più ostinati scettici: la
Mafia a Milano esiste.
Tangenti Expo, "così dieci imprese della
cupola volevano spartirsi la Città della salute". In
un rapporto della Finanza si parla di un "accordo preliminare" sul grande polo
sanitario milanese che dovrebbe sorgere a Sesto San Giovanni. E di una coop
legata a Greganti che lavorò sulla Piastra, scrive “La Repubblica”. Dieci
imprese, "pressoché" tutte in rapporti con i componenti della cosiddetta 'cupola
degli appalti' finiti in carcere nei
giorni scorsi, si sarebbero mosse per aggiudicarsi il
maxi-appalto da 323 milioni di euro per
il progetto Città della salute,
una delle gare, assieme a quelle dell'Expo e ad altre nella sanità lombarda, al
centro dell' inchiesta coordinata dai pm milanesi Claudio Gittardi e Antonio
D'Alessio. E' quanto emerge da un'informativa della guardia di finanza in cui
viene riportata anche una mail ricevuta dall'ex funzionario pci Primo Greganti e
che conteneva un "accordo preliminare" fra le società interessate ai lavori per
quel grande polo sanitario, ancora da realizzare e che dovrebbe sorgere a Sesto
San Giovanni, alle porte di Milano. E la cupola sarebbe riuscita a inserirsi
anche nei lavori per la cosiddetta Piastra dell'Expo, l'appalto più rilevante
aggiudicato per 149 milioni di euro e giunto ormai a oltre il 50 per cento di
realizzazione. A quell'infrastruttura, che è la piattaforma di base su cui si
sviluppa il sito espositivo, avrebbe lavorato - stando ai nuovi particolari che
emergono dalle carte dell'inchiesta - anche una cooperativa legata a Greganti.
Ovvero quel Compagno G che, secondo un'intercettazione, governava "le coop
rosse" come un "martello" e che avrebbe stipulato addirittura un contratto, con
tanto di "provvigioni", con il colosso delle costruzioni del mondo cooperativo:
la Cmc di Ravenna.Sul fronte Città della salute, il messaggio di posta
elettronica, come scrive la Finanza, sarebbe stato inviato al 'Compagno G' l'11
aprile del 2013 da Lorenzo Beretta, un responsabile di Olicar, gruppo che si
occupa di servizi per l'energia. Nella mail veniva indicato come oggetto "Città
della Salute e della Ricerca-Sesto San Giovanni" ed era allegato "un file"
denominato "Sesto San Giovanni accordo preliminare", che in precedenza sarebbe
stato girato, secondo gli inquirenti, dall'imprenditore vicentino Enrico
Maltauro (ora in carcere) allo stesso Beretta. Il file conteneva "la bozza di
una scrittura privata tra i seguenti soggetti: Impresa Costruzioni Giuseppe
Maltauro spa; Cons. Naz. Coop di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Scpa; Cefla
S.C; Prisma Impianti spa; Gemmo Spa; Manutencoop Facility Management spa;
Servizi Ospedalieri spa; Olicar; Vivenda spa; Sotraf". Era una bozza con
l'indicazione della "costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese"
per partecipare alla gara. Nel gruppo di imprese, sempre secondo la guardia di
finanza, doveva essere inserita in vista dei lavori anche la cooperativa
Viridia, che sarebbe stata legata a Greganti, tanto che la 'Ciro Menotti'
dichiarava nella scrittura privata di "intervenire per conto della propria
consorziata Viridia". Le società "interessate al raggruppamento temporaneo di
imprese", segnala la Finanza, erano "pressocché" tutte collegate con il
"sodalizio Frigerio-Cattozzo-Greganti-Grillo". Fra l'altro i presunti legami di
Greganti con i manager della Olicar sono documentati anche da molte altre
intercettazioni, tra cui una dello scorso 14 febbraio: intercettazione che
dimostrerebbe ancora una volta l'abitudine del Compagno G, che fu il collettore
delle tangenti rosse ai tempi di Tangentopoli, di frequentare i palazzi del
potere dopo l'ormai nota telefonata in cui diceva che stava uscendo da una
riunione in Senato. "Adesso sono in assessorato al Comune di Torino", spiegava
l'ex funzionario del Pci a Paolo Fusaro, amministratore delegato di Olicar,
aggiungendo che sarebbe arrivato a Milano per le 11 col treno e puntuale
all'appuntamento in un albergo. Molto attivo per l'affare Città della salute era
anche Gianni Rodighero, indagato e ritenuto il braccio destro dell'ex dc
Gianstefano Frigerio. Fu Rodighero il 20 febbraio scorso, stando ad
un'informativa della guardia di finanza, a ricevere una telefonata da Danilo
Bernardi, manager Manutencoop che voleva "fissare un appuntamento" con Frigerio
per discutere la "questione dei reciproci oneri di ricerca delle protezioni
politiche" per l'appalto Città della salute. Tornando alla Piastra, invece, un
altro appalto dell'Expo, dunque, diverso da quelli già venuti a galla
dall'inchiesta (tra cui la gara per le architetture di servizi), potrebbe aver
subito i condizionamenti delle presunta associazione per delinquere che aveva in
prima linea, oltre a Greganti, anche Frigerio e l'ex senatore Luigi Grillo
(Forza Italia). Grillo che, secondo quanto diceva in una telefonata Sergio
Cattozzo, ex esponente dell'Udc e presunto corriere delle tangenti, avrebbe
avuto "consolidate aderenze" e "rapporti diretti" anche "con Lupi", ministro
delle Infrastrutture e dei trasporti. Intercettazione questa, come molte altre
nelle quali la "squadra" fa nomi di politici, che gli inquirenti valutano con
cautela perché potrebbe trattarsi di millanterie. E' in un'informativa della
guardia di finanza, invece, che compaiono una serie di intercettazioni nelle
quali il 'Compagno G' parla con Fernando Turri, rappresentante legale di
Viridia, coop di Settimo Torinese attiva dal '92 e che opera in vari settori,
delle costruzioni alla produzione di energia. I finanzieri scrivono che Viridia
assume rilevanza con riferimento a buona parte delle vicende attenzionate" dai
pm Gittardi e D'Alessio: la società era interessata anche "alla realizzazione
della Città della salute" e "agli appalti" di Sogin. E soprattutto, pur "non
essendo palesemente ricompresa nel raggruppamento di imprese", capeggiato dalla
Mantovani Spa, che vinse l'appalto per la 'Piastra' (appalto citato anche nelle
carte dell'inchiesta
che a marzo 2014 ha portato in carcere
l'ex direttore generale di
Infrastrutture Lombarde, Antonio Rognoni), Viridia ha "svolto
dei lavori nel sito di Expo 2015, verosimilmente in qualità di consorziata del
Consorzio Veneto Cooperativo". Il responsabile di Viridia, poi, sempre secondo
la Finanza, "avrebbe partecipato" anche ad almeno due incontri con Greganti e
Angelo Paris, l'allora manager di Expo 2015 spa - uno del 20 dicembre 2013 e un
altro del 29 gennaio 2014 - per discutere sulla realizzazione dei padiglioni.
Greganti, scriveva Paris in un sms, "è uno che governa le coop rosse, che al
momento performano male su Expo... E quindi lui è il martello che le fa rigare".
E questi stretti collegamenti tra l'ex funzionario del Pci e le coop sembrano
acquistare anche maggior peso con il ritrovamento, da parte della guardia di
finanza, del testo di un "accordo di partnership sottoscritto da Seinco En-ri
srl", società riconducibile a Greganti, con la Cmc di Ravenna, che fra l'altro
costruirà il padiglione della Francia per l'Expo (oltre a essersi già
aggiudicata l'appalto per la rimozione delle interferenze). Il 14 febbraio
scorso, spiegano gli inquirenti, Greganti inviò una mail a Dario Foschini,
amministratore delegato di Cmc, contenente il testo di un contratto che
riconosceva "sostanzialmente da parte di Cmc un concorso in spese di ufficio per
sei mesi e, soprattutto, una provvigione sulle attività e progetti frutto del
presente accordo che (...) non potrà essere inferiore all'1 per cento del valore
delle operazioni portate a buon fine". E per l'inizio della prossima settimana
sono fissati due interrogatori decisivi per lo sviluppo delle indagini: lunedì i
pm sentiranno Paris e martedì Cattozzo, l'uomo della presunta "contabilità delle
mazzette".
Sergio Cattozzo, l'ex esponente dell'Udc ligure,
aveva in casa un dossier costituito da molti documenti su cui avrebbe appuntato
in maniera ordinata numeri, date e nomi. Contabilità che si aggiunge quindi al
biglietto che Cattozzo ha cercato di nascondere ai finanzieri che erano andati
ad arrestarlo o 0.3 o lo 0.5% sul valore degli appalti, scrive
Il Fatto Quotidiano. Non solo un post-it, ma un vero e proprio
archivio cartaceo. Sergio Cattozzo,
l’ex esponente dell?Udc ligure e corriere delle tangenti versate alla “cupola
degli appalti”, secondo la Procura di Milano, aveva in casa un
dossier costituito da molti documenti cartacei su cui avrebbe appuntato in
maniera ordinata numeri, date e nomi,
ossia una presunta contabilità delle
mazzette. Contabilità che si aggiunge quindi al biglietto che
Cattozzo ha cercato di nascondere ai finanzieri che erano andati ad arrestarlo.
Dopo un primo interrogatorio Cattozzo, che intercettato al telefono
con Frigerio sosteneva che i pubblici ufficiali andavano “coccolati” come le
“belle donne”, sarà nuovamente sentito martedì prossimo. Nei post-it, come aveva
confessato lo stesso Cattozzo al gip, aveva annotato in pratica “la contabilità
delle tangenti” con date e percentuali: lo 0.3 o lo 0.5% sul valore degli
appalti. Secondo i calcoli degli inquirenti, riscontrati già dopo gli
interrogatori, le tangenti versate dall’imprenditore vicentino
Enrico Maltauro, ammonterebbero
a circa 600mila euro in totale tra quest’anno e lo scorso anno. Anche se il
costruttore avrebbe parlato di una cifra doppia con gli inquirenti. Tra l’altro,
proprio Cattozzo in una intercettazione, parlando con l’ex parlamentare Dc
Gianstefano Frigerio ed
elencando una serie di cifre, lo rassicurava dicendo: “Io ho scritto
tutto”. “Un’organizzazione efficiente
e prismatica, quasi militarmente organizzata nella scrupolosa suddivisione dei
ruoli e delle mansioni affidate a ciascun sodale, con una produttività di
rilievo”. È una delle conclusioni del rapporto della sezione di pg della Gdf
dello scorso 31 marzo e ora agli atti dell’inchiesta. Le Fiamme Gialle, nel
descrivere la ”cupola” aggiunge che la sua “efficacia operativa” viene
dimostrata anche dalla capacità di far fronte a “variabili impreventivabili come
la perdita di una ‘pedina’ fondamentale quale
Antonio Rognoni (ex dg di
Infrastrutture Lombarde ora agli arresti domicilari, ndr)”, “prevedendo
soluzioni alternative e rapide manovre di avvicinamento,
accerchiamento o consolidamento dei rapporti coi pubblici ufficiali
interessati”. Secondo i finanzieri la cupola aveva tentato di coinvolgere nel
‘sistema’ architettato anche Riccardo Napolitano, amministratore delegato di
Finmeccanica Services Group,
“al fine di conseguire importanti vantaggi in termini economici visto che”
l’alto dirigente “gestirebbe appalti per miliardi di euro per conto dell’intero
gruppo”. In base “all’analisi delle conversazioni intercettate all’interno
dell’ufficio di Frigerio con Cattozzo e Greganti – si legge nel rapporto – è
emerso come i tre stiano consolidando il rapporto con Riccardo Napolitano”. La
sezione pg della Guardia di Finanza sottolinea che una serie di
intercettazioni telefoniche sull’utenza di Cattozzo “hanno
consentito di accertare che nei giorni 23,25 e 26″ settembre 2013, l’ex
esponente dell’Udc ha avuto “un fitto scambio di contatti telefonici con manager
o dipendenti del gruppo Finmeccanica”, cui sarebbero seguiti incontri nelle sede
del Gruppo in via Monte Grappa a Roma
e di Finmeccanica Services Group in via Piemonte, “tra cui Riccardo Napolitano
(incontrato, peraltro, insieme a Primo
Greganti), Giovanni Pontecorvo”, attuale presidente di
BredaMenarinisus, società del gruppo Finmeccanica, e due persone non meglio
identificate, tale Gianni e tale Ugo. Inoltre, si legge in una nota
dell’informativa con cui nell’ ottobre dell’anno scorso era stata chiesta una
proroga delle intercettazioni, Cattozzo e Frigerio “avrebbero ricevuto da
Napolitano un documento, riportante l’elencazione
di tutti i principali settori di servizi affidati da Finmeccanica,
agli stessi estremamente utile per individuare i servizi da mettere in
correlazione con gli imprenditori amici”. Frigerio avrebbe inviato un fax a
Napolitano “informandolo del suo interessamento presso importanti figure
politiche allo scopo di favorirlo nello sviluppo della sua
carriera professionale,
invitandolo nel contempo a ricevere tre imprenditori suoi amici in prospettiva
di favorirli nell’assegnazione degli appalti”. E per completare il quadro i
finanzieri spiegano che dalle conversazioni Cattozzo “starebbe perorando
assiduamente gli interessi economici di Francesco Marguati – ex sindaco (area
Pdl) di Tortona dimessosi nel 2009 – cui fa capo la Sotraf” impresa attiva nel
settore delle pulizie “con l’intento di fargli aggiudicare qualche gara anche in
Finmeccanica, non limitandosi, dunque, alle
strutture sanitarie” come l’ospedale San Matteo e
l’azienda ospedaliera di Pavia. ”Io stavo pensando di fare un’operazione di
questo genere (…) ma perché tu non metti in campo tutto il tuo prestigio con
Gianni Letta e il
Presidente, e Primo dall’altra parte parla con
D’Alema con chi cazzo vuole”.
Così, in un’intercettazione del 17 maggio del 2013, Cattozzo parlava con
Gianstefano Frigerio. Nella conversazione, inserita in “brogliaccio” redatto
dalle Fiamme Gialle i due, stavano parlando, in particolare, del ruolo
Napolitano. Cattozzo, annota la Gdf, dice a Frigerio che Riccardo Napolitano
“gli ha detto che gestisce 3 miliardi di euro all’anno di lavori”. Frigerio
spiega, quindi, che lui “continua a chiedere a Napolitano in quali settori”.
Cattozzo: “Adesso mi fa l’elenco dei settori”. Frigerio: “Bravo … ecco che
guardiamo io e te”. Cattozzo: “Però io stavo pensando di fare un’operazione di
questo genere (…) ma perché tu non metti in campo tutto il tuo prestigio con
Gianni Letta e il Presidente,
e Primo dall’altra parte parla con D’Alema con chi cazzo vuole”. Frigerio:
“Certo”.
Expo, cronaca di uno scandalo annunciato.
L’Antimafia aveva avvisato: attenti alla Maltauro. Ma la prefettura non l’ha
buttata fuori dagli appalti. E i cassieri delle mazzette aggiravano i controlli
sui lavori più importanti, scrivono Paolo
Biondani e Fabrizio Gatti su “L’Espresso”. Adesso qualcuno spera che
il resto della storia rimanga segreto. Prega che non si sappia che la Prefettura
di Milano avrebbe potuto, e forse dovuto, fermare l’ingresso della “Maltauro
costruzioni” negli appalti per l’Expo 2015. Perché alcuni funzionari del
prefetto avevano da tempo scritto che «la società Maltauro tende a subappaltare
lavori a ditte che sono successivamente destinatarie di informazioni antimafia
interdittive»: cioè, secondo il rapporto, l’impresa veneta si serve anche di
imprenditori collegati alla criminalità organizzata. Nessuno però in Prefettura
se l’è sentita di privare l’Expo del contributo di Enrico Maltauro, 59 anni, il
boss dell’impresa che ha vinto due appalti indispensabili all’esposizione
universale per un totale di 97 milioni e mezzo. Il 21 febbraio 2014 dopo sette
mesi di istruttoria, l’«Ufficio di supporto della sezione specializzata del
comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza sulle grandi opere Expo Milano
2015» (questo il pomposo nome) ha deciso di fare più umilmente come Penelope
durante l’assenza di Ulisse: «Si resta in attesa dell’esito degli ulteriori
accertamenti in corso», sottoscrivono la dirigente prefettizia della struttura
di sorveglianza, la dirigente di gabinetto della Prefettura, tre tenenti
colonnello, due vicequestori, un tenente e un sostituto commissario. I nove
rappresentanti della legge permettono così a Enrico Maltauro di continuare a
lavorare indisturbato nei cantieri. Fino al suo arresto, l’8 maggio, per
presunte tangenti con due immortali faccendieri di Tangentopoli anni ‘90,
Gianstefano Frigerio, 75 anni, area Berlusconi, e Primo Greganti, 70 anni,
tessera Pd ora sospesa, l’ex onorevole del Pdl Luigi Grillo, 71 anni, e Angelo
Paris, 48 anni, promettente direttore generale e responsabile dei contratti di
Expo, praticamente il numero due della società pubblica a cui resta un anno per
preparare l’evento. L’inchiesta della Procura di Milano esce allo scoperto negli
stessi giorni in cui indagini antimafia e sentenze colpiscono i pilastri di
vent’anni di centrodestra in Italia e riscoprono nomi intramontabili delle
bustarelle rosse. Così ecco la fuga in Libano del fondatore di Forza Italia,
Marcello Dell’Utri, condannato per concorso esterno a Cosa Nostra, l’arresto del
ministro dell’Interno ai tempi del G8 a Genova, Claudio Scajola, successivamente
famoso per l’appartamento sul Colosseo pagato a sua insaputa, fino all’intrigo
massonico che lega i due con la rete che protegge la latitanza dell’ex
parlamentare berlusconiano, Amedeo Matacena, condannato a sua volta per concorso
esterno alla ‘ndrangheta. Ma ecco anche il ruolo di Primo Greganti, l’ex
cassiere del Pci arrestato e condannato durante la prima inchiesta di Mani
pulite e ancora operativo, secondo la Procura, nei contratti per l’Expo e la
sanità con il coinvolgimento di alcune importanti cooperative. Tanto per
confermare quanto l’appalto con l’aiutino della stecca non faccia schifo nemmeno
a sinistra. Se questo sia l’inizio di una stagione rinnovata di Mani pulite
dipende dal supporto di uomini e mezzi che il ministro dell’Interno, Angelino
Alfano, e il collega della Giustizia, Andrea Orlando, forniranno alle indagini.
Le infiltrazioni criminali, i ritardi nel cantiere e la necessità di ridurre i
controlli antimafia per non fermare i lavori. Mentre il governo valuta anche il
"modello Bertolaso" per finire in tempo e la Mantovani, dopo la gara vinta con
un ribasso record, chiede decine di milioni extra. Allo schiaffo giudiziario
sull’Expo, si aggiunge la botta economica. La Mantovani spa, l’impresa di Padova
che ha realizzato la piastra su cui saranno costruiti i padiglioni
dell’esposizione, pretende ora 110 milioni in più rispetto al prezzo che la
stessa Mantovani aveva formulato per strappare l’appalto alle concorrenti. La
capocordata, insieme con altre imprese appartenenti all’intera lobby
parlamentare dal Pdl alla Lega Coop, si era aggiudicata il contratto più grosso
di Expo con l’offerta di 165 milioni, partendo da una base d’asta di 272
milioni. Un ribasso che aveva scandalizzato perfino un politico navigato come il
celeste senatore Roberto Formigoni, allora governatore ciellino della Lombardia
e ora imputato per la corruzione sulla sanità. Se in Francia, dove l’Esposizione
universale ha la sua sede storica, un ente pubblico formulasse una base d’asta
superiore del 65 per cento rispetto ai prezzi di aggiudicazione, i suoi manager
e progettisti verrebbero licenziati per aver gonfiato le cifre. Oppure l’offerta
dell’impresa verrebbe bocciata. In Italia no: da noi in questo modo si vincono
contratti colossali. «Questo è stato possibile grazie alla nostra consolidata
esperienza nell’affrontare sistemi complessi», raccontava a “l’Espresso”
l’allora amministratore delegato di Mantovani, Piergiorgio Baita, poco prima di
essere arrestato per associazione a delinquere finalizzata all’emissione di
fatture false e dichiarazione fraudolenta e poi condannato con un patteggiamento
a un anno e dieci mesi. Certo: esperienza consolidata. La Mantovani, guidata
dopo Baita dall’ex questore di Treviso Carmine Damiano, con la giustificazione
dei tempi di consegna accelerati, presenta dunque il conto del suo ribasso fuori
mercato: 110 milioni di maggiore spesa che il governo Renzi dovrebbe stanziare
per accontentare la società, definita solo otto mesi fa dai giudici «gruppo
economico criminale», per farla così rientrare dai preventivi spericolati
presentati dal pregiudicato Baita in una gara d’appalto la cui commissione
aggiudicante era presieduta dall’attuale detenuto Angelo Paris. Il commissario
unico per l’Expo, Giuseppe Sala, è ottimista: «Più che di contenzioso, dobbiamo
parlare di riserve», spiega a “l’Espresso”: «Chi conosce le questioni relative
agli appalti sulle costruzioni sa che in genere si chiude su un dieci-venti per
cento del valore richiesto». Altri osservatori sono un po’ più pessimisti:
«Mantovani non scenderà al di sotto dei 60 milioni». Comunque è sempre un bel
malloppo a carico degli italiani. Baita, nonostante la condanna, non è scomparso
dal panorama. Secondo i magistrati, è tuttora rappresentante legale di quattro
società. E a lui si rivolge il general manager Paris nel suo tentativo di
trovare sponsor, a cominciare da Silvio Berlusconi, per essere promosso al posto
di Antonio Rognoni, arrestato poche settimane fa, direttore generale di
Infrastrutture lombarde (Ilspa), il braccio operativo della Regione nei grandi
appalti e nella direzione dei lavori per l’Expo. «Posso chiederti un consiglio
da amico. Ti candideresti al bando pubblico per ricerca DG Ilspa?», scrive Paris
in un sms. «Se fossi in te sì. Fatti vivo. Ciao», gli risponde Baita. Sulla
Mantovani gravano sempre le parole pronunciate davanti al prefetto di Milano,
Francesco Tronca, dal procuratore vicario della Direzione nazionale antimafia
Pier Luigi Dall’Osso. Lo scorso 6 settembre durante una riunione del Comitato
per l’alta sorveglianza sui grandi appalti il magistrato aveva messo in guardia
sulla posizione dell’azienda: l’esistenza di informative ancora coperte dal
segreto e quanto già scritto dai giudici nelle inchieste venete offrono uno
spaccato dell’attività dell’impresa che «probabilmente potrà essere uno degli
elementi fondanti di importanti iniziative da adottare in tema di antimafia».
Pesa però anche l’immediata risposta del provveditore alle Opere pubbliche,
Pietro Baratono, rappresentante a Milano del ministro delle Infrastrutture,
Maurizio Lupi: Baratono dice al prefetto e ai presenti di essere preoccupato e
rammaricato per quanto ha riferito l’alto magistrato sulla Mantovani perché
«l’adozione di un eventuale provvedimento interdittivo potrebbe mettere a
rischio la realizzazione dell’evento». Per buona pace della Mantovani, il dottor
Dall’Osso non si occupa più della questione. Nel frattempo è stato promosso
procuratore a Brescia. Dopo l'inchiesta-denuncia di Fabrizio Gatti, la
prefettura ha deciso di bloccare la società siciliana in rapporti con le cosche
che si era aggiudicata l'appalto più importante. È alla vigilia di questo clima
che il 10 luglio 2013 «su richiesta della stazione appaltante Expo 2015» la
Prefettura avvia la prima istruttoria sulla Maltauro spa: l’impresa ha vinto la
commessa per 41 milioni e 902 mila euro per la realizzazione della Via d’acqua
Sud e il collegamento del canale dell’Expo con la Darsena, un’opera fondamentale
nell’immaginario dei progettisti. È il prefetto che deve concedere la necessaria
liberatoria antimafia o l’interdittiva che allontanerebbe l’azienda dai
cantieri, con il conseguente ritardo nell’avvio dei lavori. Dall’ottobre 2013 il
tempo di risposta è ulteriormente ridotto a sette giorni. Scaduti i quali, la
Prefettura è obbligata a rilasciare una liberatoria provvisoria. Ma c’è ancora
margine per evitare all’Italia la figuraccia internazionale. Invece
l’istruttoria non viene mai conclusa e il 27 gennaio 2014 Expo ne richiede una
seconda: Enrico Maltauro, questa volta secondo la Procura grazie agli aiutini di
Paris, ha vinto anche l’appalto da 55 milioni e 679 mila euro per le
architetture di servizio nell’area dell’esposizione. Finalmente per la riunione
del 21 febbraio l’ufficio di supporto al Comitato di sorveglianza presenta la
sua relazione al gruppo ispettivo antimafia della Prefettura. La Maltauro
risulta destinataria di tre informazioni atipiche emesse nel 2011 e nel 2012
dalle prefetture di Vicenza e L’Aquila. L’impresa «ha partecipato a varie gare
d’appalto con la società... indagata perché infiltrata da esponenti della
criminalità mafiosa» e vengono ricordate due inchieste delle procure antimafia
di Venezia e Palermo. L’ufficio aggiunge che «nel contesto dei lavori eseguiti
presso la base militare di Aviano la società Maltauro inseriva nelle liste
presentate per il rilascio dei pass personaggi quali... esponenti inseriti
organicamente nelle principali organizzazioni criminali». I funzionari del
prefetto avvertono anche che Enrico Maltauro «consigliere e amministratore
delegato della predetta società, risulta essere stato condannato negli anni
Novanta tra vari reati anche per corruzione e turbata libertà degli incanti». Da
qualche tempo il Tar della Lombardia si pronuncia spesso a favore delle imprese
e contro il prefetto. Forse proprio per questo e non solo per evitare ritardi ai
cantieri, i nove rappresentanti degli organismi investigativi e della Prefettura
concludono che «le informazioni finora acquisite non consento di affermare che
l’impresa presenti i connotati di infiltrazioni mafiose». La decisione viene
così ulteriormente rinviata. Nel frattempo i lavori per la Via d’acqua di
Maltauro sbattono contro una cava piena di rifiuti tossici dentro Milano. La
ditta si rifiuta di fornire informazioni al comitato di quartiere preoccupato
dagli scavi a cielo aperto. «Qualunque altro operatore che avesse agito in
questo modo», sospettava già mesi fa Enrico Fedrighini, consigliere dei Verdi,
«sarebbe stato oggetto di controlli». Aveva visto giusto. Perché per proteggere
Maltauro interviene il solito direttore generale di Expo. Il 7 marzo Paris parla
con Christian Malangone, direttore della pianificazione e controllo sul grande
evento: «Oggi han portato la terra in una discarica non autorizzata... Sei volte
hanno già fatto infrazione. Sei volte». Maltauro deve pagare a Expo una multa di
due milioni. Viene informato anche Frigerio, presentato a Maltauro dalla
«Cancellieri», l’ex prefetto di Vicenza ed ex ministro Annamaria Cancellieri:
«Perché aveva l’ufficio di Prefettura in casa sua, a Vicenza», dice Frigerio in
una telefonata. E, sempre in marzo, cerca di porre rimedio: «Dì a Enrico di
rispettare le regole sull’antimafia, perché ha fatto entrare due, tre aziende.
Meno male che abbiamo Paris».
Le infiltrazioni criminali, i ritardi nel cantiere
e la necessità di ridurre i controlli antimafia per non fermare i lavori. Mentre
il governo valuta anche il "modello Bertolaso" per finire in tempo e la
Mantovani, dopo la gara vinta con un ribasso record, chiede decine di milioni
extra, scrive Fabrizio Gatti su “L’Espresso”. C'è una storia segreta per l’Expo.
Una storia mai raccontata nelle dichiarazioni pubbliche sul grande evento che
dal primo maggio 2015 a Milano deve rilanciare l’immagine dell’Italia nel mondo.
Da una parte il malaffare di alcune imprese che si sono aggiudicate appalti
importanti, le infiltrazioni della ‘ndrangheta e il ritardo di un anno sul
programma dei lavori. Dall’altra, l’impegno di un gruppo di funzionari dello
Stato, a cominciare dal prefetto di Milano, che oggi si ritrova di fronte al
bivio: difendere la legalità con la conseguenza di rallentare i cantieri e
mettere a rischio l’intera manifestazione, oppure snellire le norme antimafia e
abbassare la guardia. La più grande opera pubblica del momento, quasi tre
miliardi di spesa tra infrastrutture e organizzazione per ospitare l’Esposizione
universale, diventa così la metafora di un Paese all’ultima spiaggia. La voglia
di fare che si scontra con il tempo perso in liti politiche: famosa la rissa che
ha bloccato l’Expo per mesi tra l’allora sindaco Letizia Moratti e l’ex
governatore Roberto Formigoni, oggi ben stipendiato in Senato. L’assalto della
criminalità all’economia sana. La corsa affannata verso l’inaugurazione. E, in
fondo a tutto, la mancanza di alternative. Si è scelto così di ridurre i
controlli: attraverso la modifica del codice nazionale antimafia oppure
l’ampliamento dei poteri speciali del commissario unico, Giuseppe Sala, come si
faceva con la Protezione civile di Guido Bertolaso. La discussione, tuttora in
corso, ha coinvolto quattro ministri, il presidente della Regione Lombardia, il
sindaco di Milano e il capo della Prefettura. Ecco il diario segreto di sei mesi
di incontri e contatti che “l’Espresso” ha ricostruito grazie alle testimonianze
di quanti erano presenti.
5 settembre 2013:
Roma, Direzione centrale della polizia criminale. Il vice capo della polizia e
direttore centrale della polizia criminale, viene aggiornato sull’arresto,
qualche giorno prima, del vicequestore aggiunto Giovanni Preziosa, 59 anni, ex
assessore alla Sicurezza nella giunta di centrodestra a Bologna. È accusato di
avere ceduto informazioni estratte dalle banche dati delle forze dell’ordine
all’impresa di costruzioni Mantovani spa, società che a Milano si è aggiudicata
l’appalto più importante di Expo 2015. L’informativa del ministero dell’Interno
evidenzia che nell’ordinanza di custodia cautelare che ha disposto l’arresto del
vicequestore Preziosa, il giudice per le indagini preliminari definisce la
Mantovani spa un «gruppo economico criminale». Il vice capo della polizia viene
anche avvertito che qualsiasi provvedimento di interdizione nei confronti della
Mantovani spa potrebbe pregiudicare lo svolgimento dell’Expo: proprio perché
l’impresa ha vinto il contratto per la struttura principale, cioè la costruzione
della “piastra” di cemento armato su cui verranno realizzati i padiglioni
dell’Esposizione universale. Anche la Prefettura di Milano è al corrente delle
criticità che riguardano la società: criticità come l’arresto il 28 febbraio
2013 dell’amministratore delegato di Mantovani, Piergiorgio Baita, per
associazione a delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni
inesistenti e dichiarazione fraudolenta.
6 settembre 2013:
Milano, Prefettura. Davanti al prefetto di Milano, Francesco Tronca, si riunisce
la sezione specializzata del “Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza
sulle grandi opere per l’Expo 2015”. I convocati ricordano quello come un
incontro carico di preoccupazioni. Il prefetto li aggiorna sul numero degli
ultimi provvedimenti interdittivi antimafia: una decina di imprese già
allontanate o che stanno per essere allontanate dai cantieri. Sotto esame non ci
sono soltanto gli appalti per il sito dell’esposizione, ma anche quelli per le
infrastrutture esterne. Tronca rivela una maggiore presenza di infiltrazioni di
origine calabrese. In particolare nelle opere viarie e nei cantieri della Teem,
la nuova tangenziale di Milano. Nonostante questo ulteriore allarme, il prefetto
annuncia che il suo ufficio ha manifestato al ministero dell’Interno la
necessità di snellire la normativa sui controlli antimafia. Una modifica che il
rappresentante del governo definisce indispensabile, pur nel rispetto della
legalità. Gli arretrati ancora in istruttoria superano il sessanta per cento
delle richieste. Percentuale che non può essere accettata. Sarà proprio la
Prefettura di Milano a scrivere la bozza della nuova normativa da inviare al
Viminale. Il comitato deve anche valutare le informazioni fornite dalla
Direzione nazionale antimafia (Dna) sulla Serenissima holding: la società della
potente famiglia Chiarotto di Padova è proprietaria della Mantovani spa e della
Fip industriale spa, altra azienda del gruppo veneto impegnata nei cantieri per
le infrastrutture viarie di Expo. Il procuratore nazionale aggiunto della Dna,
Pier Luigi Dell’Osso, spiega davanti al prefetto che non tutte le notizie
possono essere liberate dal segreto. E che l’arresto del vicequestore Preziosa e
quanto ha scritto il giudice nell’ordinanza di custodia cautelare mostrano
comunque uno spaccato dell’attività della Mantovani spa. Per questa ragione,
secondo il procuratore Dell’Osso, l’ordinanza potrà essere uno degli elementi su
cui fondare importanti iniziative da intraprendere in tema di antimafia. Ma non
tutti sono d’accordo. Se ne fa immediatamente portavoce Pietro Baratono,
ingegnere e provveditore alle Opere pubbliche di Lombardia e Liguria, che nel
Comitato per l’alta sorveglianza rappresenta il ministero delle Infrastrutture
guidato da Maurizio Lupi. Baratono dice chiaro e tondo al prefetto e ai presenti
di essere preoccupato e rammaricato per quanto ha riferito l’alto magistrato
sull’associazione tra imprese di cui la Mantovani spa è capogruppo. Perché,
trattandosi dell’affidataria dei lavori di costruzione della piastra,
l’emissione di un eventuale provvedimento interdittivo e il conseguente
allontanamento dai cantieri potrebbero mettere a rischio la realizzazione della
manifestazione. Cioè potrebbero costringere l’Italia a una memorabile figuraccia
davanti al mondo. In altre parole chi volesse adottare i necessari provvedimenti
imposti dalla legge, per proteggere la pubblica amministrazione da infiltrazioni
mafiose o attività illegali, deve assumersi la responsabilità di un fallimento
di Expo 2015. Al ministero dell’Interno e a quello delle Infrastrutture fanno le
stesse valutazioni. Il provveditore alle Opere pubbliche si lamenta anche per il
fatto che lo stato di avanzamento dei lavori verificato dai suoi funzionari nei
cantieri non corrisponde a quanto ufficialmente dichiarato dalla Expo 2015 spa,
società creata da Regione Lombardia, Comune di Milano, Provincia e Camera di
commercio per organizzare e gestire il grande evento.
28 ottobre 2013:
Roma, ministero dell’Interno. La richiesta della Prefettura di Milano di
snellire le verifiche antimafia viene accolta. Il ministro dell’Interno,
Angelino Alfano, firma la direttiva sul coordinamento degli accertamenti che
individua nella Direzione investigativa antimafia (Dia) «l’organismo sul quale
verranno a gravitare le attività info-investigative di preventivo controllo,
propedeutiche al rilascio della documentazione antimafia o all’iscrizione degli
operatori nelle cosiddette white-list». Il 7 dicembre la Gazzetta ufficiale
pubblica le nuove linee guida con le quali il Comitato di coordinamento per
l’alta sorveglianza sull’Expo fornisce “prescrizioni aggiuntive volte ad
accelerare i controlli antimafia”. Viene così formalizzata una nuova procedura
più rapida. Le imprese non segnalate nella banca dati della Prefettura o in
quella della Dia ottengono la liberatoria provvisoria nel giro di pochi giorni:
possono quindi firmare i contratti ed entrare nei cantieri.
7 gennaio 2014:
Milano, Prefettura. Alla riunione del Comitato di coordinamento per l’alta
sorveglianza sull’Expo, partecipano oggi anche l’ambasciatore Paolo Guido
Spinelli e l’architetto Andrea Del Prete per conto di Expo 2015 spa.
L’ambasciatore Spinelli, che cura i rapporti con i Paesi esteri e con il «Bureau
International des Expositions», comunica al prefetto che i lavori sono in
ritardo rispetto al programma. L’architetto di Expo, che si occupa dei problemi
tecnici del grande cantiere, spiega invece che per la realizzazione dei singoli
padiglioni, gestita dagli Stati partecipanti, si prevedono affidamenti delle
opere molto frazionate. E soprattutto che i Paesi esteri probabilmente
firmeranno con le imprese contratti di tipo privatistico e non veri e propri
subappalti pubblici. Un ostacolo in più per i controlli antimafia, tenendo conto
che l’alta frammentazione dei contratti rischia di favorire l’infiltrazione di
aziende colluse. L’impegno non è di poco conto: per la consegna dei padiglioni,
le rifiniture, gli allestimenti, i servizi qualcuno già stima il coinvolgimento
per i prossimi mesi di centinaia di piccoli e medi imprenditori italiani e
stranieri, suddivisi tra una cinquantina di filiere. Imprenditori su cui saranno
svolti accertamenti preferibilmente preventivi: cioè su nomi, documenti, banche
dati senza necessariamente inviare ispezioni nei cantieri, per non pregiudicare
l’andamento dei lavori. Com’è nell’interesse della società Expo 2015. Dietro il
paravento dei documenti in ordine, però, qualche azienda collusa è riuscita a
eludere i controlli. L’allarme è altissimo. Al prefetto viene riferito che la
criminalità organizzata si è infiltrata principalmente nei contratti per le
opere infrastrutturali stradali. Soprattutto nei lavori per la costruzione
dell’autostrada Pedemontana e della nuova tangenziale di Milano, due opere
finanziate per l’Expo. La Prefettura ha finora firmato l’interdizione antimafia
per dieci imprese impegnate nei cantieri della Teem, la tangenziale esterna
milanese. Ditte infiltrate prevalentemente dalla ‘ndrangheta. Otto sono invece
le imprese “interdette” dai cantieri della Pedemontana. Molte società hanno
ricevuto incarichi in tutte e due le grandi opere e sono spesso collegate tra
loro da legami societari e familiari. Il maggior numero di incarichi riguarda
piccoli subcontratti non sottoposti all’autorizzazione della stazione
appaltante, come invece avviene per i subappalti. Uno stratagemma, viene
spiegato nella riunione con il prefetto, sfruttato dalle imprese per sottrarsi
agli speciali controlli antimafia previsti per l’Expo. Si è scoperto così che la
criminalità organizzata è riuscita a infiltrarsi proprio grazie ai subcontratti
affidati a società che, anche se con sigle e denominazioni diverse, risultano
legate tra loro da un’intensa rete di interessi familiari e d’affari. E
strettamente connesse o addirittura presenti, indirettamente o direttamente, in
tutte le opere Expo.
13 gennaio 2014:
Milano, Prefettura. Il prefetto Tronca incontra il ministro
dell’Interno Alfano, arrivato da Roma per firmare il “Piano di azione Expo 2015
– Mafia free”. Il piano viene sottoscritto dal ministro con il presidente della
Regione Lombardia, Roberto Maroni, il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, e il
commissario unico per l’Expo, Giuseppe Sala. «La sottoscrizione del piano
d’azione», spiega il ministro Alfano all’Ansa, «cristallizza la volontà ferma e
determinata dello Stato e degli altri organismi coinvolti di attivare ogni
iniziativa utile a garantire il rispetto della legalità e della trasparenza in
tutte le fasi di realizzazione dell’evento». Nelle stesse ore, sempre in
Prefettura, il Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza sull’Expo
decide di semplificare ulteriormente la procedura antimafia sulle imprese estere
che lavoreranno nei cantieri. Le verifiche saranno limitate alle
autocertificazioni dei proprietari, degli amministratori e dei procuratori con
poteri specifici in merito al contratto, così come ha suggerito il ministero
dell’Interno. Esclusi dai controlli i familiari, i conviventi, i sindaci e i
revisori dei conti. I tempi di risposta della Prefettura vengono fissati in
quindici giorni: oltre, la stazione appaltante sarà autorizzata a firmare il
contratto con la ditta e a dare provvisoriamente il via ai lavori anche senza
liberatoria. Quanti erano presenti ricordano che il termine dei quindici giorni
è stato proposto dall’avvocato generale dello Stato, Ettore Figliolia, già
consulente legale nella Protezione civile dei grandi eventi di Guido Bertolaso.
Lo scopo della procedura semplificata è sempre quello di accelerare i tempi.
Anche se, secondo alcuni osservatori, la criminalità potrebbe ora infiltrarsi in
Expo dietro lo schermo delle imprese straniere.
11 febbraio 2014:
Lombardia, cantieri tangenziale Teem. Le aziende con collegamenti mafiosi nei
subappalti per la tangenziale esterna di Milano salgono a undici. La Prefettura
ha scoperto e allontanato un’altra ditta. Per quanto riguarda i padiglioni di
Expo 2015, il prefetto di Milano, Francesco Tronca, chiede al Comitato per
l’alta sorveglianza che le ispezioni antimafia siano meglio coordinate. È vero
che gli accessi nei cantieri delle forze di polizia, dell’Ufficio del lavoro,
delle Asl garantiscono controlli più efficaci, soprattutto se fatti a sorpresa.
Ma bisogna tenere conto dei tempi: al fine, sostiene il prefetto, di non
interferire eccessivamente con l’esecuzione dei lavori. L’imminente ingresso nei
cantieri da parte dei Paesi esteri comporterà un proliferare di imprese di ogni
tipo e provenienza. Da qui la necessità di programmare l’azione di controllo:
evitando il più possibile, è in sintesi l’invito del prefetto, rallentamenti ai
lavori e, più in generale, alla buona riuscita dell’evento. Eppure il “Piano di
azione mafia free” annunciato in pompa magna e firmato da meno di un mese da
Alfano, Maroni, Pisapia e Sala prevedeva l’esatto opposto: «Potenziare
l’attività di accesso ai cantieri da parte del gruppo interforze nonché, anche
attraverso forme di collaborazione con i corpi delle polizie locali, in deroga
ai vincoli territoriali». A gennaio le ispezioni sono state sette. E altre sette
sono programmate a febbraio. Davanti ai vari funzionari di Stato che siedono nel
comitato, il prefetto spiega che sono le autorità competenti in materia
previdenziale e di sicurezza sul lavoro o l’Asl, e non la polizia, a svolgere
controlli con maniere che rallentano i cantieri. Alcune volte anche per l’intera
giornata. Il presidente della Commissione antimafia del Comune di Milano, Davide
Gentili, e il collega della Commissione regionale antimafia, Gian Antonio
Girelli, chiedono in tempi diversi di poter partecipare o avere informazioni
sull’attività di monitoraggio contro la criminalità. I funzionari del comitato,
però, sollecitano la necessità di distinguere gli organi istituzionali da quelli
puramente politici. Il rappresentante dell’ufficio di gabinetto della Prefettura
segnala infatti il rischio che le domande avanzate da organismi di derivazione
politico-locale, in quanto espressione dell’elettorato, possano essere dirette a
conoscere l’attività riservata con il fine di renderne conto agli elettori.
24 febbraio 2014:
Milano, cantieri Expo 2015. Tra le colate di cemento liquido e il viavai di
camion, oggi nel grande cantiere che si affaccia sull’autostrada Milano-Torino
molti si sentono sollevati. Un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia
di Catania avrebbe potuto mettere in crisi l’organizzazione dell’Esposizione
universale. L’indagine riguarda la Fip industriale spa, società della
Serenissima holding di Padova, il gruppo che controlla anche la Mantovani spa.
La Fip a Milano ha ottenuto un subcontratto dalla società Astaldi per i lavori
della linea 5 della metropolitana, tra San Siro e Garibaldi. In ottobre
l’amministratore delegato della Fip, Mauro Scaramuzza e un ingegnere
dell’impresa, Achille Soffiato, sono stati arrestati in Sicilia per concorso
esterno in associazione mafiosa. Secondo l’accusa, l’azienda avrebbe frazionato
i subcontratti al di sotto del limite di 154 mila euro per non incorrere
nell’obbligo della liberatoria antimafia. E avrebbe così favorito nella
costruzione di una superstrada a Caltagirone due imprese della costellazione di
Ciccio La Rocca, boss locale di Cosa nostra. Gli arresti potrebbero trascinare
in un provvedimento antimafia anche la società sorella, la Mantovani spa.
Eventualità che bloccherebbe i cantieri dell’Expo. I dirigenti della Fip vengono
però scarcerati nel giro di qualche settimana dal Tribunale del riesame per
insufficienza di gravi indizi: secondo il giudice, Scaramuzza e Soffiato non
hanno frazionato nulla. Il loro arresto è stato deciso in base a un’errata
valutazione delle fatture. Per questo la Prefettura di Milano archivia
l’argomento. Nei cantieri della Mantovani spa ora sono tutti più tranquilli. Il
problema urgente da risolvere è ancora quello delle ispezioni e del mancato
coordinamento. Il prefetto ha scoperto che il rallentamento dei lavori è stato
provocato, come si sospettava, dagli accertamenti della Asl di Milano. Tronca
annuncia che incontrerà personalmente sia il direttore generale, sia il
presidente della Asl. Il comitato propone che gli accessi nei cantieri vengano
comunicati alla Prefettura con un mese di anticipo: in modo da permettere una
programmazione unica tra i vari enti. Anche se così si rischia di perdere
l’effetto sorpresa.
3 marzo 2014:
Milano, sede di Expo spa. La mattina in via Rovello 2, nella sede della società
Expo spa a metà strada tra il Duomo e il Castello Sforzesco a Milano, il
commissario unico Sala, il sindaco Pisapia e il presidente della Regione Maroni,
incontrano quattro ministri del nuovo governo di Matteo Renzi. Sono Maurizio
Lupi (Infrastrutture), Federica Guidi (Sviluppo economico), Dario Franceschini
(Beni Culturali) e Maurizio Martina (Agricoltura). La versione ufficiale
dell’incontro descrive la lista della spesa presentata da Maroni al governo: 2,2
miliardi di ulteriori finanziamenti per le infrastrutture e il trasporto locale.
C’è però una questione molto riservata e delicata di cui vengono informati i
ministri. Riguarda una richiesta che il commissario unico per l’Expo negli
ultimi giorni ha comunicato al prefetto di Milano. Sala sostiene che
l’applicazione del protocollo di legalità, firmato tra la Prefettura e la
società Expo nel 2012, sta creando non pochi problemi. I cantieri saranno presto
investiti dalla moltiplicazione dei lavori e dal proliferare di imprese di ogni
tipo e provenienza. Secondo Giuseppe Sala, i controlli antimafia devono essere
inquadrati in modo più sistematico e snello, comprimendo il più possibile i
tempi necessari per l’ingresso nei cantieri degli appaltatori e dei
subappaltatori. Altrimenti i lavori rallenteranno, con gravi conseguenze per il
successo dell’esposizione. Il commissario unico propone di autorizzare
l’ingresso delle imprese in cantiere immediatamente dopo l’invio della richiesta
di informazione antimafia alla Prefettura e senza attendere la liberatoria.
Scorciatoia da applicare nei casi di contratti per attività considerate non a
rischio di infiltrazione oppure, se a rischio, per importi inferiori a 20 mila
euro. A differenza degli appalti pubblici che hanno una soglia di spesa sotto la
quale non sono richiesti i controlli antimafia, tutte le imprese coinvolte in
Expo, per qualsiasi importo, devono essere certificate dalla Prefettura. Ma i
contratti sempre più numerosi e frazionati porteranno un carico di lavoro
ingestibile per gli uffici rispetto alle risorse disponibili. Con le ultime
linee guida, da dicembre i tempi per le verifiche sono già ridotti al minimo. La
Direzione investigativa antimafia ha soltanto sette giorni per completare gli
accertamenti preliminari su ogni azienda. E in caso di ritardo nella risposta,
la Prefettura rilascia automaticamente la liberatoria provvisoria. Parlando con
i suoi più stretti collaboratori, il prefetto prevede che prima o poi la società
Expo finirà con l’autorizzare le imprese a entrare nei cantieri senza essere
legittimate dalla certificazione, vanificando così l’efficacia della procedura
accelerata. In altre parole, per colpa dei ritardi che ha ereditato, Sala è con
le spalle al muro. E come lui lo sono il prefetto, il governo e l’intero sistema
nazionale di prevenzione antimafia. Per il commissario è una scelta obbligata: o
si fa così o le opere non verranno concluse in tempo. Una soluzione ipotizzata è
il modello Bertolaso, con tutti i rischi connessi: un ampliamento dei poteri
speciali di deroga riconosciuti a Giuseppe Sala. L’ipotesi è stata rappresentata
da Maroni e Pisapia che nei giorni scorsi si sono incontrati con Sala, il
prefetto e il presidente della Provincia, Guido Podestà, per parlarne in
segreto.
3 marzo 2014:
Milano, Prefettura. Il pomeriggio, terminata la visita a Milano dei ministri,
torna a riunirsi il Comitato per l’alta sorveglianza. La semplificazione del
protocollo di legalità è tra i punti all’ordine del giorno. La Prefettura
propone come via d’uscita la modifica del codice antimafia adeguando i termini
per la firma dei contratti, anche in mancanza del rilascio della liberatoria.
Oppure l’alleggerimento delle linee guida per l’Expo, stabilendo una soglia di
esenzione dai controlli. In alternativa, resta il modello Bertolaso. Tutti i
presenti comprendono che si stanno muovendo su un campo minato. Di fronte a una
moltiplicazione delle imprese, il prefetto ammette il rischio di non riuscire a
evadere le richieste di informazione antimafia in tempi brevi. Meglio quindi,
secondo Tronca, concentrarsi sugli appalti di maggior valore nei settori più a
rischio. Ed escludere dai controlli i contratti di minor valore e impatto, nel
quadro di un equilibrio tra costi e benefici. Il rappresentante dell’avvocatura
dello Stato, Michele Damiani, lamenta il ritardo con cui la società Expo spa ha
sollevato la questione. Rispetto al prefetto precedente, Tronca ha raccolto una
squadra molto più preparata. Tecnici e funzionari, uomini e donne, sono lì
seduti intorno al tavolo a testimoniare con il loro lavoro l’impegno per
realizzare una manifestazione senza scandali. Il colonnello Alfonso Di Vito,
capocentro della Dia, ricorda a tutti che con una migliore definizione del
cronoprogramma delle opere, forse questi problemi sarebbero stati evitati.
Davanti al prefetto e ai colleghi del comitato, il colonnello dice che,
probabilmente, la situazione segnalata da Expo deriva dai ritardi che la stessa
società ha contribuito a produrre: ritardi che sono quantificabili in oltre un
anno. Cioè quello che si sta costruendo ora, doveva essere fatto più di un anno
fa. Nemmeno Giuseppe Sala, però, ha alternative. La necessità del commissario
unico di cambiare le regole per completare in tempo i lavori potrebbe essere
soddisfatta solo da un decreto legge del governo, ipotizzano in Prefettura. Ma
una deroga del genere inventata ad hoc per l’Expo, avverte Baratono, il
provveditore alle Opere pubbliche, potrebbe essere strumentalizzata
politicamente. Ha ragione, dopo quello che ha detto Alfano nel presentare il
“Piano mafia free”.
10 marzo 2014:
Milano, Grattacielo della Regione. Dalle finestre del trentanovesimo piano i
cantieri si indovinano nella foschia. Il pomeriggio il presidente lombardo
Roberto Maroni è chiuso nel suo ufficio con il ministro Lupi e Francesco Tronca.
Mancano appena dodici mesi. In attesa della visita a Milano del premier Matteo
Renzi, fissata per venerdì 11 aprile, la mediazione del prefetto va avanti.
Perché dopo essersi impegnato a ripulire gli appalti Expo dalla mafia, non si
dica che ora devono liberarli dall’antimafia.
Le novità sull’Expo, scrive
Nicola Tranfaglia su “Articolo 21”. A mano a mano che passano i giorni e si
conosce di più o meglio intorno all’affare milanese, le cose sembrano
peggio rare ancora peggio per l’affare legato all’EXPO milanese di cui la banda
Frigerio & Co, ha approfittato fino ad oggi. Incominciamo dai numeri. Il valore
complessivo degli investimenti (di 2,65 miliardi di euro per la realizzazione
dell’Esposizione),1,2 milioni di euro avrebbe pagato per sua ammissione
l’imprenditore Enrico Maltauro per ottenere alcuni appalti nell’ambito dei
lavori previsti. La percentuali di tangenti che avrebbe pagato per vincere gli
appalti erano del l’0,3 o dell’O,5 per cento, secondo i calcoli dell’accusa. Ma
le novità non finiscono qui e rischiano di configurare per l’ex parlamentare di
Forza Italia, Claudio Scajola, l’accusa da parte della procura di Bergamo di far
parte di un’associazione massonico-mafiosa internazionale che era collegata ,da
una parte a Giampaolo Tarantini, l’imprenditore pugliese che organizzava le
serate di festa per Berlusconi(come era già emerso dall’inchiesta giudiziaria su
Ruby, presentata come la nipote di Mubarak) e dall’altra alla ‘ndrangheta
calabrese e in particolare ai De Stefano, cui era legato l’ex tesoriere della
Lega Francesco Belsito. Se a questo si aggiunge che – come ha chiarito già nel
novembre 2013, il presidente dell’Associazione Nazionale costruttori edili,
Paolo Bozzetti, sottolineando come, in nome della fretta sono stati ignorati
78 articoli di legge sui contratti e tra i requisiti richiesti per partecipare
alla gara c’era quello per cui era necessario aver fatturato nei cinque anni
precedenti almeno il quintuplo dell’importo a base d’asta fissato in 25 milioni
di euro. Si trattava - sottolineano ora i costruttori - di una richiesta “non in
linea con la legge vigente oggi.” Inoltre quattro vecchie ordinanze della
presidenza del Consiglio, una firmata da Romano Prodi nel 2007, le altre tre da
Silvio Berlusconi nel 2010, hanno consegnato i lavori dell’Esposizione
Internazionale di Milano alla logica perversa del grande evento. Per questo sono
state previste deroghe al codice dei contratti “per motivi di urgenza”. Con la
facoltà di sostituire i bandi di gara europei con procedure informali
procedendo su inviti alle imprese. E sottraendo gli appalti al controllo della
Corte dei Conti e dell’Autorità garante dei contratti pubblici. Non è un caso
che ora la Corte dei Conti vuol vederci anche lei chiaro sulla vicenda e che la
commissione parlamentare contro la mafia è intervenuta ascoltando il prefetto
Paolo Francesco Conta a proposito delle nuove linee guida sui controlli
modificate quindici giorni fa all’interno del protocollo antimafia. La
presidente della Commissione Rosy Bindi ha dichiarato:” Ci sono molti aspetti
che non appaiono chiari e comunque le modifiche delle linee guida avrebbero
dovuto prevedere una interlocuzione con questa commis sione.” Quel che risulta
con chiarezza da questa prima parte dell’in chiesta e preoccupa l’opinione
pubblica più attenta è che in un modo o nell’altro tutte le forze politiche
presenti in parlamento hanno partecipato (i nomi li abbiamo visti: Frigerio,
Greganti, Belsito alla grande spartizione) e c’è da chiedersi: come si spiega
che sia stato l’ex ministro Scaiola a tenere i fili del tutto e che cosa ha
fatto il sistema complessivo dei media a non dirci nulla fino all’iniziativa dei
magistrati? Sono quesiti a cui bisognerebbe un giorno o l’altro poter
rispondere.
Una Lega di Boss. Una nuova P2
'ndrangheto-lombarda scuote la Lega, scrive Nerina
Gatti su “Antimafia2000”.
Arriva a lambire l’Expo 2015 e pone inquietanti interrogativi sulle
“talpe” del Carroccio. Una nuova P2
ndrangheto-lombarda scuote la Lega, arriva a lambire l’Expo 2015 e pone
inquietanti interrogativi sulle “talpe” del Carroccio. Come già evidenziato
dall’indagine Breakfast, dalla Calabria partono le tracce e le tracciabilità
degli affari che gli uomini della ndrangheta, i faccendieri trapiantati a
Milano, i vecchi arnesi dell’eversione di destra e importanti imprenditori
intessevano, e che avevano come punto di raccordo lo studio di consulenza Mgim,
nel cuore di Milano.Non c’è da sorprendersi, anche se ancora in molti, come l’ex
prefetto di Milano GianValerio Lombardi e l’ex ministro dell’Interno Roberto
Maroni non ne vogliono sapere di ‘ndrangheta dalle loro parti. Infatti,
stavolta, non si tratta di sola ndrangheta, ma di ipotesi ancor più inquietanti:
di organizzazioni criminali segrete, di soffiate preventive da parte di pezzi
marci delle istituzioni, di affari loschi con il Vaticano e addirittura di
comprarsi banche all’estero – viene citata spesso la Arner Bank di Lugano – per
evitare i controlli di Bankitalia e di procure particolarmente tenaci come
quella di Reggio Calabria. Filoni d’indagini ancora tutte da scoprire, grazie
al sequestro dei file e dei computer effettuato nell’ultimo blitz. Fin dove
arriverà questa associazione segreta, il cui scopo era di agevolare gli affari
di una delle cosche più potenti della ndrangheta come i De Stefano è soprattutto
più pericolose dal punto di vista della penetrazione a livello criminale,
massonico e paraistituzionale? Con il suggello politico di Francesco Belsito
questa cricca segereta, aveva creato “rapporti criminogeni per milioni di euro
creando utili sotto forma di crediti d’imposta per riciclare i soldi sporchi.”
Tra queste società c’erano Fincantieri, e la multinazionale Siram, che godeva di
rapporti preferenziali sia con la regione Lombardia, di Roberto Formigoni, sia
con quella Calabria di Giuseppe Scopelliti. Calabria e Lombardia, unite a colpi
di Iban, di transazioni e , di triangolazioni tra società “amiche”. Tutte
veicolate in quegli uffici a Via Durini, nella MGiM dove l’ex tesoriere dei Nar,
Lino Guaglianone mediava gli affari sporchi per la ndrangheta, la Lega,
gli imprenditori in odor di mafia e massoneria come l’armatore Matacena, ex
deputato di Forza Italia, condannato per concorso esterno e ora latitante e
Montesano, tycoon calabrese finito nei guai per bacarotta e intestazione
fittizia di beni con aggravante mafiosa, e con legami alla Bocconi. D’altronde
già nel 1993 il pentito di Cosa Nostra, Tullio Cannella dichiarava ai pm di aver
saputo da Vito Ciancimino che la vera massoneria era in Calabria, perché i
calabresi hanno appoggi dei servizi segreti. “A Lamezia Terme- racconta Cannella
– si tenne la riunione con esponenti di “Sicilia Libera”, altri movimenti
separatisti meridionali, e ed esponenti della Lega Nord.” Non deve quindi
sorprendere il blitz di qualche giorno fa della Direzione Investigativa
Antimafia, a firma del pubblico ministero della Dda reggina Giuseppe Lombardo e
di Francesco Curcio, sostituto Nazionale Antimafia, coordinati dal procuratore
di Reggio Calabria, Federico Cafiero de Raho. Al setaccio oltre 25 società,
quattro filiali di Banca Intesa, una del Credito Artigiano e una della Banca
Popolare di Vicenza, dove lavora uno dei componenti della società segreta, Ivan
Pedrazzoli. Gli uomini del colonnello Gianfranco Ardizzone, erano a caccia di
conti correnti serviti per far transitare fondi di provenienza illecita per poi
essere riciclati. La “cricca masso-ndranghetista” grazie alle coperture
politico-istituzionali e finanziarie dei loro componenti, muoveva centinaia di
milioni di euro. Ma ora, i reati sono associazione a delinquere finalizzata ad
agevolare la cosca De Stefano e violazione della legge Anselmi sulle società
segrete, istituita proprio dopo l’indagine sulla P2 di Licio Gelli, figura con
la quale i De Stefano hanno intrattenuto rapporti anche grazie all’ex deputato
del Psdi, Paolo Romeo, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa,
per aver favorito la cosca. Tra gli indagati e organizzatori di questa “società
criminale segreta” figurano: Pasquale “Lino” Guaglianone, una condanna per
terrorismo, ex politico vicino a Ignazio La Russa. Con il socio Giorgio
Laurendi, anche lui indagato, fonda la Mgim. Pasquale Guaglianone sfrutta bene
le amicizie politiche e accumula incarichi prestigiosi ma sarebbe stata
strategica per la cricca la sua posizione in Fiera Milano Congressi, che è
diventata recentemente il partner ufficiale e organizzatore di spazi dell’Expo
2015. Altro organizzatore, sarebbe Bruno Mafrici, nominato consulente del
ministero della Semplificazione da Belsito che ne era sottosegretario. Sarà così
che aiuterà gli “amici” ad entrare nella cuccagna dei bandi e degli investimenti
statali. Ma Mafrici, cura anche i rapporti con i politici calabresi tra cui il
governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti. Proprio di Scopelliti è amico e
alleato politico un altro indagato, Giuseppe Sergi. Nella lista spunta un altro
importante imprenditore reggino Michelangelo Tibaldi, che rilevò le azioni della
Fiat in Multiservizi, una società mista del comune di Reggio Calabria che è
risultata in mano alla ndrangheta della cosca Tegano L’intreccio
cosche-amministratori della Multiservizi è uno dei fattori che ha portato allo
scioglimento per contiguità mafiose del comune di Reggio Calabria nell’ottobre
2012. Ma la storia del colosso torinese che investe in una società proprio a
Reggio Calabria è un’altra storia sulla quale bisognerà fare chiarezza. Un ruolo
di supporto lo fornivano Angelo Viola, investigatore privato, e Romolo
Girardelli, ex estremista di destra e uomo dei De Stefano per gli affari in
Liguria. Ma nel decreto di perquisizione i pubblici ministeri non dimenticano di
citare Paolo Martino, ambasciatore dei De Stefano in Lombardia ed oltre. Martino
ha frequentazioni strategiche. Tra queste Luca Giuliante, legale di Roberto
Formigoni (oltre che di Lele Mora e “Ruby”) ma soprattutto membro regionle del
PdL e tesoriere per la Lombardia del partito di Silvio Berlusconi. Giuliante
viene intercettato mentre parla con il boss Martino dandogli delle dritte su una
gara d’appalto che avrebbe interessato la ditta Mucciola, famiglia romana di
imprenditori con sede a Reggio Calabria e cliente della Mgim che poi si
aggiudicò dei lavori al Pio Albergo Trivulzio. La Mucciola spa è tra le aziende
perquisite nel blitz. Questo “cerchio criminogeno” ha consentito agli indagati
di diventare il terminale di un sistema criminale occulto, che riusciva ad
acquisire e gestire proficuamente informazioni riservate fornite da soggetti che
sono ancora in corso di individuazione, ma sicuramente facenti parte delle
istituzioni. Come già confessato da Francesco Belsito, i “colonnelli” della
Lega, come l’ex ministro della Giustizia Roberto Castelli erano conoscenza delle
perquisizioni prima che avvenissero. Si può dedurre, quindi, che tra le “talpe”
del Carroccio ci siano addirittura dei magistrati. I prossimi sviluppi si
attendono dalle rogatorie richieste in Tanzania, a Cipro e soprattutto in
Svizzera dove la cricca aveva un base a Lugano.
Cari amici di blog, scrive Roberto Galullo, da
giorni sto analizzando con voi alcuni passaggi dell’audizione del procuratore
aggiunto di Reggio Calabria, Nicola
Gratteri, resi in Commissione parlamentare antimafia il 14
aprile. Con la solita eccezionale schiettezza, quando si è trattato di parlare
di politica e mafia, Gratteri
non si è certo tirato indietro, sapendo perfettamente che di fronte si trovava
anche parlamentari calabresi. Nel servizio di due giorni fa abbiamo visto il suo
pensiero sulla politica calabrese, ritenuta debole, e il perenne dilemma della
politica locale se ceder o meno al voto di scambio. Ieri abbiamo visto come,
secondo il procuratore antimafia, si formano le liste elettorali in Calabria (e
non solo). Oggi cambiamo pagina e leggiamo un “ritorno” di
Gratteri sull’evoluzione della ‘ndrangheta. L’incipit è
duro, perché richiama gli errori che furono commessi (e amplificati da una
stampa nel migliore dei casi ignorante in altri “galoppina”) nell’ormai
famosissima (e ripeto spesso io, comunque importantissima) operazione
Crimine/Infinito sull’asse Milano-Reggio Calabria (o il contrario, fate
voi). «Quando sono state condotte l'operazione
Crimine a Reggio
Calabria e l'operazione
Infinito a Milano – ha infatti dichiarato
Gratteri – è stato commesso
un grave errore di valutazione. È stato detto, in sede di conferenza stampa, che
è stato scoperto il Riina
della Calabria, Oppedisano
Domenico, e che era stata scoperta la cupola, come nel
caso di cosa nostra. Questa è una sciocchezza. La ’ndrangheta non è piramidale
come Cosa nostra. All'interno di un locale di ’ndrangheta nessuno può
interferire. Il crimine di San Luca, che è erroneamente stato rapportato alla
cupola di cosa nostra, non è altro che il custode delle regole. Il crimine è il
custode delle dodici tavole. Il crimine esiste per presiedere il rispetto delle
regole. Il crimine interviene quando c’è una faida all'interno di un locale,
come è successo a Locri nel 1989». Per rafforzare il concetto (è
Gratteri e non l’umile
cronista che leggete, a parlare di “grave errore” e “sciocchezze”),
ricorda che da aprile 1970 (a seguito di una sentenza del Tribunale di Locri
colpevolmente dimenticata), si conosce l’unitarietà della ‘ndrangheta,
Gratteri ribadisce che, appunto
«esiste l'unitarietà della ’ndrangheta, ma ripeto che sulla vita economica,
politica e strategica all'interno del locale nessuno può interferire, a meno che
non si vìolino le regole della ’ndrangheta e il crimine di San Luca non
intervenga per dirimere la faida». Come sapete (chi mi segue lo sa) non è
un caso che l’unitarietà della ‘ndrangheta è un tema che poco mi appassiona ma
al quale molto grato sono se serve (come è accaduto con un punto ormai pressoché
fermo posto in sede di appello del processo Crimine a Reggio Calabria) per
mettere un punto fermo giudiziario e andare oltre per attaccare frontalmente la
ndrangheta 2.0 che corre molto più velocemente delle stesse verità giudiziarie.
Mentre l’audizione si appresta alla conclusione
Gratteri dirà ancora: «Il
capo crimine non fa business, non fa affari. È il custode delle regole. Qual è
l'importanza del custode delle regole? La differenza è che, se si arresta un
camorrista, ci vogliono uno schiaffo per farlo parlare e due per farlo stare
zitto. Se si arresta un calabrese, uno ’ndranghetista, si fa vent'anni di
carcere e sta zitto, perché sa che dovrebbe parlare prima di 200 parenti, poi
degli amici e poi degli amici degli amici. Per questo motivo non ci sono
collaboratori nella ’ndrangheta ». Tracciato questo quadro (visto
che non c’ero e non lo so, sarebbe stato meglio se
Gratteri avesse anche ricordato
chi, in sede di conferenza stampa spacciò il Crimine per la cupola e il
Riina della Calabria don
Mico Oppedisano: a
proposito, viste le intdegne critiche che mi sono piovute addosso negli anni da
chi ha volutamente inteso stravolgere il senso del mio pensiero, non chiamerò
più don Mico “venditore
di piantine” visto che non lo chiama più così neppure lo storico inventore
della definizione, vale a dire…lo stesso
Gratteri!!!) il procuratore
aggiunto di Reggio Calabria ha parlato anche di evoluzione della ‘ndrangheta. A
sorpresa (ma solo per chi non studia e si fa affabulare dalle veline
pronto-consumo spacciate ovunque dalle classi dirigenti di questo Paese)
Gratteri ha affermato l’ovvio
(ma l’ovvio non è conosciuto da chi non studia). «L’evoluzione della
’ndrangheta – ha dichiarato
Gratteri – è avvenuta nel 1969 , quando c’è stata una
rivoluzione interna alla ’ndrangheta con la creazione della Santa. La Santa
consiste nella possibilità per uno ’ndranghetista di essere affiliato anche alla
massoneria deviata. Questo è servito alla ’ndrangheta per avere contatti con i
quadri della pubblica amministrazione e, quindi, con medici, ingegneri e
avvocati. Un collaboratore di giustizia ci ha spiegato che «all'orecchio del
Gran Maestro» possono essere affiliati tre incappucciati. Ciò vuol dire che
questi sono conosciuti solo al Gran Maestro. Lo stesso collaboratore ci ha
spiegato che anche alcuni magistrati hanno partecipato a riunioni della Santa.
Su questo, però, non siamo riusciti ad avere riscontri». E poco dopo
Gratteri ancora dirà: «Oggi
noi abbiamo gente incensurata che gestisce la cosa pubblica in modo mafioso. Il
mafioso non va a chiedere la mazzetta, ma è lì; è una persona pubblica, un
medico o un ingegnere». Parlando di massoneria deviata (le logge
coperte e non ufficiali sono il collante della ‘ndrangheta 2.0),
Gratteri confermerà che «è
nata nel 1969-1970 con la Santa. Lo stesso ’ndranghetista, al contempo santista,
partecipa alla massoneria deviata per entrare nei quadri della pubblica
amministrazione. Per arrivare a questo c’è stata una guerra sanguinosa in
provincia di Reggio Calabria. È stato
ucciso Antonio Macrì, ed è stato ucciso
Don Mico Tripodo,
nel carcere di Poggio Reale, da due cutoliani, per conto dei
De Stefano di Reggio
Calabria». Semplice, lineare, efficace. Perfetto. Eccola la nuova
‘ndrangheta che si evolve. Non da oggi. Dal 1969. Pensate quanti anni sono stati
persi per rincorrere la “vecchia” ‘ndrangheta, quella che si alimentava solo di
rapimenti e droga. «Oggi, invece la ’ndrangheta vive con noi e si nutre con
noi»: ancora una volta, di fronte ai commissari antimafia, parole e musica
(mortali) di Gratteri
che io, umilmente, mi limito a sottoscrivere a pieno.
Cari amici di blog, da ieri sto analizzando alcuni
passaggi dell’audizione del procuratore aggiunto di Reggio Calabria,
Nicola Gratteri, resi in
Commissione parlamentare antimafia il 14 aprile 2014. Con la solita eccezionale
schiettezza, quando si è trattato di parlare di politica e mafia,
Gratteri non si è certo tirato
indietro, sapendo perfettamente che di fronte si trovava anche parlamentari
calabresi. Nel servizio di ieri abbiamo visto il suo pensiero sulla politica
calabrese, ritenuta debole, e il perenne dilemma della politica locale se ceder
o meno al voto di scambio. Oggi continuiamo su questo filone, con riferimento
alla formazione delle liste. Il ragionamento di
Gratteri è stato indotto da una domanda della
parlamentare del Pd Enza Bruno Bossio,
che ha introdotto il discorso delle liste con il caso di Limbadi (Vibo
Valentia), comune che deve andare al voto e dove anche i sassi sanno che la
cosca Mancuso controlla
pure i respiri. «Il vero problema è come fare in modo che le liste di tutti
i partiti di coloro che saranno nominati nelle prossime elezioni a Limbadi
– ha affermato Bruno Bossio
– siano assolutamente a prova di antimafia. Questo, secondo me, dovrà essere
il vero problema che ci dovremo porre, in maniera tale che chi entra nel comune
democraticamente, non come commissario, chiunque vinca, sia in grado di fare
effettivamente quella bonifica. Ripeto, io sono convinta che la maggioranza
della popolazione abbia tutt'al più paura, ma non sia coinvolta. Occorre,
quindi, controllare le liste. Il vero problema sarà non solo fare in modo che
questo non sia semplicemente un problema deontologico ed etico di ciascun
partito, ma come effettivamente impedire che nelle liste ci siano degli elementi
in collegamento con la mafia, com'era esplicitamente indicato nella relazione
della Commissione d'accesso a proposito di questa giunta comunale.
Non entro nel merito del 416-bis e del 416-ter. Non ho le competenze che ha
lei e che avete voi, ma sicuramente un problema me lo pongo. Io sono stata tra
coloro che hanno fatto una battaglia perché nell'Italicum ci fossero le
preferenze, ma vedo molto difficile il voto di scambio con le liste bloccate. È
così. Il tema non può riguardare il singolo parlamentare». Un
ragionamento concreto che pone quesiti di non poco conto, dalla enorme
difficoltà. Ed infatti Gratteri
lo affronta con misura, senza però farsi mancare le stoccate alle ipocrisie di
una classe politica (tutta) che fa finta di non vedere in Calabria come nel
resto d’Italia. «Lei parlava delle liste – dice rivolgendosi a
Bruno Bossio e alla Commissione
tutta – . La storia è molto delicata. Quando si fanno le liste, non si può
dire che in un Paese di 5.000 abitanti non si conoscono le persone. Si inserisce
nella lista scientificamente un rappresentante della famiglia di ’ndrangheta.
Gli ’ndranghetisti sono molto prolifici. Ognuno di loro fa sei figli, che a loro
volta fanno altri sei figli. Un locale di ’ndrangheta è composto da due o tre
famiglie patriarcali, cioè da 500-600 persone. In un posto in cui ci sono 5.000
abitanti ci sono 2.500 elettori. Quando io ti presento, ti metto in una lista un
rappresentante, un cugino alla lontana. Lì siamo tutti i cugini. Ci sono paesi
in cui ci sono quattro cognomi. Nel Novecento c'erano due famiglie che si sono
sposate tra di loro quattro volte. Basta mettere un elemento: la lista è fatta e
le elezioni sono vinte. Noi lo mettiamo, poi, se ci scoprono, va bene, ma
intanto abbiamo governato due o tre anni. Poi cadiamo dalle nuvole e diciamo che
non sapevamo chi fosse questa persona. Non è possibile. Questo è un problema di
etica, di morale e di deontologia dei politici e di chi fa le liste, perché non
può dire che non sa. Non siamo a Pordenone, anche se questo è vero anche a
Pordenone. L'altro giorno io ero in Friuli Venezia Giulia. Sono sempre paesi
piccoli, dove ci si conosce tutti. Il politico non può dire che non sapeva chi
fosse questa famiglia mafiosa o che non sapeva che quell'altra fosse mafiosa.
Stiamo scherzando? Scientificamente, si opera così. Le liste vengono fatte con
questi criteri, non in base alla competenza o all'amore per la politica, ma al
numero di voti che uno porta. Questo è un problema che riguarda tutta Italia,
dalla Valle d'Aosta alla Sicilia. Quanto al discorso della lista, normativamente
come faccio io a un incensurato a dire che non si può candidare, solo perché è
cugino del capomafia? Non posso creare una norma su questo punto. Il
problema è la politica. Non vi lamentate poi che sono i magistrati che si
sostituiscono alla politica. Su queste cose non può intervenire la magistratura.
Ricordate sempre che la magistratura interviene sempre dopo, non fa prevenzione.
Interviene dopo che c’è il reato». Insomma, un richiamo bello e buono
ad una piena assunzione di responsabilità da parte di chi “non può non sapere”,
vale a dire la politica. Più semplice (e vero) di così si muore.
Pane al pane e vino al vino.
Nicola Gratteri, procuratore
aggiunto della Repubblica di Reggio Calabria, è fatto così. Prendere o lasciare.
C’è chi lo ama (la gente comune) e chi, non potendolo comunque non amare o
rispettare, lo ignora (buona parte della magistratura che snobba quella sua
ruspantezza che poco si addice ai piani alti delle presunte ed eccelse classi
dirigenti italiane). Tutti (impossibile non farlo), ne apprezzano le qualità
professionali e umane che, talvolta, vengono tirate per la giacchetta dalla
politica. Calabrese (ammesso che esista) ed italiana (ammesso che esista). In
questo momento, ad esempio, in Calabria, destra, centro e sinistra (ammesso che
esista una differenza reale in quella regione) si sparerebbero in una gamba pur
di candidarlo alla tolda di comando della Regione, visto che il Governatore
Giuseppe Scopelliti è
uscente. Lui li lascia fare e spero non ceda mai alla tentazione di avere a che
fare con la politica calabrese (di ogni colore). Verrebbe sbranato. Una prova
della sua schiettezza, Gratteri
l’ha data (dico io fortunatamente) ancora una volta il 14 aprile in sede di
audizione in Commissione parlamentare antimafia (di questo mi occuperò in questo
umile e umido blog nei prossimi giorni). Il discorso, ad un certo punto, è
scivolato proprio sulla politica. Ecco cosa ha detto
Gratteri. «Mi rendo conto
della difficoltà della politica calabrese. È una politica debole. I parlamentari
calabresi sono molto deboli. Sono pochi e, inoltre, c’è il dilemma se nelle
ultime quarantott'ore si debba cedere al voto di scambio o meno. Sul palco tutti
diciamo che non vogliamo i voti della mafia. Bisogna vedere l'ultima o la
penultima notte che succede». E tenete conto che di fronte aveva anche i
parlamentari calabresi, come quella
Dorina Bianchi (Ncd e scopellitiana di ferro) che pochi minuti
prima aveva detto: «Le dico un'altra cosa, però: noi, come classe politica
calabrese, abbiamo una difficoltà reale nel momento in cui andiamo a gestire le
comunità locali, in primo luogo se non se ne fa parte e non le si conosce. Pur
avendo io vissuto tutta la mia vita a Crotone, le devo dire che in una
circostanza, peraltro di una manifestazione anti-’ndrangheta, mi sono trovata
vicino a uno dei figli degli
Arena, il quale si è presentato a me e mi ha chiesto se
fossi una giornalista. Io non l'ho riconosciuto. Le faccio questo esempio per
dirle che non sempre è semplice da parte dei calabresi conoscere realmente il
fenomeno». Un azzardo rifugiarsi dietro il “ma come faccio a sapere”, visto
che poco prima Gratteri,
non in risposta a Bianchi
ma nella sua introduzione, aveva detto che: «Oggi, invece, sono i politici
che vanno a casa dei capimafia, a chiedere pacchetti di voti in cambio di
appalti. Mediamente in Calabria i paesi hanno 5.000 abitanti. Tutti ci
conosciamo e nessuno può dire di non sapere chi è il mafioso. È impossibile,
perché siamo nati nello stesso paese di 5.000 o 15.000 abitanti. Non puoi dire
che non sai chi è il mafioso, chi è il faccendiere, chi è il politico, chi è la
persona onesta. Lo sappiamo tutti. Eppure anche la Chiesa, anche i preti, anche
i vescovi hanno detto che non possono chiedere il certificato penale. Se sei
vescovo da dieci anni in quel paese, non mi puoi dire questo. Questa risposta
non mi appaga. È una foglia di fico. Oggi se è il politico che va a casa del
capomafia a chiedere i voti, vuol dire che nel comune pensare e sentire si
ritiene che il modello vincente è il capomafia. Perché il capomafia interviene
anche sulla ristrutturazione di un marciapiede da 20.000 euro? Con tutti quei
soldi si interessa pure di un marciapiede? Sì, perché lui farà lavorare per
venti giorni cinque padri di famiglia per quel lavoro, e quando sarà ora di
votare quei cinque padri di famiglia si ricorderanno di votare per il candidato
prescelto dal capomafia». Per il momento mi fermo qui ma domani
torno con un altro approfondimento dell’audizione di
Gratteri, perché ha avuto il coraggio di mettere
soprattutto la politica calabrese nuda davanti alla sua pochezza. Senza guardare
in faccia a nessun colore politico.
Maroni o massoni?,
si chiede “Dagospia”. La Lega al centro di un intreccio torbido tra poteri
occulti e ‘ndrangheta. Ora bisogna solo dare un nome (P7? P8?) alla loggia
masso-mafio-legaiol-fascista che emerge dall’inchiesta sugli “amici” di Belsito
- Una “piovra” affaristica e criminale che si da Reggio Calabria raggiunge il
Nord ed è arrivata a sfiorare Flavio Tosi… Scrive
Guido Ruotolo per "la
Stampa". Spunta la massoneria
nella inchiesta su Lega e 'ndrangheta. Seguendo l'odore dei soldi della potente
cosca De Stefano, i magistrati reggini e gli uomini della Dia trovano prima il
cerchio magico di Umberto Bossi, di Francesco Belsito l'ex tesoriere che investe
i soldi del Carroccio usando gli stessi canali della cosca. E adesso, inseguendo
gli amici di Belsito, i Pasquale Guaglianone e Bruno Mafrici, si trovano i
leghisti «buoni», come il sindaco Flavio Tosi. C'è di peggio, per la verità,
perchè questo cerchio magico del malaffare è in contatto con gli impronunciabili
di una tragica stagione del terrore. Come Delfo Zorzi, terrorista nero di piazza
Fontana rifugiato in Giappone, che viene intercettato al telefono con l'ex
cassiere dei Nar, Pasquale Guaglianone - conversazioni di quest'inverno - a cui
chiede di salutargli anche Bruno Mafrici. E Guaglianone è amico dell'ex sindaco
di Reggio oggi governatore Calabrese, Giuseppe Scopelliti. Otto indagati per
nuove contestazioni di reato: l'associazione mafiosa e l'organizzazione segreta
punita dalla legge Anselmi. Una ventina di perquisizioni a Milano, Genova e
Reggio Calabria. Gli uomini del colonnello Gianfranco Ardizzone, capo centro Dia
di Reggio Calabria, sono andati anche in quattro filiali milanesi dell'istituto
SanPaolo, alla Banca popolare di Vicenza e al Banco del Credito Artigianale.
Vediamo gli indagati: Romolo Girardelli, «l'ammiraglio», colonna genovese degli
affari immobiliari della cosca De Stefano. Una new entry, Giuseppe Sergi, ex
consigliere comunale di Reggio Calabria, legato a Scopelliti. E poi Michelangelo
Maria Tibaldi, imprenditore socio di minoranza della Multiservizi, società
partecipata del comune di Reggio proprietà nei fatti della 'ndrangheta. E poi
Angelo Viola, investigatore privato genovese indagato per il dossieraggio
(tabulati telefonici, servizi fotografici) di Belsito nei confronti di Bobo
Maroni. E soprattutto Pasquale detto Lino Guaglianone e Bruno Mafrici. Il primo
è il titolare di quella «Mediobanca» del mondo (opaco) delle imprese reggine,
dove nascono imprese, si suggellano affari e commesse, che sono gli uffici di
Mgim srl di via Durini 14, a Milano. L' ex cassiere dei Nar, Guaglianone,
secondo gli investigatori della Dia ha tentato prima di inserirsi nel mondo
istituzionale attraverso Ignazio La Russa e Alessandra Mussolini, poi
agganciando» la Lega di Tosi attraverso comuni amici «naziskin» frequentati
nella Palestra Doria di Milano. E poi c'è lo pseudo avvocato, che avvocato non
è, Bruno Mafrici. Nel decreto di perquisizione si legge che gli indagati sono
sospettati di far parte di una associazione criminale al cui interno «opera una
componente di natura segreta, collegata alla cosca De Stefano». Obiettivi e
finalità della struttura massonico-mafiosa: «Complesse attività di riciclaggio e
reimpiego di capitali di provenienza illecita. Attraverso le relazioni personali
con Francesco Belsito l'obiettivo è consolidare e implementare la capacità di
penetrazione e di condizionamento mafioso nel mondo politico-istituzionale». La
cupola, la struttura criminale riservata, ha ai suoi vertici organizzativi:
«Bruno Mafrici, Pasquale Guaglianone, Giorgio Laurendi, noti professionisti di
origine calabresi, inseriti in multiformi contesti politici». E ancora: «Gli
imprenditori reggini Michelangelo Tibaldi e Giuseppe Sergi (che ricopre anche
incarichi politici e istituzionali di rilievo locale); con ruoli di ausilio
informativo e di supporto, Girolamo Girardelli, Angelo Viola e Ivan Pedrazzoli».
Colpisce la descrizione di questa che appare una moderna «Spectre»: «La gestione
di operazioni politiche ed economiche ha consentito alle persone sottoposte ad
indagini scrivono nel decreto di perquisizione i pm antimafia nazionale
Francesco Curcio e di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo - di divenire il
terminale di un complesso sistema criminale, in parte di natura occulta,
destinato ad acquisire e gestire informazioni riservate, che venivano fornite da
numerosi soggetti in corso di identificazione collegati anche ad apparati
istituzionali». Non è una novità per la Calabria, questo scenario. Franco Freda,
il terrorista nero, fu ospitato da latitante negli anni '70 proprio dalla cosca
De Stefano. A Lamezia Terme, a cavallo della stagione stragista del '92 e '93 si
tennero incontri delle Leghe meridionali e non solo con Cosa nostra, con Vito
Ciancimino. Anche l'esistenza,di una superloggia massonico-ndranghetista emerse
nella inchiesta del pm Enzo Macrì, anni 90.
Legami tra Lega e 'ndrangheta,
Tosi: "Fandonie, mai conosciuto Belsito". Il vice segretario della Lega, e
segretario veneto del partito risponde alle accuse mosse su presunti accordi tra
la mafia calabrese e i vertici del Carroccio: "Come accostarmi al Mostro di
Firenze", scrive “Verona Sera”. Non
conosco nessuna delle persone alle quali un articolo di stampa, parlando di
logge massoniche e 'Ndrangheta, ha accostato oggi incredibilmente il mio nome.
Tantomeno il signor Belsito e i suoi affari: credo non dico di non aver mai
parlato con lui, ma nemmeno di averlo mai salutato e, come ampiamente riportato
in passato dagli organi d'informazione, nella Lega ero tra i suoi avversari
dichiarati". Lo afferma il vice segretario della Lega, e segretario veneto del
partito, Flavio Tosi, commentando notizie giornalistiche sugli sviluppi
dell'inchiesta sull'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito.
La Direzione distrettuale antimafia di Reggio
Calabria sta indagando da alcune ore sul presunto riciclaggio di denaro della
cosca di 'ndrangheta dei De Stefano, operazione nella quale è
indagato anche l'ex tesoriere del Carroccio, Francesco Belsito. "Trovo anche più
assurdo parlare di tentativi di aggancio alla Lega di Tosi - aggiunge - tramite
fantomatici amici di una palestra di Milano a me sconosciuta quanto i suoi
presunti frequentatori. Scrivere che io
possa avere rapporti con logge massoniche o la mafia calabrese è come
attribuirmi rapporti con Jack lo squartatore o il Mostro di Firenze.
Mi riservo, ovviamente, ogni azione legale a tutela della mia onorabilità". Sul
tema era già intervenuto anche il vice-segretario federale del Carroccio, Matteo
Salvini: "Gli sviluppi dell'inchiesta di Reggio Calabria sull'ex tesoriere della
Lega sono fuffa estiva: a qualcuno fa comodo accostare la Lega
alla mafia", aveva dichiarato. "La Lega - ha aggiunto parlando delle notizie
pubblicate fra ieri e oggi - non c'entra niente con la 'ndrangheta. E se
qualcuno c'entra è già stato cacciato".
Verona, "Tangenti in Veneto per la Lega Nord".
Belsito ai pm: "Zaia e Tosi sapevano". L'ex tesoriere del Carroccio mette a
verbale le accuse contro i dirigenti per un prsunto pagamento di un milione di
euro da parte di una multinazionale francese degli appalti ospedalieri. Partono
querele, scrive “Verona Sera”. "Belsito
è uno che non è la prima volta che tenta queste sortite: la prima volta ha detto
che era noto a lui che andavo a pranzo con imprenditori per incassare soldi,
tangenti e robe del genere. Ed è stato un po' sfortunato perché
io ai pranzi non vado mai, quindi gli è andata male. Questa volta leggo che dice
che 'Zaia comunque sapeva che c'era qualcuno che andava in cerca a chiedere
soldi' ". E' secca la replica del presidente della Regione Veneto Luca Zaia alle
accuse che avrebbe lanciato, parlando con i pm per ore, l'ex tesoriere della
Lega Nord, Francesco Belsito. Quest'ultimo in un passaggio con i magistrati,
riferito oggi da Repubblica, ricostruisce il pagamento di un milione di euro
alla Lega del Veneto da parte di una multinazionale francese specializzata in
appalti ospedalieri, la Siram. Belsito avrebbe affermato che tutto lo stato
maggiore del partito era informato di quel finanziamento. "Anche
Zaia - è la tesi dell'ex tesoriere del Carroccio - fu informato".
"Rispedisco al mittente queste affermazioni - sottolinea Zaia - mi spiace perché
avrei qualcos'altro di cui occuparmi. Penso che anche la magistratura abbia
altro di cui occuparsi però a questo punto la impegnerò io facendo un querela,
tutelandomi. Spero che si faccia chiarezza da subito.
Stiamo parlando comunque di una persona che,
tra le tante cose, abbiamo scoperto aveva una Porsche pagata dalla Lega, tra
l'altro ora sequestrata. E' imbarazzante. Rimando tutto al
mittente. Sono a disposizione dei magistrati e querelo, assolutamente querelo".
Ma non solo. Secondo l'ex tesoriere del carroccio, l'ex presidente del Consiglio
regionale del Veneto, Enrico Cavaliere, indagato per corruzione per una presunta
tangente da 850mila euro che avrebbe ricevuto assieme ad un ex manager dalla
Siram, faceva parte di una "cordata" della Lega e "rispondeva
al sindaco di Verona, Flavio Tosi, e a Roberto Maroni, che erano i suoi diretti
superiori". Questo quanto ha messo a verbale lo scorso 15 luglio
dall'ex tesoriere, indagato nell'inchiesta "The Family". Dalle dichiarazioni di
Belsito sul caso Siram è nata una nuova tranche d'indagine. Durissima la
replica, a caldo, del sindaco Tosi: "Si parla di un episodio - spiega ai
microfoni di Radio Verona - che risale al 2010. Io sono segretario della Liga
Veneta da un anno o poco più. Questo da' la dimensione: tant'è che io son
diventato segretario con Maroni alla guida, dopo gli scandali, per far pulizia
in Lega. Le affermazioni vengono da una
persona schifosa come Belsito, che io non ho mai avuto nemmeno l'occasione di
salutare. Non ho mai avuto rapporti con lui nè con il cosiddetto
'cerchio magico' nè tantomeno con chi girava attorno a quelle situazioni. Penso
che il paragone più appropriato con la persona di Belsito sia quello con un
escremento. E si rischia di offendere l'escremento. Da un soggetto come lui, che
ne ha fatte di tutti i colori e che girava in ambienti torbidi, c'è da
aspettarsi di tutto. Dopo le dichiarazioni rilasciate alla stampa, il presidente
Zaia ha dato mandato al proprio legale di presentare denuncia per calunnia e una
querela per diffamazione nei confronti di Belsito. Analoghi provvedimenti
potrebbero essere presi dal sindaco di Verona, dal neosegretario della Lega,
Matteo Salvini, e dal presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni.
Report inguaia Tosi, a cena con la 'ndrangheta',
scrive “L’Ansa”. L'ira del sindaco: Chi getta fango è disperato. Report inguaia
Tosi. La trasmissione andata in onda ieri sera parte con un servizio sul caffè,
poi si passa al sindaco di Verona e la Gabanelli annuncia che il giornalista
autore dell'inchiesta su come funzionano le tangenti in ambito Lega, Sigfrido
Ranucci, è stato querelato anche per il presunto pagamento di denaro per
ottenere un fantomatico video hard con Tosi protagonista. Delle immagini nel
servizio Rai non c'è traccia e l'inchiesta passa ai rapporti tra Tosi e alcuni
calabresi, indagati o coinvolti in indagini sulla ’ndrangheta e la malavita
organizzata. Coinvolta anche la moglie del sindaco veronese Stefania
Villanova, responsabile della segreteria dell’assessore regionale alla Sanità. A
cominciare da una cena a Crotone, con Tosi a fianco di Stanislao Zurlo,
presidente della locale Provincia per il quale fu chiesto il rinvio a giudizio
per concorso esterno in associazione mafiosa. Ranucci racconta che la cena fu
organizzata da Katia Forte, consigliera comunale della Lista Tosi . A capo della
tavolata c’è Raffaele Vrenna, presidente del Crotone calcio, condannato in primo
grado per concorso esterni mafioso e poi assolto. Dopo la trasmissione, Katia
Forte ha specificato: "La cena di Crotone è stata pagata da me e mio padre".
Ranucci spiega che di Raffaele Vrenna hanno parlato tre collaboratori di
giustizia. Uno è Luigi Bonaventura che indica tra i boss orbitanti al Nord. Poi
Francesco Sinopoli, candidato ed eletto nella Lista Tosi. I Giardino, secondo il
racconto di un imprenditore, sono stati presenti nelle cene organizzate per la
campagna elettorale di Tosi e del suo assessore di origine calabrese, Marco
Giorlo». Nell'intervista un uomo racconta che
a quelle cene si parlava di appalti «con il sindaco Tosi» e al quesito se
c’erano anche altri politici dice «c’era Casali, (l’attuale vicensindaco Stefano
Casali) e Marco Giorlo». Ma Casali precisa che lui in Calabria non c’è mai
stato. Nel servizio parte la sequela su quello che è ormai l’ex assessore allo
Sport, trombato da Tosi proprio per le sue dichiarazioni «sventate» a Report.
"Se uno va a vedere, chi mi getta fango è gente disperata, prove zero,
reati zero", ha detto Flavio Tosi commentando l'inchiesta andata in onda nella
trasmissione Report di Rai 3. "I personaggi
del servizio di Report non dovrebbero stupire nessun veronese: la Signora Katia
Forte - il cui padre, imprenditore nel settore delle pulizie, è personaggio noto
alle cronache giudiziarie della città- già nel '97 mi chiedeva la sala di
rappresentanza della Provincia di Verona per presentare una nuova iniziativa ad
opera di un imprenditore crotonese del settore della gioielleria, con la
partecipazione prevista del Presidente della Provincia di Crotone". Lo ricorda
Antonio Borghesi, già Presidente della Provincia di Verona, in relazione alla
trasmissione di Report di ieri sera.. "Allorché mi vennero segnalate le condanne
dell'imprenditore in questione, per legami con la criminalità organizzata
ritirai la mia disponibilità, ma la cosa ebbe comunque luogo - continua -. Al
tempo Flavio Tosi era segretario della Lega Nord". Borghesi si rivolge poi
direttamente a Tosi, dopo la trasmissione del servizio di Report. "Alla luce di
quanto emerso dalla trasmissione e dopo l' arresto del suo vicesindaco - dice -
il sindaco Tosi dovrebbe trovare la dignità di fare un passo indietro. E invito
tutti i veronesi ad avere il coraggio di conoscere quanto da anni vedono: legami
tra precise realtà imprenditoriali ed il potere amministrativo. Le solite
querele preventive non possono più tappare un vero e proprio vaso di Pandora".
Dopo la puntata di Report di ieri sera, è stata
presentata al prefetto di Verona una richiesta formale di accertamenti sulle
infiltrazioni mafiose nel Comune di Verona. A chiederla è stato un parlamentare
veronese di centrodestra, Alberto Giorgetti. Qualora il prefetto dovesse inviare
una commissione in Comune e l’indagine riscontrasse l’esistenza di
infiltrazioni, il Comune di Verona potrebbe essere sciolto per mafia. “Se le
cose dette da Report sono vere – ha dichiarato Giorgetti – ci sarebbe un
collegamento diretto tra la ‘ndrangheta e assessori o eletti appartenenti alla
maggioranza di Flavio Tosi, per cui secondo l’attuale normativa antimafia,
sussisterebbero automaticamente i presupposti per lo scioglimento”. Nel corso
dell’inchiesta di Report, è emerso il ruolo di alcune famiglie di costruttori
calabresi trapiantanti a Verona e molto vicini a esponenti di primo piano
dell’amministrazione Tosi. In particolare il collaboratore di giustizia Luigi
Bonaventura ha per la prima volta rivelato di aver partecipato alcuni anni fa a
un summit in cui erano presenti boss della ndrangheta calabrese e rappresentanti
di una famiglia di costruttori veronesi.
LA MASSONERIA ED IL POTERE.
MONTI, LETTA E RENZI, I TRE
CURIAZI INDIVIDUATI DALLA MASSONERIA REAZIONARIA PER PIEGARE ROMA,
scrive Francesco Maria Toscano su “Il Moralista”. Esiste un livello di potere
reale, all’interno del quale si scontrano anche soggetti apparentemente alleati,
e ne esiste un altro formale buono per motivare tifoserie oramai disabituatesi a
pensare criticamente. Passiamo dalla teoria alla pratica. Il profano,
osservando oggi in superficie la situazione politica italiana, potrebbe
convincersi del fatto che esista un centrodestra lacerato che si contrappone ad
un centrosinistra altrettanto lacerato nonostante la contingenza obblighi forze
certamente diverse ad una momentanea coabitazione indispensabile per
perseguire il solito e immancabile bene del Paese. Questa rappresentazione,
con l’aggiunta del pericolo antisistema rappresentato dall’impetuosa crescita
del movimento “populista” di Beppe Grillo, è falsa nonché buona per
convincere i polli. Nel vuoto ideale che contraddistingue tutti i partiti
presenti sulla scena pubblica, l’unico collante rimane il potere per il potere.
Tutti possono dire tutto e il loro esatto contrario a patto di trarne un
beneficio di corto respiro. Qualche esempio pratico? Il partito e i giornali di
Berlusconi hanno improvvisamente scoperto tutti i limiti dell’euro in
contemporanea con l’aggravarsi della posizione del vecchio leader, oramai
chiaramente abbandonato dai potentati massonici di ispirazione reazionaria che
governano questo mostro di Ue.
Fino a ieri, quando ancora dalle parti del Biscione si aspettava
fiduciosi un cenno di amicizia dai parte dei fratelli che contano,
nessuno osava volgere lo sguardo verso le sacre stanze del potere comunitario,
mentre tutti i reprobi nemici del divino Monti venivano tacciati a giorni
alterni di demagogia e populismo. Cioè, se l’Europa massacra i
cittadini ma tutela la posizione personale di Berlusconi, allora i sacrifici
cari a Bruxelles vanno accettati serenamente nel nome della verità e della
responsabilità (alias: abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità e
quindi dobbiamo soffrire); se invece l’Europa massacra i cittadini e
permette pure che si consumi la fine politica del cavaliere Berlusconi, allora
l’euro non funziona, la Merkel è cattiva e Monti è più ottuso del cane Empy.
E’ dignitoso trovare il coraggio di dire la verità soltanto quando si ritiene di
essere stati ingiustamente mollati? Per niente. Dalle parti del Pd sono pure
peggio, perché mentre Berlusconi recita e ricatta per tutelare se stesso, i
piddini mentono per conto terzi o, nella migliore delle ipotesi, per eccesso di
stupidità. Il viceministro Stefano Fassina, considerato il più a sinistra del Pd
(figuratevi gli altri…), poco prima delle elezioni di febbraio si faceva
intervistare da Financial Times promettendo la prosecuzione delle devastanti
politiche promosse da quel Mario Monti che ora fa ipocritamente fa finta di
disconoscere.
Dopo la dura presa di posizione del Tesoro americano contro le
politiche affamatrici della Germania, tanti piccoli uomini senza decoro né
dignità trovano finalmente il coraggio di dire a voce alta quello che erano
abituati per paura a sussurrare al buio e sottovoce. Dato quindi per scontato
che nessuno crede in nulla e tutti sono disposti a cambiare versione quando
ritengono di avvantaggiarsene sul piano privato, è ora arrivato il momento di
chiedersi: qual è la vera partita di potere che si sta giocando adesso
nell’ombra? Quella che vede come terminali di diverse cordate di interessi da
una parte l’attuale premier Enrico Letta e dall’altra il sindaco di Firenze
Matteo Renzi, entrambi strategicamente convinti di dover completare la
devastazione dell’apparato produttivo italiano quanto tatticamente divisi per
ragioni di potere personale. Le improvvise critiche riservate da quel buffone di
Olli Rehn e dal suo degno compare Mario Monti alla legge di stabilità
predisposta dal massone reazionario di rito draghiano Fabrizio Saccomanni vanno
lette in questa ottica. “Se non siete in grado di continuare a spremere a
sangue gli italiani”, questo il messaggio esoterico contenuto fra le righe
dell’analisi proposta dal vicepresidente della Commissione Europea, allora
fatevi subito da parte per lasciare spazio a Matteo Renzi, cavallo di Troia
nuovo di zecca pronto a dare il colpo di grazia a questi fannulloni di italiani
mangia-spaghetti”. Enrichetto Letta, infatti, si è spaventato precipitandosi
al convegno organizzato dal Financial Times per promettere di regalare ai
padroni quel che resta del patrimonio pubblico italiano nella speranza di
allungare la vita al suo meschino governo.
Monti è soltanto un brutto ricordo, Letta arranca mentre Renzi è
pronto per sfogare tutto il suo distruttivo potenziale. Finita tra le pernacchie
e la disperazione generale la parabola del sindaco di Firenze sarà poi possibile
cominciare a pensare alla ricostruzione di un’Italia piegata e afflitta come
alla fine della seconda guerra mondiale. Se è per davvero geometricamente
indispensabile che il nostro povero Paese finisca con l’essere brutalizzato a
turno da questi tre emissari (a diverso titolo) della massoneria reazionaria
sovranazionale, allora tanto vale augurarsi una rapida accelerazione degli
eventi. Rivedremo la luce solo dopo avere attraversato per intero il tunnel
dentro il quale una manina maligna ci ha sapientemente indirizzati.
Matteo Renzi: un
personaggio costruito dal Nuovo Ordine Mondiale,
scrive Nicola Bizzi su “Signoraggio”. È appena calato il sipario sull’ennesima
carnevalata renziana alla Stazione Leopolda di Firenze, evento su cui sono stati
puntati per due giorni tutti i riflettori dei media di regime, e si pone adesso
la necessità di alcune riflessioni e considerazioni. Viaggio spesso per motivi
di lavoro e devo ammettere che mi sono decisamente stancato, ogni volta che su
un treno, su un aereo, durante una cena o una conferenza, quando mi capita di
fare conversazione con qualcuno ed emerge il fatto che sono di Firenze, mi
vengano sempre rivolte le stesse raccapriccianti domande o le stesse
esclamazioni. Vale a dire: “Come è fortunato lei a vivere in una città
amministrata da Renzi!”; “Ha avuto modo di incontrarlo?”; “Ah, Firenze, la città
di Renzi!”, e così via…Un tempo Firenze era conosciuta per altri motivi,
soprattutto per l’Arte e la Cultura e per i capolavori del Rinascimento. A
cavallo fra gli anni ’80 e ’90 era nota soprattutto per le vicende del “mostro”
(il più gettonato argomento di conversazione di allora). Ma ho avuto modo
drammaticamente di riscontrare che oggi, per la maggior parte delle persone con
cui parlo, sia in Italia che all’estero, risulta inevitabile associare il nome
della mia città a quello di Matteo Renzi. Mi sono di conseguenza chiesto,
tentando anche di darmi delle risposte, come sia stato possibile che un
personaggio a mio avviso del tutto insignificante, palesemente inadatto a fare
un ragionamento politico profondo e di senso compiuto, e con un volto che
(almeno a me) non ispira alcuna simpatia, in sostanza una personificazione “del
nulla che avanza”, sia diventato oggetto di un simile clamore mediatico. Conosco
Matteo Renzi, ho avuto l’occasione di parlare con lui alcune volte, e vi
assicuro che, a parte le frivolezze di circostanza sui livelli di ozono in città
durante l’estate e sui goal della Fiorentina (a me il calcio poi neppure
interessa), ogni volta che ho provato a fargli una domanda seria sulla sua
progettualità politica o sull’economia, ha abilmente glissato e divagato,
pronunciando frasi di circostanza e guardando nervosamente l’orologio. Certo,
per carità, per Firenze, come Sindaco, qualcosa di buono lo ha saputo fare. La
città era governata da oltre vent’anni da una disgustosa cricca di potere
affaristico legato al carrozzone del vecchio PCI (poi trasformatosi
gattopardescamente in PDS, in DS e in PD) che faceva il bello e il cattivo
tempo, con conflitti di interesse di inaudita portata e sotto lo sguardo
compiaciuto e assente di una certa magistratura politicizzata. Divenuto Sindaco,
il “ragazzo” ha abilmente decapitato questo marcio sistema di potere
sostituendolo con una squadra di boy-scout composta per lo più da suoi coetanei,
magari animata da buona volontà, ma nella pratica, da un lato troppo inesperta
per governare bene una grande città e, da un altro (fortunatamente) ancora alle
prime armi per dedicarsi a tempo pieno alle ruberie della politica. Essendo
quindi stato chiamato dal solito elettorato con il prosciutto sugli occhi a
sostituire il peggiore e più odiato Sindaco che Firenze abbia mai avuto (quel
Leonardo Domenici che, come premio per i suoi fallimenti, è stato mandato al
Parlamento Europeo), era inevitabile che qualcosa di buono dovesse pur farlo.
Ma, a parte aver evitato lo scempio del passaggio di un tram delle dimensioni di
un Eurostar da Piazza del Duomo e aver ripavimentato alcune strade del centro,
l’ex “ragazzo prodigio” ha utilizzato sapientemente Firenze come palcoscenico
per proporsi alle masse come il volto nuovo, come una sorta di messia destinato
a cambiare l’Italia, come un nuovo ed ennesimo “salvatore della Patria”. In rete
esistono decine di siti che hanno tentato, mediante ragionamenti di largo
respiro, di interrogarsi su chi sia realmente Matteo Renzi e sui retroscena
della sua folgorante carriera politica che, da giovane militante dei comitati
per Prodi (buono quello!) lo ha visto divenire prima segretario provinciale del
PPI e poi della Margherita di Rutelli e di Lusi, poi, a soli 28 anni,
Presidente della Provincia di Firenze, poi Sindaco e, progressivamente, il
personaggio politico più presente in assoluto nei programmi televisivi. Quello
che, fra cene ad Arcore con il Cavaliere e incontri con Angela Markel e Obama,
attraverso il “verbo” della rottamazione e dichiarazioni pubbliche incentrate
sulla pochezza e sull’ovvietà, si sta candidando alla guida sia del PD e di
un’Italia che affonda. Ebbene, tutti questi siti, pur facendo giuste
osservazioni e ponendosi legittimi interrogativi sui suoi rapporti con la
Massoneria e con i poteri forti della finanza internazionale, non ci danno delle
risposte, non vanno oltre il pettegolezzo o le illazioni. A noi non interessa il
pettegolezzo. Quello lo lasciamo volentieri a Marco Travaglio e ad altri simili
servi del sistema. A noi interessa che la gente apra gli occhi sulla verità, sul
grande inganno nel quale siamo immersi fino al collo. A noi interessa constatare
e far capire quella che è ormai un’evidenza: Matteo Renzi è un massone figlio di
massoni! Non ci interessa il fatto che magari non si trovino le prove di un suo
effettivo “tesseramento”, di una sua affiliazione a qualche loggia. Renzi è
l’espressione più diretta ed immediata di quella culturalità massonica di cui si
servono i grandi burattinai del potere occulto per agire indisturbati ai danni
della società. Questa massonicità lo investe come individuo, come parte
integrante di un contesto politico di potere e come espressione di una cultura
che è e resta prettamente massonica. Per stessa ammissione del Maestro
Venerabile del Grande Oriente d’Italia Gustavo Raffi, fra le fila degli iscritti
al PD si contano oltre 4000 affiliati all’obbedienza di Palazzo Giustiniani
(vale a dire quasi un quinto dei tesserati del partito), la maggior parte dei
quali risultano in Toscana. E questo senza contare i tesserati che fanno capo ad
altre obbedienze massoniche diverse dal G.O.I., che sono comunque molto forti e
radicate sul territorio. Il mondo è governato da circa 1000 grosse banche, quasi
tutte sotto il diretto controllo di potenti famiglie come i Rotschild e i
Rockfeller. La Massoneria rappresenta il loro braccio esecutivo nello scegliere
e nel selezionare quei leader politici più idonei, più gestibili e maggiormente
manovrabili che, insediatisi nei posti chiave del potere, favoriscono gli
interessi di chi realmente comanda e decide. Matteo Renzi rientra perfettamente
in questo schema, ed è il prodotto di una abile e pianificata campagna di
marketing dai toni a stelle e strisce e dal sapore inconfondibilmente massonico.
Una campagna di marketing senza dubbio preparata già da anni, e finalizzata a
lanciare mediaticamente e politicamente un “volto nuovo” in un certo senso
predestinato ad assumere le leve del potere e a fare di conseguenza, una volta
Presidente del Consiglio, gli interessi di chi sta nella cabina di regia. Questa
è l’idea che mi sono fatto personalmente di Matteo Renzi, un personaggio
abilmente costruito a tavolino e curato nei minimi dettagli per quanto riguarda
il look, la gestualità, il tenore e il contenuto dei discorsi, tanto che,
nonostante risulti agli occhi dei più attenti una squallida scopiazzatura di
Barak Obama, sta trovando sempre maggiori consensi sia fra un elettorato di
sinistra ormai senza bussola e senza identità, sia fra l’elettorato di un
centro-destra fiaccato da vent’anni di Berlusconismo e di promesse non
mantenute. Non so voi, ma io in questa cabina di regia ci vedo chiaramente i
volti del Bilderberg, dei Rotschild, della grande finanza internazionale e del
Nuovo Ordine Mondiale.
Chi è davvero Matteo Renzi,
si chiede “Il Foglio”. «Quando, il 13 settembre del 2012, al palazzo della Gran
Guardia di Verona, Matteo Renzi a un certo punto disse: “Ci candidiamo a guidare
questo Paese per i prossimi cinque anni”, fummo in molti a pensare che fosse un
megalomane. Non per il plurale maiestatis, ma per la sproporzione tra
l’obiettivo dichiarato e la sua esperienza politica. Invece, aveva ragione lui»
(Michele Brambilla) [1]. Se tutto andrà come sembra, Renzi prenderà il comando
del governo a 39 anni gli stessi che aveva Mussolini quando divenne a sua volta
presidente del Consiglio [2]. Renzi, ovvero scout, Ruota della fortuna, camicia
bianca, maniche arrotolate, giubbotto di Fonzie, rottamare ecc. Alessandro
Campi: «La parlantina sciolta che avvolge e disorienta l’interlocutore,
l’autostima forse esagerata, l’ostinazione e il coraggio che ha sempre mostrato
nei momenti decisivi, il piglio volitivo e decisionistico, l’argento vivo e la
perenne agitazione, una sfrontatezza compensata da un viso da bravo ragazzo un
filo evidente di narcisismo e un po’ della prosopopea che i fiorentini hanno da
secoli. Eppure resta la domanda su chi sia per davvero Matteo Renzi» [2]. Matteo
Renzi nasce l’11 gennaio 1975 a Firenze, secondo dei quattro figli di Laura
Bovoli e Tiziano Renzi, ex consigliere comunale della Dc a Rignano sull’Arno
[3]. La prima sconfitta della sua vita al Liceo classico Dante di Firenze, come
rappresentante studentesco. La lista capeggiata da Leonardo Bieber, “Carpe
Diem”, supera la sua, “Al buio meglio accendere una luce che maledire
l’oscurità”. Dopo il diploma nel 1993 comincia a lavorare alla Chil, l’azienda
di famiglia che si occupa di marketing e giornali [3]. Nel 1999, a ventiquattro
anni, si laurea in Giurisprudenza con una tesi su «Giorgio La Pira sindaco di
Firenze». Nello stesso anno diventa segretario provinciale del Partito Popolare.
Campi: «Politicamente, lo si continua a definire un ex-democristiano, ma quando
nel 1996 lui esordì con i Comitati Prodi la Dc storica già non esisteva da un
pezzo» [2]. Nel 2001 è coordinatore della Margherita fiorentina, nel 2003
segretario provinciale, dal 2004 al 2009 presidente della Provincia di Firenze.
Dà del tu a tutti [4]. Brambilla: «Nel settembre del 2008 si mette in testa
un’altra idea da matti, candidarsi alle primarie per il sindaco di Firenze.
Tutti a dirgli Matteo sta’ bono, non fare il passo più lungo della tu’ gamba.
Eppure vince, e vince contro uno favoritissimo, Lapo Pistelli, deputato e
responsabile nazionale Esteri del partito. Ancora una volta aveva ragione lui,
il giovane Matteo, che naturalmente poi l’anno dopo sbanca le elezioni comunali
e diventa sindaco di Firenze [1]. Pistelli: «Matteo è talmente rapido da farti
venire il mal di testa. Ed è sistematico il modo in cui colpisce. Sempre allo
stesso modo. Come un serial killer. Prenderlo è difficile. E anche le rare volte
che perde, c’è sempre una botta di culo a rimetterlo in pista. Ha la provvidenza
dalla sua» [5]. «Da sindaco gli viene prima di tutto riconosciuto il gran colpo
di aver smantellato la cupola di potere sedimentata in dieci anni di
amministrazione di Leonardo Domenici» (Denise Pardo) [6]. Filippo Sensi: «Quando
gli fanno quella domanda, la domanda, e cioè se, in fondo in fondo, sia davvero
di sinistra, Matteo Renzi si mostra tutt’altro che contrariato, anzi. Come a
dire di non temere l’esame del sangue che pure gli viene richiesto ogni due per
tre per capire se, veramente, sia uno di noi, uno dei nostri. Glielo ha chiesto
Enrico Mentana, quest’estate alla festa del Partito democratico di Genova,
ultima domanda, quella quando hai le difese basse e puoi scivolare. Ma il
sindaco di Firenze ne ha approfittato per un finale in crescendo, declinando la
parola sinistra, così insidiosa e ispida, con una sfilza di impegni presi e,
secondo lui, onorati a Firenze. Le biblioteche pubbliche, gli asili nido, la
pedonalizzazione, il wifi libero. Cioè, una sana lista di cose
“tradizionalmente” di sinistra, senza rinunciare, tuttavia, al suo frame più
abituale, quello della lotta contro il conservatorismo, contro una certa
compiaciuta supponenza, e poi, colpa grave, contro la voluttà minoritaria della
sconfitta» [7]. Da sindaco guadagna quattromiladuecento euro al mese: «Che va
bene, ma è meno di quel che prende il capo segreteria di un consigliere
regionale» [8]. La parola “rottamazione” la pronuncia per la prima volta
nell’agosto 2010, quando in un’intervista a Umberto Rosso di Repubblica attacca
i dirigenti del Pd: «Se vogliamo sbarazzarci di nonno Silvio dobbiamo liberarci
di un’intera generazione di dirigenti del mio partito. Non faccio distinzioni
tra D’Alema, Veltroni, Bersani... Basta. È il momento della rottamazione. Senza
incentivi. […] Ma li vedete? Berlusconi ha fallito e noi stiamo a giocare ancora
con le formule, le alchimie delle alleanze: un cerchio, due cerchi, nuovo Ulivo,
vecchio Ulivo... I nostri iscritti, i simpatizzanti, i tanti delusi che
aspetterebbero solo una parola chiara per tornare a impegnarsi, assistono
sgomenti ad un imbarazzante Truman show. Pensando: ma quando si sveglieranno
dall’anestesia? Ma si rendono conto di aver perso contatto con la realtà?» [9].
Nel 2012 si candida alle primarie del centrosinistra. Perde al ballottaggio con
Bersani: lui prende il 39,1%, Bersani il 60,9. «Fu quella domenica sera in cui
perse il ballottaggio che Renzi preparò la sua rivincita. Arrivò alla Fortezza
da Basso, a Firenze, guidando la sua station wagon – niente autisti e niente
scorte – con la moglie Agnese a fianco e il rosario sullo specchietto. Pronunciò
un formidabile discorso in cui disse soprattutto una cosa: ho perso. In un Paese
dove alle elezioni non perde mai nessuno, Renzi si mostrò, forse più che mai,
diverso. E lì cominciò la sua rimonta» [1]. Pippo Civati, Giorgio Gori, Giuliano
Da Empoli: lunga è la lista di amici, consiglieri, professori, esperti
d’immagine e colleghi che Renzi ha messo da parte o in alcuni casi promosso per
allontanarli (come il suo ex vicesindaco Dario Nardella, oggi deputato).
Salvatore Merlo: «E dunque Renzi si scrive i discorsi da solo, trova da solo le
sue citazioni, le immagini, le figure retoriche, le invenzioni linguistiche,
scopre da solo quali sono i libri da leggere (pochini quelli che ha letto),
studia da solo i complessi problemi di un paese strano come l’Italia» [10]. Con
Letta premier i rapporti sono sempre freddi. «Durante l’estate 2013 comincia la
marcia: il sindaco decide – lo annuncerà più avanti – di candidarsi alla
segreteria e inizia a costruire attorno a sé una rete di contatti extra
politici. E così, 13 luglio, dà il là al suo tour da presidente del Consiglio
ombra: arriva l’incontro con Merkel, arrivano i contatti con i poteri che
contano. I mesi passano, Renzi si convince che per togliere di mezzo il governo
sarebbe stato necessario votare con il Porcellum ma poi si arriva al 5 dicembre
del 2013 e cambia tutto: la Consulta dichiara il Porcellum incostituzionale e
per la prima volta Renzi confessa a un suo collaboratore a Palazzo Vecchio che
il piano B è quello: se non si riesce a fare la legge elettorale si rottama
Enrico e si va a Palazzo Chigi. Detto, fatto» (Claudio Cerasa) [11]. Note:
[1] Michele Brambilla, La Stampa 14/2; [2] Alessandro Campi, Il Mattino 15/2;
[3] Wanda Marra e Davide Vecchi, il Fatto Quotidiano 8/12/ 2013; [4]. Paola
Maraone, Gioia 11/10/2012; [5] Tommaso Labate, Corriere della Sera 15/2; [6]
Denise Pardo, l’Espresso 28/10/2011; [7] Filippo Sensi, Europa 27/9/2013; [8]
Monica Ceci, Gioia 15/10/2010; [9] Umberto Rosso, la Repubblica 29/8/2010; [10]
Salvatore Merlo, Linkiesta 18/8; [11] Claudio Cerasa, Il Foglio 14/2.
Firenze: Ritratto di Matteo
Renzi, candidato PD a sindaco. Interessanti i suoi rapporti con dei noti
immobiliaristi e altro ancora. Altro che l’Obama fiorentino!
(A cura della sinistra unita e
plurale (SUP)di Firenze). Matteo Renzi è figlio di Tiziano Renzi, ex
parlamentare della DC e gran signore della Margherita e della Massoneria in
Toscana. Il feudo incontrastato della famiglia Renzi è il Valdarno, dal quale si
stanno allargando a macchia d'olio. Il padre di Matteo controlla dalla metà
degli anni '90 la distribuzione di giornali e di pubblicità in Toscana. Questo,
unito agli affari con la Baldassini-Tognozzi, la società un po' edile e un po'
finanziaria che controlla tutti gli appalti della Regione, spiega l'ascesa di
Matteo Renzi. Le prime 10 cose che non vanno di Matteo Renzi:
1) Da presidente della
Provincia, tra il 2004 e il 2009, ha acquisito il controllo di tutta la stampa
locale, radio e tv, in Toscana. L'ultimo giornale che un po' gli era ostile era
"La Nazione". Per questo, in occasione dei 150 anni di questo giornale, ha fatto
ospitare dai locali della Provincia, in via Martelli, una mostra che,
naturalmente, è stata pagata coi soldi di noi contribuenti. In questo modo, La
Nazione è divenuta renziana.
2) Renzi per controllare
ancora meglio l'informazione locale, ha trovato un secondo lavoro a moltissimi
giornalisti: gli uffici stampa degli eventi organizzati dalla Provincia, come il
Genio fiorentino, il suo stesso portavoce, tutta una serie di riviste inutili e
costossime per la collettività (Chianti News, InToscana, ecc.) servono a lui e a
Martini, il presidente della Regione, a tenersi buoni i cronisti locali.
Inoltre, trasmissioni come "12 minuti col Presidente", che va in onda su RTV 38
e Rete 37, gli sono servite a dare delle tangenti legalizzate alle redazioni di
queste emittenti che ormai, in lui, riconoscono il vero datore di lavoro.
3) Tra le cose di cui più si
vanta Renzi, vi è il recupero di Sant'Orsola. Il grande complesso situato in San
Lorenzo, chiuso e abbandonato da molti decenni, sarebbe stato recuperato dalla
Provincia - così dice Renzi - con un investimento iniziale di 20 milioni di
euro. E questo non è vero. Infatti, a bilancio, a fine anno, la Provincia per
Sant'Orsola ha stanziato la miseria di un milione di euro. E' un esempio del suo
continuo modo di mentire.
4) Renzi in questi 5 anni ha
utilizzato la Provincia allo scopo di promuovere la propria immagine personale
coi soldi nostri. A questo servono manifestazioni inutili e costose come "Il
Genio fiorentino e "Riciclabilandia". Attraverso l'utilizzo delle consulenze,
degli uffici stampa, della commissione di sondaggi, pubblicazioni e pubblicità
ha creato una vasta rete clientelare di giornalisti che non ne contraddicono mai
le posizioni.
5) L'inchiesta di Castello:
Matteo Renzi, come presidente della Provincia, è molto più coinvolto del sindaco
Domenici. Infatti, le opere oggetto dell'inchiesta sono quasi tutte
commissionate dalla Provincia: tre scuole, una caserma nonché naturalmente il
nuovo (e che bisogno c'è?) palazzo della Provincia. Eppure sui giornali ci è
finito Domenici.
6) Il braccio destro di
Ligresti, patron della Fondiaria, Rapisarda, lo si vede bene nelle
intercettazioni telefoniche, pretende che per le commissioni di Castello la
Provincia faccia una gara d'appalto. "sennò ci accusano di fare noi il prezzo",
spiega Rapisarda al telefono all'assessore Biagi. Pochi giorni dopo quella
telefonata, compare questo titolo su Repubblica: "Renzi contro la Fondiaria: per
Castello si farà la gara d'appalto". Ovvero: Renzi è colui che meglio esegue le
volontà della Fondiaria e poi appare addirittura come quello contro i poteri
forti!
7) Nel 2004 come prima cosa
taglia i fondi della Provincia per la raccolta differenziata. Risultato, i Verdi
si arrabbiano (giustamente) e lui li espelle dalla Giunta.
8) Dal 2004 Renzi ha creato
un'infinità di società alle quali la Provincia commissiona eventi culturali,
indagini di mercato e così via. Il caso più clamoroso è quello di "Noilink" che,
durante le primarie del PD, diventa il suo vero e proprio comitato elettorale!
9) Tutti i giornaletti del
cappero che arrivano nelle case dei fiorentini a partire da "Prima, Firenze!"
sono stampati coi soldi della Provincia.
10) Nessun giornalista osa
fare una domanda su quanto abbiamo riportato nei primi nove punti a Matteo
Renzi.
Chi c’è dietro Matteo
Renzi? Si
chiede Alessandro D'Amato su “Giornalettismo”. Da Marchionne a Carrai, da Serra
a Della Valle, da Vitale a Micheli fino all’americano Phillips: Libero vi
racconta la sua verità. Chi c’è dietro Matteo Renzi? La domanda è
retorica, ma Libero di oggi la prende sul serio per imbastire una prima pagina
dedicata al presidente del consiglio incaricato e a tutti i suoi “suggeritori”,
non accusati di occultismo ma quasi. La prima pagina di Libero: CHI C’E’
DIETRO MATTEO RENZI – L’articolo di Franco Bechis comincia puntando il dito
su quel Guido Tabellini che oggi è considerato ministro dell’Economia in
pectore. Dietro il quale, come al solito, ci sarebbe la manina dell’Ingegnere:
C’è chi vede quella manina infatti nell’improvvisa emersione nel toto-ministri
del nome del professore di Economia ed ex Rettore dell’Università Bocconi, Guido
Tabellini. La sua candidatura non è nuovissima nella vigilia della formazione
dei governi. Era già emersa perfino nel 2008, per la squadra di Silvio
Berlusconi, come alternativa a Giulio Tremonti. Tabellini ha due estimatori
influenti: Sergio Marchionne (che aveva influenza sul cavaliere,mane ha pure su
Renzi) e appunto De Benedetti. Entrambi lo hanno voluto cooptare in azienda. E
infatti Tabellini siede nel consiglio di amministrazione di Fiat Industrial e in
quello di Cir, la holding operativa del gruppo De Benedetti. Una candidatura con
padrinato evidente. Ma tra i nomi spunta anche quello di Franco Bernabé, ed è
importante far notare che nell’occasione lo sponsor non è considerato De
Benedetti, ma l’amico d’infanzia di Renzi Marco Carrai. Il quale, oltre ad
essere socio di una società in partecipazione con Bernabé, ha anche ottimi
rapporti con Chicco Testa, l’ex presidente di Legambiente poi diventato
presidente dell’Enel e nuclearista convinto. Ma l’elenco non finisce qui.
Descritto come molto vicino a Carrai è infatti Fabrizio Palenzona, ex
sindacalista e poi banchiere in Unicredit oltre che collezionista di poltrone
tra AdR, Aiscat, Autostrade e così via. Palenzona sarebbe stato lo sponsor di
Lucrezia Reichlin, data al ministero dell’Economia per qualche ora ieri sui
giornali italiani. E non finisce qui: Ma c’è sempre Palenzona, sia pure a
braccetto con Paolo Fresco (altro rapporto di Renzi ricevuto in dote da Carrai)
dietro l’emergere e il solidificarsi della candidatura a ministro di Mauro
Moretti, il manager che da una vita guida le Ferrovie italiane. Fra i padrinati
dell’ultima ora ne è emerso uno istituzionale e in qualche modo naturale:
l’appoggio – assolutamente solitario e perdente – dato dal Governatore della
Banca d’Italia, Ignazio Visco, alla riconferma del suo ex direttore generale,
Fabrizio Saccomanni, all’Economia. Infine, ci sono i nomi considerati vicini a
Renzi fin dai tempi delle primarie di Firenze e di quelle contro Bersani: Nomi
in qualche caso ben noti, come il finanziere David Serra (anche lui inventato da
Carrai) e del patron di Tod’s e Fiorentina, Diego Della Valle. Ma anche qualcuno
emerso meno dalle cronache fiorentine: come l’ex banchiere che guidò Lazard in
Italia (e fondò Euromobiliare), Guido Roberto Vitale, o il finanziere Francesco
Micheli (in coppia con il figlio Carlo). Enorme il peso su Renzi di Vincenzo
Manes, presidente dell’Intek group e finanziatore generoso delle fondazioni con
cui il sindaco di Firenze ha scalato la grande politica. Contano – e non poco
-anche due personaggi che vengono dalla diplomazia e dalle reti di lobbing
americane, come John Phillips – ex found raiser di Barack Obama,ora ambasciatore
Usa in Italia. O il più oscuro Michael Ledeen, repubblicano assai conservatore,
uomo simbolo dell’American Enterprise Institute. Da segnalare che quello di
Ledeen è un nome che rientra periodicamente nelle discussioni sugli influencer
americani dei politici italiani. Non ultimo si parlò di Leeden come sponsor del
progetto Decidere.net di Daniele Capezzone: vero è che i due si conoscevano e
stimavano, ma tutta la storia era soltanto complottismo.
Massoneria e “Misteri di
Napolitano” nel libro “I panni sporchi della sinistra”.
Un capitolo del libro scritto dai giornalisti Ferruccio Pinotti (Corriere della
Sera) e Stefano Santachiara (Fatto quotidiano) parla di Unione Sovietica, di
massoneria, di Henry Kissinger e del presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, scrive “Blitz Quotidiano”. Massoneria e "Misteri di Napolitano" nel
libro "I panni sporchi della sinistra" di Pinotti e Santachiara. “I misteri
di Napolitano”: si chiama così il capitolo del libro “I panni sporchi della
sinistra” (Chiarelettere) scritto dai giornalisti Ferruccio Pinotti (Corriere
della Sera) e Stefano Santachiara (Fatto quotidiano) in cui si parla di Unione
Sovietica, di massoneria, di Henry Kissinger e del presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano. Capitolo citato da Paolo Bracalini sul Giornale: “«Il
presidente Napolitano è stato sempre garante dei poteri forti a livello
nazionale e degli equilibri internazionali sull’asse inclinato dal peso degli
Stati Uniti» scrivono i giornalisti di inchiesta Ferruccio Pinotti (del Corriere
della sera) e Stefano Santachiara (Il Fatto) in I panni sporchi della sinistra
[...] Il primo ritratto, di 60 pagine, è dedicato proprio al presidente della
Repubblica («I segreti di Napolitano»), «l’ex ministro degli esteri del Pci»
come lo definì Bettino Craxi interrogato dal pm Di Pietro nel processo Enimont.
I rapporti con Mosca, quelli controversi con Berlusconi (il mensile della
corrente migliorista del Pci, Il Moderno, finanziato da Fininvest, ma anche dai
costruttori Ligresti e Gavio), e le relazioni oltreoceano, con Washington. Una
storia complessa, dalla diffidenza iniziale del Dipartimento di Stato Usa e
dell’intelligence americana («nel 1975 a Napolitano gli fu negato il visto, come
avveniva per tutti i dirigenti comunisti»), alle aperture dell’ambasciata Usa a
Roma, al «misterioso viaggio» di Napolitano negli Stati uniti nel ’78, nei
giorni del sequestro Moro, l’altro viaggio insieme a Occhetto nel 1989, fino
«all’incontro festoso, molti anni dopo, nel 2001, a Cernobbio, con Henry
Kissinger, ex braccio destro di Nixon, che lo saluta calorosamente: My favourite
communist, il mio comunista preferito. Ma Napolitano lo corregge ridendo: Il mio
ex comunista preferito!». Il credito di Napolitano presso il mondo anglosassone
si dipana nel libro-inchiesta anche su un fronte diverso, che Pinotti segue da
anni, la massoneria, e che si intreccia con la storia più recente, in
particolare con le dimissioni forzate di Berlusconi nel 2011, a colpi di spread
e pressioni delle diplomazie internazionali. Su questo terreno gli autori fanno
parlare diverse fonti, tra cui una, di cui non rivela il nome ma l’identikit:
«Avvocato di altissimo livello, cassazionista, consulente delle più alte cariche
istituzionali, massone con solidissimi agganci internazionali in Israele e negli
Stati Uniti, figlio di un dirigente del Pci, massone, e lui stesso molto vicino
al Pd». Il quale racconta: «Già il padre di Giorgio Napolitano è stato un
importante massone, una delle figure più in vista della massoneria partenopea»
(proprio nei giorni successivi all’uscita del libro sarebbe spuntata, dagli
archivi di un’associazione massonica di primo piano, la tessera numerata del
padre di Napolitano, ndr). Tutta la storia familiare di Napolitano è
riconducibile all’esperienza massonica partenopea, che ha radici antiche e si
inquadra nell’alveo di quella francese…». Avvocato liberale, poeta e saggista,
Giovanni Napolitano avrebbe trasmesso al figlio Giorgio (legatissimo al padre)
non solo l’amore per i codici «ma anche quello per la fratellanza» si legge. E
poi: «Per quanto riguarda l’attuale presidente, negli ambienti massonici si
sussurra da tempo di simpatie della massoneria internazionale nei confronti
dell’unico dirigente comunista che a metà anni Settanta, all’epoca della Guerra
fredda, sia stato invitato negli Stati Uniti a tenere un ciclo di lectures
presso prestigiosi atenei. Napolitano sarebbe stato iniziato, in tempi lontani,
direttamente alla «fratellanza» anglosassone (inglese o statunitense)». Da lì il
passo ad accreditare la tesi, molto battuta in ambienti complottisti, di un
assist guidato a Mario Monti, è breve, e viene illustrata da un’altra fonte,
l’ex Gran maestro Giuliano Di Bernardo («criteri massonici nella scelta di Mario
Monti») e da uno 007 italiano. L’asse di Berlusconi con Putin – specie sul
dossier energia – poco gradito in certi ambienti, entra in questo quadro
(fantapolitica?). Con un giallo finale nelle pagine del libro, raccontato dalla
autorevole fonte (senza nome): Putin avrebbe dato a Berlusconi delle carte su
Napolitano. Se queste carte esistono, riguardano più i rapporti americani di
Napolitano che quelli con i russi». Materiale per una avvicente spy story su
Berlusconi, Napolitano, Monti, Putin, la Cia, il Bilderberg…”
 "Leggete
i suoi testi con me, Rino Gaetano era un massone: fatto fuori perché parlava".
L'autore dell'inchiesta sulla morte del cantante ci illustra i presunti messaggi
cifrati del cantautore: "Sapeva tutto sul caso Lockheed e sul delitto Montesi".
Intervista di Roberto Procaccini su “Libero Quotidiano”. "Rino Gaetano era
vicino agli ambienti massonici, se non massone in prima persona. Dai suoi amici
confratelli veniva a conoscenza della verità su alcuni misteri della
storia italiana del '900, che poi inseriva nei testi delle sue canzoni dietro le
mentite spoglie dell'umorismo o del non sense. Per questo è stato ucciso. Aveva
raccontato troppe cose, pestando i calli a qualcuno negli Stati Uniti". Bruno
Mautone, avvocato ed ex sindaco di Agropoli (Salerno), ha studiato per tre anni
i testi delle canzoni di Rino Gaetano. Ha analizzato le parole e colto dei
collegamenti, fino a disegnare uno scenario inedito: il cantautore calabrese,
morto in un incidente stradale nel 1981 all'età di 30 anni, è stato vittima di
un complotto. "Nel mio libro (Rino Gaetano: La tragica scomparsa di un eroe)
metto in evidenza dati che mi sembrano oggettivi - spiega -. Poi le conclusioni
possono essere condivisibili o meno, ma i fatti restano". Mautone fa riferimento
ad Anna Gaetano, la sorella di Rino, che sul nostro sito aveva definito "sogni"
le sue tesi. "Questo non lo posso accettare", replica Mautone.
"Leggete
i suoi testi con me, Rino Gaetano era un massone: fatto fuori perché parlava".
L'autore dell'inchiesta sulla morte del cantante ci illustra i presunti messaggi
cifrati del cantautore: "Sapeva tutto sul caso Lockheed e sul delitto Montesi".
Intervista di Roberto Procaccini su “Libero Quotidiano”. "Rino Gaetano era
vicino agli ambienti massonici, se non massone in prima persona. Dai suoi amici
confratelli veniva a conoscenza della verità su alcuni misteri della
storia italiana del '900, che poi inseriva nei testi delle sue canzoni dietro le
mentite spoglie dell'umorismo o del non sense. Per questo è stato ucciso. Aveva
raccontato troppe cose, pestando i calli a qualcuno negli Stati Uniti". Bruno
Mautone, avvocato ed ex sindaco di Agropoli (Salerno), ha studiato per tre anni
i testi delle canzoni di Rino Gaetano. Ha analizzato le parole e colto dei
collegamenti, fino a disegnare uno scenario inedito: il cantautore calabrese,
morto in un incidente stradale nel 1981 all'età di 30 anni, è stato vittima di
un complotto. "Nel mio libro (Rino Gaetano: La tragica scomparsa di un eroe)
metto in evidenza dati che mi sembrano oggettivi - spiega -. Poi le conclusioni
possono essere condivisibili o meno, ma i fatti restano". Mautone fa riferimento
ad Anna Gaetano, la sorella di Rino, che sul nostro sito aveva definito "sogni"
le sue tesi. "Questo non lo posso accettare", replica Mautone.
Come è arrivato alla
conclusione che Rino Gaetano sarebbe stato un massone?
«Le
sue canzoni sono piene di riferimenti alla cultura e al simbolismo massonico. In
Fiorivi, sfiorivano le viole cita il marchese La Fayette che ritorna
dall'America importando la Rivoluzione e un cappello nuovo, Mameli che
scrive una canzone tutt'ora in voga, e poi ancora Otto von
Bismarck-Shonhausen.»
E allora?
«Allora
parla di tre personaggi chiave della massoneria europea del diciottesimo e
diciannovesimo secolo in una canzone d'amore. La rivoluzione importata da
Lafayette era quella americana, cioè quella massonica per eccellenza. La canzone
tutt'ora in voga di Mameli è l'inno nazionale, Fratelli d'Italia, quando
è noto che i massoni sono soliti chiamarsi tra di loro fratelli.»
Basta a dire che Gaetano
aderisse a una loggia?
«No,
ma suoi amici strettissimi, che ho intervistato durante il lavoro di ricerca, mi
hanno confermato il suo interesse per la materia. Leggeva molti libri sulla
massoneria e sui suoi personaggi di spicco. E dirò di più: dai titoli dei dischi
del cantautore si capisce anche il suo percorso di vicinanza prima, e
allontanamento poi, dalla massoneria.»
Cioè?
«Nel
1973 Gaetano pubblica I love you Marianna. La Marianna è il simbolo della
rivoluzione francese, che è una rivoluzione massonica. Nel 1974 tocca a
Ingresso Libero, intendendo l'apertura delle logge alle nuove affiliazioni.
Poi Gaetano rompe con gli ambienti massonici e nel 1976 incide Mio fratello è
figlio unico, dove l'immagine paradossale rappresenta l'isolamento nella
loggia.»
E così Rino avrebbe avuto
agganci nella massoneria.
«Esatto.
Anna Gaetano sostiene che il fratello fosse una persona preparata, che leggeva i
giornali e arrivava a certe intuizioni grazie alla sua preveggenza. Non è così.
Lui poteva anticipare le cose perché le conosceva.»
Quanti riferimenti a casi
occulti ha contato nella discografia di Rino Gaetano?
«A
centinaia. Ce ne sono di grossi. In Berta filava, una canzone del
'75-'76, spiega lo scandalo Lockheed (un caso di corruzione affinché
l'aeronautica italiana adottasse veivoli della casa americana, ndr).
Berta sarebbe Robert Gross, detto Bert, presidente della Lockheed. Rino cantava:
"Berta filava con Mario e con Gino", che sarebbero Mario Tanassi e Gino
Gui, due ex ministri della Difesa coinvolti nell'inchiesta. Ma dal rapporto,
prosegue la canzone, nasce un bambino che non era di Mario e non era di Gino.
Cioè Rino sottintendeva che la responsabilità non fosse di Gui e Tavassi,
esattamente come si è scoperto dopo. I due ministri erano dei capri espiatorii
messi lì per coprire responsabilità più alte. Ma non è il solo esempio.»
Ne faccia un altro.
«In
Nun te reggae più Rino Gaetano cita la spiaggia di Capocotta, cioè il
delitto Montesi, e nella stessa canzone canta auto blu, sangue blu, ladri di
Stato e stupratori.»
E quindi?
«Per
l'omicidio di Wilma Montesi furono incriminati Piero Piccioni, figlio del
ministro degli Esteri Attilio, e Ugo Montagna, un marchese. Le auto blu, un
riferimento ai palazzi romani del potere. Il sangue blu, la nobiltà. Ladri di
stato, perché le hanno rubato la vita alla ragazza venendo poi clamorosamente
assolti. Stupratori, perché avevano violentato la ragazza. Rino Gaetano tutte
queste cose le sapeva.»
Racconta la sorella Anna
che Rino Gaetano avesse inserito un riferimento al caso Montesi anche in una
poesiola infantile. Per dire che il caso di nera, semplicemente, l'aveva colpito
profondamente nell'immaginario.
«Ma
ciò non esclude che più di dieci anni dopo abbia scritto Nun te reggae più
in possesso di elementi nuovi.»
E perché le avrebbe
nascoste dietro riferimenti così complessi?
«Perché
le sue canzoni erano cavalli di troia. Se fosse stato più esplicito lo avrebbero
bloccato. Invece nascondeva cose serissime dietro l'umorismo e lo stile non
sense.»
Chi è il responsabile della
morte di Rino Gaetano, allora?
«La
massoneria deviata. Direi settori in rapporti con gli Stati Uniti. L'Italia era
diventata una colonia americana, Rino l'aveva scritto in molte canzoni, come in
Ok papà, dove scrive Usa il pugnale. Anche il modo in cui l'hanno
ucciso è un riferimento alla simbologia massonica.»
Perché?
«E'
morto il 2 giungo, data scelta dai padri costituenti, tra cui molti fratelli,
per l'unica festa laica del Paese. E poi non mi spiego perché sul luogo
dell'incidente sia arrivata per prima un'ambulanza dei pompieri. Per non parlare
dell'agonia e delle insufficienze ospedaliere che ricalcano la canzone la
Ballata di Renzo.»
Mettere insieme stralci di
canzoni non le sembra un po' poco per sostenere una teoria del genere?
«Lo
so, se avessi il documento che testimonia l'associazione di Rino Gaetano alla
massoneria sarebbe tutto più chiaro. Ma ho messo in fila elementi chiari, per me
oggettivi.»
Anna Gaetano lamenta che
l'ha conosciuta, per telefono, solo a libro dato alle stampe.
«Non
avrei potuto contattarla prima. Sapevo che non avrebbe condiviso il mio libro,
che mi avrebbe messo il bastone tra le ruote. Non ho nulla contro di lei, ma se
ha paura non è colpa mia. E capisco anche che non sia d'accordo con le mie
conclusioni, ma non può dire che invento.»
Calabria e Massoneria, un
antico legame.
Le statistiche collocano la regione al terzo posto per densità
massonica in Italia, dopo la Toscana e il Piemonte. Il nostro
territorio nel corso dei secoli ha infatti espresso molte personalità del libero
pensiero, scrive Vincenzo Pitaro su “Soverato Web”. Da una recente
rilevazione, la Calabria è risultata tra le regioni a più elevata densità
massonica, dopo la Toscana e il Piemonte. Un dato che non ha mancato di
sorprendere gli esperti nazionali di statistica, i quali non sarebbero riusciti
a spiegarsi «il motivo di un simile primato». Questo perché nessuno, a quanto
pare, ha tenuto conto della storia. Il fenomeno odierno si innesta infatti sulla
scia di un’antica tradizione lasciata in Calabria da numerose personalità. Qui
infatti nacquero ed operarono Antonio Jeròcades (a lui è attribuita
l’istituzione della prima loggia calabrese), Francesco De Luca (che succedette a
Giuseppe Garibaldi nella Gran Maestranza nazionale), Saverio Fera, di Petrizzi
(CZ), artefice dello scisma del 1908 e fondatore dell’Obbedienza di Piazza del
Gesù, e tanti altri (da Armando Dito a Vittorio Colao) che ricoprirono sotto le
volte stellate incarichi di primo piano. Tra gli illustri massoni calabresi,
peraltro, la storia annovera finanche uomini di Chiesa, come lo stesso abate
Jeròcades, di Parghelia; i sacerdoti Gregorio Aracri, di Stalettì (CZ); Giuseppe
Monaldo, di Filadelfia (VV); Antonio Greco, di Catanzaro (che sedette anche nel
primo parlamento del Regno d’Italia); Domenico Angherà, arciprete di San Vito
sullo Jonio, che il 10 agosto 1861 fondò a Napoli il Grande Oriente,
trasformatosi in seguito in Supremo Consiglio di Napoli, e che da molti è
considerato l’antesignano del Grande Oriente d’Italia.
Che la Calabria fosse, dunque, «una regione di corposità massonica» non è
affatto una novità; un qualcosa che si scopre oggi per merito delle statistiche.
Il prezioso contributo offerto dalla regione alla Massoneria italiana venne
addirittura sottolineato, già nel 1875, nientemeno che da Francesco De Sanctis,
il padre della letteratura italiana, durante un suo elogio funebre tenuto
dinanzi al feretro proprio di Francesco De Luca, avvocato, professore di scienze
naturali e scrittore (fra l'altro, autore di un interessante volume su
«L’educazione dei popoli», nonché di vari opuscoli di matematica sullo «sviluppo
di un nuovo sistema di logaritmi») che era nato a Cardinale (CZ) nel 1811 e che
già dal dal 28 maggio 1865 al 20 giugno del 1867 era stato Gran Maestro del
Grande Oriente d’Italia, la massoneria di Palazzo Giustiniani. Nel discorso
tenuto in forma solenne, De Sanctis (anch’egli massone, come del resto lo furono
Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Salvatore Quasimodo, ecc.) non solo onorò la
memoria di Francesco De Luca, esaltandone le doti umani e professionali, ma
trovò modo di lodare anche la Terra che gli aveva dato i natali, sottolineando i
«nobili ideali universalistici e filantropici dei tanti calabresi che avevano
alimentato la massoneria. Ideali praticati da uomini rispettosi delle leggi
della patria, osservanti dei diritti dell’uomo e del cittadino, gelosi della
dignità della persona umana, irreprensibili nel comportamento privato e sociale.
Alla pari di tanti altri grandi massoni internazionali: da Voltaire a Cavour, da
Fleming a Washington, fino a Mozart». La forte presenza della Massoneria in
Calabria perciò altro non è altro che un fatto storico. Già nel 1864, esisteva a
Catanzaro la loggia «Tommaso Campanella» (che oggi vanta di aver «ricevuto la
luce proprio da Antonio Jeròcades»), una loggia che perdipiù - stando a quanto
sostiene qualche storico della Libera Muratoria - sarebbe stata fondata per
preparare la gioventù ad una nuova guerra contro l’Austria per la conquista di
Venezia. A innalzare le sue colonne furono sette «fratelli» (Giuseppe Rossi,
Filippo D’Alessandria, Odoardo Squillace, Giuseppe Falletti, Gaetano Palopoli,
Gregorio Iannone, Michele Martone) assieme ad Antonio Menniti-Ippolito eletto
maestro venerabile. Non si sa se a tutt'oggi spetterebbe ad essa, o meno, il
titolo di «loggia madre calabrese», visto che - tra quelle più antiche ancora
esistenti nella regione - ce n'è un'altra a Reggio Calabria, la «Domenico
Romeo». L'afflusso maggiore comunque si sarebbe registrato dal 1900 in poi, fino
all’avvento del fascismo, quando nella sola provincia di Catanzaro erano attive
molte logge, tra cui la «Francesco De Luca» a Chiaravalle Centrale; la «Giovanni
Andrea Serrao» a Filadelfia; l’«Antica Vibonese Rinnovellata» a Monteleone (oggi
Vibo Valentia); la «Dionisio Ponzio» a Nicastro; la «Bruno Vinci» a Nicotera e
la «Benedetto Musolino» a Pizzo Calabro, oltre ai «triangoli» elevati a
Nardodipace, Fabrizia e ad Arena.
L’alleanza tra ’ndrangheta
e massoneria per avvicinarsi al potere.
Le oltre duemila pagine dell’ordinanza notificata ai 39 arrestati dell’inchiesta
“Saggezza” gettano luce sui rapporti tra ’ndrangheta e massoneria, usata per
avvicinarsi ai centri decisionali politici ed economici. Non è una novità: già
nel ’92 il procuratore di Palmi, Agostino Cordova, indagò sulla massoneria
deviata, scrive Francesca Chirico su “L’Inchiesta”. «È venuto il gran maestro
del coso… del…ferma, che mi ricordo, come si chiama quell’altra obbedienza
grossa…». «Grande Oriente». «Sì, del Grande Oriente, c’era il gran maestro che è
venuto tutto pieno di collane e di cose». La trascrizione dell’intercettazione
telefonica del 4 dicembre 2006 indica, a questo punto, “risate”. Poi
l’interlocutore più esperto si ricompone e spiega: «Sono i paramenti per i
gradi». Probabilmente simili a quelli che, quattro anno dopo, durante una
perquisizione domiciliare, i carabinieri di Locri gli troveranno in casa.
Ordinatamente piegati e custoditi in camera da letto dove i militari dell’Arma
erano in cerca, forse, di pistole e munizioni. Di Nicola Nesci,
cinquantasettenne operaio forestale di Ciminà, nella Locride, sapevano i vecchi
precedenti per armi e tentata estorsione, le frequentazioni con i pregiudicati
della zona, gli affari nel noleggio delle slot-machine e l’interesse per la
politica locale, con tanto di candidatura e successiva elezione in Consiglio
comunale nel 2007. Ne conoscevano bene, per averlo arrestato con l’accusa di
narcotraffico, anche il cognato Antonio Spagnolo, boss di Ciminà fino al giorno
delle manette. Ignoravano, però, che Nicola Nesci fosse associato alla
massoneria con le cariche di “Maestro segreto di 31° grado” e “Presidente della
camera di 4° grado”. Titoli ai quali avrebbe unito, senza problemi di conflitto
d’interessi, anche quello di “mastro di Corona”. In quest’ultimo caso, però, non
parliamo di logge ma di cosche. Nelle oltre duemila pagine dell’ordinanza
notificata nei giorni scorsi ai 39 arrestati dell’inchiesta “Saggezza”, tra capi
d’imputazione come estorsione, usura, intestazione fittizia di beni, concorrenza
sleale e frode in appalti pubblici, sono emerse anche questioni relative
all’organizzazione e all’assegnazione di cariche interne alla ’ndrangheta.
Secondo i magistrati della Dda reggina proprio «il maestro segreto di 31° grado»
Nicola Nesci avrebbe infatti animato, con altri complici, «una articolazione
dell’associazione denominata “Corona”, struttura cui facevano capo i “locali” di
’ndrangheta di Antonimina, Ciminà, Ardore, Cirella di Platì e Canolo,
finalizzata al controllo mafioso dei territori di tali Comuni». Disseminati
nella Locride e svuotati dall’emigrazione, Antonimina, Ciminà, Ardore, Cirella
di Platì e Canolo bisogna metterli insieme per raggiungere quota ottomila
abitanti. E mettersi insieme, in questo fazzoletto di Calabria, tra l’Aspromonte
e le spiagge sabbiose dello Jonio, ostaggio della statale 106 e del binario
unico della ferrovia, è l’unico modo per contare qualcosa. Per i magistrati lo
avrebbe capito anche la ’ndrangheta che in zona avrebbe attivato un livello
organizzativo comprensoriale, la “Corona”, appunto, per gestire in sinergia gli
affari (appalti pubblici, attività commerciali, etc) e interloquire da una
posizione più forte con i “colleghi” del mandamento della Locride. Ma anche per
scongiurare il riproporsi di faide come quella che a Ciminà, dopo l’omicidio nel
1966 del boss Francesco Barillaro, collezionò decine di morti, compresi un
pastore sedicenne (Vincenzo Barillaro, figlio del defunto capocosca), un prete
(don Antonio Esposito, trucidato a colpi di mitra) e un sindaco (Domenico
Fazzari). L’anziano “capo corona” Vincenzo Melia, tornato in Calabria dopo quasi
50 anni trascorsi in America, e i suoi consiglieri (Nicola Nesci e Nicola
Romano) non amano sentire parlare di guerre di ’ndrangheta. Gli arresti e la
pressione delle forze dell’ordine prodotti dalla faida di San Luca e
dall’omicidio del vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Franco
Fortugno (16 ottobre 2005 a Locri), li spingono spesso a deprecare, con tono
accorati di biasimo e accenni nostalgici al passato, l’allontanamento dai valori
di “sangue e onore” di un tempo. «Hanno distrutto un paese come Locri che lo
avevano mantenuto come “una rosa nel vaso”…sia la politica, sia la ’ndrangheta,
sia la massoneria, insieme, tutti insieme, tutti d’accordo, l’avevano portato un
gioiello». Per prosperare, insomma, servono saggezza e armonia. E ad un’armonica
collaborazione tra “poteri” alcuni esponenti della “Corona” sembrano ispirare il
loro variegato curriculum da fratelli di sangue e, contemporaneamente, fratelli
massoni. «Il contatto con gli ambienti massonici – scrivono i magistrati
nell’ordinanza – costituiva un vero e proprio trampolino di lancio per gli
affiliati al sodalizio mafioso, poiché li avvicinava a quelle componenti della
società italiana che costituivano i veri centri decisionali in campo economico,
politico e sociale». Per sei degli indagati dell’operazione “Saggezza” il
contatto era formalizzato da un’iscrizione ufficiale alla “Massoneria Universale
Grande Oriente d'Italia, Ordine dell’Alto Jonio reggino”, con tanto di quota
associativa annuale da corrispondere: oltre al già citato Nicola Nesci, erano
della partita della “squadra e del compasso” anche il presunto boss di Ardore,
Giuseppe Varacalli, Giuseppe Siciliano, Rocco Mediati, Ferdinando Parlongo e
Bruno Parlongo, accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo
mafioso e intestazione fittizia di beni. E affratellati con i politici, medici,
avvocati e professionisti che il sabato a Siderno si danno appuntamento presso
la sede della loggia. Per la sua investitura, per esempio, Varacalli volò nel
2001 direttamente a Malta. Sette anni dopo lo avrebbero ammanettato per aver
favorito la latitanza del boss di San Luca, Antonio Pelle, tra i responsabili
della faida di San Luca e catturato il 16 ottobre 2008 in un bunker ricavato
proprio sotto un capannone di Varacalli ad Ardore marina. L’abbraccio tra
’ndrangheta e massoneria emerso nell’inchiesta “Saggezza” non è inedito né
recente. «Sino alla prima guerra di mafia, la massoneria e la ’ndrangheta erano
vicine, ma la ’ndrangheta era subalterna alla massoneria, che fungeva da tramite
con le istituzioni… È evidente che in questo modo eravamo costretti a delegare
la gestione dei nostri interessi, con minori guadagni e con un necessario
affidamento con personaggi molto spesso inaffidabili. A questo punto, capimmo
benissimo che se fossimo entrati a far parte della famiglia massonica avremmo
potuto interloquire direttamente ed essere rappresentati nelle istituzioni…». Il
salto, secondo Giacomo Lauro, tra i primi pentiti di ’ndrangheta, avvenne quindi
nella seconda metà degli anni Settanta, dopo l’eliminazione dei boss della
vecchia guardia da parte delle nuove leve (De Stefano, Nirta). Un salto proficuo
ma non del tutto “invisibile”. Partendo dagli affari della cosca Pesce di
Rosarno, attraverso la scoperta di relazioni pericolose tra mafiosi, politici e
imprenditori calabresi, il 16 ottobre 1992 il procuratore di Palmi, Agostino
Cordova, avviò, infatti, la prima inchiesta italiana sulla massoneria deviata,
ipotizzando l’esistenza di una “super loggia segreta” e finendo nelle trame
degli affari miliardari di Gelli e di una miriade di personaggi legati a logge
massoniche coperte. Il magistrato fu immediatamente “promosso” alla Procura di
Napoli e l’indagine, compendiata in quasi mille faldoni, finì archiviata.
Massoneria al voto, con lo
spettro della 'ndrangheta,
scrive Gianni Barbacetto su Il Fatto Quotidiano del 14 Febbraio 2014. Si
va alle urne. Il 2 marzo 2014 si vota. Non per le elezioni politiche, ma per
eleggere il nuovo Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia (Goi), la più grande
comunione massonica italiana. Quel giorno finirà l’era di Gustavo Raffi, al
vertice del Goi dal 1999. Dopo tre mandati consecutivi non può più ricandidarsi:
aperte le grandi manovre per la successione. Candidati, Stefano Bisi,
giornalista di Siena, l’ex vicesindaco socialista di Livorno Massimo Bianchi e
il notaio di Messina Silverio Magno. Raffi lascia la scena dopo 15 anni di
governo massonico. Arrivò a Villa il Vascello, la splendida sede romana del Goi,
promettendo di rinnovare l’Istituzione e far dimenticare le ombre del passato.
Veniva da Ravenna e diceva che la massoneria “doveva ripudiare l’affarismo e
diventare una casa di vetro”. Dichiarava che “la P2 sta al Grande Oriente come
le Br al Partito comunista”. Una volta gli sfuggì addirittura che “il cuore
della massoneria batte a sinistra”. Ma subito smentì e fu poi subissato di
critiche: lo accusarono di essere un falso amico della sinistra, venendo sì dai
repubblicani, ma quelli presidenzialisti e un po’ golpisti di Randolfo
Pacciardi; e di essere lui il vero affarista. Si è raddoppiato l’emolumento
annuo (portato a 130 mila euro) e ha perfino favorito il fratello (non
massonico, di sangue) affidando all’agenzia turistica di famiglia
l’organizzazione dei viaggi e soggiorni a Rimini per l’annuale Gran Loggia, il
parlamento massonico. Raffi ha sempre respinto al mittente le accuse velenose
dei fratelli coltelli, esibendo i suoi successi. I massoni del Goi erano 13 mila
nel 1999, oggi sono esattamente 22.181. Le Logge sono aumentate: erano meno di
600, oggi sono quasi un migliaio. L’età media si è abbassata. La comunione ha
riallacciato le relazioni (che erano state sospese) con la massoneria svizzera,
belga e francese. Con la riforma elettorale (“un Maestro un voto”), Raffi ha
esteso la partecipazione alle elezioni massoniche a tutti i Maestri (oggi sono
16.252), mentre prima votavano soltanto i Maestri Venerabili (quelli a capo di
una Loggia). Ecco dunque il voto del 2 marzo. Sarà eletto al primo turno il
candidato che raccoglierà almeno il 40 per cento dei voti. Sennò, ballottaggio
il 23 marzo, a ridosso del giorno esoterico dell’equinozio di primavera.
Stefano Bisi, il favorito, è
giornalista e dirigente del Corriere di Siena. È l’inventore della definizione
“groviglio armonioso” affibbiata a Siena e al Montepaschi: un “sistema” capace
di tenere insieme gli opposti e di durare dal Medioevo fino a oggi. Con lo
scandalo della banca e il crollo del suo presidente Giuseppe Mussari, il
groviglio ha preso il sopravvento e l’armonia è finita, anche perché sono finiti
i soldi che il Montepaschi distribuiva a pioggia. Anche ai giornali di Bisi,
naturalmente, che ringraziava invitando Mussari come ospite “profano” ai
convegni massonici e assumendo la direzione responsabile di Siena News, il
giornale on-line fondato dal portavoce di Mussari, David Rossi, morto
tragicamente nei giorni più drammatici dello scandalo. La voce di Bisi è rimasta
registrata più volte nelle intercettazioni dell’inchiesta sull’aeroporto di
Ampugnano, mentre parlava con due degli indagati, il presidente Mussari e
l’amministratore delegato della società aeroportuale Enzo Viani, ex dirigente
Montepaschi ma anche fratello massone, nonché amministratore di Urbs, la
società che controlla il grande patrimonio immobiliare del Goi, da Villa il
Vascello all’ultima delle Logge, vera cassaforte dei massoni.
Massimo Bianchi
è definito da qualcuno dentro le logge “candidato di disturbo”: ha fatto una
campagna elettorale d’opposizione alla gestione Raffi, dopo essere stato però
per 15 anni il suo numero due, come Gran Maestro Aggiunto. Gli oppositori della
passata gestione faranno dunque confluire i voti sul notaio messinese Silverio
Magno. C’è chi, dentro il Grande Oriente, mostra preoccupazioni per il pericolo
di infiltrazioni mafiose. Tra questi, l’avvocato calabrese Amerigo Minnicelli,
che già nel 2012 segnalava che molti tra gli indagati e gli arrestati in
Calabria per mafia e corruzione erano appartenenti al Goi. Per tutta risposta, è
stato accusato di fomentare una campagna denigratoria contro la massoneria ed è
stato espulso dal Grande Oriente. Un anno dopo, lo stesso Raffi ha dovuto
evidentemente prendere atto che il problema era reale, tanto che ha provveduto a
sospendere la Loggia Verduci, nella Locride, proprio per infiltrazioni mafiose.
Oggi Minnicelli solleva di nuovo il problema. Delle tre regioni ad alta presenza
massonica – Piemonte, Toscana e Calabria – quest’ultima ha ben 2 mila iscritti,
di cui circa 1.500 Maestri votanti. Minnicelli calcola che si può risultare
eletti con 4-5 mila voti validi. I massoni calabresi sono dunque determinanti:
lo furono alle ultime elezioni, quando Raffi vinse grazie ai mille voti ricevuti
in Calabria, che gli permisero di superare per una manciata di voti (meno di
400) il suo sfidante Natale Di Luca. Ma per sapere quale sarà il futuro della
massoneria italiana dovremo aspettare l’equinozio di primavera.
Il grande boom dei
Fratelli. Così cambia la Massoneria.
I liberi muratori eleggono il
nuovo Gran Maestro. Che guida 802 logge e 22 mila iscritti. “L’Espresso” è
entrato nella Nuova Casa. Tra misteri, potenti sotto inchiesta, giovani adepti,
sedi sfarzose che non pagano l’Imu. E le denunce per una casta interna, scrive
Gianfrancesco Turano su “L’Espresso”. Sabato 1 marzo 2014, un po’ prima
delle dieci di mattina, gli spettri che si aggirano per l’Italia, per l’Europa,
per il pianeta, si materializzano davanti all’ex cinema Belsito, alle pendici di
Monte Mario, Roma. Al riparo da una pioggerella gelida, i devoti del Gadu
(grande architetto dell’universo) si scambiano il tfa (triplice fraterno
abbraccio) in attesa che il Gm (gran maestro) uscente del Goi (Grande Oriente
d’Italia) Gustavo Raffi inauguri la nuova Casa Massonica “Ernesto Nathan”. La
libera muratoria abusa degli acronimi quanto i redattori di lettere commerciali.
E, in effetti, nella piccola folla che attende l’inaugurazione del centro Nathan
tira una certa aria da ragionieri in gita. Età media elevata. Poche donne, per
lo più mogli, madri e figlie perché il Goi rimane un’obbedienza riservata ai
maschi. I rari giovani si accollano con fierezza i labari delle RRLL
(rispettabili logge) e li dispiegano all’interno della struttura che un tempo
ospitava le adunanze craxiane mentre, da questa settimana, accoglierà le
riunioni delle logge romane nei sette templi nuovi di zecca realizzati al piano
sotterraneo del Belsito. Nonostante le luci sfavillanti e le pareti imbiancate
di fresco, il mitico complotto della massoneria universale ha un’aria dimessa.
Il cronista in caccia di vip deve limitarsi all’ex deputato radicale Massimo
Teodori, al giornalista Rai Gabriele La Porta e a Valerio Zanone, già segretario
del Partito liberale durante la Prima repubblica. L’apparenza può ingannare.
Iniziati e profani attenti al fenomeno concordano: la massoneria non è mai stata
tanto in salute. Troppo in salute, a volte. Dal gran commis di Stato al
giornalista, dal politico al militare in carriera, dal giudice al criminale
organizzato, non c’è emergente che non sia sospettato di impugnare la cazzuola
misterica in una delle 187 obbedienze, come si chiamano le associazioni
massoniche, sparpagliate per la nazione e spesso in guerra fra loro al punto che
la storia dell’Italia unita è in gran parte un seguito di faide tra fratelli:
Agostino Depretis contro Francesco Crispi, Enrico Cuccia contro Michele Sindona
e il piduista accidentale Silvio Berlusconi contro il tecnocrate Mario Monti,
presunto braccio armato delle logge internazionali. Ma dato che la libera
muratoria teorizza la copertura a scopo protettivo delle figure apicali, dalla
matinée romana di inizio marzo non c’è da aspettarsi grandi nomi o outing di
alcun genere. Anche gli organi istituzionali invitati all’ex cinema Belsito, dal
sindaco di Roma Ignazio Marino fino al presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, che alcuni indicano addirittura come presunto ufficiale di
collegamento tra i fratelli americani e i grembiuli europei, si sono limitati a
spedire un messaggio di auguri. Il Gran Maestro Raffi li giustifica. «Abbiamo
deciso questa cerimonia di apertura in tempi brevissimi. D’altra parte, ci
tenevo molto a farla io», ammette l’avvocato ravennate con trascorsi nel partito
repubblicano. I nemici lo avevano soprannominato Raffinger, molto incautamente.
Benedetto XVI si è dimesso ben prima del papa massonico che ha fatto e disfatto
statuti pur di prolungare a livelli di record la sua permanenza al vertice. Dopo
quindici anni alla guida del Goi, Raffi non si è potuto ricandidare alle
elezioni del 2 marzo. L’inaugurazione della Casa massonica intitolata a Nathan,
storico sindaco della capitale e Gm del Goi fino all’avvento del massonofobo
Benito Mussolini, non è però l’ultimo atto della carriera di Raffi e il suo
futuro da Gv (grande vecchio) è assicurato. Sotto la sua gran maestranza i
profani hanno “bussato” in massa alle porte del Goi che è salito da 9 mila a
oltre 22 mila iscritti alle 802 logge nazionali. Molti hanno storto il naso
verso la svolta modernista e movimentista del Goi. La Gran Loggia, assise
annuale che si tiene a Rimini in aprile, è diventata un happening
esoterico-spettacolare a metà tra Sanremo (con tanto di concerto di Ornella
Vanoni) e il Meeting di Comunione e liberazione. «La sola struttura centrale»,
critica il notaio messinese Silverio Magno, uno dei tre candidati alle elezioni
del 2 marzo, «costa 6 milioni di euro all’anno». Una fetta non sottile dei
ricavi va in tasca al Gm: almeno 400 mila euro tra emolumento, note spese e
fringe benefits. A differenza della gestione precedente, quando il cagliaritano
Armandino Corona pensava più che altro a salvare il Goi dai contraccolpi dello
scandalo P2, con Raffi i fratelli sono stati obbligati a una frequentazione
regolare della loggia e al pagamento puntuale della quota annua di base (400
euro), pena l’esclusione dai piedilista dell’associazione. Di soli contributi
ordinari, il Goi incassa circa 10 milioni di euro l’anno, escluse le capitazioni
straordinarie e le donazioni. E se il conto economico è florido, lo stato
patrimoniale non è da meno. Le principali casseforti societarie (Urbs e Augusta
2002) hanno decine di immobili registrati a bilancio per una ventina di milioni
di euro. Ma il valore reale è almeno quadruplo. E nonostante le esternazioni di
Raffi contro la Chiesa che non paga l’Imu, anche il Goi approfitta
dell’esenzione ogni volta che un Comune lo consente. Quando non lo consente, si
va in causa. È successo con Villa del Vascello, la magnifica residenza del
Grande Oriente alle pendici del Gianicolo per la quale il Campidoglio non ha
riconosciuto il vincolo. L’inquilino di Villa del Vascello per i prossimi cinque
anni, il giornalista senese Stefano Bisi, ha confermato il pronostico vincendo
al primo turno con oltre il 40 percento ed evitando quindi il ballottaggio.
Sabato 8 marzo il suo incarico sarà convalidato dalla commissione elettorale
salvo contestazioni. Formalmente Raffi non ha sostenuto né Bisi né gli altri due
candidati (Magno e il livornese Massimo Bianchi) ma Bisi stesso dichiara di
volere reggere la maggiore obbedienza massonica in continuità con la linea del
gran maestro uscente. «Raffi ha mostrato la strada dell’apertura verso
l’esterno», dice Bisi, 57 anni. «Quando mi sono affiliato a una loggia di via
Montanini a Siena, era il 1982, un anno dopo lo scandalo P2. Si andava alle
riunioni alla chetichella e i fratelli mi dicevano di stare attento a non farmi
vedere quando uscivo in strada. Oggi ci si ferma fuori dal portone a
chiacchierare. Soprattutto fra i giovani ci sono ancora molti massoni che non
sanno di esserlo e che spero di potere iscrivere. Con la crisi dei valori e
della politica, con la desertificazione delle anime, dove altro dovrebbe andare
un giovane?» Si potrebbe obiettare che anche il potere massonico a Siena (170
iscritti al Goi) non è del tutto esente da una certa desertificazione. Le
disavventure del Monte dei Paschi e del suo ex numero uno Giuseppe Mussari,
ufficialmente profano ma certo ben collegato agli ambienti della muratoria
senese e toscana, non hanno affatto indebolito la candidatura di Bisi, amico di
Mussari. Anzi. Con il vicedirettore del “Corriere di Siena” si sono schierate
compatte le logge calabresi, forti di 2 mila maestri votanti. I rivali di Bisi
non hanno apprezzato il sostegno plebiscitario di una regione che durante la
gestione Raffi ha acquisito un peso elettorale e politico pari a quello di
Toscana e Piemonte, molto più popolate e di lunga tradizione massonica, e molto
superiore a regioni molto più estese come la Sicilia o la Lombardia. Uno dei più
critici è stato proprio il fratello calabrese Amerigo Minnicelli, che ha
denunciato brogli alle elezioni precedenti ed è stato trascinato davanti al
tribunale, prima massonico poi ordinario. «Raffi ha ritenuto di ampliare la
base», dice Minnicelli, «e questo non è certo un delitto. Ma l’esplosione degli
iscritti nella mia regione fa riflettere, così come è anomalo in sede locale il
consenso quasi unanime su un solo candidato, l’avvocato vibonese Marcello
Colloca. E l’operazione “Decollo money” che ha portato in carcere nel 2011
l’imprenditore Domenico Macrì, calabrese con residenza in Umbria e agganci in
banca a San Marino, amico personale di Raffi, lambisce la Gran maestranza».
Raffi ha risposto a modo suo. Ha sospeso Macrì ma ha espulso Minnicelli. «E su
Colloca ci metto la mano sul fuoco», aggiunge anche se il nome dell’avvocato
viene citato nell’informativa che, pochi giorni fa, ha portato all’arresto del
capo e del vice della Squadra Mobile di Vibo Valentia, in una pagina fra le più
nere nella lotta alla ’ndrangheta. Secondo i giudici, la loggia di Colloca
(“Michele Morelli”) sarebbe la stessa che ha affiliato alcuni giudici locali e
Pantaleone “Luni” Mancuso, mammasantissima del crimine calabrese che ha
teorizzato la confluenza della’ndrangheta nella massoneria. Lo scorso settembre
un’altra sospensione è toccata alla “Rocco Verduci”, loggia del Goi all’Oriente
di Gerace nella Locride, per infiltrazioni mafiose. «È vero che ho sospeso la
Verduci», dice Raffi, «ma finora non è arrivato uno straccio di prova concreta
sulle infiltrazioni. In ogni caso, quando sono arrivato al vertice del Goi, i
malavitosi avevano quarant’anni ed erano già dentro. Sulle infiltrazioni ho
sfidato anche monsignor Giovanni Bregantini, al tempo vescovo di Locri, a un
confronto pubblico, fosse in loggia in parrocchia o in piazza, così da parlare
anche delle magagne della Chiesa. Ma lui non me l’ha concesso». La linea di
difesa ufficiale è ribadita da Aldo Alessandro Mola, “profano” e storico della
libera muratoria. «L’infiltrazione mafiosa ha colpito tutte le organizzazioni
associative e tutte le categorie: partiti, clero, finanza, magistratura. È
ingeneroso bollare d’infamia la sola massoneria che, al contrario, è la rete di
sicurezza dello Stato quando i partiti e le istituzioni scricchiolano». E le
istituzioni di certo non scricchiolano soltanto in Calabria. Oltre ai pasticci
di stampo massonico che hanno inguaiato il Monte dei Paschi e al processo per
l’aeroporto di Siena che ha coinvolto il raffiano Enzo Viani, amministratore
dell’immobiliare Urbs, la Toscana in grembiule è rimasta coinvolta dal crac
della holding Bf di Roberto Bartolomei e Riccardo Fusi, costruttore molto vicino
a Denis Verdini, banchiere in Firenze, ex coordinatore nazionale del Pdl e uomo
che sussurra all’orecchio del premier Matteo Renzi per conto dell’opposizione
forzista. In un filone dell’inchiesta sul crac Bf, sono emerse amicizie fra
alcuni giudici che dovevano occuparsi delle società di Fusi, l’amministratore
delegato della Fiorentina Sandro Mencucci e due professionisti, un dentista e un
avvocato che sono finiti sotto inchiesta in base alla legge 17 del 1982, la poco
applicata legge Anselmi sulle associazioni segrete approvata dieci mesi dopo il
ritrovamento delle liste della loggia Propaganda 2 di Licio Gelli (marzo 1981).
Per quanto la deputata democristiana Tina Anselmi sia tra le figure più odiate
in loggia insieme agli ex pubblici ministeri Agostino Cordova e Luigi De
Magistris, c’è da chiedersi se i principi delle tenebre massoniche siano un
avvocato e un dentista di Prato. La stessa domanda, peraltro, circolava ai tempi
di Gelli, ex dirigente della materassi Permaflex di Frosinone. Ma la domanda
sulle logge coperte, se esistono e quanto sono influenti, è destinata a restare
senza risposta. All’interno delle logge, governanti e oppositori sono uniti sul
no quando si chiede se esistono ancora le iniziazioni “sulla spada” o
“all’orecchio del Gran maestro”, riservate ai massoni di maggiore influenza, e
se i pezzi da novanta preferiscano iscriversi a logge straniere, a Montecarlo,
in Canton Ticino, a Malta o a Londra, per mantenere il riserbo. Ma è un no
obbligato. Gli aggiornamenti della P2 - la P3, la P4 e la P5 dello sketch di
Corrado Guzzanti - sono tutti in versione orale.
Massoneria, ai conservatori
degli Alam non piace Facebook,
scrive ancora “L’Espresso”. Antonio Binni, numero uno della Gran Loggia d’Italia
degli antichi liberi accettati muratori, è contrario al modernismo: "Io sono un
massone in blazer". «Poco tempo fa un fratello giovane ha pubblicato una sua
foto a una festa su Facebook. È stato richiamato per quello che noi consideriamo
un comportamento disdicevole». Antonio Binni, 77 anni, avvocato civilista con
studio a Bologna, numero uno della Gran Loggia d’Italia degli Alam (antichi
liberi accettati muratori) dopo le elezioni dello scorso dicembre, non ha paura
di essere elitario, un filo démodé. La sua obbedienza, che una volta stava a
Roma in piazza del Gesù e oggi si è spostata poco distante a palazzo
Vitelleschi, è la seconda sotto il profilo numerico dopo il Grande Oriente con
10 mila iscritti (500 logge) ed è sempre passata per essere più conservatrice
rispetto al Goi, oltre che collegata al Grande Oriente di Francia (52 mila
iscritti) mentre il Goi si richiamava ai fratelli inglesi della Gran Loggia
Unita. L’elezione di Binni - suo zio era l’italianista Walter - è stata una
conferma della linea di continuità con il passato contro i progetti rottamatori
dell’avversario Luciano Romoli. La parola d’ordine è “pochi ma buoni” contro
l’espansionismo modernista del Goi di Gustavo Raffi. «Lui si è dichiarato
massone in jeans. Io sono massone in blazer e non vengo remunerato per la mia
carica», dice Binni. «Non lo dico per fare polemica con lui. Abbiamo buoni
rapporti con il Grande Oriente d’Italia ma la nostra linea punta di più sugli
aspetti culturali, è più restrittiva. E quando un profano “bussa” da noi per
ottenere l’affiliazione, non ci limitiamo a richiedere il certificato penale o i
carichi pendenti, ma ci informiamo con la nostra rete locale e pretendiamo che
ci sia qualcuno che presenti il candidato facendosene garante. Questo ci ha
tenuti lontano dagli scandali giudiziari tipo P2 che, pur essendo una loggia
coperta del Goi e non nostra, ci attirò un mese di perquisizioni». La presa di
distanza dalla disinvoltura di certe affiliazioni targate Goi è evidente. Nello
stesso modo pacato e filosofico Binni non risparmia la stoccata al Vaticano che,
secondo quanto risulta al Gran Maestro, conta parecchi sacerdoti iscritti agli
Alam, con buona pace di papa Bergoglio che ha denunciato il lobbismo dei
muratori in tonaca. «Il pregiudizio religioso o laicista per noi non esiste»,
dice Binni. «A Milano ho appena affiliato un fratello musulmano che ha giurato
sul Corano. In tutto il Nordafrica siamo ben organizzati, così pure nella zona
balcanica e mi hanno appena chiesto di aprire una loggia in Ucraina». L’altro
punto di forza degli Alam è l’apertura alle iscrizioni femminili che
rappresentano il 45 per cento dell’obbedienza e che spesso sono le mogli e le
sorelle dei massoni del Goi. Nella prossima tornata elettorale, prevista nel
2016 se non sarà portata a termine la riforma verso un unico mandato
quinquennale non rinnovabile, Binni si aspetta una candidatura femminile.
«L’apporto della donna è indispensabile. Sempre sotto il profilo della
tradizione».
FINANZA E POTERE. IL GRUPPO
BILDERBERG E LE TEORIE COMPLOTTISTICHE.
Bilderberg: il gruppo dei
"poteri forti" e le teorie del complotto mondiale.
Il meeting di Torino del maggio 2018 richiama la storia del gruppo di potenti
nato nel 1954 tra ricostruzione e Guerra Fredda, fino all'Europa unita e alla
globalizzazione, scrive Edoardo Frittoli l'8 giugno 2018 su "Panorama".
Nato come gruppo neoliberista con l'intento di discutere i grandi temi
dell'economia e della politica tra i più influenti think-tank del mondo
occidentale, il gruppo Bilderberg si è riunito quest'anno a Torino, generando
non poche polemiche e proteste sulla opportunità della sua presenza e
sull'impatto della visita sulla città. Ripercorriamo le tappe principali della
sua storia, dei principali membri e delle teorie cospirazioniste che si sono
sviluppate negli anni di attività del gruppo. Il Bilderberg è nato ufficialmente
nel 1954, nel pieno della Guerra Fredda e della ricostruzione europea finanziata
dal piano Marshall. Muove i primi passi proprio negli anni cruciali della
nascita delle istituzioni europee e dell'Alleanza atlantica. Il nome Bilderberg
fu preso dall'hotel olandese che ospitò la prima riunione ad Oosterbeck dal 29
al 31 maggio 1954. I promotori del gruppo furono il consigliere politico di
nazionalità polacca Jòzef Retinger, esiliato dal governo comunista nel
dopoguerra. Assieme a lui il Principe Bernhard d'Olanda, di nascita e formazione
tedesca. A rappresentare la grande industria multinazionale tra i fondatori del
Bilderberg l'olandese Paul Rijikens a capo della Unilever. Tra i grandi
banchieri invitati al primo meeting spicca il nome dell'americano David
Rockefeller. I lavori furono organizzati dalla struttura ancor oggi in atto, un
Comitato direttivo in rappresentanza di 18 nazioni coordinato da un Presidente e
da un Segretario Generale onorario. I membri su invito possono variare da un
minimo di 120 ad un massimo di 200 ed includono figure di primissimo piano del
settore finanziario e bancario, industriale, politico e diplomatico e dei media.
Le riunioni del Bilderberg si svolgono rigorosamente a porte chiuse, secondo un
programma che include grandi temi di respiro internazionale decisi dal Consiglio
e divulgati preventivamente. La sicurezza attorno agli ospiti è massima, in
particolar modo in seguito alle crescenti proteste di piazza che si sono
intensificate negli ultimi anni nei confronti della riunione segreta dei grandi
potenti. Una caratteristica che ha contribuito ad alimentare decisamente la
tensione attorno alla riunione annuale del Bilderberg è il fatto che i
giornalisti non siano invitati e che nessuna notizia possa trapelare in merito
ai contenuti del convegno. Proprio la natura pseudo-massonica degli incontri ha
generato in oltre mezzo secolo di esistenza del gruppo Bilderberg una diffusa e
convinta serie di teorie complottiste secondo le quali i potentissimi membri del
consesso perseguirebbero l'obiettivo finale di plasmare e comandare il mondo
globalizzato secondo un "nuovo ordine mondiale" disegnato da un'élite di
oligarchi. Già dai primi passi del Bilderberg si sono susseguite le ipotesi che
la lobby politico-economica si fosse formata allo scopo di influenzare gli
equilibri globali secondo una scansione parallela allo sviluppo del mondo
occidentale postbellico dominato dagli Usa e diviso dalla Guerra Fredda.
Gli anni 50 e 60: il Gruppo
Bilderberg e l' "tlanticismo". Proprio il rapporto con l'Urss e i suoi
satelliti aprì l'ordine dei lavori della prima sessione del maggio 1954. Tra gli
organizzatori era stato incluso un personaggio di spicco, il capo della CIA
Walter Bedell Smith (che fu presente all'Armistizio di Cassibile il 3 settembre
1943 oltre che consigliere militare di Eisenhower, che nel frattempo era stato
eletto Presidente degli Usa). L'obiettivo principale del primo e dei seguenti
meeting degli anni seguenti fu la creazione del consenso internazionale alle
teorie americane del libero mercato, stimolato dagli effetti e dai finanziamenti
inclusi nel piano Marshall. I critici della prima frazione della vita del gruppo
lessero negli intenti la volontà di influenzare le scelte economiche dei Paesi
europei e di blindare il modello capitalista. Tra gli ospiti della prima
riunione figurava il Presidente della Fiat Vittorio Valletta.
Le origini naziste del
fondatore. Il Principe Bernhard, nato e cresciuto in Germania, avrebbe aderito
secondo gli archivi del NSDAP al partito di Hitler fin dalla prima ora almeno
fino al 1934. In seguito fu organico alla IG Farben, il colosso della chimica
tedesca che produsse lo Zyklon-B usato nelle camere a gas. Nel 1976 il fondatore
del gruppo Bilderberg fu coinvolto nell'affare delle tangenti noto come scandalo
Lockheed.
Il fondatore Jòzef Retinger
spia del Vaticano e della CIA? Retinger fu attivo tra le due guerre come
consigliere durante le rivolte messicane. Durante la Seconda guerra mondiale fu
a capo del Governo polacco in esilio a Londra, dove venne in contatto con
i Servizi inglesi e americani. Alla fine del conflitto fu paracadutato in
Polonia con armi e fondi per la resistenza. Esiliato dai governi comunisti, sarà
vicino all'ambiente dei Gesuiti e sospettato di essere un agente del Vaticano. I
teorici del complotto collegano il fondatore del Bilderberg alla sua opera di
costruzione del Consiglio d'Europa e del Movimento Europeo. Tra i contatti
italiani principali oltre a Vittorio Valletta, Retinger incluse il diplomatico
italiano Pietro Quaroni ed Alcide De Gasperi, che fu il primo membro italiano
del gruppo.
Il Bilderberg alimenta i
conflitti nel mondo? L'attività del gruppo è stata spesso correlata alla storia
dei conflitti seguiti al 1945. Ad esempio l'incidente del Tonchino che scatenò
la guerra in Vietnam fino al conflitto tra Europa e Serbia contro Slobodan
Miloseviç fino ad arrivare alle "armi di distruzione di massa" di Saddam
Hussein che fecero scoppiare la guerra in Iraq. I motivi delle pressioni del
gruppo, secondo i complottisti avrebbero un duplice obiettivo: mantenere la
popolazione in continua tensione e generare affari di grande valore alle lobby
delle armi che farebbero parte del gruppo di potere.
Riduzione progressiva della
sovranità nazionale tramite la globalizzazione. Il gruppo Bilderberg, che si
riunisce prevalentemente in Europa e ogni 4 anni in Nordamerica, avrebbe seguito
e plasmato direttamente le istituzioni europee che progressivamente
avrebbero tolto la Sovranità agli stati membri tramite un azione
di spersonalizzazione burocratica (gli accusatori indicano che l'80% delle leggi
della UE siano state decise da funzionari non eletti) e tramite l'istituzione
della moneta unica controllata dalla Banca Centrale Europea. L'azione di
controllo sulla sovranità monetaria avrebbe un lungo passato, inaugurata negli
anni del New Deal dal banchiere membro del Bilderberg David Rockefeller con
l'Istituzione di un gruppo simile a quello del 1954, il Council On Foreign
Relations. Il potere del presunto "nuovo ordine" avrebbe ottenuto la propria
forza politico-finanziaria con il sistema del debito sovrano degli Stati
dell'UE, usato come strumento coercitivo nei confronti delle economie nazionali
a vantaggio del sistema sovranazionale. Gli accusatori del Bilderberg citano una
situazione simile a quella europea tentata anche nel continente americano: i
teorici del complotto tracciano la storia delle relazioni tra Usa, Canada e
Messico, cercando di delineare le trame del disegno eversivo passando dall'idea
di unificazione tra Canada e Usa, dalla quale avrebbero escluso il
francofono Quèbec. Nel 1995 fu indetto nella Provincia canadese il referendum
per l'indipendenza, che fu perso per un soffio dai separatisti. L'anno
precedente la macchina economica dei poteri forti si era poi mossa con la firma
degli accordi commerciali noti come NAFTA (North American Free Trade Agreement)
che generarono la migrazione delle grandi aziende nordamericane verso il
Messico causando la profonda crisi del comparto industriale americano ancora
attuale. Nel 2005 i teorici del complotto avrebbero indicato nel meeting
tra George W. Bush, Vicente Fox e Paul Martin la ratifica di un accordo segreto
di unificazione politica e monetaria dei tre stati con adozione della moneta
unica, l'"Amero".
Poveri, sottomessi e invasi.
Una delle accuse ricorrenti nelle frequenti proteste in occasione delle riunioni
annuali del Bilderberg sarebbe stata quella di avere favorito un flusso
migratorio dai Paesi africani allo scopo di indebolire e spersonalizzare
ulteriormente le identità nazionali d'Europa, oltre a quello di garantire un
serbatoio di futuri consumatori in contrasto con una popolazione del vecchio
continente in netto declino. Molte di queste tesi sono state fatte proprie dai
movimenti politici anti-europeisti e nazionalisti emersi nell'ultimo decennio.
Le condizioni di disagio socio-economico creerebbero le condizioni per
realizzare il progetto di un nuovo "ordine mondiale".
I membri del Bilderberg sono
figli dei "rettiliani"? La tesi più curiosa dei complottisti si colloca nella
più pura tradizione della letteratura fantastica del XX secolo: ben costruita e
divulgata, l'idea della natura rettile del gruppo del Bilderberg si è divulgata
dalle idee di David Icke, un cronista sportivo secondo il quale dietro alle
figure dei potenti del gruppo si nasconderebbe una razza di gigantesche
lucertole mutanti decise a conquistare il potere mondiale. Tra gli invitati
italiani alle riunioni del Bilderberg vi sono stati: Alberto Pirelli, Alcide de
Gasperi, Ugo La Malfa, Guido Carli, Alberto Ronchey, Ugo Stille, Francesco
Cossiga, Vittorio Valletta, Romano Prodi, Mario Draghi, Umberto Agnelli, Mario
Monti, Tommaso Padoa-Schioppa e molti altri influenti politici, banchieri,
imprenditori e diplomatici.
La Trilaterale ed il
Bilderberg condannano Berlusconi
scrive Giancarlo Marcotti. Ore 19:45 di giovedì 1 agosto 2013, va in onda
l'ultima scena di una farsa colossale, la sentenza della Corte di Cassazione nei
confronti del cosiddetto processo Mediaset che vedeva fra gli imputati anche
Silvio Berlusconi. La “Cupola” che vuole governare il mondo, la Commissione
Trilaterale ed il Gruppo Bilderberg, tanto per capirci, cioè quell'insieme di
faccendieri e uomini del malaffare che stanno soffocando il mondo occidentale
portandolo alla rovina, crede così di aver raggiunto lo scopo che si era
prefisso già da diversi anni, cioè distruggere politicamente e umanamente Silvio
Berlusconi. Viene anche rispettato il copione seguito da tutte le organizzazioni
più spietate, e cioè che il nemico non va tanto eliminato “fisicamente”
(potrebbe resistere “il mito”), ma ne va distrutta la figura, la moralità e
l'integrità. L'arma impiegata per l'esecuzione è la Magistratura, che, in questi
casi, a mo' di rafforzativo, viene ribattezzata “Giustizia”. Quale sia la colpa
di Berlusconi, per la quale è stata emessa questa sentenza capitale da parte
della Commissione Trilaterale, è evidente a tutti. Berlusconi non è mai piaciuto
all'establishment che Governa il mondo, è un imprenditore non un politico, ed
anche una volta diventato Presidente del Consiglio continua a comportarsi da
imprenditore, cioè cerca di fare gli interessi economici dell'Italia senza dare
peso agli equilibri geopolitici, quindi si attira immediatamente le antipatie
delle burocrazie del Vecchio Continente e, inevitabilmente si scontra con
l'oligarchia finanziaria anglosassone. Egli stringe amicizie, ovviamente
nell'interesse dell'Italia, con leader mondiali invisi alla Trilaterale (due
nomi su tutti: Putin e Gheddafi) per garantirsi, ai migliori prezzi di mercato,
le indispensabili risorse energetiche delle quali, uno Stato manifatturiero come
il nostro, ha assoluta necessità. Per certi versi, quindi la persona alla quale
potremmo paragonarlo è certamente Enrico Mattei. Anche se Mattei non ebbe mai
incarichi politici senza dubbio era colui che “guidava” la politica economica
nazionale e lo fece nel solo interesse del nostro Paese, sappiamo tutti, poi, la
fine che gli fecero fare le multinazionali del petrolio americane. Come dicevo,
oggi, non si usa più far precipitare un aereo facendolo passare per un guasto,
Berlusconi, in un caso del genere, sarebbe diventato un “martire”, si preferisce
invece, proprio come fanno le mafie, distruggere il nemico dal punto di vista
morale, occorre infangarlo ed attribuirgli tutti i peggiori crimini.
Un comportamento ancora più
umiliante rispetto all'eliminazione fisica. D'altronde questo “metodo” era già
stato utilizzato con successo nei confronti di Bettino Craxi e Giulio Andreotti,
forse gli ultimi veri leaders politici che abbia avuto l'Italia. A Craxi ed
Andreotti non fu perdonata la vicenda di Sigonella, l'unico caso, nel
dopoguerra, in cui Carabinieri italiani e forze speciali dell'esercito americano
(i Navy Seal) furono ad un passo da uno scontro a fuoco. L'unico caso in cui
uomini politici italiani ebbero il coraggio di rifiutarsi di obbedire agli
ordini del Presidente degli Stati Uniti rispondendogli che: “Sul suolo italiano,
comandano gli italiani”. Quel gran rifiuto nei confronti dell'allora Presidente
degli Stati Uniti Ronald Reagan costò loro praticamente la vita perché fu
scatenata la Magistratura che in due procedimenti diversi li accusò delle più
infamanti nefandezze. Oggi tocca a Berlusconi, la storia si ripete, all'uomo di
Arcore è stato intimato più volte di lasciare la politica, avrebbe avuto una
vita di lussi continuando a fare l'imprenditore, ma sappiamo che nel vocabolario
del Cavaliere non esiste la parola “sconfitta” e lui ha opposto un rifiuto.
Volete una prova di questa mia tesi? Semplice! Qual è l'emblema per eccellenza
della finanza mondiale? Cosa legge prima di ogni altra cosa un uomo d'affari in
qualunque luogo al mondo si trovi? Sì certo, nessun dubbio … Il Financial Times
Ed il Financial Times come titola dopo la conferma della sentenza da parte della
Cassazione? Così ... “Cala il sipario sul buffone di Roma” Un linguaggio che non
si può trovare neppure in un tazebao di un Centro Sociale. Un titolo del genere
è più che una firma, e non lascia dubbi su chi siano i mandanti. Ed ora come
andrà a finire? Nessuno lo può ancora sapere, nemmeno la Trilaterale che pensava
già di aver “ucciso” politicamente Silvio Berlusconi quando nel novembre del
2011 organizzò il colpo di Stato in Italia che portò al governo Mario Monti. Che
si sia trattato di un colpo di Stato, penso che non ci siano dubbi. Se in un
giorno viene deposta la persona democraticamente eletta alla carica di
Presidente del Consiglio e sostituita con un'altra che non ha nessuna
legittimazione popolare, beh, come possiamo chiamarlo se non golpe? Come non c'è
alcun dubbio su chi abbia ordito il golpe visto che in quel momento Mario Monti
è il Presidente per l'Europa della Commissione Trilaterale, mandato che lascia a
Jean Claude Trichet assumendo la carica di Premier in Italia. Nelle elezioni
dello scorso febbraio, però, Berlusconi, dato da tutti per spacciato, compiva il
miracolo, risultando il vero vincitore morale della tornata elettorale e
ribaltando un pronostico che non gli dava chance, quindi anche oggi seppur
formalmente fuori dai giochi, non si può dire che il Cavaliere abbia chiuso la
sua avventura politica. Certo che se dovesse rinascere anche questa volta come
un'Araba Fenice si dovrebbe davvero gridare al miracolo, ma, come si dice,
quando c'è di mezzo Silvio Berlusconi … mai dire mai.
IL GRUPPO BILDERBERG.
Il Gruppo Bilderberg
(detto anche conferenza Bilderberg o club Bilderberg), spiega
Wikipedia, è un incontro annuale per inviti, non ufficiale, di circa 130
partecipanti, la maggior parte dei quali sono personalità influenti in campo
economico, politico e bancario. I partecipanti trattano una grande varietà di
temi globali, economici, militari e politici.
Il gruppo si riunisce
annualmente in hotel o resort di lusso in varie parti del mondo, normalmente in
Europa, e una volta ogni quattro anni negli Stati Uniti o in Canada. Ha un
ufficio a Leida nei Paesi Bassi. I nomi dei partecipanti sono resi pubblici
attraverso la stampa ma la conferenza è chiusa al pubblico e ai media. Dato che
le discussioni durante questa conferenza non sono mai registrate o riportate
all'esterno, questi incontri sono stati oggetto di critiche e di varie teorie
del complotto, come ad esempio quella sostenuta da Daniel Estulin nel libro
Il Club Bilderberg. Gli organizzatori della conferenza, tuttavia, spiegano
questa loro scelta con l'esigenza di garantire ai partecipanti maggior libertà
di esprimere la propria opinione senza la preoccupazione che le loro parole
possano essere travisate dai media.
Storia del gruppo
Bilderberg
La prima conferenza si tenne
il 29 maggio 1954 presso l'hotel de Bilderberg a Oosterbeek, vicino
Arnhem, in Olanda. L'iniziativa di tale prima conferenza fu presa da molte
persone, incluso il politico polacco Józef Retinger, preoccupato dalla crescita
dell'antiamericanismo nell'Europa occidentale e col fine di favorire la
cooperazione tra Europa e Stati Uniti in campo politico ed economico, anche in
ottica di difesa. Per quella prima conferenza furono contattati il principe
Bernhard van Lippe-Biesterfeld, il primo ministro belga Paul Van Zeeland e
l'allora capo della Unilever, l'olandese Paul Rijkens. Il principe Bernhard van
Lippe-Biesterfeld a sua volta coinvolse Walter Bedell Smith, capo della CIA. La
lista degli ospiti fu redatta invitando due partecipanti per ogni nazione, uno
per la parte liberale e l'altro per l'opposta parte conservatrice. Cinquanta
delegati da undici paesi europei insieme a undici delegati statunitensi
parteciparono a quella prima conferenza. Il successo di questo primo incontro
spinse gli organizzatori a pianificare delle conferenze annuali. Fu istituita
una commissione permanente con Retinger nel ruolo di segretario permanente. Alla
morte di Retinger divenne segretario l'economista tedesco Ernst van der Beugel
nel 1960 e in seguito la posizione fu rivestita da Joseph E. Johnson, William
Bundy e altri. Molti partecipanti al gruppo Bilderberg sono capi di Stato,
ministri del tesoro e altri politici dell'Unione Europea ma prevalentemente i
membri sono esponenti di spicco dell'alta finanza europea e anglo-americana.
Struttura organizzativa
La conferenza è organizzata da
una commissione permanente (Steering Committee) della quale fanno parte
due membri di circa 18 nazioni differenti. Oltre al presidente della commissione
è prevista la figura di segretario generale onorario. Non esiste la figura di
membro del gruppo Bilderberg ma solo quella di membro della commissione
permanente ("member of the Steering Committee"). Esiste anche un gruppo
distinto di supervisori.
Aliberti Editore ha
pubblicato
Club Bilderberg, gli uomini che comandano il mondo di Domenico Moro. In
questo estratto Moro ricostruisce la storia del Bilderberg, e la composizione
dei suoi organismi dirigenti. Precursore e per certi versi padre del
Bilderberg è il Council on Foreign Relations. Il Cfr fu fondato nel 1921 da
prominenti personalità statunitensi allo scopo di completare l’uscita dal
tradizionale isolazionismo degli Usa, iniziata con l’intervento militare nel
conflitto che si combatteva in Europa. L’obiettivo era far assumere agli Usa una
maggiore responsabilità e il ruolo di decision maker nei nuovi assetti
mondiali post bellici. Cosa che, però, si realizzò solo dopo la seconda guerra
mondiale con la liquidazione di Germania e Giappone. Anche se con molte
somiglianze con il Bilderberg il Council on Foreign Relations se ne distingueva
per l’essere – almeno inizialmente – ristretto ai soli cittadini
statunitensi e perché non rifletteva ancora il ruolo guida che gli Usa avrebbero
assunto. Tuttavia, il Cfr svolse un ruolo attivo di consulente del governo Usa
durante la guerra, confermando la tesi di Wright Mills sulla formazione
dell’élite del potere nel corso del conflitto e, secondo alcuni, influenzò
direttamente le politiche di ricostruzione post-belliche, tra le quali la
formazione delle istituzioni previste negli Accordi di Bretton Woods (Banca
mondiale, Fmi). Il periodo immediatamente successivo alla seconda guerra
mondiale presenta, rispetto al primo dopoguerra, uno scenario internazionale
mutato e contrassegnato da due fenomeni. Il primo è la ricostruzione di un
mercato mondiale capitalistico sotto l’egemonia Usa, e basato sulla
ricostruzione, sul modello statunitense, delle economie giapponese e soprattutto
europea occidentale. Il secondo è la sfida rappresentata dal rafforzamento
dell’Urss e dei partiti socialisti e comunisti non solo nel Terzo mondo ma anche
in molti Paesi avanzati. Ciò evidentemente poneva questioni importanti di
mantenimento della stabilità politica ed economica. Davanti alle élites si
presentavano, quindi, problemi nuovi e più globali, che rendevano necessaria la
formazione di sedi di confronto e di elaborazione di strategie adeguate. In
particolare, sedi transnazionali, che riunissero le élites atlantiche, ovvero
quelle di Usa ed Europa occidentale. Le élites venivano così a costituire un
livello informale e parallelo a quello ufficiale degli Stati. Questi, infatti,
sul piano economico avevano costituito l’Fmi e la Banca mondiale e sul piano
politico-militare la Nato, che, per l’appunto nacque come alleanza atlantica,
tra Usa e Europa occidentale, in funzione di contrasto all’Urss. Il gruppo
Bilderberg nacque il 29 maggio 1954 e prese il nome dall’albergo in Olanda in
cui si riunì per la prima volta. Tra i principali ispiratori e primo segretario
ci fu Joseph Retinger, di origine polacca e fondatore anche del Movimento
Europeo, organizzazione ispiratrice del processo di unificazione europea. Lo
scopo dichiarato della costituzione del Bilderberg era incentivare il dialogo
tra i leading citizens di Usa ed Europa Occidentale per «creare una
migliore comprensione delle forze complesse e delle principali tendenze che
influenzavano le nazioni occidentali nel periodo postbellico». Ma, tiene a
precisare il Gruppo, la fine della Guerra fredda non ha diminuito bensì ha
aumentato l’importanza di queste riunioni. Secondo il Bilderberg, ciò che rende
unici gli incontri sono tre caratteristiche. L’ampia presenza di leading
citizens, provenienti da vari settori della società, in incontri che hanno
una durata di tre giorni e impegnano i convenuti in discussioni informali e
off-the records su tematiche di importanza attuale, specialmente di politica
estera ed economia internazionale. Il forte feeling tra i partecipanti, che
permette di superare la varietà di orientamento e impostazione derivata dalla
provenienza da nazioni diverse. La privacy degli incontri, che non ha altro
scopo se non quello di permettere ai partecipanti di esprimersi apertamente e
liberamente. Il Bilderberg si presenta come «un forum internazionale, piccolo,
informale e non ufficiale nel quale possono essere espressi punti di vista
diversi e la reciproca comprensione sviluppata. L’unica attività del Bilderberg
sono le conferenze. Durante gli incontri non vengono fatte votazioni, né prese
risoluzioni, e neanche fatte dichiarazioni politiche». Dal 1954 si sono tenuti
cinquantanove incontri, uno all’anno, i cui partecipanti e l’agenda vengono resi
pubblici alla stampa, a differenza dei contenuti dei dibattiti. I partecipanti
ai dibattiti variano ogni volta e vengono scelti dal presidente dopo
consultazioni con lo Steering Committee sulla base delle loro conoscenze ed
esperienze a riguardo delle tematiche che verranno affrontate. La composizione
dei partecipanti, che solitamente sono circa 120, è la seguente: sul piano della
provenienza geografica per i due terzi vengono dall’Europa Occidentale ed il
rimanente dagli Stati Uniti. Sul piano dei settori sociali, essi provengono per
un terzo dalla politica e dalla istituzioni, e per due terzi dalla finanza,
dall’industria e dalle comunicazioni. Ad ogni modo, i convenuti partecipano a
livello personale e non ufficiale. Gli organismi di autogoverno del Bilderberg
sono il presidente e lo Steering Committee, il comitato direttivo. Il presidente
è eletto dallo Steering Committee, mentre quest’ultimo è eletto non si capisce
bene da chi per quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Esiste,
inoltre, la figura del Segretario esecutivo che riporta al presidente. Compiti
del presidente sono presiedere il direttivo, decidere con esso le tematiche da
discutere e, come detto, selezionare i partecipanti alle conferenze annuali. Le
spese del mantenimento del segretariato sono a carico del direttivo, mentre
quelle dei meeting annuali sono a carico dei membri del direttivo del Paese
ospitante. Vediamo ora da dove vengono, quanti e chi sono i membri del
direttivo. I Paesi cui appartengono sono 18 e sono collocati esclusivamente in
Nord America (con l’esclusione del Messico) e in Europa Occidentale, con la sola
eccezione della Turchia. Tali Paesi fanno quasi tutti parte, spesso sin
dall’inizio, della Nato, tranne la Svizzera, la Finlandia, l’Austria, la Svezia
e l’Irlanda. I membri del gruppo dirigente sono 35, di cui 33 dello Steering
Committee, cui si aggiungono il presidente, il francese Henri de Castries, ed il
membro anziano dell’Advisory Group, lo statunitense David Rockefeller.
L’egemonia statunitense è chiara, come del resto lo è anche nella Nato, anche se
il presidente è europeo. Numericamente prevalgono le personalità anglosassoni,
in tutto 16 (45,7 per cento). In particolare gli statunitensi sono 11 (31,4 per
cento), ai quali si aggiungono 3 britannici e 2 canadesi. Gli altri Paesi, con
l’eccezione della Francia con 3 membri (che ha il presidente Jean Claude Trichet
classificato come “internazionale”) e della Germania con 2, hanno tutti un solo
membro nel direttivo. Molti Paesi sono sottorappresentati, a partire dalla
Germania che pure è la seconda nazione presente nel comitato direttivo per
economia e popolazione e dall’Italia, che ha un solo membro, Franco Bernabè,
presidente di Telecom Italia, come la Norvegia, il Portogallo e la Grecia. La
composizione è piuttosto varia e copre quasi tutti i settori, anche se prevale
la finanza. Nello Steering Committee ci sono membri che hanno incarichi
direttivi in 13 grandi imprese finanziarie. Di queste 2 sono grandi gruppi
assicurativi, 4 fondi d’investimento (attivi in hedge fund e private equity), e
7 grandi banche. Dopo la finanza c’è l’industria con 11 imprese. Vi sono
rappresentati quasi tutti i settori più importanti, il metalmeccanico (2), i
mass media (2), il siderurgico (2), il chimico e farmaceutico (2), il
petrolifero (1), l’informatico (1), e le telecomunicazioni (1). Inoltre, sono
presenti esponenti di 4 think-tank, 3 esponenti del mondo politico (un
ministre d’État belga, un membro della Camera dei Lord e il Lord cancelliere
e segretario alla giustizia britannico), 2 di quello accademico e infine un
esponente del mondo della distribuzione e uno di uno studio legale
internazionale. Gli Usa prevalgono nella finanza, mentre gli europei
nell’industria. Sono statunitensi 2 banchieri e 4 dirigenti di fondi
d’investimento, ovvero la totalità del sottosettore, 3 rappresentanti dei
think-tank, il che suggerisce una egemonia ideologica, un accademico e soltanto
2 esponenti di imprese industriali. La Gran Bretagna ha 2 politici e un
banchiere. Il resto dell’Europa occidentale ha 8 dirigenti di imprese
industriali su 11 totali, 3 banchieri e un dirigente di un fondo d’investimento,
2 di assicurazioni, il presidente di un think-tank, un accademico, un legale
internazionale e un politico. In effetti, la nazionalità dei membri del
direttivo non coincide sempre con quella delle imprese cui fanno riferimento,
dato che si tratta spesso di imprese transnazionali. Ad esempio, l’irlandese
Peter D. Sutherland è dirigente di Goldman Sachs che in effetti è una banca
statunitense. Non tutte tra le imprese presenti sono gruppi transnazionali al
vertice della classifica delle imprese mondiali come Royal Dutch Shell e
Microsoft – quinta e decima al mondo per profitti nel 2010 – o ai primi posti
nel ranking dei loro settori, come Alcoa, EADS, Novartis, e Telecom Italia tra
le industriali, Goldman Sachs, Barclays, Axa, Zurich Insurance tra le
finanziarie. Le altre sono grandi imprese ma non hanno una dimensione
particolarmente grande a livello mondiale, anche se spesso si tratta di aziende
prestigiose e con contatti ramificati come la banca Lazard. In effetti,
l’appartenenza allo Steering Committee del Bilderberg non dipende strettamente
dalla grandezza o importanza dei gruppi che si dirigono, ma – come vedremo –
dalla internità al network dell’élite degli affari mondiale. È, insomma, una
appartenenza in gran parte personale, anche se ovviamente l’essere inseriti in
certe imprese aiuta. Vale forse la pena soffermarsi sulle biografie di qualcuno
dei membri del gruppo dirigente. Henri Conte de Castries, presidente del
Bilderberg dal 2010, proviene da una antica famiglia della nobiltà francese, cui
appartiene anche Christian de Castries comandante a Dien Bien Phu, ed è un
esempio dell’intreccio tra aristocrazia e mondo degli affari. Nella storia del
Bilderberg un esempio importante ne è anche il principe Bernhard van
Lippe-Biesterfeld, marito della regina Giuliana d’Olanda e tra i fondatori del
Bilderberg di cui fu primo presidente dal 1954 al 1976, allorché dovette
dimettersi per il suo coinvolgimento nello scandalo delle tangenti Lockheed. Il
principe occupò anche posizioni di responsabilità in due corporation che
ricorrono spesso nel Bilderberg e nella Trilaterale, la Shell e SGB. Henri de
Castries è rappresentativo dell’esistenza del meccanismo delle revolving
doors anche in Francia. Fu alto funzionario del ministero del Tesoro
francese sotto il governo Chirac, durante il quale (1986) partecipò alla
privatizzazione di varie aziende tra cui Compagnie Générale d’Electricité, ora
chiamata Alcatel-Lucent. Nel 1989 entrò in Axa, la seconda compagnia
assicuratrice mondiale per asset (2011), di cui è diventato presidente nel 2000.
Caratteristiche simili ha anche il belga Étienne visconte Davignon, nominato dal
re del Belgio ministre d’État, che è stato prima Commissario europeo agli
affari industriali e poi dirigente di importanti gruppi industriali belgi, come
Société Générale e Gdf Suez. Altra figura interessante è il già citato David
Rockefeller, una specie di trait d’union in carne ed ossa di varie
organizzazioni dell’elite statunitense e mondiale. È, infatti, uno dei fondatori
del Bilderberg e della Trilaterale ed è stato presidente tra 1970 e 1985 del
Council on Foreign Relations. Il nonno, John Davison Rockefeller, fu uno dei
protagonisti dell’espansione economica statunitense di fine Ottocento,
attraverso la fondazione della Standard Oil, grazie alla quale acquisì il
monopolio della produzione e raffinazione di petrolio e divenne l’uomo più ricco
del mondo. Il padre di David, John Davison Rockefeller Junior, fu punto di
riferimento dell’alta finanza negli anni Venti-Trenta e rimase coinvolto in
scandali per la corruzione di membri del Congresso e nel massacro di Ludlow,
durante lo sciopero dei minatori nel 1914. David Rockefeller, oggi patriarca
della famiglia, oltre ad essere stato presidente della JP Morgan Chase, ottava
banca mondiale per asset totali nel 2012, di cui è ancora il principale
azionista, ha ricoperto importanti ruoli in multinazionali di primaria
importanza, come Exxon Mobil e General Electric. Recentemente David Rockefeller
ha siglato una alleanza strategica con Lord Jacob Rothschild, patriarca
dell’altra storica dinastia della finanza internazionale. Un altro personaggio
la cui presenza nel comitato direttivo di Bilderberg è alquanto significativa è
Richard Perle, uno degli ideologi principali della corrente neoconservatrice,
che ha influenzato la politica estera Usa dell’ultimo decennio. Perle fu
assistente del ministro della Difesa sotto la presidenza Reagan e
successivamente con Bush II è stato membro e poi presidente del Defence Policy
Board. Perle è nel Bilderberg come Resident Fellow dell’American Enterprise
Institute, ma è anche membro di un altro think-tank neoconservatore, il Project
for the New American Century, formatosi nel 1997 con lo scopo di promuovere la
leadership globale americana. Nel gennaio 1998 Perle firmò, insieme ad altri
membri di questo gruppo di pressione, tra cui Donald Rumsfeld e Paul Wolfowitz,
una lettera diretta al presidente Clinton in cui si chiedeva di rimuovere con la
forza Saddam Hussein. L’obiettivo del gruppo era, come si evince da un altro
documento «mantenere nell’area del Golfo una consistente forza militare
americana», dato che il Golfo è «una regione di vitale importanza», a causa
della concentrazione di riserve petrolifere che vi si trova. Perle, insieme a
Rumsfeld e Wolfowitz che diventeranno rispettivamente ministro e vice ministro
alla Difesa con Bush II, sarà parte del gruppo dirigente statunitense che
inizierà, sull’onda emotiva dell’attacco alle torri gemelle, l’invasione
dell’Iraq e la cosiddetta “guerra al terrore”, che dura ancora oggi. Molto
interessante è anche osservare la composizione del Gruppo Bilderberg nel
passato. Cominciamo dai presidenti, che, compreso l’attuale, sono stati sette e
sempre europei occidentali, con una prevalenza britannica con tre presidenti, ai
quali si aggiungono un olandese, un belga, un tedesco e attualmente un francese.
Si tratta di personaggi di primissimo piano nella politica europea. Come abbiamo
detto il primo presidente del comitato direttivo fu il principe Bernhard van
Lippe-Biesterfeld della Casa reale olandese. Il secondo, tra 1975 e 1977, fu
Walter Scheel, già vice primo ministro e ministro degli esteri tedesco dal 1969
al 1974 e Presidente della Repubblica Federale di Germania dal 1974 al 1979. Gli
succedette tra 1977 e 1980 il duca Alexander Douglas-Home, primo ministro
britannico dal 1963 al 1964 e ministro degli esteri nel 1970. Fu poi la volta di
Eric Roll barone di Roll of Ipsden dal 1986 al 1989, che tra 1968 e 1977 è stato
uno dei direttori della Banca d’Inghilterra, e del barone Peter Carington, che
fu segretario di Stato britannico per gli affari esteri e del Commonwealth e
segretario generale della Nato dal 1984 al 1988. Infine, Etienne Davignon, di
cui abbiamo già parlato, fu presidente tra 1998 e 2011, allorché fu sostituito
da Henri de Castries tutt’ora in carica. Vi sono inoltre 135 personaggi che
hanno fatto parte dello Steering Committee nel passato e ora non ne fanno più
parte. Tra questi citiamo solo alcuni nomi prestigiosi, come Henri Kissinger,
forse il maggiore tra i segretari di Stato Usa dopo la seconda guerra mondiale e
sempre presente come invitato anche agli ultimi incontri, Edmond de Rothschild
della omonima dinastia finanziaria, l’olandese Wim Duisenberg, primo presidente
della Bce, e il già citato Paul Wolfowitz. La presenza anglosassone è sempre
preponderante, ma in modo meno forte di quanto non sia nel direttivo attuale,
con il 44,4 per cento dei membri, di cui 39 sono statunitensi (29,1 per cento),
15 britannici (11,1 per cento) e 5 canadesi (3,7 per cento). Il terzo Paese in
assoluto e primo Paese europeo, con l’esclusione della Gran Bretagna, è questa
volta sorprendentemente l’Italia che è stata presente nei vari direttivi con 11
personalità (8,1 per cento), seguita dalla Germania con 8 (5,9 per cento), e da
Francia e Danimarca con 7 (5,2 per cento). La forte presenza numerica italiana e
le personalità di spicco assoluto dei membri italiani dello Steering Committee
sta a dimostrare il consistente impegno italiano nella storia
dell’organizzazione. La composizione del gruppo italiano vede la prevalenza di
personalità provenienti dalla burocrazia economica e politica internazionale e
europea e dal mondo della grande industria. In particolare alcuni hanno svolto
un ruolo importante nella costruzione del mercato europeo e della valuta unica.
Quasi sempre si registra un intreccio tra i due ambiti, della grande industria e
della burocrazia internazionale. Inoltre, si nota anche un intreccio con la
politica nazionale, visto che 4 membri hanno ricoperto incarichi in almeno un
governo italiano, due sono stati presidenti del Consiglio, due ministri e uno
sottosegretario. È importante notare che ben 7 su undici degli italiani che
hanno fatto parte dello Steering Committee nella storia del Bilderberg sono
stati legati, seppure in modalità diverse, al gruppo Fiat. Senza contare che
anche l’attuale e unico membro italiano dello Steering, Franco Bernabè, è
passato per la Fiat, in gioventù come Chief Economist nell’ufficio
pianificazione e successivamente come membro del Cda. Ad ogni modo, dei 7
«uomini Fiat», Gianni e Umberto Agnelli appartengono alla famiglia fondatrice
che ancora controlla il gruppo. La presenza degli Agnelli e della Fiat in
organizzazioni a forte presenza Usa come il Bilderberg e la Trilaterale non deve
stupire. Essi hanno stabilito fin dall’origine con gli Usa un forte legame, che
con la recente acquisizione della Chrysler si è consolidato anche sul piano
industriale. Il capostipite della famiglia, Giovanni Agnelli, era amico di un
altro magnate statunitense dell’auto, Henry Ford. Il nipote Gianni,
l’“avvocato”, il cui bisnonno materno, George W. Campbell, fu ministro del
Tesoro Usa, era in gioventù membro del jet-set internazionale, divenendo amico
di personalità influenti come John Fitzgerald Kennedy, presidente Usa. Dal 1966
alla morte, avvenuta nel 2003, Gianni occupò la carica di presidente della Fiat.
Il fratello Umberto, già presidente dell’Ifil, la «cassaforte» di famiglia, gli
successe nel 2004 come presidente del Gruppo Fiat. L’importanza di Gianni
Agnelli nel Bilderberg è testimoniata dalle parole di un abituale frequentatore
degli incontri del gruppo: «Nelle occasioni in cui fui presente, Agnelli era in
qualche modo, così mi sembrò, la figura chiave; la figura cui gli altri facevano
riferimento e si rimettevano». Uomo Fiat fu anche Vittorio Valletta, che aderì
alla massoneria negli anni Venti e che diventò amministratore delegato della
Fiat nel 1939. Epurato nel 1944 dal Comitato nazionale di liberazione (Cnl) per
collaborazionismo con l’occupante tedesco, fu reintegrato nel suo ruolo nel 1946
divenendo anche presidente della Fiat fino al 1966. Dal mondo della burocrazia
economica e politica europea ed internazionale provengono 6 personaggi, di cui 4
hanno fatto parte del mondo Fiat. Il marchese Gian Gaspare Cittadini-Cesi fu
ambasciatore e segretario generale di quella che sarebbe diventata
l’Organization for Economic Cooperation and Development (Ocse) e amministratore
delegato di Fiat Francia. Straordinaria è la figura di Renato Ruggero, che ha
attraversato tutti gli ambiti, accumulando incarichi di vertice ai livelli
politico-burocratico nazionali e soprattutto internazionali. Fu capo gabinetto e
poi portavoce (1977) del presidente della Commissione europea e tra i
negoziatori dell’entrata dell’Italia nel Sistema monetario europeo (Sme), che
anticipò l’euro. Divenne successivamente ambasciatore italiano a Bruxelles e
segretario generale del ministro degli Esteri (massima carica della diplomazia
italiana). Dal 1987 al 1991 fu ministro degli Esteri in due governi successivi e
dal 1991 al 1995 responsabile delle relazioni internazionali del Gruppo Fiat.
Dal 1995 al 1999 fu direttore generale del Wto e poi presidente dell’Eni. Nel
2006 fu ministro degli esteri, ma solo per sei mesi dopodiché diede le
dimissioni dal governo di Silvio Berlusconi, che non sembra avere un gran
feeling con la Fiat in particolare e con i membri del Bilderberg. Tra questi c’è
sicuramente Tommaso Padoa-Schioppa, alla cui nomina come governatore della Banca
d’Italia Berlusconi si è sempre opposto. Ad ogni modo, la carriera di
Padoa-Schioppa è stata notevole. Direttore generale per l’economia e le finanze
della Commissione Europea nel periodo di lancio dello Sme (1979-1983),
vicedirettore della Banca d’Italia (1984-1987), membro del comitato istituito
dal presidente della Commissione europea Delors, suo amico personale, per
redigere il progetto di Unione monetaria europea, presidente Consob, membro del
comitato esecutivo della Bce (1998-2006), ministro dell’Economia con il Prodi II
(2006-2008), presidente del comitato monetario e finanziario internazionale
dell’Fmi, e, dulcis in fundo, membro del consiglio di amministrazione di
Fiat industrial (2010). Un altro membro autorevole del Bilderberg con cui
Berlusconi non sembra essersi sempre inteso è Mario Monti, ben noto come ex
rettore e presidente del consiglio d’amministrazione della Università Bocconi.
Meno risaputo è che anche Monti, amico personale di Gianni Agnelli, è stato un
uomo Fiat. Nel 1989, a soli 46 anni, fece tris d’assi, stando contemporaneamente
nel consiglio d’amministrazione della Fiat, della Banca Commerciale italiana e
delle Assicurazioni Generali. Successivamente Berlusconi lo mandò a Bruxelles
come commissario europeo, dove ebbe la delega al mercato interno e
all’integrazione e ai servizi finanziari. Quando D’Alema, nuovo presidente del
Consiglio, lo riconfermò, gli fu data la delega alla concorrenza che mantenne
fino al 2004. Fatto questo che non gli ha impedito di diventare successivamente
consulente antitrust della Coca-cola e di Goldman Sachs. Presidente europeo
della Commissione Trilaterale e membro del Bilderberg, se ne dimise nel momento
in cui fu nominato presidente del Consiglio dei ministri da Napolitano in
sostituzione di un Berlusconi ormai inviso a una buona fetta dell’élite italiana
e soprattutto transnazionale. Ma, forse il “calibro” più grande tra gli uomini
Bilderberg italiani, almeno tra i burocrati-politici, è un altro professore:
Romano Prodi. Presidente Iri, quando questa era una delle prime conglomerate del
mondo, Presidente della Commissione europea e due volte presidente del Consiglio
dei ministri italiano. La presenza di Prodi (e di Padoa-Schioppa) nello Steering
Committee è abbastanza significativa di quanto il Bilderberg sia capace di
mettere insieme figure conservatrici e progressiste, di centrodestra e di
centrosinistra. E probabilmente è ancora più significativo del fatto che
differenze tra le due ali dello schieramento politico non ce ne sono, o almeno
non ce ne sono di significative per quanto attiene agli interessi del network
del capitale transnazionale. L’elemento dominante è l’adesione alla prevalenza
del mercato autoregolato sull’intervento statale. Non a caso Prodi fu l’artefice
del progressivo smantellamento dell’Iri e della privatizzazione delle banche e
dell’industria di Stato, nonché di provvedimenti di liberalizzazione in molti
settori. Tuttavia, come il rapporto tra capitale finanziario e Stato muta, così
mutano anche le personalità del Bilderberg. Infatti, nello Steering Committee fu
presente anche Pasquale Saraceno, grande commis d’État italiano.
Economista di orientamento cattolico come Prodi (fu anche docente alla Cattolica
di Milano) entrò nell’Iri già durante il fascismo. Nel dopoguerra, da consulente
del ministro Vanoni, fautore dell’intervento dello Stato in economia, e di altri
ministri democristiani fu tra i sostenitori della programmazione economica e
della Cassa del Mezzogiorno, nonché il fondatore dell’Associazione per lo
sviluppo del Mezzogiorno (Svimez). Anche lui come altri del Bilderberg, inoltre,
fece il suo necessario passaggio europeo, come rappresentante italiano nella
Commissione economica per l’Europa di Bruxelles e consigliere della Banca
europea degli investimenti (Bei), l’istituzione che dal 1957 finanzia gli
investimenti per il raggiungimento degli obiettivi europei. Terminiamo la nostra
carrellata sui membri italiani del comitato direttivo del Bilderberg con gli
ultimi due personaggi, forse minori ma ugualmente significativi. Il primo è
Stefano Silvestri, che è stato sottosegretario alla Difesa tra 1995 e 1996 e,
oltre ad essere consulente di ministri della Difesa, Esteri e Industria, è
presidente dell’Istituto Affari internazionali (Iai), un think-tank italiano
impegnato sulle questioni militari e di chiaro indirizzo «atlantico». Il secondo
è Paolo Zannoni, un top manager collegato al capitale transazionale di origine
Usa ed italiana. Zannoni, di cui si dice che fossero ottime le entrature con
Gianni Agnelli, è stato presidente di Prysmian Spa, azienda italiana leader
mondiale nel settore cavi e sistemi per il trasporto di energia e
telecomunicazioni, ma controllata da Goldman Sachs (banca collegata ai
Rockefeller) con il 31,7 per cento e con la partecipazione di altre banche e
fondi di investimento Usa, come Blackrock, JP Morgan Chase, Lazard. Oggi,
Zannoni è sempre nell’orbita di Goldman Sachs, di cui è managing director, e
siede nel consiglio d’amministrazione e nel comitato risorse umane di Atlantia,
holding operante nelle infrastrutture e controllata dalla famiglia Benetton.
Gira sul web un video sul
gruppo di Bilderberg,
realizzato da Alessandro Carluccio e Francesco Amodeo (non dalle Iene come
precedentemente scritto, dell’errore ci scusiamo con gli autori) che è già
stato visto da oltre un milione e mezzo di persone, scrive “Link Sicilia”. E’ un
video che racconta in modo dettagliato e con parole semplici chi sono questi
esaltati del gruppo di Bilderberg e qual è, oggi, il loro potere nel mondo e,
soprattutto in Europa e in Italia. Il nostro giornale, già da tempo, denuncia la
presenza inquietante di questi signori del gruppo di Bilderberg. Il video,
adesso, fa giustizia e sputtana, definitivamente, l’ex presidente del Consiglio
nominato incredibilmente senatore a vita (che vergogna!), Mario Monti,
l’attuale presidente del Consiglio dei Ministro, Enrico Letta, la
Ministra degli Esteri, Emma Bonino, e l’uomo della Banca centrale
europea, già ai vertice della Banca d’Italia, Mario Draghi. Questi
quattro personaggi sono autorevoli rappresentanti del gruppo di Bilderberg. Nel
video a parlare, tra gli altri, c’è anche Daniel Estulin, l’autore di un
libro che è stato tradotto in 50 lingue e diffuso in 70 Paesi: “Il club di
Bilderberg”. Estulin, che è stato oggetto di attentati ed è sfuggito a un
rapimento, racconta la storia di questo gruppo d’ispirazione massonica (e ti
pareva!). E descrive in modo molto efficace il pericolo che questa setta
rappresenta per le libertà dei popoli. C’è anche una breve intervista con il
giudice Ferdinando Imposimato, che ha indagato a lungo sul gruppo di
Bilderberg. E che ha raccontato, nei suoi libri, le tante stragi compiute in
Italia. Secondo Imposimato, la strategia della tensione – cioè le stragi di
Stato compiute in Italia dalla fine degli anni ’60 del secolo scorso in poi per
fermare il riformismo dei Governi di centrosinistra – è da addebitare al gruppo
di Bilderberg. E, anche sulle stragi del 1992, il giudice vede l’ombra di
questo gruppo. Nel video si spiega il meccanismo, piuttosto semplice, con il
quale i signori del Bilderberg condizionano agli editori. Molte società
editoriali sono quotate in Borsa. Se non si comportano bene, gli fanno crollare
i titoli. Con questo metodo, secondo noi, nel novembre del 2011, hanno
mandato a casa il Governo di Silvio Berlusconi. Interessante l’intervista
con l’avvocato Luigi Marra, già parlamentare Europeo. Che racconta di
aver denunciato alla magistratura Mario Monti in quanto componente del gruppo di
Bilderberg. Marra spiega che il Parlamento Europeo (che, per inciso, costa agli
europei un sacco di soldi, visto che ogni europarlamentare si porta a casa, in
media, 40 mila euro al mese: una vergogna!) non conta nulla. Non promulga
nemmeno le leggi che vengono ‘gestite’, in tutto e per tutto, dalla Commissione
Europea, che è il Governo dell’Unione Europea non eletto dal popolo, ma
designato dalle massonerie finanziarie e bancarie. Di fatto, come il nostro
giornale ripete spesso, l’Unione Europea non è quella dei popoli sognata da
Altiero Spinelli e da Gaetano Martino, ma l’Europa delle banche (peraltro
fallite, visto che i ‘geni’ che le amministravano, nel 2008, hanno fatto incetta
di titoli tossici americani) e della finanza speculativa. Ed è per questo che
quest’Unione Europea, condizionata dal Bilderberg, va sbaraccata. E va
sbaraccata no non andando a votare per il Parlamento europeo, come predica
qualche idiota, ma andando a votare in massa e mandando a Strasburgo persone
disposte a lottare contro il gruppo di Bilderberg, contro le banche e contro la
finanza speculativa. Nel video si parla anche della truffa del fondo
salva-Stati. Con questo marchingegno truffaldino hanno rubato dalle tasche dei
popoli europei 700 miliardi di euro. Al contrario del nome che porta, questo è
un fondo truffa-Stati e non salva-Stati. Viene anche spiegato che cos’è il Mes,
sigla che sta per Meccanismo europeo di stabilità. Un’altra invenzione
truffaldina per spillare soldi agli Stati Europei. Il video chiarisce anche
perché, dal giorno dopo le elezioni politiche, i poteri forti del nostro Paese
non hanno fatto altro che attaccare il Movimento 5 Stelle. Questo perché questa
formazione politica si è rifiutata di sostenere il Governo di Bilderberg.
Come detto all’inizio, l’attuale Presidente del Consiglio, Enrico Letta, è un
uomo del gruppo di Bilderberg, come lo è Monti. Che cosa abbia a che vedere un
Partito che si dice di sinistra – il riferimento è al Pd – con questa gente non
è chiaro. Forse lo dovrebbero spiegare Bersani e lo stesso Letta. Fatto sta
che per essersi rifiutato di entrare a far parte di un Governo dove sono
presenti personaggi del gruppo di Bilderberg, il Movimento 5 Stelle è oggetto di
un attacco senza precedenti. Queste cose vanno spiegate bene ai milioni di
elettori di sinistra del nostro Paese che votano ancora per il Pd. Sappiano,
queste persone, che Letta, come hanno ripetuto i parlamentari grillini in
Parlamento – e come abbiamo ripetutamente scritto noi di LinkSicilia prima e
dopo che il signor Letta, sostenuto da Berlusconi, mettesse piede a Palazzo
Chigi – è un autorevole esponente del gruppo di Bilderberg. Questo spiega
l’ostracismo dei poteri forti verso il Movimento 5 Stelle di Grillo. Questo
spiega perché il leader di questa formazione politica non vuole ‘addizionarsi’
al Pd. E questo dimostra che in Italia c’è l’esigenza di dare vita a un
partito che si ispiri al socialismo vero e non al gruppo di Bilderberg.
Come si dice sempre nel video, i parlamentari nazionali del Movimento 5 Stelle
sono stati i primi che, in Parlamento, hanno parlato del gruppo di Bilderberg e
sel cosiddetto ‘Signoraggio’. Ed è per questo che i poteri forti gliela vogliono
fare pagare.
Il Bilderberg si mette a
nudo e smaschera le accuse di complotti.
Alle porte di Londra entra nel vivo la riunione del club riservato alle
personalità più influenti del mondo economico. Per la prima volta, il summit si
dota di un ufficio stampa e fa chiarezza su ospiti e agenda. Ma fuori
dall'albergo di lusso continuano le proteste e le congetture: "Vogliono farci
tornare al Medio Evo", scrive Enrico Franceschini su “La Repubblica”. "Eccolo,
eccolo". Giugno 2013. Un fremito scuote la folla e come un sol uomo tutti
puntano il dito accusatorio contro la limousine che sfreccia lungo la radura.
"Spazzatura, spazzatura, all'inferno brucerai", gli gridano contro i
dimostranti. Chi ci sia, dentro la vettura, è un mistero: ha i vetri dei
finestrini oscurati. E comunque sfreccia rapida davanti a qualche centinaio di
dimostranti, per entrare dentro i cancelli del Grove, un albergo a cinque stelle
alle porte di Watford, cittadina ai sobborghi di Londra. La scena si ripete ogni
quarto d'ora o giù di lì: di auto ne passano parecchie, per portare a
destinazione i 138 partecipanti alla riunione del Bilderberg, il club che si
riunisce ogni anno da qualche parte nel mondo, con l'obiettivo - perlomeno
secondo i suoi critici - di dominarlo. Non ho contato le macchine, per sapere
quanti sono i partecipanti all'edizione 2013, anche perché in teoria ce ne
potevano essere più di uno per auto (sulle limo il posto abbonda). E' stato più
facile arrivare al totale di 138: quest'anno, per la prima volta, il Bilderberg
ha diffuso la lista degli invitati. Comprende il ministro del Tesoro britannico
George Osborne, la sua controparte laburista (cioè il ministro del Tesoro
del governo ombra dell'opposizione) Ed Balls, l'ex-guru del blairismo
Peter Mandelson, il fondatore di Amazon Jeff Bezos, il boss di Google
Eric Schmdt, il presidente della Goldman Sachs Peter Sunderland,
l'ex-segretario di stato americano Henry Kissinger, l'ex-comandante delle
forze americane in iraq e in Afghanistan David Petraeus. Per l'Italia ci
sono l'ex-premier Mario Monti, mezza dozzina di amministratori delegati
di grandi società, la giornalista Lilli Gruber. Venerdì anche il primo
ministro britannico David Cameron ha preso parte al Bilderberg, e questo
ha perso provocato polemiche a Londra, anche perché ci è andato da solo, non
accompagnato da funzionari o portavoce. Il leader conservatore si è sempre
vantato di difendere la massima trasparenza negli affari di governo e ora
qualcuno lo può accusare di avere violato la sua promessa. Downing street si è
difesa sul punto sostenendo che è una riunione “privata” e che non fa venire
meno l’impegno di Cameron di dare pubblicità alle sue iniziative e alla sua
politica. Le novità del summit di quest'anno non si limitano però ai soli
partecipanti: il Bilderberg ha anche reso nota l'agenda della tre giorni di
discussioni: debito, occupazione, Europa, come i "big data" (la mole di
informazioni che circola sul web e viene analizzata con speciali algoritmi)
cambierà quasi tutto, la guerra civile in Siria, lo spionaggio cibernetico. E
come se non bastasse stavolta c'è anche un ufficio stampa, che non pubblicherà
alcuna risoluzione finale, perché non ve ne sono, ma appunto distribuisce le
suddette informazioni. C'è anche una specie di tribuna stampa per i giornalisti
che vogliono seguire l'evento, si fa per dire perché è a 5 chilometri di
distanza dall'albergo: ma, se è per questo, il centro stampa per il summit del
G8 (che si svolge anche quello nei prossimi giorni in Gran Bretagna) è a 30
chilometri dalle sale dove si incontreranno i grandi della terra. Come mai il
Bilderberg ha puntato sulla glasnost, dopo la totale segretezza del passato,
quando si sapeva a malapena dove si riuniva (a partire dal 1954, quando
l'incontro si tenne all'Hotel Bilderberg, in Germania - da cui il nome)? Forse
per cercare di smentire una volta per tutte l'accusa di essere il governo
occulto del pianeta, come e più della Trilateral Commission e di altri
organismi internazionali che suscitano i sospetti di legioni di innamorati della
teoria del complotto. La pubblicità un po' è servita: i giornali hanno scritto
più articoli del solito sul Bilderberg, pur senza aggiungere molta sostanza alle
discussioni, che escludono la stampa proprio perché non devono decidere niente e
vogliono dare libertà agli intervenuti di parlare fuori dalle prudenze
diplomatiche. Ma non è bastato a convincere chi vede complotti dappertutto. I
dimostranti sulla strada che conduce all'albergo Grove sono destinati a crescere
fino alla giornata di chiusura, domenica. La loro presenza è già diventata una
sorta di secondo summit, un Bilderberg Fringe, una riunione alternativa.
"Siamo qui per assalire questo gruppo di plutocrati internazionali e fare luce
sulle loro azioni, affinché brucino tra le fiamme dell'inferno", dice Alex
Jones, uno degli abituali organizzatori della contestazione. "Quelli là stanno
dettando l'agenda di tutto quello che avverrà nei prossimi 365 giorni e per
farci il lavaggio del cervello", accusa un altro, Wayne Fontana. Il
quale, nonostante la cortina di segretezza stesa dai complottatori del
Bilderberg, ha le idee piuttosto chiare sulle loro intenzioni: "Cominceranno con
la guerra contro l'Iran e finiranno con la dominazione totale sul mondo e la
riduzione del 90 per cento della popolazione. Prima cadrà l'euro, poi il
dollaro, poi ci diranno di usare solo le carte di plastica come denaro, poi ci
metteranno un chip sotto la pelle e a quel punto, se non faremo quello che ci
dicono, spegneranno il chip e ci faranno morire di fame". Viene il dubbio se
abbia letto la trama di "Inferno", il nuovo romanzo di Dan Brown, o se usi le
stesse fonti di un certo deputato grillino italiano. L'accusa più ingenua è
tuttavia quella di un altro dimostrante, un certo Simon Taylor, che
sostiene che lo scopo del Bilderberg è "mandare in bancarotta la classe media e
creare un nuovo Medio Evo, perché i tiranni odiano la classe media". Uhm, ma se
scompare la classe media e si torna al Medio Evo, a chi venderebbero i loro
prodotti i "tiranni" riuniti a porte chiuse al summit annuale del Bilderberg?
Chi comanda il Bilderberg e
il mistero del "direttivo".
Il presidente viene eletto
ogni quattro anni dal comitato esecutivo che sceglie il programma degli incontri
annuali e stila l'elenco degli invitati: nessuno, però, sa chi nomini i membri
del consiglio, scrive Giuliano Balestreri su “La Repubblica”. Il gruppo
Bilderberg è un circolo internazionale "piccolo, informale e non ufficiale nel
quale possono essere espressi punti di vista diversi e la reciproca comprensione
sviluppata". Un'associazione che riunisce, una volta all'anno, i potenti della
terra provenienti dagli ambienti della politica e della finanza che discutono,
ma non adottano risoluzioni nè votano alcun provvedimento. Di più, secondo il
sito ufficiale del gruppo Bilderberg, dal nome dell'albergo dove si riunirono
per la prima volta in Olanda nel 1954, "non vengono rilasciate dichiarazioni
politiche". Di certo, però, in questo modo si alimentano i misteri e le teorie
del complotto visto che la stampa non è ammessa e tutti gli interventi sono
rigorosamente "off the record". Negli ultimi anni sono cresciute le pressioni
perché sul gruppo Bilderberg si alzasse il velo di segretezza che lo circonda,
ma nonostante le insistenze del premier britannico, David Cameron, il
conservatore paladino della trasparenza poco, è cambiato. Neppure è servito
l'invito a partecipare ad alcuni giornalisti inglesi, dell'Economist e del
Financial Times (organi ufficiosi del gruppo, secondo alcuni), ma anche
italiani, tra cui il direttore del Corriere della Sera, Ferruccio de Bortoli,
l'ex direttore del Sole 24 Ore, Gianni Riotta, la giornalista Lilli Gruber e
Lucio Caracciolo, direttore della rivista di geopolitica, Limes. Gli invitati,
140 persone circa, e il programma delle conferenze sono decisi dal comitato
direttivo che – pur non essendo chiaro da chi sia nominato – resta in carica per
quattro anni. L'attuale presidente è Henri de Castries, numero uno del colosso
assicurativo Axa. Attualmente l'unico membro italiano del direttivo è Franco
Bernabè, presidente di Telecom Italia. Le spese organizzative sono sostenute dai
membri del consiglio direttivo del Paese ospitante: quest'anno l'incontro
inglese sarà pagato dall'ex ministro del Tesoro conservatore Kenneth Clarke
(ministro senza portafoglio nell'odierno governo Cameron), da Thomas Enders,
amministratore delegato di Eads, una delle più grandi aziende militari del
pianeta, e da Peter Sutherland, presidente della Goldman Sachs, la banca numero
uno della Terra. La sicurezza dei partecipanti, però, sarà a carico del governo
britannico.
I legami del gruppo
Bilderberg: gli intrecci tra politica e finanza.
Il circolo assomiglia a
un'oligarchia globale dove si riunisce l'élite mondiale: nobili attivi nel campo
della politica e della finanza. A cominciare dall'attuale presidente Henri de
Castries, numero uno di Axa, scrive Giuliano Balestreri su “La Repubblica”. Le
teorie del complotto, e della direzione occulta delle politiche mondiali, sono
alimentate dalla presenza nel comitato direttivo del gruppo Bilderberg di
personaggi profondamente connessi tra loro, espressione dell'élite mondiale e,
spesso, anello di congiunzione tra le grandi aristocrazie e il mondo degli
affari. Una sorta di oligarchia globale. Il presidente attuale, Herni de
Castries, numero uno del colosso francese Axa, appartiene alla nobiltà
transalpina, così come nobile era il principe Bernhard van Lippe Biesterfeld,
tra i fondatori del gruppo e marito della regina Giuliana d'Olanda. Nobili, ma
attivi nel mondo degli affari. Come Richard Perle, membro del direttivo,
ideologo dei neocon americani, membro di gabinetto del ministro della Difesa
sotto la presidenza di Ronald Reagan, consigliere di George Bush e fermo
sostenitore della guerra in Iraq, un'area di "vitale importanza per gli Usa" per
la concentrazione di petrolio. Nel 1998 scrisse un lettera a Bill Clinton per
chiedere la rimozione di Saddam Hussein, con lui la firmarono Donald Rumsfeld e
Paul Wolfowitz che diventeranno ministri di Bush. Del direttivo hanno fatto
parte anche l'ex segretario di Stato americano, Henri Kissinger, Edmond de
Rothschild e il primo presidente della Bce, Wim Duisenberg. Nel direttivo
Bildenberg si sono succeduti 12 italiani, compreso il membro attuale, il
presidente di Telecom Italia, Franco Bernabè. Ma a livello nazionale è
interessante come molti di questi uomini siano legati, direttamente o
indirettamente al mondo Fiat: lo stesso Bernabè oltre ad aver ricoperto il ruolo
di "Chief economist" del Lingotto, si è anche seduto nel Consiglio di
amministrazione.
Gli argomenti del
Bilderberg tra lotta al comunismo e armi.
I contenuti delle relazioni e
delle conferenze sono top secret, ma sul sito del gruppo vengono pubblicati i
temi affrontati: in cima alle preoccupazioni del circolo l'ex Urss e tutte le
minacce per l'Occidente. Compresa la crisi economia mondiale, continua scrive
Giuliano Balestreri su “La Repubblica”. Come detto i contenuti delle relazioni e
degli interventi è top secret. Anche di fronte alla presenza di giornalisti
tenuti a rispettare l'impegno a non divulgare le informazioni ricevute. Tuttavia
sono pubblici i temi affrontati. Anche perché si tratta – spesso – di tematiche
legate agli eventi politici e finanziari mondiali. Fin dagli albori, in cima
alle preoccupazioni del Bilderberg c'è stata l'avanzata del comunismo e quindi
come fronteggiare l'ex Urss. Tematiche che si sono evolute negli anni, prima con
l'apertura al dialogo da parte di Nikita Kruscev, poi con la caduta del Muro di
Berlino del 1989: il problema di come rapportarsi con la Russia è sempre stato
centrale. Così come i conflitti in Medio Oriente e – a ondate alterne – la crisi
di leadership degli Stati Uniti. Eventi vissuti come una minaccia per
l'Occidente. All'interno del Bilderberg si discute spesso di rapporti tra Europa
e Stati Uniti e, soprattutto, dalla metà degli anni 90 in poi, di economia:
dalla gestione della crisi economica mondiale all'euro, dall'inflazione al
protezionismo, dalla globalizzazione al petrolio. Ovviamente non mancano le
discussioni legate al mercato delle armi.
Gli italiani al vertice del
Bilderberg: dalla galassia Fiat a Letta e Tremonti.
In 12 sono entrati nel
consiglio direttivo del gruppo, molti sono stati legati al Lingotto: da Gianni e
Umberto Agnelli a Monti e Padoa Schioppa. Tra i presidente del Consiglio dei
ministri anche Romano Prodi è stato nel comitato esecutivo, conclude Giuliano
Balestreri su “La Repubblica”. Nel consiglio direttivo del gruppo Bilderberg si
sono succeduti 12 italiani. L'elemento più interessante riguarda, probabilmente,
la correlazione di molti con il mondo Fiat, a testimonianza della forza
internazionale del Lingotto. Primi fra tutti, Gianni e Umberto Agnelli, nipoti
del fondatore Giovanni e assidui frequentatori dei circoli internazionali,
soprattutto a matrice americana. Come loro, ha frequentato il Bilderberg,
Vittorio Valletta, il genovese che alla morte del fondatore gli succedette alla
guida del gruppo fino al 1966, prima di passare la mano a Gianni Angelli.
Instaurata una prassi, la tradizione è proseguita nel tempo con Franco Bernabè,
attuale presidente di Telecom Italia, ma già amministratore di Fiat e ancora
prima Chief economist del Lingotto. E ancora. Gian Gaspare Cittadini-Cesi,
marchese, diplomatico, fu amministratore delegato di Fiat Francia, carica per la
quale ottenne anche dal Quirinale l'onorificenza di Grande Ufficiale Ordine al
Merito della Repubblica Italiana. L'ambasciatore ed ex ministro degli Esteri,
Renato Ruggiero, è stato responsabile delle relazioni internazionali di Fiat,
prima di passare al Wto e diventare presidente di Eni. Un ruolo al Lingotto,
come membro del cda di Fiat Industrial, lo ha avuto anche Tomaso Padoa Schioppa,
già ministro dell'economia del governo Prodi e membro del comitato esecutivo
della Bce. Nel cda di Fiat è stato anche Mario Monti, poi commissario Ue e
consulente - tra le altre - di Coca Cola e Goldman Sachs: Monti si dimise dal
direttivo del Bilderberg dopo la nomina a presidente del Consiglio nel novembre
2011. Non era legato a Fiat l'ex premier ed ex presidente della Commissione Ue,
Romano Prodi, ma era alla guida dell'Iri quando Alfa Romeo, contesa anche
dall'americana Ford, passò, al Lingotto. Nel comitato direttivo si sono seduti
anche l'economista Pasquale Saraceno, tra i sostenitori della Cassa del
Mezzogiorno, Stefano Silvestri, ex sottosegretario alla Difesa, filo americano,
e Paolo Zannoni, ex numero uno di Prysmian, controllata, prima della quotazione
in Borsa, dalla banca d'affari Goldman Sachs. Numerosi sono anche gli italiani
invitati alle conferenze annuali: da John Elkann a Paolo Scaroni, da Mario
Draghi a Giulio Tremonti, da Alfredo Ambrosetti a Domenico Siniscalco, da
Rodolfo De Benedetti a Fulvio Conti e Corrado Passera, tutti hanno preso parte a
più di un meeting. Molti altri sono stati invitati almeno una volta, a
cominciare dal presidente del Consiglio dei ministri Enrico Letta.
Il Bilderberg Club di anime
belle?
(Sono arrivati gli spin doctor), scrive Marcello Foa su “Il Giornale”.
Dunque il Bilderberg cambia tattica: non è più un’associazione segreta o almeno
così lascia intendere. La grande novità della riunione annuale che inizia il 5 a
Londra è infatti l’apertura di un ufficio stampa e addirittura di uno spazio per
i contestatori. La sezione inglese del Bilderberg ha addirittura pubblicato in
anticipo la lista dei partecipanti e un istoriato dell’associazione, meglio nota
come il Club dei potenti del mondo. Ma si tratta di una vera svolta? Il
Bilderberg è diventato improvvisamente democratico e trasparente, ponendo fine
ai sospetti che lo circondano? Certi commentatori pensano di sì. Io sono più
cauto e penso che più che altro si è affidato agli spin doctor. Negli ultimi 2-3
anni il Bilderberg è finito sotto pressione non tanto sui media ufficiali quanto
su internet, sono stati pubblicati diversi libri di denuncia, non tutti
attendibili e documentati a dir la verità, e i manifestanti che tentavano di
rompere le asfissianti misure di sicurezza aumentavano di anno in anno. Insomma,
stava salendo un pericoloso rumore mediatico, non più confinato a pochi siti di
informazione alternativa. E allora il Club ha deciso di ricorrere allo spin
difensivo ovvero a una mossa a sorpresa che serve a depotenziare i sospetti che
ti vengono rivolti, appropriandoti delle accuse. Se l’accusa è quella di essere
cospirazionisti tu devi aprire le porte, persino ai manifestanti (in aree ben
circoscritte) e comunicare, comunicare, comunicare. O perlomeno dar
l’impressione di farlo (e infatti gli osservatori più acuti non hanno abboccato
come Charlie Skelton del Guardian). In tal modo da adesso in avanti sarà più
difficile tacciare il Bilderberg di essere un Club segreto e il fronte degli
accusatori si spaccherà. Una mossa molto abile, preparata da spin doctor
professionisti, che hanno saputo confezionare molto bene il sito, aggiungendo
spin allo spin; ad esempio invocando la trasparenza e la lotta alle lobby.
Proprio loro che sono una mega lobby! Elogiano Transaprency international
ovvero… un’organizzazione popolata da membri del Bilderberg. Tutto è stato
preparato con estrema cura, al fine di relativizzare, minimizzare, edulcorare.
Leggendo il sito del Bilderberg inglese si ha l’impressione che si tratti di un
Club animato da persone disinteressate, che hanno a cuore solo il bene
dell’umanità, quasi dei benefattori. Bravissimi i loro spin doctor, non c’è che
dire. Resta il dubbio, fondato, sulle finalità reali di questo Club e sul modo
in cui eserciti il proprio potere. Oggi si oscilla tra posizioni iperminimaliste
– che non vedono nulla di male nel fatto che banchieri, manager di grandissime
aziende, politici, banchieri centrali, grandi intellettuali si riuniscano dal
Dopoguerra e promuovano un’agenda segreta e globalista – e posizioni cosiddette
complottiste, come quelle di Estulin, che descrivono il Bilderberg come una
grande Spectre. La verità, verosimilmente, è molto più raffinata e sottile e per
questo difficile da decriptare. Probabilmente il Bilderberg è un anello di una
rete di interessi più complessa e articolata. Un anello che peraltro sembra
perdere smalto. I centri élitari davvero efficienti sono quelli che riescono a
preservare la capacità di selezione dei membri; qualità che non appare più
quella di un tempo, alla luce di alcune new entry anche italiane. Ma questo è un
altro discorso…
I massoni e la sinistra
italiana,
scrive Andrea Cinquegrani – tratto da "La Voce della Campania". Il Gruppo
Bilderberg nasce nel 1952, ma viene ufficializzato due anni più tardi, a giugno
del 1954, quando un ristretto gruppo di vip dell’epoca si riunisce all’hotel
Bilderberg di Oosterbeek, in Olanda. Da quel momento le riunioni si sono svolte
una o due volte all’anno, nel più totale riserbo. In occasione di una delle
ultime, nella splendida e appartata resort di Sintra, in Portogallo, il
settimanale locale News riportò una notizia secondo cui il Governo avrebbe
ricevuto migliaia di dollari dal Gruppo per organizzare «un servizio militare
compreso di elicotteri che si occupasse di garantire la privacy e la sicurezza
dei partecipanti». Ma torniamo agli esordi. I primi incontri si sono svolti
esclusivamente nei paesi europei, ma dall’inizio degli anni ’60 anche negli Usa.
Tra i promotori - precisano alcuni studiosi della semi sconosciuta materia -
occorre ricordare due nomi in particolare: sua maestà il principe Bernardo de
Lippe, olandese, ex ufficiale delle SS, che ha guidato il gruppo per oltre
un ventennio, fino a quando, nel 1976, è stato travolto dallo scandalo Lockheed;
e Joseph Retinger, un faccendiere polacco al centro di una fittissima
trama di rapporti con uomini che per anni hanno contato sullo scacchiere
internazionale della politica e dell’economia. «La loro ambizione - viene
descritto - era quella di costruire un’Europa Unita per arrivare a una profonda
alleanza con gli Stati Uniti e quindi dar vita a un nuovo Ordine Mondiale, dove
potenti organizzazioni sopranazionali avrebbero garantito più stabilità rispetto
ai singoli governi nazionali. Fin dalla prima riunione vennero invitati
banchieri, politici, universitari, funzionari internazionali degli Usa e
dell’Europa occidentale, per un totale di un centinaio di personaggi circa».
Ecco cosa hanno scritto alcuni giornalisti investigativi inglesi nel magazine on
line di Bbc News a pochi giorni dal meeting di Stresa. «Si tratta di una
delle associazioni più controverse dei nostri tempi, da alcuni accusata di
decidere i destini del mondo a porte chiuse. Nessuna parola di quanto viene
detto nel corso degli incontri è mai trapelata. I giornalisti non vengono
invitati e quando in qualche occasione vengono concessi alcuni minuti a qualche
reporter, c’è l’obbligo di non far cenno ad alcun nome. I luoghi d’incontro sono
tenuti segreti e il gruppo non ha un suo sito web. Secondo esperti di affari
internazionali, il gruppo Bilderberg avrebbe ispirato alcuni tra i più clamorosi
fatti degli ultimi anni, come ad esempio le azioni terroristiche di Osama bin
Laden, la strage di Oklaoma City, e perfino la guerra nella ex Jugoslavia
per far cadere Milosevic. Il più grosso problema è quello della segretezza.
Quando tante e tali personalità del mondo si riuniscono, sarebbe più che normale
avere informazioni su quanto sta succedendo». Invece, tutto top secret. Scrive
un giornalista inglese, Tony Gosling, in un giornale di Bristol: «Secondo
alcune indiscrezioni che ho raccolto, il primo luogo nel quale si è parlato di
invasione dell’Iraq da parte degli Usa, ben prima che ciò accadesse, è stato nel
meeting 2002 dei Bilderberg». Di parere opposto un redattore del Financial
Times, Martin Wolf, più volte invitato ai meeting: «L’idea che questi
incontri non possano essere coperti dalla privacy è fondamentalmente
totalitaria; non si tratta di un organismo esecutivo, nessuna decisione viene
presa lì». Fa eco uno dei fondatori, anche lui inglese, lord Denis Healey:
«Non c’è assolutamente niente sotto. E’ solo un posto per la discussione, non
abbiamo mai cercato di raggiungere un consenso sui grandi temi. E’ il migliore
gruppo internazionale che io abbia mai frequentato. Il livello confidenziale,
senza alcun clamore all’esterno, consente alle persone di parlare in modo
chiaro». Ed ecco cosa scrive un altro studioso di ordini paralleli e di gruppi e
associazioni che agiscono sotto traccia, Giorgio Bongiovanni. «Bilderberg
rappresenta uno dei più potenti gruppi di facciata degli Illuminati (una sorta
di super Cupola mondiale, ndr). Malgrado le apparenti buone intenzioni, il vero
obiettivo è stato quello di formare un’altra organizzazione di facciata che
potesse attivamente contribuire al disegno degli Illuminati: la costituzione di
un Nuovo Ordine Mondiale e di un Governo Mondiale entro il 2012. Sembra che le
decisioni più importanti a livello politico, sociale, economico-finanziario per
il mondo occidentale vengano in qualche modo ratificate dai Bilderberg». «Il
Gruppo - scrive ancora Bongiovanni - recluta politici, ministri, finanzieri,
presidenti di multinazionali, magnate dell’informazione, reali, professori
universitari, uomini di vari campi che con le loro decisioni possono influenzare
il mondo. Tutti i membri aderiscono alle idee precedenti, ma non tutti sono al
corrente della profonda verità ideologica di alcuni membri principali». I veri
‘conducator’- secondo questa analisi - i quali a loro volta fanno anche parte di
altri segmenti strategici nell’organigramma degli Illuminati. Due in
particolare: la Trilateral e la Commission of Foreign Relationship,
nata nel 1921, la quale riunisce a sua volta tutti i personaggi che hanno fra le
loro mani le leve del comando negli Usa. «Questi membri particolari - prosegue
Bongiovanni - sono i più potenti e fanno parte di quello che viene definito il
‘cerchio interiore’. Quello ‘esteriore’, invece, è l’insieme degli uomini della
finanza, della politica, e altro, che sono sedotti dalle idee di instaurare un
governo mondiale che regolerà tutto a livello politico e economico: insomma, le
‘marionette’ utilizzate dal cerchio interiore perché i loro membri sanno che non
possono cambiare il mondo da soli e hanno bisogno di collaboratori motivati e
mossi anche dal desiderio di danaro e potere». Passiamo, per finire, alla
Trilateral, vero e proprio luogo cult del Potere nascosto, in grado comunque di
condizionare i destini del mondo. Ovviamente ‘sponsorizzato’ della star
dell’imprenditoria multinazionale, come Coca Cola, Ibm, Pan American, Hewlett
Packard, Fiat, Sony, Toyota, Mobil, Exxon, Dunlop, Texas Instruments, Mutsubishi,
per citare solo le più importanti. L’associazione nasce nel 1973, sotto la
presidenza “democratica” di Jimmy Carter e del suo consigliere speciale
per la sicurezza, Zbigniew Brzezinsky, il vero deux ex machina. A
ispirare il progetto, le famiglie Rothschield e Rockfeller, i Paperoni
d’America. Un progetto che ha irresistibilmente attratto i potenti del mondo, a
cominciare proprio dai presidenti Usa, con un Bill Clinton in prima fila.
Così descriveva Giovanni Agnelli la Trilateral: «Un gruppo di privati
cittadini, studiosi, imprenditori, politici, sindacalisti delle tre aree del
mondo industrializzato (Usa, Europa e Giappone, ndr) che si riuniscono per
studiare e proporre soluzioni equilibrate a problemi di scottante attualità
internazionale e di comune interesse». Il solito ritornello. Di diverso avviso
il giornalista Richard Falk, che già nel 1978 - quindi a pochissimi anni
dalla nascita - scrive sulle colonne della Monthly Review di New York:
«Le idee della Commissione Trilaterale possono essere sintetizzate come
l’orientamento ideologico che incarna il punto di vista sopranazionale delle
società multinazionali, che cercano di subordinare le politiche territoriali a
fini economici non territoriali». E’ la filosofia delle grandi corporation, che
stanno privatizzando le risorse di tutto il pianeta, a cominciare dai beni
primari, come ad esempio l’acqua: non solo riescono a ricavare profitti
stratosferici ma anche ad esercitare un controllo politico su tutti i Sud - e
non solo - del mondo. La logica della globalizzazione. E i bracci operativi di
questo turbocapitalismo sono proprio due strutture che dovrebbero invece
garantire il contrario: ovvero la Banca Mondiale e il Fondo Monetario
Internazionale. «Entrambi - scrive uno studioso, Mario Di Giovanni -
sotto lo stretto controllo del “Sistema” liberal della costa orientale
americana. Agiscono a tutto campo nell’emisfero meridionale del pianeta,
impegnate nella conduzione e ‘assistenza’ economica ai paesi in via di
sviluppo». E proprio sull’acqua, la Banca Mondiale sta dando il meglio di sé:
con la sua collegata IFC (Internazionale Finance Corporation) infatti sta
mettendo le mani sulla gran parte delle privatizzazioni dei sistemi idrici di
mezzo mondo, soprattutto quello africano e asiatico, condizionando la
concessione dei fondi all’accettazione della privatizzazione, parziale o più
spesso totale, del servizio. Del resto, è la stessa Banca a calcolare il
business in almeno 1000 miliardi di dollari… Scrive ancora Di Giovanni: «Le
decisioni assunte dai vertici della Trilateral riguarderanno sempre di più
quanti uomini far morire, attraverso l’eutanasia o gli aborti, e quanti farne
vivere, attraverso un’oculata distribuzione delle risorse alimentari. Decisioni
che riguarderanno l’ingegneria genetica, per intervenire nella nuova ‘umanità’.
In una parola, tutto ciò che definitivamente distrugga il ‘vecchio’ ordine
sociale, cristiano, per la creazione di un nuovo ordine. Ma tutto questo senza
particolari scossoni. Non vi sarà bisogno di dittature, visto che le democrazie
laiche e progressiste, condotte da governi di “centrosinistra”, servono già così
efficacemente allo scopo. Governi che riproducono - conclude - una formula già
sperimentata lungo l’intero corso del ventesimo secolo e plasticamente
rappresentata dal passato governo Prodi-D’Alema: l’alleanza fra la borghesia
massonica e la sinistra, rivoluzionaria o meno».
Che autogol, Concita:
scrive di complotti ma svela quelli dei suoi amici.
Su Repubblica racconta che per
governare in Italia bisogna essere graditi ai poteri forti. Ma tutti i nomi che
fa, da Amato a Prodi, sono suoi pupilli, scrive Francesco Borgonovo su “Libero
Quotidiano”. Una mattina Concita De Gregorio, destandosi da sogni
inquieti, si trovò mutata in una complottista. Ieri, su Repubblica, è
apparsa un’articolessa di due pagine a sua firma, con notevole richiamo in
prima, dal titolo: «Da Lockheed a Bilderberg quegli amici americani che “votano”
per il Colle». Obiettivo del pezzo: spiegare l’influenza di Washington sugli
affari italici, a partire dalla scelta della persona da spedire al Quirinale.
Intrigante. Nell’articolo, la nostra Signorina Grande Firma preferita scomoda il
meglio del meglio della dietrologia internazionale, dal succitato Bilderberg
alla Trilateral, passando per Gladio, Goldman Sachs e il golpe
Borghese. Concita, che è successo? Hai scoperto i libri di Maurizio Blondet? Ti
sei invaghita di Adam Kadmon, quello che a Mistero su Italia Uno dà la colpa di
ogni catastrofe agli Illuminati? A pensar male, si direbbe che la biondocrinita
giornalista si appresti a rubare il posto a Roberto Giacobbo: «E adesso, una
bella inchiesta su come gli alieni hanno costruito le piramidi, dalla nostra
inviata spaziale Concita De Gregorio!». Per adesso, tuttavia, ci accontentiamo
di leggere le dietrologie sugli oscuri signori che dominano il pianeta, di cui
fino alla scorsa settimana la nostra cronista doveva essere ignara. Concita ci
spiega per esempio che il Club Bilderberg è una «associazione di finanzieri,
banchieri, politici e uomini di Stato fondata nel ’54», i cui membri «si
riuniscono ogni anno in un conclave a porte chiuse». Dovete sapere, infatti, che
«ai grandi gruppi economico-politici internazionali, alla finanza e dunque alla
politica nordamericana interessa molto e moltissimo chi governa, chi comanda,
chi ha influenza in Europa e in subordine in Italia». Posto che ci
meraviglieremmo del contrario, ci gustiamo l’enfatica prosa con cui la De
Gregorio spiega che «l’ombra dell’America è verde come il colore dei dollari.
Tuona come le armi che varcano l’oceano in perpetuo e spesso illecito
commercio». Non solo: l’ombra maligna degli Usa «parla la lingua dei banchieri,
la sola lingua degli affari. Si affaccia sull’Italia dalla postazione
mediterranea di Israele». Ah, già, mancava il complottone
pluto-giudaico-massonico. Insomma, il succo del discorso è che esistono delle
élite potentissime che ambiscono a governare per lo meno l’Occidente in nome
del profitto. E quindi non si fanno scrupolo a muovere le fila della politica
globale, compresa quella italiana. Motivo per cui, se uno vuol comandare qui da
noi, deve essere in qualche modo gradito a tali Signori Oscuri. Per svelare la
scomoda verità, Concita interpella persino Paolo Cirino Pomicino, il quale
confessa: «Senza le credenziali degli americani e in specie delle grandi banche
d’affari oggi nessuno può pensare di aspirare seriamente al Quirinale». Ora, se
stupisce l’improvvisa trasformazione dell’inviata di punta e soprattutto di
tacco di Repubblica in una Dan Brown in gonnella, sorprende ancora di più
l’elenco dei nomi contenuto nel suo articolo. Già, perché una volta detto che
Bilderberg, Trilateral e Aspen Insitute manovrano i nostri destini, bisogna
anche dire chi sono i loro emissari. Eccoli qua. Al Bilderberg sono passati, tra
gli altri, Monti, Draghi, Padoa Schioppa, Siniscalco, Prodi. «Ogni tanto
qualche giornalista (Lilli Gruber, per dire, ndr) una volta Veltroni, Emma
Bonino». Nell’entourage della potentissima banca d’affari Goldman Sachs sono
transitati Prodi, Draghi, Monti, Gianni Letta. Massimo D’Alema, invece, ha avuto
un «rapporto che sarebbe durato nel tempo» con Clinton, mentre Prodi «voleva
essere ricevuto subito, ma non si poteva». Quanto all’Aspen, «in Italia conta su
Amato, Prodi e D’Alema». La Trilateral «fondata da Rockefeller (...) Monti l’ha
presieduta fino al 2011. La frequentano la consulente per la politica estera di
D’Alema Marta Dassù (...), Enrico Letta...». Apprendiamo qualcosa pure su
Scalfaro. Con lui al Colle, «c’è il ciclone Mani Pulite» che dà «spazio a una
generazione nuova. Più avvezza all’uso di mondo, alle relazioni internazionali,
alla lingua degli uomini d’affari. È dal denaro, adesso, dalla finanza che
passano gli interessi politici. (...) È ai banchieri che si ricorre quando la
politica tace o sobbolle di sue interne diatribe». Riepiloghiamo: Monti,
Scalfaro, D’Alema, Veltroni, Letta jr, Prodi, Amato... Scusate, eh, ma non sono
personaggi che Repubblica ha supportato per anni e ancora sostiene? Non sono
prodotti di quella sinistra di salotto che il quotidiano di Mauro ha contribuito
a creare? E adesso Concita ci viene a dire che sono manovrati dagli americani
per fare gli interessi della finanza? Incredibile. Fortuna che è già prevista
una nuova puntata dell’inchiesta della De Gregorio. In onda a Voyager: ai
confini dell’ignoto. Rimanete collegati. Sera.
Gruppo Bilderberg. Nomi e
cognomi di tutti i partecipanti dal 1954 al 2012.
In quale girone dell’inferno
dantesco andranno a finire queste anime prave? Si chiede Matteo Vitiello.
Guardate, sinceramente, penso che per questa feccia italiana sia addirittura
troppo lusinghiero andare ad occupare un posto nella magnificenza dell’opera
letteraria per antonomasia. Ipocriti, falsari, traditori e violenti. I politici:
non dicono la verità ai cittadini italiani e, nonostante il loro dovere di
uomini politici sarebbe quello di rappresentare e servire il popolo, lo
ingannano. Banchieri: creano e sperperano il denaro per dominare e controllare.
Imprenditori violenti: Finmeccanica, Fiat, Pirelli, Olivetti, Ferruzzi, Alenia,
Selex, Fincantieri, Confindustria… sono tra i primi dieci nella scala mondiale
di produttori d’armi! …e poi si comportano da puritani, protetti dal Vaticano…
che poi non è nient’altro che la patria dei più falsi di tutti, i preti (se ne
salvano alcuni). Di seguito trovate tutti i partecipanti della nostra nobile
Italia alle diverse riunione di Gruppo Bilderberg, dal 1954 al 2011. Ricordate
che il Gruppo Bilderberg non è la riunione più importante dei potenti ma è dove
i “ranghi” più bassi (capi azienda, politici nazionali ed internazionali di
turno, giornalisti corrotti) ricevono istruzioni dai padroni della
finanza mondiale: cosa fare, che politiche attuare, cosa far credere alla gente
e così via. Ne discutono un poco e ne aggiustano i dettagli, quindi,
occhio, non crediate che tutti i bildebergers siano gente particolarmente
importante al mondo, proprio perché il loro potere decisionale è quasi nullo
rispetto ai loro capi (ne parlo dettagliatamente negli altri articoli dedicati
al Bilderberg). Vi ricordo i punti fondamentali che contraddistinguono gli
obiettivi a lungo termine del Bilderberg. Vi aiuterà a capire il perché di tanta
segretezza e di tante bugie da parte di banchieri, imprenditori, politici e
giornalisti corrotti.
1. Un’identità
internazionale: distruggere l’identità nazionale ed il concetto di
Stato-Nazione, cioè depauperare la sovranità di ogni singolo Stato (come sta
accadendo sotto i nostri occhi in Europa, ad esempio ndr), per creare un’unica
“grande impresa”, un unico governo mondiale fondato sul denaro ed il
mantenimento di uno status di “padrone-schiavi”
2. Un
controllo centralizzato della popolazione
3. Una
società a crescita zero
4. Uno
stato di disequilibrio perpetuo
5. Un controllo
centralizzato dell’educazione: qui rientra non solo la rilettura della
storia da parte dei diretti interessati ma anche la fondamentale funzione di
lavatrice del cervello svolta dalla televisione, dai giornali e da tutti i mezzi
di comunicazione principali (un mezzo di comunicazione principale è una tv, un
giornale, una radio a grande diffusione. Questa diffusione è ottenuta solo dai
mezzi di comunicazione i cui direttori/presidenti decidono di non pubblicare
notizie scomode ai potenti. Internet è, attualmente, un’eccezione, comunque è
controllato anch’esso… qualcosa ce lo lasciano scrivere per darci una sorta di
valvola di sfogo).
6. Un
controllo centralizzato di tutte le politiche nazionali ed internazionali
7. La
concessione di un maggior potere alle Nazioni Unite
8. Un
blocco commerciale occidentale
9. L’espansione
della NATO e la creazione di un unico esercito in modo tale che la catena di
comando risponda solo ad una cerchia ristrettissima di persone
10. Un
sistema giuridico unico
11. Uno stato di
benessere socialista.
1954 Oosterbeek, Olanda
Alcide De Gasperi
Raffaele Cafiero (senatore)
Giovanni Malagodi
(parlamentare)
Alberto Pirelli (Amm.
delegato Pirelli)
Pietro Quaroni
(Ambasciatore italiano in Francia)
Paolo Rossi (parlamentare)
Vittorio Valletta
(Presidente Fiat)
1955
Barbizon, Francia e Garmisch-Partenkirchen, Germania Ovest - irreperibile
1956
Fredensborg, Danimarca – irreperibile
1957 St
Simons Island, Georgia, USA
Amintore Fanfani (Ministro
Esteri)
Longo Imbriani (BNL)
Giovanni Malagodi
(Presidente Senato)
1958 – Palace Hotel,
Buxton, Inghilterra
Giovanni Agnelli
Guido Carli (Direttore
Banca d’Italia)
Giovanni Malagodi
(presidente del Senato)
Alberto Pirelli (Presidente
Gruppo Pirelli)
Pietro Quaroni (Presidente
RAI)
1963 – Cannes, Francia
Alighiero De Micheli
(Presidente Confindustria)
Aurelio Peccei (Direttore
Generale Italconsult)
Mario Pedini (parlamentare)
Alberto Pirelli (Presidente
Gruppo Pirelli)
Pietro Quaroni
(Ambasciatore in Gran Bretagna)
Vittorino Chiusano (nobile,
nipote del vescovo Paolo Maurizio Caissotti di Chiusano, membro consiglio
amministrazione Juventus)
1964 – Williamsburg,
Virginia, USA
Giovanni
Agnelli
Ugo La Malfa (parlamentare)
Ettore Lolli (Manager BNL)
Franco Malfatti
(Sottosegretario Ministro dell’Industria e del Commercio)
Aurelio Peccei (Direttore
Generale Italconsult)
Giovanni Scaglia
(parlamentare Democrazioa Cristiana)
Paolo Vittorelli (senatore)
Vittorino Chiusano (nobile,
vedi 1963)
1965 – Villa D’Este,
Lago di Como
Giovanni
Agnelli (FIAT)
Manlio Brosio (Segretario
Generale NATO)
Guido Carli (Direttore
Banca d’Italia)
Eugenio Cefis
(parlamentare)
Ugo La Malfa (parlamentare)
Giovanni Malagodi
(parlamentare)
Mario Pedini (parlamentare
e membro P2)
Giuseppe Petrilli
(Presidente IRI)
Leopoldo Pirelli (Gruppo
Pirelli)
Mariano Rumor
(parlamentare)
Paolo Vittorelli (senatore)
Gian Gasperi Cesi Cittadini
(marchese e politico)
Vittorino Chiusano (nobile,
vedi 1963)
1966 – Wiessbaden,
Germania
Giovanni Agnelli
Piero Bassetti (politico e
imprenditore azienda Bassetti)
Manlio Brosio (Segretario
Generale NATO)
Franco Malfatti
(parlamentare e giornalista)
Mario Pedini (parlamentare
e membro P2)
Vittorino Chiusano (nobile,
vedi 1963)
1967 – Cambridge,
Inghilterra
Giovanni
Agnelli
Manlio Brosio (NATO)
Principe Guido Colonna di
Paliano (commissario europeo, diplomatico NATO)
Mario Aggradi Ferrari
(parlamentare, ministro, membro Democrazia Cristiana)
Aurelio Peccei (manager
FIAT e OLIVETTI, membro fondatore del Club di Roma)
Leopoldo Pirelli (Gruppo
Pirelli)
Paolo Vittorelli (senatore)
Vittorino Chiusano (nobile,
vedi 1963)
1968 – Mont Tremblant,
Canada
Giovanni
Agnelli
Roberto Olivetti (Gruppo
Olivetti)
Aurelio Peccei (manager
FIAT, Olivetti, Club di Roma)
Leopoldo Pirelli (Gruppo
Pirelli)
Alberto Ronchey (ministro,
scrittore e giornalista Corriere della Sera)
Altiero Spinelli (Club del
Coccodrillo, commissario europeo, scrittore e politico)
Ugo Stille (giornalista
Corriere della Sera)
1969 – Marienlyst,
Danimarca
Giovanni Agnelli
Antonio Cariglia (senatore)
Fabio Luca Cavazza
(editore, scrittore, giornalista)
Piero Ottone (giornalista
Corriere della Sera)
Lorenzo Vallarino Gancia
(imprenditore Gruppo Asti-Gancia)
Gian Gasperi Cesi Cittadini
(marchese e politico)
1970 – Bad Ragaz,
Svizzera
Giovanni Agnelli
Renato Altissimo
(parlamentare)
Gilberto Bernardini (fisco
e docente fisica nucleare Università di Bologna)
Arrigo Levi (giornalista
Corriere Della Sera, RAI)
Gian Gasperi Cesi Cittadini
(marchese e politico)
1971 – Woodstock,
Vermont, USA
Gian Gasperi Cesi Cittadini
(marchese e politico)
Emanuele Gazzo
(giornalista, fondatore Agenzia Europa)
Giuseppe Glisenti
(Direttore Rai, cofondatore Democrazia Cristiana)
Gian Giacomo Migone
(docente universitario, NATO, ONU)
Piero Ottone (giornalista
Corriere della Sera)
Gianfranco Piazzesi
(giornalista Corriere della Sera)
1972 – Knokke, Belgio
Giovanni Agnelli
Gian Gasperi Cesi Cittadini
(marchese e politico)
Umberto Colombo (scienziato
italiano)
Principe Guido Colonna di
Paliano (commissario europeo, diplomatico, NATO)
Roberto Ducci
(ambasciatore, consigliere NATO)
Arrigo Levi (giornalista
Corriere della Sera, RAI)
1973 – Saltsjöbaden,
Svezia
Giovanni Agnelli
Gian Gasperi Cesi Cittadini
(marchese e politico)
Roberto Ducci
(ambasciatore, consigliere NATO)
Raffaele Girotti (manager
Montedison, ENI, senatore Democrazia Cristiana)
Siro Lombardini
(economista)
Cesare Merlini (Presidente
Istituto Affari Internazionali)
Ugo Stille (giornalista
Corriere della Sera)
1974 – Hotel Mont
D’Arbois, Megévè, Francia
Giovanni Agnelli
Enzo Bettiza (senatore,
giornalista Corriere della Sera, cofondatore de Il Giornale)
Gian Gasperi Cesi Cittadini
(marchese e politico)
Principe Guido Colonna di
Paliano (commissario europeo, diplomatico, NATO)
Roberto Ducci
(ambasciatore, consigliere NATO)
Giorgio La Malfa
(parlamentare)
Arrigo Levi (giornalista
Corriere della Sera, RAI)
Franco Maria Malfatti
(senatore)
Alberto Rochey (giornalista
Corriere Della Sera, scrittore)
1975 – Golden Dolphin
Hotel, Cesme, Turchia
Giovanni Agnelli
Gian Gasperi Cesi Cittadini
(marchese e politico)
Guido Carli (politico e
Presidente Confindustria)
Roberto Ducci
(ambasciatore, consigliere NATO)
Francesco Forte (docente
universitario, parlamentare)
Giorgio La Malfa
(parlamentare)
Arrigo Levi (giornalista
Corriere Della Sera, RAI)
1977 – Torquay,
Inghilterra
Giovanni Agnelli
Tina Anselmi (politica,
partigiana e Presidente della Commissione d’inchiesta sulla loggia massonica P2)
Gian Gasperi Cesi Cittadini
(marchese e politico)
Guido Carli (politico,
Presidente Confindustria)
Roberto Ducci
(ambasciatore, consigliere NATO)
Marcella Glisenti
(scrittrice)
Carlo Sartori (pittore)
Francesco Cossiga
1978 – Princeton, New
Jersey, USA
Giovanni
Agnelli
Nino Andreatta
Gian Gasperi Cesi Cittadini
Roberto Ducci
(ambasciatore, consigliere NATO)
Piero Ottone (giornalista
Corriere Della Sera)
Paolo Savona (economista,
docente universitario)
Stefano Silvestri
(sottosegretario Affari Europei, consulente Difesa)
1979 – Baden, Austria
Giovanni Agnelli
Vittorio Barattieri
(Direttore generale Ministero Industria)
Gian Gasperi Cesi Cittadini
Stefano Silvestri
(sottosegretario Affari Europei, consulente della Difesa)
Nicola Tufarelli (FIAT)
1980 – Aachen, Germania
Luigi
Barzini (scrittore)
Giorgio Benvenuto
(sindacalista, segretario generale UIL)
Marchese Gian Gasperi Cesi
Cittadini
Luigi Ferri (giurista)
Romano Prodi
Stefano Silvestri
(sottosegretario Affari Europei, consulente della Difesa)
Barbara Spinelli
(giornalista, cofondatrice Repubblica)
1981 – Burgenstock,
Svizzera
Giovanni
Agnelli
Romano Prodi
Stefano Silvestri
1982 – Sandefjord,
Norvegia
Piero Ostellino
(giornalista Corriere della Sera)
Romano Prodi
Virginio Rognoni (Ministro
Affari Interni)
Stefano Silvestri
1983 – Montebello,
Quebec, Canada
Umberto Agnelli
Piero Bassetti (Bassetti
Spa)
Mario Monti
Paolo Zannoni
1984 – Saltsjobaden,
Svezia
Giovanni Agnelli
Mario Monti
1985 – Rye
Brook, New York, USA
Giovanni Agnelli
Umberto Cappuzzo (Generale
Esercito Italiano)
Mario Monti
Guido Rossi (giurista e
avvocato)
Giovanni Sartori (Docente
Columbia University)
Paolo Zannoni (FIAT)
1986 – Gleneages,
Scozia, Regno Unito
Giovanni Agnelli
Antonio Maccanico
(politico, segretario generale Ufficio Presidenza Repubblica Italiana)
Mario Monti
Tommaso Padoa-Schioppa
(Direttore Banca d’Italia)
Renato Ruggiero (Segretario
Ministero Affari Esteri)
Gaetano Scardocchia
(editore, La Stampa)
Luigi Spaventa (docente
economia Università La Sapienza)
Paolo Zannoni (FIAT)
Alfredo Ambrosetti
(Presidente Studio Ambrosetti)
1987 – Villa D’Este,
Cernobbio, Lago di Como, Italia
Giovanni Agnelli
Luigi Caligaris (senatore)
Guido Carli (senatore)
Carlo Azelio Ciampi
Francesco Cingano
(Direttore Banca Commerciale Italiana)
Raul Gardini (Direttore
generale Ferruzzi Spa)
Mario Monti
Romano Prodi
Franco Reviglio (Direttore
ENI)
Cesare Romiti (FIAT)
Renato Ruggiero (Segretario
Ministero Affari Esteri)
Gaetano Scardocchia
(editore, La Stampa)
Paolo Zannoni (FIAT USA)
Alfredo Ambrosetti
Alessandro Vanzetto (FIAT)
1988 – Telfs-Buchen,
Austria
Giovanni Agnelli
Giorgio La Malfa
Mario Monti
Ugo Stille (Capo Editore
Corriere della Sera)
Paolo Zannoni
1989 – La Toja, Spagna
Giovanni Agnelli
Enrico Braggiotti (Banca
Commerciale Italiana)
Raul Gardini (Ferruzzi Spa)
Mario Monti
Filippo Maria Pandolfi
(politico Democrazia Cristiana, vice presidente Commissione Comunità Europea)
Paolo Zannoni
1990 – Glen Cove, New
York, USA
Giovanni Agnelli
Enrico Braggiotti (Banca
Commerciale Italiana)
Raul Gardini (Ferruzzi Spa)
Mario Monti
Romano Prodi
Renato Ruggiero (Ministro
Commercio Estero)
Paolo Zannoni
1991 – Baden Baden,
Germania
Giovanni Agnelli
Giampiero Cantoni
(Direttore Banca Nazionale del Lavoro)
Gianni De Michelis
(Ministro Affari Esteri)
Mario Monti
Renato Ruggiero (politico e
diplomatico)
1992 – Evian-les-Bains,
Francia
Giovanni Agnelli
Mario Monti
Sergio Romano (La Stampa)
Renato Ruggiero
Paolo Zannoni
1993 – Atene, Grecia
Giovanni Agnelli
Mario Monti
Renato Ruggiero
Barbara Spinelli
Marco Tronchetti Provera
(Pirelli Spa)
1994 – Helsinki,
Finlandia
Giovanni Agnelli
Umberto Agnelli
Alfredo Ambrosetti (Gruppo
Ambrosetti)
Franco Bernabè (Telecom,
ENI, banchiere e vicepresidente Rothschild Europa)
Innocenzo Cipolletta
(Direttore Confindustria)
Mario Draghi
Mario Monti
Renato Ruggiero
1995 – Zurigo, Svizzera
Giovanni Agnelli
Umberto Agnelli
Mario Draghi
Renato Ruggiero
1996 – Toronto, Canada
Giovanni Agnelli
Franco Bernabè
Mario Monti
Valter Veltroni
1997 - Lake Lanier,
Georgia, USA
Giovanni Agnelli
Umberto Agnelli
Carlo Rossella (La Stampa)
Stefano Silvestri
1998 –
Turnberry, Ayrshire, Scozia
Giovanni Agnell
Franco Bernabè
Luigi Cavalchini
Rainer Masera (Direttore
Gruppo SanPaolo IMI)
Tommaso Padoa-Schioppa
Domenico Siniscalco
Enrico Mattei
1999 – Sintra,
Portogallo
Agnelli Umberto
Franco Bernabè
Francesco Giavazzi
(Università Bocconi)
Paolo Fresco (FIAT)
Alessandro Profumo
(Unicredit)
2000 –
Genval, Bruxelles, Belgio
Giovanni Agnelli
Umberto Agnelli
Alfredo Ambrosetti
Franco Bernabè
Paolo Fresco
Gianni Riotta (La Stampa)
Renato Ruggiero (Schroder
Salomon Smith Barney Italia)
Giulio Tremonti
2001 – Stenungsund,
Svezia
Franco Bernabè
Mario Draghi
Gian Maria Gros-Pietro
(FIAT, Atlantia, Seat, Edison)
Mario Monti
Gianni Riotta
2002 – Chantilly
(Virginia), USA
Mario Draghi
Mario Monti
2003 – Versailles,
Parigi, Francia
Alfredo Ambrosetti
Rodolfo De Bendetti (CIR)
Franco Bernabè
Mario Draghi
Mario Monti
Marco Panara (La Republica)
Corrado Passera (Banca
Intesa BCI)
Roberto Poli (ENI)
Paolo Scaroni (Enel)
2004 – Stresa, Italia
Alfredo Ambrosetti
Rodolfo De Benedetti
Franco Bernabè
Ferruccio De Bortoli (RCS
Libri)
Lucio Caracciolo (Direttore
rivista italiana di geopolitica Limes)
Mario Draghi
Gabriele Galateri
(Mediobanca)
Francesco Giavazzi (docente
Bocconi)
Cesare Merlini
Mario Monti
Corrado Passera (Banca
Intesa Spa)
Gianni Riotta (Corriere
della Sera)
Paolo Scaroni (Enel)
Domenico Siniscalo
Giulio Tremonti
Marco Tronchetti Provera
Ignazio Visco (Banca
d’Italia)
2005 – Rottach-Egern,
Germania
Franco Bernabè
John Elkann
Mario Monti
Tommaso Padoa-Schioppa
Paolo Scaroni
Domenico Siniscalo
2006 – Ottawa, Canada
Franco Barnabè
John Elkann
Mario Monti
Tommaso Padoa-Schioppa
Paolo Scaroni
Giulio Tremonti
2007 – Istanbul, Turchia
Franco Bernabè
John Elkann
Mario Monti
Tommaso Padoa-Schioppa
Paolo Scaroni Paolo
Domenico Siniscalco
Giulio Tremonti
2008 Chantilly,
Virginia, USA
Franco Bernabè
Mario Draghi
John Elkann
Mario Monti
Tommaso Padoa-Schioppa
2009 – Atene, Grecia
Franco Bernabè
Mario Draghi
John Elkann
Mario Monti
Tommaso Padoa-Schioppa,
Minister of Finance, President “Notre Europe”
Romano Prodi
Domenico Siniscalco
2010 – Sitges, Spagna
Franco Bernabè Franco, CEO,
Telecom Italia s.p.a
Fulvio Conti Fulvio (ENI)
John Elkann John
Mario Monti
Tommaso Padoa-Schioppa
Gianfelice Rocca (Gruppo
Techint, Confindustria)
Paolo Scaroni
2011 – Sant Moritz,
Svizzera
Franco Bernabè
John Elkann
Mario Monti
Paolo Scaroni
Giulio Tremonti Giulio
2012 - Chantilly,
Virginia, USA
Franco Bernabè
Fulvio Conti (CEO and
General Manager, Enel S.p.A)
John Elkann
Lilli Gruber
Enrico Letta
[fonte: Bilderberg Meeting
Report]
LA COSTITUZIONE ITALIANA
VOLUTA DAI MASSONI.
Costituzione, Diritto al
Lavoro e Sistema Massonico.
Rapporti tra costituzione
italiana e massoneria, secondo Paolo Franceschetti.
Sommario. 1. Premessa. 2. La
prima falla: gli organi costituzionali. 3. La seconda falla. Il sistema dei
referendum. 4. La terza falla: la Corte Costituzionale. 5. La quarta falla: i
valori massonici della costituzione. 6. Il cosiddetto "diritto al lavoro". 7.
L'effettivo stato di cose. 8. Effetti della normativa a tutela dei lavoratori.
9. Considerazioni conclusive e di diritto comparato.
1. Premessa.
La nostra Costituzione è
considerata dalla maggior parte dei costituzionalisti come una legge molto
avanzata, fortemente protettiva delle classi deboli e con un bilanciamento quasi
perfetto tra i vari poteri. Rappresenta la legge fondamentale per la tutela dei
diritti di qualunque cittadino, nonché il parametro di legittimità cui
rapportare tutte le altre leggi. All’università questa era l’idea che mi ero
fatta sui vari autori, Mortati, Martinez, Barile. Solo da qualche anno ho
cominciato a riflettere sul fatto che qualcosa non va nel modo in cui tutti ci
presentano la Carta Costituzionale. Vediamo cosa. In effetti la storia (quella
vera e non quella ufficiale) ci insegna che la Carta Costituzionale fu voluta
dalla massoneria. Oltre due terzi dei padri costituenti erano ufficialmente
massoni (e sospetto anche quelli che non lo erano ufficialmente). E la
massoneria rivendica a sé altre leggi importanti, come la dichiarazione dei
diritto dell’Uomo. Dato che il fine ultimo della massoneria è il nuovo ordine
mondiale, riesce difficile pensare che abbiano voluto consegnare ai cittadini,
al popolo cioè, una legge che tutelasse davvero tutti, e che non fosse invece
funzionale agli interessi massonici. Infatti, leggendo la Costituzione senza
preconcetti, e sgombrando il campo da tutte le sciocchezze che ci insegnano
all’università, è possibile farsi un’idea diversa della Costituzione. Essa è una
legge illiberale, pensata apposta per opprimere i cittadini anzichè tutelarli.
Però il punto è che è scritta così bene che è difficile capirne l’inganno.
Apparentemente infatti sembra una legge progredita e che tutela i diritti di
tutti. Ma la realtà è ben altra. E’ noto infatti che nessuno è così schiavo come
quelli che pensano di essere liberi senza sapere di essere schiavi. Ora, la
Costituzione è fatta apposta per questo: renderci schiavi, facendoci credere di
essere liberi. Purtroppo per capirlo occorre essere molto esperti di diritto, e
contemporaneamente conoscere anche la politica, la cronaca, l'economia, ecc.;
una cosa impossibile finchè si è giovani, e quindi una preparazione
universitaria non è sufficiente per individuare dove stanno le immense falle di
questa legge – burla. Bisogna inoltre avere alcune conoscenze del sistema
massonico. I laureati in legge quindi escono dall’università senza avere la
minima conoscenza del sistema reale, ma avendo a malapena mandato a memoria i
pochi libri che hanno letto per gli esami universitari. Vediamo dove stanno
queste falle, iniziando dalle meno importanti. Per finire poi occupandoci della
presa in giro più evidente, che non a caso è proprio quella contenuta
nell’articolo 1 della costituzione.
2. La prima falla. Gli
organi costituzionali.
Anzitutto nella costituzione
sono previste efficaci garanzie per tutti i poteri dello stato meno uno. Sono
previste garanzie per il governo, parlamento, la Corte Costituzionale, la
magistratura, ma non per i servizi segreti che, come abbiamo spiegato in un
articolo precedente, sono l’organo dello stato più potente e il più pericoloso.
Quindi i servizi segreti possono agire fuori da coperture costituzionali. Ciò ha
una duplice valenza a mio parere, una giuridica e una psicologica. Dal punto di
vista giuridico infatti questa mancanza consente ai servizi di operare
nell’illegalità. Dal punto di vista psicologico, invece, tale omissione fa
sembrare i servizi segreti quasi una sorta di organo secondario che svolge ruoli
di secondo piano per il funzionamento della Repubblica; si dà al lettore, allo
studioso di legge, e all’operatore del diritto in genere, l’impressione che essi
non siano in fondo così importanti; allo stesso tempo ci si assicura che nessuno
studente approfondirà mai la figura dei servizi dal punto di vista giuridico,
cosicchè ogni laureato esce dall’università con un’idea solo immaginaria e
fantastica di questo organo dello stato, quasi come fosse inesistente, da
relegare nelle letture romanzesche dell’estate o dei film di James Bond, e non
uno dei poteri più importanti del nostro stato, con un numero di dipendenti da
far impressione a una qualsiasi altra amministrazione pubblica.
3. La seconda falla. Il
sistema dei referendum.
Un'altra mancanza gravissima è
quella del referendum propositivo. Il referendum, che è un istituto
importantissimo per la sovranità popolare, può solo abrogare leggi esistenti, ma
non proporle. Il che, tradotto in parole povere significa che se con un
referendum è stata abrogata una legge, il parlamento può riproporla tale e
quale, oppure con poche varianti, solo per prendere in giro i cittadini a
fingere di adeguarsi alla volontà popolare. Una presa in giro bella e buona.
4. La terza falla: la Corte
costituzionale.
Un’altra immensa presa in giro
è il funzionamento della Corte Costituzionale. Tale organo dovrebbe garantire
che le leggi siano conformi alla Costituzione, annullando le leggi ingiuste.
Il problema è che il cittadino non può ricorrere direttamente contro le leggi
ingiuste. E questo potere non ce l’hanno neanche i partiti o le associazioni di
categoria. Per poter arrivare ad una dichiarazione di incostituzionalità di una
legge infatti è previsto un complesso sistema per cui bisogna dapprima che sia
instaurato un processo (civile o penale); dopodiché occorre fare una richiesta
al giudice che presiede il processo in questione (che non è detto che la
accolga). In gergo tecnico questo sistema si chiama “giudizio di rilevanza
costituzionale effettuato dal giudice a quo”; in gergo atecnico e popolare
potremmo definirlo “sistema per paralizzare la giustizia costituzionale”. Ne
consegue che è impossibile impugnare le leggi più ingiuste, per due motivi:
1) o perché per qualche motivo
giuridico non è possibile materialmente instaurare il processo (ad esempio: non
è possibile impugnare le leggi che prevedono gli stipendi e le pensioni dei
parlamentari; non è possibile impugnare le leggi elettorali; non è possibile
impugnare le leggi con cui la Banca d’Italia è stata di fatto privatizzata);
2) o perché – anche quando le
legge è teoricamente impugnabile - il cittadino non ha nessuna voglia di
instaurare un processo per poi andare davanti alla Corte Costituzionale. Ad
esempio; ipotizziamo che un cittadino voglia impugnare l’assurda legge che
prevede che ogni professionista debba versare allo stato il 99 per cento del
reddito dell’anno futuro, per incassi ancora non percepiti; in tal caso bisogna
dapprima rifiutarsi di pagare (quindi commettere un illecito); poi occorre
aspettare di ricevere la cartella esattoriale da parte dell’agenzia delle
entrate con le relative multe e sovrattasse; e solo dopo queste due mosse si poi
impugnare la cartella, peraltro senza nessuna certezza di vincere la causa. Se
invece si volesse impugnare l’assurda legge sul falso in bilancio prevista dagli
articoli 2621 e ss. Cc. (legge chiaramente incostituzionale perché rende di
fatto non punibile questo reato, con la conseguenza che chi ruba una mela in un
supermercato rischia diversi anni di galera, mentre chi ruba qualche milione di
euro da una grande azienda non rischia quasi nulla), la cosa diventa
praticamente impossibile, perché prima commettere il reato, poi occorre
aspettare di essere processati per quel reato, e che in tale processo colui che
impugna sia parte in causa. Una follia!
A tutto ciò occorre aggiungere
i rilevanti costi di un giudizio davanti alla Corte, tali da scoraggiare
qualunque cittadino con un reddito medio. La conseguenza è che la Corte
Costituzionale si occupa in genere della costituzionalità delle leggi più
stupide, ma i cittadini sono impotenti di fronte ai fatti più gravi. E il
risultato finale è che la Corte Costituzionale sostanzialmente ha le mani
completamente legate contro le leggi più ingiuste e più gravemente lesive dei
diritti del cittadino.
5. La quarta falla: i
valori massonici introdotti dalla Costituzione.
Ci sono poi altre lacune molto
gravi come quella relativa alla possibilità per lo stato di espropriare beni dei
cittadini senza corrispondere il valore di mercato. Ma l’aspetto più grave della
nostra Costituzione, e allo stesso tempo anche quello più difficile da
percepire, è relativa ai valori tutelati dalla Costituzione. Ci raccontano
sempre che la Costituzione tutela la persona umana. Ma è falso, perché in realtà
a ben guardare essa mortifica la persona umana relegandola a poco più che uno
schiavo. Vediamo perché.
6. Il cosiddetto diritto al
lavoro.
Il perché è in realtà sotto
gli occhi di tutti, messo in modo plateale, bene evidenziato già nell’articolo 1
della Costituzione, ove è detto che: “la repubblica italiana è fondata sul
lavoro”. Nessuno si sofferma mai a riflettere sull’assurdità logica, giuridica,
e filosofica, di questa norma. Cosa significa che una repubblica è fondata sul
lavoro? Nulla. Giuridicamente una repubblica si fonda su tante cose. Sulla
legalità. Sulla giustizia. Sull’equilibrio dei diritti. Sul rispetto delle
leggi. Sull’equilibrio tra poteri dello stato. Ma non si fonda, né dovrebbe
fondarsi, sul lavoro. Non a caso credo che il nostro sia l’unico caso al mondo
di una Costituzione che abbia messo il lavoro all’articolo 1, tra i fondamenti
della Repubblica. Non a caso neanche repubbliche dittatoriali come la Cina o la
Russia contengono una disposizione tanto demenziale. L’idea di uno stato fondato
sul lavoro è infatti una sciocchezza per vari motivi. Prima di tutto perché ciò
presuppone che il giorno che venga trovato un modo per far avere a tutti,
gratuitamente, cibo e un tetto, e la gente fosse dispensata dal lavorare, lo
stato dovrebbe crollare. Il che ovviamente è giuridicamente un non senso. Quindi
il primo dei presupposti errati di questa norma è proprio quello giuridico. In
secondo luogo perché se la repubblica fosse fondata sul lavoro, ne deriverebbe
che i soggetti peggiori della società sarebbero i preti, i monaci e le suore di
clausura, il Papa, il Dalai Lama, gli asceti, coloro che vivono di rendita, chi
si dedica solo al volontariato, i politici (la maggior parte dei quali non ha
mai lavorato in vita sua) ecc. L’articolo 1 della nostra Costituzione si apre
insomma con un concetto assurdo, ma straordinariamente nessuno ne ha rilevato il
non senso. Anzi, autori come Mortati (il costituzionalista più famoso) hanno
addirittura plaudito a questo articolo. La nostra Costituzione poi prosegue con
altri articoli dedicati al lavoro, e tutti inevitabilmente basati su presupposti
teorici sbagliati. Il lavoro infatti è considerato un diritto. Ma riflettendoci
bene, il lavoro non è un diritto. Il lavoro è – o dovrebbe essere - una libera
scelta per esplicare la propria personalità. Il lavoro è un dovere per coloro
che non hanno abbastanza denaro per vivere. Il lavoro è poi una scelta di vita,
in quanto dovrebbe essere l’espressione della personalità del soggetto. Chi ama
dipingere vivrà di pittura; chi ama la giustizia cercherà di fare il giudice o
l’avvocato; chi ama i soldi cercherà di lavorare in banca e così via. Ma ben
possono esserci scelte alternative altrettanto nobili. Basti ricordare che le
più grandi religioni del mondo si basano sulla figura dei loro fondatori, che
non erano certamente lavoratori e che i primi discepoli di queste persone tutto
erano tranne che lavoratori. Cristo non era un lavoratore e i anche i discepoli
non erano tali ; o meglio, lo erano proprio finchè non hanno incontrato Cristo.
La stessa cosa vale per Budda e i suoi discepoli che erano dei mendicanti, e
tutt’oggi i monaci buddisti vivono sempre di carità. Una persona che accudisce i
propri figli e fa vita solo casalinga non fa una scelta meno nobile di un
dipendente delle poste, o di un funzionario di banca, o di un magistrato o un
avvocato (che spesso passa la vita a dirimere questioni condominiali e cause
assicurative, cioè occupandosi di cose infinitamente meno nobili dell’educazione
di un figlio). Ricordiamo poi che la maggior parte dei politici non ha mai
lavorato in vita sua. D’Alema e Bertinotti, che difendono i diritti dei
lavoratori, non hanno mai lavorato né hanno mai creato veramente lavoro (al di
fuori di quello delle cooperative rosse che serviva e serve per mantenere i
partiti di sinistra). Quindi il concetto del lavoro come diritto, e come
fondamento della Repubblica, non sta in piedi né filosoficamente né
giuridicamente, né dal punto di vista logico. E’ una delle balle giuridiche più
colossali che ci abbiano mai raccontato. A questo punto occorre capire perché al
lavoro è stata data un’importanza così grande, introducendo nella Costituzione
dei concetti falsi e che non hanno alcune attinenza con la realtà.
7. L’effettivo stato di
cose.
Il reale significato delle
norme sul lavoro previste dalla nostra Costituzione possono essere capite se si
conosce il meccanismo effettivo con cui il nostro sistema massonico funziona. Il
sistema massonico funziona, effettivamente sul lavoro. Il lavoro è infatti il
grosso problema della società attuale. Se voi chiedete a qualcuno qual è la più
grande preoccupazione oggi, in Europa, vi diranno: il lavoro. Non c’è lavoro.
Cosa promette un politico in cambio di voti? Un lavoro. Perché la mafia al sud è
tenuta in considerazione più dello stato? Perché dà lavoro. Perché la maggior
parte delle persone, oggi, è spinta ad entrare in massoneria? Per cercare lavoro
o per aumentare quello che ha. Se non ti allinei alle direttive del sistema qual
è la punizione più immediata che subisci? La perdita del lavoro. Perché un
magistrato copre un omicidio, un poliziotto non indaga, un dipendente pubblico
commette una scorrettezza, un giornalista non pubblica una notizia importante?
Perché altrimenti perdono il lavoro. Perché si danno le mazzette per avere gli
appalti? Perché altrimenti l’appalto non ti viene assegnato (ovverosia non hai
lavoro). Perché la maggior parte della gente non sa cosa è il signoraggio, cosa
sono le scie chimiche, cos’è la massoneria? Perché la TV non informa su questo,
per informarsi da soli ci vuole troppo tempo, e la gente non ha tempo perché
“deve lavorare”. In altre parole, il lavoro, con i suoi perversi meccanismi per
il suo mantenimento, è lo strumento che viene usato dai poteri occulti e dalla
politica per poter piegare i cittadini. In tal senso, allora, l’articolo 1 è
perfettamente coerente col sistema attuale e allora acquista un senso. La
repubblica (massonica) si fonda sul lavoro. In altre parole l’articolo 1
dovrebbe più correttamente essere letto in questo modo: L’Italia è una
repubblica massonica, fondata sul lavoro, e il potere massonico, per mantenersi,
ha bisogno di gente che sgobbi 12 ore al giorno senza mai alzare la testa per
pensare, altrimenti capirebbe l’inganno in cui la teniamo”.
8. Effetti della normativa
a tutela dei lavoratori.
A questo stato di cose si sono
aggiunte le leggi che proteggono il lavoratore a scapito del datore di lavoro.
Queste leggi sono l’attuazione dell’articolo 4 della Costituzione, che dice
espressamente che “la repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che favoriscono il loro diritto”. Il risultato
delle leggi che hanno promosso la condizioni che favoriscono i diritti dei
lavoratori è sotto gli occhi di tutti: l’impossibilità per il lavoratore di
licenziare in tronco il lavoratore sgradito (anche se ha rubato, se è un
nullafacente, ecc.), nonché la nostra demenziale politica fiscale, che ci fa
pagare tasse anche per l’aria che respiriamo, hanno prodotto lavoro in nero,
stipendi ridicoli, e lo sfruttamento sistematico di intere categorie di
lavoratori da parte dei datori di lavoro. Questa normativa ha raggiunto il
risultato esattamente contrario a quello programmato dall’articolo 4; infatti
danneggia il lavoratore, perché distorce il rapporto di forza tra lavoratori e
datori di lavoro. Mi spiego. Il rapporto di lavoro dovrebbe essere basato sulla
parità delle parti. Io lavoratore ho bisogno di lavorare per vivere; ma anche
tu, datore di lavoro, hai bisogno del lavoratore altrimenti la tua azienda non
funziona. Il sistema di leggi che riguardano il mondo del lavoro invece,
tassando dissennatamente gli imprenditori, facendo mancare il lavoro ovunque
grazie alla crisi, e impedendo il licenziamento arbitrario, ha prodotto come
risultato un sistema in cui la gente va a mendicare il lavoro da datori di
lavoro che il più delle volte lo concedono come se fosse un favore; favore di
cui i lavoratori devono ringraziare, spesso facendosi umiliare pur di non
perdere il lavoro, subendo ricatti sessuali e non, ecc. La corruzione nei
concorsi pubblici, volta a selezionare non i migliori, ma i più corrotti e i più
raccomandati in tutti i settori della vita pubblica, nella magistratura, in
polizia, negli enti pubblici, ecc., ha portato come ulteriore conseguenza una
classe di lavoratori demotivata; la maggior parte di essi infatti non hanno
scelto il lavoro in base alle loro capacità, ma in base ai posti che ha reso
disponibile il sistema. Il risultato di questa politica del lavoro durata nei
decenni è la perdita di dignità di tutte le categorie di lavoratori, anche di
quelle dirigenziali. Ovverosia:
- la maggior parte dei
lavoratori fa lavori che non sono adatti a loro;
- la maggior parte dei
lavoratori accetta di essere sottopagata;
- la maggior parte dei
lavoratori pur di lavorare accetta anche umiliazioni e trattamenti disumani;
- spesso si sente dire “non ho
lavoro, quindi non ho dignità”; i valori massonici del lavoro infatti hanno
instillato nella gente l’idea che un disoccupato non abbia dignità: a ciò
contribuisce anche il demenziale detto, accettato da tutti, che “il lavoro
nobilita l’uomo”, brocardo che non so chi l’abbia inventato, ma certamente
doveva essere un imbecille;
- poliziotti, carabinieri,
magistrati, fanno il loro lavoro non per missione di vita, come dovrebbe essere,
ma dando la prevalenza allo stipendio, ai problemi di mobilità, di avanzamento
di carriera, ecc.
- i datori di lavoro sono
costretti dalla dissennata legislazione italiana ad assumere lavoratori in nero,
sottopagarli, ecc.
- Nella massa delle persone si
instillano concetti distorti; ad esempio non è raro sentir lodare una persona
con la frase “è un gran lavoratore, lavora tutti i giorni anche dodici ore al
giorno” come se questo fosse un pregio. E ci si dimentica che chi lavora dodici
ore al giorno non ha tempo per i figli, per riflettere, per evolvere. Anche
Pacciani, infatti, per dare di sé un’immagine positiva, al processo sul mostro
di Firenze disse che era “un gran lavoratore”. Tutto questo sistema fa si che il
cittadino sia un docile e remissivo strumento del sistema in cui viviamo, ove la
frusta è stata sostituita dallo spauracchio della perdita del lavoro.
9. Considerazioni
conclusive e di diritto comparato.
In conclusione, la nostra
Costituzione è organizzata e strutturata in modo molto abile, per favorire
l’illegalità e l’ingiustizia, grazie ai suoi principi e alle sue lacune,
difficilmente riscontrabili ad una prima lettura. Tra i vari partiti politici e
i costituzionalisti, non mi risulta che nessuno abbia mai rilevato questo stato
di cose, ad eccezione della Lega Nord, che nel 1993 aveva fatto una proposta di
modifica dell’articolo 1 per cambiarlo in: L’Italia è una repubblica democratica
basata sul mercato e sulla solidarietà. Ovviamente la proposta è stata
contestata dalla sinistra. Perché si sa. La sinistra è a favore di lavoratori. E
infatti il risultato della politica di sinistra si è visto nei pochi anni in cui
abbiamo avuto governi di questo colore. Uno sfascio se possibile anche peggiore
di quello di destra, perché in effetti il più acerrimo nemico dei lavoratori, in
questi decenni, non è stata la destra, ma la sinistra. In compenso, anche la
costituzione del Sudafrica è più progredita della nostra, ove il diritto al
lavoro non compare, ma compaiono invece la tutela della dignità umana e compare
il diritto dei datori di lavoro. In altre parole l’Italia è seconda anche a
stati che, culturalmente, in teoria dovrebbero essere più arretrati di noi.
L’articolo 1 della Costituzione del Sudafrica (all. 4), molto più avanti del
nostro, recita: La costituzione del Sudafrica provvederà all’istituzione di uno
Stato sovrano, di una comune cittadinanza sudafricana e di un sistema di governo
democratico, mirante a realizzare l’uguaglianza tra uomini e donne e fra genti
di tutte le razze. Tra gli stati europei, invece, sarebbe sufficiente citare il
caso della Spagna. La Spagna ha in gran parte mutuato dal nostro sistema i
principi giuridici più importanti. Tuttavia, non a caso, l’articolo 1 della
Costituzione spagnola non fa cenno al lavoro e dichiara di fondarsi – molto più
intelligentemente di noi – su libertà, giustizia e uguaglianza. Infatti, mi
disse un professore universitario di Lima, che aveva la docenza anche in Spagna,
un certo Juan Espinoza Espinoza: in Spagna nessuno si prostituisce per avere un
semplice posto da portiere o da cameriere, come da voi. Da voi occorre essere
raccomandati anche per avere un lavoro a termine per sei mesi alle poste. Non a
caso da loro il lavoro è collocato all’articolo 35, che dice il contrario di
quanto dice la nostra Costituzione: tutti i lavoratori spagnoli hanno il dovere
di lavorare e il diritto alla libera scelta di una professione o di un mestiere.
E non a caso nel campo di concentramento di Auscwitz compariva una scritta
all’entrata: arbeit macht frei. Il lavoro rende liberi. Più o meno lo stesso
concetto contenuto nell’articolo 1 della nostra Costituzione.
FRATELLI D’ITALIA? MASSONI ITALIANI.
L’inno di Mameli? Non è l’inno della
Repubblica italiana, ma quello dei massoni!, scrive
Ignazio Coppola su "I Nuovi Vespri". Questo inno massonico ha anticipato e
accompagnato la ‘conquista’ del Sud da parte di quei ‘briganti’ dei Savoia. I
massoni si schierarono con i piemontesi per massacrare le popolazioni del
Mezzogiorno che si ribellavano alle angherie e alle prepotenze di Vittorio
Emanuele e dei suoi sgherri. Una ribellione contro un invasore volgare e
ignorante che gli storici prezzolati hanno definito “lotta al brigantaggio”. In
realtà, i “briganti”, come già detto, erano i Savoia e i massoni che li
spalleggiavano! Vi siete mai chiesti perché il nostro inno nazionale inizia con
la parola “fratelli”? E, su questo vi siete mai data una risposta? A tal
proposito vale bene ricordare che l’inno di Mameli non è mai stato l’inno
ufficiale della Repubblica italiana, bensì un inno ufficioso o, per meglio dire
“precario” come, del resto, lo è la maggior parte di tutto ciò che avviene in
questo nostro Paese. A ben vedere, per quanto infatti diremo, il “precario” e
ufficioso inno di Mameli si può definire a buon diritto l’inno che la massoneria
impose alle nascente Repubblica italiana nel lontano 1946 in sostituzione della
“marcia reale” che aveva caratterizzato il precedente periodo monarco-fascista.
“Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta”: queste infatti sono le prime parole
dell’inno di Mameli. Un inno, come si intuisce, di chiara connotazione
massonica, musicato da Michele Novaro e scritto nell’autunno del 1847 dal
“fratello” Goffredo Mameli (al quale, a riprova della sua appartenenza e
devozione ai liberi muratori, sarà poi dedicata a futura memoria una loggia)
che, non a caso e da buon “framassone”, lo fa iniziare con la sintomatica e
significativa parola “Fratelli”. Un inno scritto dal “fratello” Goffredo Mameli
nel 1848 e riproposto un secolo dopo, il 12 ottobre 1946, da un altro
“fratello”, il ministro delle guerra dell’allora governo De Gasperi, il
repubblicano Cipriano Facchinetti, da sempre ai vertice della massoneria, con la
carica di Primo sorvegliante nel Consiglio dell’Ordine del Grande Oriente
d’Italia e affiliato alla loggia “Eugenio Chiesa”. Fu in quella data
dell’ottobre del 1946 che Facchinetti, quale ministro della guerra, impose che
l’inno fosse suonato in occasione del giuramento delle Forze Armate. E da quel
momento “Fratelli d’Italia” divenne, come lo è tuttora, l’inno ufficioso della
Repubblica italiana. Ufficioso e provvisorio, perché mai istituzionalizzato con
alcun decreto e ancor di più, perché non contemplato dalla nostra Carta
costituzionale come lo è sancita, dall’articolo 12 della stessa Costituzione,
l’istituzione del tricolore come bandiera nazionale. Un inno che rimane,
pertanto, per le cose dette, ancora ad oggi, privo di ogni ruolo e di ogni
qualsivoglia definizione istituzionale. Da quanto argomentato si può altresì
facilmente desumere che l’inno degli italiani fu un inno, nella sua lunga
gestazione, fortemente voluto dai massoni che tanta parte, come abbiamo visto,
ebbero e continuano, ancora oggi, ad avere nelle vicende che portarono alla mal
digerita unità d’Italia. Fu immediatamente dopo l’unità d’Italia che il Sud si
“destò” e si accorse, sulla propria pelle e a proprie spese, di che pasta erano
fatti i “fratelli” che erano venuti a “liberarlo”. Non passò molto tempo,
infatti, che siciliani e meridionali si resero conto che i
garibaldo-italo-piemontesi non erano affatto i liberatori sperati, ma spietati
conquistatori. E che di conquista e di colonizzazione, e non di liberazione del
Sud e della Sicilia si trattò, ne è testimonianza quanto avvenne nella seduta
parlamentare del 29 maggio 1861, a Palazzo Carignano, quando, ai deputati e ai
giornali del Nord, che si ostinavano, avendone la piena convinzione, a sostenere
di avere conquistato la Sicilia e il Mezzogiorno, si opponeva il siciliano on.
Giuseppe Bruno deputato di Nicosia, il quale, in pieno Parlamento così si ergeva
a protestare: “Si è detto, in alcuni giornali e qui si è ripetuta l’espressione
di province meridionali ‘conquistate’ e siccome questa è un’espressione
offensiva, non solo, ma ingiusta, permettetemi che come testimonio oculare la
respinga risolutamente. Ciò posto, prego gli onorevoli colleghi a non volere
ripetere la frase di ‘conquista’ riguardo nostro e conto che dopo queste parole
e le spiegazioni da me date sui fatti di Sicilia accetteranno essi senza offesa
la mia protesta”. I piemontesi della protesta dell’on Bruno non ne tennero alcun
conto se, negli anni successivi, essendo ben convinti di essere conquistatori e
non liberatori, perpetreranno nei confronti delle genti del Sud eccidi e
massacri inenarrabili. Del resto, che di conquista, a tutti gli effetti, si
trattò ce ne dà ampia e documentata testimonianza anche Antonio Gramsci nel suo
autorevole saggio sul Risorgimento. Con la spedizione dei Mille, infatti, ebbe
inizio il lungo processo di conquista e di scientifica colonizzazione del Sud e
della Sicilia e la “radunata rivoluzionaria”, come ebbe a definirla lo stesso
Gramsci, fu resa possibile dal fatto che Garibaldi s’innestava nella forze
statali piemontesi e che la flotta inglese protesse di fatto lo sbarco di
Marsala e la presa di Palermo e sterilizzò la flotta borbonica. Gramsci, di
fatto, nella sua lucida analisi non faceva altro che evidenziare come la
“gloriosa “spedizione non fu altro che una grande mistificazione storica. E fu
con questa radunata rivoluzionaria, che Gramsci chiama “rivoluzione passiva” o,
meglio ancora, “rivoluzione-restaurazione”, che trionfò la logica gattopardiana
che tutto avvenne perché nulla cambiasse. Anzi, per cambiare in peggio. Una
rivoluzione-restaurazione che fa dire allo scrittore e uomo politico sardo che,
nel suo contesto, il popolo ebbe un ruolo molto marginale, anzi subalterno, così
che il risorgimento si caratterizzò, con tutte le sue ineluttabili e deleterie
conseguenze, come “conquista regia” e non come movimento popolare, perché
appunto mancava al popolo una coscienza nazionale. E in questo vuoto di
coscienza nazionale e nella estraneità del popolo al moto unitario fu così
possibile ai moderati cavouriani dirigere il processo di unificazione, regolarlo
ai propri fini e ai propri interessi, in chiave antimeridionale e a tutela degli
interessi del Nord con la creazione di un nuovo Stato che di questi fini e di
questi interessi ne fu portatore. Con la “rivoluzione-restaurazione”, il
Piemonte assume una funzione di “dominio” e non di dirigenza reale e democratica
di un processo di rinnovamento che in effetti non ci fu. Si passò, nelle regioni
meridionali, dall’assolutismo paternalistico borbonico al costituzionalismo
repressivo piemontese. “Dittatura senza egemonia”, opportunamente la definisce
ancora Gramsci, che fece pagare al Sud – e alla Sicilia in particolare – sotto
tutti i punti di vista, soprattutto in termini economici e repressivi, il prezzo
più alto. Del resto, di recente anche di “risorgimento senza popolo”, sulla
stessa lunghezza d’onda di Gramsci, parla nel suo interessante saggio Storia e
politica Risorgimento- Fascismo e Comunismo il giornalista, scrittore e
saggista Paolo Mieli, il quale nel capitolo dedicato al risorgimento, frutto di
approfondite ricerche storiche (Ernesto Ragionieri, Gabriele Turi, Fulvio
Camarrano, Giorgio Candeloro e altri) perviene alla conclusione di un
risorgimento realizzato da una “ èlite”, in cui il popolo non fu per niente
protagonista e, proprio perché èlite, riuscì a creare un’area di consenso
popolare assai ristretta o quasi nulla. “Dal 1861 – sostiene Mieli – dunque, il
popolo, anziché essere una riserva di consenso, costituì un problema per le
èlite che fecero l’Italia, con conseguenze drammatiche nella definizione dei
modi di fare e di intendere la politica”. Mieli, in premessa, prende in esame in
particolare l’arco di tempo che va dalla fine del Settecento, all’inizio
dell’Ottocento e dai movimenti popolari che li caratterizzarono (sanfedismo e
insorgenze) sino all’Unità d’Italia. Arco di tempo in cui vennero poste le basi
del risorgimento. Ebbene, saltano fuori alcuni “temi scomodi” delle nostra
storia patria che la agiografia ufficiale e i testi scolastici hanno sempre
occultato. Ossia, a differenza di quanto avvenne nelle rivolte Sanfediste e
delle Insorgenze, in cui il popolo fu protagonista attivo di quelle lotte e di
quelle rivolte, nel risorgimento, al contrario, registriamo la quasi totale
assenza di un consenso popolare e di partecipazione attiva alla sua
realizzazione. Insomma che il popolo non fu mai un soggetto protagonista, ma in
alcuni casi avverso alle lotte e agli ideali del risorgimento è acclarato da
avvenimenti incontrovertibili e documentati per quanto diremo, in questo
contesto, riferibili a Carlo Pisacane e a Ippolito Nievo. Carlo Pisacane
fortemente impregnato da una ideologia socialisteggiante e libertaria in cui
collega l’idea d’indipendenza nazionale alle aspirazioni di riscatto sociale e
politico delle masse contadine e per questo propugnatore di un “socialismo
utopistico” e libertario, alla fine si troverà, nel giugno del 1857, appena
sbarcato a Sapri, assalito e massacrato da quegli stessi contadini e popolani
per cui voleva fare la sua personale rivoluzione. E proprio nel suo Saggio sulla
rivoluzione, distinguendosi e prendendo le distanze da Garibaldi e dagli altri
nei giudizi su casa Savoia, tra l’altro così scriveva: “La dominazione della
Casa Savoia e la dominazione della Casa d’Austria sono precisamente la stessa
cosa” e poi ancora “che il regime costituzionale del Piemonte è più nocivo
all’Italia di quello che lo sia la tirannia del Borbone”. In seguito i fatti gli
daranno ampiamente ragione. Un uomo giusto e di grandi ideali che si trovò a
operare nel posto e in un contesto sbagliato. Appena sbarcato a Sapri, Pisacane
e i suoi 300 compagni, buona parte ex detenuti fatti evadere dall’isola di
Ponza, furono affrontati, circondati e massacrati, con circa un centinaio di
morti, compreso Pisacane, non come era prevedibile dalle guardie regie, ma dai
contadini e dalla stessa popolazione locale. Dell’assenza del popolo nelle lotte
risorgimentali e nella stessa spedizione dei Mille, dopo lo sbarco di Marsala
avvenuto tra l’indifferenza generale della popolazione, ce ne dà altrettanta
buona testimonianza quanto Ippolito Nievo scrive, il 24 giugno del 1860, alla
cugina Bice con la quale intrattiene una intensa corrispondenza, a proposito
della conquista di Palermo: “Ti giuro Bice… dentro pareva una città di morti,
non altra rivoluzione che, sul tardi, qualche scampanio. E noi soli, ottocento
al più sparsi in uno spazio grande quanto Milano, occupati, senz’ordine e senza
direzione, alla conquista di una città. Noi correvamo per vicoli e piazze in
cerca dei napoletani per farli sloggiare e dei palermitani per far fare loro la
rivoluzione. Riuscimmo mediocremente più nell’una che nell’altra cosa. In fin
dei conti Palermo rimase nostra di noi soli come si direbbe a Milano”. Anche
qui, secondo quanto riportato da Nievo nella lettera alla cugina, il popolo,
come in tanti altri avvenimenti e circostanze, brillò per la sua assenza. Ma
ancor di più, immediatamente dopo l’unità d’Italia, un consenso e una
partecipazione popolare attiva si ebbero addirittura, soprattutto, nel
Mezzogiorno dalla parte opposta a quella del risorgimento che culminò in una
sanguinosa guerra civile con le lotte contadine e di liberazione dall’invasione
italo-piemontese, contrabbandata, da sempre dalla storiografia ufficiale, come
lotta al brigantaggio. Partigiani e contadini poveri che si batterono per la
loro libertà, per le loro terre e per il loro diritto all’esistenza che fece
dire, come poi scrisse testualmente Antonio Gramsci su Ordine Nuovo: “Lo Stato
italiano è stato una dittatura feroce che ha messo a ferro e a fuoco l’Italia
meridionale e le isole, squartando, fucilando e seppellendo vivi i contadini
poveri che scrittori salariati tentarono di infamare con il marchio di
briganti”. Questi dunque, anche a parere di Gramsci e di tanti altri scrittori e
saggisti che di recente – come Mieli – si pongono l’obiettivo di una serena e
imparziale revisione storica, in buona sostanza, i vizi d’origine e le cause di
debolezza del nuovo stato italiano e di una mal digerita e mai metabolizzata
Unità. Vizi d’origine e debolezze che meritano oggi, più che costose retoriche e
trionfalistiche celebrazioni – come spesso è avvenuto nel passato – opportuni e
doverosi, per rispetto della verità storica, momenti di riflessione. Con la
conquista del Sud inizia infatti il processo di scientifica rapina e di
saccheggio dei beni e delle ricchezze del Mezzogiorno e della Sicilia e degli
inenarrabili massacri a cui furono sottoposte le popolazioni dei territori
“conquistati”.
Quando il massone Garibaldi si mise a
disposizione della Chiesa di Roma. E gli storici? Tacciono…,
scrive Ignazio Coppola il 10 febbraio 2016 su "I Nuovi Vespri". Solo in Italia,
per oltre 150 anni, verità storiche con tanto di testimonianze scritte possono
essere nascoste dagli storici di regime. Così, ancora oggi, i libri di storia
continuano a negare i fatti. Pensate: il ‘condottiero’ protagonista della
breccia di Porta Pia, anni prima, aveva mosso la sua spada a disposizione della
Chiesa di Pio IX che gli disse no. In cambio di denaro era pronto, sono parole
sua, “servire il Papa, il Duca, il demonio, basta che fosse italiano e ci desse
del pane”. E l’hanno fatto ‘padre della patria’ intestandogli viene scuole…Forse
non tutti sanno che Giuseppe Garibaldi il massone dei due mondi e primo massone
d’Italia si mise per fame, per bisogno e necessità a disposizione del Papa e
della Chiesa. A tal proposito vi raccontiamo la storia dell’eroe dei due mondi e
il suo lungo e travagliato excursus di adesione alla massoneria e la sua
contraddittoria disponibilità, lui massone impenitente, di mettere la sua spada
al servizio di Pio IX e della Chiesa romana. Ma cominciamo dall’inizio. Appunto
dalla sua iniziazione alla “Fratellanza Universale” che avvenne nelle lontana
America del Sud, a 37 anni, nel 1844 per poi concludersi con la sua
consacrazione a Gran Maestro nel 1864. Il primo approccio di Giuseppe Garibaldi
alla Massoneria avviene nel 1835, ai tempi della sua permanenza in Brasile, in
seguito alla frequentazione dell’amico e compatriota Livio Zambeccari, a sua
volta affiliato alla loggia massonica di Porto Alegre, ai tempi della Repubblica
del Rio Grande do Sul. In seguito, prenderà maggiore dimestichezza con
“cappucci, grembiuli, mattoni e cazzuole”, iscrivendosi, nel 1844, a Montevideo
alla loggia L’asil de la virtude (loggia irregolare). Sempre nello stesso anno e
nella stessa città, aderisce alla loggia Les amis de la patrie sotto il Grande
Oriente di Francia. Nel 1850, frequenta le logge massoniche di New York, per poi
ritrovarsi negli anni 1853/54 “alloggiato” alla Philadelphes di Londra. Ma è nel
1859 che in Italia è autorevole protagonista della ricostituita loggia del
Grande Oriente d’Italia insieme, tra gli altri, a Cavour, a Filippo Cordova, a
Massimo D’Azeglio e al gran maestro Costantino Nigra. Siamo nella immediata
vigilia della spedizione in Sicilia e, come abbiamo visto, le massonerie di
Londra e Torino, preparandola a puntino, avranno un ruolo determinante e
incisivo per la buona riuscita dell’impresa. A Garibaldi, entrato da
“conquistatore” nella capitale dell’Isola, nel giugno del 1860 verranno
conferiti, dal Grande Oriente di Palermo, tutti i gradi della gerarchia
massonica (dal 4° al 33°) e la nomina a Gran Maestro. Officianti della
cerimonia, che si svolse a Palazzo Federico, in via dei Biscottari, Francesco
Crispi e altri cinque fratelli massoni. Alcuni giorni dopo, sempre a Palermo, il
neo Gran Maestro, in virtù del massimo grado appena attribuitogli dalla
gerarchia massonica, firma le proposte di affiliazione del figlio Menotti (1
luglio 1860) e di alcuni autorevoli componenti il suo stato maggiore: Giuseppe
Guerzoni, Francesco Nullo, Enrico Guastella e Pietro Ripari (3 luglio 1860). Il
nostro eroe, da buon stakanovista della Massoneria, come vediamo, ha il suo bel
da fare. In una lettera inviata ai “fratelli” di Palermo, il 20 marzo 1862
scriveva di “avere (…) assunto di gran cuore il supremo ufficio conferitogli e
ringraziava i liberi fratelli per l’appoggio che essi avevano dato da Marsala al
Volturno nelle grande opera di affrancamento delle province meridionali. La
nomina a Gran Maestro rappresentava, come scrisse, la più solenne delle
interpretazioni delle sue tendenze, del suo animo, dei suoi voti, lo scopo per
cui aveva mirato tutta la sua vita. Ma il culmine della sua carriera massonica
Garibaldi lo raggiungerà a Firenze, nel maggio del 1864. I settantadue delegati
della prima costituente massonica, riunitisi nella città in riva all’Arno, lo
elessero, a stragrande maggioranza, Gran Maestro dei Liberi Muratori
comprendente i due riti, scozzese e italiano. Ma, a causa di divergenze e
divisioni tra le varie anime del massimo organo della Massoneria, non durerà che
pochi mesi nella suprema carica. Gli succederà Ludovico Frappolli. Nel maggio
del 1867, in una successiva assemblea tenutasi a Napoli, a sua parziale
consolazione, verrà eletto Gran Maestro Onorario. Nel 1881, infine, a poco meno
di undici anni dalla sua morte, ottenne la suprema carica del Gran Hierofante
del rito egiziano del Menphís Misrain. Come dicevamo all’inizio, da quanto
abbiamo visto, Garibaldi più che eroe dei due mondi può definirsi a pieno titolo
il “massone dei due Mondi”. V’è da credere che nella storia della Massoneria
nessuno quanto lui abbia avuto più affiliazioni nelle varie logge sparse nel
mondo. Roba da guiness dei primati. Eppure, i libri di testo delle nostre
scuole, ipocritamente e in mala fede, continuano a ignorare questa sua
appartenenza, come protagonista e figura di primo piano delle consorterie
massoniche di mezzo mondo, e il ruolo pregnante che la Massoneria ha avuto e ha
continuato ad avere sino ai nostri giorni nella storia del nostro Paese. Come
altrettanto ipocritamente e in mala fede, nel mancato rispetto della verità
storica, tutto questo è stato sempre sottaciuto in occasione delle celebrazioni
del bicentenario della sua nascita e delle celebrazioni di qualche anno fa
dell’Unità d’Italia. In dispregio alle verità ed alla trasparenza della storia,
abbiamo bisogno di eroi a ogni costo sotto le mentite spoglie di massoni,
mercenari, avventurieri e predoni. Tra le mancate virtù di Garibaldi a questo
punto, ci piace infine sottolineare e ricordare quella della sua incoerenza:
come dire, era suo solito, del predicare bene e razzolare male. Siamo a
Montevideo nel 1847 mentre, con poca gloria, si sta esaurendo la sua esperienza
uruguaiana. Avendo nostalgia dell’Italia e alla ricerca, da buon mercenario ed
avventuriero, di un nuovo padrone cui mettere a disposizione la propria spada e
i propri compagni d’arme, non trova di meglio che proporsi, egli massone,
anticlericale e mangiapreti impenitente, al servizio della Chiesa e di Pio IX.
Nell’agosto di quell’anno così scrive a un suo amico: “Io più che mai, siccome i
compagni non aneliamo ad altro che al ritorno in patria comunque sia. Dunque,
mio amico, se vedeste fosse possibile servire il Papa, il Duca, il demonio,
basta che fosse italiano e ci desse del pane. Siamo pronti a qualsiasi
condizione purché non indecorosa”. E con questa propensione all’asservimento
alla Chiesa ed a Pio IX cosi scrive il 12 ottobre 1847 a monsignor Gaetano
Bedini, nunzio apostolico a Rio de Janiero con giurisdizione sui paesi platensi:
“Offro a Pio IX la mia spada e la legione italiana per la patria e per la
Chiesa. Ricordando (egli sempre massone, ateo e anticlericale) i precetti della
nostra augusta religione sempre nuovi e sempre immortali, pur sapendo che il
trono di Pietro riposa sopra tali fondamenti che non abbisognano di aiuto,
perché le forze umane non possono scuoterli”. Monsignor Bedini, a nome di Pio
IX, rispose con molti ringraziamenti e gentilezza, declinando l’offerta di
Garibaldi e della legione Italiana. Più avanti, Garibaldi, come era nella sua
indole, non dimostrando altrettanta cortesia, definirà Pio IX e i preti un
mucchio di letame. Salvo poi, dopo la conquista della capitale della Sicilia, il
15 luglio del 1860, in occasione della festa di santa Rosalia, non aver alcun
pregiudizio, egli mangiapreti e impertinente massone, a sedere sul più alto
trono della Cattedrale di Palermo per ricevere l’incenso dall’arcivescovo di
quella città, secondo la tradizionale cerimonia della così detta “cappella
reale” simboleggiante i poteri della Legazia Apostolica. E lo ritroviamo, poco
meno di un mese dopo, a Napoli, con altrettanto fervore religioso, rendere
omaggio, se pur Gran Maestro Venerabile della Massoneria, alla Madonna
Venerabile nella chiesa di Piedigrotta ed a un breve discorso del sacerdote
officiante rispose con parole di devoto amore alla religione cristiana e alle
sue grandi e sublimi verità. Il 10 giugno, infine, rispettando le consuetudini
religiose di questa città, dispose la celebrazione della ricorrenza del patrono
San Gennaro, presenziando autorevolmente assieme agli alti prelati della chiesa
napoletana al miracoloso scioglimento del sangue del santo. Misteri della fede
massonica o cattolica dell’eroe dei due mondi. Fate voi. Ai lettori l’ardua
sentenza.
Ma quale gloriosa battaglia di
Calatafimi! Solo imbrogli e tradimenti. In stile Garibaldi,
scrive "Ignazio Coppola" il 5 gennaio 2016 su "I Nuovi Vespri". In un reportage
La Repubblica edizione di Palermo, per la firma di Gianni Bonina, ripropone
Garibaldi e la battaglia di Calatafimi. Presentata come una vicenda ‘eroica’.
Ragazzi, ormai lo sanno pure le pietre che Garibaldi ‘vinse’ sta battaglia-farsa
grazie al tradimento del generale Landi. Altro che gloria! E’ di questi giorni
sulla pagina culturale de La Repubblica edizione di Palermo un reportage a
puntate dal titolo “Sulle orme dei garibaldini – l’isola in camicia rossa”a
firma di Gianni Bonina che va dallo sbarco di Marsala l’11 maggio 1860 e via via
descrivendo ad usum delphini tutta l’impresa dei Mille di Garibaldi in Sicilia,
con particolare riferimento alla battaglia di Calatafimi pubblicata domenica 31
Luglio. Ebbene, anziché ripetere falsità storiche, come ormai da 156 anni a
questa parte ci propinano gli storiografi di regime, il nostro poco attendibile
“storico” autore del reportage sui Mille avrebbe fatto meglio a documentarsi e
trarre le debite conclusioni su come realmente si svolse la battaglia farsa di
Calatafimi. E su come questa battaglia farsa, come tante altre, rientra appunto
nell’alveo di quelle verità storiche sottaciute o, peggio ancora, mistificate e
contrabbandate come epiche gesta da tramandare ai posteri con frasi ad effetto
come quella: “Qui si fa l’Italia o si muore” che a quanto pare Garibaldi non ha
mai pronunciato. Una battaglia farsa, quella di Calatafimi, decisa, dal
tradimento e dalla corruzione del generale Landi e non dal valore dei
garibaldini. Decisiva e galeotta, infatti, fu una “fede di credito” di 14.000
ducati (poi addirittura risultata taroccata e falsa all’atto della riscossione),
pagata a Landi dallo stesso Garibaldi. Vicenda in seguito confermata dallo
stesso Landi, per cui 3000 borbonici ben addestrati e ben armati s’arresero a
circa 1000 garibaldini poco avvezzi all’uso delle armi e animati solamente da
spirito d’avventura. Per cui l’episodio della corruzione del generale Landi fu
l’unico decisivo e squallido elemento delle sorti della battaglia di Calatafimi.
Del resto basta rileggere, a conferma di questo, quanto scritto dagli
storiografi al seguito dello stesso Garibaldi per rendersi bene conto di quello
che inaspettatamente e scandalosamente avvenne a Calatafimi. Scrive Cesare
Abba nel suo diario Da Quarto al Volturno: “E proprio quando pensavamo di avere
perso, alla fine ci parve un miracolo avere vinto” (il miracolo della fede di
credito frutto della corruzione). E ancora Francesco Grandi nel suo diario I
garibaldini testualmente riporta: “Ci meravigliammo non credendo ai nostri occhi
e alle nostre orecchie, quando ci accorgemmo che il segnale di abbandonare la
contesa, come avevamo temuto, non era lanciato dalla nostra tromba, ma da quella
borbonica”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’amministratore della
spedizione dei Mille, lo scrittore Ippolito Nievo, il quale nelle sue memorie
ebbe a meravigliarsi di una vittoria, giunta, quanto mai inattesa. L’inusuale
ritirata di 3000 borbonici al cospetto di 1000 garibaldini male in arnese, trova
dunque la sua logica giustificazione nel prezzo della corruzione che Garibaldi
pagò a Landi, e dallo stesso successivamente confermato, perché inopinatamente e
inaspettatamente desse alle sue truppe l’ordine di ritirasi. E di tutto questo
il buon Gianni Bonina avrebbe fatto meglio a documentarsi, magari rileggendosi
un articolo scritto proprio su La Repubblica di Palermo qualche anno fa dallo
storico Salvatore Falzone dal titolo: “La battaglia di Calatafimi - Eroismo o
tradimento? - Battaglia o pagliacciata?” prima di riproporci nel suo reportage
lo scontro - farsa di Calatafimi come una epica battaglia da tramandare ai
posteri. E proprio ora di finirla.
Quando casa Savoia, 155 anni fa, fece
fucilare Angela Romano, una bambina di 9 anni, scrive
"Ignazio Coppola" l'1 gennaio 2017 su "I Nuovi Vespri". Parliamo della rivolta
dei Cutrara, andata in scena nei primi giorni di gennaio di 155 anni fa a
Castellammare del Golfo. Fu la rivolta dei poveri Siciliani, che non volevano
passare cinque anni della loro vita al servizio dell’esercito piemontese. I
giovani delle famiglie ricche pagavano e venivano esentati dalla leva. I poveri
dovevano piegarsi alla prepotenza di casa Savoia. Da qui la ribellione repressa
nel sangue dai ‘galantuomini’ di Torino. Che passarono per le armi vecchi, donne
e persino una bambina. Una storia di violenza e di crudeltà che i libri di
storia del nostro Paese ignorano. Ricorre in questi primi giorni di gennaio il
155° anniversario della rivolta dei “Cutrara”. Una rivolta che, per parecchi
giorni, agli albori dell’unità d’Italia, insanguinò Castellammare del Golfo.
Avvenimenti dei quali, come è spesso successo nella storia del nostro Paese, s’è
persa la memoria e ogni traccia. Una vicenda che gli abitanti di questa
cittadina siciliana del Trapanese, attraverso associazioni culturali e le
istituzioni locali, con varie iniziative, meritoriamente stanno cercando di
riportare alla luce squarciando così un pietoso velo che sinora ha condannato
all’oblio quei tragici avvenimenti che, proprio perché facenti parte della
nostra storia, ci sembra opportuno ricordare. Il primo gennaio del 1862, a poco
meno di un anno dalla proclamazione del regno d’Italia, buona parte degli
abitanti di Castellammare del Golfo, stanchi delle sopraffazioni e dei soprusi
subiti in così breve tempo, sopratutto per le esose tassazioni e l’imposizione
del servizio militare obbligatorio, scese in piazza al grido di “Abbasso la leva
e morte ai Cutrara”. La causa scatenante della rivolta fu data, appunto,
dall’introduzione della lunga leva militare obbligatoria (alla quale sotto il
Borbone i siciliani erano esenti) la cui legge istitutiva, pubblicata dalla
Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1861, prevedeva discriminatamene che i figli
dei poveri, non potendosi comprare l’esenzione, prevista dalla legge, erano
costretti ad una lunga leva di ben 5 anni, mentre al contrario ai figli dei
ricchi – appunto i Cutrara (cappeddi o galantuomini) – potendoselo permettere e
pagando profumatamente venivano esentati. Il primo gennaio 1862, esattamente 155
anni addietro, gran parte della popolazione capeggiata da due popolani Francesco
Frazzitta e Vincenzo Chiofalo insorse contro questo stato di cose e contro
queste ingiustizie. Dopo avere piantato una bandiera rossa al centro del paese
si pose alla caccia dei notabili locali – per l’appunto i Cutrara – i nobili e i
borghesi, simbolo di queste discriminazioni e di questi privilegi. Furono
assaltate la abitazioni del commissario alla leva, Bartolomeo Asaro, e del
comandante della guardia nazionale, Francesco Borruso, che vennero catturati
catturati ed uccisi e le loro case bruciate. Eccessi esecrabili di una
popolazione esasperata da vessazioni ed ingiustizie. Fatti che non possono certo
giustificare le rappresaglie e gli eccidi da parte dei piemontesi sbarcati su
due navi da guerra con centinaia di bersaglieri nel porto di Castellammare.
Militari inviati dal generale Govone al comando dal generale Pietro Quintino, un
ex garibaldino che, anziché porsi alla caccia dei colpevoli, non trovò di meglio
che passare per le armi, in dispregio ad ogni elementare norma di umanità e
legalità, uomini, vecchi, donne e persino un’innocente bambina di appena 9
anni, Angela Romano. Innocenti, rastrellati dalle truppe piemontesi in contrada
Villa Falconeria, alla periferia del paese, e massacrati. Vigliaccheria allo
stato puro. Gli altri cittadini fucilati alle ore tredici di quel maledetto
venerdì 3 gennaio 1862 furono Mariano Cruciata, di 30 anni, Marco Randisi di 45
anni, il sacerdote Benedetto Palermo, di 46 anni, la contadina Anna Catalano, di
50 anni, e i vecchi Angelo Calamia e Antonino Corona, entrambi di 70 anni. A
distanza di poco meno di due anni si ripetevano a Castellammare, ad opera dei
piemontesi, con pedissequa ferocia e con una sconcertante crudeltà, gli eccidi
andati in scena a Bronte perpetrati da Nino Bixio contro ogni aspettativa di
libertà, di giustizia e di affrancamento dalla miseria: richieste che i
siciliani avevano all’arrivo dei garibaldini prima e dei piemontesi dopo. Di
recente, in memoria degli atti di crudeltà perpetrati dai piemontesi le
Amministrazioni comunali di Castellammare del Golfo e di Gaeta hanno deciso di
intitolare una via cittadina ad Angelina Romano, la più giovane delle
incolpevoli e inconsapevoli vittime di quell’esecrabile eccidio. La rivolta di
Castellammare del gennaio del 1862 fu poi, quattro anni dopo, propedeutica della
grande rivolta palermitana del settembre del 1866 così detta del “Sette e Mezzo”
che costò miglia e migliaia di vittime a causa della repressione piemontese (qui
potete leggere l’articolo sulla rivolta del “Sette e mezzo” scritto, sempre da
Ignazio Coppola, nel settembre dello scorso anno). Rivolte puntualmente ed
ipocritamente secretate e ignorate dai testi scolastici e dalla storiografia
ufficiale. Questo, ancora una volta, fu il contributo di sangue innocente dato
dai meridionali e dai siciliani alla causa dell’unità nazionale. E proprio per
questo sarebbe giusto, oltre che festeggiare e celebrare enfaticamente – come
spesso avviene -episodici retorici dell’unità d’Italia, ricordare quei morti e
quelle vittime innocenti che furono immolate, loro malgrado, al processo
unitario. Ed è quello che, con molto merito per rimuovere una damnatio
memoriae che per lungo tempo li ha condannati all’oblio, hanno fatto in questi
ultimi tempi i cittadini di Castellammare del Golfo, commemorando e ricordando
le vittime della rivolta dei cutrara del gennaio del 1862. In piena sintonia con
quanto sosteneva Leonardo Sciascia: “Questo è un Paese senza memoria e io non
voglio dimenticare”. Ed è per non dimenticare che i Siciliani sono impegnati
alla costante ricerca della loro perduta memoria storica.
FRATELLI COLTELLI.
Massoneria, scoppia la grande faida.
Dopo il sequestro di 35 mila nomi da parte della Guardia di Finanza, nelle logge
è tutti contro tutti. Espulsioni, autosospensioni, scissioni. Riti paralleli e
incontrollabili. Macabre cerimonie di iniziazione. E sullo sfondo le
infiltrazioni criminali su cui indaga l’Antimafia, scrive Gianfrancesco Turano
il 10 aprile 2017 su "L'Espresso". Nel fine settimana della Gran Loggia,
organizzato dal Grande Oriente a Rimini dal 7 al 9 aprile, la massoneria si
mostra compatta, in salute, forte delle sue adesioni in crescita costante. Nel
trecentesimo anniversario dalla nascita della massoneria moderna a Londra, la
kermesse annuale ha convocato al Palacongressi della città romagnola duemila
persone, ha programmato spettacoli teatrali dedicati alla vita di Enzo Tortora,
commemorazioni di fratelli illustri come l’attore Arnoldo Foà e l’apneista Enzo
Maiorca. Fra i politici invitati, gli habitués Daniele Capezzone (Direzione
Italia) e il viceministro delle Infrastrutture e segretario socialista Riccardo
Nencini. Abbondanti e varie anche le delegazioni internazionali presenti in
Italia per ottenere il riconoscimento del Goi: Mali, Sudafrica e cinque Stati
della federazione brasiliana. Tutto sotto il patrocinio del segretario esecutivo
della conferenza dei Gran Maestri internazionali, il chirurgo pediatrico rumeno
Radu Balanescu. Tutto bene, quindi? Non è proprio così. Dietro labari e
stendardi le divisioni aumentano. Il triplice fraterno abbraccio del rituale non
esclude la pugnalata alla schiena e di faide massoniche è piena la storia
d’Italia. Ma quello che sta accadendo ai vertici delle due principali obbedienze
italiane (Grande Oriente d’Italia o Goi e Gran Loggia degli Alam) non si vedeva
da 36 anni, ai tempi della tempesta P2, loggia speciale del Goi guidata da Licio
Gelli.
A fare detonare le tensioni che covavano da tempo
fra le colonne mistiche di Jachin e Boaz sono state le pressioni della
Commissione parlamentare antimafia, presieduta da Rosy Bindi che, dopo settimane
di trattative, promesse mancate e offerte di collaborazione andate a vuoto, ha
rotto gli indugi sequestrando gli elenchi di 35 mila iscritti alle quattro
principali obbedienze nazionali. In origine l’obiettivo dell’Antimafia erano i
fratelli di Sicilia e Calabria, regioni ad alto rischio dove si è registrato un
boom di affiliazioni alla libera muratoria. Alla fine, com’è accaduto nel 1992
su ordine del procuratore di Palmi Agostino Cordova, gli uomini della Guardia di
finanza hanno prelevato gli elenchi in blocco. Per tutelare le esigenze di
riservatezza e prevenire le fughe di notizie, finora nessuno dei parlamentari ha
avuto accesso alle liste che saranno controllate da esperti informatici per
verificare eventuali manipolazioni. Il lavoro di catalogazione si svolgerà con
la supervisione dei magistrati consulenti della Commissione e sarà lungo. A oggi
non risulta che gli elenchi siano stati trasferiti alle principali procure che
indagano sul crimine organizzato. Ma il segnale è chiaro. A un quarto di secolo
dall’inchiesta di Cordova finita in nulla dopo l’avocazione da Palmi a Roma, la
magistratura ha preferito cedere l’iniziativa alla politica e non ha sequestrato
gli elenchi direttamente, come pure poteva, proprio per agire in parallelo con
una commissione dove sono presenti tutti i gruppi parlamentari. L’intervento,
mirato a scoprire le infiltrazioni del crimine organizzato fra i grembiuli, ha
incrinato il riserbo dei massoni che, dopo l’inchiesta dell’Espresso di due mesi
fa, hanno rivelato lotte interne, guerre di potere, episodi boccacceschi e
rituali in stile Grand-Guignol, piuttosto lontani dalle tradizioni
risorgimentali. Fra espulsioni, scissioni e processi massonici, nelle logge è
tutti contro tutti.
La spaccatura più grave riguarda la Gran Loggia
degli Alam (antichi liberi accettati muratori), seconda associazione massonica
per numero di iscritti (8114 in 510 logge), unica in Italia ad accettare le
donne e molto legata, sul piano internazionale, agli oltre 50 mila iscritti del
Grande Oriente di Francia. Gli Alam sono guidati da Antonio Binni, avvocato
civilista modenese con studio a Bologna, classe 1937, studi a Berlino e
Gottinga, nipote del grande italianista e dantista Walter Binni. Eletto nel
2013, Binni ha lasciato l’attività forense e per questo è stato il primo Gran
Maestro degli Alam ad attingere all’emolumento annuale previsto dagli statuti
(40 mila euro, con l’ipotesi di aumentare a 60 mila). Poca cosa rispetto ai 130
mila euro del numero uno del Goi, Stefano Bisi. In compenso, non è trascurabile
il patrimonio degli Alam. Il Centro sociologico italiano, semplice associazione
collegata agli Alam, gestisce 22 immobili, quasi tutti destinati a case
massoniche, escluse quelle estere che spaziano da Beirut a Toronto («niente
calabresi, molti lucani», ha dichiarato Binni all’antimafia a proposito delle
logge canadesi). Il 17 dicembre 2016 Binni ha rivinto le elezioni per il secondo
mandato con una maggioranza risicata. Il giorno dopo, con un gruppo di sei
fedelissimi e in assenza dei suoi nove oppositori, ha rivoluzionato il Supremo
Consiglio del Rito Scozzese Antico e accettato (Rsaa). Al posto dei nove
dissidenti con grado 33 (il massimo riconosciuto dal Rsaa), il Gran Maestro e
Sovrano Gran Commendatore Binni ha nominato ventinove fratelli e si è garantito
il controllo del consiglio convalidando la decisione il 14 gennaio 2017. Per
capire l’importanza dell’operazione, bisogna aggiungere che il Rito Scozzese è
l’élite dell’iniziazione massonica. Oltre a essere il più praticato a livello
internazionale, consente di proseguire il percorso iniziatico al di là dei tre
gradi di apprendista, compagno e maestro previsti dall’ordinamento. Le
conseguenze del colpo di mano del 17 dicembre sono state drammatiche per
l’obbedienza di palazzo Vitelleschi, splendida dimora al centro di Roma. Gli
esclusi hanno protestato invano contro Binni, che in audizione davanti
all’Antimafia si è vantato di governare l’obbedienza con le maniere forti. Uno
scambio incrociato di Tavole d’accusa ha portato alla secessione di circa 600
fratelli che hanno seguito l’ex Gran Maestro degli Alam Luigi Pruneti verso una
nuova obbedienza. Il 18 febbraio Pruneti e il fiorentino Riccardo Cecioni sono
stati espulsi da Binni. Per usare la terminologia esoterica, sono stati bruciati
fra le colonne del Tempio, nel rogo simbolico che rappresenta la massima
punizione della giustizia massonica, in quanto colpevoli di spergiuro e
tradimento. Circa un migliaio di fratelli si sono messi in sonno
(autosospensione). Altri si stanno rivolgendo (stanno bussando, in gergo) ad
altre obbedienze. Chi ha deciso di rimanere combatte la battaglia dall’interno
sotto la guida di Sergio Ciannella, avvocato che ha il titolo di Venerabile Gran
Priore del Supremo Consiglio. In sostanza, è il numero tre degli Alam schierato
insieme al suo gruppo contro il numero uno, Binni, e il suo vice, Luciano
Romoli, ex avversario di Binni diventato il suo delfino e autore di una
strategia di riavvicinamento al Vaticano che non tutti hanno apprezzato
all’interno dell’obbedienza. Ancora meno è stato apprezzato l’atteggiamento di
Binni davanti all’Antimafia, il 25 gennaio 2017, quando il Gran Maestro ha
negato qualunque infiltrazione indicando ai parlamentari il problema delle 92
obbedienze (non logge, quindi, ma intere organizzazioni) nella sola Arezzo e
aggiungendo di non essere amato né in Calabria, né in Sicilia. In verità, Binni
sembra poco amato anche altrove. «Non vogliamo sentire parlare di Vaticano, di
Bilderberg e di altri poteri forti», dice il napoletano Ciannella. «Siamo figli
dei patrioti dell’Ottocento e vogliamo continuare nell’alveo della tradizione
senza uscire dall’obbedienza. È Binni che deve uscire. Il suo comportamento
davanti all’Antimafia ha suscitato indignazione fra gli Alam in Piemonte, in
Lombardia, in Toscana. Il Gran Maestro ha scaricato i fratelli siciliani e
calabresi in modo indiscriminato e poi si è messo al riparo dicendo che non li
controlla. Si è dimenticato di dire che gli affiliati da lui sospesi sono stati
reintegrati con sentenze della magistratura ordinaria. Molti di noi hanno invece
apprezzato l’atteggiamento di Stefano Bisi del Goi a difesa della privacy di chi
è iscritto a un’associazione non riconosciuta prevista dalla Costituzione». La
gestione di Binni è stata contestata anche di recente durante una riunione con
circa 200 fratelli piemontesi a Torino. Il Gran Maestro ha replicato con piglio
autocratico alle domande riguardanti la questione del Supremo consiglio e certi
presunti favoritismi come quello verso una giovanissima affiliata. La sorella è
stata promossa di tre gradi in un colpo solo all’interno del Rito scozzese
antico e accettato per opera di un “motu proprio” del Gran Maestro. Eppure
proprio Binni sottolinea nel suo programma per la gran maestranza che “occorre
ostacolare con ogni dovuta fermezza la corsa ai gradi”. A chi gli ha fatto
notare l’incongruenza fra teoria e prassi Binni ha replicato ammettendo a suo
modo l’errore: avrebbe dovuto avanzare di quattro gradi invece che di tre la
giovane sorella. Secondo fonti investigative, c’era anche lei oltre a Binni a
palazzo Vitelleschi la notte in cui sono stati sequestrati gli elenchi. «Siamo
arrivati al punto», dice il membro di una loggia della Toscana meridionale, «che
un fratello promosso dal terzo al grado, un passaggio molto importante, ci ha
telefonato per rinunciare alla cerimonia». Consultato dall’Espresso, Binni ha
affidato a un portavoce il suo desiderio di non rilasciare commenti sui dissidi
interni degli Alam. Presto dovrà comunque farlo. Il conflitto sul colpo di mano
del 17 dicembre scorso è stato portato a conoscenza della magistratura ordinaria
con una citazione al Tribunale di Roma mirata a ottenere l’annullamento delle
sospensioni deliberate da Binni. Il verdetto dovrebbe arrivare entro metà
giugno. Prima, il 20 aprile, si riunirà l’Alta Corte di Giustizia massonica
convocata dal gruppo di Ciannella contro Binni e Romoli. In seguito, si terrà il
processo interno a parti invertite. Già nel 1998, a Bologna, c’era stato uno
scontro finito davanti al tribunale ordinario fra il Maestro Venerabile della
loggia Carducci Vincenzo Maria Santoro, notaio, e l’allora numero uno
dell’obbedienza, il commercialista Renzo Canova, che aveva espulso Santoro.
Canova era difeso dall’avvocato Binni. Ma la situazione di oggi è molto più
grave.
La crisi degli Alam è una copia della scissione
che colpì il Goi nel 1993, quando il numero uno di allora, Giuliano Di Bernardo,
decise di abbandonare l’obbedienza a seguito dell’inchiesta di Cordova. Di
Bernardo fondò la Gran Loggia Regolare d’Italia portandosi dietro l’ambitissimo
riconoscimento della Gran Loggia d’Inghilterra. Al Goi non la presero bene e
bruciarono materialmente i ritratti del Gran Maestro scissionista nel tempio. Il
Grande Oriente d’Italia (23 mila iscritti in 805 logge) è l’obbedienza che più
si è scontrata con l’Antimafia. Per certi aspetti il braccio di ferro con la
commissione ha puntellato sul fronte interno il numero uno del Goi. Nelle sue
audizioni Stefano Bisi ha sempre tenuto una posizione antagonistica sulla
consegna degli elenchi. Molti fratelli hanno apprezzato e, anche se Bisi non
conferma, molti transfughi della Gran Loggia degli Alam stanno bussando a Villa
del Vascello, il lussuoso palazzo al Gianicolo che ha sostituito come sede del
Goi palazzo Giustiniani, acquisito dal Senato della Repubblica. Con i
parlamentari lo scontro continua a salire di livello. Il 17 marzo il Goi ha
presentato alla Commissione un’istanza di revoca in autotutela contro il
sequestro degli elenchi avvenuto il primo giorno di marzo nella sede
dell’obbedienza. Non avendo ottenuto risposta, il 31 marzo il collegio difensivo
del Goi si è rivolto alla magistratura di Roma «con una richiesta di verifica
sulle liceità dei comportamenti e degli atti adottati dalla Commissione e dai
suoi componenti». Bisi si è difeso dagli attacchi dell’Antimafia con lo stesso
vigore che ha dimostrato nei confronti di don Luigi Ciotti, il fondatore di
Libera che ha messo in relazione stretta ’ndrangheta e massoneria sulla scia
delle inchieste della Procura di Reggio Calabria. La polemica e i continui
battibecchi fra la presidente Bindi e il Gran Maestro Bisi, entrambi senesi,
hanno animato le audizioni e hanno fatto passare in secondo ordine i contrasti
sul fronte interno della maggiore fratellanza italiana. C’è una richiesta di
dimissioni del Gran Maestro avanzata da parte di un dirigente di alto livello
del Goi, il Gran Tesoriere Giovanni Esposito, commercialista napoletano di 49
anni. Esposito ha chiesto il passo indietro di Bisi in relazione al processo per
ricettazione che coinvolge il leader del Goi a margine delle vicende del Mps.
L’udienza preliminare dove si doveva decidere sul rinvio a giudizio di Bisi
chiesto dalla Procura di Siena è slittata dal 16 febbraio a giovedì 6 aprile,
quando questo numero dell’Espresso era in stampa. Ma anche in caso di rinvio a
giudizio, Bisi resterà al suo posto a Villa del Vascello. Non è detto che lo
stesso capiti a Esposito sul quale pende una tavola d’accusa massonica per la
sua presa di posizione contro il Gran Maestro. «Non mi sembra il caso», dice
Bisi, «di soffermarsi sui processi disciplinari interni. Nella nostra comunione
in questo momento ci si occupa di altro. In Calabria, Sicilia o Umbria, siamo
tutti molto coesi in difesa del gruppo. Se fratelli di altre obbedienze come gli
Alam o la Gran Loggia Regolare hanno apprezzato il nostro atteggiamento, non può
che farmi piacere soprattutto in rapporto a come si sono comportati i loro Gran
maestri davanti al presidente Bindi». La stoccata non troppo fraterna è riferita
all’apparente disponibilità di Binni e di Venzi a consegnare gli elenchi alla
Commissione dietro un semplice ordine di presentazione. Venzi, in particolare,
ha dichiarato nell’audizione del 24 gennaio che la sua obbedienza ha l’abitudine
di consegnare due volte all’anno gli elenchi al ministero dell’Interno, mentre
le liste locali vengono recapitate alla Digos, ai carabinieri e alle prefetture
delle varie province. In realtà né Binni né Venzi hanno rispettato la data
ultimativa di consegna chiesta dalla Commissione (8 febbraio) e hanno consegnato
le liste solo con l’intervento della Guardia di finanza.
Fra gli elementi di scontento all’interno del Goi
non c’è soltanto la vicenda personale del Gran Maestro. Oggi come ieri la
massoneria vive di un contrasto fra la tendenza esoterica e l’ambizione di
entrare in un circuito privilegiato che garantisce relazioni di potere e affari
più o meno legittime.
«I riti vanno distinti dall’Ordine iniziatico»,
dice un membro pugliese del Goi e del Rito simbolico italiano dietro garanzia di
anonimato. «La massoneria prevede solo i primi tre gradi, che peraltro non vanno
considerati in modo gerarchico come fanno i più, e finisce qui. I riti sono
associazioni satellite e accessorie alla massoneria, autonome ma non
indipendenti, che hanno il ruolo di approfondire determinati aspetti della
massoneria con una chiave di lettura propria. Questa chiave è l’esoterismo
iniziatico, che può essere di origine cavalleresca, come nel caso del Rsaa o del
rito di York, ovvero egizio nel caso di Memphis e Misraim. Il Rito Scozzese si
picca di fornire una formazione completa dell’adepto ma in realtà in Italia
dietro la facciata spiritualistica si nasconde una vera e propria scuola di
potere che dal dopoguerra ha determinato la politica del Goi. I calabresi che
tengono in vita Bisi sono patologicamente fissati con l’appartenenza e sono
quasi tutti nel Rsaa. Fanno favori a tutti i livelli e affari solo agli alti
livelli e non mi riferisco all’Italia ma al mondo intero. Va ricordato che il
Rito scozzese è nato negli Stati Uniti e ha due case madri, Washington e Boston.
La nostra disgrazia fu che nel dopoguerra il Rsaa americano intervenne
pesantemente in Italia. Per fare decollare il movimento le logge dovettero
subire l’imposizione di gente come Giovanni Alliata di Monreale nel Goi o
Giuseppe Pièche fra gli Alam, vale a dire l’estrema destra, perché si era in
clima di guerra fredda. L’unico che usò il Rsaa senza esserne usato fu Gelli».
Oggi il Sovrano Gran Commendatore del Rito Scozzese nel Grande Oriente è un
imprenditore con mille interessi in Italia e all’estero come Leo Taroni.
Ravennate, 69 anni, costruttore, immobiliarista e commerciante, Taroni è stato
nominato alla guida del rito più prestigioso nel dicembre del 2015 e presiede la
confederazione europea dei Supremi consigli. Il Sovrano Gran Commendatore è
azionista di minoranza di Forza Rossa, concessionaria della Ferrari e della
Lotus in Romania, Serbia, Montenegro e Moldova. La maggioranza di Forza Rossa
appartiene a Ion Bazac, ministro socialdemocratico della Sanità nel 2008 e 2009
con il governo guidato dal liberaldemocratico Emil Boc. Taroni è reduce da una
lite con un imprenditore reggiano per l’acquisto di una Ferrari FXX K da 2,2
milioni di euro. Dopo avere rischiato di perdere la concessione con Maranello,
il numero uno del Rsaa versione Grande Oriente, ha chiuso la faccenda con poco
danno e una transazione. «Nessuno ci ha rimesso nulla», ha dichiarato Taroni al
Corriere della Sera. «Sono stati restituiti i soldi». Tutto è bene quel che
finisce bene. Ma se si trattava di dare della massoneria un’idea diversa da una
rete di relazioni a fini affaristici, è un’occasione persa.
ABOLIAMO LA MASSONERIA?
Aboliamo la Massoneria.
Un’inchiesta politica e giudiziaria senza precedenti dai tempi della P2 mette
sotto scacco il mondo degli incappucciati. E la commissione Antimafia vuole i
nomi degli affiliati. Era ora. Ma non basta, scrive Gianfranco Turano il 10
febbraio 2017 su “L’Espresso. Abolire la massoneria? Nessun esponente delle
istituzioni può rispondere sì in modo formale. Non le procure, né la commissione
parlamentare antimafia. Ma le loro indagini hanno stretto i liberi muratori in
una morsa politico-giudiziaria senza precedenti dai tempi della P2 (marzo 1981)
quando Licio Gelli, il Venerabile per eccellenza, gestiva un potere occulto,
alternativo allo Stato democratico, raccogliendo un’oligarchia di deputati,
ministri, generali, imprenditori e criminali che si erano sottratti alle leggi
della Repubblica. Oggi i parlamentari sono spariti, almeno così dicono i
Maestri. Ma i guai giudiziari rimangono. Forse perché in 35 anni la legge 17 del
1982 sulle associazioni segrete, firmata da Tina Anselmi e da Giovanni
Spadolini, non certo un massonofobo, è rimasta inapplicata. I due tentativi
fatti nel 1992 dal procuratore di Palmi, Agostino Cordova, e negli anni Duemila
dall’allora pm di Catanzaro Luigi De Magistris (inchieste Why not e Poseidone),
non hanno raggiunto risultati significativi. Tre decenni e mezzo dopo Tina
Anselmi, la presidente dell’Antimafia Rosy Bindi ha chiesto, come fece Cordova
nel 1992, l’esibizione degli elenchi ai Gran Maestri con scadenza 8 febbraio. Le
resistenze opposte dalle due obbedienze più frequentate, il Grande Oriente
d’Italia e la Gran Loggia degli Alam (antichi liberi accettati muratori), hanno
seri appigli giuridici nella libertà di associazione prevista dalla
Costituzione, più che dalla legge sulla privacy ed è prevedibile che lo scontro
durerà a lungo. Di certo Gelli, a poco più di un anno dalla sua morte, sembra
avere seminato anche troppo bene. Come alla fine dell’Ottocento, è tornato di
moda il motto del garibaldino e deputato Felice Cavallotti: «Non tutti i massoni
sono delinquenti, ma tutti i delinquenti sono massoni». La cronaca sembra
confermare il teorema. In Calabria le inchieste Meta, Lybra, Decollo Money,
Purgatorio, Fata Morgana, solo per citarne alcune, rivelano una compenetrazione
fra ’ndrangheta e massoneria dove la seconda avrebbe inglobato la prima, come ha
sintetizzato in una celebre intercettazione il boss di Limbadi Pantaleone
Mancuso “Vetrinetta”. In Sicilia, nel trapanese in particolare, il binomio fra
grembiuli e Cosa nostra sembra solido quanto lo è in Calabria. A Roma Giulio
Occhionero, ingegnere informatico e hacker con server negli Stati Uniti,
arrestato a gennaio, spiava politici, manager ed esponenti dell’intelligence,
senza dimenticare circa 300 suoi fratelli del Grande Oriente d’Italia (Goi).
Siena, la città del Gran Maestro del Goi Stefano Bisi, è stata scossa da uno
scandalo ad alta densità massonica come quello del Monte dei Paschi, che ha
coinvolto lo stesso Bisi (intervista a pagina 12). E l’aeroporto della città del
Palio, un’avventura chiusa con un buco da 9 milioni di euro, ha travolto la
società di gestione presieduta da Enzo Viani, l’uomo che amministra
l’immobiliare del Goi (Urbs). Anche il crac della Bf dei costruttori Roberto
Bartolomei e Riccardo Fusi, molto vicino a Denis Verdini, ha coinvolto alcuni
iniziati fra le colonne di Jachin e Boaz. Perfino il tormentato caso Cucchi ha
visto la fallita ricusazione da parte della famiglia del perito e medico legale
Francesco Introna, massone in sonno. Vietato generalizzare, certo. I massoni si
sono difesi attaccando le magagne dei partiti o dei preti pedofili. Ma i partiti
non si sono mai più ripresi sul serio dallo choc di Tangentopoli e la Chiesa,
quanto meno, si è dissanguata in cause di risarcimento. La massoneria, invece,
prospera a dispetto degli scandali. In alcune zone, forse proprio grazie alla
sua aura di impunità e riservatezza, oltre alla capacità di fornire una rete
relazionale a livello nazionale e internazionale. Anche ai vertici della libera
muratoria qualcuno teme che le logge abbiano accolto un tasso di criminali
superiore alla media e che le tegolature, come i massoni chiamano i controlli di
ingresso sui candidati o “bussanti”, siano state poco conformi alle norme
edilizie del Gadu, il grande architetto dell’universo sul quale l’iniziato deve
giurare. Tutti i Gran Maestri negano in modo risoluto che esistano logge segrete
e che sia ancora in voga l’iniziazione all’orecchio (o “sulla spada”) nota
soltanto al Venerabile che guida la loggia. Sono anche concordi nel riferire la
grande crescita di iscrizioni all’aumento delle vocazioni esoteriche, in una
fase di crisi dei valori. Qualunque sia il motivo, i dati raccontano una storia
di successo. Nel 1992, in piena tempesta Cordova, quando il gran maestro
cosentino Ettore Loizzo denunciava all’allora numero uno del Goi Giuliano Di
Bernardo che 28 logge calabresi su 32 erano in mano alla ’ndrangheta, i fratelli
in Calabria erano circa 800 su circa 9 mila affiliati in Italia. Dopo il boom di
iscrizioni a livello nazionale durante i 15 anni di granmaestranza di Gustavo
Raffi (21 mila in 802 logge), l’attuale Gran Maestro Stefano Bisi ha dichiarato
che su 23 mila iscritti al Goi in 805 logge (dati al 31 dicembre 2015) ce ne
sono 2634 in Calabria e 2208 in Sicilia. Il 21 per cento degli affiliati è nelle
due regioni più a sud dell’Italia. Le logge calabresi sono passate dalle 32 dei
tempi di Loizzo alle attuali 80. La stessa proporzione (21 per cento) vale per
la Gran loggia regolare d’Italia, obbedienza fondata da Di Bernardo e retta da
Fabio Venzi con 2400 iscritti in Italia. La Gran Loggia degli Alam di Antonio
Binni, seconda obbedienza in Italia con 8114 iscritti, ha la proporzione più
bassa con complessivi 1357 fratelli calabro-siculi (16,7 per cento). In compenso
104 logge degli Alam su 510 totali sono in Calabria o in Sicilia (20,3 per
cento). La piccola Serenissima Gran Loggia di Massimo Criscuoli Tortora (197
membri) ha la percentuale più alta con circa 60 fratelli affiliati alle tre
logge calabresi (30 per cento) oltre agli iscritti alla loggia di
Messina-Catania. Per ovvi motivi non si hanno cifre sulle obbedienze irregolari
o spurie che sovrastano in numero le circa dieci obbedienze regolari. Le
massonerie fai da te sono 124 secondo Criscuoli Tortora e 192 secondo Binni, di
cui 97 nella sola Arezzo, patria di Gelli. La sproporzione è evidente,
considerato che i residenti di Calabria e Sicilia sono 7 milioni, cioè l’11 per
cento della popolazione nazionale. Inoltre, non è dato sapere quanti calabresi e
siciliani siano affiliati a logge che non sono in Calabria o in Sicilia, per non
parlare delle logge estere facenti capo a obbedienze italiane in vari paesi:
Malta, Libano, Romania, Ucraina e in Canada a Toronto, città strategica nello
scacchiere internazionale del crimine italo-americano. Nelle varie obbedienze si
nota una prevalenza di iscritti a livello provinciale di Reggio, per la
Calabria, e di Trapani, per la Sicilia, con una particolare vivacità esoterica a
Campobello di Mazara e a Castelvetrano. È il regno di Matteo Messina Denaro, il
capo latitante di Cosa nostra. Già nel 1986 a Trapani è emerso il radicamento
della massoneria più oscura quando la polizia scoprì che il centro studi
Scontrino era la copertura di sette logge inaugurate da Gelli sei anni prima e
frequentate da politici, imprenditori e mafiosi. Le spiegazioni date dai
responsabili a questo surplus di spirito iniziatico in Calabria e a Trapani sono
le più varie. Sostiene Bisi che la prima Loggia italiana sarebbe stata fondata a
Girifalco (Catanzaro) nel Settecento e si sa che i calabresi amano le loro
tradizioni. Binni invece ha preso le distanze e dice: «Io non sono amato dai
fratelli di Calabria e Sicilia. Hanno moltiplicato il numero di logge per
contrastare la mia elezione». Più articolato il discorso di Venzi. In
commissione antimafia il Gran Maestro con maggiore anzianità in circolazione (è
stato eletto nel 2001 a 39 anni) ha dichiarato: «Bisogna verificare gli ambienti
di Rotary, Lions e Kiwanis, dove massoni regolari e irregolari si incontrano. La
’ndrangheta sceglie le obbedienze spurie piuttosto che sopportare le nostre
riunioni a carattere filosofico-culturale». Il presidente Bindi ha colto
l’assist e ha replicato: «Questa è gente che si fa anni di galera. Si figuri se
si spaventano per una conferenza». Ma il tema della cinghia di trasmissione fra
massoneria ufficiale, non ufficiale e associazioni paramassoniche non è da
trascurare. Nel tempio, come sostiene Venzi, «un fratello non mi deve sbagliare
una deambulazione». Vietatissimo parlare d’affari. In una cena al Rotary è
diverso. Non si portano guanti e grembiule. L’ambiente è più informale. E il
Venerabile o gli Ispettori Magistrali non sorvegliano. Più problematico è il
ragionamento sulle massonerie irregolari. Che ci sia una proliferazione è
indiscutibile. Basta navigare mezz’ora sul web per essere sommersi da sigle
mistiche rette da Gran Commendatori e Supremi Sovrani, in un’orgia di
abbreviazioni che ricorda le targhe sulla porta dei direttori galattici nei film
di Fantozzi. È vero che per creare un’associazione massonica bastano cinque
minuti, sette persone un notaio. Ma poi? Aldo Alessandro Mola, storico di
riferimento della massoneria in Italia, risponde: «Non vedo quale interesse
potrebbe avere la ’ndrangheta a inserirsi in logge massoniche spurie che non
hanno contatti su base nazionale o internazionale con le obbedienze regolari.
Anche quando si parla di P2, se ne parla in modo inesatto. La P2 non era affatto
una loggia coperta. Era una loggia speciale affiliata al Goi con tre
caratteristiche. Primo: l’iniziazione non avveniva in loggia. Secondo: non c’era
diritto di visita ossia altri fratelli non potevano visitare la loggia. Terzo:
non c’era obbligo di riunioni. Infatti la P2 non si è mai riunita. La loggia di
Gelli era una replica della Propaganda massonica, costituita nel 1877 come
vetrina e fiore all’occhiello del Goi tanto che i fratelli erano dispensati dal
pagare le quote. Anche la P2 aveva capitazioni ridicole. Il cantante Claudio
Villa versava 2 mila lire all’anno e lo scrittore Roberto Gervaso 60 mila. Erano
somme piccole anche negli anni Settanta».
La giustizia interna alla massoneria, esercitata
in parallelo con quella dello Stato o “profana”, è un tema chiave dello scontro.
Per quanto i giuramenti sulle costituzioni dei liberi muratori siano abbinati
alla dichiarazione di fedeltà alla Costituzione della Repubblica e alla
presentazione di certificati giudiziari e di carichi pendenti, l’indulgenza
della giustizia massonica è un dato di fatto. Il timore è che questa
inclinazione al perdonismo si estenda alle aule dei tribunali ordinari quando un
fratello giudica un fratello o alle commissioni parlamentari quando un fratello
scrive una legge che può favorire altri fratelli. Anche su questo i Gran
Maestri, alle domande di Rosy Bindi, hanno dato una risposta compatta: nelle
logge non ci sono magistrati, che non possono starci pena censura del Csm, e non
ci sono parlamentari. Dipendenti pubblici sì, militari sì, professionisti in
abbondanza e persino qualche sacerdote, ma nessuna traccia degli oltre 100
deputati e senatori che furono trovati negli elenchi della P2.
E i santisti? Mai sentiti nominare, hanno risposto
compatti i Gran maestri a proposito degli esponenti riservati del crimine
organizzato. Nemmeno del progetto separatista al Sud, durante la transizione fra
Prima e Seconda Repubblica, si è parlato direttamente nell’aula della
Commissione a palazzo San Macuto. Se ne stanno occupando i magistrati fra
Sicilia e Calabria tirando le fila di una tradizione che inizia con il massone
Andrea Finocchiaro Aprile, antifascista e leader indipendentista, figlio di
Camillo, carbonaro, massone e ministro del Regno. Anche sui picciotti ordinari
di Cosa nostra e ’ndrangheta la giustizia massonica è stata piuttosto pigra. A
fronte dell’emergenza mafiosa, Raffi e Binni hanno demolito in 17 anni tre logge
nel reggino (Caulonia, Brancaleone, Gerace) e una nel Lazio, per insufficienza
di iscritti. Un altro caso è significativo. Nel 1992, mentre reggeva il Goi, Di
Bernardo ha abbattuto la Rispettabile Loggia Colosseum di Roma, creata
nell’immediato dopoguerra per accogliere gli agenti della Cia operativi in
Italia. Il più noto era Frank Gigliotti, calabrese emigrato negli States. Anche
Binni ha chiuso alcune logge degli Alam in Sicilia, per questioni
amministrative: non pagavano le quote in polemica con il Gran Maestro. È un
bilancio striminzito e, in materia di giustizia massonica, Di Bernardo ha
confermato all’Antimafia che la condanna è un caso straordinario. In genere, si
censura, magari si sospende. «Alla fine, tutti assolti». Le due eccezioni note
sono quelle di Gelli, cacciato dopo lo scandalo P2 con un processo giudicato
sommario e scorretto dallo stesso Di Bernardo, e Amerigo Minnicelli da Rossano
(Cosenza), promotore di una lettera a Raffi nell’ottobre 2011 dopo l’inchiesta
penale Decollo Money (riciclaggio e narcotraffico fra Italia e San Marino), che
coinvolgeva l’imprenditore massone calabrese residente in Umbria Domenico Macrì.
A fine gennaio Minnicelli ha consegnato all’Antimafia la lettera, firmata da
altri trenta fratelli dissidenti rispetto alla gestione del numero uno regionale
Marcello Colloca. L’Espresso ha potuto leggerla. Nella lista delle richieste a
Raffi, che includono la consegna delle liste alla Direzione distrettuale
antimafia, risalta il punto 3: «Non accada che i fratelli vengano “risvegliati”
in Orienti diversi da quelli di loro provenienza». Tradotto in linguaggio
profano, si sottolinea la fluidità eccessiva nei passaggi da una loggia
all’altra di iniziati che hanno avuto problemi con la giustizia ordinaria o
massonica. Né è pensabile che gli agenti segreti della Colosseum si siano
iscritti alla bocciofila di quartiere dopo l’abbattimento della loggia da parte
di Di Bernardo. L’ex Gran maestro del Goi e della Gran loggia regolare d’Italia,
unica riconosciuta dalla Gran Loggia Madre di Inghilterra fondata tre secoli fa
(1717), è uno dei quattro testimoni-chiave della Procura di Reggio Calabria,
guidata da Federico Cafiero de Raho, nella sua inchiesta per associazione
segreta ribattezzata Gotha dopo l’unificazione di cinque procedimenti (Fata
Morgana, Araba Fenice, Sistema Reggio, Rhegion e Mammasantissima). Gli altri
quattro sono tre collaboratori di giustizia siciliani: Tullio Cannella,
Gioacchino Pennino e Antonio Calvaruso, che ha indicato il boss Leoluca
Bagarella come uno dei pochissimi in Cosa nostra a conoscere la componente
apicale segreta, e unificata, del crimine calabro-siculo infiltrato nei templi
dei liberi muratori. Di Bernardo, 76 anni, è stato pubblicamente criticato dal
successore Venzi per non avere tentato di ripulire il Goi dall’interno. Di
sicuro ha molto da rievocare dei suoi 55 anni di militanza frammassonica. Ne ha
dato prova all’antimafia parlando di un fallito traffico d’armi con il
presidente del Togo, che al tempo era Gnassingbé Eyadéma, massone come molti
leader della cosiddetta Françafrique. Il business sarebbe stato gestito dal suo
predecessore alla guida del Goi. In audizione Di Bernardo non lo ha mai nominato
ma è Armando Corona, il professionista cagliaritano chiamato a guidare il Grande
Oriente dopo lo scandalo P2. Corona è scomparso nel 2009, quattro anni dopo
Eyadéma. Ma i Fratelli d’Italia sono spesso coltelli, da vivi e da morti.
Nudo accanto allo scheletro: i riti della
massoneria "hard". Un pentito racconta l'iniziazione
da affrontare per entrare nella superloggia, scrive Gianfranco Turano il 21
settembre 2016 su "L'Espresso". Finora l'ammissione in loggia era stata svelata
ai profani dal film “Un borghese piccolo piccolo” di Mario Monicelli con il
Venerabile Romolo Valli che accoglie fra le colonne di Jachin e Boaz un Alberto
Sordi voglioso di carriera. Ma il personaggio di Sordi è un semplice
apprendista. Il superpentito Cosimo Virgiglio ha raccontato ai magistrati
reggini un rito “molto duro”, chiamato “penta” perché riservato a cinque persone
e dedicato a un grado iniziatico superiore. Nel verbale del 29 aprile 2015,
ancora in larga parte riservato, Virgiglio parla di un personaggio, il cui nome
è coperto da omissis, che ha il compito di sovrintendere al cerimoniale segreto
e occupa le cariche di Gran maestro del Grande Oriente di San Marino e di
Venerabile della loggia Montecarlo, madre di tutte le logge coperte. I cinque
candidati pensano a una semplice formalità. È l’inizio di un’ordalia. «Vengono
arrestati», racconta il pentito, «all’ingresso della dogana, si chiama così.
Tutti belli pimpanti, ridono. Di colpo, pum, vengono bloccati e messi nel
furgone al buio». Il Venerabile «si permetteva il lusso di farli morire al mondo
profano perché il rito di iniziazione è molto duro. Lui si permetteva di farli
morire al mondo profano nella Rocca di San Leo, la Rocca di San Marino».
Virgiglio si riferisce alla Rocca o Forte di San Leo, antica capitale del ducato
di Montefeltro che si trova circa 5 chilometri a ovest del territorio del Titano
ma ancora in provincia di Rimini. La Rocca ha un particolare significato per il
rito massonico perché le sue segrete hanno ospitato Giuseppe Balsamo conte di
Cagliostro, frammassone e avventuriero settecentesco di fama internazionale. «Io
l’ho vissuto», continua Virgiglio parlando del penta, «Non lì. Io l’ho vissuto a
Vibo e ho fatto sette ore, seminudo con lo scheletro a fianco e una luce. Lì fai
testamento». Il pubblico ministero che interroga, Giuseppe Lombardo della
direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, chiede se si tratti di uno
scheletro vero. La risposta è affermativa. Come nel Borghese piccolo piccolo, la
commedia all’italiana lascia presto il posto al dramma. Nel racconto di
Virgiglio emergono i motivi che impongono ai livelli più riservati
dell’associazione segreta tali durezze con chi deve “morire al mondo profano”.
Virgiglio spiega al magistrato: «Per farle capire come materialmente è avvenuta
l’interrelazione tra la componente massonica e quella tipicamente criminale, il
varco, che nel gergo massonico è riferito alla breccia di Porta Pia, è
costituito da quella nuova figura criminale che è identificata con la Santa.
Attraverso quel varco, costituito dai santisti che sono rappresentati da
soggetti insospettabili, il mondo massonico entra nella ’ndrangheta e non
viceversa. Il ruolo di santista all’interno della ’ndrangheta non consente in
automatico il contatto con la massoneria. È necessario che si individuino
ulteriori soggetti-cerniera, in giacca, cravatta e laurea». Virgiglio delinea il
doppio scopo strategico della nuova formazione. «Il sistema allargato aveva come
obiettivo finale quello di garantire alla componente massonica, fortemente
politicizzata, la gestione dei flussi elettorali. La componente di ’ndrangheta
mirava al consolidamento dei capitali sporchi che andavano ricollocati sul
mercato anche estero mediante strumenti finanziari evoluti». Virgiglio descrive
per diretta conoscenza la struttura massonica calabrese grazie al «mio ruolo
qualificato all’interno della Loggia dei due mondi di Reggio di cui detenevo il
“maglietto pulito”; esiste il cosiddetto “maglietto sporco o occulto” che
costituisce quell’ambito riservato o invisibile della stessa componente
massonica; di tale contesto facevano parte numerosi soggetti collegati
all’ambiente criminale di tipo mafioso che per evidenti ragioni non potevano
essere inseriti nelle logge regolari ovvero nella parte visibile». Questi nomi
sono ancora segreti, tranne uno che non è più perseguibile. Appartiene
all’inventore della massoneria segreta italiana, morto a 96 anni nel suo letto
alla fine del 2015. Licio Gelli, chi altri?
E poi c’è quello che non ti
aspetti.
AFFARI DEI TEMPLARI
LEGHISTI.
Affari dei Templari leghisti.
Appalti dei Gran Maestri. Contratti con Asl, Pirellone, Comune di Brescia oltre
ai ruoli nel partito: così la Suprema Militia piazza parenti e amici, scrive
Leonardo Piccini su “Libero Quotidiano”. Chi sono e, soprattutto, quali sono gli
scopi che si sono prefissati gli adepti alla organizzazione templare attiva in
Lombardia e in tutta Italia, detta la “Suprema Militia”, composta come abbiamo
visto nella prima puntata da uomini politici, prefetti, imprenditori? Persone
decise ad assumere le vesti di epigoni del gran maestro Jacques de Molay,
seguaci di quei cavalieri dispersi nel quattordicesimo secolo dalle persecuzioni
dal Papa e dal re di Francia. A colpire sono soprattutto le implicazioni di
rapporti cementati dall’appartenenza a un ambiente iniziatico ed esclusivo tra
esponenti della pubblica amministrazione, della politica, dell’economia. In
teoria questa “Suprema Militia Equitum Christi” dovrebbe promuovere un percorso,
per i suoi adepti che assomiglia molto a un lavoro iniziatico di conoscenza e di
approfondimento dei temi principali dell’esistenza, da perseguire mediante la
carità, la beneficenza, il servizio ai diseredati. Ma al suo interno si trovano
affiliati che si occupano di questioni molto mondane e pratiche: consulenze
professionali, incarichi pubblici, politica, imprese, strategie delle
multiutility lombarde. Senza contare poi la presenza di chi, per dovere
istituzionale, è chiamato a rappresentare lo Stato, non ultimo, il prefetto di
Pesaro e Urbino, Attilio Visconti, pronto a vestire i panni di cerimoniere e a
occuparsi della formazione degli adepti e dei novizi di una cupola riservata.
Ieri Visconti ha spiegato: «Ma quale loggia massonica o associazione segreta: la
Suprema Militia Equitum Christi è una onlus che fa beneficenza, non politica.
Non ha legami con la Lega, ed elenco degli iscritti e bilanci sono pubblici».
Visconti s’è detto «onorato di far parte di questa associazione». Fatto sta che
insieme a lui ci sono altri esponenti delle istituzioni, come il vicesindaco di
Brescia Fabio Rolfi, l’assessore regionale Monica Rizzi, e il dirigente comunale
Marco Antonio Colosio, l’ex consigliere regionale e, ora, vicepresidente
dell’Aler bresciana, Corrado Della Torre. E che dire poi della presenza, in un
gruppo di duri e puri del cattolicesimo più intransigente, di un massone, come
Marco Belardi, il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia, in forza
alla Glri, la Gran Loggia Regolare d’Italia? A suscitare interrogativi è questo
mix di rapporti e interessi profani e spirituali, trattati all’ombra di un
gruppo coperto e lontano da occhi e orecchie indiscrete. È forse in virtù della
comune militanza templare con il vicesindaco leghista, che l’ingegnere Belardi
ottiene consulenze ben retribuite dal Comune di Brescia? Nel marzo del 2010, la
sua società, la “Intertecnica Group” si vede assegnare un incarico per la
ristrutturazione di impianti idrotermo-sanitari di una proprietà comunale;
mentre nell’aprile del 2011, sempre la sua “Intertecnica” si aggiudica un
incarico di progettazione e direzione lavori nell’area archeologica cittadina
del Capitolium. Il vicesindaco Rolfi, da qualche mese anche segretario
provinciale della Lega Nord, è censito come cavaliere dell’ordine templare già
nel 2009 nella “Commanderia San Gottardo” di Brescia; almeno dallo stesso
periodo risulta aver incrociato, a San Gottardo, proprio il “novizio” Marco
Belardi, che proprio dall’ottobre del 2009 si insedia nella posizione delicata e
prestigiosa di presidente dell’Ordine degli Ingegneri. È forse grazie a questa
consorteria così profondamente annidata nel cuore della Lega Nord che Fabio
Rolfi, fallito il primo tentativo di sistemare la moglie Silvia Raineri
attraverso un concorso pubblico indetto dalla provincia di Brescia, la piazza
all’Asl di Milano? Il concorso della provincia di Brescia aveva suscitato un
clamore nazionale, perché delle sei vincitrici ben cinque erano leghiste e
parenti di esponenti politici leghisti di primo piano del bresciano. Un tale
clamore da rendere necessaria una commissione d’inchiesta e da indurre il
presidente della provincia Molgora, pure leghista ma estraneo all’ambiente di
Rolfi e dei cavalieri, a congelare le assunzioni. Così Rolfi si rivolge prima al
gruppo leghista in regione Lombardia, che conferisce a Silvia Raineri un
incarico, poi al leghista Giacomo Walter Locatelli, potente direttore generale
dell’Asl di Milano: la Rainieri si piazza diciottesima in un concorso per
l’assunzione di un solo impiegato, ma viene ugualmente assunta; si dimette
dall’incarico in Regione, prende possesso dell’impiego all’Asl, ottiene
immediatamente dal direttore generale un’aspettativa e riassume il suo incarico
in Regione. C’è poi chi fa notare certe coincidenze: recentemente eletto alla
carica di segretario provinciale della Lega Nord, Rolfi affronta il nodo di
Montichiari, importante comune della provincia in cui la Lega governa dagli anni
90 e dove ha sofferto, in occasione delle ultime elezioni, una secessione che ha
portato fuori dal partito tutto il gruppo dirigente locale, compreso sindaco e
vicesindaco. Dopo anni la spaccatura viene ricucita e l’incarico di commissario
della sezione leghista di Montichiari, tutt’ora percorsa da forti tensioni, va a
Corrado Della Torre, il Grand Commandeur dei cavalieri di San Gottardo dei quali
fa parte lo stesso Rolfi. Quel Della Torre che, intervistato da Marta Calcagno,
su il Giornale del 09/10/2010, dichiarava che «nell’Ordine dei Templari ci sono
vari gradi di cavalleria, che sono immutabili dal 1100. C’è una composizione
sociale varia: dal generale dei carabinieri, a professionisti di diversi
livelli, sino ad imprenditori e industriali». A San Gottardo non mancava mai un
altro abitué del Tempio, il prefetto Attilio Visconti: nato a Benevento il 21
ottobre del 1961, per due anni, dal 1990 al 1992, presta servizio nel Comitato
Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza (Cesis). Nel 2006 è
trasferito alla Prefettura di Brescia, dove gli viene conferito l’incarico di
Capo di Gabinetto. Nel 2007 è chiamato a svolgere il ruolo di commissario
straordinario per i Comuni di Offlaga, Travagliato e Borno. Il 12 dicembre del
2007 è nominato viceprefetto Vicario di Brescia. Nel giugno del 2008 è nominato
commissario prefettizio del comune di Edolo (il paese di Bruno Caparini, il Gran
Baylo dell’ordine templare in cui milita lo stesso Visconti). Poi l’incarico di
viceprefetto vicario a Torino, l’arrivo a Caserta e la tanto agognata nomina a
Prefetto di Urbino. In molti di questi incarichi, soprattutto in quelli di
commissario prefettizio in comuni bresciani, Visconti è sempre accompagnato da
due giovani leghisti: il fido Marco Antonio Colosio, presente nell’elenco dei
templari bresciani, e l’architetto Franco Claretti, oggi sindaco leghista di
Coccaglio, un paesone del bresciano. E l’amministrazione comunale di Brescia,
in cui Fabio Rolfi è vicesindaco e dominatore assoluto, nomina entrambi
dirigenti fin dal debutto della giunta di centrodestra. Il capo del gruppo
lombardo è Bruno Caparini, cofondatore assieme a Bossi della Lega e attuale
membro del consiglio di sorveglianza di A2A. Di lui, fino a poco tempo fa,
Monica Rizzi, assessore regionale allo Sport (una adepta della loggia templare
fino all’anno scorso, espulsa, forse, per la vicenda della finta laurea in
psicologia, più credibilmente per incompatibilità con l’ambiente e gli altri
cavalieri leghisti, ormai di stretta osservanza maroniana), conservava una foto
in assessorato: abito nero con mantello bianco e croce templare rossa sul cuore,
spada Carlo V e decorazione dell’ordine appesa al collo.
PARLIAMO DI MASSONERIA, MAFIA, FINANZA E
MAGISTRATURA.
Tanto si è detto sull'origine della massoneria,
scrive Alessandro Olimpo. Chi la vuole sorta seimila anni fa in uno sconosciuto
angolo della terra, chi ne semplifica la genesi alla storica data del 1717,
ognuno ha un'idea diversa, un'immagine confusa dell'antica fratellanza. Il
filosofo J.G.Fichte, uno dei maggiori rappresentanti dell'idealismo, affrontava
la questione e scrisse. "….nei primi decenni del secolo XVIII, precisamente in
Londra, si presenta in pubblico una società, che verosimilmente era sorta ancor
prima, ma della quale nessuno sa dire donde venga, che cosa sia e che cosa
voglia. Essa si propaga,nonostante ciò, con rapidità inconcepibile, e si
diffonde attraverso la Francia e la Germania in tutti gli stati dell'Europa
cristiana, e perfino in America. Uomini di tutte le classi, reggenti, principi,
nobili, dotti, artisti, commercianti, entrano nella sua cerchia. Cattolici,
luterani e calvinisti si fanno iniziare e si fanno chiamare fratelli." Ma per
capire a fondo le origini della massoneria non saranno sufficienti date e
luoghi. Fin dalle più remote antichità due contrastanti tendenze apparirono tra
gli uomini: idealismo e materialismo. Fin dai primordi il genere umano si è
diviso in due tipi di individui che assecondavano, ciascuno per la sua, tali
opposte tendenze. Da una parte c'erano coloro i cui interessi erano volti
unicamente al soddisfacimento dei propri bisogni terreni: cibo, sesso, ecc…,
dall'altra si distinguevano menti più raffinate che ricercavano le motivazioni
dell'esistenza, indagavano sui misteri della vita e dell'universo. Per meglio
comprendere immaginiamo per un istante di trovarci presso un'antica tribù
primitiva. Il tran-tran giornaliero poteva essere il procacciamento del cibo, la
conquista delle donne più appetibili, la difesa dagli aggressori, fossero essi
animali o altri uomini, la protezione dalle calamità naturali e così via.
Contemporaneamente altri uomini più dotati intellettivamente, pensavano a
soluzioni diverse e dal pensiero scaturivano le scoperte che conducevano il clan
verso una vita più qualificata. Non c'era campo che questi filosofi non osassero
investigare, ivi compreso quello del cosiddetto sapere divino. Nacque così la
scienza e ad opera di tali uomini nacque l'arte. Scienza ed arte, fusi in un
unico ordine di sapere, divennero il patrimonio di questi "diversi" il cui
potere conoscitivo era grande ma nello stesso tempo, e proprio per questo,
invidiato e quindi insidiato dai guerrieri e dai capi delle società dell'epoca.
La difesa contro questi ultimi era quella di coalizzarsi e di difendere la
conoscenza faticosamente acquisita, e trasmessa ai discepoli ritenuti adatti, al
fine di evitarne utilizzazioni improprie da parte degli indegni. La frattura fra
il bene e il male , fra potere sacro e potere profano, fra i filosofi e i
politici era ormai insanabile. La conoscenza filosofica è potere reale in senso
assoluto e mai deve cadere nelle mani di coloro che ne approfitterebbero per
perseguire i loro fini personali e materiali a danno dell'evoluzione
dell'umanità. Da queste premesse è facile dedurre il perché dell'origine delle
fratellanze iniziatiche. I sacerdoti di Iside e di Osiride per lungo tempo, la
comunità degli Esseni, gli Orfici, i Pitagorici, i primi cristiani e quindi i
più recenti Templari, i Fedeli d'Amore, gli alchimisti,i Rosacroce e tanti
altri,in ultimo la massoneria che da tutti costoro ha raccolto l'eredità morale
e di pensiero, sono le società che hanno conservato nei loro templi il sapere
dei millenni. L'evoluzione del pensiero è sempre associata a forti idee di
personaggi in qualche maniera legati a culture esoteriche. Gli Esseni in
Palestina, da cui probabilmente è sorto il cristianesimo che tanto ha prodotto
in termini di crescita sociale dell'umanità;le scuole filosofiche di Pitagora
prima e di Platone poi, lo stesso Dante Alighieri, membro della setta dei Fedeli
d'amore, ma anche accreditato di appartenenza all'Ordine Templare; bacone,
Newton, Goethe e tanti altri, noti per aver fatto parte di società segrete,
quali i Rosacroce e la massoneria, tutto questo lascia intendere che la cultura
storica è in parte carente laddove si voglia interpretare il ruolo delle società
misteriche nel tessuto portante della storia. Se poi si voglia sapere quando la
massoneria ha assunto la forma attuale con le odierne costituzioni ed i moderni
rituali, allora bisogna riandare alle corporazioni di mestiere medioevali e
risalire alla distruzione dell'Ordine del Tempio.
Fondato nel 1119 con il compito di difendere la
terra santa, quest'ordine religioso-militare - voluto da Ugo de Payns, primo
gran maestro e appoggiato da Bernardo da Chiaravalle, monaco, dottore della
chiesa e santo - conservava nel suo seno le dottrine segrete dell'iniziazione a
cui venivano ammessi solo i cavalieri meritevoli sotto il duplice aspetto della
morale e del desiderio di conoscenza.
Non si conoscono esattamente le interrelazioni e i
metodi di interscambio culturale che legavano tali potenti cavalieri ai vari
monasteri ed alle suddette corporazioni di mestiere, fatto è che al loro tempo
fiorirono nuovi stimoli interiori, nacque dal nulla una nuova forma
architettonica, il gotico, che meravigliò il mondo intero.
Tutto ciò non poteva durare. Le leggi
dell'ignoranza e della superstizione, dell'egoismo e della malafede, prevalsero
di nuovo sul buon senso e sulla giustizia. L'ingordo Filippo il Bello ed il papa
Clemente V determinarono la fine del Tempio nel 1311. Jacques de Molays, gran
maestro, e cinquantaquattro cavalieri vennero condannati al rogo. Il resto
dell'Ordine fu disperso. Ma i cavalieri del Tempio non cessarono la loro
attività iniziatica. Dispersi ai quattro angoli della terra si rifugiarono
presso le logge dei liberi muratori germanici, scozzesi e dovunque il pensiero
libero e la ricerca pura fossero i benvenuti. In Portogallo nacque l'Ordine del
Cristo, in Scozia l'Ordine del Credo. Continuarono così a lavorare nell'ombra
sino alla costituzione dell'Ordine dei Templari nel XVIII secolo: Così
presumibilmente nacque la massoneria medievale, madre della massoneria moderna.
Il 24 giugno 1717 i maestri delle quattro logge londinesi si incontrarono con
alcuni rappresentanti della misteriosissima fratellanza della Rosacroce. Questi,
perseguitati, chiesero alla fratellanza dei Liberi e Accettati muratori di
entrare a far parte dell'Ordine. Così nasceva, in un albergo di Charles Street
(che in seguito fu la sede della prima Gran Loggia d'Inghilterra) la
frammassoneria moderna, decisa a combattere in campo aperto per la libertà di
pensiero, di indagine, di coscienza, per la fratellanza universale, per il
progresso, per la riconquista della dignità della persona umana. Subito molti
Ordini misterici riapparvero in Europa come per incanto e quasi tutti entrarono
a far parte della massoneria. Nobiltà, clero, scienziati, filosofi, artisti,
commercianti: tutti chiedono di essere iniziati all'Arte Reale. " Quando i
governi dispotici si allarmarono era ormai tardi. La reazione non potè arrestare
la valanga che li avrebbe travolti. Il Contratto Sociale veniva discusso e
commentato dovunque; l'agitazione cresceva, si parlava ormai apertamente dei
Diritti dell'Uomo e finalmente scoppiava la Rivoluzione Francese." Ricordiamo
ancora la Rivoluzione americana e la Carboneria italiana la cui ispirazione
massonica è nota a tutti,non sono che pochi esempi dell'influsso delle idee
muratorie sul mondo "profano", ma che servono a far meglio conoscere la capacità
morale di quella fucina del libero pensiero che era la libera muratoria.
Già nell'analisi delle origini appaiono ben chiari
gli scopi della massoneria.
- La "Dichiarazione dei principi" approvati dal
convento dei supremi consigli confederati riuniti a Losanna nel settembre 1875:
la massoneria.
- "…non impone alcun limite alla ricerca della
verità, ed è per garantire a tutti questa libertà che esige da tutti la
tolleranza."
- …"accoglie qualunque profano senza preoccuparsi
di conoscere quali siano le sue opinioni politiche e religiose, purchè esso sia
libero e di buoni costumi."
- "… ha per scopo di lottare contro l'ignoranza
sotto tutte le sue forme; è una scuola scambievole, il cui programma si riassume
in questi punti: obbedire alle leggi del proprio paese, vivere secondo l'onore,
praticare la giustizia, amare i propri simili, lavorare senza posa al bene
dell'umanità e perseguire la sua emancipazione progressiva e pacifica."
- " per innalzare l'uomo ai propri occhi, per
renderlo degno della missione sulla terra, la Massoneria pone come principio che
il Creatore supremo ha dato all'uomo, come il bene più prezioso, la libertà: la
libertà, patrimonio dell'umanità tutta intera, raggio così luminoso che nessun
potere ha diritto di spegnere o di offuscare e che è la fonte di ogni sentimento
d'onore e di dignità".
La prefazione degli Statuti Generali delle società
dei Liberi Muratori del Rito Scozzese Antico ed Accettato,ristampa del 1874:
" Quella unione di uomini saggi e virtuosi, che,
con allegorico significato, si appella ordinariamente Società dei Liberi
Muratori,è stata in ogni tempo considerata come il Santuario dei buoni costumi,
l'asilo dell'innocenza, la scuola della virtù, il tempio della filantropia".
" …ha per fine il perfezionamento del cuore umano;
e si propone, qual mezzo necessario per ottenere questo fine, l'esercizio e la
pratica delle virtù."
" Il Fratello Libero Muratore deve per necessità
essere uomo probo, sobrio, onesto e virtuosamente benefico. Chi non possiede
queste necessarie doti non può affatto aspirare al merito di poter far parte di
questa unione di saggi."
Ci sembra utile riportare le tesi del già citato
Fichte: "…poiché il fine dell'esistenza è quello di chiarire il senso della vita
alla luce dell'eternità, questa società offre all'essere ragionante il massimo
di luce; di conseguenza, lo scopo della cultura umana è contemporaneamente
quello della cultura massonica; questo fine verrebbe meno se tale cultura non
sopprimesse i contrasti della divisione del lavoro e se non trasformasse in
cultura universale le pluralità delle classi sociali; la sua azione nel mondo
trae origine dall'influsso reciproco di tali classi; la massoneria non è fine a
se stessa più che la Chiesa; dando alla religione una "educazione massonica", se
ne svincola il concetto di universalità; la massoneria libera l'uomo
dall'aspetto falsamente universale della sua religione; questo stesso uomo cessa
di essere religioso, ma pensa e agisce religiosamente; lo scopo politico della
massoneria è identico al suo scopo spirituale, perché unisce il patriottismo al
cosmopolitismo; in tutto questo la massoneria è l'erede della cultura segreta
dell'umanità, perché sempre sono esistiti uomini pronti a notare i difetti della
società della loro epoca, e a gettare il seme per il futuro."
Citiamo infine la voce ufficiale della massoneria
italiana.
"Quando si parla di Massoneria si suole
identificarla come Ordine, ed, invero, le sue origini radicate nelle
corporazioni dei Liberi Muratori si ricollegano ad una serie di livelli
operativi quali Apprendista, Compagno, Maestro perfettamente sovraordinati l'uno
all'altro e regolati da norme liberamente accettate da tutti gli adepti e perciò
ancor più vincolanti che se fossero imposte. Tali norme consentono di
conquistare progressivamente una sempre più profonda conoscenza di se stessi e
di accostarsi alla verità ed alla perfezione rendendo così il Massone idoneo a
svolgere il suo compito filantropico di operare per il bene ed il progresso
dell'Umanità. Questa metodologia affascinò uomini delle più diverse condizioni
accostandoli l'un l'altro in un'ansia di ricerca che aboliva ogni differenza
sociale ed economica creando viceversa un vincolo profondo che si rafforzava via
via che gli adepti acquistavano sempre maggiore coscienza della comune origine
dal suolo italico e della missione unificatrice delle sue genti che essi
assumevano.
Il “Gioco Grande”. Il mezzo secolo di intrecci
tra massoneria deviata, mafia e servizi segreti deviati che ha sconvolto
l’Italia.
Dallo sbarco degli Alleati in
Sicilia alle stragi di Capaci e via D’Amelio, il panorama italiano è stato
governato da accordi tra mafia, massoneria e servizi segreti italiani e
americani, scrive
Gea Ceccarelli.
All’inizio del ’900, circa un milione di siciliani abbandonò le proprie terre
per trasferirsi negli States, in special modo a
New York, città che, già dal 1870, era legata a
Palermo grazie al commercio di
agrumi. In mezzo alle centinaia di migliaia di emigranti, vi furono molti
“uomini d’onore” che nella Grande Mela trovarono terreno fertile per le proprie
attività delinquenziali; in particolar modo il traffico dei prodotti commerciali
divenne una prerogativa italiana, le banchine dei porti di New York parlavano
siciliano. Per decenni Cosa Nostra
in America regnò indisturbata, il
gangsterismo si configurò come una potenza occulta e feroce, in
rapida crescita, mentre, in Sicilia, le famiglie d’onore venivano tartassate dal
regime di Mussolini e
vivevano in uno stato di profonda crisi in concomitanza della
Seconda Guerra Mondiale. E
proprio in questo contesto vi fu il primo vero e documentato approccio del
governo americano alla mafia. Il 9 febbraio 1942, infatti, un ex transatlantico
trasformato in unità di trasporto truppe, la Normandie, prese misteriosamente
fuoco e si capovolse alle foci dell’Hudson. Subito si pensò che si fosse
trattato di un sabotaggio e i primi ad essere additati come colpevoli furono gli
italo-americani di New York. Per far luce sull’incidente, dunque, la
Marina degli Stati Uniti decise
di entrare in contatto con la mafia che controllava i docks del porto. Così, su
raccomandazione di due boss, Joseph Socks Lanza e Meyer “Little Man” Lansky, gli
ufficiali dell’US Navy contattarono
Charles Lucky Luciano, già in carcere. Lui, considerato il padre
moderno del crimine organizzato, primo boss ufficiale della famiglia Genovese,
dall’alto del suo potere, era in grado di cambiare le sorti della guerra. E
così, spinto dal patriottismo e dalla solidarietà verso i “cugini” mafiosi
siciliani, vessati da Mussolini, Luciano decise di collaborare con le autorità e
fece in modo che i porti newyorkesi si schierassero dalla parte degli Alleati.
Un aiuto incredibile, grazie cui gli americani si resero effettivamente conto di
quanto fosse importante avere dalla propria parte la mafia. Per questo, durante
la preparazione dell’Operazione Husky,
decisero di rivolgersi nuovamente a Luciano, stavolta tramite l’Oss,
l’Office of Strategic Service, precursore della più nota
Cia. Luciano, in cambio della
grazia, mise in moto una serie di trattative che si videro compiute il 10 luglio
del 1943, quando gli americani sbarcarono sulla costa sud della Sicilia. Lì
trovarono un terreno favorevole per l’occupazione, proprio grazie alle famiglie
mafiose contattate da Cosa Nostra Americana. Nel frattempo, l’agente Max Corvo,
diretto referente di Allen Dulles,
alto funzionario dell’Oss, formò un’unità militare denominata
“the mafia circle”, grazie alle raccomandazioni di
Luciano: tra i contatti “celebri” si contavano personalità quali il boss
Vito Genovese e i finanzieri
Michele Sindona e Licio Gelli.
Grazie al loro contributo, i servizi segreti americani riuscirono a
raggiungere le prigioni siciliane e liberarono circa 850 mafiosi per arruolarli.
Una volta terminata la guerra, nella sola provincia di Palermo, almeno 62 di
essi vennero nominati sindaci. Il legame con Luciano, nello spaccato della
Seconda Guerra Mondiale, non fu certo l’unico ambiguo, per Dulles.
Nello stesso periodo, infatti, l’alto funzionario
mantenne contatti anche con il generale delle SS,
Karl Wolff, che comandava i
contingenti della Gestapo in Italia. Un rapporto scottante, che si vide compiuto
nei negoziati dell’Operazione Sunrise.
In base ad essi, le forze naziste sarebbero state “graziate” dagli americani, in
cambio del loro appoggio nella battaglia pre-pianificata atta a sconfiggere la
minaccia sovietica. Cioè la Guerra
Fredda. Al tempo stesso, per permettere ai nazisti di salvarsi,
Dulles consigliò a Wolff di avvalersi delle “ratlines”, le vie di fuga del
Vaticano. Quelle stesse vie che furono poi utilizzate da Cosa Nostra, negli anni
’80, per il contrabbando di droga in America, l’ormai celebre operazione
“Pizza Connection” su cui
indagò anche Falcone. Non deve sorprendere l’affinità della Santa Sede con la
Cia: molti illustri membri dell’agenzia segreta americana erano anche Cavalieri
dello Smom, meglio conosciuto come
Ordine dei Cavalieri di Malta, da sempre ritenuto il braccio
armato del Vaticano. Fu così che, in nome degli accordi presi con gli Usa, gli
ormai ex nazisti si spostarono tutti verso l’America
Latina, laddove combatterono la minaccia comunista, allestendo
di fatto il terreno per la Guerra Fredda. Non molto diverso fu il panorama in
Europa, in cui il
lavoro preparatorio aveva stabilito di rovesciare o contrastare i governi eletti
democraticamente attraverso una rete di “unità
Stay Behind”equipaggiata con uomini fascisti, in Italia
organizzata sotto l’egida dell’Operazione
Gladio, voluta prevalentemente dalla Nato.
Nel nostro paese, la Gladio venne costituita il 26
novembre del 1956, con un protocollo di intesa tra servizi segreti italiani e
americani. Si trattava di un’organizzazione atta a bloccare qualsivoglia
invasione sovietica nel Paese.
Nel 1972, questa struttura, che sorse in
Sicilia, si collegò
indissolubilmente al Sid
di Vito Miceli. Erano
gli anni in cui Gladio iniziava a potenziarsi: nascevano nuclei indipendenti,
tra cui quello della neofascista Rosa
dei Venti, coinvolto in numerosi atti eversivi, non in ultimo il
celebre “Golpe Borghese”.
Il primo a parlare di Gladio fu l’ex terrorista
Vincenzo Vinciguerra, accusato della strage di Peteano.
Nel 1984, all’interno del processo della
strage di Bologna, l’uomo parlò
apertamente di una struttura occulta nelle forze armate italiane, che era stata
in grado di coordinare le varie stragi per evitare che il paese si spostasse
troppo a sinistra; questo, sempre secondo la testimonianza dell’ex terrorista, a
nome della Nato e con
il supporto dei servizi segreti e di alcune forze politiche e militari italiane.
E’ interessante notare come il perito balistico
Marco Morin, che si occupò
della strage di Peteano, nonché dell’omicidio
Moro e di quello
Dalla Chiesa, risultò essere
legato all’organizzazione Gladio e, secondo il giudice Felice Casson, falsificò
la perizia per nascondere come le armi utilizzate nella strage provenissero
proprio dai depositi di Gladio. Nello stesso procedimento per la strage di
Bologna, Gian Adelio Maletti,
l’ex capo Reparto D del Sid, venne accusato di depistaggio delle indagini, come
anche Licio Gelli. Nel 2001, in un’intervista, il generale dichiarò come, ai
tempi, esistesse una “regia
internazionale” delle stragi, relativa alla strategia della
tensione, e come la Cia finanziasse sia il Sid che Gladio. Intanto, il Sid aveva
formato una “altra Gladio”, ben più celata. Su di essa scrisse Paolo Biondani:“Una
struttura mista militari civili, parallela alla rete ‘Stay Behind’, con
obiettivi analoghi ma con protagonisti diversi: nuovi nomi, ancora top secret,
di presunti responsabili di operazioni coperte che i magistrati collegano alla
strategia della tensione degli anni 1969-1974. Un’organizzazione che agiva sotto
una sigla pseudo istituzionale, "Nuclei
di difesa dello Stato", della quale finora nessuna autorità
aveva mai parlato, neppure dopo la divulgazione degli elenchi dei 622 gladiatori
‘ufficiali’”. Sei anni dopo le allusioni di Vinciguerra, nel 1990,
Giulio Andreotti rese pubblica
l’esistenza di Gladio. Si disse che era una struttura atta a contrastare la
criminalità organizzata.
Nello stesso anno morì Miceli e due magistrati
militari aprirono un’inchiesta per far luce sui misteri legati all’unità “Stay
Behind” siciliana. Conducendo indagini, risalirono a diversi fascicoli
archiviati dai Servizi. In essi si leggeva chiaramente come la Cia rivestisse un
ruolo di primo piano nella vicenda. L’agenzia americana raccomandava ai Servizi
italiani di mantenere il segreto su Gladio: “si dovrebbe sapere solo che ha il
compito di creare quadri di guerriglieri destinati a svolgere attività armata
contro l’occupante. Avrebbe poca importanza che le strutture Sios, i servizi
segreti delle singole armi, vengano a conoscenza di questi compiti, l’importante
è che pensino che i nominativi che forniscono sono destinati a questo scopo
soltanto” Inoltre, la Cia si sarebbe posta in prima linea per rendere
operativo il tutto: “nostra cura creare altri
due livelli organizzativi, che
sarebbero di nostra esclusiva conoscenza nei quali immettere a varie tappe
coloro che abbiano dato buona prova”. Sempre nel 1990 l’ex agente della Cia
Richard Brenneke,
raccontò di come l’agenzia, ai tempi, avesse pagato ingenti somme a Licio Gelli
affinché mettesse in moto una serie di stragi, in maniera tale da far
sprofondare l’Italia nel terrore. Lui,
Gelli, entrato in contatto con gli americani dopo le
raccomandazioni di Lucky Luciano durante la Seconda Guerra Mondiale, è una
figura chiave di questi anni. I suoi rapporti con l’Agenzia segreta vennero
rinforzati dalla sua collaborazione con Ronal Rewald, fondatore dell’Istituto
finanziario Bishop, Baldwin, Rewald, Dillingham & Wong con base alle Hawaii, una
società della CIA che poi divenne la Banca Nugan Hand, di proprietà della CIA
stessa. Al tempo stesso, Gelli fu Maestro Venerabile della lista
Propaganda 2, la celebre P2.
La stretta connessione tra l’operazione Gladio e
la loggia massonica la esplicò lui stesso in un’intervista del febbraio 2011, in
cui dichiarò: “Io avevo la P2, Cossiga
la Gladio, Andreotti l’Anello”.
Erano, tutti e tre, apparati “segreti”, anelli di
congiunzione tra la società civile e gli 007. Sulla figura di Gelli si concentrò
anche il giudice bolognese Libero
Mancuso, secondo cui, in Italia, operava un’unica centrale
criminale, una sorta di holding in grado di mettere d’accordo tutti,
raccogliendo fondi e investendo in aree, settori e uomini. In questo contesto,
l’imprenditore si configurava come l’uomo di raccordo tra tutti i protagonisti:
servizi segreti, mafia, massoneria, Vaticano, estremismo neofascista. Il potere
di Gelli, in continua crescita, venne bruscamente interrotto nel 1979. I Servizi
segreti americani scaricarono il massone, ormai troppo influente, inserendo, al
suo posto, un faccendiere romano legato agli 007, Francesco Pazienza, anch’egli
iscritto alla P2. Il tutto rientrava in un piano di preparazione in vista del
1980, quando, secondo la Cia, si sarebbe verificata una vera e propria
rivoluzione, a cui Gladio avrebbe dovuto rispondere potenziandosi e
modificandosi. Si parlava, cioè, del
golpe di Michele Sindona. Raccomandato dal boss Luciano
esattamente come Gelli, Sindona fu uno dei più potenti e corrotti massoni
coinvolti nel “ Gioco Grande”. I suoi primi guai cominciarono nel 1967, quando,
dopo aver comprato la Banca Privata
Finanziaria, l’Interpol lo segnalò come implicato nel
riciclaggio di denaro sporco proveniente dal traffico di stupefacenti, gestito
da Cosa Nostra americana: numerosi boss, d’altronde, erano suoi soci. Nel 1969
Sindona s’associò alla banca vaticana, lo
Ior, e, attraverso essa, fece
trasferire enormi somme in Svizzera. Nel frattempo, tramite una serie di
libretti al portatore, trasferì 2 miliardi di lire nelle casse della
Democrazia Cristiana, mentre
parecchi milioni di lire transitarono attraverso la CIA, la Franklin Bank e il
SID per finanziare, secondo la commissione d’inchiesta del Senato degli Stati
Uniti, la campagna elettorale di 21 politici italiani. Nonostante fosse stato
più volte definito da Giulio Andreotti “il salvatore della Lira”, Sindona, nel
1974, spinse la Banca Privata Italiana in bancarotta per frode e cattiva
gestione. Per questo venne ordinato un commissario liquidatore,
Giorgio Ambrosoli, che assunse
la direzione dell’istituto e, nel frattempo, esaminò tutte le trame occulte e
criminose con cui il finanziere Sindona aveva cercato, negli anni, di salvare il
banco. Un’indagine che gli costò la vita: nel ’79 venne ucciso dal sicario
legato a Cosa Nostra americana William Jospeh Aricò (accusato di aver freddato,
cento giorni prima, il giornalista Mino
Pecorelli) su mandato di Michele Sindona. L’intento del
finanziere era quello di nascondere le tracce di come avesse investito il
denaro sporco di boss
mafiosi della portata di Stefano
Bontate, Salvatore Inzerillo e Rosario Spatola.
Gli stessi con cui, nello stesso 1979, il
finanziere tentò il golpe: si recò in Sicilia cercando di convincere le cosche a
scindere l’isola dal resto dell’Italia, per consegnarla in mano alle famiglie
mafiose e alla P2, dove trovava spazio anche Umberto Ortolani, membro del
consiglio interno dei Cavalieri di Malta, e considerato “il grande apri porta
Vaticano”. Sindona era collegato a un’altra figura di spicco, di questi anni:
Roberto Calvi,
direttore del Banco Ambrosiano,
una banca privata, strettamente legata allo
Ior. Proprio grazie a Gelli e
Sindona, Calvi entrò nella P2. Quando, al finire degli anni ’70, il Banco si
trovò ad affrontare una crisi di liquidità, Calvi domandò aiuto a
Eni e a Bnl, che finanziarono
circa 150 milioni di dollari. Nel 1980, a una seconda crisi, l’uomo pagò
tangenti a Claudio
Martelli e a
Bettino Craxi affinché la Eni
tornasse a erogare stanziamenti per il Banco Ambrosiano. Nel 1981 esplose il
caso della P2; Calvi, ormai in rotta anche con Sindona, rimase senza protezione
e, nell’estremo tentativo di appianare il debito del Banco Ambrosiano, strinse
rapporti con Flavio Carboni,
finanziere legato a personalità del calibro di Gelli,
Pippo Calò e i membri della
banda della Magliana. Amicizie
pericolose, che giocarono un grosso peso nel suo destino. Nel 1982, il banchiere
venne ritrovato impiccato a Londra, appeso sotto il ponte dei Frati Neri,
apparentemente suicida. Secondo la vedova, il vero capo della P2 era Andreotti,
il quale avrebbe fatto uccidere l’uomo. Effettivamente, prima di partire per
Londra, Calvi incontrò il politico, ma al riguardo non si sa altro.
Nel frattempo, in Italia, fu aperta un’inchiesta,
basata sulle testimonianze di diversi collaboratori di giustizia. Tra queste,
quella di Francesco Marino Mannoia,
il quale sostenne che Calvi e Gelli avevano investito denaro sporco nello Ior e
nell’Ambrosiano per conto del boss mafioso. Al riguardo dichiarò: “Calvi fu
strangolato da Francesco Di Carlo
su ordine di Pippo Calò. Calvi si era impadronito di una grossa
somma di danaro che apparteneva a Licio Gelli e a Pippo Calò. Prima di fare
fuori Calvi, Calò e Gelli erano riusciti a recuperare decine di miliardi e, quel
che più conta, Calò si era tolto una preoccupazione perché Calvi si era
dimostrato inaffidabile.” Una versione contestata da Francesco Di Carlo, il
quale negò di essere l’assassino, pur ammettendo che gli fosse stato domandato.
Ma, sottolineò il pentito, “la questione venne risolta con i napoletani”.
Antonino Giuffrè, un
altro pentito, sposò questa tesi, spiegando come i
camorristi legati ai Corleonesi
- di cui Calò curava gli interessi - si fossero affidati a Calvi per i propri
investimenti, e che dunque, una volta perso tutto, volessero vendicarsi. E
ancora, il collaboratore Pasquale
Galasso raccontò di come l’esecutore materiale dell’omicidio
fosse Vincenzo Casillo, che doveva un favore a Pippo Calò, mentre
Antonio Mancini, membro della
banda Magliana, specificò che, oltre al boss mafioso, l’altro mandante
dell’assassinio era Flavio Carboni. Non di poca rilevanza, inoltre, è il fatto
che Roberto Calvi, su richiesta del Vaticano,
finanziò “paesi e associazioni politico-religiose” in America Latina
“allo scopo di contrastare la penetrazione e l’espandersi di ideologie
filomarxiste”. Cioè, collaborava parallelamente all’operazione
Sunrise voluta dalla Cia. Un altro membro della potente loggia fu
Eugenio Cefis. Fu lui, dal suo
ruolo di presidente dell’Eni, ad aiutare Roberto Calvi quando l’Ambrosiano
riversava in gravi condizioni economiche. Imprenditore potentissimo, fu al
centro di un libro inchiesta di Pier
Paolo Pasolini. In questo volume, il regista, poco prima della
misteriosa morte, ipotizzò che Cefis avesse avuto un ruolo nello stragismo
legato alle trame internazionali. Inoltre, Pasolini lo indicò come principale
sospettato nell’ambito della morte del suo predecessore e fondatore dell’Eni,
Enrico Mattei. Sulla
morte di Mattei ritorna ancora la Cia,
così come Cosa Nostra.
L’onorevole Oronzo Reale affermò come il mandante dell’assassinio fosse Cefis,
dopo che Mattei scoprì che era manovrato dagli agenti segreti americani. Ma, al
tempo stesso, un’altra ipotesi è stata mossa negli anni, ossia quella che vede
nel fondatore dell’Eni un nemico per le
“sette sorelle”, le compagnie
petrolifere più ricche del mondo che domandarono dunque a Cosa Nostra di
eliminare il rivale. Una tesi sostenuta da pentiti di mafia come
Gaetano Iannì e
Tommaso Buscetta, nonché da un
agente del KGB di
stanza in Italia negli anni ’60, Leonid
Kolossov. Anche un eventuale intervento della Cia pare non poter
essere preso sotto gamba: l’agenzia, proprio nei giorni in cui si verificò
l’attentato contro Mattei, era impegnata in una fase cruciale della Guerra
Fredda e, di conseguenza, aveva buone ragioni per sperare nella morte
dell’imprenditore, che con la Russia
aveva allestito una linea commerciale, rompendo di fatto l’embargo politico.
Quel che è certo è che, il 27 ottobre 1962, il più potente manager di stato
italiano venne ucciso dall’esplosione di una bomba sull’aeroplano privato su cui
viaggiava. Venne aperta un’inchiesta, condotta dal pm Vincenzo Calia, il quale,
durante le indagini, rintracciò anche un appunto del Sismi, nel quale veniva
illustrato il ruolo di Cefis nella P2: ne era il
fondatore. Precedentemente
Pasolini, anche il giornalista Mauro De
Mauro si interessò alla morte di Mattei, prima di sparire nel
nulla.
Ufficialmente è stato ucciso dalla mafia, come
almeno altri due personaggi noti che si occuparono del caso:
Boris Giuliano e
Carlo Alberto Dalla Chiesa.
Quest’ultimo, nel particolare, prima di essere ucciso da Cosa Nostra, si era
occupato, tra gli altri casi, del sequestro e dell’omicidio di
Aldo Moro, il quale aveva
sollevato seri dubbi su ciò che Gladio compieva in Italia, tanto da citare
l’organizzazione nei suoi memoriali. E non stupirà sapere che le carte relative
al sequestro del politico, che Dalla Chiesa aveva portato con sé a Palermo,
sparirono inspiegabilmente dopo l’attentato che gli strappò la vita. Dopo Moro e
Dalla Chiesa, un altro personaggio si interessò all’unità “stay behind”
italiana: Giovanni Falcone.
Il magistrato voleva approfondire l’incidenza di Gladio nei delitti
politici di Palermo degli ultimi anni, tra cui quello di
La Torre, di
Reina e di Mattarella.
Aveva inoltre supposto che dietro la morte del giornalista
Mauro Rostagno potessero
celarsi gli agenti segreti, visto e considerato che, durante le sue indagini, il
cronista si era imbattuto in verità scottanti riguardo il
contrabbando di droga e di armi
con l’Africa. Verità
talmente sconvolgenti da aver persino richiesto, prima di morire, un colloquio
con Falcone, presumibilmente riguardante la base operativa
Centro Scorpione, una
propaggine di Gladio, a Trapani, creata nell’87. Per l’omicidio di Rostagno,
avvenuto nell’88, fu sospettato come mandante il boss trapanese
Vincenzo Virga, colui che, pochi anni dopo, fu
incaricato dal boss Riina di procurare gli esplosivi per le stragi e da Marcello
Dell’Utri di trattare il recupero di un credito di Publitalia con la
Pallacanestro Trapani. Lo stesso mafioso è anche mandante della
strage di Pizzolungo. E’
interessante notare come Rostagno avesse scoperto casualmente i traffici verso
il Continente Nero, laddove, pochi anni dopo, nel marzo 1994, sarebbe stata
uccisa in circostanze misteriose Ilaria
Alpi. Inviata in Somalia a seguire in prima persona la guerra
civile e per indagare sul traffico
d’armi e di rifiuti tossici illegali, probabilmente scoprì che nella questione
erano coinvolti anche i servizi segreti, come confermato successivamente da
alcuni pentiti. Altresì, riveste i contorni di oscuro presagio il fatto che, nel
novembre precedente, era stato ucciso, sempre in
Somalia, l’informatore della
stessa Alpi sul traffico illecito di scorie tossiche nel paese africano, il
sottufficiale del SISMI Vincenzo Li
Causi, capo del Centro Scorpione. Scrisse Alfio Caruso: “Che bel
mistero quel Centro Scorpione, ufficialmente incaricato di contrastare dal basso
Mediterraneo l’arrivo dell’Armata Rossa, viceversa invischiato in combinazioni
poco chiare, talmente cieco – ma è possibile? – da non accorgersi che da Trapani
per otto anni sono transitati tutti i carichi di missili, di esplosivo, di mine,
di granate diretti verso l’Iran e l’Iraq, impegnatissimi a scannarsi
vicendevolmente.” Falcone iniziò a sospettare qualcosa. Ritenne che esistessero
strutture segretissime all’interno di Cosa nostra “con finalità ancora ignote ma
certamente di enorme portata”. Trovò prove inoppugnabili di come la mafia fosse
stata interpellata per salvare Aldo Moro, nonché collegamenti tra omicidi
celebri e massoneria: su tutti Pierluigi Concutelli, assassino di Occorsio,
tessera 4070 della Loggia Camea di Palermo. Ma, quando il giudice provò ad
indagare sul Centro Scorpione di Trapani, gli venne impedito. Il procuratore
Pietro Giammanco gli comunicò che avrebbe preferito condurre lui quell’inchiesta
e il magistrato si trasferì a Roma, divenendo direttore degli affari penali,
accettando il posto offerto da Martelli. Non per questo smise di interessarsi a
Gladio e al Centro Scorpione. Fu la sua ultima indagine, sebbene non ufficiale.
Conservò tutti gli appunti sul suo computer, forse arrivò veramente vicino alla
verità. Così tanto che divenne impellente la necessità di eliminarlo. Il 23
maggio 1992, a Capaci, Falcone venne ammazzato e, con lui, la moglie e alcuni
uomini della scorta. Nei cieli volava anche un piper sconosciuto, probabilmente
dei Servizi. Poche ore dopo, qualcuno s’introdusse nell’ufficio del magistrato e
manomise i dati su Gladio.
"La mafia braccio armato dell'altra
massoneria". I rapporti inediti della stagione delle
stragi: uomini di Cosa nostra infiltrati nelle logge siciliane, scrivono
Francesco La Licata e Guido Ruotolo su “La Stampa”. Novembre del 2002. Documento
della Dia, Divisione investigativa antimafia, alla Procura antimafia di Firenze
che indaga sulle stragi del ‘93. «Cosa nostra, storicamente, per raggiungere
determinati obiettivi essenziali - condizionamento dei processi e realizzazione
di grossi arricchimenti - si è sempre mossa attivando da una parte referenti
politico-istituzionali, dall’altra ponendo in essere azioni delittuose, alla
bisogna, anche estreme. Altra determinante leva di pressione è stata sicuramente
quell’alleanza con una parte della massoneria deviata, incarnata nelle logge
occulte, riferibile, tra le altre, alla loggia del Gran Maestro della
Serenissima degli Antichi Liberi Accettati Muratori-Obbedienza di Piazza del
Gesù - Maestro Sovrano Generale del Rito Filosofico Italiano - Sovrano Onorario
del Rito Scozzese Antico e Accettato, di origini palermitane, di stanza a
Torino, il noto prof. Savona Luigi, particolarmente sentito nel decennio
Ottanta, in seno a Cosa nostra, per il suo profondo legame con la cosca
mazzarese, intrecciato attraverso il mafioso Bastone Giovanni, personaggio di
primo piano nel panorama criminale torinese nel periodo succitato, che come si
vedrà più avanti ha avuto un ruolo non certo insignificante nella vicenda
relativa alla collocazione di un ordigno, non volutamente fatto brillare, nel
giardino di Boboli a Firenze». Il rapporto della Dia si dilunga sui rapporti di
Savona con i mafiosi della famiglia Lo Nigro, e più in generale della massoneria
deviata con Cosa nostra: «Questo particolare aspetto relazionale deviante della
massoneria, viene definito “mafioneria”; una sorta di ordinamento composto da
mafiosi e massoni, che trova ambiti ben definiti in un’area oscura della
politica, connotata da una perversa logica di potere». C’è un passaggio
dell’informativa della Dia del 2002 che richiama alle polemiche di questi giorni
sulla strategia stragista finalizzata a favorire la discesa in campo di nuovi
soggetti politici: «L’avvio di una trattativa, nella logica pragmatica mafiosa,
con le Istituzioni non poteva che prevedere l’apporto e l’intervento di soggetti
asserviti a Cosa nostra... in questo quadro si inserisce il ruolo svolto
dall’indagato Vincenzo Inzerillo, ex senatore Dc (poi la sua posizione è stata
archiviata nell’ambito del fascicolo sui mandanti delle stragi di Firenze, Roma
e Milano, ndr), collegato con la famiglia dominante del quartiere Brancaccio di
Palermo, capeggiata all’epoca dai fratelli Graviano, cui l’Inzerillo era
asservito». Inzerillo (condannato in Appello, l’11 gennaio del 2010, a 5 anni e
4 mesi per concorso in associazione mafiosa) in quell’autunno del ‘93 è
impegnato nella nascita di un partito politico, Sicilia Libera. «La possibilità
di poter disporre di una forza politica da inserire poi in un più ampio
raggruppamento, che fosse espressione di un vero soggetto politico, avrebbe
consentito a Cosa nostra, secondo il suo progetto, di poter realizzare
direttamente e senza alcuna mediazione quegli affari abbisognevoli di appoggi di
natura politica, ma anche di poter condizionare con subdoli interventi
l’andamento dei processi avviati contro i propri sodali». Sempre la Dia, ma
dieci anni prima (10 agosto 1993). Un documento corposo analizza scenari e
moventi all’indomani delle stragi di luglio di Roma e Milano: «Lo scenario
criminale delineato sullo sfondo di questi attentati ha messo in evidenza da un
lato l’interesse alla loro esecuzione da parte della mafia, ma ha lasciato
altresì intravedere l’intervento di altre forze criminali in grado di elaborare
quei sofisticati progetti necessari per il conseguimento di obiettivi di portata
più ampia e travalicanti le esigenze specifiche dell’organizzazione mafiosa». Si
sofferma sul punto il rapporto della Dia: «Si potrebbe pensare a una
aggregazione di tipo orizzontale, in cui ciascuno dei componenti è portatore di
interessi particolari perseguibili nell’ambito di un progetto più complesso in
cui convergano finalità diverse. Un gruppo che, in mancanza di una base
costituita da autentici rivoluzionari si affida all’apporto operativo della
criminalità organizzata. Gli esempi di organismi nati da commistioni tra mafia,
eversione di destra, finanzieri d’assalto, funzionari dello Stato infedeli e
pubblici amministratori corrotti non mancano». Infine un accenno alla
massoneria: «Recenti indagini - si legge nel rapporto Dia del 10 agosto 1993 -
hanno evidenziato la presenza di uomini di “cosa nostra” nelle logge palermitane
e trapanesi, senza dimenticare il ruolo chiave svolto alla fine degli anni ‘70
da Michele Sindona nei contatti tra gli ispiratori di progetti golpisti ed
elementi di spicco della mafia siciliana». Un salto di un anno. Siamo al 4 marzo
del 1994. Questa volta si tratta di una informativa all’autorità giudiziaria da
parte della Dia. Settanta pagine corpose. Un capitolo importante è dedicato al
regime carcerario, al 41 bis: «Solo alcuni giorni prima degli attentati di
Milano e Roma, il ministro di grazia e giustizia aveva disposto il rinnovo dei
provvedimenti di sottoposizione al regime speciale per circa 284 detenuti
appartenenti a organizzazioni mafiose. La logica che ha fatto considerare
vincente l’attuazione di una campagna del terrore deve aver avuto alla base il
convincimento che, dovendo scegliere se affrontare una situazione di caos
generale o revocare i provvedimenti di rigore nei confronti dei mafiosi, le
Autorità dello Stato avrebbero probabilmente optato per la seconda soluzione,
facilmente giustificabile con motivazioni garantiste o, come avvenuto in
passato, affidando all’oblio, agevolato dall’assenza di nuovi fatti delittuosi
eclatanti, una normalizzazione di fatto».
Un'analisi organica dei rapporti fra massoneria
deviata e cosche mafiose è contenuta nella relazione della Commissione
parlamentare antimafia presieduta da Luciano Violante, scrive Salvo Palazzolo.
"Il terreno fondamentale sul quale si costituiscono e si rafforzano i rapporti
di Cosa nostra con esponenti dei pubblici poteri e delle professioni private è
rappresentato dalle logge massoniche. Il vincolo della solidarietà massonica
serve a stabilire rapporti organici e continuativi". Questo il punto di partenza
dell'analisi proposta. "L'ingresso nelle logge di esponenti di Cosa nostra,
anche di alto livello, non è un fatto episodico ed occasionale ma corrisponde ad
una scelta strategica - spiega la Commissione antimafia - Il giuramento di
fedeltà a Cosa nostra resta l'impegno centrale al quale gli uomini d'onore sono
prioritariamente tenuti. Ma le affiliazioni massoniche offrono
all'organizzazione mafiosa uno strumento formidabile per estendere il proprio
potere, per ottenere favori e privilegi in ogni campo; sia per conclusione di
grandi affari sia per "l'aggiustamento" dei processi, come hanno rivelato
numerosi collaboratori di giustizia. Tanto più che gli uomini d'onore nascondono
l'identità dei "fratelli" massonici ma questi ultimi possono anche non conoscere
la qualità di mafioso del nuovo entrato" (punto 57 della citata Relazione).
Rapporti fra Cosa nostra e massoneria sono comunque emersi anche nell'ambito dei
lavori di altre due Commissioni parlamentari d'inchiesta: quella sul caso
Sindona e quella sulla loggia massonica P2, che già avevano approfondito la
vicenda del finto rapimento del finanziere e della sua permanenza in Sicilia dal
10 agosto al 10 ottobre 1979. Agli atti, le indagini della magistratura milanese
e di quella palermitana, che avevano svelato i collegamenti di Sindona con
esponenti mafiosi e con appartenenti alla massoneria. Il finanziere era stato
aiutato da Giacomo Vitale, cognato di Stefano Bontade, capomafia della famiglia
palermitana di Santa Maria di Gesù e da Joseph Miceli Crimi: entrambi aderenti
ad una comunione di Piazza del Gesù, "Camea" (Centro attività massoniche
esoteriche accettate). Nel gennaio 1986 la magistratura palermitana dispone una
perquisizione e un sequestro presso la sede palermitana del Centro sociologico
italiano, in via Roma 391. Vengono sequestrati gli elenchi degli iscritti alle
logge siciliane della Gran Loggia d'Italia di Piazza del Gesù. Fra gli iscritti
figurano i nomi dei mafiosi Salvatore Greco e Giacomo Vitale. Nel mese di
gennaio dello stesso anno, la magistratura trapanese dispone il sequestro di
molti documenti presso la sede del locale Centro studi Scontrino. Il centro,
presieduto da Giovanni Grimaudo, era anche la sede di sei logge massoniche:
Iside, Iside 2, Osiride, Ciullo d'Alcamo, Cafiero, Hiram. L'esistenza di
un'altra loggia segreta trova poi una prima conferma nell'agenda sequestrata a
Grimaudo, dove era contenuto un elenco di nominativi annotati sotto la dicitura
"loggia C". Tra questi, quello di Natale L'Ala, capomafia di Campobello di
Mazara. Nella loggia Ciullo d'Alcamo risultano essere affiliati: Pietro Fundarò,
che operava in stretti rapporti con il boss Natale Rimi; Giovanni Pioggia, della
famiglia mafiosa di Alcamo; Mariano Asaro. Nel processo, vari testimoni hanno
concordato nel sostenere l'appartenenza alla massoneria di Mariano Agate,
capomafia di Mazara del Vallo. Alle sei logge trapanesi e alla loggia "C" erano
affiliati imprenditori, banchieri, commercialisti, amministratori pubblici,
pubblici dipendenti, uomini politici (la Commissione antimafia, nella citata
relazione, ricorda come l'onorevole democristiano Canino, nell'estate del '98
arrestato per collusioni con Cosa nostra, abbia ammesso l'appartenenza a quella
loggia, pur non figurando il suo nome negli elenchi sequestrati). Già nel
processo di Trapani e poi successivamente in quello celebrato nel '95 a Palermo
contro Giuseppe Mandalari (accusato di essere il commercialista del capo della
mafia, Totò Riina) sono emersi contatti fra le consorterie mafiose e massoniche
di Palermo e Trapani. Mandalari, "Gran maestro dell'Ordine e Gran sovrano del
rito scozzese antico e accettato" avrebbe concesso il riconoscimento "ufficiale"
alle logge trapanesi che facevano capo a Grimaudo. Le indagini sui rapporti
mafia-massoneria continuano. Seppur fra tante difficoltà. L'unica condanna al
riguardo, ottenuta dai pm palermitani Maurizio De Lucia e Nino Napoli, riguarda
proprio Pino Mandalari, il commercialista di Riina attivo gran maestro. Solo nel
febbraio del 2002, è stata sancita in una sentenza la pesante influenza dei
"fratelli" delle logge sui giudici popolari di un processo di mafia: la Corte
d'assise stava seguendo il caso dell'avvocato palermitano Gaetano Zarcone,
accusato di avere introdotto in carcere la fiala di veleno che doveva uccidere
il padrino della vecchia mafia Gerlando Alberti. Non è stata facile la
ricostruzione del pm Salvatore De Luca e del gip Mirella Agliastro, che poi ha
emesso sette condanne: non c'erano mai minacce esplicite, solo garbati consigli
a un "atteggiamento umanitario". Questo il volto delle intimidazioni tante volte
denunciate. Il caso più inquietante di cui si sono occupate le indagini è quello
di una misteriosa fratellanza, la Loggia dei Trecento, anche detta Loggia dei
Normanni. Il pentito Angelo Siino ha fugato ogni dubbio: il divieto per gli
aderenti a Cosa nostra di fare parte della massoneria restò sempre sulla carta.
"Le regole erano un po' elastiche - spiega - come la regola che non si devono
avere relazioni extraconiugali". Erano soprattutto i boss della vecchia mafia,
Stefano Bontade e Salvatore Inzerillo, ad avere intuito l'utilità di aderire
alle logge. Rosario Spatola seppe da Federico e Saro Caro che Bontade "stava
cercando di modernizzare Cosa nostra. Vedeva più in là, vedeva la potenza della
massoneria, e magari riteneva di potere usare Cosa nostra in subordine, come una
sorta di manovalanza". Per questo aveva creato una sua loggia. Era appunto la
Loggia dei Trecento. Anche Siino riferisce di "averne sentito parlare: si diceva
che ne facevano parte parecchi personaggi quali i cugini Salvo, Totò Greco "il
senatore" e uomini delle istituzioni. La loggia non era ufficiale e non aderiva
a nessuna delle due confessioni, né a quella di Piazza del Gesù né a quella di
Palazzo Giustiniani". Correvano a Palermo i ruggenti anni Settanta. Il pentito
Spatola conferma il ruolo di Bontade come gran maestro della Loggia dei
Trecento. E spiega: "Ne facevano parte soggetti appartenenti alle categorie più
disparate, e per questo era molto potente. E troppa potenza si era creata anche
attorno a Stefano Bontade, per questo andava eliminato lui ma anche la loggia".
Il 23 aprile 1981, Bontade fu ucciso dai corleonesi di Totò Riina e Bernardo
Provenzano. Ha svelato Spatola che fu proprio Provenzano, attuale capo
dell'organizzazione mafiosa, a prendere l'iniziativa di sciogliere la Loggia dei
Trecento. Particolare davvero inedito e curioso. Quale autorità aveva mai don
Bernardo per intervenire d'autorità su una fratellanza tanto riservata? Forse
era massone anche lui? Forse, già allora, aveva ben presenti rapporti e
complicità eccellenti che da lì a poco avrebbero fatto a gara per riposizionarsi
e ingraziarsi i nuovi potenti?
LE RIVELAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA
Tommaso Buscetta.
Nel 1984 parla per la prima volta del rapporto fra mafia e massoneria nel
contesto del tentativo golpista di Junio Valerio Borghese del dicembre 1970. Il
collegamento tra Cosa nostra e gli ambienti che avevano progettato il colpo era
stato stabilito attraverso il fratello massone di Carlo Morana, uomo d'onore. La
contropartita offerta a Cosa nostra consisteva nella revisione di alcuni
processi.
Leonardo Messina.
Sostiene che il vertice di Cosa nostra sia affiliato alla massoneria: Totò
Riina, Michele Greco, Francesco Madonia, Stefano Bontade, Mariano Agate, Angelo
Siino (oggi collaboratore di giustizia pure lui). Ritiene che spetti alla
Commissione provinciale di Cosa nostra decidere l'ingresso in massoneria di un
certo numero di rappresentanti per ciascuna famiglia.
Gaspare Mutolo.
Conferma che alcuni uomini d'onore possono essere stati autorizzati ad entrare
in massoneria per "avere strade aperte ad un certo livello" e per ottenere
informazioni preziose ma esclude che la massoneria possa essere informata delle
vicende interne di Cosa nostra. Gli risulta che iscritti alla massoneria sono
stati utilizzati per "aggiustare" processi attraverso contatti con giudici
massoni.
Massoneria, poteri criminali, finanza e
magistratura. Libro "La Massoneria smascherata" di
Giacinto Butindaro. Fratelli nel Signore, ecco un altro mio libro confutatorio:
si intitola ‘La massoneria smascherata: contro l’infiltrazione e l’influenza di
questa diabolica istituzione nelle Chiese Evangeliche’. E’ un libro particolare,
diverso per certi aspetti da tutti gli altri, e capirete il perchè leggendolo e
studiandolo. La sua lettura e il suo studio vi richiederanno parecchio tempo e
impegno, ma sappiate che questo è un libro molto importante che ognuno di voi
deve leggere. Vi avverto da subito che questo è un libro che contiene
informazioni e notizie che produrranno in voi sbigottimento, e tanta rabbia e
tristezza. Ma nello stesso tempo sono sicuro che esso vi farà gioire ed esultare
nel Signore e vi farà ringraziare Dio perchè smaschera una delle più potenti ed
efficaci macchinazioni di Satana contro la Chiesa dell’Iddio vivente e vero,
colonna e base della verità. Un’ultima cosa: molti di voi leggendo questo libro
scopriranno di essere stati MASSONIZZATI, in quanto la Chiesa o la Denominazione
o l’Associazione di cui fanno parte è sotto l’influenza o il controllo della
Massoneria. A costoro dico: Ravvedetevi e separatevi immediatamente da coloro
che vi hanno MASSONIZZATI. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con
coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen. Ho deciso di introdurre in
questo mio libro anche una parte dedicata ai rapporti tra la Massoneria e i
poteri criminali, perchè credo che sia importante conoscere a grandi linee le
collusioni tra Massoneria e criminalità organizzata in Italia, per avere un
quadro il più possibile chiaro sulla Massoneria. Citerò soprattutto delle
informazioni presenti nel libro Fratelli d’Italia scritto dal giornalista
Ferruccio Pinotti, che ritengo molto utile per capire questo aspetto della
Massoneria, o meglio di una parte della Massoneria perchè non tutti i Massoni
accettano o sono d’accordo con la presenza di criminali mafiosi nella Massoneria
anche perchè l’ingresso di un criminale o di un mafioso nella Massoneria viola
uno dei requisiti essenziali che deve avere il ‘profano’ per entrare nella
Massoneria, cioè quello di essere di buoni costumi, che nel linguaggio massonico
significa che il ‘profano’ per essere ammesso nella Massoneria ‘deve essere buon
genitore, buon cittadino, rispettoso delle leggi, della morale comune e della
libertà altrui; avere uno stile morale di vita, se non irreprensibile, almeno
superiore alla media quanto a serietà, saggezza, discrezione e prudenza. Insomma
non l’uomo perfetto, ma un uomo che mediamente, nel giudizio dei più, in una
certa società ed in un determinato periodo, sia considerato persona onesta ed
affidabile, corretto nelle relazioni umane, rispettoso delle leggi e degli
altri. Dovrebbe essere questo l’individuo di “buoni costumi” del quale dobbiamo
andare in cerca. Tratterò anche brevemente i legami della Massoneria con la
finanza, perchè esistono e sono anche forti. Ed infine farò un accenno anche ai
legami che esistono tra la Massoneria e certi ambienti della magistratura.
Cosa nostra. I
rapporti tra massoneria e mafia risalgono già al periodo della seconda guerra
mondiale, quando il ‘pastore’ protestante Frank Bruno Gigliotti, massone ed
agente dell’OSS (poi CIA), preparò lo sbarco in Sicilia degli alleati attraverso
i rapporti con la mafia e la massoneria. Quindi la massoneria siciliana ha avuto
un ruolo fondamentale, insieme a elementi della mafia, nel preparare lo sbarco
degli Alleati in Sicilia. Ma questi rapporti sono proseguiti nel tempo e si sono
rafforzati. L’ex Gran Maestro del GOI Giuliano Di Bernardo racconta che mentre
era Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia Armando Corona (1982-1990), siccome
Corona fece riscrivere i regolamenti interni, le costituzioni del GOI,
trasformando – come dice lui – la massoneria in una specie di società per azioni
in cui la giunta è diventata un consiglio d’amministrazione, avvenne che la
massoneria americana tolse il riconoscimento al GOI, e a questo punto rivela dei
particolari a dir poco inquietanti: ‘La riforma della costituzione massonica
voluta da Corona fece perdere al Grande Oriente il riconoscimento da parte della
massoneria americana. I gran maestri regionali, soprattutto del Sud, che erano
molto irritati, avevano rapporti molto stretti con la Gran Loggia di New York.
Quindi anche con la mafia, infiltrata nella famosa loggia Garibaldi: un
concentrato di esponenti dell’area grigia tra massoneria e malavita. Ricordo che
una volta, quando andai in visita a quella loggia, pensai di avere intorno a me
tutti i capi di Cosa nostra in America. Altre concrete prove sui rapporti tra
Massoneria e Mafia provengono dal processo sull’omicidio di Roberto Calvi,
infatti nella requisitoria del pubblico ministero Luca Tescaroli al processo
"Omicidio di Roberto Calvi", si legge a proposito di Angelo Siino, ex «ministro
dei lavori pubblici» di Cosa nostra ed ora collaboratore di giustizia: «Gran
Maestro dell’Oriente di Palermo della loggia massonica Camea, con il grado di
trentatré, Angelo Siino ha riferito di aver incontrato per caso Roberto Calvi a
Santa Margherita Ligure all’interno della sede della loggia, una chiesa
sconsacrata, adibita a tempio massonico, mentre stava parlando con l’allora Gran
Maestro della loggia, Aldo Vitale, personaggio importante in quella zona, medico
condotto. Siino si era recato a Santa Margherita con Giacomo Vitale, cognato di
Stefano Bontate, massone parimenti appartenente alla loggia Camea». Siino
descrisse quell’incontro in questa maniera: "Aldo Vitale, sempre espansivo,
gentile ed accogliente nei suoi confronti, gli aveva detto di ‘aspettare un
attimo”. Si era meravigliato ed aveva domandato al suo accompagnatore “ma chi è
questo che è in compagnia di Vitale?". Questi gli aveva risposto che era Calvi,
un banchiere di Milano un personaggio importante, anche perchè gestisce dei
soldi nostri. Aveva usato il plurale maiestatis per fargli intendere che gestiva
dei soldi di Cosa nostra. Nell’occasione, aveva detto che gestiva anche denaro
di altri. Aveva usato l’espressione ‘e non solo’. Si era meravigliato del fatto
che Aldo Vitale conoscesse Roberto Calvi. Era, però, un personaggio importante,
anche amico di Licio Gelli, circostanza che aveva potuto constatare
personalmente. Oltre al Siino, anche un altro ex mafioso ora collaboratore di
giustizia che si chiama Gioacchino Pennino è un massone, infatti nella
requisitoria si legge a suo proposito: «Uomo d’onore riservato, medico
specialista, Gioacchino Pennino ha fatto parte di una loggia appartenente
all’obbedienza di Palazzo Giustiniani e, prima ancora, sin dagli anni Sessanta,
all’ordine di Rito Scozzese antico e accettato di cui era Gran Sovrano il
principe Giovanni Alliata di Monreale, che aveva sede a Roma, in via del Gesù, e
che si rifaceva alla loggia del Mondo di Washington. Negli anni Sessanta aveva
ricevuto il titolo massonico di ‘dumitis’ dell’Ordine del gladio e dell’aquila,
ed ha rivelato delle cose sulla massoneria che vale la pena trascrivere: "Il
principe Gianfranco Alliata è appartenuto alla famiglia mafiosa di Brancaccio e,
al contempo, ha rivestito il ruolo di Grande Sovrano della massoneria di piazza
del Gesù, con il ruolo di sovrano dell’ordine di Rito scozzese antico ed
accettato, che aveva come riferimento il duca di Kent, la Gran Loggia Unita di
Inghilterra e, in America, la loggia del Mondo di Washington. E’ stato uno dei
mandanti della strage di Portella delle Ginestre per conto del partito
monarchico e della massoneria. Facevano parte di questa massoneria Michele
Sindona e Antonino Schifando; ed era frequentata da alcuni associati a Cosa
nostra, quali Angelo Cosentino, responsabile della famiglia di Santa Maria del
Gesù a Roma, con il ruolo di capo decina; da Giuseppe Calò e Luigi Faldetta.
Aveva appreso le circostanze sull’appartenenza e le frequentazioni massoniche di
questi boss nel corso degli anni, da Stefano Bontate e dal cognato Giacomo
Vitale, entrambi defunti e massoni. Non era in grado di precisare a quale
massoneria apparteneva Bontate. Giacomo Vitale, dapprima, apparteneva alla
massoneria di piazza del Gesù e, successivamente, aveva aderito alla Camea,
loggia di origine ligure, con alcune logge in Sicilia e a Palermo soprattutto.
Gianfranco Alliata aveva presentato Michele Sindona a Stefano Bontate". E
proseguiamo, perchè di prove ce ne sono altre molto importanti. Infatti
nell’aprile del 1986 la squadra mobile di Trapani fece irruzione nel Centro,
situato in via Carreca, sequestrando gli elenchi di sette logge massoniche
(circa 200 gli iscritti). Dopo un attento esame si scoprì che una delle sette
logge era ‘coperta’ e i suoi quasi cento affiliati non erano presenti in alcun
elenco o registro ufficiale. Dopo qualche settimana emersero i primi nomi degli
affiliati segreti: funzionari del comune e della provincia, un burocrate della
prefettura, imprenditori edili, commercianti, un famoso deputato della
Democrazia Cristiana, e boss mafiosi. Il giornalista Attilio Bolzoni scrisse
allora su La Repubblica: «Alcuni fratelli, ammette un investigatore, oltre ad
essere in buoni rapporti con i boss, occupano posti importanti nella Pubblica
amministrazione. Altri, forse, hanno anche in mano le chiavi della città … Un
sospetto inquietante. Di quel Centro si occupò pure la Commissione parlamentare
antimafia. Nel resoconto stenografico della seduta del 4 dicembre 1992, che era
presieduta dall’onorevole Luciano Violante si legge: "Nell’aprile del 1986 la
magistratura trapanese dispose il sequestro di molti documenti presso la locale
sede del Centro studi Scontrino. Il centro studi, di cui era presidente Giovanni
Grimaudo – con precedenti penali per truffa, usurpazione di titolo, falsità in
scrittura privata e concussione – era anche la sede di sei logge massoniche:
Iside, Iside 2, Osiride, Ciullo d’Alcamo, Cafiero ed Hiram. L’esistenza di
un’altra loggia segreta, trovò una prima conferma nel rinvenimento, in un’agenda
sequestrata al Grimaudo, di un elenco di nominativi annotati sotto la dicitura
"loggia C"; tra questi quello di Natale L’Ala, capomafia di Campobello di
Mazara. Nella loggia Ciullo d’Alcamo risultano essere stati affiliati: Fundarò
Pietro, che operava in stretti rapporti con il boss mafioso Natale Rimi; Pioggia
Giovanni, della famiglia mafiosa di Alcamo; Asaro Mariano, imputato nel
procedimento relativo all’attentato al giudice Carlo Palermo". La relazione
della Commissione antimafia dice ancora quanto segue: «Nel procedimento
trapanese contro Grimaudo vari testimoni hanno concordato nel sostenere
l’appartenenza alla massoneria di Mariano Agate; dagli appunti rinvenuti nelle
agende sequestrate al Grimaudo risultano poi collegamenti con i boss mafiosi
Calogero Minore e Gioacchino Calabrò, peraltro suffragati dai rapporti che
alcuni iscritti alle logge intrattenevano con gli stessi. Alle sei logge
trapanesi ed alla ‘loggia C’ erano affiliati amministratori pubblici, pubblici
dipendenti (comune, provincia, regione, prefettura), uomini politici
(l’onorevole Canino ha ammesso l’appartenenza a quelle logge, pur non figurando
il suo nome negli elenchi sequestrati), commercialisti, imprenditori, impiegati
di banca. Gli affiliati a questo sodalizio massonico interferivano sul
funzionamento di uffici pubblici, si occupavano di appalti e di procacciamento
di voti in occasione delle competizioni elettorali, tentavano di favorire
posizioni giudiziarie e di corrompere appartenenti alle forze dell’ordine amici.
Il Grimaudo risulta aver chiesto soldi agli onorevoli Canino (Dc) e Blunda (Pri)
per sostenerne la campagna elettorale; la moglie di Natale L’Ala ha testimoniato
che, su richiesta del Grimaudo, il marito si attivò per favorire l’elezione
degli onorevoli Nicolò Nicolosi (Dc) e Aristide Gunnella (Pri)», e riferisce
pure: «Particolare rilevanza assume, infine, nel contesto descritto, il rapporto
di Grimaudo con Pino Mandalari. Mandalari fu arrestato nel 1974 per
favoreggiamento nei confronti di Leoluca Bagarella e nel 1983, fu imputato con
Rosario Riccobono. E’ legato a Totò Riina e socio fondatore nel 1974, con il
mafioso Giuseppe Di Stefano, della società Stella d’Oriente di Mazara del Vallo,
della quale fece parte dal 1975 Mariano Agate. Della società facevano parte
parenti del boss camorristico Nuvoletta, membro di Cosa nostra. Mandalari è un
esponente significativo della massoneria e riconobbe, nel 1978, le logge
trapanesi che facevano capo a Grimaudo». Il giornalista Antonio Nicaso definisce
il Mandalari "il commercialista di Totò Riina" e "Gran Maestro dell’Ordine e
Gran Sovrano del Rito scozzese antico e accettato, un uomo al centro di mille
sospetti e di altrettanti misteri". Anche negli atti del processo Dell’Utri
emergono collusioni tra la Massoneria e la Mafia, infatti nella lunga
requisitoria pronunciata dai pubblici ministeri Antonio Ingroia e Nico Gozzo nel
corso di diverse udienze viene detto dai pm: «Il tema della massoneria è
centrale in questa parte della requisitoria che riguarda la fine degli anni ’70.
E’ fondamentale per l’associazione mafiosa, e specie per Bontate, che voleva
svezzare Cosa nostra ed introdurla ancora di più negli ambienti che contano.
Tramite la massoneria viene acquisita una serie di contatti [...]. La massoneria
– ed in particolare proprio Licio Gelli, fondatore della loggia massonica
coperta Propaganda 2 – in quel periodo si trova al centro di una serie di
interessi, che avevano come propri terminali associati mafiosi». Ed in effetti,
come dice Ferruccio Pinotti, in Sicilia, tra il 1976 e il 1980, i mafiosi fanno
a gara per entrare nella massoneria. Cosa nostra offre ai massoni l’efficacia
della propria macchina militare, ma soprattutto una formidabile carta di
pressione politica: il denaro. I massoni offrono ai boss i canali legali per
riciclare e investire i soldi, i contatti politici giusti per concludere grandi
affari e i magistrati adatti per l’«aggiustamento» dei processi.
Le logge, negli anni Ottanta, fioriscono. Solo a
Palermo, dopo la Camea, la Armando Diaz, la Normanni di Sicilia. Nella sola
Sicilia all’epoca si contano più di centosettanta logge. Questa commistione tra
Massoneria e Mafia è stata confermata dal collaboratore di giustizia Vincenzo
Calcara, l’ex capo mafioso di Castelvetrano (Trapani). Ecco infatti cosa riporta
la requisitoria del PM Tescaroli (nel processo sull’omicidio di Calvi) sulle sue
dichiarazioni in merito ai rapporti tra mafia e massoneria: «Appare utile, per
poter apprezzare l’attendibilità delle sue dichiarazioni dibattimentali,
riportare quanto ha riferito Calcara sui temi d’interesse del presente processo.
In data 2.12.1992, ha riferito: «Voglio adesso parlare di un argomento del quale
avevo già iniziato a parlare con il Giudice Borsellino ma solo a voce. E con il
quale avevamo rimandato la verbalizzazione di tali fatti. Esiste infatti un
grosso collegamento tra la Loggia Massonica di Castelvetrano, Campobello e
Trapani e l’organizzazione mafiosa che milita in quella zona. Infatti il
Vaccarino è un massone, e anche l’avv. Pantaleo di Campobello. Voglio essere
molto preciso nel parlare di queste cose perchè chiaramente sono cose molto
delicate. So per certo che molti uomini d’onore delle famiglie di cui ho parlato
sono appartenenti alle Logge Massoniche. Una volta il Vaccarino parlando di tale
argomento, mi disse che la Massoneria era una cosa grande, più grande di noi. E
mi disse che il suo piacere era che io facessi parte di tale organizzazione. Fu
lo stesso Vaccarino a dirmi che lo Schiavone è massone e nell’ambito delle
famiglie si diceva che anche il giudice Carnevale era massone. Ricordo, che una
volta mi recai a Roma e lì andai a trovare lo Schiavone il quale mi accompagnò a
Montecitorio perchè io dovevo consegnare per conto di Pantaleo una grande busta
sigillata, da consegnare a mano all’on.le Miceli dell’Msi. A Montecitorio la
Segreteria dell’on.le Miceli mi disse che l’onorevole non era in sede. Io allora
uscii da Montecitorio (fuori mi aspettava lo Schiavone) e chiamai per telefono
il Pantaleo che mi aveva consegnato la busta. Questi mi disse di consegnarla
allo Schiavone. Di tali fatti chiesi spiegazione al Vaccarino che mi disse:
‘Cose di Massoni’ e in quell’occasione aggiunse che parlavano di una cosa più
grande di noi. Sono argomenti estremamente difficili e delicati perchè di
difficile riscontro. Bisogna anche considerare che i probabili anzi più che
probabili elenchi dopo tutti questi fatti siano stati occultati. Ricordo che il
giorno prima che Borsellino morisse, conversammo, per telefono; Borsellino in
quella occasione mi disse che dovevamo vederci presto per parlare di quelle
‘cose importanti’ e chiaramente intendeva riferirsi a quei discorsi sulla
Massoneria che insieme avevamo fatto. Voglio aggiungere sull’argomento che ho
anche sentito dire che l’on.le Culicchia era massone e comunque ribadisco che
moltissimi uomini d’onore delle famiglie di cui ho parlato fanno parte della
Loggia Massonica e ciò perchè per la realizzazione di determinati traffici tale
condizione li aiutava, e anche per quello che è la vita sociale in genere.
Voglio però precisare che non intendo affermare che, per quanto a mia
conoscenza, il semplice fatto di essere massone significhi essere legato
all’organizzazione mafiosa. Certo è comunque, come ho già detto, che i mafiosi
che fanno parte della Loggia Massonica evidentemente ne ricevevano i loro
vantaggi». Come ha scritto giustamente un giornalista su La Repubblica: «Le
affiliazioni massoniche offrono all’organizzazione mafiosa uno strumento
formidabile per estendere il proprio potere per ottenere favori e privilegi in
ogni campo, sia per la conclusione di grandi affari sia per l’aggiustamento di
processi, come hanno rilevato numerosi collaboratori della giustizia». E io
aggiungo, non solo all’organizzazione mafiosa, ma anche a quei pastori
evangelici corrotti che si affiliano alla massoneria – non importa se a logge
ufficiali o coperte – per ricevere aiuti dai criminali, che poi loro
puntualmente presenteranno alle loro Chiese come aiuti provenienti da Dio! E di
cosa bisogna meravigliarsi sapendo quanta corruzione e malvagità esiste nelle
denominazioni evangeliche e che ci sono pastori in esse che si alleerebbero pure
con il diavolo in persona per perseguire i loro interessi personali? Questi sono
tra quei pastori amici di malfattori, che cercano il loro proprio interesse e
non ciò che è di Cristo, e di cui il profeta Isaia dice: “I guardiani d’Israele
son tutti ciechi, senza intelligenza; son tutti de’ cani muti, incapaci
d’abbaiare; sognano, stanno sdraiati, amano sonnecchiare. Son cani ingordi, che
non sanno cosa sia l’esser satolli; son dei pastori che non capiscono nulla; son
tutti vòlti alla loro propria via, ognuno mira al proprio interesse, dal primo
all’ultimo. ‘Venite’, dicono, ‘io andrò a cercare del vino, e c’inebrieremo di
bevande forti! E il giorno di domani sarà come questo, anzi sarà più grandioso
ancora!’” (Isaia 56:10-12). Guai a loro! La commistione tra Massoneria e mafia
in Sicilia è tale che dopo le stragi di Capaci e di Via d’Amelio, avvenute nel
1992, in cui furono uccisi dalla mafia i magistrati Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino, il professor Orazio Catarsini, uno dei massimi esponenti del mondo
accademico, presidente del collegio dei Maestri Venerabili, sottopone ai
confratelli delle logge un documento di condanna delle stragi, ma il documento
non passa. L’ex Gran Maestro del GOI Giuliano Di Bernardo, a tale proposito, ‘ha
raccontato al Procuratore di Palmi che, in una riunione del Collegio dei Gran
Maestri delle logge siciliane, il 26 luglio 1992, il suo presidente, il
professor Catarsini «aveva ritenuto opportuno far approvare un documento che
attestasse la presa di posizione della massoneria rispetto alla mafia, anche
alla luce dei gravi fatti accaduti con l’uccisione di Falcone e Borsellino.
Subito dopo la riunione, Catarsini mi telefonò alle Canarie» ricorda Di Bernardo
«dove mi trovavo in vacanza, comunicandomi, turbato, la mancata approvazione del
documento, che lo aveva disorientato e non sapeva come interpretare». Le
conclusioni della Commissione antimafia presieduta da Luciano Violante: "Il
complesso delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia appare essere
concordante su tre punti: - intorno agli anni 1977-1979 la massoneria chiese
alla commissione di Cosa nostra di consentire l'affiliazione di rappresentanti
delle varie famiglie mafiose; non tutti i membri della commissione accolsero
positivamente l'offerta; malgrado ciò alcuni di loro ed altri uomini d'onore di
spicco decisero per motivi di convenienza di optare per la doppia appartenenza,
ferma restando la indiscussa fedeltà ed esclusiva dipendenza da Cosa nostra; -
nell'ambito di alcuni episodi che hanno segnato la strategia della tensione nel
nostro paese, vale a dire i tentativi eversivi del 1970 e del 1974, esponenti
della massoneria chiesero la collaborazione della mafia; - all'interno di Cosa
nostra era diffuso il convincimento che l'adesione alla massoneria potesse
risultare utile per stabilire contatti con persone appartenenti ai più svariati
ambienti che potevano favorire gli uomini d'onore".
‘Ndrangheta.
C’è commistione anche tra la Massoneria e la ‘ndrangheta calabrese, una delle
più potenti organizzazioni criminali in Italia, anzi la più potente secondo l’ex
procuratore nazionale antimafia Pier Luigi Vigna che l’ha definita «la mafia più
potente, l’agente monopolistico nel traffico degli stupefacenti. Ha collegamenti
internazionali in Germania e in Francia e con logge massoniche coperte che non
appartengono alla massoneria ufficiale: centri di interessi, di incontri, di
agevolazioni». Nel 2007 Giancarlo Bregantini, il vescovo cattolico romano di
Locri, in un convegno ha dichiarato che «la mafia è diventata ancora più
insidiosa perchè ora è meno evidente e stringe sempre più i rapporti con la
massoneria». Sui rapporti tra Massoneria e ‘ndrangheta il giornalista Mario
Guarino – esperto in rapporti tra massoneria e criminalità – ha scritto: «Mentre
i manovali del crimine eseguono dunque il lavoro sporco eliminando gli
avversari, e mentre i capicosca trattano per accaparrarsi appalti e per
concludere affari su enormi quantitativi di droga, ci sono Maestri della
massoneria che, al riparo dei loro ‘centri studi’ o dei propri uffici
commerciali o notarili, tessono la tela con pezzi del potere politico,
finanziario o giudiziario. Essi rappresentano il ‘volto istituzionale’ delle
‘ndrine. E’ un passaggio obbligato, perchè attraverso la massoneria la
‘ndrangheta da organizzazione avulsa dalla società civile assume un’altra
sembianza per diventare mafia imprenditrice». Anche il giornalista Antonio
Nicaso – che risiede a Toronto perchè molti anni fa lasciò la Calabria e andò in
Canada dietro suggerimento del magistrato Giovanni Falcone che praticamente gli
disse: ‘Vattene, altrimenti ti uccideranno …’ – afferma sostanzialmente la
stessa cosa: «La ‘ndrangheta ha modificato il suo assetto organizzativo per
favorire l’ingresso dei suoi esponenti di vertice nelle logge coperte. Una sorta
di enclave paramassonica in seno alla ‘ndrangheta è servita a favorire il
dialogo diretto con esponenti delle istituzioni, della finanza, senza più
delegare questo delicato compito ai politici. In Calabria, il processo di
integrazione con gli ambienti eversivi e paramassonici avvenne nel 1979 quando,
durante la latitanza a Reggio Calabria del terrorista nero Franco Freda, venne
costituita la cosiddetta ‘Superloggia’, un organismo segretissimo con
diramazioni a Messina e Catania, collegato alla Loggia dei Trecento,
l’organizzazione massonica di Stefano Bontate. Alla Superloggia, oltre ai più
importanti capibastone della ‘ndrangheta, avrebbero aderito esponenti della
destra eversiva, ‘fratelli’ già affiliati alla P2 e ad altre logge coperte,
uomini politici, rappresentanti delle forze dell’ordine e del mondo
imprenditoriale, magistrati». Il magistrato Nicola Gratteri, che lavora presso
la Procura della Repubblica di Reggio Calabria e che è un profondo conoscitore
dei rapporti tra ‘ndrangheta e massoneria, ha affermato che «massoneria,
‘ndrangheta, camorra e mafia si giovano del ‘trasversalismo’ che ormai impera
anche nei rapporti tra politica e crimine organizzato, un trasversalismo che
coinvolge sinistra, destra e centro senza distinzioni, da Forza Italia ai Ds», e
traccia delle analogie tra la ‘ndrangheta e la massoneria che secondo lui
favoriscono una sorta di riconoscimento reciproco. Tra queste analogie c’è
quella del giuramento, dice infatti il magistrato: «Anche nella ‘ndrangheta,
come nella massoneria, agli affiliati è richiesto un giuramento di fedeltà, che
prevede di recitare una formula, che tradotta in italiano suona: ‘Giuro su
quest’arma e di fronte a questi nuovi fratelli di Santa di rinnegare la società
di sgarro e qualsiasi altra organizzazione, associazione e gruppo e di fare
parte della Santa Corona e di dividere con questi nuovi fratelli di Santa la
vita e la morte nel nome dei cavalieri Osso, Mastrosso e Carcagnosso. E se io
dovessi tradire dovrei trovare nello stesso momento dell’infamia la morte».
Comunque, per Gratteri la doppia appartenenza sia alla ‘ndrangheta che alla
massoneria è possibile, in quanto «la doppia appartenenza è particolarmente
utile quando si tratta di operazioni di un certo livello, di sedersi al tavolo
della pubblica amministrazione per decidere gli appalti». Nel 1992 il
procuratore di Palmi Agostino Cordova avviò una inchiesta sui rapporti tra
‘ndrangheta e massoneria, e chiese al Grande Oriente d’Italia gli elenchi dei
massoni calabresi. Allora era Giuliano Di Bernardo a capo del GOI. Il Di
Bernardo mostrò un atteggiamento collaborativo, nonostante le pressioni interne,
perchè si convinse che il lavoro di Cordova era fondato basandosi su elementi
concreti. A tale riguardo, ecco dei particolari interessanti raccontati dal
Pinotti sempre nel suo libro Fratelli d’Italia in cui intervista il Di Bernardo:
"Di Bernardo, in quel momento, si sente in dovere di opporre resistenza
all’inchiesta, ma qualcosa lentamente lo convince che il lavoro di Cordova non è
infondato, che l’inchiesta del magistrato si basa su elementi concreti. E’ il
passaggio più difficile del suo racconto. «Un giorno mi sono recato a incontrare
Cordova in un luogo segreto. Ricordo ancora vividamente quell’incontro. Il
Magistrato mi guardò fisso e mi apostrofò con queste parole: ‘Professore, lei lo
sa di essere un fiore su una palude? Lo sa di rappresentare delle realtà con le
quali lei non ha nulla a che fare?’ Cordova disse proprio così». Come valutò il
professore quelle parole? «Inizialmente reagii male: ‘Come si permette di dire
cose del genere? Le può dire solo se è in grado di dimostrarle’». Ma poi
qualcosa mutò il suo atteggiamento. Di Bernardo spiega che Cordova gli produsse
vasta evidenza empirica dei fatti, che le indagini sulle connessioni tra mafia,
‘ndrangheta e massoneria si basavano su denunce che provenivano addirittura
dagli stessi massoni, cioè da liberi muratori onesti preoccupati del dilagare
dei comitati d’affari e delle collusioni pericolose con ambienti malavitosi. Di
fronte a queste rivelazioni, avvenute nell’incontro «segreto», Di Bernardo restò
senza parole, ammutolito da una realtà molto più complessa di quella che poteva
immaginare. Gli addebiti dell’inchiesta Cordova non erano fantasie, ma
provenivano addirittura dall’interno del Grande Oriente. Non si trattava delle
persecuzioni di un magistrato; ma di «fratelli» onesti, che erano stanchi di
essere affiancati a disinvolti affaristi. Di Bernardo deve affrontare un grosso
dilemma morale: collaborare con la magistratura, dando così ai «fratelli»
l’impressione di averli traditi, o assumere un atteggiamento di cieca difesa,
tradendo così la propria coscienza? Il Gran Maestro, in cuor suo, sente che non
può ignorare quanto il magistrato gli sta dicendo; che il suo interlocutore ha
delle ragioni serie per indagare. Sceglie così di collaborare con la giustizia,
difendendo allo stesso tempo le ragioni della parte pulita della massoneria. Ma
è una linea troppo sottile per essere compresa. Attorno a Di Bernardo si scatena
un violento scontro, che non può essere percepito dall’esterno ma che scuote
dalle fondamenta l’istituzione massonica". Questa sua collaborazione con Cordova
fece dunque infuriare il GOI, che gli si rivolta contro e lo lascia solo per
indurlo a dimettersi, e difatti il 20 marzo 1993 durante una assemblea il Di
Bernardo quando prende la parola lancia accuse. Accuse contro gli istigatori
dell’ormai evidente progetto. Contro coloro che ne erano diventati portavoce.
Contro tutti quelli che si erano riuniti la sera precedente. Contro il governo
dell’Ordine. Contro i Gran Maestri Onorari. Di Bernardo precisa e rilancia nuove
accuse. Dichiara di essere stato lasciato solo.
Isolato. Di non avere avuto alcun appoggio per le
richieste di epurazione di alcuni fratelli. Di essere stato ostacolato nel suo
progetto di trasparenza. Le accuse sono forti e cadono precise.
Nella sala il silenzio è assoluto. Nel libro Oltre
la cupola si legge a proposito di quegli eventi: "E dentro al Goi si scatena la
bagarre. Il Gran Maestro Di Bernardo propone l’operazione trasparenza, ma
nessuno lo segue su questo terreno. Anzi, gli fanno poco alla volta le scarpe.
Al Vascello, la grande casa del Goi tra villa Pamphili e il Gianicolo, si apre
una lotta senza esclusione di colpi. Armando Corona si mette alla testa dei
rivoltosi, non perdona a Di Bernardo di essere stato morbido con Cordova. La
battaglia si svolge per qualche settimana alla pari, ma il timore di sbragare di
fronte ai giudici sposta definitivamente l’ago della bilancia a favore dei
ribelli". Ma quel violento scontro scoppiato all’interno della Massoneria contro
il Di Bernardo è fatto anche di gravissime minacce che ricevono sia il Di
Bernardo che la sua famiglia, minacce che lo porteranno a decidere di dimettersi
e di uscire dal Grande Oriente d’Italia. Egli infatti il 14 Aprile 1993 convoca
una riunione dei membri di Giunta del Grande Oriente, in cui afferma: «Volevo
comunicarvi le mie decisioni. Ho ricevuto minacce gravissime e con me tutta la
mia famiglia. Ho visto mia madre piangere per l’inquietudine che avevano
suscitato in lei quelle minacce. Ne hanno ricevute mia moglie e i miei figli. La
mia famiglia è spaventata e vive in constante angoscia. Ho quindi deciso di
dimettermi». Ma che fine ha fatto poi quell’inchiesta di Cordova?
Innanzi tutto proseguì tra tanti ostacoli. Lo
stesso Agostino Cordova – come si legge nel libro Oltre la cupola – il 9 luglio
1993 davanti alla Commissione antimafia denunciò che alla sua inchiesta stanno
mettendo i bastoni fra le ruote. «Il fatto più allarmante è che sembra esservi
una generale riluttanza ad eseguire le indagini. Abbiamo scritto pressoché a
tutti gli organi di polizia giudiziaria – Digos, comandi provinciali dei
carabinieri, guardia di finanza, eccetera – illustrandone l’oggetto. E’ raro
però che vengano eseguite. Numerosi organi di polizia rispondono dicendo di non
conoscere, nel loro territorio, l’esistenza di logge massoniche, talvolta anche
in centri dove tali logge pullulano. Normalmente le indagini consistono nella
spedizione di elenchi anagrafici di coloro che risultano iscritti alle varie
logge. Quasi sempre gli elenchi li mandiamo noi, ma ad essi non segue nessuno
sviluppo degli elementi acquisiti e ci si limita a mandare le generalità,
notizie sull’attività svolta, qualche volta la denuncia dei redditi dell’ultimo
anno e se quelle persone abbiano avuto “pregiudizi penali”, con ciò intendendo
giudiziari. Ma questa è una attività che potremmo benissimo svolgere noi
collegandoci all’anagrafe comunale e tributaria, o al terminale del ministero
degli Interni. Questa degli organi di polizia è una strana indisponibilità,
strana. La stranezza è subito spiegata. Negli elenchi in possesso di Cordova
innumerevoli sono gli ufficiali (esercito, CC, Finanza e Ps) appartenenti alle
logge. Moltissimi anche i generali. Ma essa proseguì anche tra tanti attacchi
contro il magistrato, infatti sempre in Oltre la cupola si legge: ‘Nel frattempo
il senatore Cossiga, sempre lui, viene a conoscenza del rapporto riservato che
Cordova aveva inviato al Csm e reagisce in maniera furibonda. «Fascista.
Paleostalinista. Modestissima persona. Ma chi ti ha fatto entrare in
magistratura? Meno male che non lo feci nominare Superprocuratore antimafia», è
solo qualche assaggio della vulgata cossighiana. Il senatore è infuriato per i
riferimenti ai suoi rapporti con Armando Corona contenuti nella relazione. «Nel
1987», si legge nel rapporto «Corona, tramite l’onorevole Sergio Berlinguer
(segretario generale del Quirinale), raccomandò a Cossiga il maresciallo De Lisa
perchè fosse trasferito al Sismi.» L’ex capo dello Stato è «intervenuto molte
volte in difesa della Massoneria, e Corona fu invitato all’insediamento di
Cossiga e si recò da lui centinaia di volte». Nel caso di inviti improvvisi
«Corona veniva prelevato all’aeroporto dagli autisti del Quirinale». Se ce ne
fosse ancora bisogno, ecco un’ulteriore prova di interferenza della massoneria
nei pubblici poteri: il capo dei massoni che raccomanda al capo dello Stato uno
007. Ma a Cossiga non pare così: «Cordova è andato a raccogliere spazzatura
negli angiporti di qualche confidente delle forze di polizia» dirà ai
giornalisti. La polemica non finisce lì, il senatore è fermamente intenzionato a
dare una spallata decisiva all’inchiesta. Telefona al presidente Scalfaro e gli
segnala una presunta illegalità del dossier Cordova, a cui fa seguire una
interpellanza urgente al presidente del Consiglio e ai ministri di Grazia e
Giustizia e dell’Interno dove adombra il sospetto di essere stato spiato da
Cordova in maniera abusiva. Cossiga si sente perseguitato, tanto da sostenere di
nutrire dubbi sulla sua incolumità e di avere bisogno di una scorta. Chiede
persino che la Procura di Roma apra una indagine su chi lo avrebbe intercettato,
visto che la raccomandazione di Corona gli arrivò per telefono.
Questo dimostra di quanto sia difficile persino ad
un magistrato indagare su questo fronte così delicato. Poi Agostino Cordova
nell’ottobre 1993 fu trasferito a Napoli. Dice il giornalista Guarino: «Sperando
che la smetta di occuparsi di questioni tanto destabilizzanti per la politica e
la massomafia, i Palazzi del potere già da tempo avevano deciso di isolare
Cordova, attraverso giornali ed emittenti amiche. La sua candidatura a
Procuratore antimafia nazionale era stata bocciata, ma poichè il magistrato
aveva le carte in regola, ecco il trasferimento-promozione alla Procura di
Napoli, il 6 ottobre 1993. Un modo come un altro per far sì che non si
impicciasse più di massomafia-politica. Prima di trasferirsi a Napoli, Cordova
ha avuto la soddisfazione di assistere a una manifestazione popolare in suo
favore». Poi le indagini vennero trasferite – per «incompetenza tecnica» della
Procura di Palmi a occuparsi della materia – alla Procura di Roma nel giugno del
1994.
Il procedimento rimase pressoché fermo per quasi
sei anni, e poi nel dicembre 2000, il giudice per le indagini preliminari
dispose l’archiviazione dell’inchiesta, nonostante nel corso degli anni fossero
stati raccolti ottocento faldoni e ci fossero sessantun indagati.
Finanza. La
Massoneria ha forti legami con l’alta finanza, l’economia e gli affari (legami
che ovviamente determinano anche scelte e indirizzi politici sia a livello
nazionale che internazionale); e questo perchè da sempre la libera muratoria
rappresenta le élites, il mondo dell’establishment. Prima di parlare di questi
legami però è bene tenere presente che la massoneria ha avuto un ruolo
fondamentale nell’unità d’Italia, in quanto dietro Garibaldi e Cavour c’era la
Massoneria inglese, che infatti finanziò la spedizione dei Mille condotta da
Giuseppe Garibaldi, lui stesso massone (anzi ‘Primo massone d’Italia’). Ed
inoltre bisogna considerare che i primi passi dell’Italia unita furono guidati
da un Parlamento costituito in gran parte da massoni ed è cosa risaputa che i
Massoni si aiutano tra di loro per cui i politici massoni spesso e volentieri
aiutano e favoriscono i finanzieri e imprenditori massoni e viceversa.
D’altronde è stato provato che persino nella
magistratura i giudici massoni non sono imparziali, in quanto favoriscono i loro
fratelli massoni nei processi. Tra i numerosi parlamentari che erano massoni
ricordiamo i seguenti. Bonaventura Mazzarella (1818-1882). Il 27 gennaio 1861,
quando si tennero le consultazioni elettorali per scegliere il primo Parlamento
del Regno d’Italia, fu eletto nel collegio di Gallipoli. Nel gennaio 1863
riprese la sua attività di magistrato dopo essere stato richiamato dal ministro
di Giustizia a svolgere le funzioni di consigliere presso la corte d’appello di
Genova. La nomina a magistrato lo costrinse a dimettersi da deputato fino alle
elezioni del 22 ottobre 1865, quando entrò alla Camera, dove sarebbe rimasto
anche per le successive legislature schierato nelle fila dell’estrema Sinistra.
Carlo Pellion di Persano (1806-1883). Deputato nelle legislature VII e VIII per
il collegio della Spezia, divenne Ministro della Marina nel primo governo
Rattazzi e fu nominato senatore l’8 ottobre 1865. Agostino Depretis (1813-1887).
Fu presidente del Consiglio dei ministri italiano ben nove volte tra il 1876 e
il 1887. Michele Coppino (1822-1901). Nel 1860 venne eletto nell’ultima
legislatura del Regno di Sardegna, e rieletto nel 1861 nella prima legislatura
del Regno d’Italia. Da allora fece parte del Parlamento quasi ininterrottamente
per quarant’anni, e fu più volte Presidente della Camera dei deputati. Ministro
della pubblica istruzione nel primo e nel secondo governo Depretis (1876-1878),
nel 1877 varò la riforma (Legge Coppino) che rese obbligatoria e gratuita la
frequenza della scuola elementare. Fu nuovamente ministro dell’istruzione nei
governi Depretis e Crispi tra il 1884 e il 1888. Francesco Crispi (1818-1901).
Fu presidente del consiglio dei ministri del Regno d’Italia dal luglio 1887 al
febbraio 1891 e dal dicembre 1893 al marzo 1896.
Giuseppe Zanardelli (1826-1903). Fu per alcune
volte presidente della Camera; ministro dei Lavori Pubblici nel primo governo
Depretis del 1876 e ministro della Giustizia nel governo Depretis del 1881. Fu
inoltre Presidente del Consiglio dei ministri dal 1901 al 1903. Tra la fine del
diciannovesimo e l’inizio del ventesimo secolo, la massoneria ebbe un ruolo
importante nel decollo economico e finanziario del Nord Italia, infatti la Banca
Commerciale Italiana (Comit) – che è stata una delle prime e più importanti
banche italiane – fu fondata nel 1894 dal massone Otto Joel (insieme a Federico
Weil) il quale ne fu direttore centrale tra il 1894 e il 1908, e successivamente
ne fu amministratore delegato. Sarà proprio Otto Joel a chiamare in Italia il
potente banchiere massone Giuseppe Toepliz nel 1891, il quale avrà grande parte
nello sviluppo del Nord industriale italiano negli anni a venire. Terminata la
prima guerra mondiale, la Comit contribuì alla riconversione postbellica
dell’apparato produttivo. Nel corso degli anni venti, la banca – guidata da
Giuseppe Toeplitz – fu sempre più coinvolta nel finanziamento dei grandi gruppi
industriali, diventandone in molti casi azionista di maggioranza. Nello stesso
periodo la Comit proseguì la sua espansione all’estero, soprattutto nell’Europa
Centrale, Orientale e balcanica, fino alla Turchia e all’Egitto. La grande
economia – spiega lo storico Aldo Mola – era in mano allora a uomini della
finanza di appartenenza massonica: ‘Giuseppe Volpi, Otto Joel, Giuseppe Toepliz,
vale a dire l’alta banca privata, Bonaldo Stringher, direttore generale della
Banca d’Italia e membro autorevole della ‘Dante Alighieri’, e numerosi altri
esponenti di prima fila del mondo finanziario, largamente rappresentato tra le
colonne dei Templi massonici oltre che presso Borse, Camere di commercio,
consigli d’amministrazione di società finanziarie, commerciali, industriali,
erano andati ultimamente imprimendo fiduciosa e dinamica baldanza alla politica
estera italiana» (Aldo Mola, Storia della Massoneria Italiana, pag. 393-394).
Tra gli imprenditori massoni che in quel periodo contribuirono a far decollare
l’economia dell’Italia Unita, segnaliamo il potente imprenditore Luigi Orlando
che apparteneva alla Loggia segreta Propaganda, che era stata creata nel 1877
per accogliere importanti personaggi della vita politica, economica e
finanziaria del paese. Luigi Orlando (1862-1933) comprò nel 1902 da un gruppo di
francesi la Società Metallurgica Italiana (SMI) che era una società metallurgica
con tre stabilimenti situati a Limestre, Livorno e Mammiano. Nel 1905 poi
Orlando fondò la SELT – Società Ligure Toscana di Elettricità con il sostegno
del gruppo industriale degli Odero di Genova e della Banca Commerciale Italiana.
Nel primo dopoguerra la massoneria finanziò il movimento fascista aiutandolo ad
andare al potere, e questo perchè ‘nel primo dopoguerra la massoneria, composta
in prevalenza di elementi della piccola e media borghesia, sebbene si ispirasse
a un patriottismo democratico di origine risorgimentale e coltivasse in larga
misura propensioni progressiste, fu coinvolta dalla paura del bolscevismo e
dall’ansia del ristabilimento dell’ordine. «Si spiega così come mai alcune logge
vedessero con favore il movimento fascista fin dalle origini e molti massoni
partecipassero a questo e poi al Pnf» …. «Questi massoni fascisti appartenevano
in parte a logge dipendenti dal Grande Oriente di Palazzo Giustiniani, di cui
era Gran Maestro Domizio Torrigiani, e in parte forse maggiore alle logge
scissioniste di tendenza conservatrice, dipendenti dalla Gran Loggia di piazza
del Gesù di cui era Gran Maestro Raoul Palermi, che a Mussolini, già incontrato
alla vigilia della marcia su Roma, conferì in seguito la sciarpa e il brevetto
di 33° grado». Il rapporto tra fascismo e massoneria, quindi, per alcuni anni fu
tutt’altro che conflittuale. E’ così, a cominciare dal finanziamento offerto da
alcune logge milanesi alle squadre fasciste che si apprestavano a marciare su
Roma. L’andata al potere del fascismo, del resto, fu auspicata da Palazzo
Giustiniani fin dal 19 ottobre del 1922, pur con l’avvertimento che i massoni
sarebbero insorti a difesa della libertà, qualora venisse imposta all’Italia una
dittatura o un’oligarchia. Tra i finanziatori del nascente fascismo vi furono
gli industriali massoni Cesare Goldmann e Federico Cerasola e il ‘fratello’
Napoleone Tempini, poi perseguitati dallo stesso Mussolini. Il fascio di Milano
fu fondato da Mussolini il 21 marzo del 1919 al numero 9 di piazza San Sepolcro,
grazie a Cesare Goldmann, che mise a sua disposizione il salone dell’Alleanza
industriale e commerciale di Milano. Fra gli intervenuti c’erano i ‘fratelli’
Eucardio Momigliano, Camillo Bianchi e Pietro Bottini; Michele Bianchi,
affiliato a piazza del Gesù; Ambrogio Binda, medico personale di Mussolini e
massone di piazza del Gesù; Federico Cerasola, presidente del Collegio dei
venerabili delle logge milanesi obbedienti a Palazzo Giustiniani; Roberto
Farinacci, iscritto alla massoneria di Palazzo Giustiniani nel 1915 e passato a
quella di piazza del Gesù nel 1921; Decio Canzio Garibaldi, Mario Giampaoli e il
citato Cesare Goldmann; Luigi Lanfranconi, massone di piazza del Gesù; Giovanni
Marinelli; Umberto Pasella, affiliato a piazza del Gesù; Guido Podrecca,
direttore de ‘L’Asino’; Luigi Razza, affiliato a piazza del Gesù: e Cesare
Rossi’ (Ferruccio Pinotti, Fratelli d’Italia, pag. 327-329). Ricordiamo peraltro
che l’economista massone Alberto Beneduce (1877-1944), conoscitore e manovratore
dei meccanismi finanziari, lavorò nell’ombra per lunghi anni con Benito
Mussolini (che aveva grande stima di lui) e il suo ruolo fu essenziale nella
ristrutturazione dell’economia italiana successiva alla crisi mondiale del 1929.
Il Beneduce fu infatti tra gli artefici della creazione dell’IRI e suo primo
presidente. L’IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale) è stato un ente
pubblico italiano, istituito nel 1933 per iniziativa dell’allora capo del
Governo Benito Mussolini al fine di evitare il fallimento delle principali
banche italiane (Commerciale, Credito Italiano e Banco di Roma) e con esse il
crollo dell’economia, già provata dalla crisi economica mondiale iniziata nel
1929. Nel secondo dopoguerra, alla ricostruzione dell’economia italiana ha dato
un forte impulso oltre che la Comit anche Mediobanca, un istituto di credito
italiano fondato nel 1946 per iniziativa di Raffaele Mattioli (allora Presidente
della Banca Commerciale Italiana che ne fu promotrice insieme con il Credito
Italiano) e di Enrico Cuccia (che ne fu il Direttore Generale dalla fondazione
al 1982). ‘Mediobanca fu costituita per soddisfare le esigenze a media scadenza
delle imprese produttrici e per stabilire un rapporto diretto tra il mercato del
risparmio e il fabbisogno finanziario per il riassetto produttivo delle imprese,
reduci dalle devastazioni della Seconda guerra mondiale’. Ebbene, il banchiere
Enrico Cuccia (1907-2000), era un massone membro della loggia massonica segreta
‘Giustizia e Libertà’ (cfr. Aldo Mola, Storia della Massoneria Italiana, pag.
744), ed è stato uno degli uomini più potenti d’Italia (ed anche d’Europa) fino
alla sua morte. Raffaele Mattioli, stando alla biografia ufficiale, non era
massone, ma sul sito del Grande Oriente democratico si dice di lui che di
Massoneria ed Esoterismo se ne intendeva assai. In merito al ruolo della Comit e
di Mediobanca nella ricostruzione economica postbellica, è interessante quello
che dice lo storico Silvano Danesi: «Il piano Marshall era uno strumento
economico strettamente connesso con la Nato, ossia con la partecipazione a
un’alleanza difensiva che legava tra loro le due sponde dell’Atlantico. Gli
Americani, quando pensarono al nostro Paese, delegarono in buona sostanza il
governo della nazione ai cattolici, che avevano il consenso della maggioranza
della popolazione e una rete diffusa di presidi (le parrocchie) sul territorio;
mentre la gestione dell’economia fu affidata alla finanza laica che, nella
fattispecie, era incarnata da Comit e da Mattioli. Mattioli, la Comit,
Mediobanca e Cuccia sono stati, dunque, gli interlocutori e i garanti di una
ricostruzione che doveva avvenire all’interno di un patto, quello atlantico, che
scaturiva dalla sconfitta del fascismo e del nazismo. [...] Mattioli fu il
garante di quel patto sul versante finanziario, così come De Gasperi lo fu su
quello politico. [...] La Comit e Mediobanca, indipendentemente dal fatto che
Cuccia fosse massone, sono state, in primo luogo, la cabina di regia della
ricostruzione dell’economia reale e del capitalismo italiani all’interno di uno
schema atlantico».
Veniamo ora alla FIAT che ha avuto un ruolo
fondamentale nello sviluppo economico dell’Italia nel dopoguerra. Dice Ferruccio
Pinotti che i padroni della Fiat hanno sempre avuto rapporti di simpatia e
frequentazione con il mondo massonico [....]. Tutto l’ambiente in cui si muovono
gli Agnelli, sin dalla fine dell’Ottocento, è di impronta massonica (Ferruccio
Pinotti, Fratelli d’Italia, pag. 351). Giovanni Agnelli senior (1866-1945), che
fu tra i fondatori della casa automobilistica FIAT nel 1899 e ne fu
amministratore delegato e presidente, aveva come stretto collaboratore di alto
livello il professore Attilio Cabiati, che era un massone. Peraltro, nel 1908 la
massoneria venne in aiuto a Giovanni Agnelli – che era imputato di illecita
coalizione, aggiotaggio e falso in bilancio – infatti Vittorio Emanuele Orlando,
che era l’allora ministro della Giustizia e che era un importante massone,
esercitò un’ingerenza nei confronti della magistratura torinese e affermando che
«un’azione penale nei confronti di Agnelli avrebbe avuto conseguenze negative
sulla nascente industria nazionale, in particolare piemontese». E così con la
benevola attenzione del ministro Vittorio Emanuele Orlando e attraverso ricorsi
vari, Agnelli riuscì a rinviare il processo sino al 21 giugno 1911, e poi il 22
maggio 1912 il Tribunale assolse Agnelli, e a nulla servì il ricorso del
pubblico ministero. Giovanni Agnelli nel 1921 chiamò alla Fiat come direttore
centrale il massone Vittorio Valletta, che poi seguirà e affiancherà Giovanni
Agnelli junior per alcuni decenni. Giovanni Agnelli assieme a Vittorio Valletta
saranno tra i primi membri italiani del Bilderberg Group, che è un potente
circolo finanziario paramassonico mondiale sorto ufficialmente nel 1954 ma le
cui prime riunioni informali si tennero già nel 1951. Alla morte di Giovanni
Agnelli senior, Valletta assumerà la presidenza della FIAT e ne rimarrà
presidente fino al 1966 quando poi verrà nominato senatore a vita. Il suo posto
lo prenderà Gianni Agnelli «l’avvocato» (1921-2003), che, secondo il giornalista
Roberto Fabiani, conobbe la massoneria su incitamento dell’allora presidente
della Fiat e massone Vittorio Valletta e secondo Licio Gelli faceva parte di
una loggia «coperta», la loggia di Montecarlo, il che non meraviglia affatto
visto che l’appartenenza a logge coperte o segrete di importanti personaggi
italiani dell’economia e della finanza è una cosa molto diffusa da molto tempo,
in quanto ciò serve a proteggere questi importanti personaggi ‘da pressioni
indebite da parte di altri «fratelli», parole queste di Giuliano Di Bernardo ex
Gran Maestro del GOI, come anche non meraviglia che questa loggia a cui
apparteneva Gianni Agnelli fosse all’estero, visto che l’affiliazione all’estero
pare essere una prassi per i personaggi molto importanti della finanza,
dell’economia e della politica. Peraltro Gianni Agnelli è stato uno dei
fondatori della Commissione Trilaterale che collaborò con David Rockefeller. Non
sorprende quindi affatto venire a sapere (lo ha dichiarato lo stesso Agnelli ai
giudici, e la cosa è stata confermata dall’ex Gran Maestro del GOI Giuliano di
Bernardo) che la FIAT ha finanziato abbondantemente il Grande Oriente d’Italia
all’epoca quando era Gran Maestro Lino Salvini. Oltre a Gianni Agnelli, un altro
noto imprenditore e finanziere massone che ha avuto un ruolo importante
nell’economia e nella finanza in Italia è Carlo De Benedetti. Anche lui infatti
– come Gianni Agnelli – risulta affiliato alla Massoneria, in quanto risulta
essere entrato nella Massoneria a Torino, nella loggia Cavour del Grande Oriente
d’Italia, «regolarizzato nel grado di Maestro il 18 marzo 1975 con brevetto n.
21272». L’anno prima, De Benedetti era diventato presidente dell’Unione
Industriali di Torino. Nel 1978 entrò in Olivetti, di cui divenne presidente. In
questa azienda pose le basi per un nuovo periodo di sviluppo, fondato sulla
produzione di personal computer e sull’ampliamento ulteriore dei prodotti, che
vide aggiungersi stampanti, telefax, fotocopiatrici e registratori di cassa.
Però a causa di una grave crisi della Olivetti, nel 1996 decise di lasciare
l’azienda, (di cui rimase presidente onorario fino al 1999) dopo aver fondato la
Omnitel. Nel 1987, attraverso la CIR, De Benedetti entrò nell’editoria
acquisendo una partecipazione rilevante nella Arnoldo Mondadori Editore e,
attraverso di essa, nel gruppo Espresso-Repubblica. Nel 1997 l’Espresso
incorporò Repubblica e assunse l’attuale denominazione di Gruppo Espresso. E
veniamo all’imprenditore Silvio Berlusconi, l’ex presidente del Consiglio, che è
uno degli uomini più ricchi e potenti in Italia, perchè anche lui è massone, in
quanto risulta essersi iscritto alla Loggia P2 – anche questa una loggia coperta
come quella di Montecarlo – di cui Licio Gelli era il Maestro Venerabile.
Berlusconi fu iniziato alla Loggia massonica P2 (Tessera n° 1816, Fascicolo
0625) nel 1978. Per quale ragione Berlusconi è entrato nella Massoneria, ce lo
dice Gioele Magaldi del Grande Oriente Democratico: «…. l’adesione di Berlusconi
alla Massoneria non fu soltanto il desiderio di entrare a far parte di un
network nazionale e internazionale molto potente: in lui c’era anche un
desiderio filosofico autentico di percorrere un sentiero iniziatico di
perfezionamento spirituale. Certo, la sua idea della Via massonica era e resta
un’idea elitaria, gerarchica, oligarchica, in nome della quale dei Gruppi
ristretti di Maestri (presunti) Illuminati hanno il diritto-dovere di manipolare
le masse, asservendole ai loro disegni superiori». E sempre il Magaldi ci spiega
come la Massoneria ha aiutato Berlusconi ad arrivare alla sua posizione
dominante nel campo dei mezzi di comunicazione e ad entrare nel mondo della
politica, infatti dice: Grazie alla protezione di Gelli e di altri potenti
Fratelli Massoni piduisti, negli anni ’70 innanzitutto Berlusconi fu “sdoganato”
dallo status di semplice imprenditore brianzolo a quello di player autorevole
nel mondo dei media. I Fratelli Massoni consentirono al titolare della tessera
P2 n.1816 di diventare un autorevole opinionista sul Corriere della Sera
“piduista”, mentre iniziava l’acquisizione azionaria del Giornale di Indro
Montanelli. Dopo di che, già dagli anni 1978-80, i dirigenti della P2
pianificarono che Berlusconi potesse essere il loro “cavallo di Troia” per la
costituzione progressiva di un gruppo televisivo privato al servizio dei loro
interessi, secondo quanto prevedeva il cosiddetto “Piano di rinascita
democratica” stilato pochi anni prima. Non bisogna dimenticare, però, che a
partire dalla primavera 1981, dopo il blitz di Castiglion Fibocchi del 17 marzo
1981 che dette origine al cosiddetto “scandalo P2”, il Fratello Berlusconi
iniziò a “guardarsi intorno” in cerca di nuove protezioni. Che trovò
immediatamente e in modo clamoroso proprio nel principale avversario di Licio
Gelli nel G.O.I: l’ex Presidente della Corte Centrale (massonica) e Gran Maestro
di Palazzo Giustiniani a partire dal 1982, Fratello Armando Corona. Proprio
negli anni dal 1982 al 1990 Berlusconi verrà supportato in modo formidabile a
incrementare e conservare lo status di semi-monopolista della televisione
privata italiana, con importanti “sortite” industriali anche all’estero. E sarà
supportato dalla Massoneria italiana e internazionale così come dal PSI craxiano
a grande densità massonica. Ma dal 1982 al 1990 (anni della Gran Maestranza del
G.O.I. di Armando Corona) i Fratelli che aiutarono Berlusconi a diventare
dominus nel campo dei media non erano per la gran parte piduisti. Erano Massoni
importanti, semmai, come il Gran Maestro Corona, che insieme al Presidente della
Repubblica Francesco Cossiga (dal 1985 al 1992), all’Onorevole Giuseppe Pisanu,
a Flavio Carboni e ad altri, si riunivano spesso e volentieri per dei summit
strategici con il Fratello Silvio Berlusconi . Sempre in merito a questo legame
tra massoneria e finanza, ricordiamo che nel mese di Marzo del 2007 partì dalla
Procura di Catanzaro, guidata dal sostituto procuratore Luigi De Magistris,
un’inchiesta sui rapporti tra politica corrotta, massoneria, lobby d’affari e
malavita organizzata. Il sistema affaristico indagato da De Magistris sarebbe
stato tenuto, secondo l’ipotesi accusatoria, da una loggia massonica coperta con
sede a San Marino: un comitato d’affari che avrebbe influito sulle scelte di
amministrazioni pubbliche sia per l’utilizzo di finanziamenti europei che per
l’assegnazione di appalti. Ed a conferma di questo stretto legame, nel libro
Fratelli d’Italia di Ferruccio Pinotti c’è una testimonianza molto interessante
fatta ad un banchiere di cui viene occultato il vero nome (come vengono
occultati altri nomi per ragioni legali) e che viene chiamato Fabrizio Girelli,
il quale racconta una storia reale – ambientata nel mondo bancario del profondo
Nord – sostenuta da documenti depositati presso uno studio legale. Trascrivo una
parte di questa testimonianza. «Sono stato assunto alla Banca Popolare nel 1994
dopo alcuni mesi di indecisione sulle mie future scelte professionali. Ero
infatti in procinto di trasferirmi a Londra per Banque Paribas dopo aver
sostenuto con successo il colloquio di selezione presso la sede inglese della
banca d’affari. La decisione di scegliere l’istituto anziché Londra è stata
presa per ragioni familiari; era infatti dal 1986 che la mia vita si svolgeva
lontano da casa e vedevo la soluzione Banca Popolare come un’opportunità di
avvicinamento.
Non era facile per le mie caratteristiche
professionali trovare un lavoro soddisfacente vicino a casa. Avevo lavorato
esclusivamente in istituzioni finanziarie internazionali (Goldman Sachs, Merrill
Lynch e ING) e la professionalità maturata in molti anni di lavoro con
esperienze anche all’estero non rendevano facile una collocazione in una banca
italiana. Dovetti accettare un ridimensionamento professionale ed economico
significativo in cambio di una scelta di vita e mi sono rimesso in gioco.
D’altronde pensavo che gestire la fase di ristrutturazione di un istituto di
credito, anche se piccolo, avrebbe potuto creare delle opportunità e una nuova
esperienza che poteva anche riuscire interessante.». Gli inizi furono un pò
faticosi, per il giovane banchiere. «I primi mesi furono molto difficili perchè
non riuscivo ad adeguarmi ai lenti ritmi di lavoro e la mentalità era un pò
troppo arretrata. Dopo un mese circa di assoluta inattività iniziai a cercare di
capire almeno i numeri della tesoreria per sapere come la banca gestiva il
portafoglio titoli di proprietà e quali erano i risultati che si prospettavano
per fine anno. Insomma, non si sapeva se si guadagnava o si perdeva e non
c’erano strumenti di monitoraggio adeguati per valutare le posizioni
d’investimento. Con mia enorme sorpresa, fu difficilissimo ottenere i dati
relativi a un portafoglio titoli che era di quasi 600 miliardi nel 1994 e
incontrai un certo ostruzionismo da parte di alcune persone che vedevano il mio
interessamento come un’intrusione in affari altrui.» Quando chiese il perchè di
questa strana difficoltà ad avere i dati, Fabrizio incontrò le prime allusioni
alla massoneria e ad altri giri di potere occulto che alcune persone
esercitavano nella banca, scoprendo che alcuni percorsi di carriera all’interno
dell’azienda sembravano, per alcune persone, già tracciati e accettati dai più
come cose fatte. «Ma non volli fermarmi a quelle voci e mi impegnai ancora di
più nel lavoro. Con l’aiuto di un bravo impiegato del settore si iniziò la
ricostruzione manuale di tutta la posizione in titoli che richiese più di un
mese. Alla fine emerse con enorme stupore che la banca stava perdendo circa 150
miliardi ma nessuno lo sapeva, o almeno si cercava di non farlo sapere. 150
miliardi erano l’intero patrimonio di allora e quando me ne resi conto fui preso
dal panico. Avevo deciso di venire a lavorare in un istituto dove avrei dovuto
giocarmi tutto il mio passato e il mio futuro e ora mi accorgevo che la mia
scelta era stata un gravissimo errore perchè la banca era virtualmente fallita.
Tutto poteva finire in poche settimane nel peggiore dei modi. Potevo già
immaginare una imminente aggregazione con un altro istituto dove avrei dovuto
spiegare che io non c’entravo nulla e che avevo trovato una situazione
disastrosa. La banca sarebbe fallita su errati investimenti in titoli e io ero
il responsabile, seppure da pochi mesi, proprio di quel settore. Le voci su
interferenze massoniche proseguivano, ma non sapevo che peso veramente
attribuire a tali indiscrezioni e come valutarle. Cercai di tenere duro.»
Fabrizio Girelli spiega: «In ogni caso non potevo tornare più indietro e mi
diedi da fare per informare la direzione e cercare di uscire dalla tragica
situazione. Il nuovo direttore generale Ramada dovette correre in Banca d’Italia
per informare la vigilanza e dopo alcune titubanze gli fu concesso un anno per
sistemare le cose. Con un pò di fortuna e una serie di operazioni azzeccate
uscimmo da tale situazione; e nell’arco di un anno eravamo ancora in corsa per
la possibilità di iniziare a esplorare nuove esperienze manageriali, nuove
strategie e nuove iniziative. La banca era ripartita e i risultati erano
veramente incoraggianti. Da parte mia ero riuscito a creare un gruppo di persone
veramente affiatato e molto motivato. Quando ero arrivato mi avevano assegnato
un ufficio di tre persone. Alla fine del 1999 avevo una intera direzione con
oltre 60 persone e il 50 per cento dei ricavi dell’istituto provenivano
direttamente e indirettamente dal settore finanziario. Tutto andava per il
meglio fino a quando nell’estate del 1999 la direzione generale decise di
acquistare una rete di promotori finanziari». Di nuovo il giovane banchiere non
capisce, sente che c’è qualcosa di strano. «Quella decisione non venne motivata.
E di nuovo iniziarono i rumors che parlavano di pressioni massoniche
dell’ambiente romano per effettuare quella acquisizione. Purtroppo tale acquisto
si rivelò una decisione sciagurata perchè la rete rilevata celava una serie di
pesantissime minusvalenze sul portafoglio titoli e questa situazione era stata
tenuta nascosta dai venditori alla direzione. Non essendo stata effettuata
alcuna due diligence [verifica tecnica basata su parametri bancari specifici]
sulla composizione delle attività finanziarie in essere sui clienti, nessuno si
era accorto che la rete era ingestibile e che le perdite sui titoli della
clientela avrebbero compromesso qualsiasi possibilità di ottenere reddito da
tale acquisizione, anche perchè il portafoglio dei clienti avrebbe potuto
rimanere immobilizzato per anni in attesa che i titoli obbligazionari
strutturati, che erano stati collocati a suo tempo, tornassero al valore di
emissione. Le minusvalenze complessive si quantificavano in circa 80 miliardi su
un portafoglio di 500 miliardi circa. Una cifra enorme per una piccola banca del
Nord come la nostra, dove tutti i ricavi di un anno (il margine lordo
d’intermediazione), in quel periodo, assommavano a 200 miliardi di lire. Fui io
a constatare il disastro in seguito ad alcune verifiche che avevo fatto fare da
un collaboratore e informai con urgenza la direzione generale». Ma fu così che
iniziarono i problemi di Fabrizio Girelli, che fu costretto a dimettersi nel
2002 perchè – con le sue prese di posizione contrarie alla filosofia aziendale –
si era rifiutato di entrare nel giro dei grembiulini che dominava dentro e fuori
la banca, e una volta uscito fu investito da una vasta ondata di diffamazione,
infatti tra le altre cose la direzione cercò di far capire ai suoi ex colleghi
che Girelli era stato licenziato perchè aveva provocato pesanti perdite alla
banca. Girelli passò un periodo difficile pensando più volte al suicidio a causa
del profondo stato di angoscia e depressione nel quale si trovava. Poi alla fine
però, grazie all’intervento della magistratura con la quale il Girelli collaborò
come persona informata dei fatti sul dissesto di Banca Popolare, magistratura
che fece emergere connessioni criminali e giri pericolosi in cui era coinvolta
l’ex banca di Girelli, venne fuori la verità, e lui ‘ha visto riconosciute le
ragioni delle sue scelte coraggiose e contro corrente; in qualche modo ha
«vinto» la sua lunga guerra. Ma il prezzo pagato è stato alto. Dal lungo
racconto che fa il Girelli nell’intervista dunque emerge in maniera evidente che
nel sistema bancario e finanziario italiano esistono forti pressioni massoniche.
Stesso discorso ovviamente per quello internazionale. Esiste un forte rapporto
tra finanza massonica e finanza Vaticana, che secondo l’ex direttore finanziario
dell’Eni Florio Fiorini, ‘che conosce come pochi i rapporti tra finanza e poteri
occulti, i canali sotterranei attraverso i quali si decidono le sorti del denaro
(Ferruccio Pinotti, Fratelli d’Italia, pag. 370), si è venuto a creare con
Giovanni XXIII (che fu eletto papa nel 1958), che risulta infatti essere stato
affiliato alla massoneria. Dice Fiorini: ‘La finanza vaticana è stata più o meno
stabile fin tanto che non è arrivato al soglio pontificio Giovanni XXIII. Prima
di lui, ad avere in mano la finanza vaticana era la cosiddetta ‘nobiltà nera’,
la quale era imparentata sia coi francesi – basti citare Paolina Bonaparte, che
aveva sposato il principe Borghese – sia con gli inglesi, pensiamo al legame
dell’ammiraglio Nelson con Napoli. Quindi la finanza vaticana, gestita dalla
nobiltà romana, era infiltrata da elementi di contatto con la massoneria
francese e inglese, che fungevano da ‘sponde’ internazionali in Europa. Tutto
cambiò con Giovanni XXIII il quale, da buon figlio di contadini, non si sentiva
legato a questo mondo della nobiltà romana ed europea. Era invece un uomo che
aveva viaggiato e che come nunzio apostolico aveva conosciuto molte realtà. In
particolare, fu il primo Papa a orientare la finanza vaticana verso gli Stati
Uniti, e il tramite per operare quel cambiamento fu il potente cardinale di New
York Francis Spellman, il «gran protettore» dei Cavalieri di Malta, il quale era
vicino alla massoneria e attivo negli USA dal 1927, e che aveva intensi rapporti
con l’ingegnere Bernardino Nogara, il noto amministratore delle finanze vaticane
che lo Spellman definì ‘dopo Gesù Cristo la cosa più grande che è capitata alla
Chiesa cattolica’, e questo perchè dopo che il Vaticano concluse i Patti
Lateranensi con il Governo di Mussolini nel 1929, fu proprio Nogara ad
amministrare i soldi che il Vaticano ricevette dallo Stato Italiano e a farli
fruttare grandemente. Per cui si può dire che i mezzi finanziari che lo Stato
italiano diede al Vaticano costituirono il fondamento su cui venne costruito
quell’impero finanziario che il Vaticano costituisce oggi. Entriamo un pò nel
merito per spiegare cosa avvenne. Il giorno stesso in cui l’accordo con Benito
Mussolini fu ratificato Pio XI creò una nuova agenzia finanziaria, la
Amministrazione Speciale della Santa Sede e ne nominò suo direttore e manager
Bernardino Nogara. Costui accettò la proposta del papa perché il papa soddisfece
le sue richieste tra cui c’erano queste: che tutti gli investimenti che egli
scegliesse di fare fossero totalmente e completamente liberi da qualsiasi
considerazioni religiose o dottrinali; che egli fosse libero di investire i
fondi del Vaticano dovunque nel mondo. E così Nogara si mise in moto. Martin
Malachi, Gesuita ex-professore al Pontificio Istituto Biblico di Roma, nel suo
libro Rich Church, Poor Church (Chiesa Ricca, Chiesa Povera) edito nel 1984,
dice: ‘Fedele ai suoi piani iniziali, i primi maggiori acquisti di Nogara in
Italia furono attuati nel ramo del gas, dei tessili, nella costruzione pubblica
e privata, nell’acciaio, nell’arredamento, negli alberghi, in prodotti minerari
e metallurgici, prodotti dell’agricoltura, energia elettrica, armi, prodotti
farmaceutici, cemento, carta, legname da costruzione, ceramica, pasta,
ingegneria, ferrovie, navi passeggeri, telefoni, telecomunicazioni e banche.
Prima dello scoppio della seconda guerra mondiale il Vaticano acquisì il
controllo di molte compagnie e banche sia in Italia che all’estero e in molte
altre compagnie invece riuscì ad avere una partecipazione minore ma sostanziale.
Verso gli anni ‘30 il Vaticano possedeva circa 3 milioni e 716.000 metri
quadrati di beni immobili a Roma, e col tempo sarebbe diventato il maggior
proprietario terriero in Italia dopo lo stesso governo italiano.
Quando Mussolini ebbe bisogno di armamenti per
l’invasione dell’Etiopia nel 1935 una sostanziosa parte di essi fu provveduta da
una fabbrica di munizioni che Nogara aveva acquisito in nome del Vaticano. Il 27
giugno 1942 Pio XII, su proposta di Nogara, fondò una nuova società finanziaria
nel Vaticano chiamata Istituto per le Opere Religiose (IOR). La proposta di
Nogara era stata questa: ‘Stabilire una società ecclesiastica centrale per la
Chiesa Universale, una società dotata dello status di una banca all’interno
dello Stato sovrano della Città del Vaticano e che avesse il vantaggio di
appartenere al papato e al Vaticano; una società che si specializzasse
nell’investire e nel negoziare i fondi e le risorse degli enti ecclesiastici
della Chiesa intera. Tramite lo IOR i vari organismi ecclesiastici erano in
grado di investire il loro denaro in tutta segretezza ed esenti da tasse. Dopo
la seconda guerra mondiale, sempre sotto Nogara, l’impero finanziario vaticano
continuò a crescere. Quando Bernardino Nogara morì nel 1958 – lo stesso anno in
cui salì al soglio pontificio Giovanni XXIII – lasciò un Vaticano enormemente
ricco. Ma anche dopo la morte di Nogara le finanze continuarono a crescere,
appunto tramite Giovanni XXIII (che fu papa dal 1958 al 1963) che orientò la
finanza vaticana verso gli USA. Anche sotto Paolo VI (che fu papa dal 1963 al
1978), che era massone come il suo predecessore, il Vaticano continuò ad
arricchirsi grandemente. Verso la metà degli anni sessanta, le agenzie
finanziarie del Vaticano controllavano la metà delle agenzie di credito in
Italia. Molte industrie avevano dietro denaro del Vaticano. L’Istituto
Farmacologico Serono di Roma per esempio era di proprietà Vaticana. Nel 1968,
secondo quanto dichiarò l’allora ministro delle Finanze Preti, la S. Sede
possedeva titoli azionari italiani per un valore di circa 100 miliardi, con un
dividendo che oscillava dai tre ai quattro miliardi l’anno. Anche all’estero il
Vaticano possedeva titoli azionari per molti miliardi. Esso aveva pacchetti
azionari in diverse grandi compagnie internazionali tra cui la General Motors,
la Shell, Gulf Oil, General Electric, Betlehem Steel, International Business
Machines (IBM), e TWA. Nel 1971 Paolo VI nominò Paul Marcinkus (anche lui
massone) presidente dello IOR, e sotto la sua direzione lo IOR risultò coinvolto
in alcuni scandali finanziari a motivo di manovre finanziarie illegali da esso
compiuto con l’aiuto del finanziere siciliano Michele Sindona (massone) – il
mandato di cattura spiccato contro Sindona parlava "di prove documentali di
operazioni irregolari effettuate da Sindona per conto del Vaticano" -, e di
Roberto Calvi (anche lui massone), presidente del Banco Ambrosiano. Per tornare
agli investimenti del Vaticano negli USA, essi hanno delle implicazioni
massoniche perchè dopo il 1945 gli USA espressero la loro politica estera in
Italia anche attraverso la massoneria, e il Vaticano sfruttò questi canali per i
suoi investimenti negli USA. E così oggi la Chiesa Cattolica Romana americana è
tra le cinque potenze immobiliari negli USA. Ovviamente il Vaticano è una
potenza immobiliare anche in Italia. In un articolo dal titolo ‘San Mattone’
apparso su Il Mondo nel maggio 2007 e scritto da Sandro Orlando si legge per
esempio: Un quarto di Roma, a spanne, è della Curia. Partendo dalla fine di via
Nomentana, all’altezza dell’Aniene, dove le Orsoline possiedono un palazzo di
sei piani da oltre 50 mila metri quadri di superficie, mentre le suore di Maria
Ripatrarice si accontentano di un convento di tre piani; e scendendo a sud est
per le centralissime via Sistina e via dei Condotti, fino al Pantheon e a piazza
Navona, dove edifici barocchi e isolati di proprietà di confraternite e
congregazioni si alternano a istituzioni come la Pontificia università della
Santa Croce. E ancora, continuando giù per il lungotevere e l’isola Tiberina,
che appartiene interamente all’ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio. E poi
su di nuovo per il Gianicolo, costeggiando il Vaticano fino sull’Aurelia Antica
dove si innalza l’imponente Villa Aurelia, un residence con 160 posti letto, con
tanto di cappella privata e terrazza con vista su San Pietro, che fa capo alla
casa generalizia del Sacro Cuore. È tutto di enti religiosi. Un tesoro immenso
che si è accumulato nei decenni grazie a lasciti e donazioni: più di 8 mila
l’anno scorso nella sola area di Roma città. Ma non c’è solo la Capitale. La
Curia vanta possedimenti cospicui anche nelle roccaforti bianche del Triveneto e
della Lombardia: a Verona, Padova,Trento. Oppure a Bergamo e Brescia, dove gli
stessi nipoti di Paolo VI, i Montini, di mestiere fanno gli immobiliaristi. «Il
20-22% del patrimonio immobiliare nazionale è della Chiesa», stima Franco
Alemani del gruppo Re, che da sempre assiste suore e frati nel business del
mattone. Senza contare le proprietà all’estero. «A metà degli anni ‘90 i beni
delle missioni si aggiravano intorno ai 800-900 miliardi di vecchie lire, oggi
dovrebbero valere dieci volte di più», osserva l’immobiliarista Vittorio Casale,
massone conclamato che all’epoca era stato chiamato dal cardinale Jozef Tomko a
partecipare ad un progetto di ristrutturazione del patrimonio di Propaganda
Fide, il ministero degli Esteri del Vaticano.
Magistratura.
Alcune parole ora sui rapporti tra Massoneria e magistratura. Innanzi tutto va
detto che affiliarsi alla Massoneria non è reato, in quanto la Massoneria non è
tra le "associazioni segrete" proibite dalla Costituzione italiana con
l’articolo 18 (Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere
militare); tuttavia ‘il Consiglio Superiore della Magistratura ha affermato con
chiarezza l’incompatibilità fra affiliazione massonica e l’esercizio delle
funzioni di magistrato, perchè le caratteristiche delle logge massoniche sono
quelle di «un impegno solenne di obbedienza, solidarietà, e soggezioni a
principi e a persone diverse dalla legge» e determinano perciò «come conseguenza
inevitabile una menomazione grave dell’immagine e del prestigio del magistrato e
dell’intero ordine giudiziario»; e secondo la Cassazione, il giudice massone può
essere ricusato dall’imputato, in quanto l’appartenenza a logge preclude «di per
sè l’imparzialità» del magistrato (La Cassazione, 5a sezione penale n° 1563 /
98), in altre parole, perchè – come ha detto il giudice Alfonso Amatucci –
essere iscritti alla massoneria significa vincolarsi al bene degli adepti,
significa fare ad ogni costo un favore. E l’unico modo nel quale un magistrato
può fare un favore è piegandosi ad interessi individuali nell’ emettere
sentenze, ordinanze, avvisi di garanzia. Esistono allora magistrati che sono
massoni? Sì. Per esempio ecco cosa si legge nell’articolo dal titolo "E sui
magistrati massoni indagherà anche Conso" a firma di Franco Coppola e apparso su
La Repubblica il 15 luglio 1993: Smentiscono, querelano, minacciano fuoco e
fiamme. Ma i loro nomi sono lì, negli atti giudiziari raccolti dalle procure di
Palmi e di Torino. Sono le toghe incappucciate, i magistrati sparsi per il
territorio nazionale che hanno giurato fedeltà alla Costituzione e al credo
massonico, qualcuno addirittura aderendo alle logge segrete, quelle
espressamente vietate anche a chi non fa parte dell’ ordine giudiziario. Per ora
sono usciti fuori 36 nomi, due o tre dei quali appartenenti a personaggi ormai
in pensione che hanno appeso nell’armadio dei ricordi le toghe da magistrati ma
forse non i grembiulini e i cappucci da massoni. E così ora di loro si occupano
non più soltanto il Consiglio superiore della magistratura, che può trasferirli
d’ufficio ad altra sede o ad altra funzione, ma anche il ministro della
Giustizia Giovanni Conso e il procuratore generale della Cassazione Vittorio
Sgroi che, come titolari dell’azione disciplinare, possono avviare un
procedimento disciplinare, le cui conseguenze potranno essere, a seconda dei
casi, blande o particolarmente severe.
Una annotazione finale: diamo per scontato che
tutti i magistrati qui elencati e le centinaia di colleghi iscritti alla
massoneria svolgano il loro lavoro con diligenza e professionalità. Quello che
il cittadino (vittima, imputato, parte offesa, imprenditore a rischio
fallimento) ha il diritto di sapere è che restano legati fino alla morte a quel
giuramento. Che la massoneria non è un gioco di società dal quale si esce a
piacimento. E che violare quel patto ha significato, per molti, perdere la vita.
Tutt'altra storia è il caso di Paolo Ferraro.
Espulso dalla magistratura per aver “inventato” la presenza in Italia di sette e
poteri occulti. C’è una storia di ordinaria ingiustizia, che rimbalza sulla rete
ma non ottiene visibilità negli “autorevoli media” nazionali e che riguarda il
dottor Paolo Ferraro, un giudice già attivo in battaglie esemplari quali la
riconquista della nostra sovranità monetaria e della nostra indipendenza
nazionale, oggetto delle attenzioni della casta e al quale si vuole,
praticamente, togliere la dignità di cittadino ed essere umano. Contro Paolo
Ferraro, espulso di recente dalla Magistratura con provvedimento del CSM perché
accusato di essersi “inventato” la presenza e l’attività in Italia di massonerie
e sette sataniche, sta andando avanti a tappe forzate una “damnatio”. Il Csm ha
proposto innanzi al Tribunale di Roma un’istanza per porre Ferraro, addirittura,
sotto ad “amministrazione di sostegno e cure farmacologiche”. In sostanza una
richiesta di revoca di capacità giuridica di agire. Secondo Paolo Ferraro si
tratta in sostanza di un accerchiamento da più lati (ci sono di mezzo le
iniziative legali della coniuge separata) per bloccare la sua attività di
denuncia e politica. “Per il 14 marzo 2013 – scrive Paolo Ferraro – sono stato
convocato in udienza dinanzi al giudice tutelare di Roma (presidente della
sezione Tribunale) per la “nomina di amministratore di sostegno” non alla mia
anziana madre o alla signora terminale in ospedale… ma a me…Chi sa capisce
quanto grave sia questa iniziativa che significa togliere a un soggetto
autonomia capacità di agire ed in crescendo intrappolarlo rapidamente .. nella
direzione finale che è stata evidentemente tracciata dall’odio di chi credeva di
poter mettere tutto a tacere”. Paolo Ferraro svolgeva la funzione di sostituto
pm presso la Procura di Roma ed era definito anche dai colleghi come un
magistrato preparato, attento, scrupoloso e molto affidabile che ha sempre
portato a termine in modo ottimale i suoi compiti. In ogni caso, verso la fine
del 2008 formalizzava una denuncia in Procura assumendo che nella sua
abitazione, nel quartiere romano della Cecchignola, nei tempi in cui lui non era
in casa, avvenivano rituali satanici, pratiche sessuali in condizioni di ipnosi
e comunque sotto l’effetto di sostanze alteranti, che vedevano coinvolti adulti,
bambini e quale vittima posta in stato di incoscienza l’allora sua compagna. Una
denuncia suffragata da registrazioni audio ambientali. Il sospetto di quanto
potesse accadere a danno della sua donna e dei minori conduceva il dott. Ferraro
ad intraprendere “ingenuamente e inconsapevolmente comprendendone i tasselli,
legami e ruoli solo molto tempo dopo” – sue parole – una lunga e tortuosa
attività di studio e approfondimento personali che, a suo dire, lo portavano a
scoprire trame occulte e deviate tra i poteri istituzionali dello Stato, gli
alti gradi militari (che trovavano nel quartiere della Cecchignola abitazione),
psicologi, psichiatri e altri professionisti compiacenti, massoneria e sette
sataniche. Perciò le sue “denunce”, inizialmente passavano per i canali
“ufficiali e istituzionali”. Ciò l’avrebbe portato a “scoprirsi” e a divenire
obiettivo da neutralizzare per tali poteri deviati. Così si spiegherebbero, dal
suo punto di vista, un TSO convertito in ricovero volontario nel maggio/giugno
2009, con forzata assunzione di neurolettici; due procedure di dispensa dalle
sue funzioni, avviate presso il CSM nel 2009 e 2010 su segnalazione delle
Procure di Roma e Perugia e concluse con l’archiviazione; un’aspettativa per
infermità di più di un anno (agosto 2011- dicembre 2012), seguita dalla delibera
di dispensa dalle sue funzioni assunta per motivi di salute dal CSM lo scorso
06.12.2012 (che intende impugnare al TAR). La notifica del ricorso del
Procuratore Capo di Roma per la nomina di un amministratore di sostegno che
dovrà acconsentire in sua vece alla somministrazione a lui di psicofarmaci gli è
giunta il 7 marzo. Come nota Armando Manocchia, giornalista di imolaoggi, “al di
là della fondatezza o meno della sue tesi, va però tutelato il suo diritto
individuale di libertà a decidere del suo stato di salute ed, eventualmente, la
sua libertà di curarsi o meno; la nomina di un amministratore di sostegno, in
assenza di condizioni di pericolosità alcuna, è una violenza per lui e
violazione dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo che non può
venire tollerata. Non di meno il gravissimo fatto che lo sta coinvolgendo lede
la fondamentale libertà di espressione e manifestazione del pensiero”. Un
magistrato denuncia progetti di controllo mentale in Italia e l’esistenza di una
setta occulta che coinvolgerebbe alte cariche militari, con legami nella
giustizia, nella politica, nella psichiatria e nella massoneria deviata.
Difficile individuarli. Coperti da corporazioni, lobby e governi, di destra e di
sinistra, manipolano l’opinione pubblica e condizionano le menti di reclute,
politici, malati psichici, giovani donne e bambini per avere il controllo
sull’agenda mondiale e sulla storia. Il sostituto procuratore aggiunto di Roma
Paolo Ferraro è stato ascoltato dai pubblici ministeri che indagano sulla morte
di Melania Rea. Ferraro dopo avere raggiunto la procura è stato trasferito nella
sede del comando provinciale dei carabinieri di Teramo, nella caserma Porrani
per il colloquio con i pm Davide Rosati e Greta Aloisi ai quali lui stesso aveva
chiesto di essere sentito sul delitto. L’udienza è durata circa tre ore. Ferraro
ha parlato della sua indagine sulla presunta presenza di sette sataniche
all’interno delle caserme italiane, partendo da quanto accertato, sempre secondo
le sue affermazioni, nella caserma romana della Cecchignola. Il magistrato è
stato di recente sospeso dal Consiglio superiore della magistratura, in via
cautelativa per quattro mesi, per presunta infermità mentale. L’ex sostituto è
stato poi sottoposto a due perizie psichiatriche che hanno stabilito essere sano
di mente. Avrebbe riferito che le sue disavventure sono iniziate dal momento in
cui fu resa nota la sua indagine su presunte presenze massoniche e di sette
sataniche all’interno delle caserme italiane. L’ipotesi è che tali sette
potrebbero essere state presenti anche nella caserma di Ascoli Piceno nella
quale Parolisi prestava servizio come addestratore di reclute ed essere in
qualche modo in relazione con l’atroce delitto di Melania Rea. A proposito di
Melania lo stesso ex sostituto avrebbe dichiarato di averla notata o di aver
notato una donna molto simile alla vittima, qualche tempo prima della sua
scomparsa, negli uffici della procura di Roma.
Ma la Massoneria non e’ solo magistratura: è pure
politica. Se a livello nazionale la polemica tra iscritti al Pd e massoneria
crea imbarazzo, a livello locale molto meno, perlomeno laddove è tradizione
consolidata. A Perugia, per esempio, dove più di qualcuno ha iniziato a fare
“outing”. Mario Valentini, ex sindaco Psi negli anni Novanta e fondatore del Pd
perugino, oggi ricorda: “L’esperienza della massoneria, della quale mi onoro di
appartenere, è ricca di storia civile e progressista della città.
Considero la massoneria un patrimonio da
conservare e testimoniare. Quella in atto oggi nel partito è una polemica
vecchia, datata. Posso assicurare che, durante il mio mandato di sindaco, non ho
mai ricevuto pressioni che tendessero a condizionare la mia libertà di primo
cittadino”. Il legame tra massoneria e Pd non un mistero in città, ma ora dopo
il recente scandalo, il segretario locale invita alla calma: “Quella della
massoneria è una questione sensibile – spiega Giacomo Leonelli -. Chi aderisce
al Pd deve farlo in maniera trasparente, altrimenti crea disagio al partito e
agli altri militanti”. Sono soprattutto gli ex socialisti, ora confluiti nel Pd,
ad avere dimestichezza con grembiuli e cappucci. Ma non tutti sono disposti ad
ammettere di essere massoni. Cesare Fioriti dice: “Non sono massone, però
difendo la massoneria. E poi i principi della massoneria non sono forse validi?
Penso alla fratellanza, alla riflessione, allo sviluppo delle idee”. Angelo
Pistelli, altro esponente Pd ex socialista, dopo la polemica non si sente più a
suo agio nel partito: “In effetti del Pd ormai non condivido più tanto.
Bisognerebbe dare spazio a tutte le voci. Invece comandano le solite culture
dominanti, a noi resta ben poco. E poi sono sincero: se scoprissi che non ci
sono massoni nel gruppo dirigente del Pd mi dispiacerebbe”. A tal proposito uscì
un articolo: I grembiulini del Pd di Perugia di Marco Sarti su “Il Riformista”.
Il Pd e la massoneria.
Due realtà inconciliabili? Mentre in
Italia infuria la polemica, a Perugia il tema non appassiona più di tanto. La
sintesi tra squadre, compassi e militanza politica di sinistra, qui esiste da
decenni. E nessuno si stupisce più. Perché se il capoluogo umbro è un feudo
elettorale del Partito democratico, è anche vero che solo nelle vie del centro
si contano almeno 19 logge. E così, nella nuova casa
massonica perugina, in un antico palazzo a Corso Cavour, c'è persino chi si
indigna di fronte all'ipotesi che qualche fratello possa venire epurato dal Pd.
«Ma quale polemica… - si sfoga un responsabile del Collegio Venerabile - Nessuno
ha mai fatto caso che ogni volta che c’è una crisi si tira fuori questo
argomento? I nostri luoghi di ritrovo sono pubblici. Già nel lontano 1985
abbiamo sistemato una targa fuori dalla sede di Palazzo Giustiniani. Allo stesso
modo abbiamo messo bene in chiaro i nostri riferimenti sull’elenco telefonico.
Qualcuno si scandalizza se non viene resa pubblica anche l'identità dei nostri
fratelli? Eppure mi sembra che persino gli elenchi degli iscritti a partiti e
associazioni siano riservati». «I massoni del Pd? - racconta un anonimo
militante - Vengono tutti dal Partito socialista». In effetti, a Perugia, il
movimento storicamente più vicino al Grande Oriente è proprio quello un tempo
guidato da Bettino Craxi. La gente ancora ricorda una storica seduta del
Consiglio comunale, nei primi anni 90, quando il sindaco Mario Valentini (eletto
nelle liste del Psi, poi fondatore del Pd perugino) rivendicò con orgoglio la
sua appartenenza a un'influente loggia cittadina. «L'esperienza della massoneria
- racconta oggi Valentini - della quale mi onoro di appartenere, è ricca di
storia civile e progressista della città. E non mi riferisco solo al periodo
post-fascista, parlo anche della Perugia laica dopo il governo papalino.
Considero la massoneria un patrimonio da conservare e testimoniare. Una vicenda
fatta da uomini esempio di vita e rettitudine nel governo della cosa pubblica.
Quella in atto oggi nel partito è una polemica vecchia, datata. Posso assicurare
che, durante il mio mandato di sindaco, non ho mai ricevuto pressioni che
tendessero a condizionare la mia libertà di primo cittadino». Che tra i quadri
del Pd perugino, ancora oggi qualcuno si cimenti con cappucci e grembiule non è
un mistero.
Solo che, dopo il recente scandalo, nessuno è
disposto a parlare.
Giacomo Leonelli, segretario del Partito
democratico della città, predica calma: «Quella della massoneria è una questione
sensibile. Sono temi dove ognuno esprime le proprie idee secondo convinzioni
personali. Per carità, sono convinto che chi si iscrive al Pd lo fa perché crede
nel nostro progetto politico, non per altri fini».
A scanso di equivoci, il segretario si appella
allo statuto. «Chi aderisce al Pd deve farlo in maniera trasparente. Altrimenti
crea disagio al partito e agli altri militanti». Eppure sembra che fare politica
tra Piazza Morlacchi e Corso Vannucci non possa prescindere da certi
riferimenti. «Quando si governa a Perugia - conclude Leonelli - è normale
entrare in contatto con determinate realtà cittadine». Contattati al telefono, i
componenti della piccola pattuglia socialista nel Pd non si stupiscono di certi
accostamenti.
Ma negano, con cortesia, qualsiasi coinvolgimento
personale.
Cesare Fioriti fa parte del direttivo del Pd di
Perugia. Ex capogruppo del partito socialista in consiglio comunale, qualche
anno fa è riuscito a fare intitolare una via alla memoria di Vittor Ugo Bistoni,
storico esponente del Psi cittadino, presidente del Collegio umbro dei Maestri
Venerabili e fondatore della Loggia “Guglielmo Miliocchi”. «Certo che è strano -
ripete anche Fioriti - questa vicenda della massoneria viene fuori a orologeria.
Secondo me serve a spostare il baricentro dell’opinione pubblica altrove,
rispetto a temi come la crisi. Ricordo un altro scandalo simile: accadde nei
primi anni 90, ai tempi di Tangentopoli». Fioriti non è legato ad alcuna loggia:
«No, non sono massone - precisa subito -. Però difendo la massoneria. La penso
esattamente come Voltaire (altro “illuminato”, ndr) “Anche se disapprovo quello
che dite, difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo”. I consiglieri
comunali devono avere piena libertà di espressione, quindi anche di
associazione. E poi scusi, i principi della massoneria non sono forse validi?
Penso alla fratellanza, alla riflessione, allo sviluppo delle idee». Squadra e
compasso non creano alcun imbarazzo. «Il fine della massoneria è l’evoluzione
del pensiero - continua Fioriti -. Mi spieghi lei come fa il Pd a condannare
un’organizzazione del genere». Angelo Pistelli è un altro esponente del Pd
umbro. Anche lui di provenienza socialista, fino a poco tempo fa era
nell'esecutivo regionale. Dopo le ultime polemiche sulla massoneria non si trova
più molto a suo agio nel partito. «In effetti del Pd ormai non condivido tanto -
ammette Pistelli -. Ma io mi sento di sinistra e non ci sono altri partiti in
cui potrei militare. Bisognerebbe dare spazio a tutte le voci. Invece comandano
le solite culture dominanti, e a noi resta ben poco».
Sembra quasi che Pistelli sia pronto a fare coming
out, quando corregge il tiro. «Specifico che non sono un massone. Diciamo che
difendo ogni espressione personale. Credo che anche all’interno del partito
ognuno debba essere libero di aderire a quello che gli pare. Non vogliono i
massoni? Allora io dico che non voglio l’adesione di tutti quelli che provengono
dal Pci. Hanno calcolato che in Italia ci sarebbero 4mila iscritti legati alla
massoneria. A occhio e croce non mi sembrano mica tanti. E poi sono sincero: se
scoprissi che non ci sono massoni nel gruppo dirigente del Pd mi dispiacerebbe».
E’ spuntato in internet ed ha già attirato la
curiosità di molti. E’ il file in formato excel dove sono riportati i nomi dei
26.409 iscritti alla Massoneria italiana. Con tanto di data di nascita,
residenza, e professione. Il percorso è presto detto: si parte da Google e, una
volta inserita nella stringa la parola chiave “elenco massoni” ecco che al primo
posto (su un totale di 58.500 voci) fa bella figura di sè il
“files.meetup.com/207935/pidue.xls”. Basta un click e il gioco è fatto. Il
documento non è di per sè una novità: si tratta di una lista datata, vecchia
almeno di più decenni, già in parte pubblicata da quotidiani. Nel 1998 ci provò
anche la rivista “Cuore” a pubblicare, a puntate, tutta quella massa di dati, ma
l’esperimento si fermò al terzo numero. Nel 2004 il file arrivò alla redazione
di Macchianera che non lo pubblicò perchè ormai era già disponibile nei siti
peer to peer. Ma è evidente che chi oggi l’ha messa in rete, ha voluto gettare
benzina sul fuoco del sempre tanto discusso e dibattuto tema della fratellanza:
non fosse che lo stesso file, in chiusura, è stato ribattezzato “pidue”, quando
nessuno dei 26mila risultava iscritto in quello della P2 di Licio Gelli che finì
nel mirino della magistratura. Perchè, vale ricordarlo, essere iscritti ad una
loggia non è reato. Diverso fu il caso della P2 i cui affiliati finirono
coinvolti in diverse inchieste di eversione, stragi, depistaggi e tentato colpi
di Stato. Ma torniamo al file. Alcuni di quella lista sono morti. Un centinaio
infatti sono quelli che oggi avrebbero più di 100 anni. Non furono pochi quelli
che, all’indomani dell’inchiesta del procuratore Agostino Cordova, uscirono
dalla massoneria. “E’ fu un bene – dicono dagli ambienti ternani – molti erano
entrati non perchè credessero nei nostri valori, ma perchè convinti che
avrebbero potuto beneficiare di chissà quali favori. Chi ci credeva e ci crede è
rimasto e alla fine quella indagine si rivelò una fortuna per l’onorabilità
della massoneria”. Quelli rimasti hanno proseguito il loro ‘percorso’. A
guardare quell’elenco c’è chi ha avuto fortuna. Ma c’è anche a chi non è andata
affatto bene. Eccoli tutti insieme, tutti e 26.409: docenti, medici, impiegati,
avvocati, commercianti, ferrovieri, geometri, ingegneri, agricoltori, bancari,
farmacisti, architetti.
LE LOGGE: Tre i principali Ordini massonici. Il
Grande Oriente d’Italia (GOI), il più numeroso con i suoi 30mila iscritti, la
Gran Loggia Regolare d’Italia (GLRI) e la Gran Loggia d’Italia, l’unica a
concedere l’accesso alle donne. Tutte hanno il loro sito internet al quale hanno
affidato persino gli indirizzi delle loro strutture. Un po’ più difficile avere
la lista degli iscritti (per quanto gli elenchi sono pubblici e dunque
consultabili presso i rispettivi uffici). Grazie ad un iscritto ad una loggia di
Perugia è possibile tracciare un quadro più aggiornato sugli iscritti in Umbria.
G.O.I: è la più antica, nata nel 1805 (il primo
Gran Maestro fu Eugenio De Beauharnais, figliastro di Napoleone Bonaparte), e la
più numerosa. Attualmente è presieduta dall’avvocato Gustavo Raffi. 29 in tutto
le logge umbre, 24 in provincia di Perugia, 5 in quella di Terni. Perugia: La
loggia storica per eccellenza è la “Francesco Guardabassi” (n. 146), una delle
18 logge perugine che vantano ca. 1.300 affiliati. Seguono “Fede e Lavoro”,
“Riccardo Granata”, “Mario Angeloni”, “I Figli di Horus” (che si richiama al
rito egizio di Memphis e Misraim), “Fratelli Bandiera”, “Concordia”, “Ver
Sacrum”, “Bruno Bellucci”, “Luca Mario Guerrizio”, “Francesco Baracca”, “La
Fermezza”, “Guglielmo Miliocchi”, “Humanitas”, “La Fenice”, “Quatuor Coronati”,
“XX Giugno 1859” e “Enzo Paolo Tiberi” (la più recente, n. 1.325). Città di
Castello: 150 i “muratori” che compongono le 4 logge presenti a Città di
Cstello, ribattezzate “XI settembre”, “I Liberi”, “Armonia” e “Atlantide”. A
Foligno sarebbero una trentina gli affiliati alla “Domenico Benedetti Roncalli”
mentre un po’ di meno quelli alla “Luigi Pianciani” di Spoleto. Terni: cinque le
logge per circa 200 iscritti. La prima ad essere aperta è la ‘Tacito’ seguita
dalla “Giuseppe Petroni”, “Paolo Garofoli”, J.W. Goethe” e “Alessandro Fabri”.
G.L.R.I.: fondata da Giuliano Di Bernardo a
seguito dello scisma nel 1993 dal GOI. Attualmente è presieduta dal dottr Fabio
Venzi. In Umbria vanta un centinaio di iscritti e 4 logge: la “Luigino Marra” di
Spoleto, Piero della Francesca” e “San Bevignate” di Perugia e la “Braccio
Fortebraccio” di Umbertide. Tutte operano nel capoluogo di regione dove gli
iscritti si ritrovano, a cadenza settimanale, in una nota struttura ricettiva.
G.L.I. (Obbedienza di Piazza Del Gesù Palazzo
Vitelleschi): E’ un “Ordine iniziatico di uomini e donne”, l’unica infatti ad
aprire le porte anche alle donne. Fondata nel 1910 è oggi retta dal professor
Luigi Pruneti. La sede umbra (per gli Orienti di Terni e Perugia) è presso il
Centro Sociologico Italiano in Via Valentini a Perugia. Gli iscritti sarebbero
una cinquantina.
I massoni di Perugia: questa persecuzione deve
finire. Dall’archivio de “Il Corriere della Sera” l’inchiesta di Bruno Tucci. LA
CAPITALE DEI VENERABILI. Mille affiliati. Li accusano di condizionare la città e
loro: "Siamo eredi dei laici che hanno sconfitto il Papa Troppe calunnie, quel
magistrato viola il codice. Mille iscritti alle logge sparsi per la provincia:
tutti nelle stanze dei bottoni. Ospedali, banche, università e poi ancora in
magistratura, negli ordini professionali, tra gli avvocati, i medici, gli
ingegneri fino alle istituzioni. La mappa della massoneria in questo lembo del
Paese raggiunge percentuali da capogiro. Perugia si sente afflitta e
condizionata? "Non diciamo eresie", esclama il presidente del collegio
venerabile, Giancarlo Zuccaccia. "Chi ha conquistato posti importanti nella
società non lo deve certo a noi, ma esclusivamente alla propria
professionalità". Eppure, le accuse sono specifiche: vengono da un giudice
calabrese che punta il dito contro i massoni e cerca di inchiodarli con elementi
e prove inconfutabili. Lo avrete capito: il magistrato in questione è Agostino
Cordova, procuratore di Palmi, il quale sta combattendo una battaglia personale
in un campo così delicato e difficile. Le parole di Cordova non ammettono dubbi
di sorta. In Umbria, e specificamente nella provincia di Perugia, i massoni sono
tanti, troppi e condizionano la vita della città. Tutto passa attraverso il
controllo delle logge: assunzioni, promozioni, avvicendamenti, scatti di
carriera. Come mai? Semplice: al timone della barca ci sono loro e soltanto
loro. "Fandonie, fesserie, calunnie", risponde a tono Giancarlo Zuccaccia,
presidente dell' Ordine degli avvocati dall'ottobre del 1992. Sibila: "Sono
stato eletto con 250 voti. Dovrebbero avere tutti una stessa etichetta, secondo
Cordova. Ed invece, non è così, glielo posso assicurare. La verità è che questo
magistrato ha preso di mira la massoneria. Ha sguinzagliato per tutta Italia i
suoi scherani e siccome non è riuscito a trovare un bel nulla, allora tira
fendenti alla cieca. Ma, attenzione, sta violando il codice penale". Un' accusa
pesante, avvocato... "Già, è vero. Allora non la scriva. Però, rimane il fatto
che noi siamo alla gogna, criminalizzati per episodi che non esistono. Siamo
stanchi, mi creda, perché ne dobbiamo sopportare di tutti i colori". Dunque, non
avete stretto tra di voi patti di alleanza spartitoria? Insomma, una specie di
lottizzazione massonica? "Non scherziamo. Chi di noi raggiunge risultati
professionali lo deve soltanto alla bravura ed all'onestà. Il resto sono
chiacchiere che non stanno né in cielo, né in terra". Il presidente venerabile
si difende, ammette che in Umbria ci sono 24 logge tra Perugia, Terni, Spoleto e
Città di Castello, ma non vuole sentir parlare di favoritismi e di clientelismo.
Sono parole sconosciute nel vocabolario dei massoni. Ma chi sa e conosce Perugia
e dintorni non è d'accordo. Legge delle indagini condotte da Agostino Cordova e
si frega le mani. "Finalmente! Era ora", grida qualcuno. "Questa storia, prima o
poi, doveva pur finire. Speriamo si faccia in fretta, perché i giovani non ne
possono più di un simile condizionamento". Parlano i perugini che non hanno
niente a che spartire con la massoneria, però si trincerano dietro l'anonimato.
Hanno paura di tarparsi le ali, di non poter
combinare più nulla in futuro, se dovessero essere scoperti. Con tale premessa
vanno avanti nel racconto e confessano al cronista che chi non sta dalla parte
dei massoni incontra grossi ostacoli. I favoritismi sono a senso unico. Un
esempio: se vuoi assicurarti un posto o se desideri compiere un salto di
qualità, non hai altra scelta se non rivolgerti a quelli che contano. E, guarda
caso, nelle stanze dei bottoni ci sono soltanto loro. Così è all' università,
nelle banche, in ospedale, negli enti pubblici, dappertutto. "Noi agiamo alla
luce del sole", replica Giancarlo Zuccaccia. "Non siamo un partito, abbiamo
sempre combattuto la lottizzazione", aggiunge un altro "fratello perugino",
l'avvocato Giacomo Borrione. "Anzi, sa che cosa le dico? E' vero il contrario:
abbiamo sofferto l'infiltrazione dei partiti. Noi interveniamo soltanto quando
un "fratello" è in stato di bisogno. E chi aiuta non appare, rimane tutto
avvolto nel segreto". La voce di popolo grida a gran voce l'esatto contrario.
Cita nomi, cognomi di affiliati: gente di potere che solidarizza solo con chi è
iscritto. Ad esempio, la famiglia De Megni, sulla quale sono stati spesi fiumi
di parole. "Alle cene annuali in casa loro partecipa il fior fiore della
massoneria, il vertice delle logge umbre". Non si salva nessuno, nemmeno il
rettore dell'Università, alcuni commissari di polizia, ufficiali dei
carabinieri. Chiacchiere? "Se sono bugie, lo vedrete il giorno in cui Cordova
avrà completato la sua inchiesta", rispondono i perugini. Giancarlo Zuccaccia va
su tutte le furie: "Io ai pranzi di De Megni non ci sono mai stato. Se mi
chiedete se sono massone, rispondo di sì. Sono apparso in gonnellino pure alla
tv. Ma non andiamo oltre, parlando di sette, di logge segrete, di clientelismo.
Il venerabile Licio Gelli (come lo chiamate voi) lo abbiamo espulso nel 1976,
avete capito?". Ed allora perché tanti massoni a Perugia o in Umbria, se
preferisce? "E' semplice: perché siamo laici ed abbiamo subito la dominazione
pontificia per 400 anni. Lo sa che il 20 giugno, puntualmente, Perugia festeggia
la cacciata dei papalini?
Ed è una festa a cui partecipa tutta la città,
comune compreso.
Questa persecuzione di Cordova deve finire. Io ho
subito minacce telefoniche e sono in allarme per la mia incolumità". In Corso
Vannucci, la strada dello struscio, scuotono la testa e commentano: "I massoni?
Se non stai con loro, è meglio che emigri. Sono forti, fortissimi ed hanno tutte
le leve del potere. Quindi..."
Ma nella massoneria esistono anche avvocati,
cancellieri, docenti di materie giuridiche, ufficiali giudiziari, e così via,
che sono affiliati alla massoneria. Tutto ciò si evince ancora dal libro "La
Massoneria smascherata" di Giacinto Butindaro. Ed ovviamente tutti costoro, in
virtù del loro giuramento massonico (che recita tra le altre cose: ‘…. prometto
e giuro di non palesare giammai i segreti della Libera Massoneria, di non far
conoscere ad alcuno ciò che mi verrà svelato; prometto e giuro di prestare aiuto
ed assistenza a tutti i Fratelli Liberi Muratori sparsi su tutta la superficie
della Terra….’), devono anche loro aiutare i loro fratelli massoni, per cui è
ovvio che quando un massone si troverà indagato o imputato in un processo, egli
al ‘momento giusto’ riceverà una qualche forma di aiuto dai suoi fratelli che
sono nella magistratura (o nella politica) che si muoveranno come sanno fare
loro in questi casi. Un esempio di inchiesta giudiziaria contro dei massoni
‘affossata’ è quello dell’inchiesta del procuratore di Palmi Agostino Cordova da
lui avviata nel 1992, a cui abbiamo accennato prima, che dopo che Agostino
Cordova fu trasferito-promosso alla Procura di Napoli nel 1993 e che le indagini
vennero trasferite (per «incompetenza tecnica» della Procura di Palmi a
occuparsi della materia) alla Procura di Roma nel giugno del 1994, rimase
pressoché ferma per quasi sei anni, e poi nel dicembre 2000, il giudice per le
indagini preliminari dispose l’archiviazione dell’inchiesta, nonostante fossero
stati raccolti centinaia di faldoni e tantissime fonti di prova sulle attività
illecite di logge italiane con decine di indagati, coinvolgenti influenti
personaggi del mondo imprenditoriale, finanziario, politico e istituzionale,
nonché della stessa magistratura, collusi con la ‘ndrangheta con cui avevano
costituito delle vere e proprie società di affari, attraverso le quali si
spartivano i proventi derivanti dagli accordi perversi del sodalizio criminale.
Per capire la portata dell’inchiesta di questo coraggioso magistrato consiglio
di leggere Oltre la cupola: massoneria, mafia, politica, scritto da Francesco
Forgione e Paolo Mondani, pubblicato da Rizzoli Editore nel 1994. Un esempio
invece di processo in cui erano imputati dei massoni con evidenti prove di
colpevolezza contro di essi, e che si è concluso con la loro assoluzione, è
quello del "golpe Borghese". Il "golpe Borghese" fu un colpo di Stato tentato in
Italia durante la notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970 e organizzato e guidato da
Junio Valerio Borghese (ex comandante della X Mas nella repubblica sociale
italiana, e leader dell’organizzazione neofascista Fronte nazionale), allo scopo
di impedire l’accesso del Partito Comunista al governo. Il nome del colpo di
stato aveva come nome in codice ‘Operazione Tora Tora’, in ricordo dell’attacco
giapponese a Pearl Harbor del 7 dicembre 1941. Tra i golpisti c’erano oltre che
uomini dei servizi segreti e fascisti, anche massoni e mafiosi. In vista del
‘golpe Borghese’ infatti, la Massoneria aveva chiesto l’aiuto di Cosa nostra e
della criminalità organizzata calabrese per averne un appoggio armato. La sera
del 7 dicembre 1970, i congiurati – in gran parte armati, e provenienti da varie
regioni d’Italia – si concentrarono nei vari punti prestabiliti della Capitale.
Il piano eversivo prevedeva tra le altre cose, l’uccisione del capo della
polizia Angelo Vicari, e l’irruzione al Quirinale di una squadra di congiurati
armati comandati da Licio Gelli (capo della loggia massonica segreta P2) per
sequestrare il presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Ma ecco che poco
dopo la mezzanotte ai congiurati arriva improvviso il contrordine: l’azione
golpista è sospesa e rinviata. L’inchiesta giudiziaria che ne seguì non riuscirà
a chiarire le circostanze dell’improvviso contrordine impartito ai congiurati.
Secondo alcuni, la sospensione del golpe è da attribuire alla defezione di un
importante personaggio che avrebbe reso impossibile l’attuazione dell’aspetto
strategico del golpe. Secondo altri, il golpe non fu attuato, benchè avallato
dagli USA, a causa dell’imprevista presenza della flotta russa nel Mediterraneo
la notte tra il 7 e l’8 dicembre. Comunque il tentato golpe ci fu. In merito al
procedimento giudiziario e il processo che si tenne contro coloro che furono
coinvolti nel ‘Golpe Borghese’, ecco cosa dice il senatore Sergio Flamigni, che
ha fatto parte della Commissione Parlamentare sulla Loggia P2: ‘Nel procedimento
giudiziario scaturito dal «golpe Borghese» risulteranno coinvolti piduisti di
primo piano: il generale Vito Miceli, promosso capo del Sid per intervento di
Licio Gelli presso il ministro della Difesa Mario Tanassi (il cui segretario
particolare, Bruno Palmiotti, e il cui fratello, Vittorio Tanassi, sono
affiliati alla Loggia segreta); Giuseppe Lo Vecchio, colonnello
dell’Aeronautica; Giuseppe Casero, ufficiale dell’Aeronautica; Giovanni Torrisi,
ufficiale di Marina; Giovambattista Palumbo, Franco Picchiotti e Antonio
Calabrese, ufficiali dei Carabinieri; Giuseppe Santovito, ufficiale
dell’Esercito; il banchiere Michele Sindona; l’alto magistrato Carmelo
Spagnuolo; il consigliere regionale andreottiano Filippo De Jorio (consigliere
di Andreotti a Palazzo Chigi anche dopo il suo coinvolgimento nel tentato
golpe). Tutti costoro risulteranno affiliati alla Loggia P2 nel gruppo Centrale,
cioè in diretto collegamento con Gelli. Nella «Operazione Tora Tora»
risulteranno coinvolti anche altri massoni, tra i quali: Duilio Fanali (capo di
Stato maggiore dell’Aeronautica, che nel tentato golpe aveva il compito di
insediarsi nel ministero della Difesa e impartire ordini a tutto l’apparato
militare); il costruttore romano Remo Orlandini; Sandro Saccucci (deputato nelle
liste del Msi, nel 1972, per avvalersi dell’immunità parlamentare); Salvatore
Drago (ufficiale medico della Polizia, fedelissimo del piduista Federico Umberto
D’Amato); Gavino Matta e Tommaso Rook Adami (massoni appartenenti alla Comunione
di Piazza del Gesù); Giacomo Micalizio. [....] Benchè nella «Operazione Tora
Tora» abbia avuto un ruolo centrale, Licio Gelli non viene coinvolto nel
processo seguito al «golpe Borghese». Il Venerabile gode infatti di particolari
coperture e di ferree protezioni.
Nel luglio 1974, nello studio privato del ministro
della Difesa Giulio Andreotti, si tiene una riunione alla quale partecipano,
oltre al ministro: il nuovo capo del Sid ammiraglio Mario Casardi il comandante
dei Carabinieri generale Enrico Mino, il capo dell’ufficio D del Sid generale
Gianadelio Maletti (piduista), e gli ufficiali del Sid colonnello Sandro
Romagnoli e capitano Antonio Labruna (piduista). Oggetto della riunione è un
dossier compilato dai Servizi sul «golpe Borghese», da inviare alla
magistratura. Il dossier giunto al ministro Andreotti è già stato sottoposto a
numerosi tagli; infatti il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio
Eugenio Henke, ha disposto la cancellazione di ogni riferimento ad alcuni
collaboratori del Sid. Ma a questo punto è Andreotti che suggerisce a Maletti di
«sfrondare il malloppo e di eliminare i dati non riscontrabili». Così dal
rapporto scompare il nome di Gelli [....]. Il processo per il «golpe Borghese»,
celebrato presso il Tribunale di Roma, consentirà di accertare una serie di
gravissimi fatti. Ma tutti gli imputati piduisti, anche grazie al sotterraneo
attivismo di Licio Gelli, verranno assolti.
[....]. I gravissimi fatti culminati nel tentato
golpe della notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970 subiranno in fasi processuale un
inopinato ridimensionamento. Benchè si sia trattato di un preciso piano eversivo
sostenuto da ampi settori dei vertici militari in collegamento con gruppi armati
di civili ramificati in tutto il Paese, a conoscenza dei comandi Nato e con la
partecipazione di Cosa nostra e della ‘ndrangheta calabrese, nel corso dei vari
gradi di giudizio il processo si risolverà in un progressivo insabbiamento, tra
proscioglimenti e archiviazioni, fino alla generale assoluzione degli imputati
superstiti da parte della Corte di Cassazione. [....] Le sentenze della Corte di
assise di Roma del 14 novembre 1978 e della Corte di assise d’appello del 27
novembre 1984, affermando l’insussistenza del delitto di insurrezione armata,
predisporranno la Corte di cassazione a trasformare il tentato golpe in un
semplice «complotto di pensionati», e ad assolvere tutti gli imputati. Molti
anni dopo, il giudice istruttore del Tribunale di Milano Guido Salvini scriverà
infatti che «una vasta e continuativa trama golpista, corroborata sul piano
probatorio anche da numerosi elementi documentati, [è stata] così ridotta ai
progetti velleitari di qualche anziano Ufficiale nostalgico e di poche Guardie
forestali. Certamente non è stato così». Il giudice citerà una serie di
documenti e testimonianze, prove di un’ampia articolazione eversiva di forze:
alti ufficiali delle Forze armate e Massoneria, P2 e servizi segreti, mafia
siciliana e ‘ndrangheta calabrese, strutture clandestine di militari e civili e
gruppi della destra eversiva e neofascista, con sullo sfondo i comandi della
Nato.
A conferma che anche nella magistratura si muove
la mano della Massoneria dal libro "La Massoneria smascherata" di Giacinto
Butindaro vi propongo una parte di un interessante scritto dal titolo
«Fratellanza giuridica». "I magistrati e la massoneria" a cura di Solange
Manfredi, pubblicato sul blog di Paolo Franceschetti il 20 luglio 2010, che
credo renda bene l’idea di questo intreccio, che spiega il perchè certe indagini
che coinvolgono massoni vengono ostacolate o affossate, e dei processi contro
esponenti della massoneria finiscono con l’assoluzione degli imputati. [....].
Quando mio padre (avvocato) morì, 15 anni fa, nella cassaforte di casa trovai,
insieme al suo tesserino di affiliazione alla massoneria, centinaia di documenti
massonici. Tra questi rinvenni un piccolo libricino rilegato che riportava in
copertina: “Fratellanza Giuridica” Statuto. Appena ne lessi il contenuto rimasi
sconvolto, come sconvolti sono rimasti avvocati e giudici (non massoni
ovviamente) a cui l’ho mostrato. L’esistenza di uno Statuto che, all’interno
delle varie logge (e quindi tra massoni già vincolati dal giuramento di
silenzio, assistenza ed aiuto reciproci e dal divieto di denunciare un fratello
al Tribunale profano), univa in una “più fraterna collaborazione” avvocati –
cancellieri – docenti di materie giuridiche – dottori commercialisti –
magistrati – notai – ragionieri ed ufficiali giudiziari, in altri termini tutti
i tasselli “sensibili” di un Tribunale, era sconvolgente. Un legame così stretto
tra i protagonisti delle vicende giudiziarie si prestava veramente a deviazioni
infinite. Il fatto, poi, che gli elenchi di questa “Fratellanza Giuridica”
fossero a disposizione dei massoni iscritti alle varie logge italiane poteva
rendere ogni Tribunale raggiungibile da qualsiasi fratello in cerca di aiuto
massonico. Nessun rischio a chiedere un “aiutino”: il massone infatti ha giurato
sia di aiutare sia di non denunciare mai un fratello al Tribunale profano. Non a
caso ogni scandalo che ha riguardato magistrati e massoni è sempre stato
originato dalla scoperta di documenti durante una perquisizione o, come in
questo caso, da intercettazioni telefoniche; ma mai in nessun caso un’indagine
ha avuto origine dalla denuncia di un fratello verso un altro fratello. Se
all’interno della stessa loggia, della stessa cittadina, si ritrovano
regolarmente per studiare, lavorare, o altro… avvocati, cancellieri, magistrati
e ufficiali giudiziari, si sa, l’occasione fa l’uomo ladro. La frequentazione,
l’amicizia, ma, soprattutto, il giuramento di reciproco aiuto ed assistenza,
fanno sì che in queste “logge” possa scattare la richiesta di “aiutino”. In
fondo, per insabbiare un processo, per depistare, per creare confusione, basta
poco: una notifica sbagliata, un fascicolo sparito, una nullità non rilevata,
ecc.. piccoli errorini, idonei a deviare il corso di un processo; ma errorini
per cui in Italia non si rischia assolutamente nulla. Certo si parla di
possibilità, non è detto che accada però, come già sottolineato, l’occasione fa
l’uomo ladro. Proprio per questo i magistrati ed avvocati più attenti a livello
deontologico (non vi preoccupate, è una razza ormai quasi estinta) evitano le
frequentazioni con avvocati almeno dello stesso foro in cui esercitano. Il
motivo di tale comportamento è chiaro (o dovrebbe esserlo) il giudizio del
magistrato, per non lasciare adito ad alcun dubbio, deve essere il più possibile
scevro da condizionamenti di qualunque genere. Chi frequenta i Tribunali,
invece, spesso si trova a dover costatare comportamenti ben diversi, e si può
incappare in situazioni in cui avvocati e magistrati dello stesso foro dividono
l’affitto di una garconier con cui andare con le rispettive amanti. Sarà,
dunque, forse un caso che più di 7 processi su dieci saltano per notifiche
sbagliate? Sarà forse un caso che spesso le indagini o processi che vedono
coinvolti massoni hanno un iter burrascoso con avocazioni di indagine (Why not,
Toghe Lucane), trasferimenti di sede (Piazza Fontana, Golpe Sogno, Scandalo
loggia P2) od altro?
Probabilmente si, non vogliamo in alcun modo
pensar male anche se, come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato ma,
raramente, si sbaglia. Trascrivo qui il contenuto dello Statuto rinvenuto tra i
documenti di mio padre. Ovviamente, e per estrema correttezza, avverto il
lettore che non posso assicurare che detto statuto sia vero, ma, dati i rapporti
che intratteneva mio padre (avvocato), ciò che mi aveva detto riguardo i
magistrati che frequentavano regolarmente la nostra casa e il fatto di averlo
rinvenuto all’interno di una cassaforte insieme a centinaia di documenti
giuridici firmati da “fratelli”, mi fa propendere per il si. Se così fosse
parrebbero esistere “Fratellanze” costituite esclusivamente da magistrati,
avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari, professori universitari, ecc.. le
cui “deviazioni” potrebbero condizionare il sistema giudiziario ostacolando il
corso di processi importanti.
A.G.D.G.A.D.U.
GRAN LOGGIA NAZIONALE
DEI LIBERI MURATORI D’ITALIA
“GRANDE ORIENTE D’ITALIA”
*
STATUTO
DELLA
“FRATELLANZA GIURIDICA”
(Approvato a Roma, il 21 settembre 1968)
1. La Fratellanza Giuridica è costituita da
Fratelli attivi e quotalizzanti nelle rispettive Logge della Comunione italiana,
appartenenti alle seguenti categorie professionali, e che ne facciano domanda:
avvocati e procuratori legali –cancellieri – docenti di materie giuridiche –
dottori commercialisti – magistrati – notai – ragionieri – ufficiali giudiziari.
2. La Fratellanza Giuridica ha come principali
finalità: a) Dare, quando richiestane, pareri giuridici al Grande Oriente o ai
vari Organi massonici, attraverso la Gran Segreteria; b) Promuovere lo studio
dei problemi interessanti i vari aspetti del diritto, internazionale e
nazionale, e quelli delle singole categorie iscritte alla Fratellanza; c)
Consentire una più fraterna collaborazione, nell’ambito di ciascuna categoria,
per l’esercizio dell’attività degli iscritti; d) Indicare nominativi di
difensori d’ufficio, se richiestane dai Tribunali massonici; e) Curare la
raccolta della giurisprudenza delle decisioni degli organi giudiziari massonici,
anche comparata con l’opera giudiziaria delle altre Comunioni regolari; f)
Studiare ed approfondire ogni altra questione attinente all’esercizio
professionale degli iscritti, nel rispetto delle leggi e delle tradizioni
massoniche.
3. La Fratellanza Giuridica ha sede presso il suo
Presidente effettivo. Essa può essere sciolta in qualunque momento, o per
decisione del Gran Maestro, previo il parere favorevole del Consiglio
dell’Ordine, o per decisione dell’Assemblea degli iscritti. Le elezioni e le
decisioni dei vari Organi della Fratellanza Giuridica sono valide a maggioranza
semplice ed impegnano anche gli assenti e, per il caso di scioglimento, con il
voto favorevole di almeno due terzi degli iscritti. Le cariche non sono
rinunciabili ed impegnano gli eletti sino a quando non siano accettate eventuali
loro dimissioni, da inoltrarsi al Consiglio Direttivo.
4. Sono Organi della Fratellanza Giuridica:
a) L’Assemblea degli iscritti;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) L’Ufficio di Presidenza;
d) Ufficio di Segreteria e Tesoreria.
5. L’Assemblea degli iscritti è convocata
dall’Ufficio di presidenza almeno una volta l’anno, entro il 31 marzo, o quando
appaia opportuno, ovvero quando gliene faccia richiesta la maggioranza semplice
del Consiglio Direttivo oppure almeno un quinto degli iscritti. Alla Assemblea
sono demandate tutte le decisioni comunque riguardanti la Fratellanza Giuridica,
anche nelle materie di spettanza dei singoli Organi.
6. Il Consiglio Direttivo è composto dai Delegati
circoscrizionali, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Delegati
circoscrizionali vengono eletti, anche mediante schede inviate per posta, dagli
iscritti alla Fratellanza Giuridica, nell’ambito delle circoscrizioni regionali
massoniche. Il Consiglio Direttivo si riunisce per convocazione dell’Ufficio di
Presidenza, almeno due volte l’anno, ovvero quando ne faccia richiesta, allo
stesso Ufficio di Presidenza, almeno un terzo dei suoi membri.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide
con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In caso di parità di voti
prevale quello del presidente.
8. Ciascun delegato circoscrizionale deve
promuovere riunioni di iscritti, iniziative e attività varie, nell’ambito della
propria circoscrizione, in armonia con le leggi massoniche, con le finalità
della Fratellanza Giuridica, con le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo.
9. L’Ufficio di Presidenza è composto:
a) Dal Gran Maestro;
b) Dal presidente effettivo, che viene eletto dal
Consiglio Direttivo;
c) Da un Vice-Presidente.
Al Presidente effettivo (o, in caso di suo
impedimento o assenza, al Vice-Presidente) spettano la rappresentanza, la
direzione, le decisioni di ordinaria amministrazione della Fratellanza
Giuridica.
10. L’Ufficio di Segreteria è composto:
a) Dal Gran Segretario;
b) Da un Segretario o da un Vice-Segretario,
nominati dal Consiglio Direttivo, ai quali spetta la tenuta degli schedari, dei
verbali, della corrispondenza della Fratellanza Giuridica. L’Ufficio di
Segreteria effettua il controllo annuale della regolare appartenenza alle Logge
della Comunione di tutti gli iscritti della Fratellanza.
Il Segretario o il Vice-Segretario possono essere eletti anche al di fuori del
Consiglio Direttivo, nel qualcaso vi partecipano senza diritto di voto.
11. Il Tesoriere è nominato da Presidente
effettivo, anche non fra i Delegati circoscrizionali, nel qual caso partecipa al
Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Tesoriere cura l’amministrazione,
la contabilità, la riscossione delle quote e degli eventuali contributi
volontari, e quant’altro attiene alla economia della Fratellanza Giuridica. Il
Tesoriere redige, entro il 31 dicembre di ciascun anno il bilancio consuntivo
degli incassi e delle spese, ed un bilancio preventivo per l’anno successivo, da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
12. Per far fronte alle spese di organizzazione e
funzionamento della Fratellanza Giuridica, tutti gli iscritti devono versare una
quota annuale.
13. Entro il 31 maggio di ciascun anno il
Consiglio Direttivo:
a) Predispone ed approva bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Tesoriere
da sottoporre all’Assemblea;
b) Fissa l’ammontare della quota annuale
obbligatoria a carico degli iscritti;
c) Redige una relazione morale sull’attività compiuta nell’anno precedente che,
se approvata dall’Assemblea, viene inviata alla Gran Maestranza;
d) Delibera la destinazione delle somme pervenute
per contributi volontari dai vari iscritti.
14. Ogni notizia relativa agli elenchi degli
iscritti potrà essere chiesta e fornita dai rispettivi Delegati
circoscrizionali, a ciascuno dei quali tali elenchi verranno consegnati, ovvero,
in mancanza, dall’Ufficio di Segreteria.
15. Il presente Statuto potrà essere modificato
con delibera di almeno un terzo degli iscritti, i Assemblea.
16. E’ demandata al Consiglio Direttivo la
formulazione del regolamento di attuazione del presente Statuto.
Note: Come rivela una sentenza a sezioni unite del
Tribunale massonico del 28/X/1978, per il principio n. 1 Cap. IV degli Antichi
Doveri” il massone anche se a conoscenza di un reato non può neanche minacciare
di denunciare un fratello a quello che viene definito “Tribunale Profano”,
ovvero l’organo giudiziario previsto dalla Costituzione italiana, pena
l’immediata espulsione dalla loggia. Peraltro, vorrei anche dire che quando un
magistrato (o un politico e così via) afferma: «La massoneria? Io l’ho lasciata
da tempo…», e non prova in alcuna maniera questa sua affermazione, quello che
intende dire è che in effetti lui non ha lasciato la Massoneria, ma soltanto che
si è messo ‘in sonno’, che nel linguaggio massonico significa che un massone ha
deciso per sue esigenze personali di autosospendersi dai lavori rituali e dalla
vita dell’ordine, ma egli rimane a tutti gli effetti un massone obbligato ad
osservare il giuramento massonico, pena gravissime conseguenze per la sua vita;
e questa sua condizione di ‘dormiente’ è revocabile in qualsiasi momento e
quando uscirà dal suo stato di ‘sonno’ i suoi fratelli massoni faranno festa.
Massoneria e mafia, la vera storia
occulta del generale Ganzer. Un reportage di Paride
Leporace. La ricostruzione di una
storia italiana dopo la clamorosa condanna a 14 anni del generale dei Ros: i
misteri d’ Italia, i processi ai movimenti, le trame. Rinasce la
P3, il solito
Dell’Utri, il coordinatore di
Forza Italia, il
vecchio faccendiere Carboni.
Siamo abituati. Un po’ meno al fatto che un generale dei carabinieri, capo
dell’ineffabile Ros, sia duramente condannato a 14 anni in primo grado per aver
messo in piedi una rete che acquista cocaina in
Colombia per far meglio carriera. Il
generale Ganzer non ha fatto
una piega. Aspetta le motivazioni di una sentenza del
processo meno raccontato dai media italiani.
Eppure i protagonisti e i fatti meritavano
approfondimenti. Ma oggi nel Belpease chi si mette a scrivere delle ombre del
reparto operativo più osannato nella lotta al crimine? A Milano hanno condannato
anche ufficiali e sottoufficiali del Ros e un alto generale. Si chiama
Mauro Obinu. Vice di
Ganzer. Ma anche imputato in
altri processi poco raccontati. A Palermo fa coppia sul banco degli imputati con
il generale Mori. Sono
accusati di non aver catturato Binnu
Provenzano. In quel periodo attraverso i
Ciancimino avevano avuto anche
il mandato di trattare con Cosa Nostra
invece di pensare ad arrestare boia e mandanti delle stragi che uccisero
Falcone, Borsellino e le loro
scorte. Obinu sta all’Aise.
Che non è un’azienda di elettrodomestici ma una delle sigle dei nostri
straordinari servizi segreti che ogni tanto cambiano sigla per
rinverdire il brand. Il capo di Obinu è
Gianni De Gennaro condannato in
Appello ad un anno e quattro mesi per la macelleria messicana della scuola
Diaz di Genova quando era il capo della polizia italiana. Poi richiamo alla
vostra memoria che il comandante generale della Guardia di Finanza,Roberto
Speciale era stato condannato ad un anno e mezzo per peculato ed
è stato ricompensato con una nomina a senatore del partito berlusconiano.
Vogliamo aggiungere
Niccolò Pollari direttore del
Sismi salvato dalle accuse per
il rapimento di Abu Omar con il segreto di Stato e ricompensato con una
qualifica di Consigliere di Stato. Vi meravigliate?
Io ho poco disincanto forse perché essendo un
direttore di giornale ho potuto verificare che in favore di Pollari con dossier
mirati si muovevano strani personaggi calabresi in odor di massomafia.
Non avete mai incontrato uomini delle istituzioni che si sentono Stato più Stato
degli altri? Spesso in rapporto stretto con giornalisti di grido dotati di
ottimi fonti e che nelle redazioni possono far emergere titoloni su quel
personaggio o capaci di far circolare dossier molto documentati contro avversari
interni o esterni. Anche loro P3?
Chissà. Stiamo ai fatti senza troppo dietrologia e comprendiamo
chi è il generale Ganzer condannato a 14 anni
da un Tribunale di quello Stato che doveva servire. Accademia Militare di Modena.
Capitano e allievo del generale Dalla
Chiesa tiene il fortino strategico di Padova dove coordina il
blitz contro l’Autonomia. Si tratta del processo «7 aprile» ovvero quando
l’inquisizione politica consente l’eclisse del Diritto. Il dossier che arriva al
giudice Calogero porta le firma di Ganzer. Sul fronte della criminalità cattura
la banda dei giostrai. Poi infiltra uno dei suoi uomini nella “Mafia del
Brenta” di Felice Maniero.
Pochi ricordano che un pm indaghi l’ufficiale dei carabinieri per falsa
testimonianza a difesa dell’infiltrato. La circostanza è citata da Fiorenza
Sarzanini del Corsera che la elogia in positivo chiosando : “preferì finire
sotto processo piuttosto che tradire un collaborante”.
Carabinieri su una linea d’ombra. Stato nello Stato. Ma ci sono anche
magistrati che non fanno sconti. Parte da lontano la vicenda che ha visto
condannare il capo Dei Ros ad una pesantissima condanna a 14 anni di carcere.
A Ganzer è andata male perché ha
trovato un mastino sulla sua strada. Lo stesso magistrato che ha indagato sul
Sismi di Pollari. Un pm tostissimo. Armando Spataro della Procura di Milano. Che
si fida ciecamente di Ganzer. Ma quelli come Spataro non si bevono tutto come
oro colato. Anche se ti chiami Ganzer. Il pm riceve la richiesta
di un’ autorizzazione a ritardare il sequestro di una partita di droga. Questo
il racconto del pm dagli atti processuali:«Mi disse che il Ros disponeva di un
confidente colombiano che aveva rivelato l’arrivo nel porto di Massa Carrara di
un carico di 200 chilogrammi di cocaina. Era destinata alla piazza di Milano e
il confidente era disposto a fornire al Ros le indicazioni necessarie per
seguire il carico fino a destinazione e catturare i destinatari della merce».
Spataro firmò il decreto di ritardato sequestro. Ma i piani del Ros cambiarono:
l’operazione infatti fu effettuata. Ma, dopo aver compiuto l’operazione, il Ros
non diede più informazioni. Insospettito, Spataro si presentò negli uffici
romani del Raggruppamento operativo speciale e chiese notizie attorno al
sequestro dei due quintali di cocaina. Gli fu mostrata della droga conservata in
un armadio. Quando, molti mesi dopo, Ganzer gli prospettò l’ipotesi di vendere
quella droga a uno spacciatore di Bari, Spataro decise di informare il capo
della procura e alcuni suoi colleghi. E ordinò la distruzione della droga. Un
copione che sarebbe poi stato ricalcato molte altre volte. Secondo l’accusa, gli
stessi carabinieri erano diventati protagonisti del traffico e le brillanti
operazionì non erano altro che delle retate di pesci piccoli messe in atto per
gettare fumo negli occhi all’ opinione pubblica. Anche
Fabio Salomone pm bresciano
indaga sul Ros. Quello di Bergamo. I carabinieri reclutano giovani pusher su
piazza. Trovano i clienti e vendono la coca. Un gruppo di carabinieri fa
carriera con operazioni dove i soldi spariscono e che hanno una sorta di regia
etorodiretta.
Un esponente della malavita,
Biagio Rotondo, detto «Il
Rosso» racconta al pm Salomone che nel 1991 due carabinieri del Ros lo
avvicinarono in carcere e gli proposero di diventare un confidente nel campo
della droga. In realtà, secondo l’accusa, questi confidenti (tra il 1991 e il
1997 ne furono reclutati in gran numero) venivano utilizzati come agenti
provocatori, come spacciatori, come tramiti con le organizzazioni dei
trafficanti. «Il Ros – scrivono i giudici nel rinvio a giudizio – instaura
contatti diretti e indiretti con rappresentanti di organizzazioni sudamericane e
mediorientali dedite al traffico di stupefacenti senza procedere nè alla loro
identificazione nè alla loro denuncia… ordina quantitativi di stupefacente da
inviare in Italia con mercantili o per via aerea, versando il corrispettivo con
modalità non documentate e utilizzando anche denaro ricavato dalla vendita in
Italia dello stupefacente importato. Denaro di cui viene omesso il
sequestro». «Si tratta – annota la Procura di Milano – di istigazione ad
importare in Italia sostanze stupefacenti». I sottoufficiali indagati nascondono
microspie ambientali e registrano l’interrogatorio del Pm. Per Ganzer è
un gioco facile denunciare Salomone per abuso alla procura di Venezia e
paralizzare per lungo tempo l’inchiesta.
Un’inchiesta, nata a Brescia nel 1997 (pm Fabio
Salamone) passata poi a Milano (pm Davigo, Boccassini e Romanelli) perchè
coinvolgeva un pm bergamasco, salvo poi essere mandata a Bologna (per un
episodio a Ravenna), restituita da Bologna a Milano, girata a Torino e rispedita
a Bologna, che sollevò conflitto di competenza in Cassazione, la quale stabilì
infine la competenza di Milano. Un giro d’Italia che ha ritardato la fine di un
processo durato un’eternità e che a quello di piazza Fontana gli fa un baffo per
quanti tribunali ha visitato nel silenzio generale. E Biagio Rotondo detto “Il
Rosso”? Il testimone che ha permesso di scoprire i giochi del Ros è morto
suicida in carcere a Lucca il 29 agosto nel 2007. Cinque giorni prima la squadra
mobile lo ha arrestato nell’ambito di un’inchiesta su delle rapine avviata con
delle intercettazioni. Fuori dal ristorante dove lavora è stata trovata avvolta
in un tovagliolo una vecchia pistola di strana provenienza e che ha giustificato
il fermo per porto d’armi abusivo. Nella sua ultima lettera indirizzata anche ai
magistrati che hanno gestito la sua collaborazione c’è scritto: “Confermo che
tutto quello che ho detto corrisponde a verità. E’ un momento tragico per la mia
vita, sono fallito come tutto e ritrovarmi in carcere senza aver fatto nulla è
per me insopportabile…Vi chiedo scusa per questo insano gesto”. C’è un’altra
presunta mela marcia in questa storia. E’ il magistrato
Mario Conte che a Bergamo offre
la copertura legale al supermarket carrierista della droga. E quando l’inchiesta
Salomone decolla Conte si fa trasferire a Brescia acconto alla stanza di
Salomone. Per motivi di salute la sua posizione è stralciata e si trova in
attesa di giudizio. Si vedrà. Per il momento una sentenza di primo grado ci dice
che il metodo Ganzer nella lotta alla droga ha permesso l’ arresto di molti
pesci piccoli, sono aumentate le finanze di molti narcos ed è aumentato il
volume della cocaina nel nostro Paese. Senza dimenticare le violazioni del
diritto e la deviazione delle istituzioni. Chissà se vi è capitato di assistere
in televisione a vedere i servizi di quelle operazioni antidroga come “Cobra” o
“Cedro” e che nulla altro sarebbero state che delle recite a soggetto. I Ros di
Ganzer avrebbero anche installato una finta raffineria a Pescara per rendere più
brillante l’operazione. Ma tutto questo non era un’associazione a delinquere
secondo il Tribunale di Milano. Resta con la prescrizione una zona d’ ombra
anche per un carico arrivato dal Libano di 4 bazooka,119 kalasnikov, 2
lanciamissili in quel caldissimo 1993 italiano e che secondo l’originario capo
d’accusa i Ros avrebbero venduto alla cosca dei Macrì-Colautti. I soldi
dell’affare non si trovano. Solo qualche traccia bancaria sbiadiata. Guadagni
forse personali e qualche conto off shore che l’inchiesta non è stata in grado
di trovare.
Ganzer e
Obinu sapevano quello che combinavano i sottoposti.
Sono stati tutti condannati insieme al loro
tramite libanese Jean Ajai Bou Chaya che dovrà scontare 18 anni di carcere.
Intanto a Milano per arrivare a questa sentenza sono stati escussi trecento
testimoni (a favore di Ganzer la difesa ha anche chiamato l’ex procuratore
nazionale Vigna) e
accorpati centoquaranta fascicoli. Tenute 163 udienze in cinque anni, 28 tra
requisitorie e arringhe, 8 giorni di camera di consiglio. Nessuno ha seguito il
processo fatto salvo rinvio a giudizio, richiesta pena e cronache sulla
sentenza. L’unica eccezione è rappresentata da un articolo dell’Unità apparso in
pagina il 25 febbraio del 2009 a firma di
Nicola Biondo.
Il generale Ganzer in tutto questo trambusto è
diventato capo del Ros dal 2002 con beneplacito di destra e sinistra. A Mario
Mori sotto processo a Palermo succede Ganzer condannato ieri a Milano. Allievi
di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Nucleo speciale. Molti ufficiali
e poca truppa.
Investigazione speciale e segreta. I magistrati
sono stati spesso al loro guinzaglio, intercettazioni invasive e operazioni
nella terra di mezzo con il confidente. Una strana miscela che ha fatto
esplodere conflitti esplosivi come quello tra il colonnello Riccio e Mori in
Sicilia. Anche per Riccio condotte illegali nelle indagini antimafia gli sono
costate una condanna in Appello a 4 anni e 10 mesi. Chi è più Stato dello Stato?
I Ros di Ganzer oggi gestiscono le
inchieste sui fondi neri a Finmeccanica, i ricatti a Marrazzo, tutte le nobile
gesta della cricca, l’asse calobro-lombarda delle ndrine e gli affari della
Camorra. Può il generale rimanere al suo posto? Secondo il
ministro dell’Interno leghista e per il Comando generale
dell’Arma non ci sono dubbi, dall’opposizione non vola neanche una mosca. L’
attuale presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, da ministro dell’Interno vide lungo e chiese
che alcune competenze dei reparti speciali italiani andassero ai comandi
territoriali. Il Gico della Guardia di Finanza e lo Sco della Polizia hanno
ottemperato alla disposizione. Tranne il Ros dei carabinieri che con le sue
ventisei sezioni dislocate nelle Procure distrettuali restano delle monadi
impenetrabili. Da quei reparti vengono uomini come
Angelo Jannone, Giuliano Tavaroli, Marco
Mancini e finiti tutti nello scandalo dei dossier illegali
Telecom-Sismi. E gli ex Sismi
accusano gli ex Ros di avere contatti proprio con Ganzer che con il Ros di Roma
va a Palermo a disarticolare l’ufficio di Genchi subito sospeso dall’incarico
senza essere formalmente indagato mentre il generale resta al suo posto mancando
solo la promozione di generale di brigata. I Ros sono quelli che
arrestarono a Milano il calabrese Daniele Barillà, sette anni di carcere
innocente risarcito con soldi e la fiction di Beppe Fiorello “L’uomo sbagliato”.
Potremmo narrarvi tante storie sul Ros. Ma
io che sono un cronista di provincia ricordo che il Ros di Ganzer si occupò
anche dei No Global di Cosenza e della Rete del Sud ribelle dopo i fatti di
Genova. E dal mio archivio pesco un documentato articolo di
Peppino D’Avanzo che su
Repubblica ci svelava questa trama: «ACCADE che il Raggruppamento
Operazioni Speciali (Ros) dell’Arma dei Carabinieri si convinca che dietro i
disordini di Napoli (7 maggio 2001) e di Genova (21 luglio 2002) non ci sia
soltanto il distruttivo, nichilistico furore di casseur europei o il violento
spontaneismo delle teste matte (e confuse) di casa nostra, ma addirittura
un’associazione sovversiva. Concepita l’ipotesi, gli investigatori dell’Arma
intercettano, spiano, osservano, pedinano. In assenza di contraddittorio,
s’acconciano come vogliono cose, frasi, dialoghi, eventi, luoghi edificando una
conveniente e coerente cabala induttiva. È il sistema che più piace agli
addetti: “lavorare su materia viva, a mano libera”. Organizzato il
quadro, occorre ora trovare un pubblico ministero che lo prenda sul serio. Alti
ufficiali del Ros consegnano il dossier, rilegato in nero, di 980 pagine più 47
di indici e conclusioni ai pubblici ministeri di Genova. Che lo leggono e
concludono che ‘quel lavoro è del tutto inutilizzabile’. Gli investigatori
dell’Arma non sono tipi che si scoraggiano. Provano a Torino. Stesso risultato:
“Questa roba non serve a niente”. Il dossier viene allora presentano ai pubblici
ministeri di Napoli. L’esito non è diverso: il dossier, da un punto di vista
penale, è aria fritta.
Finalmente gli ufficiali del Ros rintracciano a
Cosenza il pubblico ministero Domenico Fiordalisi. Fiordalisi si convince delle
buone ragioni dell’Arma dei Carabinieri. Ora rendere conto delle buone ragioni
del Ros che diventano buone ragioni per il pubblico ministero e il giudice delle
indagini preliminari, Nadia Plastina, è imbarazzante per la loro e nostra
intelligenza». Nadia Plastina è stata
promossa, Fiordalisi è diventato pm in una procusa sarda e vive sotto scorta per
le minacce ricevute. I militanti arrestati nell’operazione No global sono stati
tutti assolti nel processo di primo grado e devono affrontare quello d’appello.
Il generale Ganzer è stato condannato da un tribunale dello Stato e resta al suo
posto di comandante del Ros.
L'inchiesta a Bergamo di Matteo Pandini su “Libero
Quotidiano”. Le toghe a tavola fanno festa coi boss del narcotraffico. Spuntano
le foto di tre magistrati bergamaschi con Patrizio e Massimo Locatelli: finiti
in carcere dopo il papà per traffico di droga. Della famiglia di malavitosi
parla Roberto Saviano nel suo ultimo libro "ZeroZeroZero". «Il nome di un
trafficante di droga non lo ricorda mai nessuno». Lo scrive Roberto Saviano nel
suo ultimo libro, ZeroZeroZero, in cui parla di cocaina e spiattella la
storia del boss bergamasco Pasquale Claudio Locatelli. Attualmente è in carcere:
poco dopo il suo arresto finirono in cella pure i due figli Patrizio e
Massimiliano. Saviano si sorprende che nessuno, neanche nella provincia
lombarda, avesse sentito puzza di bruciato quando i rampolli facevano fortune
con un’industria edile come la Lopav Spa, mentre il papà-boss era già in galera
con accuse pesantissime e il sospetto di legami con i clan di mezzo mondo, tra
cui quello camorristico dei Mazzarella. Saviano ha ragione: nessuno sembrava
sospettare. Neanche i magistrati bergamaschi. Tanto che alcuni di loro, tra i
più seri e brillanti, facevano festa e pranzavano proprio con i figli del
narcotrafficante. Facendosi addirittura fotografare per una rivista locale. Era
infatti successo che poco prima di essere arrestati per ordine del gip di
Napoli, i due ragazzi avessero organizzato un evento per riunire i 150
dipendenti e le relative famiglie. Era domenica 19 settembre 2010. Alle Ghiaie
di Bonate, oltre ai titolari e agli operai, c’erano parecchi ospiti vip.
Qualche politico. Alcuni religiosi, come
l’arcivescovo Gaetano Bonicelli. E soprattutto tre magistrati: Carmen Pugliese,
Angelo Tibaldi, Mario Conte. Non erano soli. C’era anche un ispettore di polizia
in servizio in Procura. Questo dicono le fotografie. In più, alcuni dei presenti
ricordano di aver visto pure il direttore del carcere di Bergamo Antonino
Porcino e un sottoufficiale della Guardia di Finanza. Circa un mese dopo,
Patrizio e Massimiliano Locatelli finiranno in manette con l’accusa di concorso
in traffico di stupefacenti e riciclaggio. Gli hanno sequestrato beni per circa
10 milioni. Già questo avrebbe dell’incredibile. Ma il peggio è che il padre,
Pasquale Claudio, era un fuoriclasse della malavita. Saviano lo racconta bene
nel libro. Quando aveva vent’anni si dedicava al furto di auto di grossa
cilindrata. Locatelli - scrive Saviano - è furbo e inizia a imparare le lingue
per allargare i suoi interessi. Austria. Francia. Poi Spagna. S’inventa parecchi
soprannomi e si stabilisce in una villa nei dintorni di Saint-Tropez. Viene
arrestato nel 1989. In casa gli trovano 41 chili di coca colombiana. Finito nel
carcere di Grasse per scontare una decina di anni, si rompe un braccio. Gli
agenti lo trasportano a Lione. Quando arriva a destinazione, un commando attacca
la scorta e scappa col boss. È fuga. Va in Spagna e si fa chiamare «Mario di
Madrid». Come racconta Saviano, è l’uomo di riferimento dei narcos colombiani in
Europa e proprietario di una flotta navale per il traffico internazionale di
cocaina. Non proprio un pesce piccolo, insomma. Lo scrittore lo definisce un
«broker della polvere». E scrive: «Ha intuìto che l’eroina come mercato di massa
stava finendo, mentre il mondo ne consumava ancora tonnellate». Nel 1991
riuscirà a scappare da una villa nel Bresciano, dove era andato dalla sua
compagna Loredana. Pochi anni più tardi verrà pizzicato con un avvocato e il
sostituto procuratore di Brindisi: nel processo il magistrato riuscirà a
dimostrare di non sapere chi fosse Pasquale Locatelli e verrà prosciolto.
Evidentemente, qualche boccone con le toghe sono un vizio di famiglia. Dopo anni
di galera in Spagna, il boss torna nella prigione di Grasse (quella
dell’evasione), ma nel 2004 devono estradarlo a Napoli. Una sentenza della Corte
di cassazione gli ridà la libertà. E Locatelli senior torna in Spagna, dove fa
dentro e fuori da galera distribuendo false identità. Intanto i due figli sono
rimasti in Italia e mettono in piedi la Lopav Spa, che si occupa di
pavimentazioni. Vincono pure un appalto da 500mila euro all’Aquila. Oltre a
quello per il nuovo centro commerciale di Mapello, Bergamo, che a fine 2010
verrà scandagliato per la scomparsa della 13enne Yara Gambirasio, inghiottita
nel buio di Brembate Sopra il 26 novembre 2010 e trovata cadavere tre mesi dopo.
Nel maggio 2010 Pasquale Locatelli finisce in carcere, dopo che gli inquirenti
avevano pedinato proprio il figlio che lo stava raggiungendo in Spagna. Pochi
mesi dopo, anche i rampolli subiranno lo stesso trattamento. Nel corso delle
indagini su Yara, era emerso che il padre della ragazza, Fulvio Gambirasio,
aveva avuto rapporti di lavoro con la Lopav. Per Saviano, aveva addirittura
testimoniato in un processo contro Pasquale Locatelli. Ma la pista di un
possibile collegamento con la scomparsa della 13enne è stata abbandonata in
fretta. Erano tanto sicuri di sé, i rampolli Locatelli, da invitare a pranzo dei
magistrati. Angelo Tibaldi fu tra i più giovani ed efficaci sostituti
procuratori che indagarono sugli episodi di corruzione che, nell’era di
Tangentopoli, riguardavano anche Bergamo. Da anni è giudice del tribunale
civile. Carmen Pugliese è attualmente il sostituto procuratore di maggior
anzianità della Procura orobica. Si è occupata di più settori: dallo spaccio di
droga alla pedofilia. Mario Conte, già sostituto procuratore a Bergamo e oggi
giudice del tribunale civile, negli anni ’90 ha lavorato anche a Milano con Di
Pietro. Recentemente è stato assolto dalla Corte d’assise di Milano dall’accusa
di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti nel
procedimento che lo vedeva imputato per i suoi rapporti con i carabinieri del
Ros del generale Giampaolo Ganzer. Questa volta ha ragione Saviano. «Il nome di
un trafficante di droga non lo ricorda mai nessuno».
Nel tempo dell'inganno universale, dire la
verità è un atto rivoluzionario!
SE TU DENUNCI LE INGIUSTIZIE DIVENTI MITOMANE O
PAZZO. IL SISTEMA E LA MASSOMAFIA TI IMPONE: SUBISCI E TACI. LA STORIA DI
FREDIANO MANZI E PIETRO PALAU GIOVANETTI.
FREDIANO MANZI UN
GESTO ESTREMO CONTRO L'ABBANDONO DEGLI USURATI.
Si è dato fuoco,
davanti alla sede milanese della Rai, Frediano
Manzi, presidente
dell’associazione SOS Racket e Usura. Un gesto disperato, estremo, compiuto per
richiamare l’attenzione delle istituzioni sulle tante, troppe, vittime del
pizzo, dei soldi prestati a strozzo. Attività monopolio della criminalità
organizzata per la quale non esiste crisi. Manzi ha lasciato comunque una
lettera in cui spiega le ragioni del gesto e avanzerebbe alcune richieste:
“Una commissione d’inchiesta sul caso Ferrigno”; “rimozione del presidente del
Fondo nazionale antiusura”. L’uomo avrebbe riportato ustioni di terzo grado
su tutto il corpo, specie alla braccia e al torace. L’episodio è avvenuto poco
dopo le 20.30 del 5 febbraio 2013 in corso Sempione. Dopo essersi cosparso il
corpo di benzina il coordinatore di SOS
Racket e Usura,
secondo i giornalisti presenti, ha detto: “Tra 5 minuti mi do fuoco per tutte
le vittime di usura. Addio”. Poi ha tirato fuori un accendino e si è dato
fuoco. Ad intervenire per primo, mentre Manzi era avvolto dalle fiamme, è stato
un autista
del tram numero 19 che
vedendo la scena è sceso dal mezzo pubblico con l’estintore e l’ha scaricato
addosso a Manzi, che altrimenti rischiava davvero la morte o comunque
conseguenze ancora peggiori di quelle in cui si trova adesso. L’autista ha
raccontato: “Stavo transitando in corso Sempione
quando ho visto le fiamme e istintivamente mi sono fermato. Poi ho capito che
era un uomo e sono sceso con l’estintore e ho spento il fuoco che lo avvolgeva”.
Il 4 gennaio 2013 Manzi si era già tagliato le vene denunciando di trovarsi in
una situazione economica disperata e di aver dovuto chiudere due attività. Sotto
minaccia da parte dalla criminalità organizzata (“per la ‘ndrangheta sono un
morto che cammina”) a fine 2011 aveva scioccato tutti dicendo di aver
commissionato due attentati a una della sue attività, un negozio di fiori.
Perché? Per attirare l’attenzione su Sos Racket e Usura. Per questo finì
indagato a
Milano e Busto Arsizio e la sua credibilità, inevitabilmente, subì un duro
colpo. Manzi aveva patteggiato un anno e otto mesi
di reclusione dopo aver confessato di aver commissionato per 1.200 euro al
pluripregiudicato Alberto Marcheselli un finto attentato a un suo chiosco
di fiori a Parabiago, per poi denunciare che si
trattava di un atto di intimidazione contro l'attività della sua associazione.
Ciò non toglie che grazie all’attività dell’associazione da lui presieduta e
alle sue denunce sono state aperte diverse inchieste, come nel 2010 quando a
Milano erano state arrestate alcune persone per il racket sulle case popolari.
Era stato sempre Manzi a sporgere denuncia contro l’ex prefetto di Napoli Carlo
Ferrigno, che due anni fa per le accuse di millantato credito e prostituzione
minorile ha patteggiato una
pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione. Manzi aveva chiesto di parlare ai
giornalisti che si occupavano del telegiornale e quando gli addetti alla
portineria lo hanno invitato ad allontanarsi ha minacciato di darsi fuoco. Poco
dopo, si è cosparso di liquido e ha dato corpo alla sua minaccia. L'uomo è stato
soccorso da un tramviere dell'Atm. "Stavo transitando in corso Sempione quando
ho visto le fiamme e istintivamente mi sono fermato", ha raccontato il
soccorritore. "Poi ho capito che era un uomo e sono sceso con l'estintore e ho
spento il fuoco che lo avvolgeva". Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che
si sono fatti consegnare la lettera lasciata da Manzi agli uscieri e che
cominciava così: "Ho deciso di darmi fuoco per portare l'attenzione delle
istituzioni su tutte le vittime dell'usura". Prima di cospargersi di benzina e
appiccare le fiamme a se stesso con un accendino, Manzi ha consegnato alla tv di
Stato una lettera in cui ribadisce il motivo del suo gesto, accompagnandolo con
delle richieste, disperate tanto quanto lui. «Per le vittime dell’usura che
nessuno aiuta», si legge nel foglio, scritto a mano. Poi alcune richieste,
quelle degli ultimi 10 anni di lotte. «Una commissione d’inchiesta sul caso
Ferrigno», o «rimozione del presidente del Fondo nazionale antiusura». In realtà
Frediano Manzi da tempo versava in uno stato di profonda prostrazione, e aveva
recentemente già tentato il suicidio tagliandosi le vene. Dopo i clamori seguiti
alle importanti inchieste che le denunce della sua associazione (che negli anni
è diventata un punto di riferimento per le vittime del racket) avevano fatto
partire, nell’ambito non solo dell’usura ma dell’intreccio tra la criminalità
organizzata e gli enti locali, lui stesso era scivolato nel baratro finendo a
sua volta denunciato per aver simulato un attentato a uno dei suoi negozi di
fiori. Così era inevitabilmente cominciato il declino della sua credibilità. Una
situazione che, insieme ai suoi problemi economici e alle continue minacce della
criminalità organizzata, lo avevano minato profondamente spingendolo ormai a una
vita border line.
Povero Frediano Manzi.
Non sa che per essere finanziato e sostenuto basta santificare i magistrati ed
essere di sinistra?
IN CARCERE PER AVER DIFESO LA GIUSTIZIA.
Lui non si chiama SALLUSTI... è PIETRO PALAU
GIOVANETTI presidente di AVVOCATI SENZA FRONTIERE... sta per finire in carcere
in ITALIA per avere difeso i diritti dei cittadini...
«Se potete vi prego di
fare qualcosa è assurdo che mi mettano in carcere per avere denunciato la
corruzione giudiziaria. Pensate che ieri abbiamo scoperto che la Procura
Generale di Brescia ha omesso di trasmettere alla Cassazione il Ricorso per
incidente di esecuzione che mi nega sia la prescrizione sia la continuazione sia
l'errore di calcolo della pena residua. Lo Stato di diritto è morto....» Pietro
Palau Giovannetti.
Tra le altre cose
questo signore ha scritto sul suo sito questo pezzo.
QUANDO IL P.M. FA L'AVVOCATO DEGLI IMPUTATI: LO
SCANDALOSO CASO MASTROGIOVANNI
Udienza 2 ottobre 2012, Vallo della Lucania.
Per l'omicidio preterintenzionale di
Francesco Mastrogiovanni, come prevedibile il P.M. Martuscelli ha chiesto di
derubricare i reati più gravi, smontando l'impianto accusatorio del precedente
P.M., Francesco Rotondo, "promosso"
per impedirgli di concludere il processo, scrive “La Voce di
Robin Hood”.
La Segreteria di Avvocati senza Frontiere, mentre
è ancora in corso la requisitoria, rende noto che, a seguito della mancata
astensione del P.M. Renato Martuscelli che ha ignorato la richiesta del
difensore della Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood, costituita parte
civile con l'Avv. Michele Capano del Foro di Salerno, ha inviato un
circostanziato Esposto al C.S.M. e al Procuratore
Generale presso la Corte d'Appello di Salerno per procedere in sede
disciplinare nei confronti del P.M. Martuscelli e per valutare la
rilevanza penale delle gravi e molteplici violazioni procedimentali che
si sono verificate nell'ambito del processo in corso da oltre tre anni. Dopo
aver sottoposto ad attenta disamina lo svolgimento del processo, nonché le
attività svolte dalle parti, i legali dell'Associazione si sono resi conto
dell'intollerabile assenza del P.M. che in spregio alle sue funzioni
istituzionali ha assunto in maniera sfacciata, senza mezzi termini, la difesa
degli imputati, cercando di minimizzare le gravi responsabilità
degli stessi, rivolgendo, viceversa, le proprie attività d'accusa nei confronti
della vittima, nel precipuo scopo di alleggerire le condotte dei medici e del
personale ospedaliero, nonché delle stesse forze dell'Ordine che hanno eseguito
con modalità illegittime, il brutale fermo di una persona assolutamente sana di
mente e pacifica che implorava di non venire portato presso il lager
psichiatrico del San Luca di Vallo della Lucania, preavvertendo con
grande lucidità che sarebbe stato ucciso. A riguardo, i legali di Avvocati senza
Frontiere hanno ricordato la pregressa attività persecutoria del P.M.
nei confronti del maestro elementare Francesco Mastrogiovanni, quando il povero
Mastrogiovanni era ancora in vita, sottoponendolo, ingiustamente, già anni
orsono, alla misura della custodia cautelare per oltre 9 mesi,
per fatti del tutto insussistenti di pretesa "resistenza e oltraggio a
pubblico ufficiale", dai quali l'odierna vittima è stata poi
assolta con formula ampia dalla Corte d'Appello di Salerno,
riconoscendo l'abuso da parte delle Forze dell'Ordine, e
condanna dello Stato Italiano da parte della Corte Europea per i
Diritti dell'Uomo di Strasburgo, per l'ingiusta detenzione.
L'esposto prosegue denunciando l'anomalo comportamento endoprocessuale
e l'assoluta inerzia investigativa del P.M. Martuscelli, anche nel connesso
procedimento R.G.N.R. 1799/09, nell'ambito del quale ha richiesto nelle scorse
settimane l'archiviazione nei confronti dei medici che avevano disposto il TSO
di Mastrogiovanni, risultando perciò evidentemente incompatibile e impensabile
che potesse oggi sostenere la Pubblica Accusa, sostituendo l'originario P.M. che
aveva svolto in maniera ineccepibile le indagini e disposto i rinvii a giudizio,
venendo infine rimosso, mediante promozione: "promoveatur ut amoveatur"
(noto brocardo latino, la cui traduzione è "sia promosso affinché sia
rimosso", usato per esprimere la necessità di liberare un ruolo chiave
dell'organigramma dalla persona che lo occupa, promuovendola ad un qualunque
altro ruolo di rango superiore, quale unico mezzo per poterlo "legalmente"
allontanare dalla posizione occupata, ritenuta scomoda agli interessi dei poteri
dominanti). Ciò non bastando, anche le stesse condotte endoprocessuali tenute
dal Dr. Martuscelli nel corso del dibattimento hanno rivelato la sua manifesta
parzialità, animosità e acrimonia verso la persona del defunto Mastrogiovanni,
nei cui confronti giungeva addirittura ad infierire con diffamanti e false
insinuazioni, dipingendolo come pericoloso sovversivo, spingendo i testimoni ad
esprimere valutazioni negative e del tutto inconferenti alla illegittima
prolungata contenzione che ne ha provocato la morte. D'altro canto, il
Martuscelli rivelava prevenzione e grave inimicizia, omettendo qualsiasi
attività, quale rappresentante della Pubblica Accusa, neppure ravvisando la
necessità di sollevare eccezione di inammissibilità circa l'ammissione della
testimonianza della Dr.ssa Di Matteo, in quanto indagata nel parallelo
procedimento connesso R.G.N.R. 1799/09, relativo al TSO, giungendo, infine, ad
omettere di richiedere l'acquisizione del video integrale delle oltre 83
ore di tortura con mani e piedi legati, senza acqua nè cibo, da cui si
poteva, altresì, accertare la presenza del primario che invece la difesa
sosteneva in ferie. Ragioni per cui prima di conoscere l'esito della
requisitoria del P.M. che si è poi appreso aver richiesto la derubricazione dei
reati più gravi, premonitoriamente il comunicato stampa di Avvocati senza
Frontiere avanzava l'ipotesi che vi erano fondati motivi per ritenere che il
Martuscelli avrebbe richiesto l'assoluzione del primario del lager psichiatrico
e pene miti nei confronti dei terzi imputati aventi causa.
In effetti, l'anomala Pubblica Accusa è andata
ben oltre, ritenendo insussistente il reato di sequestro di
persona, contestato in origine dal P.M. rimosso, a tutti i 18 imputati tra
medici ed infermieri, ha fatto cadere l'imputazione di cui all'art. 586 c.p.
(morte come conseguenza di altro delitto), sostenendo la mancanza dell'elemento
doloso del delitto, chiedendo, infine, la derubricazione ad omicidio colposo.
Attraverso tale capzioso percorso argomentativo, insultando il buon senso e
l'intelligenza del popolo italiano che ha visto il video integrale dell'atroce
agonia inflitta ad un uomo sano, libero e in pieno possesso della sue facoltà
mentali, il P.M. Martuscelli, ritenendo la contenzione che ha provocato l'atroce
morte della vittima, come "blanda e irrilevante", ovvero (sic!)
un "atto medico dovuto", anzichè barbara tortura medievale, ha
chiesto lievi pene comprese tra i due anni e i due anni e 7 mesi per il
personale medico e sanitario in servizio la notte tra il 3 e il 4 agosto 2009.
La difesa di Avvocati senza Frontiere anticipa che nella propria arringa
richiederà anche ai sensi dell'art. 523 c.p.p., la visione del filmato
integrale, sottolineando che, senza l'acquisizione agli atti di tale basilare
prova, nessun giusto verdetto potrà scaturire all'esito del processo. E'
da ritenersi infatti che l'anomalo P.M. non si mai neppure peritato di esaminare
integralmente il filmato, in quanto ove avesse trovato il coraggio di
farlo, posto di fronte alla consapevolezza dei fatti e a quali atroci sofferenze
e' stata ininterottamente sottoposta la vittima di tali disumani trattamenti,
definiti del tutto incoscientemente "atti medici dovuti" non
avrebbe di certo avuto l'ardire di definire la contenzione praticata "blanda
e irrilevante", nè tantomeno di coprire le ben più gravi responsabilità
penali e sarebbe giunto a ben diverse ipotesi, contestando invece l'omicidio
preterintenzionale.
A tal riguardo è uscito un articolo su
“L’Espresso”. A firma di Ermanno Forte. “Ora processano Mastrogiovanni”.
Requisitoria da anni '50 nel dibattimento sull'omicidio del maestro: il pm
difende gli imputati e se la prende con le 'bizzarrie' della vittima. Non c'è
stato sequestro di persona perché la contenzione è un atto medico e quindi chi
ha lasciato un uomo legato mani e piedi a un letto, per oltre 82 ore, ha
semplicemente agito nell'esercizio di un diritto medico. Al massimo ha ecceduto
nella sua condotta, ma questo non basta a considerare sussistente il reato di
sequestro. E' questa la considerazione centrale della requisitoria formulata da
Renato Martuscelli al processo che vede imputati medici e infermieri del reparto
di psichiatria dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, per la morte di
Francesco Mastrogiovanni. Per il pubblico ministero decade dunque il capo
d'imputazione principale contestato ai sanitari, e di conseguenza anche quello
ad esso collegato, la morte come conseguenza di altro delitto. Martuscelli ha
così derubricato quest'ultima imputazione, chiedendo invece la condanna per
omicidio colposo dei soli medici e infermieri in servizio il 3 agosto del 2009,
l'ultimo giorno di agonia del maestro cilentano (che muore alle 2 di notte del 4
agosto). Nel dettaglio: tre anni di reclusione per Michele Di Genio, il primario
del reparto; due anni e sei mesi per Americo Mazza e Rocco Barone e due anni e
sette mesi per Anna Ruberto (i tre medici in servizio quel giorno). Il pm ha
contestato l'omicidio colposo anche ai sei infermieri in servizio il 3 agosto
(Antonio De Vita, Antonio Tardio, Alfredo Gaudio, Antonio Luongo, Nicola
Oricchio e Raffaele Russo), per i quali ha chiesto la condanna a due anni. In
sostanza Martuscelli sostiene che chi era di turno l'ultimo giorno di vita di
Mastrogiovanni avrebbe dovuto accorgersi del peggioramento delle sue condizioni.
E che l'unica colpa penalmente rilevante dei sanitari di quel reparto sia
questa. Viene invece confermata per tutti i medici l'accusa di falso in atto
pubblico, per non aver registrato la contenzione sulla cartella clinica:
Martuscelli ha chiesto condanne per un anno e due mesi di carcere (oltre che per
i tre medici sopra citati, anche per Michele Della Pepa e Raffaele Basso),
eccezion fatta per il primario Di Genio (la richiesta è di un anno e quattro
mesi). Il pm ha dunque in gran parte sconfessato l'impianto accusatorio
imbastito nella fase delle indagini e di richiesta di rinvio a giudizio da
Francesco Rotondo, il magistrato che sin dall'inizio ha lavorato sul caso,
disponendo l'immediato sequestro del video registrato dalle telecamere di
sorveglianza del reparto psichiatrico, e che poi è stato trasferito. Nella prima
parte della requisitoria - durata un paio d'ore, davanti al presidente del
tribunale Elisabetta Garzo –Martuscelli si è soffermato a lungo sui verbali di
carabinieri e vigili urbani relativi alle ore precedenti al ricovero (quelli
dove si descrivono le reazioni di Mastrogiovanni alla 'cattura' avvenuta sulla
spiaggia di San Mauro Cilento e le presunte infrazioni al codice della strada
commesse dal maestro), oltre a ripercorrere la 'storia sanitaria' di
Mastrogiovanni, già sottoposto in passato a due Tso, nel 2002 e nel 2005. "Una
buona metà dell'intervento del pm è stata dedicata a spiegare al tribunale
quanto fosse cattivo e strano Franco Mastrogiovanni" commenta Michele Capano,
rappresentante legale del Movimento per la Giustizia Robin Hood, associazione
che si è costituita parte civile al processo "sembrava quasi che l'obiettivo di
questa requisitoria fosse lo stesso maestro cilentano, e non i medici di quel
reparto". Il processo continuerà il 16 ottobre, con l'arringa di Caterina
Mastrogiovanni, l'avvocato dei familiari della vittima, e dei legali delle altre
parti civili. A seguire ci saranno le arringhe dei difensori degli imputati,
fino alla pronuncia della sentenza, prevista per il 30 ottobre.
CHI E’ PIETRO PALAU GIOVANNETTI.
Sono Pietro Palau Giovannetti, presidente del
Movimento per la Giustizia Robin Hood e della rete "Avvocati senza Frontiere",
nonché direttore responsabile del giornale on line www.lavocedirobinhood.it,
Enti no profit che dirigo da oltre 25 anni, battendomi in prima persona per
l'affermazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e
una giustizia pulita libera da mafie, partiti, logge massoniche e corruzione. Mi
permetto di richiedere la solidarietà
di tutti gli spiriti liberi e le persone oneste, perché tra
qualche giorno sarò tratto
ingiustamente in arresto,
senza aver mai commesso
alcun reato, se non quello che non può certo considerarsi tale, di aver
denunciato, sin dai tempi di "mani pulite", la dilagante corruzione
politico-giudiziaria e gli abusi nei confronti dei soggetti più deboli che non
hanno mezzi o stuoli di avvocati prezzolati, in grado di condizionare le
istituzioni, ostacolando il regolare corso della Giustizia. Se nei prossimi
giorni il P.G. di Brescia riterrà di arrestarmi, sono pronto ad andare in
carcere a testa alta, perché credo in una
Legge molto più grande di
quella umana, controllata da logiche perverse e dalle varie mafie che soffocano
la legalità. Sono intimamente convinto che in uno «Stato-mafia»,
come quello in cui viviamo che imprigiona ingiustamente i deboli e lascia
deliberatamente impuniti colletti bianchi, criminali politici e mafiosi, "anche
una prigione sia un luogo adatto per un uomo giusto", come affermava Henry
David Thoreau, grande pensatore del Rinascimento americano, il quale nel saggio
"Disobbedienza civile", sosteneva tra l'altro che è ammissibile non rispettare
le leggi quando esse vanno contro la coscienza e i diritti dell'uomo, ispirando
cosi i primi movimenti di protesta e resistenza non violenta. A fronte del mio
incessante impegno civile e lotta alla "massomafia", ho subito
oltre 750 procedimenti penali, di cui ben 114 solo in
Cassazione, con le accuse più disparate per pseudoreati di natura ideologica,
scaturenti dalle mie stesse denunce, ritenute assurdamente "corpi di
reato", o dagli articoli pubblicati sui siti web dell'Associazione.
Procedimenti da cui sono sempre stato per lo più assolto, per manifesta
infondatezza delle notizie di reato. Ma ciò nonostante, dal 1986, sono stato
fatto continuamente oggetto di rinvii a giudizio e addirittura di ripetute
richieste di perizie psichiatriche, come in uso nelle dittature dei Paesi
dell'Est, costringendomi a difendermi, senza sosta, in ogni sede, per gran parte
della mia vita. Solo attraverso una ferrea difesa e la mia fede nella vera
Giustizia sono riuscito a contrastare questa impressionante mole di attività
persecutorie che non trovano precedenti nella storia del diritto internazionale,
anche tenuto conto dell'enorme dispendio di risorse pubbliche impiegate per
l'istruzione di svariate migliaia di udienze e centinaia di procedimenti penali,
privi di qualsiasi consistenza, rilevanza e interesse sociale. Per l'abnormità
delle procedure adottate il mio caso richiama quello del pacifista nonviolento,
Danilo Dolci, che dagli
anni '50, in Sicilia, dedicò la sua vita alla causa degli ultimi, lottando per
l'emancipazione dalla povertà e dall'ignoranza, venendo, come me, ingiustamente
arrestato e condannato per reati di opinione dalla magistratura di regime
dell'epoca, tutt'oggi, purtroppo, ancora, asservita agli interessi della
politica e della "massomafia",
cioè di quel regime occulto trasversale ai partiti che da oltre 150 anni governa
il Paese. La sua condanna venne infatti scandalosamente confermata dalla Suprema
Corte di Cassazione, seppure in sua difesa avessero testimoniato Premi Nobel ed
intellettuali di fama mondiale del calibro di Carlo Levi, Erich Fromm, Norberto
Bobbio, Elio Vittorini, Lucio Lombardo Radice, Padre David Turoldo, Don Zeno,
etc., e l'arringa fosse stata pronunciata da Piero Calamandrei, tra i padri
fondatori della nostra amata Costituzione. Oggi anch'io rischio il carcere,
stante la definitività di alcune inique condanne per oltre
5 anni di reclusione,
confermate dalla Cassazione per reati di pretesa "diffamazione, calunnia,
oltraggio, resistenza", nei confronti di magistrati, avvocati e altri
infedeli rappresentanti delle istituzioni, seppure, come riconosciuto dallo
stesso Tribunale di Sorveglianza - che qui cito testualmente - i cosiddetti "precedenti
penali" a me ascritti: "concernono sostanzialmente situazioni e
contesti legati ad iniziative sociali quali quelle patrocinate dal Movimento per
la Giustizia Robin Hood". Ma ciò
nonostante mi vogliono mandare in galera dopo avermi perseguitato per oltre un
quarto di secolo, neanche rappresentassi un pericolo pubblico!
Le condanne inflittemi non colpiscono infatti un pericoloso delinquente, bensì
un Human Rights Defender
che, da oltre 25 anni, si adopera a tutela della legalità,
denunciando gli abusi del potere e l'impunità di cui godono gli affiliati ai
vari comitati d'affari e logge massoniche, che hanno occupato lo Stato,
soffocando la democrazia, attraverso il controllo capillare delle istituzioni,
dell'economia, dei media e della cultura, garantendosi in tal modo il «controllo
sociale» e una forma di governo parallelo, che Ernst Fraenkel
denominò "Doppio Stato".
Cioè, la compresenza nell'assetto statuario di "normatività" e
"discrezionalità", dove a fianco di un sistema apparentemente democratico,
convive un ordine perverso, che applica, come ai tempi della Germania nazista,
la discrezionalità sistematica nell'applicazione e nel rispetto delle leggi,
allo scopo di intimidire, reprimere e sopprimere ogni forma di dissenso,
perpetuando proprio grazie a questa autoreferenziale contraddizione di sistema,
l'organizzazione del consenso e il dominio sui governati, dove le istituzioni
sono invase da politici, pubblici amministratori e magistrati corrotti, in
simbiosi con banchieri, massoni e mafiosi, mentre una parte sana ma minoritaria
e priva di mezzi dello Stato e della Società civile, cerca di contrastarli, a
rischio della propria stessa vita o di venire delegittimati, come fu per
Falcone, Borsellino, Cordova, De Magistris, Ingroia e tanti altri fedeli
servitori dello Stato. A riguardo, sin
dagli anni '80, ho infatti inascoltatamente segnalato, anche con
grandi manifesti, che la mafia aveva messo le mani sulla città, denunciando
l'imperversante speculazione edilizia e gli abusi ambientali nei quartieri
metropolitani milanesi, da parte dei vari comitati d'affari che, già da allora,
all'ombra di illecite protezioni, spadroneggiavano impunemente, controllando il
territorio e i gangli vitali delle istituzioni, attraverso quella che i P.M. di
"mani pulite" definirono come "corruzione
ambientale", senza poi però riuscire ad andare sino in fondo.
Denunce, occorre ricordare, che hanno permesso alla Procura di Milano di portare
alla luce massicci episodi di corruzione nella Guardia di Finanza e nella stessa
magistratura, portando all'arresto, tra gli altri, del Generale
Giuseppe Cerciello, e
dell'allora insospettato Presidente del Tribunale di Milano,
Diego Curtò, entrambi da me
denunciati, sin dal 1989, venendo io, però, dapprima, incriminato per
diffamazione e calunnia, nonché preso per "visionario", fino al loro arresto e
alla definitiva condanna degli stessi per fatti di corruzione (quest'ultimo,
come molti ricorderanno, in relazione alla
megatangente Enimont e al
lodo Mondadori). Il
Movimento per la Giustizia Robin Hood, spezzando in parte l'azione
ostruzionistica nei suoi confronti, ottenne poi il riconoscimento quale Onlus
nella sezione civile del Registro del Volontariato della Regione Lombardia, con
effetto retroattivo dal 1998, in forza di due sentenze del T.A.R., di cui una
per obblighi di fare. Nonostante l'alto
valore sociale di tali attività, come riconosciuto dallo stesso
Tribunale di Sorveglianza, lo scorso 15/1/13, i giudici bresciani che avevano
precedentemente sospeso il processo, rinviandolo a nuovo ruolo, in attesa
dell'esito dei giudizi pendenti in Cassazione per incidente di esecuzione e
avanti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - che se accolti comportano la
revisione automatica del processo "non equo" -, hanno invece cambiato
indirizzo, riservandosi sulla revoca del mio affidamento ai Servizi Sociali,
cosa che implicherà nei prossimi giorni l'obbligo di arresto per scontare una
pena residua di 2 anni,
8 mesi, 17 giorni, dopo aver già espiato anni 1, mesi 5 e giorni 7 di
reclusione, oltre ad 1 anno di Libertà
controllata, neanche fossi un mafioso o un criminale,
per un totale di ben oltre 5 anni di
carcerazione! Taluni media falsamente garantisti quando si
tratta di coprire i potenti, sicuramente cercheranno di gettare altro fango,
insinuando ogni sorta di dubbio e calunnia nei miei confronti, a partire da il
Giornale di Sallusti, che ho già avuto modo di denunciare per
il contenuto diffamatorio dell'articolo: "Il nuovo eroe antipremier? E' in
realtà un bancarottiere condannato per calunnia", articolo apparso in data
14/5/11, in occasione del processo Mills e del mio fermo illegale
avanti al Tribunale di Milano, ad opera della Digos, che molti forse
ricorderanno, avendo destato anche presso la stampa estera, notevole
indignazione e scalpore per le modalità brutali e la manifesta ingiustizia.
Voglio quindi si sappia che, al di là delle calunnie della stampa di regime, non
ho mai subito alcuna definitiva condanna per reati societari come il padrone di
Sallusti e che l'unica vera ragione dell'accanimento di settori deviati della
magistratura nei miei confronti, risiede nel fatto che ho denunciato, per primo,
l'esistenza di poteri esterni allo Stato, ovvero di un «Regime occulto»,
in grado di condizionare l'intero arco parlamentare, media, forze dell'ordine e
organi giurisdizionali, sino alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, mettendo
in luce il ruolo di subalternità delle mafie agli apparati dell'alta
finanza e dello Stato e, quel che, sicuramente, più
disturba, alla Massoneria internazionale, secondo la stessa
prospettiva investigativa di Giovanni Falcone, che partendo dalle rivelazioni di
Tommaso Buscetta aveva capito, sin dal 1984, come la Massoneria rappresenti il «collante»
dei vari poteri criminali con la politica, le istituzioni e i servizi segreti.
Non credo perciò di meritare di andare in carcere per le mie denunce, come non
lo meritava neppure Sallusti, seppure coltivasse ragioni diametralmente opposte
alle mie, perché in un Paese veramente libero nessuno può venire incarcerato per
le proprie idee. Grazie di cuore per la Vs. attenzione e per il Vs. sostegno
nelle forme che più riterrete opportune.
Pietro Palau
Giovanetti secondo “Il Giornale”. E meno male che Sallusti sa cosa vuol dire
essere perseguito per reato di opinione. Le urla, «vergogna, vergogna», gli
spintoni, la polizia che arriva e trascina via il contestatore: il tutto sotto
gli obiettivi delle telecamere, che documentano in diretta l'ennesimo caso di
repressione del dissenso. La scena accade davanti al tribunale di Milano,
blindato dale forze dell'ordine per la nuova udienza a carico di Silvio
Berlusconi. Protagonista della protesta solitaria, racconteranno le cronache e
le telecronache, un avvocato: un professionista indignato per le malefatte del
capo del governo, e deciso a manifestare il suo sostegno a Ilda Boccassini e ai
suoi colleghi. Ma
alle 15.36 di ieri pomeriggio un comunicato dell'Ordine degli avvocati milanesi
costringe a rivedere la faccenda: «A seguito dei recenti fatti di cronaca
divulgati in data 9 maggio 2011 in relazione allo svolgimento del processo
Mills, in occasione del quale si è riferito di un contestatore, Pietro Palau
Giovannetti, indicato dalla stampa come avvocato, si comunica che tale Pietro
Palau Giovannetti non risulta iscritto negli elenchi professionali tenuti dal
consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano».
E quindi? Se non è un avvocato, come hanno
scritto i giornali, chi è il signore alto e robusto che i carabinieri hanno
trascinato via mentre urlava «vergognatevi buffoni» ai militanti del Pdl in
attesa di Berlusconi sotto il tribunale? L'aspirante icona della sinistra (emulo
di Pietro Ricca, che nel 2003 urlò «buffone» a Berlusconi in tribunale e su
questo costruì una carriera) è in realtà un personaggio di cui le cronache
giudiziarie si sono dovute occupare in più di un'occasione. Titolare di una
piccola azienda di auto d'epoca, la Classic Cars, Palau finisce gambe all'aria
all'inizio degli anni Novanta e viene inquisito per bancarotta fraudolenta. A
quel punto si trasforma in un implacabile accusatore della magistratura che - a
suo dire - lo avrebbe ingiustamente inquisito. Attraverso l'associazione «Robin
Hood» di cui è presidente, segretario e unico militante lancia la sua crociata
contro le malefatte dei giudici. Se la prende in particolare con il procuratore
Francesco Saverio Borrelli, che accusa di malefatte di ogni genere: querelato
dal capo di Mani Pulite, Palau viene condannato per calunnia. Ma non si arrende,
anzi. E qui la faccenda si fa
interessante. Il nome di Palau Giovannetti viene infatti citato in una
intervista al Corriere, nel maggio 1997, dal pm Piercamillo Davigo. Si parla del
misterioso «dossier Achille», un documento attribuito al Sisde in cui si
ipotizzavano tra l'altro infiltrazioni ebraiche e massoniche nel pool Mani
Pulite. Ed ecco cosa dice Davigo: «Per carità, io posso fare solo un'ipotesi.
L'unica cosa che mi viene in mente è la valanga di denunce presentate da Pietro
Palau Giovannetti... La conosce la sua storia? Quel signore abitava in uno
stabile di un immobiliarista milanese, Virginio Battanta. Ricevuto lo sfratto,
Palau lo ha denunciato. Poi, quando è finito sotto inchiesta per due fallimenti,
ha cominciato a presentare esposti a Brescia contro i pm di Milano che, a suo
dire, non avrebbero indagato. Di lì è nato un groviglio di inchieste a catena,
con decine o forse centinaia di denunce incrociate, penso che ora se ne occupi
Trento ma non escludo che prima o poi, passando da una Procura all'altra,
finisca tutto a Trieste. Ecco, ricordo che una delle tante denunce di Palau fu
indirizzata al procuratore Cordova (all'epoca procuratore di Palmi), che
all'epoca era titolare della maxi-inchiesta sulle logge coperte. Che io ricordi,
quella è l'unica denuncia che abbia mai ipotizzato infiltrazioni
giudaico-massoniche, espressione forse usata in senso generico, approssimativo,
tra i magistrati di questa Procura».
Sono passati quattordici anni. E
lunedì scorso il bancarottiere che allora accusava la Procura milanese di essere
un covo di massoni riemerge all'improvviso, trasformandosi in «avvocato» e
incarnando per mezza giornata la nuova icona del popolo filo-giudici.
Marco Travaglio a
riguardo ha qualcosa da dire.
HANNO AVUTO IL CORAGGIO DI CHIAMARLA "GUERRA TRA
PROCURE", QUANDO L'UNICA VERA GUERRA E' QUELLA MOSSA DAI POTERI OCCULTI ALLA
PARTE SANA DELLA MAGISTRATURA PER INSABBIARE LE INDAGINI SUGLI INTRECCI TRA
MAFIA, STATO E MASSONERIA. IL TRISTE EPILOGO ALL'ITALIANA DELLE INCHIESTE
SCIPPATE ALLA PROCURA DI SALERNO E I PROVVEDIMENTI CONTRO IL PROCURATORE
APICELLA E GLI ALTRI MAGISTRATI CHE INDAGAVANO SUI FILONI DI DE MAGISTRIS NE
SONO LA PIU' CHIARA DIMOSTRAZIONE. STATO E C.S.M. HANNO DATO L'ENNESIMA PROVA DI
STARE DALLA PARTE DELL'ILLEGALITA', INSIEME AL PRESIDENTE NAPOLITANO CHE AL DI
LA' DELLE SOLITE DICHIARAZIONI RETORICHE DI FINTA EQUIDISTANZA NON HANNO SAPUTO
FAR ALTRO CHE DIFENDERE I PERVERSI INTERESSI DELLA POLITICA E DI CHI VUOLE
METTERE LE MANI SULLA GIUSTIZIA.
Di seguito pubblichiamo sul tema un intervento di
Marco Travaglio tratto dal Blog Voglio Scendere: "Scontro finale tra politica e
magistratura".
"Buongiorno a tutti.
Non so se avete notato la miseria di questo
dibattito sulla questione morale.
Il ritorno del dibattito sulla questione morale: i
giornali pullulano di interviste dei vari Pomicini, De Michelis, Di Donato.
Vari parenti di Craxi... persino Capezzone che
dice che Veltroni dovrebbe chiedere scusa a Bettino Craxi.
La questione morale, come al solito, viene usata
per buttarsi addosso a vicenda le proprie vergogne anziché guardarle e
possibilmente cancellarle.
Tant'è che il massimo di risposta che sono
riusciti a partorire i vertici del PD, quando Berlusconi ha visto la questione
morale - ovviamente soltanto la loro e non la sua che è talmente gigantesca che
non riesce nemmeno più a vederla, data la statura fra l'altro - è stata: "ma tu
hai portato in Parlamento inquisiti e condannati".
Naturalmente hanno dimenticato i propri.
Il massimo che possono dire è "noi ne abbiamo di
meno", come se ci si potesse difendere o addirittura attaccare dicendo "noi
abbiamo meno inquisiti e meno condannati di te".
Bisognerebbe poter dire "noi non ne abbiamo".
Quando Grillo e tanti altri hanno proposto questa
legge di iniziativa popolare per cacciare i condannati dalle liste elettorali,
anche se le firme raccolte questa volta erano quelle giuste e nessuno ha potuto
metterle in discussione, nemmeno Carnevale, il Parlamento se l'è presa comoda,
tant'è che non siano ancora nemmeno arrivati a una discussione sul tema.
Lasciamo perdere queste menate di partiti che
ormai stanno chiaramente disfacendosi, sfarinandosi, dissolvendosi senza nemmeno
che se ne rendano conto, e vediamo di parlare dell'altro grande titolo che
campeggia sui giornali da quasi una settimana.
Cioè da mercoledì scorso, quando la procura di
Salerno è scesa a Catanzaro per sequestrare gli atti dell'indagine Why Not e
comunicare a un bel po' di magistrati calabresi e lucani che sono indagati per
il mega complotto ipotizzato contro Luigi De Magistris.
Il titolo che è andato in edicola e in onda a reti
unificate e a edicole unificate è "Guerra fra procure", "Guerra fra PM",
"Scontro fra procure, interviene Napolitano".
Questo è l'unico dato costante.
La prima riga del titolo serviva a giustificare la
seconda: se c'è effettivamente una guerra fra procure deve intervenire qualcuno
a spegnare l'incendio, e quindi meno male che c'è il Capo dello Stato.
La domanda è: ma davvero c'è una guerra fra
procure? Davvero c'è uno scontro fra PM? Davvero Salerno e Catanzaro stanno
sullo stesso piano e si attaccano vicendevolmente, ma abusivamente tanto da
giustificare l'intervento del pompiere del Quirinale e dei pompieri del
Consiglio Superiore della Magistratura?
Vediamo. I fatti sono questi.
Qualche mese fa, De Magistris viene trasferito
dalle funzioni che occupa e dalla sede che occupa, cioè da Pubblico Ministero e
da Catanzaro, dal Consiglio Superiore che stabilisce come lui non possa più fare
il Pubblico Ministero e non possa più fare il magistrato a Catanzaro.
Quindi viene trasferito alla giudicante a Napoli.
Nel frattempo arrivano in pellegrinaggio alla
procura di Salerno decine di suoi inquisiti o di suoi superiori o colleghi che
vogliono denunciarlo per enormi nefandezze da lui commesse durante i tre anni di
procura a Catanzaro.
Soprattutto, si concentrano sulle tre indagini
importanti che De Magistris aveva fatto e che, secondo questi denuncianti in
processione, sono tutte quante viziate da ogni sorta di nequizia.
L'indagine Poseidone, sui depuratori che si
dovevano fare in Calabria e che sono stati finanziati dall'Unione Europea con
800 milioni di euro e non se n'è mai visto uno, di depuratore.
L'indagine sulle toghe lucane, per i comitati
d'affari che collegano magistrati della Basilicata, sui quali è competente a
indagare Catanzaro e per questo se ne stava occupando De Magistris.
Eppoi l'indagine Why Not, quella che, oltre a vari
faccendieri, ex piduisti, ufficiali dei servizi segreti, della Guardia di
Finanza, politici, giornalisti collusi, qualche mafiosetto di passaggio, aveva
come principale imputato questo Antonio Saladino, capo della Compagnia delle
Opere che è il braccio finanziario-affaristico di Comunione e Liberazione.
E, al suo fianco, una lobby trasversale di uomini
politici che coinvolge personaggi che stanno intorno all'allora presidente del
Consiglio Prodi, che viene lui stesso indagato ma non perché sia accusato di
avere fatto qualcosa lui personalmente, ma perché c'era uno di questi del suo
giro coinvolto nei rapporti poco chiari con Saladino, che utilizzava un
cellulare in uso anche a Prodi.
Per vedere come veniva usato questo cellulare
viene indagato Prodi, proprio per poter chiedere al Parlamento l'autorizzazione
a utilizzare e indagare su quei tabulati.
Poi Mastella, l'ultimo degli indagati perché
appena viene indagato, allora ministro della Giustizia - siamo all'ottobre del
2007 - De Magistris si vede togliere anche questa indagine.
Bene, queste tre indagini, secondo tutti questi
processionari che vanno a Salerno, sarebbero viziati da gravi reati commessi da
De Magistris: fughe di notizie, abusi.
Perché vanno a Salerno a denunciare De Magistris?
Perché Salerno è competente a indagare sugli eventuali reati commessi da
magistrati di Catanzaro.
Per fortuna i magistrati di Catanzaro non possono
indagare su se stessi, indaga Salerno.
Se poi Salerno ha commesso irregolarità, indaga
Napoli. Su Napoli indaga Roma, su Roma indaga Perugia e così a catena.
Una volta c'erano le competenze incrociate tra le
procure: Perugia indagava su Roma e Roma su Perugia.
Brescia indagava su Milano e Milano su Brescia.
Genova su Torino e Torino su Genova.
Catanzaro indagava su Salerno e Salerno su
Catanzaro.
Ma se io indago su Beppe Grillo e Beppe Grillo
indaga su di me, alla fine può capitare che, se siamo due poco di buono, ci
mettiamo d'accordo: io non indago su di te, tu non indaghi su di me, una mano
lava l'altra e così continuiamo a fare le nostre porcherie, indisturbati.
Ecco perché, nel 1998, furono cancellate le
competenze incrociate e quindi si stabilì che se io indago su Grillo, lui non
può indagare su di me: su di me deve indagare una terza persona, in modo che
così non ci possiamo mettere d'accordo perché non abbiamo il do ut des.
Quindi Salerno è competente per indagare sui reati
dei magistrati di Catanzaro, e lì arrivano coloro che vogliono denunciare De
Magistris per quello che ha fatto a Catanzaro.
Ma anche De Magistris a Salerno fa delle denunce:
denuncia a sua volta i sui superiori e alcuni suoi imputati, avvocati di suoi
imputati, giornalisti al seguito dei suoi imputati o dei suoi superiori, che
secondo lui lo avrebbero screditato, calunniato, isolato, espropriato delle sue
inchieste.
Insomma, avrebbero creato i presupposti per levare
prima le inchieste e poi lui.
Quindi i magistrati di Salerno non possono fare
altro, perché ricevono queste denunce, di De Magistris e contro De Magistris,
essendo competenti devono approfondirle per vedere quali sono fondate e quali
no.
La legge glielo impone, è obbligatoria l'azione
penale.
Ricevi una denuncia, devi verificarla.
Quindi cominciano a lavorare, per mesi e mesi,
nessuno ne sa niente, di quello che succede a Salerno.
Lavorano in silenzio, nessuno li ha mai visti in
televisione, nessuno li ha mai sentiti parlare, nessuno sa nemmeno che faccia
abbiano i pubblici ministeri Gabriella Nuzi e Dionigi Verasani e il loro capo
che si chiama Luigi Apicella.
A un certo punto, questi tre magistrati di Salerno
vengono sentiti dal Consiglio Superiore: la prima volta nell'ottobre dell'anno
scorso, quattordici mesi fa, l'altra volta il 9 gennaio di quest'anno, undici
mesi fa.
Vennero sentiti perché, fermo restando che loro si
occupano delle questioni penali, se ci sono reati negli uffici giudiziari di
Catanzaro, il CSM si occupa dei profili disciplinari e di incompatibilità.
Anche se non c'è un reato da parte di un
magistrato, se si scopre che un magistrato ha violato le regole deontologiche
della sua professione deve essere punito.
Se invece è in condizioni di incompatibilità, cioè
non può stare in quel posto, non per colpa sua ma perché magari è parente di
qualche avvocato, amico di qualche avvocato, fidanzato di qualche avvocato,
fidanzato o parente o amico di qualche indagato... non è colpa sua ma non è bene
che stia lì, ma da un'altra parte.
Trasferimento per incompatibilità ambientale
oppure procedimento disciplinare nel caso in cui un magistrato, pur non
commettendo reati, abbia fatto delle scorrettezze di tipo professionale.
Quindi, il CSM sente i magistrati di Salerno per
capire che cosa sta emergendo.
Anche perché il CSM, in quel momento, deve
decidere sul trasferimento proposto dal procuratore generale della Cassazione in
seguito alle ispezioni ministeriali disposte prima da Castelli e poi,
soprattutto, da Mastella contro De Magistris, per incompatibilità ambientale con
Catanzaro e funzionale con il ruolo di PM.
Vogliono capire che cosa sta emergendo per poter
farsi un'idea di qual è il caso De Magistris e, nello stesso tempo, farsi
un'idea se ci sono altri, a Catanzaro, che è meglio mandare via oppure
sanzionare.
I pubblici ministeri di Salerno raccontano, per ore e ore, quello che sta
emergendo dalle loro indagini.
E quello che raccontano è clamoroso: dicono che le
denunce contro De Magistris si sono rivelate totalmente infondate.
Cioè non risulta che De Magistris abbia fatto
nessuna scorrettezza, anzi dicono: "le indagini di De Magistris sono corrette,
non emergono reati a carico di De Magistris" e quindi tutte le denunce che sono
state presentate contro di lui, erano decine e decine, saranno archiviate.
E infatti, pochi mesi dopo, arriva l'archiviazione
per tutte le indagini su De Magistris che viene liberato da ogni sospetto.
Le sue indagini erano doverose, tutto quello che
ha fatto l'ha fatto bene, in buona fede.
Anche l'iscrizione di Mastella sul registro degli
indagati era doverosa, si imponeva in base agli elementi che erano venuti fuori,
niente da eccepire.
Il CSM dovrebbe prendere atto del fatto che,
comunque, di è stabilito che De Magistris si è comportato correttamente.
Il CSM se ne infischia e lo trasferisce con dei
cavilli, che non sto qui a spiegare ma poi vi dico, se volete approfondire,
quali libri potete trovare che lo spiegano.
Invece, i magistrati di Salerno, sempre
nell'audizione al CSM del 9 gennaio di quest'anno, raccontano anche che cosa sta
emergendo sull'altro tipo di denuncia, quella fatta da De Magistris contro quel
comitato trasversale, quello che lui chiama la nuova P 2.
Non c'è più Licio Gelli, ci sono alcuni piduisti.
Ma non è un problema di ex iscritti alla P2, il
problema è un network di persone che dovrebbero controllarsi le une con le altre
e che invece stanno pappa e ciccia e si coprono a vicenda.
E quando arriva qualche magistrato che sta fuori
dal network, libero e indipendente come De Magistris, si coalizzano per andargli
addosso e fare in modo che se ne vada.
Quindi è necessario che ci siano magistrati,
giornalisti, politici, avvocati, faccendieri, imprenditori, qualche bel
mafiosetto... eccetera.
Tutti insieme contro di lui, questa è la denuncia
di De Magistris.
Queste denunce, secondo i magistrati di Salerno,
si sono rivelate fondate.
Tant'è che dicono e rimane scritto nel verbale che
firmano nell'audizione al CSM, che De Magistris è stato costretto a lavorare "in
un contesto giudiziario fortemente condizionato da interessi
extragiurisdizionali, talvolta illeciti, perché ci sono magistrati legati ad
avvocati, imputati" che poi ricevono dei favori, moltissimi favori.
Per esempio hanno ricevuto magistrati da Saladino,
che ha fatto assumere loro amici, parenti, nelle sue società e quindi ha un
credito di riconoscenza, e questi magistrati hanno un credito, e infatti si sono
dedicati tutti a interferire nel lavoro di De Magistris che su Saladino stava
indagando.
Viene fuori, quindi, un quadro gravissimo.
Fermo restando che la procura di Salerno deve
occuparsi dei reati di questi magistrati di Catanzaro, il CSM dovrebbe prendere
immediatamente la palla al balzo per punire disciplinarmente o trasferire da
Catanzaro tutti quelli che risultano incompatibili.
Chi ha ricevuto favori, a Catanzaro, da un
imprenditore calabrese come Saladino, indagato in questa inchiesta, come minimo
deve essere cacciato e mandato da un'altra parte.
Invece il CSM non fa nulla: cioè trasferisce De
Magistris, la vittima del presunto complotto, ma gli autori del presunto
complotto li lascia tutti al loro posto.
Tant'è che, l'altro giorno, i magistrati di
Salerno sono andati a perquisirli e a notificargli che sono indagati e li hanno
trovati tutti al loro posto, a Catanzaro.
Pensate, se il CSM avesse fatto il suo dovere di
mandarne via qualcuno, di sospenderne qualcuno e di punirne qualcuno, l'altro
giorno quando c'è stato il blitz, avrebbe potuto dire "ma noi avevamo già
provveduto, avevamo già risolto il problema, adesso vedete se hanno commesso
anche reati".
Paradossalmente, anche se il CSM ritiene che De
Magistris meritasse di andare via, anche gli altri dovevano andare via.
Se è vero che quando c'è una contesa si mandano
via tutti, se questa è la prassi che adotta il CSM, mandassero via anche quelli
che hanno ostacolato De Magistris.
Invece no, sono rimasti tutti al loro posto e così
l'effetto del blitz di Salerno a Catanzaro è stato dirompente, perché stavano
tutti lì, nell'esercizio delle loro funzioni.
Come se nulla fosse stato detto a gennaio dai
magistrati di Salerno, che avevano avvertito il CSM di come stavano andando le
indagini e quale direzione avrebbero preso.
Questo è l'antefatto.
Noi abbiamo una procura che, per legge, deve
indagare su quelle denunce e se le ritiene fondate deve perseguire i reati
commessi da questi magistrati di Catanzaro.
Quindi cosa fanno? A un certo punto, dato che si
stanno anche occupando dell'insabbiamento delle indagini di De Magistris perché
l'ipotesi d'accusa è che sia stato privato delle sue indagini perché venissero
date a colleghi più malleabili, i quali con i soliti giochi di prestigio,
stralci, archiviazioni, parcellizzazione del materiale alla fine hanno
insabbiato tutto.
Voi sapete che a De Magistris l'indagine Poseidone
sui depuratori l'ha tolta il suo capo, non appena ha indagato l'On. Pittelli di
Forza Italia.
Pittelli è anche l'avvocato del procuratore capo,
amico del procuratore capo dell'epoca, Lombardi, il quale ha una seconda moglie
che ha un figlio da un altro uomo.
Il figlio della seconda moglie di Lombardi è socio
in affari dell'On. Pittelli.
Possibile che il procuratore capo tolga a De
Magistris l'indagine appena indaga Pittelli che è socio del figlio della sua
convivente?
Questo, per esempio, è il primo caso scandaloso.
Secondo caso: non appena viene indagato Mastella,
il procuratore generale Dolcino Favi, facente funzioni perché lui era l'avvocato
generale dello Stato, toglie a De Magistris anche l'indagine Why Not, dove sono
indagati Prodi, Mastella, Saladino e gli altri.
Con quale argomento?
Dicendo che dato che Mastella gli ha mandato gli
ispettori e poi ha chiesto al CSM di trasferirlo, allora De Magistris non può
indagare su Mastella perché vuol dire che ce l'ha con lui, è in conflitto di
interessi.
In realtà è troppo comodo: è un po' come sostenere
che nella favola del lupo e dell'agnello ha ragione il lupo, che sta a monte e
accusa l'agnello di intorbidargli l'acqua a valle.
Lì non era Mastella vittima di De Magistris, era
De Magistris vittima di Mastella.
Non è che De Magistris ce l'aveva con Mastella,
era Mastella che ce l'aveva con De Magistris perché stava lavorando su di lui e
quindi ha chiesto di trasferirlo prima di essere indagato.
Poi De Magistris l'ha indagato e il procuratore
generale gli ha detto che non poteva indagare perché ce l'hai con Mastella!
Il ribaltamento totale della logica.
Tolta anche l'indagine Why Not, gli restava toghe
lucane sul malaffare politico-affaristico-giudiziario in Basilicata, dirompente
anche questa perché è un'indagine che coinvolge addirittura un ex big del CSM,
cioè l'On. Bucicco, sindaco di Matera, parlamentare di AN, un avvocato
importante.
Anche lui indagato.
Quell'indagine, toghe lucane, insieme al fatto che
coinvolge un sacco di magistrati della Basilicata, De Magistris riesce a
portarla a termine ma non proprio fino alla fine.
Quando lo trasferiscono da Catanzaro a Napoli,
ormai l'inchiesta è finita e allora fa gli avvisi di chiusura delle indagini,
cioè avvisa gli indagati che le indagini sono finite e hanno venti giorni di
tempo per chiedere un supplemento istruttorio.
Dopodiché, farà le richieste di rinvio a giudizio
e chiuderà il suo lavoro in quell'indagine.
Bene, gli impediscono anche di fare quei venti
giorni per poter scrivere le richieste di rinvio a giudizio.
Lo cacciano da Catanzaro, fisicamente, un attimo
prima che lui sia riuscito a scrivere le richieste di rinvio a giudizio.
Nessuna, quindi, delle tre indagini clamorose si è
conclusa con la firma di De Magistris.
Perché dico questo? Perché il CSM sapeva che i
magistrati stavano scoprendo che queste indagini gli erano state tolte per
brutti fini.
Sapeva che secondo la procura di Salerno
competente, aveva ragione De Magistris e torto i suoi avversari.
Sapeva soprattutto, il CSM, perché la procura di
Salerno lo informava, che da mesi la procura di Salerno stava chiedendo a quella
di Catanzaro la copia degli atti delle indagini Why Not sulla quale si stava,
appunto, indagando per verificarne l'eventuale insabbiamento.
Una volta l'hanno chiesta, due volte, tre,
quattro... sette volte la procura di Catanzaro rifiuta a quella di Salerno
l'invio delle copie di questa indagine.
Ecco perché l'altro giorno c'è stato il blitz:
perché quelli di Salerno, che ormai aspettavano da quasi un anno quegli atti e
se li vedevano negare illegalmente - non puoi rifiutarti di esibire un atto che
un magistrato competente ti chiede - sono andati a prenderseli.
Con la polizia giudiziaria sono andati lì, hanno
spazzolato tutto ciò che c'era nelle cassaforti, cassetti, uffici e anche nelle
abitazioni.
Nei computer privati dei magistrati.
Dice: "ma uno è stato denudato".
A parte che quelli di Salerno dicono che non è
vero, ma in ogni caso se uno è in pigiama e si cerca un pen drive e non lo si
trova, per evitare che se lo sia messo nelle mutande è giusto perquisirlo anche
corporalmente, è una cosa che succede a chiunque venga perquisito quando si
cerca non un transatlantico ma un temperino!
I magistrati sono soggetti alla legge come tutti
gli altri.
Quello era un magistrato indagato, quello che è
stato forse perquisito anche nel pigiama.
Se gli davano le carte, non andavano a prenderle.
Non gliele hanno date: sono andati a prendersele.
Illegalmente? No, con un provvedimento di
sequestro perfettamente motivato.
Sono 1700 pagine. Se qualcuno ha voglia di farsi
un'idea precisa su questo caso, gli suggerisco di perdere una giornata e di
leggersi almeno le parti sottolineate di questo decreto di perquisizione, che è
rintracciabile sul blog di Carlo Vulpio, giornalista valoroso del Corriere - che
infatti non viene più fatto scrivere su questa storia, carlovulpio.it, e sul
nostro www.voglioscendere.it.
Se la leggete scoprite un sacco di cose
scandalose, delle quali i giornali, salvo rare eccezioni, non parlano.
Perché parlano di guerra fra procure, che non
esiste.
Salerno legittimamente va a prendersi le carte e a
fare le perquisizioni, è competente.
Catanzaro fa una cosa che non potrebbe fare: il
procuratore generale di Catanzaro se ne va in TV a dire che l'atto di Salerno è
eversivo e in realtà compie lui un atto che se non è eversivo sicuramente è poco
regolare.
Perché incrimina lui i colleghi di Salerno che lo
hanno incriminato, come se fosse competente lui!
A parte che lui è un procuratore generale e non
può indagare, può farlo il procuratore capo.
Ma soprattutto lui è procuratore generale di
Catanzaro e i reati di Salerno li valuta Napoli, quindi se voleva denunciare dei
reati di Salerno doveva fare un esposto a Napoli.
Poi se sei parte in causa, addirittura indagato,
come puoi pensare di indagare sui tuoi indagatori!
C'è un conflitto di interessi clamoroso, e infatti
per legge chi è parte in causa, da magistrato, deve astenersi in un processo.
Non c'è una guerra fra due cattivi: c'è un atto
legittimo e doveroso della procura di Salerno al quale si risponde con atti
abusivi e abnormi da parte di quella di Catanzaro.
E' questa che viene definita la guerra fra
procure, perché bisogna fare pari e patta.
Allora come si fa a controbilanciare l'abominio di
quello che ha fatto Catanzaro? Bisogna addebitare qualcosa a Salerno.
E dato che Salerno non ha fanno nulla di male,
ecco che ci si inventa il fatto che li hanno fatti denudare, anche se non è vero
- c'è stata forse una perquisizione corporale di un indagato in pigiama, visto
che erano le 7 del mattino -, si inventa che sarebbe abnorme il decreto di
sequestro degli atti solo perché è di 170 pagine.
Perché, c'è una legge che stabilisce quante pagine
deve avere un decreto?
Se ne facevano due, di pagine, avrebbero detto
"son due paginette, non c'è niente, è tutto campato per aria".
Se lo motivi bene, con 1700 pagine, non va bene lo
stesso.
E poi dicono: "sono andati a sequestrare
l'originale di un fascicolo giudiziario in corso, bloccando l'attività di
indagine".
A parte che languivano per conto loro da mesi, da
quando le avevano tolte a De Magistris, ma è chiaro che il sequestro serviva a
fare le fotocopie, cioè ad avere quella copia che Catanzaro non aveva mai
mandato.
Non è che bloccavano per sempre le indagini.
Bene, per queste quisquilie il Capo dello Stato ha
addirittura chiesto gli atti dell'indagine a Salerno, prima di fare lo stesso
con Catanzaro.
Come se Salerno dovesse rendere conto al Capo
dello Stato di quello che fa.
Questo sì è un atto inaudito, mai visto, mai
sentito: il Capo dello Stato che chiede degli atti a una procura.
Come si deve sentire un magistrato di Salerno se
il Capo dello Stato gli chiede gli atti quando lui sta facendo semplicemente il
suo mestiere, il suo dovere previsto dalla legge?
Apoteosi finale: il CSM nel giro di 24 ore - non
so come abbiano fatto a leggersi 1700 pagine in 24 ore, io ci sto provando da
giorni e ancora non sono riuscito a finire - valuta il tutto con la rapidità
della luce e propone al plenum di trasferire sia il procuratore generale di
Catanzaro, quello che ha detto che i suoi colleghi erano eversori, sia quello di
Salerno che ha fatto semplicemente il suo dovere!
Pari e patta, guerra fra procure.
Ecco perché i giornali e i politici hanno detto
"guerra fra procure", perché dovevano coprire un atto incredibile come quello
commesso dal Capo dello Stato, mai visto, e uno altrettanto incredibile fatto
dal CSM.
Facciamo finta che De Magistris abbia torto, che
abbia sbagliato tutto, che sia un incapace come ci viene raccontato.
Allora, per quale motivo non si lascia che
concluda le sue indagini?
E non si lascia che Salerno, competente su quella
faccenda, concluda le sue?
Se è un incapace e viene sempre smentito dai
giudici, dai GIP, dai tribunali del riesame, lasciate che finisca le sue
indagini, che finisca davanti a un GIP o a un riesame che gliele bocci.
Così fa brutta figura De Magistris!
Perché, invece, gliele tolgono sempre prima in
modo da consentirgli di dire che gliele hanno impedite di concludere?
Allora vuol dire che hanno paura che non sia così
incapace. Hanno paura che abbia scoperto delle cose molto gravi, altrimenti se
uno deve andare a sbattere lascialo andare a sbattere, no?
Allo stesso modo, se ha torto, si lasci che
concluda la procura di Salerno. Se poi la procura di Salerno ha a sua volta
torto, ci sarà un GIP, un tribunale del riesame, un tribunale normale, una corte
d'appello, una Cassazione che darà torno a Salerno.
Perché impedire a Salerno di andare avanti con
questi atti violenti, trasferimento del capo, ispezioni ministeriali del solito
Alfano, avvertimenti strani del Capo dello Stato, CSM scatenato, politici e
giornali pure?
Viene persino il dubbio che loro l'abbiano capito
chi aveva ragione e chi aveva torto.
Però devono continuare a raccontarci che sono
tutti uguali, che c'è una guerra fra bande così hanno la scusa per mettere le
mani sulla giustizia.
Una volta si pensava alla Berlusconi che le mani
sulla giustizia le potesse mettere la politica contro il volere della
magistratura, adesso si sta cercando di coinvolgere una parte, la peggiore,
della magistratura, il peggior CSM che si sia mai visto, e un Capo dello Stato
che sicuramente non sta brillando per le sue funzioni di garanzia, proprio
perché collaborino tutti quanti alla normalizzazione di quei pochi magistrati e
quelle poche procure che ancora fanno il loro dovere senza guardare in faccia a
nessuno.
Per fortuna la verità è più forte di qualunque
pressione, per cui chiusa una porta esce dalla finestra, chiusa la finestra la
verità rompe il vetro.
Quindi, chi pensava di archiviare il caso De
Magistris e quello collegato della Forleo, adesso è di nuovo preoccupato perché
cacciati i due magistrati, la verità sta tornando fuori più prepotente che mai.
Per chi la vuole conoscere fino in fondo
suggerisco, per Natale, dei libri: Roba Nostra di Carlo Vulpio, pubblicato da Il
Saggiatore; Il caso De Magistris, di Antonio Massari pubblicato da Aliberti; Il
caso Forleo, sempre di Antonio Massari pubblicato sempre da Aliberti.
Poi c'è il nostro vecchio Toghe Rotte di Bruno
Tinti, che spiega i meccanismi, e c'è il nostro Mani Sporche dove c'è l'inizio
del caso De Magistris. Poi tutti gli sviluppi li trovate in un libro che sta per
uscire, Per chi suona la banana, pubblicato per Garzanti, che raccoglie gli
articoli che ho dedicato anche a questi casi sull'Unità.
Vi saluto e come al solito, dopo la lettura,
passate parola!"
MASSONI. QUEGLI UOMINI IN NERO NASCOSTI TRA
POLITICA, MAGISTRATURA ED AFFARI.
La massoneria? «Conta davvero molto più di quanto
si immagini». Parola di Cesare Geronzi, ultimo "banchiere di sistema", tranne il
superstite Giovanni Bazoli. E se allora si provasse a ribaltare la vulgata che
vuole la politica unica responsabile dello scandalo del Monte dei Paschi di
Siena e si guardasse un po' più nel capitalismo feudal-relazionale percorso da
solidi intrecci di esoterismo massonico, che può tingersi di rosso e anche di
bianco? Si chiede Alberto Statera su “La Repubblica”. Nessuno negherà che a
Siena la rossa la politica sceglie da sempre attraverso la Fondazione i manager
del Monte. Ma chi è il Leone e chi la Volpe, la politica o l'economia? Il
Centauro che combina insieme forza e astuzia a Siena ha un timbro platealmente
iniziatico persino nella toponomastica. Ma è in tutta l' Italia senza borghesia
e con pochi princìpi che si annodano in nome del potere e del denaro legami e
solidarietà trasversali. Tra l'alta burocrazia e la finanza, tra gli alti gradi
delle forze armate e l'università, tra i servizi segreti e le grandi imprese,
tra i gabinetti ministeriali, i tribunali amministrativi, naturalmente la
politica e persino le sacre stanze vaticane. Racconta Geronzi, campione per un
trentennio dei poteri trasversali nelle memorie consegnate a Massimo Mucchetti:
«Una volta andai a trovare nel suo nuovo ufficio in Vaticano un importante
prelato che era appena stato elevato alla porpora cardinalizia. Nell'avvicinarmi
alla sua scrivania rimasi di sale. Sul montante lungo era applicato un tondo che
recava in bassorilievo i simboli massonici». Curioso, peraltro, lo stupore
dell'ex banchiere "di sistema" visto che il suo sodale Gianni Letta è il trait
d'union tra chiesa, Opus Dei e massoneria, ruolo che per tre lustri ha svolto
con passione da Palazzo Chigi e che ha continuato a svolgere imponendo alcuni
catto-massoni nel governo di Mario Monti. Il quale ha dovuto smentire la sua
affiliazione: «Non sono massone e non so neanche bene cosa sia la massoneria».
Sarebbe un torto all'intelligenza credere che davvero il presidente del
Consiglio, ex presidente della Bocconi, ex commissario europeo e grande
consulente della finanza internazionale da decenni, frequentatore di tutti i
consessi del potere mondiale, a cominciare da Bilderberg, non sappia che cos'è
la massoneria. Ma il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia Gustavo Raffi si
era forse spinto un po' troppo oltre quando aveva dichiarato: «Mario Monti è un
gran galantuomo, potenzialmente ha tutte le carte in regola per essere un ottimo
fratello». Il Grande Oriente d' Italia, 22 mila fratelli e 762 logge, centinaia
di "bussanti" che per entrare devono attendere i passaggi di fratelli anziani
all' Oriente eterno è la maggiore "obbedienza" italiana, ma tante altre,
regolari e irregolari, pullulano quasi sempre in lotta tra loro, dilaniate da
lotte intestine, travolte dall'indebolimento del "fondamento iniziatico" e dalla
"profanizzazione". Raffi, avvocato ravennate con antichi rapporti professionali
col Monte dei Paschi di Siena, Gran Maestro da quattordici anni, è al centro di
una combattiva opposizione interna, che ha portato alla costituzione di una
sorta di corrente, come nei partiti politici, denominata Grande Oriente d'Italia
Democratico. Per accrescere il suo prestigio, vorrebbe parlare inglese perché la
Gran Loggia Unita d' Inghilterra, è la madre di tutte le massonerie mondiali. Ma
non può perché il Grande Oriente d'Italia non è più riconosciuto da Londra. Fu
espulso per volontà del duca di Kent dopo l'ultima scissione del 1993, dodici
anni dopo lo scandalo della P2 di Licio Gelli, quando il Gran Maestro Giuliano
Di Bernardo fondò la Gran Loggia Regolare d' Italia, invocando la revoca del
riconoscimento al GOI e ottenendolo per sé. Non contento, ha fondato anche
l'Accademia degli Illuminati, che si richiama agli Illuminati di Baviera e si
riunisce una volta l'anno a Roma. Trai suoi adepti, Di Bernardo colloca più o
meno esplicitamente, come ha confessato al giornalista Ferruccio Pinotti, anche
il presidente di Intesa San Paolo Giovanni Bazoli, oltre a Vincenzo De Bustis,
il banchiere considerato vicino a D'Alema che portò al Monte dei Paschi per un
prezzo considerato allora esorbitante la Banca del Salento. E poi ancora Carlo
Freccero, ex Fininvest e poi Rai, Rubens Esposito degli Affari legali Rai,
Sergio Bindi, ex consigliere Rai e antico portaborse del democristiano Flaminio
Piccoli, Severino Antinori, specialista della fecondazione assistita, il
filosofo Vittorio Mathieu, il generale Bartolomeo Lombardo, ex Sismi. Banche,
informazione, medicina, cultura, Servizi segreti, non manca niente. Ma la Rai
sembra un luogo privilegiato di coltura della massoneria se è vero, come
testimonia il professor Aldo Mola, che a un certo punto al Grande Oriente giunse
in dote una Loggia coperta, retta dal Venerabile Giorgio Ciarocca, di cui
facevano parte Cesare Merzagora, Eugenio Cefis, Giuseppe Arcaini dell'Italcasse,
nonché Guido Carli, Enrico Cuccia, Raffaele Ursini, Michele Sindona e Ettore
Bernabei, notoriamente soprannumerario dell'Opus Dei. Anche la Gran Loggia d'
Italia, obbedienza di Piazza del Gesù Palazzo Vitelleschi, al contrario di Di
Bernardo, non gode di buona reputazione a Londra perché il 30 per cento dei
fratelli sono sorelle, unica obbedienza tra le grandi famiglie massoniche
italiane che ammette la presenza femminile, trascurando la tradizione britannica
che concepisce invece la massoneria come un club esclusivamente maschile. «Certo
- spiega Alessandro Meluzzi, ex deputato di Forza Italia, massone, ma anche
diacono della comunità di Pierino Gelmini - la Loggia implica un' iniziazione
solare, mentre le donne rappresentano la metà lunare del cielo, le stelle d'
oriente e non di occidente». «L' idiota religione massonica è roba da
diciottesimo secolo», disse Benedetto Croce. E in certi casi come dargli torto?
Ma è possibile che grandi banchieri e uomini d' affari misurino le loro mosse
sui binari dell' ortodossia massonica? È escluso, ma non è affatto escluso che
utilizzino per i loro scopi più o meno commendevoli la miriade di confraternite
del potere che impiombano questo paese. Di certo «non è vero che tutti i massoni
sono delinquenti, ma non ho mai conosciuto un delinquente che non fosse anche un
massone», disse il massone Felice Cavallotti prima di essere ucciso in duello da
un suo fratello massone.
MASSONERIA: GLI
INSOLITI NOTI CHE SONO IN MEZZO A NOI.
E' ricomparso in
questi giorni su Repubblica.it il personaggio di una gag televisiva de "Il
caso Scafroglia", il
fortunato programma tv di Corrado Guzzanti. Era il lontano 2002 e Guzzanti
impersonava il "massone", un incappucciato nero con tanto di compassi e squadre,
che si esprimeva in uno sgrammaticato napoletano, che ammetteva cose indicibili,
quali quella di essere a un passo dal regime, ieri, in Italia, e negava cose
scontate, quali la tendenza del nuovo sistema informativo a ... disinformare,
appunto. Così scrive Francesco Specchio
su “Eco Costiera”. Oggi viene usato, il personaggio, per contribuire alla
battaglia civile contro la cosiddetta legge bavaglio
sulle intercettazioni, la legge figlia prediletta dei figli prediletti della
massoneria (deviata?) italiana. Una cosa però ce la dobbiamo pur chiedere: come
mai, visto che a parlarne possono essere solo i degnissimi eredi della
tradizione dei cantastorie medioevali (gli unici minimamente autorizzati a
criticare i potenti, seppure sotto la
forma dello sberleffo), a tenere costantemente il bavaglio sono tutti gli altri,
giornalisti compresi, intorno a fatti, progetti, persone, alleanze, soprattutto
vittorie della massoneria italiana? Eppure questi fratelli massoni sono proprio in mezzo a noi, se ne stanno tranquilli, tutte persone per
bene (loro), non danno mai nell'occhio, sono noti ma insolitamente poco vistosi,
per un'Italia rumorosa ed appariscente. Se poi decidono di
delegare qualcuno a rappresentarli pubblicamente, lo scelgono tra i più
irrefrenabili, tra i meno affidabili in fatto di riservatezza, e, dopo averlo
messo in sonno, si dice così tra di loro, lo
tengono lì come un burattino, prigioniero del silenzio, e della trama dei loro
interessi indescrivibili. Il prode
Mussolini fece approvare una legge
contro di loro, che però sarebbe servita contro gli anti-fascisti, e a
sbugiardarlo in aula, a Montecitorio, in una delle ultime sedute vere, fu
proprio Antonio Gramsci, indicando l'autentico obiettivo-bersaglio di quella
legge, e sostenendo che l'autentico partito della borghesia, appunto la
massoneria, avrebbe provveduto a cooptarli, lui ed i suoi accoliti fascisti, e
ad usarli a dovere. Così come in effetti avvenne. Ma furono bravi, i fratelli
massoni italiani, anche a nascondere i rinnovati legami instaurati dalle nuove
autorità italiane con le potentissime logge nordamericane, già con la
liberazione della Sicilia da parte delle prime truppe alleate, Non riuscì
altrettanto bene per i contatti, comprovati storicamente già dopo una decina di
anni, tra i servizi segreti alleati e la mafia siciliana: eppure in quel caso
l'attitudine alla segretezza sarebbe dovuta essere totale. No, la mafia non è
altrettanto brava dei fratelli cattivi,
da sempre, tanto è vero che oggi a squarciare il velo della ignobile trattativa
tra lo stato repubblicano e la mafia stessa, quella che fu anticipata,
accompagnata e chiusa dalle stragi del '92, hanno provveduto adepti
dell'organizzazione criminale siciliana, mentre quelli che l'avevano ordita, la
trama, e l'avevano chiuso, l'accordo politico, sulla pelle di Borsellino,
continuano a starsene zitti e, non tanto oggi, tranquilli, coperti non dai loro
grembiulini,
ma dai loro ermellini, dalle loro scrivanie
ultra-accessoriate (soprattutto di apparecchiature elettroniche), dai loro
intrecci inestricabili, e poi dai loro palazzi romani.
In altri Paesi la massoneria esaurisce l'intero sistema politico,
come succede in Argentina, dove spazia dalla destra fascista alla sinistra
guerrigliera (quella che furono i montoneros),
ma lo fa apertamente, persino quando organizza un colpo di stato militare, con i
suoi generali felloni e sanguinari.
Negli Stati Uniti è lo stesso sistema
istituzionale ad essere pervaso dai suoi miti, dal suo spirito, dalle sue stesse
leggi, eppure anche lì è quasi tutto pubblico, fino al punto di conoscere la
loggia a cui è iscritto l'ultimo, il più atipico, il nero, il progressista
Obama. E se no, come avrebbe potuto anche sognare la presidenza USA? Da noi no,
deve rimanere tutto segreto, o poco credibile, o fantasioso. Chi ne parla, nelle
riunioni politiche, quelle dei consessi democratici, ovviamente, si vede
attribuire giudizi che oscillano tra il folle visionario e il fissato un pò
romantico. Mai che si accetti di discutere dei fatti, e delle relative
responsabilità, si incomincia sempre a parlare di altro, un altro meno scomodo.
In Italia la massoneria sembra essere tutto un sogno, e così continua ad essere
l'incubo della democrazia. Su quanto sta emergendo, del patto scellerato
stato-massoneria, era già tutto scritto, in
ultimo nel ponderoso libro Il caso Genchi,
tutto: fatti, date, personaggi, eppure era Genchi, o chi prima di lui, ad essere
il pazzo. Sul fatto che la P2 non si fosse mai sciolta lo aveva
affermato e preventivato la lungimirante Tina Anselmi
(partigiana, madre della Repubblica e sua leale servitrice),
nel suo ruolo di coraggiosa Presidente della Commissione
parlamentare sulla P2. Ma allora c'era un
Presidente della Repubblica vero, un
altro partigiano avvezzo alle battaglie a viso aperto, anche contro i poteri
occulti, i più pericolosi. Da quanto oggi si viene a sapere della
cricca, una delle tante camere stagne della
rinnovata P2, si riscopre un personaggio singolare, un po' defilato, ma pur
sempre un sottosegretario del Governo nazionale, che, si badi bene, venne
ampiamente citato e sanzionato sia nella relazione di maggioranza (Anselmi),
che in quella di minoranza (Matteoli, si, proprio lui, allora
esponente di AN, antimassone, e oggi folgorato sulla via dei governi Berlusconi),
indicato dalla Commissione come il "messaggero" della P2. E che dire dei
rapporti ormai comprovati tra le compagnie religiose della Lombardia e le
massonerie-"ndranghete della lontana
Calabria: tutto già scritto, già analizzato da Cordova prima e da De Magistris
poi. Per entrambi e per loro inchieste uguale responso: pazzi loro e fantasie
irresponsabili agli atti. Volendo seguire le successive esperienze partenopee
del Procuratore Cordova, verremmo pure a scoprire che anche lì diventò
improvvisamente scomodo, anche per i salotti democratici e
progressisti della città, che pure in un primo
tempo lo avevano osannato, non appena incominciò a lavorare su alcune collusioni
in grembiulino.
Non era cambiato lui; erano
cambiati, o si erano scoperti i frequentatori dei salotti.
Insomma in Italia, non appena qualcuno
sparla, o anche solo parla di massoneria, cade in disgrazia.
Qualche volta
succede che, come da tutte le chiese, si conceda la dispensa. Ed è successo,
questo evento, per una giornalista televisiva, cui è spettato il compito,
professionale, sia chiaro, di lasciar trasparire, anzi far apparire l'immagine
della buona massoneria, o l'immagine buona della massoneria, questo onestamente
non lo sapremmo dire. Fatto sta che da una parte ci sono nobili parole, e nobili
dichiarazioni di principio, antenati illustri e fulgidi esempi di rettitudine ed
eroismo, passati, elenchi specchiati e specchiabili, oggi, dall'altra parte c'è
tutt'altro. Ora, è vero che la massoneria italiana se l'è dovuta vedere,
storicamente, non solo con sovrani e principi, reazionari e retrivi, ma anche
con papi e cardinali, scaltri e disincantati, nonchè sanguinari (essendo pur
vero, sempre storicamente, l'intreccio e il reciproco
inquinamento
tra le due chiese), ma quanto ancora e per quanto tempo dovrà pagare, questo
nostro Paese, per colpe sicuramente non attribuibili al suo popolo?
Forse è proprio venuto il tempo che questo
popolo conquisti il diritto a sapere. A sapere sulle sue sorti passate, e quindi
sul suo torbido presente.
Come tutti i
diritti, il diritto a sapere va però conquistato, sul campo della battaglia
politica democratica. Ho sempre considerato la
massoneria un mondo a me estraneo, spiega Roberto Galullo. Non per altro: in
democrazia mi sembrano paradossali e buffi i vincoli di segretezza e fratellanza
che talvolta degenerano in patti esclusivi per affari e prodigiose scalate al
potere. Potere tout court da girare e rigirare tra “fratelli” in ogni
settore, talvolta a scapito dei migliori. O degenerano in ben altro: ricordate
lo scandalo P2? Di massoni sono pieni le banche, i partiti (tutti), il
Parlamento, le assemblee elettive, i vertici ministeriali, la Rai, i media
televisivi, i giornali e poi ci sono giudici, prefetti, professori universitari,
avvocati, commercialisti, gli ordini professionali, le associazioni, le imprese,
la sanità, il mondo dello spettacolo e tutto quanto fa classe sociale: esclusiva
e spesso intoccabile. E la Chiesa? Beh, lasciamo perdere…Ora direte, cari amici
di blog, perché ce ne parli proprio ora. Chissenefrega dei massoni te lo ha mai
detto nessuno? E come no! Soprattutto i massoni che conosco ma che non sanno che
io so…E si, perché la segretezza (che poi viene violata se a saperlo sono già in
due e nelle logge due non sono mai) è sacra: perché poi? Se non c’è da
vergognarsi escano allo scoperto… Come ho fatto io, quando esattamente 16 anni
fa fui avvicinato da un conoscente, alto dirigente (ancora oggi) di
un’importantissima associazione che mi voleva far conoscere le meraviglie della
fratellanza. Io, che un fratello già ce l’ho, ed è un capitano dell’Esercito (a
proposito, le Forze dell’Ordine sono zeppe di massoni) ho risposto picche. “Ma
ti aiuta nella carriera” mi disse. E chissenefrega risposi. Punto e a capo
(per fortuna sono stato apprezzato lo stesso e di questo ringrazio il mio
attuale gruppo editoriale che, cambiando manager e direttori, non ha mai
cambiato atteggiamento nei miei confronti). I motivi per cui ne scrivo ora sono
tanti. Il mensile la “Voce delle Voci” della “Voce della Campania”,
ha appena finito di (ri)pubblicare un elenco sterminato di oltre 26mila massoni
iscritti alle logge ufficiali. Sarà forse per questo che il 3 dicembre il suo
sito è stato devastato dagli hacker? Comunque le liste pubblicate mi sembrano –
lo dico sinceramente – ampiamente incomplete e datate, forse datatissime: alcuni
risultano ancora iscritti come impiegati della Sip. Chi di voi si ricorda cos è
la Sip? Ve lo dico io: la vecchia compagnia telefonica di Stato, sì quella dei
telefoni con il dito da infilare nei buchi per girare la ghiera e comporre i
numeri. Ah, bei vecchi tempi andati. Bene, quella lista mi ha sorpreso non tanto
perché vi ho ritrovato persone che conosco (e che, sarà un puro caso, hanno
fatto carriera nelle loro professioni anche se secondo me avrebbero meritato di
essere cancellate dalla vita lavorativa) ma soprattutto per le persone che “non”
ho trovato, compreso quel mio conoscente che voleva farmi indossare un
grembiulino (ma vi pare! un grembiulino, come alla scuola materna, suvvia!). Non
saranno massoni allora, penserete voi. Beata ingenuità: mai sentito parlare di
logge coperte? E veniamo a noi (non nel senso fascista del termine). La
massoneria mai come adesso va di gran moda. Un successone “venerabile”. Per chi
volesse fare due conti vi elenco una serie di episodi su cui riflettere. Alla
fine le somme le tirerete voi. Partiamo da Sanremo, dove martedì 9
dicembre 2008 il Casinò ospiterà nei “martedì letterari” Licio
Gelli, il Venerabile, che presenterà un libro sulla P2 (è un suo diritto, lo
premetto, siamo in democrazia). “Dal 1983 – scrivo riportando
testualmente quel che compare nel sito del Casinò -
in oltre venti anni di vita i martedì letterari hanno
ospitato più di mille scrittori di caratura nazionale e internazionale. Si è
spaziato dai temi filosofici a quelli scientifici, da quelli religiosi agli
argomenti storici”. Ecco, ora conosciamo i
motivi dell’invito: la caratura nazionale e internazionale dello scrittore
Gelli, accolto in un’elite di mille, non a caso come quelli di Giuseppe
Garibaldi (Gran Maestro massone, ma altra epoca). Gelli – che scrive,
compare in tv e richiama ancora oggi folle come un tempo, chissà perché - parla
con tutti tranne che con i magistrati, come i pm della Dda di Palermo Roberto
Scarpinato, Fernando Asaro e Paolo Guido che il 4 novembre sono partiti di
Palermo e sono arrivati ad Arezzo (nella sua residenza Villa Wanda) per
interrogarlo sull’intreccio tra Cosa Nostra e massoneria. Il Venerabile si è
avvalso della facoltà di non rispondere. La gola e l’ugola, evidentemente, vanno
preservate per le occasioni pubbliche. Ebbene – a parte qualche pasdaran ligure
e alcune associazioni che lo aspetteranno al varco davanti al Casinò –
pochissimi hanno notato l’appuntamento e lo hanno criticato (nel bene e nel
male). Magari per chiedergli conto del perchè il Venerabile-scrittore non
risponde ai magistrati. O meglio: il Pd imperiese ha stigmatizzato l’episodio ma
il giorno in cui Gelli visiterà il Casinò per parlare alle folle, a Sanremo gli
amministratori locali del Pd invece che darsi appuntamento davanti al
Casinò saranno chiamati alle 21 presso il Centro Melograno (raccomandata la
puntualità, come si legge sul sito del Pd di Imperia) a dibattere su un ordine
del giorno che prevede la “problematica rifiuti” (manco fossero in Campania) e
la conferenza programmatica provinciale. Vitale! Prima però, alle 18, tutti
nella sede di Arma di Taggia per discutere del tesseramento. Impegnati!
Quando la situazione stava scappando di mano a molti, il Consiglio Provinciale
di Imperia nella seduta di martedì 25 novembre ha dato mandato al presidente
Gianni Giuliano di esprimere al Presidente del Casinò di Sanremo, di cui la
Provincia è azionista di minoranza, le perplessità del Consiglio sull'invito a
Licio Gelli per i "martedì letterari". Il dibattito si è aperto in seguito ad
una richiesta dei consiglieri Giovanni Trucco di Sinistra Democratica e Sergio
Scibilia del Partito Democratico, alla quale hanno aderito gli altri consiglieri
di minoranza. Gli altri: partiti, Chiesa e società civile, zitti e mosca.
Ma forse è per questo che – secondo la classifica sulla felicità pubblicata dal
mio giornale il 17 dicembre 2007 – gli imperiesi sono i più felici in Italia!
Toda gioia toda beleza!
Da Imperia a Catanzaro
c’è un bel viaggio (soprattutto da Salerno in avanti e non solo per
l’autostrada) ma noi atterriamo subito in Calabria. Bene bene bene. Avete
presente Luigi De Magistris, il magistrato a cui hanno avocato l’inchiesta sulla
cupola affaristico-politico-mafiosa-massonica? Bene, quando lo intervistai oltre
un anno fa a Catanzaro, mi disse una cosa che non scrissi per il quotidiano del
quale sono inviato, il Sole-24 Ore, perché era un’accusa vaga. Ora non più e
assume un altro sapore, che vi invito a gustare. “I massoni – mi confidò
– nella Procura di Catanzaro e non solo, sono sopra, sotto, a destra e a
sinistra”. Non fece nomi anche se lo invitai a farli – allora sì che sarebbe
diventato interessante scriverlo - ma nisba. Certo che quel “sopra” a mio
giudizio parla chiaro ma oltre non vado, lo lascio alla vostra immaginazione,
così come si va forse corroborando da quello che sta accadendo in queste ore
sull’“autostrada politico-mafioso-affaristico-massonico” Salerno-Catanzaro
(strano, nessun magistrato della Procura di Catanzaro è presente nelle logge
ufficiali i cui nomi sono stati pubblicati dalla “Voce delle Voci”). E ora
andiamo alle dichiarazioni di due personaggi agli antipodi: il giudice
Clementina Forleo e Angela Napoli.
«Avevo capito – si legge nel libro-intervista a Forleo “Un
giudice contro", appena editato da Aliberti e scritto da Antonio Massari
- che il nervo scoperto non erano tanto le inchieste Why Not e Poseidone,
quanto quella sulle Toghe Lucane, che apriva uno squarcio sui malanni del
terzo potere dello Stato, il potere giudiziario. De Magistris, a mio avviso, a
prescindere dai singoli indagati in Toghe Lucane, stava affondando le mani in un
contesto ben preciso: le infiltrazioni nella masso-mafia meridionale, ed era
incappato in magistrati che rivestivano ruoli direttivi (...)”. Chiaro? E
ora veniamo all’onorevole Angela Napoli, fuggita da An e membro della
Commissione parlamentare antimafia. In un’intervista rilasciata il 3 dicembre a
Traiano Bertolini dell’”Opinione”, giornale diretto da
Arturo Diaconale, si legge tra l’altro:
“Onorevole Napoli
quale idea si è fatta della gestione politica nella sua regione?
«Lo
scenario attuale e la materia delle inchieste in corso confermano la validità
degli allarmi che ho lanciato a più riprese in merito al connubio esistente in
Calabria tra mondo criminale, in particolare 'ndrangheta, mondo politico ed
imprenditoriale. Non dobbiamo sottovalutare nel contempo anche l'importanza
della massoneria deviata, che ha contribuito a confondere e ad insabbiare le
attività illegali esistenti nella regione, rendendo difficile l'attività
investigativa e il normale corso delle inchieste della magistratura.»
Perché fa
riferimento alla massoneria deviata?
«La
massoneria deviata è al vertice assoluto in Calabria. E' ormai comprovato che
uomini delle principali cosche della 'ndrangheta, ripuliti ed in possesso di un
titolo di studio, i cosiddetti colletti bianchi, si sono infiltrati nella
massoneria e le inchieste, come "Why not", seppur frammentate in diversi filoni
ed in diverse procure, stanno facendo emergere un sistema di collusioni e di
malaffare, che è alla base del mancato sviluppo della regione»”.
Ora è chiaro
l’incrocio tra massoneria (deviata, per carità, ed è sacrosanto riconoscerlo) e
quello che sta accadendo in tutta Italia, a partire dalla Calabria? No, e allora
proviamo a fare un altro ragionamento sui fratelli massoni calabresi. Sapete chi
c’è nell’elenco degli iscritti calabresi alla massoneria così come riportato
dalla “Voce delle Voci”? Vittorio Zupo. E chi è? direte voi. Calma: è un
commercialista cosentino, bocciato nel ’94 alle elezioni politiche per il Senato
dove si presentava nel centro-destra, che cura gli affari di una grande fetta
del mondo imprenditoriale calabrese. E che, insieme a F.I., altro
commercialista (quest’ultimo indagato proprio nell’inchiesta Why Not ma poi la
sua posizione è stata archiviata nel corso delle indagini preliminari a distanza
di circa due anni) e Vincenzo Gatto (fratello di Tonino Gatto,
presidente della Despar, da una vita sotto i riflettori dei magistrati
antimafia), l’11 agosto ‘99 figurava nel cda di
G.H.N. S.A., Soci.t. Anonyme. Siege social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard
Royal. R. C. Luxembourg B 54.579,
società anomima lussemburghese. Per carità, questo non vuol dire
nulla, non è un reato (anche se su molte cose la magistratura continua a
indagare). A me – semplicemente - tutto ciò che suona di segretezza,
fratellanza, anonimato, mi suona strano ed estraneo. Chissà perché poi, ci trovo
radici comuni che non sono e non saranno mai le mie.
Le inchieste "Why Not", "Poseidone" e "Toghe
Lucane", dovevano essere fermate ad ogni costo, scrive Francesco Viviano su “La
Repubblica”. I personaggi a vario titolo coinvolti, erano "eccellenti" e
"potenti". C'erano politici, massoni, magistrati, imprenditori in odor di mafia
e tanto altro. E su tutto questo ci fu anche il "silenzio" del presidente della
Repubblica Napolitano, "nonostante avessi pubblicamente auspicato un suo
intervento". Queste le accuse che il pm Luigi De Magistris, titolare di quelle
inchieste ha consegnato ai colleghi di Salerno in numerosi interrogatori. "Le
indagini "Why Not" - racconta De Magistris ai magistrati di Salerno - stavano
ricostruendo l'influenza dei poteri occulti. In particolare si stavano
ricostruendo i contatti intrattenuti da Giancarlo Elia Valori, Luigi Bisignani,
Franco Bonferroni ed altri e la loro influenza sul mondo bancario ed economico
finanziario. Elia Valori pareva risultate, dagli accertamenti preliminari che
stavamo svolgendo con la massima riservatezza, ai vertici della massoneria
"contemporanea". Elia Valori si è occupato spesso di lavori pubblici. Nel
recente passato, agli inizi del 2000 ha trovato anche una sponda rilevante a
sinistra, all'interno del governo D'Alema, in Marco Minniti. E si era anche
interessato di telefonia, - settore in cui, come poi dirò, si è interessato
anche il professor Francesco Delli Priscoli, figlio del pg della Cassazione
Mario (che aveva promosso l'azione disciplinare nei confronti di De Magistris
ndr). Non posso però non tenere conto dei seguenti elementi, pur se non si
volesse mettere in discussione onestà e serenità di giudizio delle persone
elencate: sul vice presidente del Csm, Nicola Mancino (che presiede la sezione
disciplinare che dovrà giudicarmi) che ha già fatto intendere in una intervista
che avrei violato il codice etico della magistratura, del consigliere togato,
Fabio Roja, del giudice Luerti attuale presidente dell'Anm che ha stretti
rapporti con la Compagnia delle Opere".
MAGISTRATI ED AVVOCATI MASSONI?
Magistrati e avvocati massoni? Dalle
intercettazioni pare proprio di sì. Quei magistrati che il Gip di Salerno
lascia al loro posto, scrive Franco Venerabile su “L’Indipendente Lucano”.
Non ci sarebbe nulla di male, sia beninteso. Lo stesso presidente Napolitano usa
esprimere familiari auguri e sentimenti cordiali al Gran Maestro di turno. Ma
sarebbe utile capire, avere qualche risposta a questioni che aleggiano da alcuni
anni. Almeno dal 2007, da quando, in una telefonata intercettata tra un
giornalista di cui il PM Annunziata Cazzetta ed il Gip Angelo Onorati erano
all'affannosa ricerca delle fonti, qualcuno disse che Vincenzo Autera
(magistrato della Corte d'Appello di Potenza) ed Emilio Nicola Buccico (avvocato
materano) erano in forza ad una loggia estera. La fonte, in quel caso, era un
appartenente alla Massoneria noto per questa sua legittima adesione, ma nessuno
ritenne di approfondire la questione e tutto rimase in un nastro ed in qualche
foglio di trascrizione. Sembra che solo a nominarla, la Massoneria crei
imbarazzo. Poi, molto poi, si accertò che tutte quelle intercettazioni, Cazzetta
ed Onorati le avevano disposte e tenute illecitamente e nel giugno 2012 un
giudice stabilì di trasferire il procedimento a Catanzaro. Anche lì, Vincenzo
Autera aveva un precedente: indagato per associazione mafiosa dal 2007 al 2009
(ma l'iscrizione originaria, a Firenze, era del 2005), procedimento archiviato.
In quei quattro anni, nessuno aveva comunicato l'iscrizione di una ipotesi di
reato così grave alla Procura presso la Corte di Cassazione. Il che è
gravissimo, pare! Anche Cazzetta era ben nota a Catanzaro, alcune decine di
procedimenti la vedevano indagata per reati anche gravissimi. Quasi tutti
definiti con archiviazione, alcuni pendenti. Ma tutti senza alcuna attività
d'indagine, almeno tutti quelli tenuti dal PM Paolo Petrolo: più che un
magistrato inquirente si potrebbe definire un magistrato paragnosta. Tranne che
per l'identità degli indagati (se magistrati), che suole iscrivere
nell'imminenza della formulazione della richiesta di archiviazione, per il resto
i fascicoli appaiono scevri di qualsivoglia attività ma motivati da potenti
precognizioni. Significativo il caso in cui si accertò la mancanza di oltre
cento faldoni che, secondo il Gip, non avrebbero potuto contenere alcun elemento
utile a modificare la decisione di archiviare. Quasi che quegli atti d'indagine
che nessuno aveva potuto visionare fossero carta straccia. Che a Catanzaro la
preveggenza non sia una virtù, lo si scopre attraverso una recentissima
inchiesta della Procura di Salerno. "La 'ndrangheta non esiste più, fa parte
della massoneria. Abbiamo amicizie: medici, avvocati, politici, giudici,
commissari", la frase è di un noto boss della 'ndrangheta ed è intercettata
dalle microspie dei Carabinieri del ROS di Salerno. Il collante è proprio
l'appartenenza alla massoneria. Massone è anche il magistrato /Gip) Giancarlo
Bianchi che di favori, secondo la Procura di Salerno, ne distribuisce più d'uno.
E qui ritroviamo il PM Paolo Petrolo, parte de "l'ingranaggio" a disposizione
della 'ndrangheta. Un sistema di contatti, che ruota attorno al giudice Bianchi
e a due sostituti procuratori della Dda di Catanzaro: Giampaolo Boninsegna e
Paolo Petrolo. Per questi tre magistrati, il PM di Salerno aveva chiesto
l'interdizione: negata! Se fossero stati semplici poliziotti sarebbero stati
arrestati ma non tutti nascono col cappuccio. Resta un'ultima domanda, questa al
Dr. Paolo Petrolo: scusi, lei è massone?
In ogni città vi è un
gruppo di malavitosi comuni, organizzati o meno, che si dedica alle più svariate
attività illegali. I componenti fanno capo a ben distinte famiglie-clan
criminali, a cui si aggiungono gli affiliati. Fanno notizia e sono perseguiti
solo coloro i quali commettono reati di mediatica utilità o contro la sicurezza
pubblica: omicidi, rapine, spaccio di droga e per il sol fatto di associarsi.
In ogni città vi è un
sistema di potere non meno criminale, organizzato o meno, fatto da stimati
insospettabili, che si dedica illegalmente ai destini istituzionali, politici ed
economici della comunità. Questa cupola è composta dalle famiglie più note,
blasonate e rispettate, che da sempre ricoprono i posti chiave della società. In
loco caste, lobby, mafie e massonerie decidono chi e come deve diventare
magistrato, avvocato quotato, parlamentare di rango, ecc.. Spesso sono i figli
dei notabili del posto a ricoprire gli incarichi dei padri. Per fare ciò serve
una rete di connivenze, di servilismo e di omertà. Per ricoprire certi ruoli non
serve la raccomandazione: basta il nome. I reati commessi da costoro sono spesso
attinenti l’amministrazione della cosa pubblica o l’economia. Essi intaccano le
libertà dei cittadini, per questo sono più gravi e più subdoli, ma sono taciuti
ed impuniti, essendo gli stessi autori ad occuparsene.
Molte volte tra clan
criminali e le cosiddette buone famiglie vi è commistione negli affari,
specialmente quando si tratta di spartirsi e gestire i miliardi di euro in opere
pubbliche che piovano dai finanziamenti dello Stato e della Comunità europea.
A livello centrale vi è
l'oligarchia degli alti burocrati. Secondo Galli della Loggia: Una invisibile
supercasta.
Non è vero che il
contrario della democrazia sia necessariamente la dittatura. C’è almeno un altro
regime: l’oligarchia. E tra i due regimi possono esserci poi varie forme
intermedie. Una di queste è quella esistente da qualche tempo in Italia. Dove ci
sono da un lato un Parlamento e un governo democratici, i quali formalmente
legiferano e dirigono, ma dall’altro un ceto di oligarchi i quali, dietro le
quinte delle istituzioni democratiche e sottratti di fatto a qualunque controllo
reale, compiono scelte decisive, governano più o meno a loro piacere settori
cruciali, gestiscono quote enormi di risorse e di potere: essendo tentati spesso
e volentieri di abusarne a fini personali. I frequenti casi scoperti negli
ultimi anni e nelle ultime settimane hanno aperto squarci inquietanti su tale
realtà.
Non si tratta solo
dell’alta burocrazia dei ministeri, cioè dei direttori generali. A questi si è
andata aggiungendo negli anni una pletora formata da consiglieri di Stato, alti
funzionari della presidenza del Consiglio, giudici delle varie magistrature
(comprese quelle contabili), dirigenti e membri delle sempre più numerose
Authority, e altri consimili, i quali, insieme ai suddetti direttori generali e
annidati perlopiù nei gabinetti dei ministri, costituiscono ormai una sorta di
vero e proprio governo ombra. Sempre pronti peraltro, come dimostra proprio il
caso del governo attuale, a cercare di fare il salto in quello vero.
È un’oligarchia che non
è passata attraverso nessuna selezione specifica né alcuna speciale scuola di
formazione (giacché noi non abbiamo un’istituzione analoga all’Ena francese).
Designati dalla politica con un grado altissimo di arbitrarietà, devono in
misura decisiva il proprio incarico a qualche forma di contiguità con il loro
designatore, alla disponibilità dimostrata verso le sue esigenze, e infine, o
soprattutto, alla condiscendenza, all’intrinsichezza — chiamatela come volete —
verso gli ambienti e/o gli interessi implicati nel settore che sono chiamati a
gestire. Ma una volta in carriera, l’oligarchia — come si è visto dalle
biografie rese note dai giornali — si svincola dalla diretta protezione
politica, si autonomizza e tende a costruire rapidamente un potere personale.
Grazie al quale ottiene prima di tutto la propria sostanziale inamovibilità.
Sempre gli stessi nomi
passano vorticosamente da un posto all’altro, da un gabinetto a un ente, da un
tribunale a un ministero, da un incarico extragiudiziale a quello successivo,
costruendo così reti di relazioni che possono diventare autentiche reti di
complicità, sommando spessissimo incarichi che incarnano casi clamorosi di
conflitto d’interessi. E che attraverso doppi e tripli stipendi e prebende varie
servono a realizzare redditi più che cospicui, a fruire di benefit e di
occasioni, ad avere case, privilegi, vacanze, stili di vita da piccoli nababbi.
Se i politici sono la
casta, insomma, l’oligarchia burocratico- funzionariale italiana è molto spesso
la super casta. La quale prospera obbedendo scrupolosamente alla prima (tranne
il caso eccezionale della Banca d’Italia non si ricorda un alto funzionario che
si sia mai opposto ai voleri di un ministro), ma facendo soprattutto gli affari
propri.
Chi ha cercato di
indagare sul sistema parallelo criminale in Italia, infiltrato in tutti i gangli
del potere Legislativo, Giudiziario ed Amministrativo, ha fatto una brutta fine:
Falcone e Borsellino uccisi; Cordova e De Magistris allontanati. Io, Antonio
Giangrande, cerco di riportare i fatti sottaciuti attinenti una realtà fatta da
tante mafie. Non ho paura, mi hanno già ucciso, condannato, affamato. Cerco di
parlarne ai posteri, perché i contemporanei mi hanno isolato.
LOTTA ALLA MAFIA:
IPOCRISIA E DISINFORMAZIONE, OSSIA LOTTA DI PARTE O DI FACCIATA.
Secondo Filippo Facci
su “Libero quotidiano” i soliti quattro scemi attendono la venuta di una nuova
normativa anti-corruzione come se il problema stesse tutto lì, in una legge: e
non in chi dovrebbe applicarla. Eppure uno come Piercamillo Davigo, che in
genere viene citato per bastonare la classe politica, ha già evidenziato dei
dati sorprendenti nel suo libro «La corruzione in Italia» scritto a quattro mani
con Grazia Mannozzi. L’ex pm di Mani pulite ha spiegato che negli ultimi decenni
la maggior parte delle condanne per corruzione sono intervenute a Milano,
Torino, Napoli e - molto distanziata - Roma, che pure ha una giurisdizione
vastissima; mentre in ben tre corti (Cagliari, Caltanissetta e Reggio Calabria)
il dato è inferiore alle dieci condanne. «Stando alla rappresentazione
giudiziaria», ha scritto, «la corruzione in alcune regioni d'Italia non esiste e
non è mai esistita, e ciò mentre si susseguono, al riguardo, denunce
circostanziate e precise».
Questo
evidenzia due cose, forse. Una è che indagare dove c'è la criminalità
organizzata è senz'altro più difficile. Ma la seconda è che la magistratura,
oltreché della soluzione, fa parte del problema, fa parte del Paese, talvolta fa
parte addirittura della corruzione.
La quale abbonda non tanto dove ci
sono le inchieste che la scoprono, come accade in Lombardia e dove pure indagano
con le vecchie e care leggi; abbonda dove la pace regna sovrana. Molte
competenze sono variate con l’istituzione del Consiglio Superiore della
Magistratura nel 1958, che ha sottratto al ministro di Grazia e Giustizia, tutti
i poteri in relazione al reclutamento, nomina, trasferimento, promozioni,
sanzioni disciplinari e dimissioni dei magistrati, tanto ordinari che onorari.
Per combattere non contro i mulini a vento come don Chisciotte, ma contro la
‘ndrangheta, i colletti bianchi, la borghesia mafiosa, la zona grigia,
l’imprenditoria collusa e corrotta, i servizi segreti deviati, la massoneria.
Agostino Cordova, procuratore capo della Repubblica di Palmi ci provò: firmò,
nel 1992, la prima grande inchiesta italiana sulla massoneria deviata.
Partendo dagli affari
del clan Pesce, attraverso la scoperta di relazioni pericolose tra mafiosi,
politici e imprenditori calabresi, Cordova finì nelle trame degli affari
miliardari di Gelli e di una miriade di personaggi legati a logge massoniche
coperte. Fu come aprire un vaso di Pandora, da cui continuavano a uscire nomi e
connessioni. Il 27 maggio del 1993 Cordova inviò un rapporto al Csm
sull’ingerenza dei massoni nel potere pubblico: consegnò i nomi di 40 giudici e
due liste di parlamentari. Fioccarono come la neve a Madonna di Campiglio le
interrogazioni parlamentari e le interpellanze, luogo comune, e venne…
“promosso” alla Procura di Napoli, quarta città d’Italia; scusate se è poco.
Promoveatur ut amoveatur (sia promosso affinchè sia rimosso). E dovette
mollare barca, vela ed ormeggi. Ma il Gran Maestro venerabile, Giuliano Di
Bernardo, lasciò il Grand’Oriente denunciandone le deviazioni. Il gip Augusta
Iannini, moglie di Bruno Vespa, archiviò tutta la sua indagine per l’assenza di
“elementi significativi e concludenti in merito ai reati ipotizzati”. Una pietra
tombale su nomi e vicende. Strumentale allontanamento dalla Procura di Palmi,
ben documentato in “Oltre la cupola. Massoneria, mafia, politica” di Francesco
Forgione e Paolo Mondani, con la prefazione di Stefano Rodotà e una postfazione
di Agostino Cordova, edito da Rizzoli (1994). Tutto bene in Campania, finchè non
mise il naso nella tangentopoli napoletana… Finchè non si mise contro il “re di
Napoli” Antonio Bassolino, sindaco di sinistra, protetto da giornali di
sinistra, politici di sinistra, giudici di sinistra“; finchè non fece quelle
famigerate dichiarazioni all’Antimafia sui colleghi della Procura e dell’ufficio
Gip …”Andai avanti, non me ne curai molto. Nel 2000, il Csm mi diede atto della
“mia notevolissima capacità professionale”. Che avevo condotto “la Procura di
Napoli a un’efficienza organizzativa mai raggiunta in passato” e che ero “un
magistrato inquirente insensibile a pressioni condizionamenti o attacchi di
qualsiasi tipo e genere”. Eppure un anno dopo, partì il trasferimento e fui
espulso”. Defenestrato. Silurato. Epurato, in nome della “incompatibilità
ambientale”, da quello stesso CSM, che prima lo aveva osannato con un elogio
cerchiobottista. Quello stesso CSM, che lo…”promuoverà” Consigliere di
Cassazione e lo trasferirà a Roma.
Un altro giudice (come
il padre, il nonno ed il bisnonno) Luigi de Magistris, fu accolto in Calabria a
Catanzaro, riverito, omaggiato, ringraziato ed idolatrato. Bravo, bravissimo,
illuminato, terzo, obiettivo, lungimirante, deciso, fermo e risoluto, campione
della legalità ed altra aggettivazione altisonante. Ma quando decise di
mettere il naso nelle logge massoniche, nelle cupole mafiose, nei comitati
d’affari, (Poseidone, Why Not, Toghe Lucane, SbP), un terremoto
giudiziario simile ad una tangentopoli, invischiati: premiers, generali,
ministri, segretari nazionali dei partiti, Governatori, avvocati, magistrati,
imprenditori, funzionari ecc. fece la fine di Cordova. Anzi peggio, perché fu
pure inquisito e rinviato a giudizio. Difeso a spada tratta dal Movimento “E
adesso ammazzateci tutti”, galvanizzato da Aldo Pecora. Fecero epoca e cronaca
gli scontri fra le Procure di Catanzaro e di Salerno con uno tsunami bis.
Trasferito anche lui a Napoli, per incompatibilità ambientale, su richiesta del
ministro della Giustizia, in illo tempore, Clemente Mastella; che combinazione!
Come pure il procuratore capo della Repubblica di Catanzaro, Mariano Lombardi,
trasferito a Messina e rinviato a giudizio, ma non prese mai servizio. Preferì
di mettersi in pensione. E poco dopo morì, ma per un male, ribelle ad ogni cura.
Aveva 76 anni. Era stato alla guida della procura calabrese per circa 40 anni.
Luigi De Magistris, fu eletto dapprima sindaco della città partenopea e poi
europarlamentare nientemeno, (secondo candidato più votato d’Italia, dopo Silvio
Berlusconi, con 415.646 preferenze); magari fra poco, anche deputato o senatore.
Luigi De Magistris, intanto, pure rinviato a giudizio, si è dimesso dalla
magistratura. Valle di lacrime anche per un altro giudice in gonnella, pure lui,
anzi lei, trasferita, alla procura di Cremona, come giudice ordinario, per
incompatibilità ambientale.
Donna di grande
coraggio, che assurse alla cronaca con la famosa inchiesta sulle scalate
bancarie dell’estate 2005. Unipol, che faceva capo a Consorte e Sacchetti;
personaggi vicini all’ex Pci-Pds-Ds, che tentò la scalata a Bnl. Assieme a
Fiorani, presidente della Bpi; appoggiato dell’allora governatore di Bankitalia
Fazio.Il segretario dei Ds,del tempo, Piero Fassino si lasciò sfuggire la
battuta galeotta, “Finalmente abbiamo una banca”, che scatenò l’inchiesta. Ma
poi, dopo le palate di fango e tre anni d’inferno, il CSM, si è dovuto
rimangiare tutto e restituirle l’onore e le funzioni di Gip a Milano. Giusta
decisione e sentenza del TAR e del Consiglio di Stato. Clementina Forleo, che
ospite della trasmissione tv ‘Annozero’ affermava: «Quando il re è nudo e si ha
il coraggio di denudarlo, dove per re intendo i poteri forti, il potere
politico, il potere economico e lo stesso potere giudiziario, il giudice è solo.
“Chi tocca i fili muore”» - alludendo al potere politico:
Latorre, D’Alema (che si fece scudo dell’immunità di europarlamentare),
Fassino?. Un brutto film… “La Prima Commissione del Consiglio Superiore della
Magistratura, delibera all’unanimità l’apertura della procedura per
incompatibilità ai sensi dell’art. 2 della Legge sulle Guarentigie nei confronti
della dott.ssa Maria Clementina Forleo, giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Milano. In relazione a situazioni di grave disagio determinatesi
nell’ambiente nel quale ella svolge le proprie funzioni giudiziarie e a
dichiarazioni pubbliche rese dal magistrato relativamente ad interferenze ed
intimidazioni istituzionali subìte, che non hanno trovato riscontro
nell’istruttoria svolta”. Il Vicepresidente della Commissione, prof. Letizia
Vacca, disse alla stampa … “Le sue dichiarazioni hanno creato preoccupazione
negli ambienti giudiziari e sono state lesive dell’immagine dei magistrati di
Milano, che si sono sentiti offesi. La situazione appare completamente diversa
da come è stata rappresentata da Forleo: non risulta nessun complotto e nessuna
intimidazione”. Tutti segnali chiari, al di là di questa o quella storia, che
dicono, che oltre un certo livello non si possa indagare. Chi lo fece, giudici
coraggiosi, come Falcone e Borsellino, pagò con la vita. Ma non si sfugge alla
Giustizia Divina. Là, non ci sono coperture, nepotismi, raccomandazioni, minacce
e pressioni o Logge di Stato che tengano. La società civile? C’è, ma non si
vede. Collusa o codarda, subisce e tace.
Gian Marco Chiocci e
Massimo Malpica su “Il Giornale” affermano che il verbale al Copasir
dell’ex braccio destro di De Magistris tira in ballo toghe e giornalisti per
fughe di notizie "letali". Le accuse di Genchi colpiscono anche Annozero e i
fratelli Ruotolo. L’audizione segretata al Copasir del super esperto
informatico Gioacchino Genchi, a processo per abuso d’ufficio insieme all’ex pm
Luigi De Magistris (la storia è quella dei tabulati telefonici di otto
parlamentari controllati senza autorizzazione del parlamento) è una bomba.
Rivela una vicenda di presunte, diaboliche, commistioni fra magistrati
antimafia, protagonisti dello scandalo Telecom e giornalisti autori di scoop che
Genchi definisce devastanti, letali, per le indagini sulla ’ndrangheta (strage
di Duisburg, omicidio Fortugno, eccetera). L’ex braccio destro del pm De
Magistris tira la croce addosso al numero due dell’Antimafia nazionale, Alberto
Cisterna, ai pm calabresi Mollace e Macrì, scomoda e coinvolge giornalisti
esperti come i fratelli Ruotolo, Guido (La Stampa) e Sandro (Annozero, poi
Servizio Pubblico), e Paolo Pollichieni, ex direttore di Calabria Ora. Li mette
tutti insieme nel frullatore e poi aziona l’interruttore. La miscela è
esplosiva, con accuse da brivido di cui Genchi ripete di prendersi la piena
responsabilità. A Genchi viene chiesto conto del perché vennero controllati
anche i tabulati del procuratore Piero Grasso. L’esperto informatico parte da
lontano, dall’inchiesta Poseidone, dalla teste Merante e dagli articoli che
Pollichieni manda in edicola, col risultato che i traffici telefonici del
cronista finiscono nel fascicolo. «Dal tabulato di Pollichieni viene fuori una
serie di rapporti continui, quasi osmotici, con Cisterna. Con il dottor Mollace,
con utenze della Dna, e tra Macrì e Mollace». Normale. «Ma vi è di più: lo
scambio di cellulari, almeno quattro o cinque della procura nazionale antimafia
con Pollichieni. Per scambio intendo che si sono scambiati le sim, i telefoni o
entrambe le cose. È un rapporto telefonico che vi invito ad analizzare perché
altamente preoccupante». Alcuni pm della Dda, prosegue Genchi, erano preoccupati
dalle fughe di notizie sul pentimento di Novella nel caso Fortugno. Dai tabulati
di Pollichieni, aggiunge Genchi, «emerse sostanzialmente questo rapporto
continuo (coi magistrati) nelle fasi dinamiche dell’acquisizione della notizia
del pentimento». E così anche per le fughe di notizie nelle indagini per la
strage di Duisburg «che ha determinato l’interruzione di tutte le
intercettazioni su persone di San Luca che si dovevano arrestare, che sono state
rese latitanti e che probabilmente sono state uccise per intempestività di
un’azione giudiziaria che è stata violentemente e bruscamente interrotta da
quella fuga di notizie, di cui il protagonista ancora una volta è Pollichieni».
La tecnica delle fughe di notizie, insiste Genchi, avveniva con la pubblicazione
di anticipazioni su altri giornali «di chi le aveva recepite perché alcune
giornalisti non hanno accettato il regalo, tipo l’immaginetta della santa che
pubblica il giorno prima Ruotolo su La Stampa in un asse perfetto che ha
collegato i due giornalisti di nome Ruotolo, e vi dirò moltissime cose
sull’argomento. (...). In particolare a Ruotolo, che ritengo sia uno dei
soggetti principali di questa vicenda, a tutto ciò che ha ruotato intorno
all’asse Ruotolo come persona fisica della Stampa e il fratello, e questo anche
il perfetto raccordo sincronico dell’articolo “Il Palazzo nelle mani del
giudice” con la puntata di “Annozero” che era stata programmata. A questa
trasmissione - continua il super consulente - io, il dottor Ingroia e altri
amici abbiamo implorato De Magistris di non andare, per non prestarsi a quella
che era una strumentalizzazione, anche dei giornalisti, per loro finalità,
probabilmente anche nobili (quelle di Ruotolo sicuramente non lo erano, perché
intendevano “realizzare”). Vi siete mai chiesti come mai il dottor Genchi non
sia andato ad Annozero, nonostante tutte le volte che è stato invitato (solo una
settimana dopo, il 5 febbraio 2009, Genchi sarà invece presente nella
trasmissione di Michele Santoro)» mentre «non ho paura di andare a Matrix perché
conosco l’onestà di Mentana, che so da che parte sta, non ho paura nemmeno dei
mafiosi, perché so da che parte stanno. Ho paura di quelli che non sanno da che
parte stare, mi spiego?». Genchi non si ferma. «Rutolo (Guido) c’entra perché è
in rapporto organico con Pollichieni come fornitore di informazioni». Poi si
lascia andare a incomprensibili considerazioni antropologiche: «Un medico mi ha
spiegato che i gemelli, pur avendo due corpi e una struttura cerebrale autonoma,
nel momento delle sinapsi mobili, ossia quando si realizza la massima
evoluzione, hanno bisogno di essere insieme come nel grembo materno». E quando
ti aspetti l’affondo finale per alcuni imprecisati «soggiorni in Calabria»,
Genchi torna sui suoi passi: «Secondo me i Ruotolo sono due persone per bene».
Del giudice Mollace, il consulente dice che «ha utilizzato decine di cellulari
(60-70, non conosco il numero preciso) ha poi denunciato il furto di uno di
questi e se ne è fatti assegnare non so quanti dal Comune di Reggio Calabria».
Guido Ruotolo, rintracciato dal Giornale, si dice incredulo. «È un delirio, sono
cose insensate. Non voglio commentare. Domani mi tocca leggervi, poi andrò
dall’avvocato e cercherò di capire come stanno effettivamente le cose».
Pollichieni è più loquace: «È vero, facendo il giornalista ho rapporti con i
magistrati e nessun rapporto con la ’ndrangheta. Le mie notizie non hanno
rovinato alcuna indagine posto che per l’omicidio Fortugno/pentimento Novella (e
lo scoop peraltro fu della Gazzetta del Sud, non mio) sono stati comminati 4
ergastoli, per Duisburg 6. Non sono mai stato imputato di nulla, mai ho ricevuto
un avviso di garanzia, mentre lui si ritrova sotto processo. L’ho già citato in
giudizio, ogni commento è assolutamente superfluo».
Ed ancora su “il
Giornale” i rapporti ravvicinati di un certo tipo tra giornalisti e magistrati.
Rapporti pericolosi che s’intersecano con fughe di notizie pilotate, scoop
«criminali» e scambi di atti giudiziari, coperti dal segreto e non. Dal verbale
bomba del superconsulente Gioacchino Genchi, segretato al Copasir, spuntano i
nomi di Ilda Boccassini, del procuratore antimafia Piero Grasso, del suo vice
Cisterna, dei pm calabresi Mollace e Macri, dell’ex capo degli ispettori Miller,
di tante altre toghe controllate via tabulati. Rivelazioni devastanti quelle
dell’esperto informatico Gioacchino Genchi che il 17 aprile 2012 sarà alla
sbarra a Roma insieme all’ex pm Luigi De Magistris per rispondere dell’accusa di
aver prelevato e utilizzato senza apposita autorizzazione i tabulati telefonici
di Prodi, Mastella, Pittelli, Minniti, Pisanu, Gentile, Gozi e pure di Rutelli
che quel 30 maggio 2009 guida l’audizione di Genchi in quanto presidente del
comitato di controllo sui servizi segreti. Relazioni pericolose tra PM e
giornalisti. L’anticipazione del sito Dagospia delle indiscrezioni raccolte dal
settimanale Tempi invitano a spulciare nelle 150 pagine di audizione custodite
in cassaforte. Nell’affrontare l’imbarazzante capitolo del perché si arrivò a
controllare il traffico telefonico dell’ex capo dei Servizi segreti militari,
Nicolò Pollari, Genchi si contrappone spesso ai presenti. Giura di non aver mai
saputo che quell’utenza corrispondesse al numero uno dell’intelligence
nonostante un preciso indizio uscisse, per tempo, dall’agenda elettronica del
generale della guardia di finanza, Walter Cretella, perquisito da De Magistris.
Gli domandano: «Quando lei ha visionato, come esperto della procura, la rubrica
del generale Cretella e ha letto “Gen. Pollari” non le è venuto il dubbio che si
trattasse del generale Pollari del Sismi?». Risposta lapidaria: «No». Seguita da
altra singolare puntualizzazione: «Ho saputo che il tabulato era il suo solo
quando l’hanno scritto i giornali». E nel mentre la discussione prosegue, da un
lato, sul perché ci si concentrò tanto sul numero uno di Forte Braschi che nulla
c’entrava con Why Not («non ho avuto niente contro Pollari e anzi, sulla base di
altre risultanze processuali, ho maturato un sentimento di profonda ammirazione
nei suoi confronti anche per le vicende di cui è oggetto») e dall’altro si
dibatte di una sua vecchia intervista a Repubblica dove affermava che tutto
sommato i tabulati di Pollari erano repliche dei tabulati già acquisiti dalla
procura di Milano (il pm Spataro all’epoca lo smentì), Genchi tira in ballo
cronisti amici che gli avrebbero passato carte sottobanco: «Mi sono procurato
tramite alcuni amici giornalisti di avere i provvedimenti di Milano dai quali
risultava il numero di Pollari nell’indagine Abu Omar. Volevo difendermi dagli
attacchi...». Lì per lì Genchi non fa i nomi. Ma quando passa a parlare di
oscure trame fra indagini di ’ndrangheta, fughe di notizie pilotate e scandalo
Telecom, cita Lionello Mancini del Sole 24 ore, amico di Gianni Barbacetto del
Fatto. Nell’anticipazione di Dagospia su Tempi si azzarda: «Chi fossero questi
“amici giornalisti” non c’è scritto nella relazione del Copasir. Lo si può
sospettare solo quando Genchi, nel vortice di un’audizione deragliata al caso
Telecom-Tavaroli, riferirà ai commissari di una - a suo dire - misteriosa
triangolazione telefonica riguardante un aspetto di quella storia». Nel verbale,
riprendendo retroscena collegati a Mancini, il consulente afferma: «Posso anche
dirvi chi è stato. Gianni Barbacetto (perché io ho molti amici giornalisti) che
ho conosciuto a Palermo molti anni fa, il quale mi disse di essere amico di Ilda
Boccassini, con cui sarebbero andati a casa sua». Barbacetto, contattato dal
Giornale, cade dalle nuvole: «Così come si legge dal verbale non è chiaro quel
che vuole dire Genchi. Io non ho mai preso documenti dalla Boccassini da girare
a Genchi al quale, al massimo, posso aver detto di aver conosciuto Lionello
Mancini (che a un certo punto si mise a scrivere contro Genchi «e Gioacchino era
molto preoccupato») a una festa a casa della Boccassini, dove andai con mia
moglie, ma anni e anni prima rispetto ai fatti di cui si parla e in un periodo
in cui Ilda era ancora socievole coi giornalisti. Ere geologiche precedenti a
questa». E Genchi? «L’ho conosciuto a Palermo, ma più recentemente per scrivere
delle note inchieste che seguiva con De Magistris. Ma di Pollari non avevo né
carte né numeri. Al massimo posso avergli girato qualche atto giudiziario
vecchio, pubblico, in possesso di qualsiasi cronista».
A tal proposito Stefano
Zurlo interviene sempre su “Il Giornale”. Qualcuno li considera pubblici
ministeri di complemento. Giornalisti che non devono bussare in procura, perché
vantano amicizie o liason con i magistrati titolari di delicatissimi fascicoli.
Ma la verità è più sfumata: procuratori e opinionisti spesso hanno rapporti alla
pari, s’influenzano a vicenda e alimentano un unico circuito
mediatico-giudiziario, com’è normale fra persone che si stimano e si
frequentano. Caso classico, da manuale, è il legame fra due big del giornalismo
e della magistratura: Marco Travaglio e Antonio Ingroia. Travaglio ha firmato la
prefazione del saggio di Ingroia «C’era una volta l’intercettazione » e l’ha
incensato spiegando che «il libro è uno strumento per capirci qualcosa nella
giungla delle leggi vergogna del regime berlusconiano», Ingroia si è presentato
al forum di lancio del quotidiano travagliesco il Fatto, oggi imperdibile per la
sinistra girotondina e giustizialista. Una cortesia, in sè un episodio quasi
banale, che però ha acceso le micce della diffidenza dalle parti del
centrodestra, abituato a duellare con Ingroia da sempre, come in un celebre
racconto di Conrad. Nessuno, invece, ha notato che fra le leggi di Berlusconi,
non importa se sacrosante o della vergogna, non c’è proprio quella sulle
intercettazioni, fermata dal fuoco di sbarramento dell’apparato di cui Ingroia e
Travaglio sono esponenti di punta. Se n’è andato il Cavaliere, il libro, pur se
con il titolo declinato all’imperfetto, è ancora in circolazione. Insomma, la
lobby intellettuale esercita un fascino e un potere di seduzione straordinari e
che non possono essere misurati a colpi di verbali pubblicati da questa o quella
gazzetta. E la premiata coppia Travaglio-Ingroia non è stata ammaccata nemmeno
dall’infortunio capitato a uno stretto collaboratore del pm, il maresciallo
della Dia Giuseppe Ciuro che andò anche in vacanza insieme ai due. Si è scoperto
che l’insospettabile sottufficiale, esempio classico di un certo mimetismo tutto
italiano, era la talpa alla Direzione distrettuale antimafia di personaggi poco
raccomandabili. Così mafia e antimafia hanno convissuto finché Ciuro è stato
condannato a 4 anni e 8 mesi. La solita claque dei benpensanti, a parte i
puntuti articoli di Repubblica, ha metabolizzato con disinvoltura il
guaio. Ma la stessa benevolenza non sempre è stata accordata a toghe e firme
della carta stampata, sfiorate da inchieste su P varie o da voci e sussurri
malevoli. In Italia non c’è un clima di tolleranza bipartisan e anzi i
giornalisti cosiddetti progressisti si perdonano tutto quel che viene condannato
se il peccato arriva dall’altra parte, magari da un cronista d’assalto della
fantomatica struttura Delta. Quella che, secondo i maestri della penna rossa,
fabbricherebbe complotti su scala industriale per screditare i nemici del
berlusconismo. Altra coppia chic, oggetto di infinite illazioni, è quella
formata dal pm Henry John Woodcock, quello di innumerevoli inchieste ad alta
densità di vip, e da Federica Sciarelli, la bella conduttrice del popolarissimo
programma di Rai3 Chi l’ha visto?. C’è una foto, famosa, che immortala i
due mentre fanno jogging per le vie di Roma. E un’altra che li riprende in
barca, nell’estate del 2009, insieme a Sandro Ruotolo, il baffuto braccio destro
di Michele Santoro e fratello del cronista giudiziario della Stampa,
Guido. «La mamma dei Ruotolo e la mia erano grandi amiche», ha raccontato
Woodcock per spiegare questo intreccio di rapporti. Nel 2009 un esposto anonimo
accreditava l’ipotesi che la Sciarelli fosse l’autrice di scoop cuciti
nell’ufficio di Wooodcock. Ma l’anonimo ha fatto cilecca, anzi si è rivelato un
falso. Nessun cortocircuito e invece lui firma la prefazione al libro di lei "Il
mostro innocente". Altro che fughe di notizie. Semmai un salotto che diventa
un’icona per la solita opinione pubblica.
Anche Paolo Bracalini
sull'argomento "Fughe di notizie impunite" interviene su “Il Giornale”. Ci sono
inchieste in cui «un cittadino viene, in modo repentino, processato e condannato
dai media, etichettato come un “mostro” e gettato in pasto all’opinione
pubblica. Tutto ciò ancor prima della conclusione della istruttoria condotta
dagli organi inquirenti e del processo, vero e proprio», che magari si conclude
«con l'assoluzione» e quindi con la beffa più tremenda. Una professione di
garantismo a firma di Henry John Woodcock, il pm dei vip, nella prefazione al
libro (Il mostro innocente) di una giornalista amica con cui è stato più volte
paparazzato, Federica Sciarelli, già Telekabul e conduttrice di Chi l'ha visto?
su Rai3. «Solo un'amicizia» quella tra Woody e la bella Federica (prediletta di
Cossiga e ammiratissima da Tinto Brass), spiegò Woody al cronista di Di Più,
settimanale di gossip, curioso delle faccende private di quel magistrato dal
cognome esotico, amante del sigaro, del jogging e delle Harley-Davidson. Ecco,
forse la Sciarelli è uno dei nomi della PW, la rete (solo amicizia e qualche
chiacchiera) di Woodcock, pubblico ministero dalla grande fantasia
investigativa, con già tre famosi brevetti all’attivo: il Savoiagate,
Vallettopoli e la P4. Ai giornali patinati raccontò che furono altri giornalisti
amici ad introdurlo alla Sciarelli, i fratelli Ruotolo. Il primo, Sandro, è lo
storico braccio destro di Santoro ad Annozero (che si è occupato spesso delle
inchieste di Potenza), l’altro, Guido, è cronista di giudiziaria alla Stampa
(che per il quotidiano Fiat segue proprio l’inchiesta sulla P4). Anche loro
esponenti della Pw, la rete (per carità, solo di amicizie e chiacchiere) di HJW?
«Io e Federica Sciarelli ci siamo conosciuti grazie ad amici comuni, tra i quali
i fratelli Sandro e Guido Ruotolo. La mamma dei Ruotolo e mia mamma erano grandi
amiche», raccontò Woodcock ai cronisti rosa, per spiegare l’origine della sua
amicizia con la conduttrice. Un colpo di fulmine, professionale ed
intellettuale, che sbocciò all’epoca dell’inchiesta su Vittorio Emanuele di
Savoia, schiaffato in carcere per sette giorni come presunto capo di una cupola
malavitosa, poi assolto «perché il fatto non sussiste». La Sciarelli si presentò
in redazione, a Chi l’ha visto, coi faldoni dell’inchiesta ed un entusiasmo a
fior di pelle: «Aho, ma quant’è fico Woodcock, non paga il biglietto della
metropolitana, lui scavarca!» fece davanti ai colleghi, dopo un incontro a Roma
col pm. Da lì Chi l’ha visto? si occupò più volte dell’inchiesta su Vittorio
Emanuele, che pure non era scomparso, ma ben sorvegliato agli arresti
domiciliari. Il 19 giugno 2006 le agenzie rilanciano l’intervista fatta dalla
Sciarelli a Chi l’ha visto al gip di Potenza Alberto Iannuzzi, che assicura:
«L’inchiesta su Savoia non è una bolla di sapone». Poi la Sciarelli ci torna la
puntata successiva, il 26 giugno, con un’intervista al presidente
dell’associazione antiusura sulle indagini relative al Casinò di Campione e sul
sindaco Salmoiraghi, accusato insieme al principe. Un’amicizia ispiratrice,
forse anche troppo secondo Felicia Genovese, pm di Potenza e arcinemica di
Woodcook, che produsse una relazione sulle possibili connessioni tra le
inchieste della Sciarelli su Rai3, le indagini di Woodcock e quelle di un pm
amico, Luigi De Magistris, un altro elemento della PW. La pm racconta tra
l’altro un episodio, «nel corridoio davanti alla stanza del dott. Woodcock,
quest'ultimo in compagnia del dott. De Magistris. Di fronte al mio sguardo
sorpreso, il collega Woodcock si è premurato di rivolgere agli addetti alla Sua
Segreteria la richiesta di alcuni atti per il dott. De Magistris, il quale è
rimasto in silenzio, limitandosi a rispondere al saluto». E poi che «nelle
trasmissioni condotte dalla Sciarelli nei mesi scorsi (...) si ritrova il
riferimento al dott. De Magistris come magistrato catanzarese che si occupa di
note vicende di cronaca verificatesi in Basilicata...». Una connection solo a
parole, chiarì Woodcock: «Mai nel corso della mia frequentazione con la
giornalista Sciarelli, ho rivelato notizie sulle mie indagini». Solo di
colleganza anche i rapporti con De Magistris. Chi ha seguito quelle inchieste
racconta però che «De Magistris si arrabbiava quando lo paragonavano a
Woodcock», e che in privato abbia manifestato più d’una perplessità sui talenti
investigativi del collega. Un trait d’union tra i due pm è Gioacchino Genchi
(che è anche vicino all’Idv di Di Pietro e De Magistris, ospite del congresso
nel 2010 a Roma, e ospiti spesso di Santoro e Ruotolo, amici di...), consulente
informatico di molte Procure, che inseriamo nella PW per un’intervista ad
Antimafiaduemila dove racconta di «una riunione operativa alla quale hanno
partecipato Woodcock, un ufficiale di polizia giudiziaria di Woodcock, il dottor
De Magistris» e infine un consulente finanziario. Una riunione «che atteneva ad
altri ambiti di collegamento investigativo con le indagini di Woodcock sulla
massoneria in particolare». Collaboratore di Woodcock in diverse inchieste è il
colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio, alias «Capitano Ultimo», capo del
Noe (quello che ha perquisito il Giornale per la vicenda Marcegaglia, altra
inchiesta Woodcock...). E chi l’ha anche visto De Caprio? La Sciarelli, che l’ha
intervistato nel suo programma il 6 novembre 2009. Nella comitiva di amici che
si telefonano, si chiedono e scambiano informazioni (solo innocue chiacchiere)
compare anche Riaccardo Iacona (collega di Santoro, Ruotolo, amici di...), che
sembra particolarmente ansioso di avere notizie in anteprima, anche riservate. E
De Magistris lo riferisce in una audizione per una presunta fuga di notizie: «Mi
chiede, Iacona, (...) è uscita la notizia e me lo potevi anche dire questo
fatto. Ma quella è una notizia riservata, io non posso dire nulla». Tutti membri
della PW, la P-Woodocock. Che è tutta un’invenzione, naturalmente. Non una
cricca vera come la P4.
Sono da poco passate le
19.15 del 24 settembre 2008 all’ITC Battisti di Fano: nonostante il turno
infrasettimanale del campionato di calcio, nonostante sia ora di cena e
nonostante il traffico impazzito di questa sana città di provincia, l’aula magna
dell’edificio scolastico è gremita in ogni ordine di posti. Il giornalista del
Corriere della Sera, Carlo Vulpio, ha raccolto con entusiasmo
l’invito dell’Associazione Res Publica Amici di Beppe Grillo e della
Libreria Omnia a presentare il suo primo libro, “Roba Nostra”. E’
arrivato in mattinata per curare personalmente gli ultimi dettagli e aspetta
insieme a noi l’arrivo dell’altro ospite illustre. Dopo pochi minuti, attorniata
da tre poliziotti di scorta, si presenta Clementina Forleo, sul viso un
sorriso appena accennato, affaticata da un lungo viaggio. E’ partita da
Brindisi, nel primo pomeriggio, con un’autovettura non blindata, le auto di
scorta erano già tutte prenotate, nonostante il suo livello di protezione sia
così alto da renderne necessario l’uso per gli spostamenti sul territorio
italiano. Si perché nonostante lei abbia rifiutato la scorta, lo Stato, quello
stesso Stato che attraverso il CSM ha deciso la sua incompatibilità ambientale,
togliendole di fatto le note inchieste sulla scalate bancarie per cui sono
indagati parlamentari del PD come D’Alema, Fassino e Latorre, quello Stato le ha
imposto una protezione, con le stesse modalità tipiche di una cosca mafiosa.
Clementina Forleo da tempo, infatti, vive giorno e notte protetta da tre guardie
di scorta, da quando cioè, svolgendo il proprio lavoro di brillante magistrato
quale è, si è ritrovata in mano le intercettazioni telefoniche tra il senatore
Latorre (PD) e l’ex numero uno di Unipol, Giovanni Consorte dalle quali risultò
chiaro ai più, tranne che al CSM, e a tutta una pletora di politici, che i due
erano non soltanto amici, ma soggetti operanti illecitamente nella scalata di
Unipol alla BNL.
Ettore Marini,
presidente di Res Publica introduce la serata, e chiede a Vulpio perché
quel libro, perché fosse stato necessario un libro e non fosse bastata
un’indagine giornalistica. «Certe faccende - replica Vulpio - non si possono
scrivere sui giornali, i giornali li leggono molti italiani, e queste sono cose
da tenere segrete». «Nei libri – prosegue – si può dire, ad esempio, che il
presidente del Senato frequentava Nino Mandalà, mafioso e capomandamento di
Villabate ("Tutti gli uomini di Cosa Nostra", di Lirio Abbate e Peter
Gomez), ma nei quotidiani tutto ciò è impensabile». Vulpio è un giornalista
fortunato perché a suo dire può pubblicare il 60-70% di quello che scrive,
sempre dopo aver contrattato con il direttore Mieli ogni singola parola, di ogni
singolo articolo.
La Forleo, pur non
facendo mai menzione della sua vicenda personale, concorda con Vulpio quando,
analizzando la situazione dell’informazione in Italia, la definisce in stato
comatoso e completamente asservita ai poteri forti: politici, finanziari e
giudiziari. Il magistrato, raccogliendo l’invito dell’ex Presidente Ciampi,
seppur rivolto agli organi di informazione piuttosto che ai magistrati, ha
sempre tenuto “la schiena dritta”, evitando accuratamente di iscriversi alle
numerose correnti interne all’ANM (Associazione Nazionale Magistrati). Correnti
che, come un sistema di vasi comunicanti, determinano gli equilibri del potere
all’interno sia della magistratura che della politica. Una magistratura
completamente da rifondare, secondo Vulpio, che è diventata organica alla
politica e operante attivamente, con molti dei suoi più famosi esponenti, anche
nella gestione del malaffare.
“Roba Nostra”,
infatti, è un “j’accuse” nei confronti del malaffare che si è fatto
sistema. Non più la volgare e semplice mazzetta, data dall’imprenditore al
politico, ai partiti. La nuova frontiera del malaffare ha un’etichetta di
garanzia, CE, come quella stampata su tutti i prodotti che oggi circolano
nella Comunità Europea. CE stavolta non è però sinonimo di sicurezza e di
tutela di un prodotto manufatto e distribuito in Europa, ma il marchio infamante
di una truffa ai danni dei cittadini italiani, per miliardi di Euro. Decine
di miliardi di euro, scientificamente dirottati da Bruxelles nelle tasche di
politici e imprenditori, con l’ausilio di prefetti, magistrati, poliziotti,
carabinieri ed avvocati di tre regioni italiane, la Basilicata, la Campania e la
Calabria. «“Roba Nostra” è un libro di nomi e di cognomi e luoghi
geografici precisi - prosegue Vulpio - Non è assolutamente un trattato di
sociologia, ma un’inchiesta di stampo anglosassone, come non se ne vedono più da
decenni in Italia». Vulpio accenna alle tre inchieste sulle quali indagava De
Magistris, “Why not?”, “Toghe Lucane” e “Poseidone”: «Le prime due – dice – sono
state scippate dalle mani dello zelante magistrato; per la terza, visto che non
potevano togliergli l’inchiesta, hanno tolto lui dall’inchiesta, chiedendone il
trasferimento». Il giornalista quindi si sofferma sulla vicenda dei fidanzatini
suicidi di Policoro, una storia parallela saltata fuori all’improvviso durante
le indagini sui finanziamenti della Comunità Europea per costruire dei
megavillaggi turistici sulla costa jonica lucana.
E’ il tragico il
destino di due giovani fidanzati di 21 anni, colpevoli di sapere troppo. Nel
marzo del 1988 vengono ritrovati cadaveri nella vasca da bagno: si parla di
morte incidentale, dovuta al cattivo funzionamento di uno scaldabagno. Fatto
strano, non viene mai eseguita l’autopsia. Otto anni dopo però i due cadaveri
vengono riesumati per via di alcune rivelazioni fatte da una supertestimone e si
scopre che i due sono stati brutalmente ammazzati. Si scopre poi una lettera di
Marirosa in cui lei confessa a Luca di aver partecipato a festini a luci rosse e
cocaina, in cui erano presenti noti professionisti tra cui, guarda caso, il pm
di Matera Autera, titolare delle indagini dei fidanzatini e denunciato dei
genitori delle vittime per non aver autorizzato l’autopsia sui loro cadaveri. Si
scoprirà che anche l’avvocato, nonché senatore di AN Emilio Buccico - prima
difensore dei genitori dei fidanzatini, poi guarda caso del Pm Autera – ed il
segretario provinciale di AN Labriola, partecipavano a questi festini a base di
sesso e coca. (Carlo Vulpio, Corriere della Sera 17 marzo 2007, p.25).
Nel corso della ricostruzione di questo tragico evento la sala dapprima
ammutolisce e poi tra i presenti si levano grida di protesta e di rabbia. Vulpio
ricorda agli intervenuti che per questa vicenda è stata richiesta
l’archiviazione, mentre Buccico nel 2006 faceva ancora parte della Commissione
Parlamentare antimafia.
Vulpio quindi ritorna
sulle modalità con cui le tre inchieste furono tolte dalle mani di De Magistris,
e non ricorda nella storia d’Italia un atto analogo, nemmeno durante il
fascismo. Mastella chiede il trasferimento di De Magistris, ma non quello dei
magistrati inquisiti, e tutta la stampa tace su questo aspetto tutt’altro che
secondario. Si riscontra cioè l’incompatibilità di un magistrato che onestamente
fa il suo mestiere, ma non viene intrapresa nessuna azione disciplinare per quei
funzionari dello Stato indagati dallo stesso De Magistris.
La Forleo a questo
punto accenna l’unico riferimento alla sua vicenda e ricorda il giorno in cui
comparve davanti al CSM e le parole della vicepresidente Letizia Vacca, che la
definì un “cattivo magistrato”, dalla personalità psicolabile e fortemente
emotiva. E’ inutile dire che i presenti in sala come me hanno apprezzato la
forza morale e la estrema lucidità con cui la donna Forleo, il magistrato Forleo
ha portato la sua testimonianza non parendoci affatto né emotiva né tantomeno
psicolabile.
Pubblico il testo
dell'intervista video di Claudio Messora a Clementina Forleo e Carlo Vulpio,
pubblicata su You tube il 24 marzo 2009, sul tema dell'informazione. Testo
dell'intervista.
Carlo Vulpio: "Le
parole sono importanti, e con le parole ci imbrogliano. Un esempio è questo
continuo utilizzo della parola legalità, trasformata immediatamente in
giustizialismo. Cioè chiunque di noi, chiunque di voi chieda l'applicazione
della legge per quel famoso Articolo 3 della Costituzione, perchè ritiene che la
legalità è il potere dei senza poteri, per ciò stesso evocherebbe un intervento
giustizialistico, un dispiegamento di forze giustizialiste che godono al
tintinnar di manette. Ecco il primo imbroglio. Noi che stiamo qui a parlare
adesso, siamo dei sovversivi. Se venisse qualcuno di questi tempi in Italia ad
osservare un incontro di questo tipo e avesse sentito l'intervento della
dottoressa Forleo, dedurrebbe che qui si sta lavorando alla costruzione di un
covo di sovversivi, perchè si sta addirittura ponendo il problema della vigenza
dell'articolo 3 della Costituzione. Niente di meno! Io l'altro giorno ho letto
sul mio quasi ex giornale (Il Corriere della Sera) una filippica contro
l'articolo 3 della Costituzione, e piano piano mi andavo convincendo che
effettivamente anche io fossi dalla parte dei sovversivi, laddove arrivato al
commento dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, cioè quello che
materialmente dovrebbe rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad
un'uguaglianza effettiva, diceva il commentatore di cui non farò il nome per non
fargli pubblicità, che era troppo generico quest'articolo 3 della Costituzione,
era troppo ampio, era troppo! E' fondamentale questo passaggio. Si comincia
così. Si comincia a gettare il sasso nello stagno. Si comincia con il grande
giornale, il grande commentatore magari un tanto al chilo, che propone un
articolo di questo tipo, si dice tecnicamente 'detta l'agenda', detta l'agenda
politica, del dibattito pubblico, e una volta dettata l'agenda le pecore, il
pubblico, l'opinione pubblica che non esiste, è un'invenzione, l'opinione
pubblica non c'è, segue. E' proprio internet, è proprio la rete che in qualche
maniera ci ha salvati. Ha salvato quelli come noi: giornalisti, magistrati,
lavoratori comuni che non avrebbero più potuto far sentire la loro voce,
sarebbero entrati definitivamente in un cono d'ombra, se non ci fossero stati i
blogger, i blog, il cosiddetto popolo della rete. E grazie alla rete si è
formata un'opinione pubblica nuova, con caratteristiche totalmente inedite, che
ovviamente hanno allarmato i tradizionali poteri, anche quelli che editano i
giornali. Se una nuova opinione pubblica si forma sulla rete, e se la rete ci
salva, allora la rete diventa pericolosa. Se la rete non ci fosse stata noi non
avremmo potuto parlare adesso, così, a centinaia, migliaia, milioni di persone,
e probabilmente le nostre storie sarebbero state storie eccellenti, ma sarebbero
deperite in questa loro eccellente solitudine."
Clementina Forleo: "Io
credo che se siamo qui, se siamo qui questa sera a parlare di queste cose, che
poi sono i temi fondamentali del libro Roba Nostra, è perchè ci sentiamo un poco
intrappolati, perchè purtroppo la trappola, senza accorgercene, è scattata sulle
regole, sulla democrazia, sulla legalità, sulla giustizia, sull'etica... cioè è
scattata su quelli che dovrebbero essere i termometri di una democrazia moderna.
E allora dobbiamo cercare di evitare di fare la fine appunto di quel famoso
topolino di un altrettanto famosa metafora, il quale appunto preso in una
trappola, ai suoi amici intenti a liberarlo diceva che non si lamentava poi
della trappola, ma si lamentava della cattiva qualità del formaggio. E allora
leggendo i giornali, soprattutto negli ultimi tempi, io ho paura appunto di
questo, del fatto che ci stiamo convincendo che tutto sommato stiamo meno male
di quanto si può stare. La rete ci salva e ci salverà. Io fino a poco tempo fa
avevo una speranza. Avevo la speranza che alcune testate conservassero dei
margini di libertà. Purtroppo mi sono resa conto che anche in questo campo sono
stata un po' ingenua, e che ultimamente le testate più libere si sono un po'
asservite, probabilmente perchè i tempi sono difficili e bisogna assecondare i
poteri forti, dove per poteri forti in questo caso intendo i potentati economici
e politici che sorreggono le grosse testate. Quindi i blog, internet e la rete,
nell'immediato quanto meno (mi auguro che nel medio e lungo termine le cose
possano cambiare) sono destinati a sostituire la classica informazione, che è
un'informazione deviata, un'informazione deviante, un'informazione che non ci
passa le cosiddette notizie."
Carlo Vulpio: "In
Italia siamo, per libertà di informazione, agli ultimi posti in tutte le
classifiche europee e mondiali. Questo non è un fatto grave in sè, è un fatto
grave perchè attraverso l'informazione che è uno snodo strategico, passano mille
altre cose, alcune delle quali fondamentali per il destino di un paese. Pensate
a come è stata trattata la giustizia."
Clementina Forleo: "Sul
caso Salerno - Catanzaro, per esempio, è stata forse volutamente fatta passare
l'opinione, attraverso un'informazione non sempre fedelissima, l'idea di questo
scontro, di questa guerra tra Salerno e Catanzaro. A mio avviso non si è
trattato di uno scontro, perchè uno scontro presuppone due corpi in movimento.
In questo caso Salerno aveva legittimamente, come è stato appurato dal Tribunale
del Riesame, disposto una perquisizione e un sequestro di atti nei confronti
appunto di Catanzaro. Catanzaro non poteva replicare con un contro-sequestro per
il semplice motivo che i reati ipotizzati da Catanzaro dovevano essere
denunciati all'autorità competente, cioè appunto un'altra autorità, perchè
evidentemente i magistrati di Catanzaro non potevano autodifendersi. Quindi non
tanto la politica ma la stessa magistratura ha voluto consegnare al potere dei
magistrati che stavano facendo onestamente il proprio lavoro e avevano toccato,
come aveva toccato poi in fondo Luigi de Magistris, dei nervi scoperti che
toccavano anche lo stesso potere giudiziario in Calabria, e che avevano aperto
uno squarcio sul terzo potere dello Stato, e che poteva poi far saltare dei
nervi anche in altri territori dello Stato."
Carlo Vulpio: "Pensate
a come è stata trattata l'economia, pensate a come è stato trattato il lavoro
dall'informazione. Un'informazione addomesticata, un'informazione orientata non
serve. Per entrare davvero in Europa noi abbiamo bisogno di una informazione a
livelli europei. L'Italia ai livelli europei, da questo punto di vista, non è
ancora arrivata. Tutto quello che accade nella sfera pubblica è affare nostro.
Se noi non ce ne occupiamo, qualcun altro farà in modo di occuparsene al posto
nostro."
Ecco il testo
integrale della lettera contenuta sul Blog di Carlo Vulpio con cui il giudice
Guido Salvini denuncia le riunioni segrete nel Palazzo di giustizia di Milano
per far fuori il gip Clementina Forleo. Il Csm ha aperto un procedimento
disciplinare sui presunti “congiurati”, Salvini è stato convocato per essere
sentito, nessuna procura d’Italia ha aperto alcun procedimento per eventuali
reati commessi e tutti i giornali e le tv, sebbene sappiano tutto, non danno la
notizia.
“Caro Cosimo e cari
colleghi,
anch’io sono contento,
anche sul piano umano, per la sentenza del Consiglio di Stato (quella che
conferma la pronuncia del Tar del Lazio e annulla la decisione del
Consiglio superiore della magistratura di trasferire da Milano a
Cremona, per “incompatibilità ambientale”, il gip Clementina Forleo,
che quindi ora può tornare a Milano – ). Non conosco a fondo il caso UNIPOL
e dintorni ma avevo letto la sentenza redatta dal consigliere Fabio Roia
e l’avevo trovata povera sul piano giuridico e riferita a fatti del tutto
inconferenti per un giudizio di “incompatibilità ambientale” che per un giudice
è quasi la morte civile. Una sentenza di quattro paginette, concepita con la
supponenza con cui di frequente il CSM motiva decisioni importanti
ritenendo di aver comunque sempre ragione. Aggiungo che sono stato testimone
diretto dello sviluppo dell’azione “ambientale” contro la collega (cioè, la
Forleo) dato che all’epoca ero anch’io GIP presso il Tribunale di Milano. Ho
assistito a scene desolanti quali l’indizione con passa parola di
riunioni pomeridiane in alcune stanze per discutere la “strategia” contro
la collega, guidate dai maggiorenti dell’ufficio tra cui un paio di
colleghi “Verdi” più rancorosi di tutti, come spesso accade, anche se del
tutto estranei al caso. Da simili iniziative, che mi ricordavano le “Giornate
dell’odio” descritte da George Orwell nel romanzo “1984″, mi
sono dissociato.
Non ci si comporta così
tra magistrati ed è facile e privo di rischi accerchiare una persona in un
ufficio e magari in questo modo anche portarla a sbagliare, visto anche il
carattere poco “diplomatico” della vittima. L’incompatibilità ambientale, che si
ignora cosa in realtà sia di preciso, e che spesso è semplicemente l’accanimento
dell’ “ambiente” contro una singola persona, è quasi sempre una procedura
barbara e prettamente inquisitoria. Il suo raggio d’azione, per fortuna, con le
modifiche che conosciamo, si è ridotto, ma dovrebbe esserlo ancora di più,
sopratutto nella pratica, sino a quasi scomparire come dovrebbe scomparire la
prassi, in qualche modo speculare, delle ”pratiche a tutela”.
Un caro saluto a tutti
Guido Salvini
(domenica 19 giugno 2011, 23:09)
PARLIAMO DI MAFIA E
MASSONERIA: FACCE DI UNA STESSA MEDAGLIA.
PARLIAMO DI
MASSONERIA
In internet un file
‘anonimo’ con tutti i dati. Ma non è aggiornato. 32 logge in Umbria fra Perugia,
Terni, Spoleto, Foligno, Castello e Umbertide.
E’ spuntato in internet
ed ha già attirato la curiosità di molti. E’ il file in formato excel dove sono
riportati i nomi dei 26.409 iscritti alla Massoneria italiana. Con tanto di data
di nascita, residenza, e professione. Il percorso è presto detto: si parte da
Google e, una volta inserita nella stringa la parola chiave “elenco massoni”
ecco che al primo posto (su un totale di 58.500 voci) fa bella figura di sè il
“files.meetup.com/207935/pidue.xls”. Basta un click e il gioco è fatto.
Il documento non è di
per sè una novità: si tratta di una lista datata, vecchia almeno di più decenni,
già in parte pubblicata da quotidiani. Nel 1998 ci provò anche la rivista
“Cuore” a pubblicare, a puntate, tutta quella massa di dati, ma l’esperimento si
fermò al terzo numero. Nel 2004 il file arrivò alla redazione di Macchianera che
non lo pubblicò perchè ormai era già disponibile nei siti peer to peer. Ma è
evidente che chi oggi l’ha messa in rete, ha voluto gettare benzina sul fuoco
del sempre tanto discusso e dibattuto tema della fratellanza: non fosse che lo
stesso file, in chiusura, è stato ribattezzato “pidue”, quando nessuno dei
26mila risultava iscritto in quello della P2 di Licio Gelli che finì nel mirino
della magistratura. Perchè, vale ricordarlo, essere iscritti ad una loggia non è
reato. Diverso fu il caso della P2 i cui affiliati finirono coinvolti in diverse
inchieste di eversione, stragi, depistaggi e tentato colpi di Stato. Ma torniamo
al file. Alcuni di quella lista sono morti. Un centinaio infatti sono quelli che
oggi avrebbero più di 100 anni. Non furono pochi quelli che, all’indomani
dell’inchiesta del procuratore Agostino Cordova, uscirono dalla massoneria. “E’
fu un bene – dicono dagli ambienti ternani – molti erano entrati non perchè
credessero nei nostri valori, ma perchè convinti che avrebbero potuto
beneficiare di chissà quali favori. Chi ci credeva e ci crede è rimasto e alla
fine quella indagine si rivelò una fortuna per l’onorabilità della massoneria”.
Quelli rimasti hanno proseguito il loro ‘percorso’. A guardare quell’elenco c’è
chi ha avuto fortuna. Ma c’è anche a chi non è andata affatto bene. Eccoli tutti
insieme, tutti e 26.409: docenti, medici, impiegati, avvocati, commercianti,
ferrovieri, geometri, ingegneri, agricoltori, bancari, farmacisti, architetti.
LA LISTA UMBRA: nel
1992 erano poco più del 4% gli umbri iscritti alle varie logge. 845 quelli
residenti nella provicnia di Perugia, 232 in quella di Terni. La parte del leone
la facevano i nati nel capoluogo di regione (562), seguiti da Terni (156), Città
di Castello (65), Foligno (35), Gubbio (17), Spoleto (16), Bastia Umbra (13),
Assisi (11), Amelia (7) etc..
LE LOGGE: Tre i
principali Ordini massonici. Il Grande Oriente d’Italia (GOI), il più numeroso
con i suoi 30mila iscritti, la Gran Loggia Regolare d’Italia (GLRI) e la Gran
Loggia d’Italia, l’unica a concedere l’accesso alle donne. Tutte hanno il loro
sito internet al quale hanno affidato persino gli indirizzi delle loro
strutture. Un po’ più difficile avere la lista degli iscritti (per quanto gli
elenchi sono pubblici e dunque consultabili presso i rispettivi uffici). Grazie
ad un iscritto ad una loggia di Perugia è possibile tracciare un quadro più
aggiornato sugli iscritti in Umbria.
G.O.I: è la più antica,
nata nel 1805 (il primo Gran Maestro fu Eugenio De Beauharnais, figliastro di
Napoleone Bonaparte), e la più numerosa. Attualmente è presieduta dall’avvocato
Gustavo Raffi. 29 in tutto le logge umbre, 24 in provincia di Perugia, 5 in
quella di Terni. Perugia: La loggia storica per eccellenza è la “Francesco
Guardabassi” (n. 146), una delle 18 logge perugine che vantano ca. 1.300
affiliati. Seguono “Fede e Lavoro”, “Riccardo Granata”, “Mario Angeloni”, “I
Figli di Horus” (che si richiama al rito egizio di Memphis e Misraim), “Fratelli
Bandiera”, “Concordia”, “Ver Sacrum”, “Bruno Bellucci”, “Luca Mario Guerrizio”,
“Francesco Baracca”, “La Fermezza”, “Guglielmo Miliocchi”, “Humanitas”, “La
Fenice”, “Quatuor Coronati”, “XX Giugno 1859” e “Enzo Paolo Tiberi” (la più
recente, n. 1.325). Città di Castello: 150 i “muratori” che compongono le 4
logge presenti a Città di Cstello, ribattezzate “XI settembre”, “I Liberi”,
“Armonia” e “Atlantide”. A Foligno sarebbero una trentina gli affiliati alla
“Domenico Benedetti Roncalli” mentre un po’ di meno quelli alla “Luigi
Pianciani” di Spoleto. Terni: cinque le logge per circa 200 iscritti. La prima
ad essere aperta è la ‘Tacito’ seguita dalla “Giuseppe Petroni”, “Paolo
Garofoli”, J.W. Goethe” e “Alessandro Fabri”.
G.L.R.I.: fondata da
Giuliano Di Bernardo a seguito dello scisma nel 1993 dal GOI. Attualmente è
presieduta dal dottr Fabio Venzi. In Umbria vanta un centinaio di iscritti e 4
logge: la “Luigino Marra” di Spoleto, Piero della Francesca” e “San Bevignate”
di Perugia e la “Braccio Fortebraccio” di Umbertide. Tutte operano nel capoluogo
di regione dove gli iscritti si ritrovano, a cadenza settimanale, in una nota
struttura ricettiva.
G.L.I. (Obbedienza di
Piazza Del Gesù Palazzo Vitelleschi): E’ un “Ordine iniziatico di uomini e
donne”, l’unica infatti ad aprire le porte anche alle donne. Fondata nel 1910 è
oggi retta dal professor Luigi Pruneti. La sede umbra (per gli Orienti di Terni
e Perugia) è presso il Centro Sociologico Italiano in Via Valentini a Perugia.
Gli iscritti sarebbero una cinquantina.
L'INCHIESTA di CURZIO
MALTESE su “La Repubblica”: Chi comanda nelle città. Perugia, il potere soft tra
Medioevo e futuro.
Un viaggio in Umbria è
sempre un viaggio nel tempo, in molti sensi. Anzitutto, non bisogna aver fretta.
Il cuore d'Italia ha il battito lento, la terra dove "la calma si trova a due
passi dalla passione" (De Musset) attira più pellegrini che turisti. Non solo ad
Assisi. In fondo anche i milioni di visitatori di Umbria Jazz, di Eurochocolat,
di "Cantine Aperte" e della marcia della Pace, a modo loro sono in
pellegrinaggio verso santuari laici. Disposti a perdersi nell'incanto dei
paesaggi, nelle valli belle come la Toscana, ma meno oleografiche, più ruspanti
e segrete. Di gran moda fra le star, come Sting e Bruce Springsteen, che hanno
appena traslocato famiglie e clan dal Chiantishire a Montone. Ed è un viaggio
nelle epoche, in una regione sospesa fra Medioevo e futuro. Come la pittura
umbra, che salta dal Perugino a Burri. Perugia, l'"Oxford italiana" di Indro
Montanelli, con la sua università antica di sette secoli, le mura alte e
perfette, la Rocca Paolina, è un museo vivente ma anche il laboratorio sociale
di un felice "melting pot" all'italiana, con una popolazione di immigrati fra le
più alte e un indice di criminalità fra i più bassi. Non esiste consiglio
comunale che non abbia consiglieri immigrati ed è palestinese il deputato di
Perugia, Ali Rashid di Rifondazione. L'università per gli stranieri è il miglior
ponte culturale fra Italia e Cina, per non dire l'unico, visto che qui studia la
metà degli studenti cinesi presenti nel nostro Paese. L'euforia di un'aria
pulita, il carezzevole tratto degli orizzonti, lo splendore dell'arte, il
profumo stordente dei fiori e delle utopie, tutto rende questa terra a prima
vista paradisiaca. Perfino la globalizzazione in Umbria è stata dolce. E'
arrivata prima che altrove, con i due colossi industriali, la Buitoni-Perugina e
le acciaierie di Terni, finite nelle mani di Nestlè e Krupp. In compenso la
perugina Colussi è diventata una multinazionale e fa shopping nel mondo dei
marchi (Misura, Liebig, Sapori, Flora) e le medie imprese innovative si sono
organizzate per rispondere con guizzi di originalità e oggi c'è chi vende
frigoriferi agli eschimesi, legno ai canadesi, energia solare agli spagnoli,
cioccolata agli svizzeri, cashmere agli indiani, jazz agli americani. Medioevo
e futuro s'intrecciano nelle strutture del potere. Perugia è un groviglio di
circoli chiusi, impenetrabili come fortezze, con una massiccia presenza della
massoneria: trentaquattro logge in una città di 160 mila abitanti. Il
tradizionale legame fra università e massoneria si attiva molto in queste
settimane di campagna elettorale per i rettorati. Sono favoriti gli uscenti, il
microbiologo Francesco Bistoni all'università per italiani e l'italianista
Stefania Giannini agli stranieri, ma si combatte a colpi di comizi e riunioni.
E' la vera campagna elettorale perugina. Le altre si chiudono di fatto quando i
Ds locali comunicano i nomi dei candidati alle poltrone di sindaco, presidenti
di provincia e regione, seggio alla Camera e al Senato. E' diviso in feudi anche
il potere nell'informazione, con i due giornali di Perugia, il Giornale
dell'Umbria e il Corriere dell'Umbria, in mano a due cementieri, entrambi
eugubini, il gruppo Colaiacovo (colosso con tremila dipendenti) e il concorrente
Barbetti, che li usano per farsi la guerra, in omaggio a un vecchio adagio
umbro: "Il sogno segreto/ dei corvi di Orvieto/ è mettere a morte/ i corvi di
Orte". Con una netta prevalenza di Carlo Colaiacovo, al centro di un sistema di
potere che comprende anche tre tv locali, la presidenza dell'associazione
industriali e della fondazione bancaria, senza farsi troppi scrupoli di
conflitto d'interessi. Eppure nel Medioevo umbro si aprono squarci di modernità.
Non c'è forse un'altra regione in Italia, per esempio, dove s'incontrino
altrettante donne nei posti di comando. Tutte nipotine di Luisa Spagnoli, la
pioniera che nel 1907 fondò la Perugina, inventò il celebre "Bacio", si dice per
amore di Francesco Buitoni, e poi la celebre catena di negozi, oggi gestita con
talento dalla pronipote Nicoletta. Sono le sorelle Maria Grazia e Teresa a
mandare avanti la Lungarotti, colosso del vino. Una quarantenne di Foligno,
Catia Bastioli, amministratore delegato della Novamont, ha progettato una
plastica biodegradabile e per questo è candidata al premio di inventore europeo
dell'anno. Sono donne i sindaci di Todi e Città di Castello, la rettore
dell'università degli stranieri e naturalmente lei, la "regina dell'Umbria", la
presidente Maria Rita Lorenzetti. Contraria alle "quote rosa" perché non ne ha
mai avuto bisogno. A meno di trent'anni era sindaco di Foligno, a trentacinque
presidente della commissione parlamentare dell'ambiente, a quaranta (nel 2000)
prima e unica governatrice d'Italia, riconfermata nel 2005 con un plebiscito, il
63,2 per cento, record nazionale. A conferma di una regione al femminile, come
testimonial della Regione Umbria si è offerta Monica Bellucci, nata a Città di
Castello. La popolarità della "regina" Lorenzetti si spiega con la ricostruzione
dopo il terremoto del 1999 e con la fama di politico più antiberlusconiano
d'Italia per via di alcune clamorose polemiche con l'ex presidente del
Consiglio, sulla marcia Perugia-Assisi, sul 25 aprile e appunto sul terremoto.
"Quando crollò quella scuola in Molise, Berlusconi ebbe il coraggio di dire: non
faremo come l'Umbria. Perché non viene adesso a vedere come sono stati
restaurati i borghi, più belli di prima?". Tutto vero, con qualche eccezione.
Per esempio il centro storico di Nocera Umbra, ancora in macerie. "Guarda caso,
l'unico dove c'è un sindaco di destra", risponde pronta. "Siamo circondati da
una fama di regione vecchia, bella ma immobile. I problemi ci sono, a partire
dall'invecchiamento della popolazione, duecentomila pensionati su
ottocentocinquantamila abitanti. Ma guardi Perugia, il modo in cui ha integrato
gli stranieri, eliminato il traffico cittadino con le scale mobili che ci
copiano da tutto il mondo, inventato manifestazioni di successo nel mondo. Provi
a visitare i nuovi distretti tecnologici verso il Trasimeno, a parlare con i
giovani imprenditori e vedrà che stiamo vivendo una piccola rivoluzione". Seguo
il consiglio e a una decina di chilometri da Perugia, vicino Corciano, visito
quella che è forse la più piacevole fabbrica del mondo, la Cucinelli. Un borgo
del '300, Solomeo, del tutto restaurato, dove le operaie lavorano nei casolari,
all'ombra degli affreschi, guadagnano il doppio delle colleghe dei maglifici
senza mai fare un'ora di straordinario e mangiano in una mensa da Gambero Rosso.
Brunello Cucinelli, 43 anni, è il re del cashmere, esporta in tutto il mondo,
dagli Stati Uniti al Giappone, ora in Cina e India, ma è l'esatto contrario
dell'esangue e manierato stilista. Figlio di contadini, un passato di
estremista, ha l'aria del francescano di sinistra e ricorda da vicino Mario
Capanna. La sua rivoluzione l'ha fatta con i colori e il cashmere, ma ora si
preoccupa "di restituire alla società una parte della mia fortuna". Ha salvato
Solomeo dalla distruzione, adesso pensa a costruire un teatro neoclassico, che
Luca Ronconi dovrebbe inaugurare, parchi per la meditazione religiosa,
fondazioni benefiche. Cita Sant'Agostino, San Benedetto e Aristotele molto più
di quanto non parli del bilancio consolidato o delle sfilate milanesi. In
maniera perfino sospetta per uno che aumenta il fatturato del 20 per cento
all'anno. E' presidente dei quindici teatri umbri, uno più bello dell'altro, e
direttore dello Stabile di Perugia. Come quasi tutti gli industriali umbri,
coltiva ulivi e vigne. "L'amore per il territorio era un lusso e oggi è
diventato un marchio di garanzia nei mercati internazionali". Un altro
imprenditore filosofo è Gianluigi Angelantoni, erede di Giuseppe, a capo di
un'altra fabbrica-convento, sullo splendido Cimacolle davanti a Todi, che è un
gioiello della tecnologia italiana. L'Angelantoni è specializzata in ingegneria
del freddo, ha costruito simulatori ambientali usati in cinque continenti, il
più avanzato simulatore per testare i satelliti, venduto all'India e inaugurato
nel febbraio scorso a Bangalore durante il viaggio di Prodi, il sistema per
conservare l'Uomo di Similaun e altro ancora. La prossima scommessa di Gianluigi
Angelantoni è il progetto Archimede, in collaborazione col premio Nobel Rubbia.
"E' un nuovo sistema di produzione di energia solare mutuato dallo stesso
concetto degli specchi ustori di Archimede" spiega. "Sarà destinato ad abbattere
i costi dell'energia solare. Gli spagnoli l'hanno già prenotato su vasta scala.
In Italia, come sempre, siamo molto prudenti...". La terza tappa dell'Umbria
Jazz Economy mi porta in una specie di giardino dell'Eden, a Montefalco, la
terra del Sagrantino. Le industrie Caprai, settore tessile, hanno trasformato in
business il tradizionale hobby degli industriali umbri per la vinificazione.
Marco Caprai ha investito sul Sagrantino, vino originalissimo e fra i migliori
d'Italia, quando nessuno ci credeva. Il risultato è un boom paragonabile a
quello del Brunello negli anni Novanta. E' appena tornato dalla California, dove
due produttori gli hanno chiesto una consulenza per riprodurre il Sagrantino:
"Avevo soltanto capito che prima o poi la gente si sarebbe stufata di bere
soltanto Merlot, Cabernet e Chardonnay, bastava aspettare e resistere". Al
ritorno a Perugia incontro Eugenio Guarducci, 42 anni, autentico mito nascente
dell'imprenditoria umbra. E' l'uomo che ha inventato Eurochocolate, un milione
di visitatori, una sagra della cioccolata moltiplicata per mille. "Sono uno che
ha inventato l'acqua calda" dice lui. "Che cosa ci voleva? Perugia è la città
dei baci di cioccolata, la capitale della dolcezza. La città è bellissima e gli
stranieri ci vengono sempre volentieri. Bastava soltanto mettere i manifesti".
Peccato che nessuno ci avesse pensato prima. Dopo il successo di Eurochocolate,
anche gli svizzeri si sono accorti di non averci pensato prima e hanno chiamato
Guarducci per organizzare la festa europea della cioccolata. Intanto a Perugia,
con gli incassi della fiera, ha aperto un centro congressi e una catena di
alberghi tematici, uno dedicato naturalmente alla cioccolata, un altro al vino e
il terzo, appena inaugurato, al jazz. Grazie ai Cucinelli, Angelantoni, Caprai,
Guarducci, alla vivacità dell'imprenditoria al femminile, l'Umbria cresce più
del resto d'Italia e ha l'indice di disoccupazione più basso al di sotto della
pianura padana. Qualche anno fa Ernesto Galli della Loggia, in un lungo dialogo
con il deputato diessino Stramaccioni, dedicò un pamphlet ("Rossi per sempre")
all'Umbria come metafora del declino nazionale. Se questo è il declino, ci
possiamo stare.
I massoni di Perugia:
questa persecuzione deve finire. Dall’archivio de “Il Corriere della Sera”
l’inchiesta di Bruno Tucci. LA CAPITALE DEI VENERABILI. Mille affiliati. Li
accusano di condizionare la città e loro: "Siamo eredi dei laici che hanno
sconfitto il Papa Troppe calunnie, quel magistrato viola il codice. Mille
iscritti alle logge sparsi per la provincia: tutti nelle stanze dei bottoni.
Ospedali, banche, università e poi ancora in magistratura, negli ordini
professionali, tra gli avvocati, i medici, gli ingegneri fino alle istituzioni.
La mappa della massoneria in questo lembo del Paese raggiunge percentuali da
capogiro. Perugia si sente afflitta e condizionata? "Non diciamo eresie",
esclama il presidente del collegio venerabile, Giancarlo Zuccaccia. "Chi ha
conquistato posti importanti nella società non lo deve certo a noi, ma
esclusivamente alla propria professionalità". Eppure, le accuse sono specifiche:
vengono da un giudice calabrese che punta il dito contro i massoni e cerca di
inchiodarli con elementi e prove inconfutabili. Lo avrete capito: il magistrato
in questione è Agostino Cordova, procuratore di Palmi, il quale sta combattendo
una battaglia personale in un campo così delicato e difficile. Le parole di
Cordova non ammettono dubbi di sorta. In Umbria, e specificamente nella
provincia di Perugia, i massoni sono tanti, troppi e condizionano la vita della
città. Tutto passa attraverso il controllo delle logge: assunzioni, promozioni,
avvicendamenti, scatti di carriera. Come mai? Semplice: al timone della barca ci
sono loro e soltanto loro. "Fandonie, fesserie, calunnie", risponde a tono
Giancarlo Zuccaccia, presidente dell' Ordine degli avvocati dall'ottobre del
1992. Sibila: "Sono stato eletto con 250 voti. Dovrebbero avere tutti una stessa
etichetta, secondo Cordova. Ed invece, non è così, glielo posso assicurare. La
verità è che questo magistrato ha preso di mira la massoneria. Ha sguinzagliato
per tutta Italia i suoi scherani e siccome non è riuscito a trovare un bel
nulla, allora tira fendenti alla cieca. Ma, attenzione, sta violando il codice
penale". Un' accusa pesante, avvocato... "Già, è vero. Allora non la scriva.
Però, rimane il fatto che noi siamo alla gogna, criminalizzati per episodi che
non esistono. Siamo stanchi, mi creda, perché ne dobbiamo sopportare di tutti i
colori". Dunque, non avete stretto tra di voi patti di alleanza spartitoria?
Insomma, una specie di lottizzazione massonica? "Non scherziamo. Chi di noi
raggiunge risultati professionali lo deve soltanto alla bravura ed all'onestà.
Il resto sono chiacchiere che non stanno né in cielo, né in terra". Il
presidente venerabile si difende, ammette che in Umbria ci sono 24 logge tra
Perugia, Terni, Spoleto e Città di Castello, ma non vuole sentir parlare di
favoritismi e di clientelismo. Sono parole sconosciute nel vocabolario dei
massoni. Ma chi sa e conosce Perugia e dintorni non è d'accordo. Legge delle
indagini condotte da Agostino Cordova e si frega le mani. "Finalmente! Era ora",
grida qualcuno. "Questa storia, prima o poi, doveva pur finire. Speriamo si
faccia in fretta, perché i giovani non ne possono più di un simile
condizionamento". Parlano i perugini che non hanno niente a che spartire con la
massoneria, però si trincerano dietro l'anonimato. Hanno paura di tarparsi le
ali, di non poter combinare più nulla in futuro, se dovessero essere scoperti.
Con tale premessa vanno avanti nel racconto e confessano al cronista che chi non
sta dalla parte dei massoni incontra grossi ostacoli. I favoritismi sono a senso
unico. Un esempio: se vuoi assicurarti un posto o se desideri compiere un salto
di qualità, non hai altra scelta se non rivolgerti a quelli che contano. E,
guarda caso, nelle stanze dei bottoni ci sono soltanto loro. Così è all'
università, nelle banche, in ospedale, negli enti pubblici, dappertutto. "Noi
agiamo alla luce del sole", replica Giancarlo Zuccaccia. "Non siamo un partito,
abbiamo sempre combattuto la lottizzazione", aggiunge un altro "fratello
perugino", l'avvocato Giacomo Borrione. "Anzi, sa che cosa le dico? E' vero il
contrario: abbiamo sofferto l'infiltrazione dei partiti. Noi interveniamo
soltanto quando un "fratello" è in stato di bisogno. E chi aiuta non appare,
rimane tutto avvolto nel segreto". La voce di popolo grida a gran voce l'esatto
contrario. Cita nomi, cognomi di affiliati: gente di potere che solidarizza solo
con chi è iscritto. Ad esempio, la famiglia De Megni, sulla quale sono stati
spesi fiumi di parole. "Alle cene annuali in casa loro partecipa il fior fiore
della massoneria, il vertice delle logge umbre". Non si salva nessuno, nemmeno
il rettore dell'Università, alcuni commissari di polizia, ufficiali dei
carabinieri. Chiacchiere? "Se sono bugie, lo vedrete il giorno in cui Cordova
avrà completato la sua inchiesta", rispondono i perugini. Giancarlo Zuccaccia va
su tutte le furie: "Io ai pranzi di De Megni non ci sono mai stato. Se mi
chiedete se sono massone, rispondo di sì. Sono apparso in gonnellino pure alla
tv. Ma non andiamo oltre, parlando di sette, di logge segrete, di clientelismo.
Il venerabile Licio Gelli (come lo chiamate voi) lo abbiamo espulso nel 1976,
avete capito?". Ed allora perché tanti massoni a Perugia o in Umbria, se
preferisce? "E' semplice: perché siamo laici ed abbiamo subito la dominazione
pontificia per 400 anni. Lo sa che il 20 giugno, puntualmente, Perugia festeggia
la cacciata dei papalini? Ed è una festa a cui partecipa tutta la città, comune
compreso. Questa persecuzione di Cordova deve finire. Io ho subito minacce
telefoniche e sono in allarme per la mia incolumità". In Corso Vannucci, la
strada dello struscio, scuotono la testa e commentano: "I massoni? Se non stai
con loro, è meglio che emigri. Sono forti, fortissimi ed hanno tutte le leve del
potere. Quindi..."
Ma la Massoneria non e’
solo magistratura: è pure politica.
Se a livello nazionale
la polemica tra iscritti al Pd e massoneria crea imbarazzo, a livello locale
molto meno, perlomeno laddove è tradizione consolidata. A Perugia, per esempio,
dove più di qualcuno ha iniziato a fare “outing”. Mario Valentini, ex sindaco
Psi negli anni Novanta e fondatore del Pd perugino, oggi ricorda: “L’esperienza
della massoneria, della quale mi onoro di appartenere, è ricca di storia civile
e progressista della città. Considero la massoneria un patrimonio da conservare
e testimoniare. Quella in atto oggi nel partito è una polemica vecchia, datata.
Posso assicurare che, durante il mio mandato di sindaco, non ho mai ricevuto
pressioni che tendessero a condizionare la mia libertà di primo cittadino”. Il
legame tra massoneria e Pd non un mistero in città, ma ora dopo il recente
scandalo, il segretario locale invita alla calma: “Quella della massoneria è una
questione sensibile – spiega Giacomo Leonelli -. Chi aderisce al Pd deve farlo
in maniera trasparente, altrimenti crea disagio al partito e agli altri
militanti”. Sono soprattutto gli ex socialisti, ora confluiti nel Pd, ad avere
dimestichezza con grembiuli e cappucci. Ma non tutti sono disposti ad ammettere
di essere massoni. Cesare Fioriti dice: “Non sono massone, però difendo la
massoneria. E poi i principi della massoneria non sono forse validi? Penso alla
fratellanza, alla riflessione, allo sviluppo delle idee”. Angelo Pistelli, altro
esponente Pd ex socialista, dopo la polemica non si sente più a suo agio nel
partito: “In effetti del Pd ormai non condivido più tanto. Bisognerebbe dare
spazio a tutte le voci. Invece comandano le solite culture dominanti, a noi
resta ben poco. E poi sono sincero: se scoprissi che non ci sono massoni nel
gruppo dirigente del Pd mi dispiacerebbe”.
A tal proposito uscì un
articolo: I grembiulini del Pd di Perugia di Marco Sarti su “Il Riformista”. Il
Pd e la massoneria. Due realtà inconciliabili? Mentre in Italia infuria la
polemica, a Perugia il tema non appassiona più di tanto. La sintesi tra squadre,
compassi e militanza politica di sinistra, qui esiste da decenni. E nessuno si
stupisce più. Perché se il capoluogo umbro è un feudo elettorale del Partito
democratico, è anche vero che solo nelle vie del centro si contano almeno 19
logge. E così, nella nuova casa massonica perugina, in un antico palazzo a Corso
Cavour, c'è persino chi si indigna di fronte all'ipotesi che qualche fratello
possa venire epurato dal Pd. «Ma quale polemica… - si sfoga un responsabile del
Collegio Venerabile - Nessuno ha mai fatto caso che ogni volta che c’è una crisi
si tira fuori questo argomento? I nostri luoghi di ritrovo sono pubblici. Già
nel lontano 1985 abbiamo sistemato una targa fuori dalla sede di Palazzo
Giustiniani. Allo stesso modo abbiamo messo bene in chiaro i nostri riferimenti
sull’elenco telefonico. Qualcuno si scandalizza se non viene resa pubblica anche
l'identità dei nostri fratelli? Eppure mi sembra che persino gli elenchi degli
iscritti a partiti e associazioni siano riservati». «I massoni del Pd? -
racconta un anonimo militante - Vengono tutti dal Partito socialista». In
effetti, a Perugia, il movimento storicamente più vicino al Grande Oriente è
proprio quello un tempo guidato da Bettino Craxi. La gente ancora ricorda una
storica seduta del Consiglio comunale, nei primi anni 90, quando il sindaco
Mario Valentini (eletto nelle liste del Psi, poi fondatore del Pd perugino)
rivendicò con orgoglio la sua appartenenza a un'influente loggia cittadina.
«L'esperienza della massoneria - racconta oggi Valentini - della quale mi onoro
di appartenere, è ricca di storia civile e progressista della città. E non mi
riferisco solo al periodo post-fascista, parlo anche della Perugia laica dopo il
governo papalino. Considero la massoneria un patrimonio da conservare e
testimoniare. Una vicenda fatta da uomini esempio di vita e rettitudine nel
governo della cosa pubblica. Quella in atto oggi nel partito è una polemica
vecchia, datata. Posso assicurare che, durante il mio mandato di sindaco, non ho
mai ricevuto pressioni che tendessero a condizionare la mia libertà di primo
cittadino». Che tra i quadri del Pd perugino, ancora oggi qualcuno si cimenti
con cappucci e grembiule non è un mistero. Solo che, dopo il recente scandalo,
nessuno è disposto a parlare. Giacomo Leonelli, segretario del Partito
democratico della città, predica calma: «Quella della massoneria è una questione
sensibile. Sono temi dove ognuno esprime le proprie idee secondo convinzioni
personali. Per carità, sono convinto che chi si iscrive al Pd lo fa perché crede
nel nostro progetto politico, non per altri fini». A scanso di equivoci, il
segretario si appella allo statuto. «Chi aderisce al Pd deve farlo in maniera
trasparente. Altrimenti crea disagio al partito e agli altri militanti». Eppure
sembra che fare politica tra Piazza Morlacchi e Corso Vannucci non possa
prescindere da certi riferimenti. «Quando si governa a Perugia - conclude
Leonelli - è normale entrare in contatto con determinate realtà cittadine».
Contattati al telefono, i componenti della piccola pattuglia socialista nel Pd
non si stupiscono di certi accostamenti. Ma negano, con cortesia, qualsiasi
coinvolgimento personale. Cesare Fioriti fa parte del direttivo del Pd di
Perugia. Ex capogruppo del partito socialista in consiglio comunale, qualche
anno fa è riuscito a fare intitolare una via alla memoria di Vittor Ugo Bistoni,
storico esponente del Psi cittadino, presidente del Collegio umbro dei Maestri
Venerabili e fondatore della Loggia “Guglielmo Miliocchi”. «Certo che è strano -
ripete anche Fioriti - questa vicenda della massoneria viene fuori a orologeria.
Secondo me serve a spostare il baricentro dell’opinione pubblica altrove,
rispetto a temi come la crisi. Ricordo un altro scandalo simile: accadde nei
primi anni 90, ai tempi di Tangentopoli». Fioriti non è legato ad alcuna loggia:
«No, non sono massone - precisa subito -. Però difendo la massoneria. La penso
esattamente come Voltaire (altro “illuminato”, ndr) “Anche se disapprovo quello
che dite, difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo”. I consiglieri
comunali devono avere piena libertà di espressione, quindi anche di
associazione. E poi scusi, i principi della massoneria non sono forse validi?
Penso alla fratellanza, alla riflessione, allo sviluppo delle idee». Squadra e
compasso non creano alcun imbarazzo. «Il fine della massoneria è l’evoluzione
del pensiero - continua Fioriti -. Mi spieghi lei come fa il Pd a condannare
un’organizzazione del genere». Angelo Pistelli è un altro esponente del Pd
umbro. Anche lui di provenienza socialista, fino a poco tempo fa era
nell'esecutivo regionale. Dopo le ultime polemiche sulla massoneria non si trova
più molto a suo agio nel partito. «In effetti del Pd ormai non condivido tanto -
ammette Pistelli -. Ma io mi sento di sinistra e non ci sono altri partiti in
cui potrei militare. Bisognerebbe dare spazio a tutte le voci. Invece comandano
le solite culture dominanti, e a noi resta ben poco». Sembra quasi che Pistelli
sia pronto a fare coming out, quando corregge il tiro. «Specifico che non sono
un massone. Diciamo che difendo ogni espressione personale. Credo che anche
all’interno del partito ognuno debba essere libero di aderire a quello che gli
pare. Non vogliono i massoni? Allora io dico che non voglio l’adesione di tutti
quelli che provengono dal Pci. Hanno calcolato che in Italia ci sarebbero 4mila
iscritti legati alla massoneria. A occhio e croce non mi sembrano mica tanti. E
poi sono sincero: se scoprissi che non ci sono massoni nel gruppo dirigente del
Pd mi dispiacerebbe».
La Massoneria. Erede di
misteriose società segrete avvolte nella leggenda, come il Priorato e i
Rosacroce, è considerata un’organizzazione di sicura esistenza anche oggi. Non è
ben chiaro, però, se questa società sia da vedersi come un’erede di quelle del
passato, o piuttosto come un altro volto della medesima organizzazione,
perseguente sempre gli stessi scopi, ma con rituali differenti. L’origine
della Massoneria sembra da collocarsi in età moderna, quando, nel 1717, la
Grande Loggia dei Massoni di Londra rese pubblica la sua esistenza. Ma ci sono
diverse prove che la società esistesse già precedentemente: nel 1646
l’antiquario Elias Ashmole fu iniziato alla Massoneria, mentre una poesia di
Henry Adamson del 1638 vi fa riferimento. Ma ci sono anche teorie che ne fanno
risalire la fondazione all’epoca antica e che costituiscono la “Leggenda della
libera Muratoria”. Essa si basa su documenti pubblicati nel 1800, che collegano
la Massoneria alla costruzione del Tempio di Salomone, considerato il primo Gran
Maestro. L’origine della società si fa anche ricondurre ai Templari, essendo
stati ritrovati simboli massonici su pietre tombali in loro castelli. Quindi,
ancora una volta, l’Ordine del Tempio, che dovrebbe essere stato il supremo
difensore della fede, viene messo in relazione con un gruppo dalla religiosità
discutibile. I massoni, infatti, credono in una suprema divinità, che però non
si specifica chiaramente se sia un dio cristiano oppure no, visto che vengono
accolte persone di tutte le religioni. Nel 1738, papa Clemente XII emanò una
bolla in cui proibiva ai cattolici di aderire alla Massoneria, situazione che
cambiò solo nel 1976.
La Massoneria prevede
un rigido rituale, a cui deve attenersi chi vuole accedere ai diversi gradi, il
cui simbolismo è riassunto in alcune Tavole illustrate, nelle quali sono sempre
presenti i simboli fondamentali, riconducibili alla geometria e
all’architettura: il Libro Sacro, la squadra, il compasso. L’aspirante al Primo
Grado è detto Apprendista e deve essere bendato, indossare un abito di lino, con
un cappuccio e un cordone intorno al collo (possiamo scorgere un’analogia con il
cordone usato nella cerimonia d’iniziazione dei Templari). L’apprendista deve
anche giurare di non rivelare mai i segreti che gli verranno svelati, altrimenti
incorrerà in una terribile pena: aver la mia gola tagliata, la mia lingua
strappata alla radice, e il mio corpo sepolto nelle ruvide sabbie del mare al
limite della bassa marea. Sembra che questa minaccia non sia mai stata messa in
atto, ma serve comunque a definire il sapere della Massoneria come esoterico.
La Tavola del Primo
Grado comprende una rappresentazione del Sole e della Luna, a sottolineare
l’importanza del concetto di dualismo che governa l’universo. Di rilievo sono le
due colonne, corinzia e dorica, che rappresentano il passaggio dell’Apprendista
verso un altro stato, e che pare siano quelle del Tempio di Salomone, chiamate
Jachim (lo spirito attivo e creativo, ed anche la conoscenza) e Boaz (lo spirito
passivo e riflessivo, ed anche l’ignoranza), i due giganti che sorreggono le
colonne d’Ercole.
Nella Tavole del
Secondo Grado, a cui accede chi è diventato Compagno, le colonne sono cave e
possono contenere documenti segreti (ci viene in mente l’abate Saunière che a
Rennes-le-Château forse trovò delle pergamene in una colonna cava). Vi è,
inoltre, la rappresentazione della scala di Giacobbe che sale verso il cielo
(anche nella chiesa di Rennes troviamo un richiamo a Giacobbe tramite le parole
sul timpano d’entrata Terribilis est locus iste).
Le Tavole del Terzo
Grado, con cui si diventa Maestro, mostrano la simbologia che accompagna uno
strano rituale: viene mimato l’assassinio da parte di tre cospiratori
dell’architetto del Tempio, Hiram Abif, e l’iniziato riceve tre colpi,
simbolici, sul capo. I simboli che si ritrovano sulle Tavole si addicono ad un
fatto di sangue: una bara e il “Teschio” ossia un teschio su due femori
incrociati. Ci sono tantissimi luoghi nel mondo dove è possibile trovare
nell’architettura simboli massonici. Ad esempio la cappella di Rosslyn in
Scozia, già sito prediletto dai cercatori del Santo Graal: due colonne sembrano
essere quelle del Primo Grado, un’immagine di una testa ferita ricorda
l’uccisione di Hiram, una scultura sembra rappresentare un Templare che
amministra riti massonici. Sembra che i massoni abbiano partecipato alla
progettazione di intere città, come Washington D.C., progettata seguendo viali
diagonali, che formano triangoli e che sono allineati secondo eventi
astronomici. Il viale diagonale principale, infatti, è la Pennsylvania Avenue,
che pare allineata secondo tale evento: la sera del 10 agosto il sole tramonta
esattamente alla fine del viale, mentre mezz'ora più tardi nello stesso punto
tramonta una costellazione che include quella della Vergine. Intorno a questa
costellazione c'è un triangolo rettangolo formato dalle stelle Regolo, Arturo e
Spica, che ricalca quello formato da Pennsylvania Avenue, il Mall (vasto viale
diretto ovest verso il fiume) e una linea che passa lungo il Monumento a
Washington. Innegabile è l'influenza della Massoneria nella storia degli Stati
Uniti, essendo massoni gran parte dei firmatari della Dichiarazione
d'Indipendenza ed essendo lo stesso Washington membro della Loggia Alexandria.
Il monumento a Washington è costruito sul modello di un obelisco egiziano,
simbolo molto usato dalla Massoneria; una statua dedicata al presidente Garfield
mostra uno zodiaco; il Gran sigillo degli Stati Uniti (quello che si vede sul
dollaro) raffigura una piramide sormontata dall'Occhio-che-Tutto-Vede. Anche
molte associazioni universitarie utilizzano un simbolismo massonico: il più
lampante esempio è la confraternita Teschio e Ossa di Yale, della quale fecero
parte molti politici e personaggi in vista, tra i quali George H. W. Bush e
George W. Bush. Esiste una città vicino a noi che sembra nascondere tra le sue
vie ed i suoi monumenti chiari riferimenti massonici, Torino.
Il capoluogo torinese è
notoriamente considerato un “città magica”, dove proliferano le sette e i
sedicenti maghi. Torino sarebbe, infatti, un omphalos primordiale, un centro
d’irradiazione di energia tellurica e spirituale, sorgendo su un nodo
geomantico, cioè in un punto d’intersezione tra correnti enrgetiche dette leys
(le stesse dove potrebbero essere sorti i luoghi di culto delle civiltà antiche,
specialmente quelli dedicati alla Dea Madre). Torino farebbe, dunque, parte di
un doppio triangolo magico, i cui vertici sarebbero altre città magiche del
mondo: Lione, Praga, Londra e San Francisco. A Torino sono segnalati da chi si
diletta di magia ed occultismo 33 punti magici, negativi e positivi. Il punto di
maggiore positività si situa in piazza Castello, dove si trova la meridiana
astrologica sulla prima colonna di destra del Duomo e la cancellata della
Piazzetta Reale su cui sono rappresentati i Dioscuri, simboli dell’opposizione
tra luce e tenebre, Sole e Luna, secondo un dualismo caro ai massoni. Il punto
di maggiore negatività sarebbe Piazza Statuto, rivolta ad Ovest, dove si
eseguivano le condanne capitali. Nella storia di Torino è anche rilevante il
legame con l’Egitto, i cui simboli si ritrovano in alcuni rituali massonici: la
città sembra, infatti, aver dato asilo al principe eretico Eridano, che avrebbe
scelto questo sito per fondare una città nel XV secolo a. C., perché il Po gli
ricordava il suo Nilo. Anche il nome stesso della città potrebbe essere di
origine egizia, ricollegandosi al culto del Toro sacro di Menfi. La chiesa della
Gran Madre di Dio (indicata come uno dei luoghi del Santo Graal) si dice sia
stata costruita sulle rovine di un antico tempio di Iside. Vi è, inoltre, in
Piazza Solferino, un’opera d’arte palesemente ispirata dal simbolismo massonico,
la Fontana Angelica. Essa era stata progettata per essere collocata davanti al
Duomo, mentre nella posizione attuale ha perduto parte del suo significato
simbolico, non essendo rivolta ed est. Le statue rappresentano due figure
maschili, l’Autunno e l’Inverno, che si possono identificare con Jaquim e Boaz.
Essi versano l’acqua da due otri, uno a forma d’Ariete, l’altro d’Acquario.
L’acqua rappresenta la conoscenza, mentre l’Ariete è il Vello d’Oro cercato
dagli Argonauti, ma anche la trasformazione della materia verso la perfezione
(la Massoneria è considerata depositaria di segreti alchemici); l’Acquario,
invece, rappresenta l’Era dell’Acquario a cui deve tendere l’umanità. Le due
figure maschili, però, possono anche rappresentare la divinità egizia Osiride, e
allora quelle femminili, la Primavera e l’Estate sarebbero la sua compagna
Iside. Se poi ci si pone di fronte alla fontana si vedrà che tra l’Autunno e
l’Inverno si apre un varco: quello che l’iniziato deve attraversare per giungere
alla vera conoscenza. Ecco che una città dalle antiche tradizioni di magia è
stata eletta da una società segreta come luogo privilegiato per esprimere i
propri riti e forse svelare i propri segreti all’attento osservatore.
La Massoneria in
Italia. Essa visse stentatamente fra le persecuzioni fino alla occupazione
napoleonica. Si ha notizia dì qualche Loggia in Firenze, Napoli, Torino, Cremona
e Milano. Il 5 marzo 1805 si costituì in Milano il primo Supremo Consiglio
d'Italia, ad opera dei fratelli massoni Francesi di 33° Grado, appartenenti alla
Armata Napoleonica, e furono eletti a Sovrano Gran Commendatore il Viceré
d'Italia Principe Eugenio Beauharnais e Gran Cancelliere il Principe Gioacchino
Murat. Nel 20 giugno dello stesso anno si formò il Grande Oriente d'Italia, pure
in Milano col quale si fusero le Logge Francesi del Grande Oriente e della
Divisione Militare del Regno d'Italia. Nel 1806 furono pubblicati gli Statuti
della Franca Massoneria in Italia ed i Rituali dei primi tre Gradi; nel 1809 la
Costituzione Generale del Grande Oriente in Italia; nel 1812 una nuova edizione
degli Statuti, da cui derivano gli Statuti generali del Rito Scozzese Antico ed
Accettato, stampati in Napoli; nel 1820 ed ancor oggi in uso.
Dal 1806 al 1808 si
ebbero nell'Italia settentrionale più di 30 Logge, composte dai migliori
elementi della società del tempo, tra i quali il filosofo Romagnosi, Vincenzo
Monti, ed il musicista Paganini. Nei documenti ufficiali Napoleone era chiamato
" Potentissimo Fratello Protettore dell'Ordine".Nel 1808 si costituì il Grande
Oriente di Napoli con Gioacchino Murat Gran Maestro; l'anno successivo fu
fondato il Grande e Supremo Consiglio per le due Sicilie dei Potentissimi Grandi
Ispettori Generali, con sede in Napoli e Murat Sovrano Gran Commendatore. Il
Colletta riferisce che nel 1813 la Massoneria meridionale contava 94 Logge.
Caduto Napoleone, il Supremo Consiglio di Milano si sciolse, mentre continuò il
fervido lavoro segreto delle Logge nell’Italia meridionale. Dopo il 1848 sembra
che vi fosse in Torino uno Supremo Consiglio, che però non fu molto attivo fino
al 1862; nel 16 dicembre di quell'anno si costituì in Torino un Concistoro del
32° Grado, che funzionò fino al 1866, anno in cui si ebbe un Supremo Consiglio
per l'Italia, che continua il suo lavoro ancora nel 1883. Nel 1861 la Massoneria
funzionava ancora in Napoli, ove la Loggia "Sebezia" assumeva il titolo di Gran
Loggia Madre per affermare la sua diretta discendenza dal Supremo Consiglio di
Napoli; a Palermo si creavano altre due Massoneria, una delle quali si fondeva
con il Supremo Consiglio di Torino nel 1867, è l'altra nel 1862 eleggeva alla
carica di Sovrano Gran Commendatore Giuseppe Garibaldi.Divenuta Firenze capitale
del Regno, nel 1864 molti membri della Supremo Consiglio di Torino vi si
trasferirono; ivi veniva fondato nel 1869 un nuovo Supremo Consiglio, che
nel 1872 si trasferiva a Roma. In tale data veniva nominato Sovrano Grande
Commendatore Giorgio Tamayo. Nel 1863 la situazione della Massoneria italiana
era la seguente: un Supremo Consiglio a Torino con a capo il Generale Milbitz,
un Supremo Consiglio a Firenze con a capo Francesco De Luca, un Grande Oriente a
Napoli, un Supremo Consiglio a Palermo. Una ispezione del Potentissimo Fratello
Albert G. Goodall del Supremo Consiglio di Boston dichiarava illegittimi i
Supremi Consigli di Palermo e di Firenze, e regolare il solo Supremo Consiglio
di Torino, cui spettò di partecipare al Congresso di Losanna del 1875. Circa
nel 1869 il Grande Oriente di Napoli si fondeva con il Supremo Consiglio di
Torino, nel 1875 auspice Giuseppe Garibaldi si fondevano i Supremi Consigli di
Roma e di Torino, creandosi un nuovo Supremo Consiglio per l'Italia con sede a
Roma, al quale aderiva nel 1876 il Supremo Consiglio di Palermo. Ma varie
vicende, specie per il fatto di dover trasferire la sede a Roma, rompevano
l'accordo; però nel 1879, per iniziativa di alcuni Supremi Consigli esteri tutti
i fratelli italiani di 33 Grado, convocati a Roma, creavano il Supremo Consiglio
per l'Italia ed il nuovo Sovrano Gran Commendatore nella persona di Giorgio
Tamayo. Però la Massoneria piemontese si tenne ancora in disparte, cessando di
essere regolare. La fusione completa avveniva poi nel 1887 per opera di Adriano
Lemmi, Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia in Roma: morti nel 1895 il
Riboli di Torino è nel 1897 il Tamayo di Roma, veniva nominato Sovrano Gran
Commendatore della Massoneria italiana il Lemmi, che tenne la carica fino alla
sua morte, avvenuta nel 1906. Dopo il 1860, parallelamente al Rito Scozzese, e
sul tipo della Massoneria francese, si era formata in Italia una Grande Loggia
Simbolica, che non riconosceva Gradi superiori al 3°. Ne furono Grandi
Maestri Costantino Nigra, Giuseppe Garibaldi, Francesco De Luca, e il Marchese
Cordova. Adriano Lemmi si adoperò perché il Rito Scozzese ed il Rito Simbolico
si riunissero, delegando i due poteri ad un Grande Oriente d'Italia per la
sovranità sulle Logge; il patto potè dirsi perfetto nel 1882 quando Adriano
Lemmi, già Sovrano Gran Commendatore, fu eletto anche Gran Maestro del Grande
Oriente. Morto Adriano Lemmi nel 1906, gli succedevano come Gran Maestro Ettore
Ferrari e come Sovrano Gran Commendatore Achille Ballori, il quale aveva come
Luogotenente Saverio Fera. Nel 1908 la Massoneria si divise in due a causa di un
conflitto sorto, essendo un gruppo di Deputati al Parlamento stato minacciato di
espulsione per non essersi schierato con sufficiente energia circa un progetto
di Legge sulla laicità dell'insegnamento. In sostanza, si contestava la
inopportunità dell'intervento ed il diritto del Gran Maestro E. Ferrari di
imporsi sulla coscienza dei massoni Deputati in questioni politiche e religiose
che non toccavano direttamente l'Ordine. Perciò il Supremo Consiglio, quale
tutore della regolarità delle Rito Scozzese, minacciò di demolizione il Grande
Oriente. Il Sovrano Gran Commendatore A. Ballori in un primo momento si schierò
contro E. Ferrari, ed in secondo tempo si alleò a questi avendo contro di sé
tutto il Supremo Consiglio, lasciò la carica al Luogotenente Saverio Fera.
Questi creò allora secondo gli Statuti Scozzesi una Gran Loggia Nazionale
d'Italia, di cui venne nominato Gran Maestro. Si ebbero così due Massonerie, che
dalle rispettive sedi furono dette Piazza della Gesù (Fera) e di Palazzo
Giustiniani (Ballori). Una ispezione allora a nome dei vari Supremi Consigli
Esteri ed a mezzo del Potentissimo Fratello Belga De Paepe riconobbe regolare la
prima, tale decisione venne confermata dalla Conferenza di Washington del 1912;
così nel mentre la Massoneria regolare di Piazza del Gesù rimaneva federata con
le 56 Potenze massoniche di Rito Scozzese, quella di Palazzo Giustiniani
rimaneva collegata con alcuni Grandi Orienti irregolari, fra i quali il Grande
Oriente di Francia e la Gran Loggia Simbolica di New York. Morto Saverio Fera,
furono Gran Maestri della Massoneria Scozzese Italiana i Sovrani Gran
Commendatori Leonardo Ricciardi, William Burgess e Raoull Vittorio Palermi. La
posizione delle due Massoneria venne definitivamente regolata dalla Conferenza
di Losanna del 1922 il delegato di Palazzo Giustiniani non venne ricevuto,
perché ritenuto irregolare, e Raoul Vittorio Palermi, delegato di Piazza delle
Gesù, fu nominato Presidente della prima Sezione, ottenendo il riconoscimento da
parte di tutti i Supremi Consigli rappresentati alla Conferenza, della sua
regolarità. Tra il 1919 ed il 1922 le due Massoneria presero posizione contro i
movimenti estremisti, che avevano fatto piombare il Paese nell'anarchia. Giunto
al potere Benito Mussolini, con un programma costruttivo di disciplina
nazionale, tanto il Palermi, che Domizio Torrigiani Gran Maestro di Palazzo
Giustiniani, gli resero pubblico omaggio, e malgrado il divieto fatto ai
fascisti di essere massoni, tutti gli uomini più eminenti delle fascismo erano
iscritti a Logge dell’una o dell'altra parte. A causa del delitto Matteotti e
del discorso del 3 gennaio 1925, la Massoneria assunse verso il regime un
atteggiamento di aperta sfiducia: mentre però il Torrigiani si chiuse in una
rigida opposizione, il Palermi cercò di salvare il salvabile; ma nulla potè
conseguirne, infatti fu promulgata la legge 20 novembre 1925 contro le Società
Segrete. Ma la Massoneria non era morta: gruppi di massoni si tenevano in
contatto nelle varie città. Alla fine del conflitto bellico le Logge servirono a
far divampare la Sacra fiamma massonica che, sopita ma non spenta, brilla di
luce antichissima: essa potrà e dovrà di nuovo riverberarsi nella vita italiana,
riportare il contributo dello splendore dello Scozzesismo alla ricostruzione
della Patria ed al suo ritorno nel Consesso delle Nazioni.
Torino capitale, covo
di massoni. La città incarna le ragioni del laicismo contro quelle della chiesa.
Dopo la fine del sogno rivoluzionario quarantottino, a decine di migliaia gli
esuli della libertà vanno a Torino, nuova e impensabile capitale italiana.
Impensabile è la parola giusta: da sempre la classe dirigente torinese ha avuto
il francese come eloquio privilegiato, esclusivo per le buone occasioni. Non è
un caso che Cavour abbia fatto esercitazioni di italiano prima di affrontare i
dibattiti in Parlamento. Torino diventa la capitale morale d’Italia facendo
proprie le ragioni del mondo civile contro quelle della barbarie medioevale,
incarnate dalla Chiesa cattolica. Non solo: Torino diventa Gerusalemme. Il
Paragone non sembra ardito a Roberto Sacchetti: "Torino saliva allora al colmo
del suo splendore. Era stata forte e diventava grande - bella, balda di una
gioia viva e seria come una sposa a cui preparano le nozze. La Mecca d’Italia
diventava la Gerusalemme". A Torino, nuova capitale morale e religiosa d’Italia,
si trasferiscono, e non può che essere così, tutti i liberal-massoni
(Free-Mason, Franc-Maçon, Libero-Muratore, liberalismo e Massoneria sono
nell’Ottocento praticamente sinonimi) del resto d’Italia. I regnanti sardi
offrono ai "fratelli" italiani un’accoglienza tanto calorosa da riservare loro
(a tutto discapito dei locali) alcuni dei posti più prestigiosi nelle
università, nei giornali, nella diplomazia, nello stesso Parlamento. Ecco come
il siciliano Giuseppe La Farina, una delle più eminenti personalità massoniche
emigrate a Torino, racconta l’accoglienza riservata agli esuli in una lettera
alla "carissima amica" Ernesta Fumagalli Torti, spedita il 2 giugno 1848.
"Arrivati appena a Torino - scrive - stavamo spogliandoci, quand’ecco il popolo
preceduto da bandiere venire sotto le nostre finestre, e farci una dimostrazione
veramente magnifica. Mi affacciai alla finestra, ringraziai; fui salutato con
mille prove ed espressioni d’affetto. La mattina seguente, dopo essere stati da’
ministri, ritorniamo a casa; e dopo un momento, chi viene a visitarci? Tutta la
Camera de’ Deputati col presidente. Onore insigne, che i parlamentari non
sogliono concedere né anco ai propri re". L’accoglienza "regale" offerta alla
generosa emigrazione italiana, permette ai Savoia di incassare un importante
obiettivo politico: li rende preziosi e credibili alleati degli stati che
contano. Offre garanzie ai liberali - protestanti e massoni di tutto il mondo -
che sono intenzionati a fare sul serio. Che hanno davvero deciso di rompere con
la tradizione cattolica del proprio stato e della nazione cui quello stato
appartiene. I Savoia per amore di regno e quindi per furto - come scrive
D’Azeglio nei suoi ricordi - diventano fautori dell’ideologia massonica e della
religione protestante che apertamente combattono la cultura e la religione
nazionali. Grazie a questa scelta strategica che rende il Piemonte docile feudo
della cultura inglese, americana, tedesca, di parte del Belgio e dell’imperatore
Napoleone III, i Savoia godono dell’appoggio incondizionato dell’una o l’altra
di queste potenze e realizzano l’unità d’Italia sfruttando fino in fondo e con
grande spregiudicatezza l’unico elemento in proprio favore: la radicale
disomogeneità culturale e religiosa con il resto della penisola.
L’anima massonica del
regno sardo, e in particolare del Parlamento subalpino, viene mai apertamente
alla luce? No, perché l’associazione è pluri-scomunicata e perché il primo
articolo dello Statuto vincola i parlamentari all’ossequio della fede cattolica
definita religione di stato. L’11 novembre 1848, però, un brillante intervento
del deputato Cavallera rende palpabile la "fraternità" quasi come l’aria che si
respira. Si sta discutendo di sollevare le finanze dello stato, esauste per la
campagna militare, ricorrendo all’esproprio e alla vendita dei beni delle
corporazioni religiose. Contrario alla proposta Cavallera fa un discorso
brevissimo, allusivo, singolare e sintomatico insieme, che dopo un primo momento
di sconcerto suscita la generale ilarità. Ecco le poche battute del curioso
intervento. Gli ordini religiosi - osserva il deputato - sono nati in Italia
dove esistono da "più di dodici secoli". Bisogna dedurne che "necessariamente
corrispondono ad un bisogno reale della società (rumori) [chiosa degli Atti del
Parlamento subalpino]; e per conseguenza se si volessero abolire, altre se ne
dovrebbero sostituire; infatti i moderni che vollero abolire i frati, vi
sostituirono un’altra specie di frati: e cosa sono i circoli politici, se non
vere fraterie? (Sorpresa e scoppio generale di risa prolungate). Perciò posto
che non si sa stare senza frati, ai moderni preferisco gli antichi (Segue
ilarità e mormorio di voci diverse)".
PARLIAMO DI MASSONERIA
DEVIATA, MAFIA, SERVIZI SEGRETI E SETTE SATANICHE.
Carlo Palermo (Avellino
1947) è stato magistrato, avvocato, politico italiano, già sostituto procuratore
a Trento dal 1975 al 1984 e poi a Trapani fino al 1989. Entrato in Magistratura,
diventò noto al grande pubblico quando, a Trento, aprì un'indagine su un ampio
traffico di armi e droga che - per il tramite del finanziere Ferdinando Mach di
Palmstein - coinvolse il segretario del PSI, Bettino Craxi. Il sospetto fu che i
traffici illeciti avvenissero con l'appoggio di alcuni esponenti politici, in
cambio di finanziamenti illeciti. Oltre a Bettino Craxi, venne sfiorato dal
coinvolgimento nell'inchiesta pure il banchiere socialista (poi parlamentare di
Rifondazione Comunista e PDCI) Nerio Nesi. L'inchiesta si concluse con un nulla
di fatto e, dopo una fortissima reazione degli indagati e di Craxi in
particolare, culminata in una denuncia al CSM il magistrato fu trasferito nel
1985 a Trapani, dove le sue indagini si erano incrociate con il collega
Giangiacomo Ciaccio Montalto ucciso nel 1983, dove intendeva continuare a
indagare sui traffici di armi e droga. Nella città siciliana, dopo solo 50
giorni dal suo arrivo, la mafia reagì e tentò di ucciderlo con un'autobomba a
Pizzolungo, una frazione del trapanese. Il magistrato restò ferito, poiché al
momento dell'esplosione l'auto del magistrato stava superando una vettura su cui
si trovavano Barbara Rizzo e i suoi due piccoli gemelli Salvatore e Giuseppe
Asta, che morirono dilaniati, investiti in pieno dall'esplosione. Ma
l'attentato, visto il breve tempo, non fu solo una storia di mafia. Pochi mesi
dopo l'attentato Carlo Palermo si trasferì per qualche tempo a Roma al
ministero, poi lasciò la magistratura e intraprese l'avvocatura, oltre a
impegnarsi in politica. Per La Rete è stato dall'aprile 1992 deputato alla
Camera nel collegio Trento-Bolzano, fino a quando, nel novembre 1993 fu
dichiarato incompatibile.
L’inchiesta ‘armi e
droga’ condotta dal giudice Carlo Palermo che fornisce spunto all’articolo di
Luigi Cipriani riportato di seguito, finì come noto travolta dalle assoluzioni
generalizzate per tutti gli inquisiti, descritte in calce all’articolo con altre
brevi notizie e indicazioni bibliografiche per chi non avesse seguito la vicenda
sulla stampa.
Luigi Cipriani, Armi e
droga nell'inchiesta del giudice Palermo, in Democrazia proletaria maggio 1985.
Riportata sul sito della Fondazione Cipriani.
Il traffico di eroina
pura e morfina base scoperto dal giudice Carlo Palermo agli inizi del 1980,
proveniente dai luoghi di produzione in Turchia, arrivava in Italia passando
dall'Austria o dalla Jugoslavia. La droga veniva rilavorata in Italia e
distribuita in tutto l'Occidente dalla grande mafia siculo-statunitense. Molto
spesso la droga veniva scambiata con armamenti, in connessione con servizi
segreti, industrie belliche, finanzieri, partiti e governi. I capi della mafia
turca Abuzer Ugurlu e Bekir Celenk (entrambi padrini dell'attentatore del papa,
Ali Agca) dirigevano i loro traffici dalla capitale bulgara Sofia. Entrambi, per
poter agire in tranquillità, fungevano da informatori per i servizi segreti
dell'est e dell'ovest, erano cioè agenti doppi. Ciò spiega anche le molte
perplessità manifestate dalla Cia quando, in Italia, il giudice Martella si mise
a seguire la pista bulgara in merito all'attentato al papa. Al trasporto della
'merce' via terra provvedevano Karafa Mehmet Alì (con una dozzina di
autotrasportatori jugoslavi, raggiungeva le piazze di Trento, Verona e Milano) e
un dirigente della narcotici turca, su auto della polizia. Al trasporto via
mare, che raggiungeva gli Usa, provvedeva l'armatore Mehemet Cantas con la
società panamense Sutas.
Del trasporto di eroina
negli Usa via mare si occupava anche l'altro capomafia turco Cil Huseyn.
L'armatore Mehemet Cantas, per gestire meglio i propri traffici, si era
trasferito a Los Angeles, dove era in contatto con la mafia siciliana.
Interrogato dal giudice Palermo, dichiarò di avere venduto navi sia a Bekir
Celenk che al grande trafficante Henry Harsan. In Germania agiva il trafficante
d'armi turco Tegmen Herten, agente della Dea (agenzia antidroga Usa) residente a
Monaco di Baviera: trattava ogni tipo di armamenti in stretto rapporto coi
servizi tedeschi e la Nato.
In Germania veniva
anche riciclato il denaro sporco, Francesco Coll e Rodolfo Corti trasportavano
la valuta da Bolzano verso la Dresdmer Bank di Monaco di Baviera, il cui
direttore Kriske è stato arrestato. A Zurigo trafficava in armi, in collegamento
con agenti dei servizi italiani, il finanziere Hans Kunz, che fu tra gli
organizzatori dell'ultimo viaggio di Roberto Calvi. Nell'area mediorientale,
sotto la copertura della società svizzera Petrocom, trafficava il fratello del
presidente siriano, Hassad Rifaat, assieme ad alcuni agenti dei servizi siriani.
Trafficante di armi e di droga sull'asse Berlino-Varsavia era il turco-siriano
Derki Badi, anch'egli legato al trafficante milanese Arsan.
L'Italia centro del
traffico mondiale di armi e di droga.
Ma il vero centro del
traffico di armi e di droga è risultato essere il nostro Paese. Le richieste di
ogni tipo di armamenti, dalle pistole alle tecnologie nucleari, pervenivano da
ogni parte del mondo, assieme a grandissime quantità di eroina e di cocaina. Le
contrattazioni internazionali fra i trafficanti avvenivano in Bulgaria all'hotel
Giapponese di Sofia e all'hotel Marmara di Monaco di Baviera. Quel che
sorprende, infatti, è il numero delle società commerciali italiane che operano
con la Bulgaria, ben 776 contro le 800 che operano con l'intera Urss. La catena
di trafficanti italiani scoperta dal giudice Palermo inizia appunto dalla
frontiera est, da Bolzano. Nel giardino della villa di Herbert Hoberhofer,
terrorista, 'eroe' sudtirolese, in realtà informatore del servizio segreto della
nostra Guardia di finanza, sul finire del 1979, vennero ritrovati 130 chili di
eroina. Centro del traffico a Bolzano era l'hotel Grifone. L'Hoberhofer venne
arrestato insieme al giardiniere Meraner.
Già da allora
l'inchiesta di Palermo incontrò le prime, violente reazioni. La stampa locale e
le associazioni sudtirolesi fecero pressioni fin quando l'Hoberhofer venne
rimesso in libertà provvisoria dal tribunale di Trento. Successivamente
riarrestato dal giudice Palermo, Hoberhofer è stato condannato a diciotto anni.
Nella provincia di Verona, responsabile del traffico era Giorgio Malon,
anch'egli condannato a diciotto anni dal tribunale di Trento, presidente
Antonino Crea. Il vero capozona del traffico di armi e di droga era però Karl
Kofler di Trento. Il Kofler era collegato a Milano con i grandi trafficanti di
armi e con la grande mafia che, tramite Angelo Marai e Leonardo Crimi, portava
alla famiglia di Gerlando Alberti. Tramite Leonardo Crimi, legato alla mafia
trapanese, Kofler si incontrava all'hotel des Palmes di Palermo con Gerlando
Alberti. Va ricordato che all'hotel des Palmes venne portato Sindona dalle
famiglie Gambino, Inzerillo e Spatola, all'epoca del famoso rapimento del
finanziere della mafia, con lo scopo di fargli rivelare la lista dei
cinquecento. A quei tempi, in particolare con Totò Inzerillo, si incontrava
anche Francesco Pazienza, sempre al famoso hotel des Palmes. Kofler era quindi
un testimone importante, disposto a parlare molto e, puntualmente, venne
eliminato. Siamo al secondo episodio di attacco all'inchiesta Palermo: il 7
marzo 1981, nel carcere di Trento, benché sottoposto a sorveglianza stretta,
Karl Kolfer fu assassinato e mai venne scoperto l'assassino. Dal carcere di
Trento riuscì a fuggire un altro testimone del traffico, l'industriale turco
Nehiz Hasan, in realtà boss mafioso.
Tutte le vie portano a
Milano.
Karl Kofler fece al
giudice Palermo il nome di una società milanese, la Stibam che, caso strano,
aveva sede in una palazzina di proprietà del Banco ambrosiano di Calvi e nella
quale abitava anche il vicepresidente del Banco, Rosone. Perquisendo la sede
della Stibam, Palermo trovò montagne di ordini, offerte, richieste di armamenti
provenienti da tutto il mondo. Molte delle operazioni si avvalevano della
'consulenza' finanziaria dell'Ambrosiano. Socio maggioritario della Stibam era
un siriano residente da molti anni in Italia e, forse non casualmente, a Varese,
Henry Arsan. Altri soci erano Mario Cappiello, Giuseppe Alberti ed Edmondo
Pagnoni. Il siriano-milanese Arsan si rivelò essere uno dei maggiori trafficanti
d'armi del mondo in combutta, come vedremo, con agenti dei servizi segreti
italiani. A titolo di esempio, basti notare che in una ventina di trattative
vennero smerciati 116 carri armati e 20 elicotteri per la Somalia, 238 carri
armati per Taiwan, altri 10 elicotteri da combattimento antisom, missili Tow,
aerei C-130, missili Arpoon e relativi lanciatori, tre fregate della classe
Battista de Andrade, 100 carri Leopard, 50 elicotteri Elios, 30 carri Leopard
Mk-2, 60 cannoni 155/175, 10.000 proiettili C16, 60 elicotteri Bell Ah-16
residuati dal Vietnam e destinati al Kuwait, 100 motori per carri R-16, 33 chili
di plutonio e 1.000 chili di uranio. Arsan era anche un grande trafficante di
droga e disponeva di due navi, la Anika e la Golden sun, acquistate dalla
società panamense Sutas dell'armatore e trafficante turco Mehemet Cantas. Nel
solo 1981, Arsan fece arrivare a Milano 4.100 chili di eroina purissima,
sufficiente per oltre 100.000 dosi che, distribuita sul mercato, fruttò circa
400 miliardi. Eppure, nel 1981, la Criminalpol conosceva benissimo Henry Arsan:
era un agente della Dea, li aveva informati fin dal 1977 il responsabile
dell'agenzia antidroga Tom Angioletti, sia pure con cinque anni di ritardo, da
quando, nel 1972, era diventato loro informatore. A Milano, la Stibam di Arsan è
collegata ad alcune società di copertura di mafiosi turchi, come la Ital Orient
di Mohamed Nabir e la Wapa, gestita da due turchi, Salah Al Din e Pannikian
Onnik, che distribuiva eroina in Lombardia e in Calabria. Ma il collegamento più
interessante, come vedremo, è quello fra il turco Salah Aldin Wacekas ed Angelo
Marai, uomo di Gerlando Alberti, che ci condurrà alla grande mafia siciliana.
Altra società che operava nel traffico d'armi a Milano era la Comin di via
Canova i cui proprietari, Antonio De Mitri e il fratello, facevano la spola con
la Bulgaria, smerciando carri armati e missili di fabbricazione occidentale. In
Bulgaria, a trattare partite d'armi ben più consistenti, si recava anche, per
conto di Arsan, un noto armiere della Valtrompia (Brescia), Renato Gamba. Con
Renato Gamba, entra in scena una vecchia società, quotata alla borsa di Firenze
e Milano, la Broggi Izar, specializzata nella lavorazione di metalli preziosi.
Con l'ingresso di nuovi proprietari, la Broggi Izar realizzò un consistente
settore bellico, acquistando piccole industrie, tra le quali quella di Renato
Gamba. Dall'interrogatorio del presidente della Broggi Izar, Cesco della Zorza,
emerse che i capitali erano stati investiti dalla finanziaria Cepim, legata a
Vittorio Emanuele di Savoia, iscritto alla P2 e noto trafficante di armi.
Responsabile del settore armi della Broggi Izar era un americano, Reginald
Allas, introdotto sia al Pentagono che al Cremlino. Entrambi i dirigenti della
Izar furono fatti arrestare dal giudice Palermo: in sostanza, la Broggi Izar
fungeva da paravento per il traffico illegale di armi, coperto da autorizzazioni
ottenute per il commercio di armamento leggero. La società Broggi Izar appare
anche nella attività di investimento di uno dei quattro 'cavalieri' di Catania,
il Graci, assieme all'altro 'cavaliere', il Rendo, accusati di investire i
denari della mafia.
Entrano in campo i
servizi segreti.
Collegati al milanese
Arsan, vi erano altri trafficanti internazionali di armi, legati ai servizi
segreti: il giudice Palermo li fece arrestare e cominciò a ricevere telefonate
minacciose. Essi erano:
-GLAUCO PARTEL: ex
ufficiale di Marina, grande esperto in missilistica, direttore di un centro di
ricerca privata di Roma. Il Partel era agente del Nsa (National security agency)
statunitense; contemporaneamente, egli lavorava per il ministero della Difesa a
Roma, come direttore del Centro studi trasporti missilistici. Lo stesso Partel,
nella sua duplice funzione di trafficante d'armi planetario ed agente dei
servizi, era in grado di fornire notizie interessanti sulla funzione degli
eserciti, in particolare nei Pvs. Ad esempio, durante la guerra delle Falkland,
per conto dei servizi segreti britannici e tramite la P2, contattò il
maresciallo di vascello argentino Alfredo Corti, iscritto alla P2, per offrirgli
dei missili Exocet che non furono mai trovati, facendo perdere tempo agli
argentini.
-MASSIMO PUGLIESE:
monarchico, massone P2, agente del Sifar e del Sid, andato in pensione, ma
rimasto collegato al generale Santovito capo del Sismi, a sua volta massone P2.
Uscito dal Sid, andò a fare il consulente per alcune ditte nazionali produttrici
di armi. Pugliese gestiva il traffico internazionale di armi per mano di due
società, la Horus e la Promec, in quanto monarchico era in rapporti stretti con
Vittorio Emanuele di Savoia. Tramite l'attore Rossano Brazzi, massone a sua
volta, Pugliese ebbe la possibilità di mandare messaggi al presidente Reagan, ad
esempio per favorire le concessioni di crediti alla Somalia, necessari per
l'acquisto di armi. Il Pugliese, assieme al bresciano Rolando Pelizza, fondò la
società lussemburghese Transpresa per la vendita del 'raggio della morte'.
Tramite i servizi italiani, il 'raggio della morte' venne proposto al governo
italiano: il Pugliese si incontrò con Andreotti, Piccoli, Loris Fortuna. A
quanto pare, i politici si convinsero di avere messo le mani sulla superarma,
visto che interessarono il governo Usa, il quale organizzò un esperimento, del
cui esito si sono perse le tracce. Il giudice Palermo sottopose a lunghi
interrogatori i politici citati dal Pugliese, attirandosi altre maledizioni. Tra
le carte di Massimo Pugliese, venne ritrovato un dettagliato dossier sulle
attività del giudice Palermo. Fin dall'inizio, l'inchiesta era seguita con molta
attenzione da parte dei servizi segreti.
-ROSSANO BRAZZI: ex
attore, amico personale di Reagan, massone, in contatto col mafioso Robert
Vesco, voleva fondare su un'isola deserta la 'nuova Aragona', occasione di
investimento del denaro frutto del traffico d'armi. Il Brazzi è anche indicato
come personaggio legato alla Oto Melara.
-CARLO BERTONCINI:
proprietario della Seric di Pomezia, specializzata in strumentazione elettronica
per l'esercito, agente del Sismi dal 1970, quando venne scoperto che spediva
materiale elettronico ai paesi dell'est.
-ENZO GIOVANNELLI: (ex
partigiano nella brigata Osoppo Friuli) fornitore della base Usa della
Maddalena in Sardegna. Il Giovannelli apre la serie degli spedizionieri (operava
a Olbia) legati al traffico di armi con la copertura del Sismi di Santovito. Un
dossier della Guardia di finanza indicò il Giovannelli, con suo cognato
Sebastiano Sanna, ex contrammiraglio, ed altri, implicati in un traffico d'armi
favorito dalla Nato (comprendente 43 caccia F-101, 10 aerei scuola Tf-104 G,
quattro fregate ed alcuni simulatori di volo) in combutta con Flavio Carboni e
Francesco Pazienza.
-MAURIZIO BRUNI:
massone P2, operava come spedizioniere a Livorno. Di lui si serviva il
trafficante Arsan per spedire armi e droga in tutto il mondo. E' stato inquisito
anche dal giudice fiorentino Pierluigi Vigna.
-ALESSANDRO DEL BENE:
cassiere della P2 in Toscana, grande elettore del Psi, legato al ministro della
Difesa Lagorio e spedizioniere anch'egli a Livorno. Tra l'altro, il Del Bene è
stato coinvolto in un traffico di congegni di puntamento segreti della Nato che,
prodotti dalle officine Galileo finivano, tramite Gelli, alla Romania.
-ANGELO DE FEO: agente
Sid dell'ufficio Ris, competente per la concessione del benestare di fattibilità
per la vendita di armi italiane. Interrogato dal giudice Palermo, ha affermato
che tutto il traffico di armi è controllato dai servizi segreti. Ad esempio, ha
affermato De Feo, i ricognitori Usa scoprirono 4 carri Leopard nel deserto
libico: erano stati venduti dall'Italia, con autorizzazione del contrammiraglio
Martini del Sismi. Il trasporto fu controllato dal colonnello D'Agostini del
Sismi, iscritto alla P2. De Feo ha denunciato anche la vendita proibita di
ingenti quantità di armi (anche navi) al Sudafrica, di 300 aerei Siai Marchetti
e Aermacchi alla Libia e centinaia di missili venduti alla Mauritania,
trasportati sul posto da un aereo della Cia decollato da Ciampino militare.
Sulla base di tutte queste deposizioni, il giudice Palermo chiese
l'incriminazione del capo del Sismi generale Santovito, iscritto alla P2, a sua
volta accusato dal giudice Sica insieme al colonnello Giovannone, agente del
Sismi in Libano, iscritto alla P2 e cavaliere di Malta, per avere dichiarato il
falso sulla scomparsa dei giornalisti Toni e Di Palo. I due giornalisti,
recatisi in Libano per seguire le tracce di un traffico d'armi e droga,
scomparvero nel nulla.
Come abbiamo visto, la
società Stibam di Milano e il suo proprietario Arsan erano al centro di un
vastissimo traffico di armi e droga. Per questo motivo l'Arsan, molto
opportunamente, morì nel carcere di san Vittore a Milano nel novembre 1983: per
arresto cardiaco, questa fu la diagnosi.
C'era anche Gheddafi.
Il 29 gennaio 1985, su
mandato del giudice Palermo, è stato arrestato Gabriel Tannouri, finanziere
libico intimo di Gheddafi e di Nixon. Tannouri venne chiamato in causa per un
contratto di fornitura di materiale fissile ed attrezzature per confezionare
piccole bombe atomiche, messi in vendita da due sudamericani, Diego Arias e
Helio Guerrero. Sembra una favola, ma il giudice Palermo sforna pacchi di
documenti autentici: il contratto venne firmato a Ginevra da Tannouri e Mared
Pharaon, fratello del saudita trafficante internazionale Gait Pharaon. Il
Pharaon avrebbe dovuto fornire parte dei finanziamenti per un contratto che si
prospettava da un miliardo e duecentomila dollari nel 1980. In garanzia del
finanziamento, 1l 23 dicembre 1980, a Lugano, di fronte al notaio Alida
Andreoli, il Tannouri depositò ben 203.785 azioni da 4.000 lire e 203.478 azioni
da 3.000 lire delle Assicurazioni generali. Una quota elevatissima che solo i
maggiori azionisti come Mediobanca, Euralux, la Banca d'Italia, il servizio
Italia della Bnl e la Comit erano in grado di esibire. Le azioni nel 1978 erano
intestate alla società Claus Fin di Milano, sciolta nel 1984 e all'epoca del
contratto vennero depositate dalla filiale svizzera della banca Lambert di
Bruxelles. Dagli atti presso il notaio Andreoli di Lugano risultò che a
depositare le azioni presso la banca Lambert furono gli italiani Achille Caproni
e Flavio Briatore. Ad un certo punto il Pharaon, che ha cominciato a versare
accrediti per mezzo della banca Morgan di Ginevra, prelevandoli dal Credito
svizzero di Ginevra e Parigi, chiede a Tannouri maggiori garanzie. Entrano in
campo i trafficanti italiani, Capogrossi, lo spedizioniere Giovannelli e
l'agente della Nsa Glauco Partel. Con Partel entra in campo anche la Cia tramite
l'agente australiano Eugene Bartolomeus, coinvolto nel fallimento della banca
della Cia, la Nugan hand bank, trafficante d'armi legato alla mafia Usa ed
australiana. Di fronte alla possibilità che le bombe finissero ai libici o ai
siriani, il trasportatore e agente del Sismi Giovannelli ebbe dei problemi di
coscienza ed avvertì il console d'Israele a Milano. La trattativa finì nel
nulla, probabilmente si trattò di un colossale 'pacco' giocato dalla Cia alla
Libia. Fatto sta che Tannouri risultò disporre proprio di un conto da 1.200.000
dollari presso la società Rexine Sa certificata dalla Deutsche bank. Molti telex
rivelarono altresì contatti con altri clienti presso la Trade developement bank
del Lussemburgo, spesso citata nel traffico d'armi internazionale. Molto
probabilmente, giocato il 'pacco' alla Libia, la Cia dirottò il materiale
fissile verso clienti più affidabili.
Da Milano alla Sicilia.
Come abbiamo visto, il
duo dei trafficanti milanesi Arsan e Partel era collegato alla mafia turca
tramite Salah Aldin Wacekas e a quella siciliana tramite Angelo Marai, entrambi
operanti a Milano. A sua volta, Marai era collegato a Leonardo Crimi e alla
grande mafia siciliana tramite Gerlando Alberti. Quest'ultimo lavorava l'eroina
nei laboratori siciliani e la spediva negli Usa e ai marsigliesi incaricati di
rifornire i mercati del Nordeuropa. Assieme all'Alberti, il giudice Palermo
rinviò a giudizio i mafiosi Matteo Bricola, Rosario d'Agostino e Nicolò Puccio.
Gerlando Alberti porta alle grandi famiglie mafiose siculo-statunitensi dei
Gambino, degli Inzerillo e degli Spatola, i padrini di Sindona. La filiale
trapanese delle grandi famiglie palermitane è rappresentata dai clan di Minore,
Evola, Bonanno, Magaddino, originari di Trapani. Trapani è stata definita la
'Svizzera della mafia' perché, pur avendo un'economia molto debole, in essa
affluisce il 40% dei depositi bancari di tutta la Sicilia. A Trapani sono
presenti sei banche di interesse regionale, 28 banche provinciali ed un
centinaio di casse rurali. Inutile aggiungere che gli amministratori delle
banche sono tutti uomini della Dc. I Bonanno, originari di Castellammare del
Golfo (Trapani) da molti anni si sono trasferiti negli Usa, entrando a fare
parte delle grandi famiglie mafiose. Il giudice Ciaccio Montalto, prima di
essere ucciso dalla mafia, aveva scoperto un colossale traffico di droga e di
armi che, partendo da Trapani, raggiungeva il Nordafrica e gli Usa. Fiduciari
del traffico per conto dei Bonanno erano i fratelli Di Chiara, originari di
Castellammare del Golfo: Lorenzo operava negli Usa e Antonio in Sicilia, a
Mazara del Vallo. I fratelli Di Chiara erano collegati al clan dei Minore di
Trapani: ancora una volta, il cerchio delle inchieste dei giudici Palermo e
Montalto si chiude intorno ai medesimi personaggi. Gli stessi nomi si
riscontrano in attività di riciclaggio del denaro sporco: Leonardo Crimi,
trafficante di armi e droga in società con il clan dei Minore e con i cavalieri
del lavoro catanesi Rendo e Costanzo, eseguirono lavori nel Belice terremotato e
nel trapanese. Cominciarono ad emergere anche nomi di insospettabili. Il giudice
Palermo, indagando su un grosso traffico d'armi in partenza per l'Africa, si
imbattè nella società Coprofin, controllata dal Psi e gestita dal finanziere
Ferdinando Mach di Palmenstein, la quale stava trattando la vendita illegale di
aerei da combattimento al Mozambico. Nello stesso tempo, dal porto di Livorno
era in partenza una nave ufficialmente carica di liofilizzati destinati al
Mozambico. Ad organizzare la spedizione era la medesima società di Ferdinando
Mach, mentre i liofilizzati erano di proprietà di una ditta del cav. Mario Rendo
di Catania. Fatto strano, ma è successo che appena il giudice Palermo ha
cominciato a indagare sulle attività del finanziere del Psi Ferdinando Mach, il
trasporto degli innocui liofilizzati per il Mozambico è stato annullato. Il nome
di Mario Rendo è comparso anche nella truffa dei petroli come uno dei padrini
del comandante della Guardia di finanza, il generale Raffaele Giudice (P2) e nel
traffico di armi e petrolio con la Libia, emerso dal fascicolo segreto del Sid,
il famoso Mi.Fo.Biali.
C'erano anche Pazienza
e Carboni.
Francesco Pazienza
iniziò il suo viaggio nei servizi segreti occidentali a partire dallo Sdece
francese, passò alla Nato e al Dipartimento di Stato Usa quando il suo capo,
Alexander Haig, divenne segretario di Stato di Reagan, per arrivare al Sismi del
generale Santovito (P2). Fin dal 1978, il Pazienza trafficava in armi con la
copertura dei servizi segreti, avvalendosi di una società lussemburghese, la Se.
Debra, assieme a Nico Schaffer, ex amministraore della Fasco di Sindona e al
grande trafficante arabo Kashoggi. Un rapporto del Sisde segnalò un incontro
all'hotel de Paris di Montecarlo tra Francesco Pazienza e il trafficante d'armi
Trapolus, il mafioso Francesco Gallo, l'ex magistrato genovese Giorgio Righetti
e Licio Gelli. In qualità di amministratore dei beni della famiglia dell'ex scià
di Persia, Pazienza era introdotto nelle grandi banche Usa che riciclano il
denaro della mafia. Pazienza era amico di Totò Inzerillo, ucciso nel 1981, ed
era in contatto con le grandi famiglie della mafia Usa: i Gambino, gli
Inzerillo, gli Spatola, i Bonanno ecc. Quando costoro, nel 1979, organizzarono
il finto rapimento di Sindona, il Pazienza fece numerosissimi viaggi in aereo
verso Palermo e Catania, utilizzando i mezzi messi a disposizione dalla Cai del
Sismi e quelli dell'Ata del mafioso milanese Carmelo Gaeta. Il super-agente si
incontrava con Totò Inzerillo, probabilmente per conoscere a che punto erano le
trattative per la famosa lista dei cinquecento. Sui medesimi aerei viaggiava un
altro personaggio molto noto a Pazienza, don Masino Buscetta. Pazienza era
legato al malavitoso romano Domenico Balducci, ucciso il 16 ottobre 1981,
terminale della mafia palermitano-calabrese nella capitale, legato al cassiere
della mafia Pippò Calò, arrestato recentemente. Pippo Calò investiva il denaro
della mafia per mezzo del costruttore romano Danilo Sbarra in Sardegna, nelle
numerose società immobiliari facenti capo alla Sofint di Flavio Carboni, legato
quest'ultimo alla Dc (Roich, De Mita) e all'Opus dei, socio dell'editore
dell'Espresso, organizzatore con Pazienza dell'ultimo viaggio di Roberto Calvi.
Carboni era collegato al trasportatore e trafficante d'armi di Olbia, Enzo
Giovannelli, che a sua volta riconduce ai grandi trafficanti Glauco Partel ed
Henry Arsan di Milano.
I quattro
dell'apocalisse in Sudamerica.
I quattro
dell'apocalisse - Gelli, Ortolani, Marcinkus, Calvi - si affacciarono per far
affari nel continente sudamericano quando questo era in preda ad una crisi
disastrosa, con tassi di inflazione del 200%. Ma gli affari che essi trattavano
non conoscono crisi, attraverso la P2 erano in contatto con i dittatori militari
e civili del continente, notoriamente anche grandi trafficanti di armi e droga.
Obiettivo dei quattro non era solo quello di fare affari, ma di sostenere regimi
autoritari ferocemente antimarxisti sui quali puntano sia il presidente degli
Usa che il Vaticano, impegnato in una 'nobile' battaglia contro la teologia
della liberazione. Il 1 gennaio 1980, a Buenos Aires in Argentina, Roberto Calvi
inaugurò la nuova sede del Banco ambrosiano de America del Sud. Nel medesimo
palazzo verranno installati gli uffici del generale Massera (P2) e di Videla.
Gelli e Ortolani, attraverso i loro rapporti coi gerarchi fascisti fuggiti in
Argentina, erano da molti anni in rapporti di amicizia con Peron e con il capo
degli squadroni della morte, Lopez Rega; lo stesso Gelli era incaricato d'affari
argentino in Italia. Il generale Massera era un grande trafficante d'armi ed era
in contatto con l'ammiraglio Torrisi (P2) in Italia. Grazie alla mediazione di
Massera, buona parte dei 6.000 miliardi di armamenti spesi dal generale Videla,
dal 1976 in avanti, sono affluiti alle industrie italiane. Ortolani aveva
preceduto Calvi in Sudamerica con il proprio Banco financiero di Montevideo in
Uruguay, divenuto insufficiente alla bisogna: si rendeva necessaria la rapida
espansione dell'Ambrosiano, con le garanzie dello Ior del Vaticano. La prima
banca ad installarsi fu la Cisalpina Overseas bank delle Bahamas, trasformata in
Banco ambrosiano Overseas, seguita dalla Ultrafin di New York, Il Banco
ambrosiano andino a Lima in Perù, l'Ambrosiano representacao y servicios in
Brasile, l'Ambrosiano group banco commercial di Managua in Nicaragua,
l'Ambrosiano group promotion a Panama. In Cile, l'Ambrosiano partecipava al più
grande gruppo finanziario sostenitore di Pinochet, il Banco hypotecario, detto
'Piranas' dagli esuli cileni. Il Banco ambrosiano ha finanziato, nel 1976, la
vendita di 6 fregate da parte del Cnr della Fincantieri alla Marina del
Venezuela, di corvette all'Equador, di 4 fregate Lupo al Perù nonché di numerosi
elicotteri Agusta, mentre i piduisti installati all'Ufficio italiano cambi e
alla Sace concedevano autorizzazioni e crediti. In Guatemala, l'Ambrosiano
finanziò il governo di destra del generale Vernon, ex agente Cia, legato al
Dipartimento esteri Usa di Alexander Haig, attraverso la società Brisa, fondata
per lo sfruttamento delle risorse minerarie del Paese. Nel 1978 il dittatore del
Nicaragua, Somoza, era in forte crisi sotto la pressione della rivoluzione
sandinista. A partire da quella data il Banco ambrosiano, per mezzo della
propria filiale di Managua, trasferì centinaia di milioni di dollari nel Paese.
Da un'altra banca del Sudamerica dell'Ambrosiano, il Banco andino di Lima, sono
passate molte delle operazioni di traffico d'armi e di petrolio con Cile,
Nicaragua, Argentina, Brasile, Nigeria ed i traffici con la Tradeinvest
dell'Eni, fino al finanziamento di 21 milioni di dollari concesso al Psi.
Esaminando i conti dell'Andino, alla fine del 1981, gli ispettori della Banca
d'Italia scoprirono un 'buco' da 1.000 miliardi, inizio della fine di Calvi. Nel
medesimo periodo, anche il gruppo Rizzoli ebbe una grande espansione editoriale
in Sudamerica, mentre il Corriere della Sera in Italia pubblicava le interviste
di Roberto Gervaso (P2) a Videla e Somoza e censurava gli articoli sui
desparecidos del corrispondente dall'Argentina. Giova solo ricordare che il duo
Massera-Videla viene processato in Argentina, accusato di aver organizzato
centri di tortura in tutto il Paese e di aver assassinato trentamila oppositori,
bambini compresi.
Il caso Psi-Argentina.
Durante la
perquisizione degli uffici di uno dei trafficanti d'armi, tale Michele Jasparro,
arrestato il 16 giugno 1983, titolare di una fabbrica di giubbotti
antiproiettile legato all'Agusta, il giudice Palermo venne in possesso di una
lettera proveniente dall'Argentina. A scriverla era Gaio Gradenigo,
amministratore della Comte srl di Buenos Aires. Il Gradenigo informava Jasparro
che "Bettino Craxi è furibondo per il fallimento delle trattative per la
costruzione della metropolitana di Buenos Aires" e parlava dell'interesse del
Psi per la costruzione della fabbrica di elicotteri che l'Agusta avrebbe dovuto
realizzare in Argentina, dopo la sconfitta nella guerra delle Falkland.
Sull'interesse del Psi nelle due operazioni esistono riscontri obiettivi: la
metropolitana milanese (il cui presidente Natali, padrino del giovane Craxi nel
Psi, è attualmente in carcere per tangenti) realizzò lo studio di progetti per
il metrò di Buenos Aires. Per la realizzazione del metrò erano in gara la Fiat,
l'Ansaldo e la Breda, ma il generale Gualtieri preferì destinare i fondi al
potenziamento degli armamenti e alle autostrade, facendo arrabbiare Craxi. Per
quanto riguarda la fabbrica di elicotteri Agusta, che fa capo all'Efim,
presidente Fiaccavento di area Psdi, nel 1983 subì l'offensiva del ministro
delle Pp.Ss. De Michelis. Il Psi nell'Agusta aveva già un'importante pedina,
l'amministratore delegato Raffaele Teti, ma De Michelis propose di portare
l'Agusta sotto il controllo dell'Iri, liquidando la quota rimasta al vecchio
proprietario, il conte Agusta, scaricando contemporaneamente i debiti della
società sull'Iri. Per l'acquisizione della quota del conte Agusta (20%), il Psi
aveva già un'acquirente di fiducia, tale Pietro Fascione, al prezzo di 80
miliardi. In poche parole il Psi, per via pubblica e privata, puntò al controllo
totale dell'Agusta, proprio nel periodo in cui si prospettava la costruzione
della società di elicotteri in Argentina. Ma vi è di più. Durante la guerra
delle Falkland una delegazione di maggiorenti argentini, guidata dal segretario
del partito socialista argentino, Pasquale Ammirati, si incontrò con Craxi per
ottenere la revoca dell'embargo posto dal presidente del Consiglio Spadolini e
dal ministro degli Esteri Colombo. Cosa che puntualmente avvenne, con il
sostegno di Psi e Pci. Della delegazione che incontrò Craxi facevano parte anche
i fratelli Macrì, i maggiori industriali argentini, rappresentanti degli
interessi della Fiat. I Macrì sono due fratelli, Antonio e Franco, sono accusati
di aver messo sul tappeto la questione della fabbrica di elicotteri e di
traffico illegale di armi. I Macrì controllano con la loro holding oltre 50
imprese, hanno acquisito il controllo della filiale Fiat argentina in forte
perdita. Durante il periodo delle dittature militari hanno costruito strade ed
autostrade, hanno l'appalto per la pulizia di Buenos Aires e rappresentano la
Techint (Fiat). I Macrì erano strettamente legati ai militari P2 dell'Argentina,
Massera e Mason, e sono imparentati con uno dei dirigenti del peronismo, Carlos
Grosso. Un documento dei servizi segreti inglesi accusò i fratelli Macrì di aver
cercato in Italia l'appoggio per l'acquisto di missili Exocet, formalmente
destinati al Perù, durante il periodo dell'embargo posto dalla Francia. La
delegazione argentina, prima di incontrare Craxi, fece tappa a Zurigo, dove
operava il trafficante Hans Kunz, in contatto con Roberto Calvi durante il suo
ultimo viaggio nel giugno 1982. Nello stesso frangente le banche argentine, tra
le quali l'Ambrosiano, trasferirono grossi capitali nelle loro filiali svizzere.
Il governo argentino era disposto a pagare per un missile più di 2 milioni di
dollari, contro i 700.000 dollari normalmente richiesti sul mercato ufficiale.
Il periodo della trattativa sugli Exocet coincise con il viaggio di Calvi il
quale, prima di approdare a Zurigo, venne portato da Pazienza a Carboni in
Austria, a Klagenfurt, dove operava il trafficante d'armi Sergio Vatta,
inquisito dal giudice Palermo. Il Vatta era in contatto con il trafficante e
agente del Nsa Glauco Partel, il quale da un lato attirò gli argentini in una
trattativa fasulla (per gli Exocet) e contemporaneamente informò i servizi
segreti inglesi. Molto probabilmente, una delle cause della morte di Roberto
Calvi sta nel ruolo svolto dall'Ambrosiano e dalla P2 in appoggio all'Argentina
durante la guerra delle Falkland. Dobbiamo ricordare che i servizi segreti
britannici sono strettamente legati alla massoneria inglese della quale Calvi,
molto probabilmente, faceva parte, perché esistono fotografie che lo ritraggono
a fianco della regina Elisabetta, notoriamente gran patronesse della massoneria.
Del resto, il ritrovamento nelle tasche della giacca e sui genitali del cadavere
di Calvi di alcuni mattoni (oltre al nome del ponte Frati neri) nel simbolismo
massonico starebbe a indicare tradimento. Tornando al caso Argentina-Psi, sulla
base degli elementi emersi, il pubblico ministero di Trento, Enrico Cavaliere,
avrebbe voluto emettere subito mandati di comparizione e convocare Bettino Craxi
come testimone. Il giudice istruttore Palermo lo convinse a pazientare,
chiedendo di poter approfondire le indagini e interrogando l'ex addetto stampa
di Craxi, il piduista Vanni Nisticò, ed un personaggio introdotto nell'industria
bellica, Giancarlo Elia Valori. Elia Valori, amico personale di Peron,
contendeva a Gelli il controllo della P2 in Argentina e per questo ne fu
espulso. In Italia Elia Valori è legato agli ambienti della Dc nelle Pp.Ss., è
stato vicepresidente della Italstrade, attualmente forlaniano legato al
cardinale Palazzini dell'Opus dei e agli ambienti golpisti della Fiat (Chiusano
e Scassellati). Dopo essere stato ad indagare in Argentina, il giudice Palermo
tornò in Italia con un nome: Ferdinando Mach di Palmenstein, amministratore di
alcune società facenti capo al Psi, già comparso nel caso Eni-Petromin. Le
società sono: la Sofinim, al 99% del Psi, fondata nel 1976 da Nerio Nesi,
presidente della Bnl; Vincenzo Balsamo e Rino Formica, tutti del Psi; la
Coprofin, con sedi a Bucarest e Maputo in Mozambico; la Promit, con sede a Roma.
Il Mach è anche presidente di una società di Firenze, la Promec, specializzata
nella acquisizione di appalti e forniture pubbliche.
Ferdinando Mach, nelle
sue molteplici attività e traffici, era in stretto rapporto con Francesco
Pazienza (esistono numerose registrazioni telefoniche) e fu per suo tramite che
Pazienza si incontrò più volte con Bettino Craxi, con Michael Leeden, spione e
provocatore della Cia, organizzatore con lo stesso Pazienza, assieme ai servizi
libici, del Billygate che assestò un duro colpo al presidente Carter, favorendo
l'elezione di Reagan nel 1981.
Il caso Psi-Somalia.
I rapporti del Psi con
la Somalia di Siad Barre sono molto stretti; lo stesso cognato di Craxi,
Pillitteri, è console onorario di Somalia a Milano. Famoso, nei rapporti
Psi-Somalia, è stato il caso del piano regolatore di Mogadiscio. Nel 1975,
l'ingegner Luciano Ravaglia, con il patrocinio della regione Lombardia, iniziò a
interessarsi del piano regolatore di Mogadiscio. Nel 1978, il Ravaglia si
incontrò con Siad Barre ed ottenne l'avvallo alla prosecuzione dello studio. Il
5 agosto 1981, il progetto Ravaglia venne inserito negli accordi firmati a
Mogadiscio dal ministro degli Esteri, Colombo, entrando così nella fase
operativa. Improvvisamente, l'11 novembre 1981, il sottosegretario agli Esteri
Roberto Palleschi del Psi avocò a sé con effetto immediato il carteggio del
piano, che venne sospeso. Nel marzo 1982, il progettista Ravaglia ricevette una
comunicazione dal sottosegretario Palleschi, nella quale si affermava che
"d'accordo col ministro somalo Habib, il piano regolatore di Mogadiscio è stato
affidato all'architetto Portoghesi" del Psi. Ma le attività di mediazione nel
territorio africano da parte delle società facenti capo al Psi sono
numerosissime: oltre al piano regolatore, esse hanno trattato la costruzione di
dighe, impianti siderurgici, allevamenti di bestiame, impianti per surgelati
ecc. Tutto ciò sempre in rapporto con le industrie pubbliche, le banche dell'Iri
e col ministro degli Esteri. Ferdinando Mach si interessò anche della vendita di
aerei da guerra e da trasporto G-222 al Mozambico, riuscendo strumentalmente a
fare sì che il presidente Pertini si incontrasse con la delegazione degli
acquirenti. Il Mach è accusato di avere venduto aerei G-222 alla Nigeria, un
affare da 170 miliardi per il quale ottenne una tangente del 20%. Allo scopo di
agevolare i propri traffici, lo stesso Mach scrisse al Psi per ottenere che
all'Ufficio italiano cambi venisse nominato un uomo fidato, carica che venne
ricoperta da uomini della P2. L'occasione dell'affare più ghiotto venne offerta,
come sempre, dalla Somalia che aveva ottenuto un finanziamento Usa per
l'acquisto di 116 carri H18-A5 e 20 elicotteri Cobra HgS con 1.000 missili Tow
per un totale di 600 miliardi nel 1982. Non potendo esporsi direttamente, gli
Usa attivarono il canale della Cia e del Sismi, vale a dire Santovito, Pugliese
e Partel. Il 17 ottobre 1982 avrebbe dovuto essere firmato il contratto a
Mogadiscio, contemporaneamente nella città era presente una delegazione del Psi,
guidata da Pillitteri e comprendente Ferdinando Mach. Occasionalmente, nello
stesso giorno, era in visita in Somalia il ministro della Difesa, il Psi
Lagorio. Sfortunatamente, tutto andò in fumo perché il giudice Palermo, con
mandato di cattura, aveva provveduto ad arrestare i trafficanti Partel e
Pugliese. A questo punto, il giudice decise di rompere gli indugi, accusando
Ferdinando Mach di associazione per delinquere al fine di traffico di armi e,
contemporaneamente, il segretario del Psi di violazione dell'art.7 della legge
sul finanziamento pubblico dei partiti. Nel mandato di perquisizione a carico
della società Sofinim, Palermo commise però l'errore di citare i nomi di Craxi e
Pillitteri senza avere ottenuto l'autorizzazione a procedere dal Parlamento e
dalla Commissione inquirente. Avvertito tempestivamente, Bettino Craxi scrisse
su carta intestata il famoso telex al Procuratore capo Tamburrino, il quale
bloccò la perquisizione (che non verrà mai più effettuata) e diede inizio al
provvedimento disciplinare nei confronti di Carlo Palermo.
Intimidazioni, suicidi,
fughe, provocazioni, errori, avocazioni e repressione.
Sin dall'inizio della
sua inchiesta, il giudice Palermo ricevette intimidazioni e minacce, sicché gli
dovettero raddoppiare la scorta. Altri fatti intervennero per disinnescare la
portata dell'inchiesta internazionale su armi e droga. Karl Kofler, uno dei
testimoni chiave, benché in carcere isolato, venne trovato 'suicidato': gli
avevano infilato uno spillone nel cuore e tagliato la gola. Altri imputati,
testi, riuscirono misteriosamente ad evadere dal carcere mentre il principale
imputato, l'agente della Dea Henry Arsan, morì per arresto cardiaco nel carcere
di san Vittore. Vi è poi il caso degli avvocati Roberto Ruggiero e Bonifacio
Giudiceandrea, figlio del Procuratore della repubblica di Bolzano, entrambi
difensori del trafficante Giovannelli di Olbia. L'avvocato Ruggiero che, da
intercettazioni telefoniche, risulta essere conoscente di Bettino Craxi, è stato
accusato da Palermo di traffico d'armi e indicato come collaboratore del libico
Tannouri, al pari del commercialista Arnaldo Capogrossi, legato a sua volta al
trasportatore Giovannelli. Nel giugno del 1983, durante un interrogatorio da
parte di Palermo del Giovannelli, l'avvocato di questi, Ruggiero, interruppe
continuamente il giudice, il quale commise l'errore di perdere le staffe,
accusando l'avvocato di condurre in modo disonesto la professione. L'avvocato
Ruggiero fece verbalizzare il tutto e lo trasmise al Procuratore generale della
Cassazione Tamburrino. Due mesi più tardi, i carabinieri fecero avere al giudice
Palermo il testo dell'intercettazione di una telefonata tra gli avvocati
Ruggiero e Giudiceandrea, dalla quale erano ravvisabili i reati di
favoreggiamento e divulgazione di segreti d'ufficio. Il giudice Palermo fece
arrestare i due avvocati, scatenando la reazione dei colleghi romani che scesero
in sciopero.
Stranamente e solo dopo
gli arresti, i carabinieri si accorsero di aver commesso un errore nella
trascrizione della registrazione, nel senso che, laddove l'avvocato
Giudiceandrea affermava "ho preso il fascicolo", si doveva intendere "ho appreso
dal fascicolo". Un errore molto opportuno. Il giudice Palermo venne sommerso da
un'ondata di critiche, screditandosi il valore di tutta l'inchiesta su armi e
droga.
Il 1 maggio 1983, il
giudice istruttore di Trento prosciolse Ruggiero e Giudiceandrea dai reati di
favoreggiamento e corruzione e il 24 ottobre il pretore Vettorasio dichiarò non
doversi procedere contro i due per rivelazione di segreti d'ufficio. Il 15
novembre l'avvocato Giudiceandrea inviò un esposto al Tribunale di Trento contro
Palermo per "avere effettuato intercettazioni non autorizzate e per non aver
informato il Pm e il Procuratore generale sui cambiamenti avvenuti
nell'inchiesta". Il 13 gennaio 1984, sulla base della denuncia di Giudiceandrea,
il giudice Palermo venne indiziato di interesse privato dal Procuratore della
repubblica di Venezia. Di fronte a tanti attacchi, i magistrati di Trento
scesero in campo rendendo pubblico un documento di solidarietà nei confronti di
Palermo. Gli avvocati di Gerlando Alberti, sfruttando la situazione, chiesero la
ricusazione del tribunale di Trento, che venne accordata. In questo modo, tutto
il filone mafia dell'inchiesta Palermo venne stralciata e trasferita al
tribunale di Brescia, dove tuttora giace dal 17 giugno 1984. Un altro imputato,
la spia della Guardia di finanza Oberhofer, chiese ed ottenne la ricusazione del
tribunale di Trento dal Procuratore generale Capriotti che già l'aveva negata
nel 1981. Dopo il Procuratore generale Tamburrino, scese in campo anche il
ministro Martinazzoli, il quale avviò un'inchiesta disciplinare nei confronti
dei giudici trentini, investendo anche il Csm. Da quando, con la sua inchiesta,
il giudice Palermo aveva chiamato in causa i massimi livelli politici del Psi,
gli sono piovuti addosso attacchi di ogni genere e il suo lavoro venne smembrato
in mille rivoli. Nel giugno 1984, Palermo chiese di lasciare l'inchiesta armi e
droga. In suo appoggio intervenne il presidente del Tribunale di Trento, Rocco
La Torre. Il presidente del Tribunale dichiarò: "Ci sono state velenose e
virulente reazioni determinate dal processo a causa dei sudici, sotterranei,
colossali interessi colpiti. Contro la persona di Palermo ci sono stati molesti,
incessanti e frustranti attacchi".
Lo stesso Palermo
denunciò che, da quando aveva imboccato la pista politica, erano stati riesumati
provvedimenti già dati per archiviati. Nel giugno 1984, di fronte al magistrato
di Venezia che lo interrogava, Palermo affermò: "Non pare fuori luogo notare fin
d'ora che le più pesanti accuse mosse nei miei confronti da parte di avvocati,
imputati e politici sono seguite al sequestro di documenti operato il 16 giugno
1983, in cui compariva, per la prima volta, il nome dell'onorevole Craxi in
relazione al commercio illecito di armi con l'Argentina e sono proseguite con
maggiore spinta, dando luogo a procedimento penale e disciplinare nei miei
confronti allorché, il 10 dicembre 1983, sequestrai la documentazione da me
trasmessa alla Commissione inquirente". Nel luglio 1984, il giudice Palermo
inviò una memoria difensiva al Procuratore della Repubblica di Venezia dottor
Naso, affermando: "Successivamente all'intervento del Procuratore generale
Tamburrino (su sollecitazione di Craxi) il dottor Naso ha emesso comunicazione
giudiziaria nei confronti del sottoscritto, dopo che egli stesso aveva chiesto
l'archiviazione delle denunce degli avvocati Ruggiero e Giudiceandrea perché
ritenute infondate. Lo stesso dottor Naso mi riferì che anche la Procura
generale di Milano aveva chiesto l'archiviazione dell'esposto presentato
dall'avvocato Ruggiero perché infondato". Nonostante tutto ciò, nell'agosto del
1984, dopo che Palermo ebbe inviato alla Commissione P2 e all'Inquirente gli
incartamenti sul coinvolgimento dei politici nell'inchiesta armi e droga, la
Corte d'appello di Trento decise di accogliere la richiesta dell'avvocato
Ruggiero, togliendo l'inchiesta al giudice Palermo.
La Commissione
parlamentare inquirente ha scagionato Bettino Craxi e il cognato Pillitteri.
Ancora una volta, la rete protettiva attorno a Bettino Craxi ha funzionato;
rimangono aperte le inchieste nei confronti delle finanziarie del Psi e di
Ferdinando Mach, l'accusa di traffico d'armi nei confronti dell'avvocato
Ruggiero ed il procedimento penale nei confronti del giudice Palermo.
Da Trento a Trapani.
Isolato, sottoposto a
provvedimento disciplinare, espropriato dell'inchiesta armi e droga, il giudice
Palermo chiese 'spontaneamente' di essere trasferito da Trento alla Procura di
Trapani. La città dalle mille banche non ha un palazzo di giustizia funzionante,
quello vecchio è cadente, quello nuovo è in costruzione dal 1958 e la Dc domina
la città. Carlo Palermo è andato a prendere il posto di Ciaccio Montalto, il
Procuratore assassinato dalla mafia perché stava seguendo la pista del traffico
di droga internazionale. Anche Ciaccio Montalto, sentendosi completamente
isolato a Trapani e a Roma, chiese di lasciare la Sicilia per trasferirsi a
Firenze, da dove avrebbe voluto proseguire le indagini, seguendo una pista che
collegava la famiglia Minore con uno dei cavalieri del lavoro, Carmelo Costanzo.
Prima di andarsene, nel dicembre 1982, da una serie di intercettazioni
telefoniche trovò le prove che un Procuratore della repubblica, Enzo Costa (poi
arrestato) era un uomo della mafia, legato ai Minore. Un mese dopo, il 25
gennaio 1983, alcuni killer venuti dagli Usa, assieme ai trapanesi,
assassinarono il giudice Montalto. In passato, Ciaccio Montalto si era scontrato
coi politici locali, mettendo sotto accusa gli ex parlamentari dc Diego Playa,
consigliere provinciale, Giuseppe Magaddino e il repubblicano Francesco
Grimaldi. I fratelli Minore, accusati di essere i mandanti dell'assassinio di
Montalto, opportunamente avvertiti, sono riusciti a fuggire e sono tuttora
latitanti, dopo che furono assolti grazie all'intervento del Procuratore Enzo
Costa. L'indagine innescata dal giudice assassinato era però destinata ad avere
un seguito. Le bobine delle intercettazioni telefoniche da lui ordinate (ben 26)
furono fatte sparire dal commissario Collura. Le ritrovò, parecchio tempo dopo,
il Procuratore capo di Caltanissetta, Patanè, che le consegnò a quello di
Trapani, Lumia. Quest'ultimo, in procinto di essere trasferito per procedimento
disciplinare dal Csm a causa dei suoi rapporti con il Procuratore Costa,
probabilmente per rivalsa nei confronti dei politici, diede incarico al nuovo
arrivato, Carlo Palermo, di occuparsi appunto delle intercettazioni telefoniche.
Le conseguenze furono immediate: Carlo Palermo fece incarcerare Calogero Favata,
un finanziere della mafia, Salvatore Bulgarella, presidente dei giovani
industriali siciliani e legato al clan dei Minore. In galera finiscono anche un
funzionario dell'Agip, Jano Cappelletto, ed un armatore di Messina, Antonio
Micali, accusati di voler acquisire con tangenti l'esclusiva per i collegamenti
con la piattaforma dell'ente petrolifero. Colpiti i personaggi minori, Carlo
Palermo si trovò nuovamente sulla pista dei politici. Infatti, su Panorama del
15 aprile 1985, sono stati indicati i nomi di costoro, menzionati nelle
intercettazioni che il giudice Patanè ha provveduto ad inviare alla Procura
generale di Palermo.
Essi sono: Francesco
Camino, dc; Aldo Baffi, dc; Domenico Cangelosi, dc; Calogero Mannino, dc; Guido
Bodrato, dc; Aristide Gunnella, Pri; Gianni De Michelis, Psi; Vincenzo Costa,
Psdi. Le registrazioni avevano dormito per lungo tempo, con l'arrivo di Palermo
si sono messe in moto le inchieste, anche quelle della Guardia di finanza sui
fondi neri e le false fatturazioni dei cavalieri Rendo, Costanzo, Graci,
industriali da tempo in odore di mafia, che nessuno aveva mai osato inquisire.
Il Procuratore capo Lumia, in procinto di andarsene, avocò a sé l'inchiesta
riguardante i cavalieri del lavoro che Palermo chiedeva di arrestare. Alcuni
giorni dopo, il 2 aprile 1985, è avvenuto l'attentato contro Carlo Palermo.
Il seguito lo
conosciamo, sono partiti i mandati di cattura contro Rendo, Costanzo, Graci.
Puntualmente, sono arrivati dal Palazzo gli inviti a Carlo Palermo perché
desista, arrivano anche le reazioni indignate della Confindustria e dei Cdf
delle industrie di proprietà degli arrestati, preoccupati per l'economia
dell'isola e per il posto di lavoro. Mentre il Tribunale di Venezia conferma
l'istruttoria di Palermo contro 33 mafiosi italiani e turchi, rincarando la dose
delle accuse ed emettendo nuovi mandati di cattura, e viene scoperta
un'importante raffineria di morfina base a Castellammare del Golfo (Trapani),
gli avvocati dei pezzi da novanta, profittando del discredito buttato sul
giudice, tentano di far saltare il processo. Dopo aver subito l'attentato,
Palermo ha dovuto denunciare ancora una volta l'isolamento nel quale lo Stato lo
lascia, riducendogli addirittura la scorta ed ha aggiunto che la mafia e i
servizi segreti "hanno formato un potere parallelo pericolosissimo" per le
stesse istituzioni. Fatto gravissimo, Bettino Craxi, spalleggiato dal ministro
degli Interni Scalfaro, è nuovamente sceso in campo contro il neo sostituto
Procuratore di Trapani, esprimendo preoccupazione per i mandati di cattura
emessi da Palermo (contro i Rendo, Graci, Costanzo, Parasiliti) durante il suo
discorso di fronte all'Assemblea regionale siciliana, il 30 aprile 1985. Il
gioco del segretario del Psi e presidente del Consiglio si fa sempre più
scoperto e pesante, segno di nervosismo e difficoltà.
Il seguito.
L’assoluzione degli
inquisiti in sede giudiziaria avvenne in passaggi successivi. In primo grado, il
Tribunale di Venezia, cui fu assegnata la cognizione della causa dalla corte di
Cassazione, dopo 30 udienze e 10 ore di camera di consiglio, mandò assolti 22
imputati, condannandone altri 9 : Glauco Partel, a 7 anni e 8 mesi più la
interdizione dai pubblici uffici per associazione a delinquere e violazioni
della legge sulle armi del 1967; con le stesse accuse Carlo Bertoncini a 6 anni,
Ivan Galileos a 5 anni e 4 mesi, Renato Gamba a 5 anni e 8 mesi; a pene più
lievi sotto il profilo delle sole violazioni di legge, lo spedizioniere Vincenzo
Giovannelli a 3 anni, a 2 anni e 8 mesi ciascuno Vincenzo Corteggiani, il
colonnello Massimo Pugliese, il turco – tedesco Ertem Tegmen e il siriano Nabil
Moahamed Al Maradni (sentenza del 1 febbraio 1988, presidente Giuseppe La
Guardia, p.m. Nelson Salvarani). Contro la sentenza di primo grado si
appellarono i 9 condannati e la Corte d’appello di Venezia assolse anche loro
con la motivazione della insussistenza, per i primi 4, della associazione a
delinquere e, per tutti, che ‘il fatto non costituisce reato’ in merito alle
violazioni della legge sulle armi ritenute in primo grado. La Corte accolse le
tesi avanzate dallo stesso rappresentante dell’accusa, Ennio Fortuna, secondo
cui la intermediazione destinata allo smercio di armi non è prevista come reato
dalla legge italiana se concerne gli stati esteri, senza transito in Italia, né
abbisogna in questo caso di autorizzazioni; alle tesi del p.m. si rimisero i
difensori, rinunciando alle arringhe in aula (sentenza del 12 aprile 1989,
presidente Giuseppe Di Leo).
Mentre era in corso il
processo a Venezia e nei giorni della sentenza, la stampa pur riferendone dava
maggior risalto ad altri fatti, quali gli attacchi di Martelli a Leoluca Orlando
che si apprestava ad aprire le porte di ‘Palazzo delle Aquile’ al Pci, e l’esito
del terzo processo contro ‘Cosa nostra’ a Palermo, che il 15 aprile 1989 mandò
assolti i componenti della cosiddetta ‘cupola’ (fra cui i Greco, Provenzano,
Riina) così che l’esito del processo ‘armi e droga’ non suscitò particolare
clamore. Esito peraltro quasi scontato in un Paese come l’Italia che non
criminalizza né la intermediazione né il commercio di armamenti ma li protegge
in conformità con i propri fini politici, non certo pacifici, e l’inserimento
nella Nato.
Appena intervenuta
l’assoluzione, l’ex ufficiale dei carabinieri Massimo Pugliese che ha smentito
di aver trafficato in armi, asserendo la non veridicità del rapporto del
servizio che lo indicava come personaggio centrale nel traffico e fu alla base
della sua incriminazione, iniziò una lunga polemica contro il giudice Palermo,
dai toni accesissimi, sia in sede giornalistica che giudiziaria, denunciandolo
unitamente ai giudici che collaborarono all’inchiesta, con l’accusa di essere un
“sequestratore” per aver fatto carcerare innocenti e financo della morte di
Arsan, avvenuta in carcere per cardiopatia, il che definisce “omicidio bianco”.
Citò inoltre a giudizio gli allora ministri delle Finanze Colombo, della
Difesa Zanone e il presidente del Consiglio De Mita, nell’intento di ottenere
un risarcimento di 9 miliardi, giungendo per non aver trovato ascolto in Italia,
fino alla corte di Strasburgo. Più interessante è l’oggetto di una ulteriore
denuncia, anch’essa archiviata dal Tribunale dei ministri, contro gli on.
Spadolini e Capria per “180 miliardi trasferiti a Zurigo, con l’autorizzazione
dell’on. Spadolini, come compenso di mediazione a M. Al Talal per le navi da
guerra ‘vendute’ all’Iraq, che non le pagò e le lasciò sul gobbo di Pantalone
per 2.500 miliardi di lire” (cfr. il suo volume Perché nessuno fermò quel
giudice editrice Adriatica e La rivincita del colonnello, ne L’Espresso 5 marzo
1989). Il giudice Palermo dal canto suo, continuò a difendere la sua inchiesta
non nascondendo l’amarezza per l’esito finale, e a denunciare i traffici di armi
e droga anche in sede politica (fu deputato della Rete) e giornalistica (cfr.
fra gli altri i servizi pubblicati da Avvenimenti il 2 ottobre 1991 Ecco il
cuore dei crimini di Stato. Le banche dei servizi segreti che prende spunto
dallo scandalo della Bbci, e il 19 febbraio 1992). Egli si è ritirato dalla
magistratura per esercitare la professione. La sua inchiesta è pubblicata per
ampi stralci in Armi e droga. L’atto di accusa del giudice Carlo Palermo,
Editori riuniti 1988, con saggio introduttivo di Pino Arlacchi ed è descritta
nelle varie fasi fino alla vigilia dell’esito assolutorio, in Fermate quel
giudice, di Maurizio Struffi e Luigi Sardi, Reverdito editore, Trento 1986.
PALERMO: DALLA
MASSONERIA ALLA MAFIA.
Da quanto si apprende
da “La Repubblica” la struttura organizzativa della massoneria italiana subisce
una radicale mutazione durante il Risorgimento. L'esoterismo e la speculazione
filosofica sono messi in secondo piano sovrastati dai processi politici e
sociali di costruzione dell'Unità d'Italia. Il nuovo corso massonico in Sicilia
nasce con la scelta di Garibaldi di fondare nel 1860 il "Supremo Consiglio
Grande Oriente d'Italia di rito scozzese antico e accettato Valle dell'Oreto
sedente all'Oriente di Palermo" assumendone la guida (in una sola seduta è
investito di tutti i gradi del Rito Scozzese, dal 4° al 33°). Il progetto è di
creare un soggetto politico che, facendo perno su Palermo, supporti il processo
che porterà all'unità d'Italia con Roma capitale. Il gran maestro Garibaldi,
infatti, in un suo decreto del 1865 ribadisce che il Grande Oriente d'Italia ha
«sede provvisoria a Palermo, finché Roma non sia capitale degli Italiani». I
massoni siciliani, sotto l'attenta regia di Crispi, plaudono formalmente al
progetto di Garibaldi, ma, di fatto, si rendono conto che non possono essere il
motore dell'unificazione dei liberi muratori italiani e preferiscono ripiegare
sulla dimensione regionale consolidando una struttura alla quale si affida la
costruzione del consenso elettorale di Crispi e del partito democratico. È
quanto emerge dalla lettura di alcuni fascicoli dell'archivio dell'Oriente
palermitano ritrovati casualmente e contenenti una documentazione che va dal
1861 al 1900. Il braccio operativo di Francesco Crispi, maestro venerabile ad
vitam 33, a Palermo è Giovan Battista Chianello barone di Boscogrande, maestro
venerabile 33 della Loggia Centrale, non solo consigliere provinciale e
comunale, ma anche responsabile della segreteria elettorale del presidente del
Consiglio. La sua capacità organizzativa è messa alla prova soprattutto nelle
elezioni anticipate del 1892: Crispi e il suo gruppo sono in affanno in quanto
gli avversari si battono contando sull'appoggio dei presidenti del Consiglio
Rudinì prima e Giolitti poi. Boscogrande agisce, in continuo contatto epistolare
e telegrafico con Crispi, con grande accortezza raccordando l'impegno dei
fratelli con quello dei profani. Sul fronte della massoneria il 28 maggio 1892
organizza un incontro con il maestro venerabile Francesco Crispi 33° presso «il
punto geometrico accessibile solo ai liberi muratori regolari della Massoneria
universale» (Tempio massonico), posto in via Biscottari nel palazzo Conte
Federico, alla presenza dei fratelli delle Logge: Centrale (maestro venerabile
Chianello di Boscogrande 33°), Alighieri (maestro Carmelo Trasselli 33°),
Risveglio (Giovanni Lucifora 33°), Triquetra (Giuseppe Masnata 30°), Ercta
(Francesco Paolo Tesauro 30°), Cosmos (Giorgio Maggiacono 18°). La lettura del
resoconto degli interventi della serata fornisce un vivido ritratto delle
posizioni politiche sia di Crispi sia dei massoni che operano su Palermo.
Boscogrande, inoltre, organizza comitati, promuove banchetti elettorali come
quello che si svolgerà all' hotel delle Palme con presenze significative come
quelle di Girolamo Ardizzone direttore del Giornale di Sicilia, di Artese
direttore del Corriere del Mattino, di Michele Serra direttore dell'Amico del
Popolo o dell'avvocato Gioacchino Seminara. L' obiettivo è quello di raccogliere
fondi per la campagna elettorale affidandone la tesoreria al fratello massone
Napoleone La Farina. Il giorno delle elezioni segue lo spoglio e invia il
seguente telegramma a Crispi: «Congratulazioni auguri sinceri a vostra
eccellenza rieletto con voti 2138». In realtà, i risultati non sono esaltanti:
Crispi è eletto, ma Muratori, altro candidato crispino, soccombe sotto i colpi
dello spregiudicato Trabia. Crispi, nel frattempo, si era reso conto che il
progetto di Garibaldi di utilizzare l'Oriente palermitano come strumento per il
processo di unificazione della massoneria italiana era diventato impraticabile e
appoggia il progetto di un Grande Oriente romano al quale aderiscano tutte le
altre realtà regionali. Nel 1877 Tamajo, massone di sicura fede crispina
(senatore prima e prefetto poi), quale rappresentante della Comunione massonica
italiana sedente in Roma, e l'avvocato Pietro Messineo 33, in nome del Grande
Oriente d'Italia sedente a Palermo, stipulano un concordato in base al quale
l'Oriente di Palermo è dichiarato Sezione del Supremo Consiglio della massoneria
italiana sedente in Roma capitale della nazione. Tra le adesioni si trovano
numerosi protagonisti della politica palermitana quali il senatore Gaetano La
Loggia, l'avvocato Pietro Messineo, Camillo Finocchiaro Aprile, il principe
Pietro Vanni di San Vincenzo. Un altro filone che emerge dalle carte
dell'Oriente palermitano è quello relativo alla sua attenzione nei confronti
della vita universitaria. Il barone di Boscogrande diventa interlocutore
privilegiato del mondo accademico siciliano per due motivi: il primo per
interloquire con il Consiglio superiore della pubblica istruzione per la
gestione dei concorsi; il secondo per governare i finanziamenti che il Comune e
la Provincia di Palermo danno al Consorzio costituito per la realizzazione di
laboratori scientifici. Le affiliazioni alla Loggia Centrale di professori
universitari sono numerose fra le quale si trova traccia di quella del professor
Damiano Macaluso, ordinario di fisica, che si affilia nel settembre del 1888 e
ha come garante il confratello 30 professore Gaetano Giorgio Gemmellaro. I
massoni Gemmellaro (1874-76 e 1880-83) e Macaluso (1890-93) saranno eletti
Magnifici Rettori, mentre Boscogrande, come maestro venerabile della Loggia
Centrale, diventa il referente per la gestione degli "affari" universitari. Il
vissuto dell'Oriente di Palermo non è soltanto gestione del potere, ma anche
scontro politico sul programma, sul processo di riunificazione, sulle alleanze.
La spedizione dei Mille spazza via non solo i borbonici, ma anche il vissuto
delle logge dei liberi muratori del Settecento siciliano intorno al quale si
aggrega la cultura democratica siciliana e il complesso progetto riformatore che
fa capo a viceré massoni come Caracciolo e Caramanico. Garibaldi è colui che
apparentemente si carica della responsabilità di avviare il cambiamento, ma, in
realtà, queste carte permettono di ipotizzare un'ipotesi di ricerca che veda in
Crispi il vero motore del progetto di rifondazione massonica in Sicilia.
Ma cosa ha sviluppato
tanto impegno della massoneria in Sicilia?!?
Dalla stampa si
apprende che otto persone tra poliziotti, medici, imprenditori, boss e iscritti
a logge massoniche sono stati arrestati dai carabinieri di Trapani e Agrigento
in diverse città. L'accusa è di essersi accordati per ottenere di ritardare
l'iter giudiziario di alcuni processi in cui erano imputati affiliati a cosche
delle due città siciliane. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del
tribunale di Palermo. Gli arrestati, tra i quali figurano un'agente della
polizia di Stato, un ginecologo di Palermo, imprenditori di Agrigento e Trapani,
un impiegato del ministero della Giustizia in servizio ad una cancelleria della
Cassazione e un faccendiere originario di Orvieto, sono tutti accusati di
concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione in atti giudiziari,
peculato, accesso abusivo in sistemi informatici giudiziari e rivelazione di
segreti d'ufficio. L'operazione, per la quale sono state anche svolte decine di
perquisizioni, è stata denominata "Hiram", vede impegnati anche i carabinieri,
non solo di Agrigento e Trapani, ma anche quelli di Palermo, Roma e Terni.
Dall'inchiesta emerge che boss mafiosi, grazie all'aiuto di persone appartenenti
a logge massoniche, avrebbero ottenuto di ritardare l'iter giudiziario di alcuni
processi in cui erano imputati affiliati a cosche di Trapani e Agrigento.
L'indagine ha preso il via da accertamenti svolti sulle famiglie mafiose di
Mazara del Vallo e Castelvetrano, in provincia di Trapani. Oltre alle
perquisizioni controlli vengono svolti anche su conti correnti bancari intestati
agli indagati. Avviso di garanzia a un sacerdote. I pm hanno inviato un avviso
di garanzia anche a un sacerdote, gesuita, con l'accusa di concorso esterno in
associazione mafiosa. Il religioso vive a Roma. La sua abitazione è stata
perquisita. Secondo l'accusa il prete, su indicazione di uno degli indagati,
avrebbe predisposto lettere inviate a giudici, al fine di condizionare l'esito
di procedimenti penali nei quali erano coinvolti esponenti vicini a Cosa nostra.
Il peso e l'autorevolezza del sacerdote che apponeva la sua firma alle lettere
inviate ai magistrati, per l'accusa avrebbero influito sull'esito dei ricorsi
giurisdizionali proposti a diverse autorità giudiziarie. Perquisiti gli uffici
della Cassazione. Nell'ambito della stessa operazione sono state effettuate
anche perquisizioni in alcuni uffici della Cassazione. Secondo quanto si
apprende da indiscrezioni, fra le persone arrestate vi sarebbe anche un
impiegato del ministero della Giustizia in servizio proprio in una cancelleria
della Cassazione.
E non è tutto.
Un'analisi organica dei
rapporti fra massoneria deviata e cosche mafiose è contenuta nella relazione
della Commissione parlamentare antimafia presieduta da Luciano Violante.
"Il terreno
fondamentale sul quale si costituiscono e si rafforzano i rapporti di Cosa
nostra con esponenti dei pubblici poteri e delle professioni private è
rappresentato dalle logge massoniche. Il vincolo della solidarietà massonica
serve a stabilire rapporti organici e continuativi". Questo il punto di partenza
dell'analisi proposta.
"L'ingresso nelle logge
di esponenti di Cosa nostra, anche di alto livello, non è un fatto episodico ed
occasionale, ma corrisponde ad una scelta strategica - spiega la Commissione
antimafia - Il giuramento di fedeltà a Cosa nostra resta l'impegno centrale al
quale gli uomini d'onore sono prioritariamente tenuti. Ma le affiliazioni
massoniche offrono all'organizzazione mafiosa uno strumento formidabile per
estendere il proprio potere, per ottenere favori e privilegi in ogni campo; sia
per conclusione di grandi affari sia per "l'aggiustamento" dei processi, come
hanno rivelato numerosi collaboratori di giustizia. Tanto più che gli uomini
d'onore nascondono l'identità dei "fratelli" massonici ma questi ultimi possono
anche non conoscere la qualità di mafioso del nuovo entrato" (punto 57 della
citata Relazione).
Rapporti fra Cosa
nostra e massoneria sono comunque emersi anche nell'ambito dei lavori di altre
due Commissioni parlamentari d'inchiesta: quella sul caso Sindona e quella sulla
loggia massonica P2, che già avevano approfondito la vicenda del finto rapimento
del finanziere e della sua permanenza in Sicilia dal 10 agosto al 10 ottobre
1979. Agli atti, le indagini della magistratura milanese e di quella
palermitana, che avevano svelato i collegamenti di Sindona con esponenti mafiosi
e con appartenenti alla massoneria. Il finanziere era stato aiutato da Giacomo
Vitale, cognato di Stefano Bontade, capomafia della famiglia palermitana di
Santa Maria di Gesù e da Joseph Miceli Crimi: entrambi aderenti ad una comunione
di Piazza del Gesù, "Camea" (Centro attività massoniche esoteriche accettate).
Nel gennaio 1986 la
magistratura palermitana dispone una perquisizione e un sequestro presso la sede
palermitana del Centro sociologico italiano, in via Roma 391. Vengono
sequestrati gli elenchi degli iscritti alle logge siciliane della Gran Loggia
d'Italia di Piazza del Gesù. Fra gli iscritti figurano i nomi dei mafiosi
Salvatore Greco e Giacomo Vitale.
Nel mese di gennaio
dello stesso anno, la magistratura trapanese dispone il sequestro di molti
documenti presso la sede del locale Centro studi Scontrino. Il centro,
presieduto da Giovanni Grimaudo, era anche la sede di sei logge massoniche:
Iside, Iside 2, Osiride, Ciullo d'Alcamo, Cafiero, Hiram. L'esistenza di
un'altra loggia segreta trova poi una prima conferma nell'agenda sequestrata a
Grimaudo, dove era contenuto un elenco di nominativi annotati sotto la dicitura
"loggia C". Tra questi, quello di Natale L'Ala, capomafia di Campobello di
Mazara. Nella loggia Ciullo d'Alcamo risultano essere affiliati: Pietro Fundarò,
che operava in stretti rapporti con il boss Natale Rimi; Giovanni Pioggia, della
famiglia mafiosa di Alcamo; Mariano Asaro. Nel processo, vari testimoni hanno
concordato nel sostenere l'appartenenza alla massoneria di Mariano Agate,
capomafia di Mazara del Vallo. Alle sei logge trapanesi e alla loggia "C" erano
affiliati imprenditori, banchieri, commercialisti, amministratori pubblici,
pubblici dipendenti, uomini politici (la Commissione antimafia, nella citata
relazione, ricorda come l'onorevole democristiano Canino, nell'estate del '98
arrestato per collusioni con Cosa nostra, abbia ammesso l'appartenenza a quella
loggia, pur non figurando il suo nome negli elenchi sequestrati).
Già nel processo di
Trapani e poi successivamente in quello celebrato nel '95 a Palermo contro
Giuseppe Mandalari (accusato di essere il commercialista del capo della mafia,
Totò Riina) sono emersi contatti fra le consorterie mafiose e massoniche di
Palermo e Trapani. Mandalari, "Gran maestro dell'Ordine e Gran sovrano del rito
scozzese antico e accettato" avrebbe concesso il riconoscimento "ufficiale" alle
logge trapanesi che facevano capo a Grimaudo.
Le indagini sui
rapporti mafia-massoneria continuano. Seppur fra tante difficoltà. L'unica
condanna al riguardo, ottenuta dai pm palermitani Maurizio De Lucia e Nino
Napoli, riguarda proprio Pino Mandalari, il commercialista di Riina attivo gran
maestro. Solo nel febbraio del 2002, è stata sancita in una sentenza la pesante
influenza dei "fratelli" delle logge sui giudici popolari di un processo di
mafia: la Corte d'assise stava seguendo il caso dell'avvocato palermitano
Gaetano Zarcone, accusato di avere introdotto in carcere la fiala di veleno che
doveva uccidere il padrino della vecchia mafia Gerlando Alberti. Non è stata
facile la ricostruzione del pm Salvatore De Luca e del gip Mirella Agliastro,
che poi ha emesso sette condanne: non c'erano mai minacce esplicite, solo
garbati consigli a un "atteggiamento umanitario". Questo il volto delle
intimidazioni tante volte denunciate.
Il caso più inquietante
di cui si sono occupate le indagini è quello di una misteriosa fratellanza, la
Loggia dei Trecento, anche detta Loggia dei Normanni. Il pentito Angelo Siino ha
fugato ogni dubbio: il divieto per gli aderenti a Cosa nostra di fare parte
della massoneria restò sempre sulla carta. "Le regole erano un po' elastiche -
spiega - come la regola che non si devono avere relazioni extraconiugali". Erano
soprattutto i boss della vecchia mafia, Stefano Bontade e Salvatore Inzerillo,
ad avere intuito l'utilità di aderire alle logge.
Rosario Spatola seppe
da Federico e Saro Caro che Bontade "stava cercando di modernizzare Cosa nostra.
Vedeva più in là, vedeva la potenza della massoneria, e magari riteneva di
potere usare Cosa nostra in subordine, come una sorta di manovalanza". Per
questo aveva creato una sua loggia. Era appunto la Loggia dei Trecento. Anche
Siino riferisce di "averne sentito parlare: si diceva che ne facevano parte
parecchi personaggi quali i cugini Salvo, Totò Greco "il senatore" e uomini
delle istituzioni. La loggia non era ufficiale e non aderiva a nessuna delle due
confessioni, né a quella di Piazza del Gesù né a quella di Palazzo Giustiniani".
Correvano a Palermo i
ruggenti anni Settanta. Il pentito Spatola conferma il ruolo di Bontade come
gran maestro della Loggia dei Trecento. E spiega: "Ne facevano parte soggetti
appartenenti alle categorie più disparate, e per questo era molto potente. E
troppa potenza si era creata anche attorno a Stefano Bontade, per questo andava
eliminato lui ma anche la loggia". Il 23 aprile 1981, Bontade fu ucciso dai
corleonesi di Totò Riina e Bernardo Provenzano. Ha svelato Spatola che fu
proprio Provenzano, capo dell'organizzazione mafiosa, a prendere l'iniziativa di
sciogliere la Loggia dei Trecento. Particolare davvero inedito e curioso. Quale
autorità aveva mai don Bernardo per intervenire d'autorità su una fratellanza
tanto riservata? Forse era massone anche lui? Forse, già allora, aveva ben
presenti rapporti e complicità eccellenti che da lì a poco avrebbero fatto a
gara per riposizionarsi e ingraziarsi i nuovi potenti?
LE RIVELAZIONI DEI
COLLABORATORI DI GIUSTIZIA
Tommaso Buscetta
Nel 1984 parla per la
prima volta del rapporto fra mafia e massoneria nel contesto del tentativo
golpista di Junio Valerio Borghese del dicembre 1970.
Il collegamento tra
Cosa nostra e gli ambienti che avevano progettato il colpo era stato stabilito
attraverso il fratello massone di Carlo Morana, uomo d'onore.
La contropartita
offerta a Cosa nostra consisteva nella revisione di alcuni processi.
Leonardo Messina
Sostiene che il vertice
di Cosa nostra sia affiliato alla massoneria: Totò Riina, Michele Greco,
Francesco Madonia, Stefano Bontade, Mariano Agate, Angelo Siino (oggi
collaboratore di giustizia pure lui). Ritiene che spetti alla Commissione
provinciale di Cosa nostra decidere l'ingresso in massoneria di un certo numero
di rappresentanti per ciascuna famiglia.
Gaspare Mutolo
Conferma che alcuni
uomini d'onore possono essere stati autorizzati ad entrare in massoneria per
"avere strade aperte ad un certo livello" e per ottenere informazioni preziose
ma esclude che la massoneria possa essere informata delle vicende interne di
Cosa nostra. Gli risulta che iscritti alla massoneria sono stati utilizzati per
"aggiustare" processi attraverso contatti con giudici massoni.
Le conclusioni della
Commissione antimafia presieduta da Luciano Violante:
"Il complesso delle
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia appare essere concordante su tre
punti:
- intorno agli anni
1977-1979 la massoneria chiese alla commissione di Cosa nostra di consentire
l'affiliazione di rappresentanti delle varie famiglie mafiose; non tutti i
membri della commissione accolsero positivamente l'offerta; malgrado ciò alcuni
di loro ed altri uomini d'onore di spicco decisero per motivi di convenienza di
optare per la doppia appartenenza, ferma restando la indiscussa fedeltà ed
esclusiva dipendenza da Cosa nostra;
- nell'ambito di alcuni
episodi che hanno segnato la strategia della tensione nel nostro paese, vale a
dire i tentativi eversivi del 1970 e del 1974, esponenti della massoneria
chiesero la collaborazione della mafia;
- all'interno di Cosa
nostra era diffuso il convincimento che l'adesione alla massoneria potesse
risultare utile per stabilire contatti con persone appartenenti ai più svariati
ambienti che potevano favorire gli uomini d'onore".
Cosa ne è scaturito da
tutto ciò?
Alla Regione Sicilia
finora si andava dal peculato alla concussione, dal voto di scambio
all’intestazione fittizia di beni. Stavolta scattano la frode e l’esercizio
abusivo dell’attività finanziaria con gli ultimi due deputati della Regione
Sicilia finiti nella maglie di un’inchiesta giudiziaria. Due deputati del Pdl,
Roberto Corona in cella e Fabio Mancuso ai domiciliari. Da aggiungere ai 26 già
inquisiti fino a ottobre, quando il deputato Mario Bonomo di «Alleati per la
Sicilia» risultò indagato per concussione nell’ambito dell’inchiesta in cui era
stato già arrestato a marzo il suo ex compagno del Pd Gaspare Vitrano, fermato
mentre intascava una mazzetta di dieci mila euro da un imprenditore del
fotovoltaico.
Si sta per sfiorare
così il record del 30 per cento di inquisiti nel parlamento più antico del mondo
dove il presidente Francesco Cascio cerca di spingere il dibattito e il disegno
di legge sulla riduzione degli “onorevoli” siciliani da 90 a 70. Ma intanto lo
spettacolo è sempre più indecoroso nella regione che ha visto condannare per
mafia il governatore Totò Cuffaro e che da un anno e mezzo è in fibrillazione
per il suo successore, Raffaele Lombardo, indagato per favori alla mafia dalla
procura di Catania che ne ha poi chiesto l’archiviazione.
Si arriva al paradosso
che i finanzieri della Polizia Valutaria in collaborazione con lo Scico
notifichino un ordine di custodia ai domiciliari a un loro ex collega, appunto
Fabio Mancuso, un tempo maresciallo della Guardia di Finanza impegnato nella
caccia alle cooperative fasulle e ai dirigenti corrotti. Ormai considerato un
problema e non certo una risorsa per le Fiamme Gialle, tre legislature
all’Assemblea debbono aver lasciato il segno. Come è accaduto per l’onorevole
Vitrano, anch’egli parlamentare da guinness dei primati visto che non s’era mai
visto un deputato in “esilio” a Roma, con “obbligo di dimora fuori dalla
Sicilia”. Lui fa parte del drappello dei quattro finiti dentro negli ultimi tre
anni. Un panorama desolante se si considera che c’è pure chi, come il deputato
di Forza del Sud Franco Mineo, è addirittura ritenuto prestanome dei boss del
quartiere palermitano dell’Acquasanta.
Ma ci sono altre cose
che non si sanno.
IL MAGISTRATO PAOLO FERRARO E LE SETTE DI
STATO.
Il sapere è
potere. Tutto quello che non devi sapere...Sara
Tommasi e Melania Rea le probabili vittime del “'Monarch” militare, scrive
Antonio Del Furbo. Il magistrato Paolo
Ferraro continua la battaglia sui presunti abusi avvenuti all'interno della
città militare della "Cecchignola". Lui, Paolo Ferraro, l'uomo che ha pagato
screditato come uomo prima e come istituzione poi prosegue il viaggio per far
conoscere a tutti le sue inchieste. I militari e i servizi segreti non
avrebbero mai concluso il progetto di controllo mentale ma addirittura avrebbero
rimodulato tale progetto con l'aggiunta di riti satanici e atti sessuali. Il
magistrato, come riferito in più circostanze, ha incontrato più volte Melania
Rea nei corridoi della procura di Roma. La donna sarebbe stata a conoscenza
delle pratiche che si svolgevano all'interno della caserma di Ascoli Piceno e
della Cecchignola. «Basi segrete per la manipolazione mentale, angherie sulle
reclute, festini a base di sesso e droghe» racconta Ferraro. Poi tiene a
precisare che: «quando mi sono unito con la mia nuova compagna e iniziare una
convivenza in un appartamento della Cecchignola destinato ai militari, l'ex
marito della donna sottufficiale dell'esercito, non si è assolutamente opposto
all'unione ma, anzi, l'ha incoraggiata». Ferraro s'insospettisce soprattutto
guardando l'atmosfera e gli sguardi di chi gli sta intorno: strani sguardi
d’intesa tra vicine di casa, che però non si parlano, anzi all’apparenza
sembrano detestarsi, bambini che sembrano automi. Il magistrato comincia a
notare strani comportamenti nella moglie che, dopo insistenze da parte di
Ferraro, ammette di aver fatto parte di una specie di setta. I racconti appaiono
fumosi e con molte lacune. A quel punto il magistrato decide di registrare tutto
ciò che avviene in quella casa quando lui è a lavoro: da lì inizia una triste
storia. Ferraro scopre che, in sua assenza, all'interno dell'appartamento
avvengono fatti indicibili. La sua compagna è la protagonista involontaria di
orge di gruppo anche con minori. Si riconosce la voce atona di lei che risponde
come un automa a comandi di altre persone. Gemiti suoni risposte strozzate,
tentativi di rifiuto “Bevi. No non mi va”. Secondo Paolo Ferraro nella stessa
rete sarebbe caduta anche Sara Tommasi che ha più volte dichiarato: «Mi mettono
in casa il gas dai bocchettoni. Mi addormento e dormo tantissimo. Mi danno
sostanze perché sia più lasciva durante le riprese, dietro ci sono i servizi
segreti». La Tommasi ultimamente ha ritrattato tutto dicendo di aver rilasciato
tale dichiarazioni solo per farsi pubblicità. Certo è che il beneficio del
dubbio ammette anche un'altra ipotesi: che la showgirl possa essere stata
ricattata dalla Camorra. La criminalità organizzata gestirebbe il servizio delle
escort in tutt'Italia e, tramite Fabrizio Corona e Lele Mora, sarebbe entrata
nella fornitura delle prostitute in casa Arcore. Leo Lyon Zagami è un siciliano
aristocratico, un massone gran maestro di 33°grado affiliato alla loggia
massonica P2 di Monte Carlo, il quale ha rotto i legami con gli illuminati a
giugno del 2006 e sta rivelando tutti i segreti inconfessabili del satanismo
collegato ai vertici politici degli USA, del Vaticano e dei Gesuiti. Insieme
a Zagami, molti altri “pentiti” hanno rivelato segreti che nessuno avrebbe mai
potuto conoscere riguardo gli illuminati. L'uomo, che ha vissuto sulla propria
pelle i metodi criminali utilizzati dai vertici corrotti di Massoneria e
Illuminati che, come denuncia da anni, arriverebbero a utilizzare la
manipolazione mentale, la tortura, l’omicidio, il sacrificio di sangue e la
pedofilia per compiere i loro obiettivi del tutto “terreni”. Lo SMOM, Corpo
Militare dell'Ordine di Malta, avrebbe forti collegamenti con la Cecchignola e
ambienti militari italiani. Elio Lannutti, il 17 novembre 2011, presentò
un'interrogazione al Ministero della Giustizia e al Ministero della Difesa in
cui chiedeva conto delle informazioni a disposizione del Governo sui fatti
esposti da Paolo Ferraro e Milica Fatima Cupic. Ancora oggi non se ne sa nulla.
Salvatore Parolisi complice di personaggi
innominabili ancora a piede libero: ecco le prove,
scrive
“La Voce Delle Voci” il
19 Settembre 2015 su “L’Infiltrato”. “Salvatore Parolisi non fu
forse assassino ma complice. Di personaggi innominabili”, scrive Rita Pennarola, che
in un’inchiesta pubblicata nel 2012 su La Voce delle Voci raccontava
una storia cui nessuno dava credito. Salvo ricredersi, come sempre accade con le
inchieste de La Voce, dopo anni. Ecco la ricostruzione shock su Salvatore
Parolise e i “personaggi innominabili” che sarebbero stati i veri esecutori del
delitto.
Moventi
illogici, che non reggono, eppure diventano prove. Armi del delitto mai trovate.
E quell’ombra dei clan che lasciano una firma sul cadavere, senza che nessuno
voglia vederla. Lontane dalla prontezza delle Direzioni Antimafia, molte Procure
di provincia seguono per mesi ed anni piste passionali, ruotando intorno a
gelosie familiari, storie a luci rosse o al massimo sballi da balordi di
periferia. Ma ecco come, da Melania alle altre, è possibile ricostruire una
storia ben diversa. Manca l’arma del delitto. Oppure è lo stesso cadavere che
non viene ritrovato, se non per circostanze del tutto fortuite. O ancora, il
movente risulta illogico anche rispetto al più elementare buon senso. Restano
così per sempre senza giustizia le ragazze sgozzate e lasciate dentro un bosco
seminude, con gli occhi ancora spalancati a guardare il cielo, le mani giunte
come in preghiera. Le donne belle e innocenti come Melania Rea. Un classico, la
vicenda giudiziaria sul suo tragico destino: corpo ritrovato solo grazie ad un
telefonista rimasto anonimo, arma (in questo caso un coltello da punta e taglio)
finita chissà dove, movente assurdo. E in carcere con l’accusa di omicidio,
ovviamente, il marito. Senza che nessuno (o quasi, come vedremo) dei tanti
inquirenti succedutisi intorno a questa atroce vicenda abbia saputo – o più
probabilmente, potuto – rispondere ai mille interrogativi lasciati aperti dalla
pista passionale. Un quadro da manuale che accontenta tutti, quella moglie
gelosa accoltellata dal coniuge innamorato pazzo dell’altra. Così nessuno
solleverà più il velo su eventuali traffici della malavita organizzata
all’interno dell’esercito. E forse cala una pietra tombale sulle vere ragioni
dell’assassinio.
LA
LEZIONE DI IMPOSIMATO.
«Accade talvolta – dice
Ferdinando Imposimato, giudice istruttore nelle più scottanti vicende della
storia italiana, da Aldo Moro a Emanuela Orlandi – che
il movente di un crimine risulti illogico, non congruente. Ciononostante taluni
investigatori continuano a perseguire lo stesso filone d’indagini, che poi o
viene smontato in fase processuale, oppure travolge con accuse pesantissime
persone risultate poi innocenti». La tesi di Imposimato – che qui non parla
in riferimento al delitto Rea, ma risponde ad una nostra domanda sui moventi
“illogici” – è stata confermata fra l’altro nel caso della contessa Alberica
Filo della Torre: attraverso una rigorosa ricostruzione dei fatti, sulla Voce di
aprile 2009 Imposimato smontava la solita pista passionale seguita per vent’anni
dagli inquirenti, indicando le responsabilità del cameriere filippino,
sbrigativamente scagionato nei primi giorni successivi al delitto. Ed arrestato
solo ad aprile 2011, dopo la scoperta del suo Dna in una macchia di sangue nel
letto della vittima. «Ero stato colpito –
spiega Imposimato – non solo dalla
mancata valutazione di indizi che portavano univocamente in direzione del
filippino, ma anche da quella che consideravo l’ingiusta incriminazione di
alcune persone contro cui non esistevano indizi gravi, precisi e concordanti».
Come Roberto Jacono, accusato, arrestato e poi prosciolto, una vita avvelenata
da indagini miopi. Perciò ripartiamo da qui. Dalla grande lezione di Imposimato
sulla necessità di un solido movente. Che non pare essere un amore folle, per il
marito di Melania Salvatore Parolisi. Ma una motivazione forte, come vedremo,
manca anche nella ricostruzione giudiziaria attuale di altre vicende che tengono
da mesi col fiato sospeso gli italiani. Casi per lo più irrisolti, che
nell’immaginario collettivo misurano quanto la nostra magistratura sia in grado
di dar pace alle vittime e ai familiari con sentenze e prove definitive.
IL GIP
CHE SAPEVA TROPPO.
A
disporre l’arresto di Salvatore Parolisi è la Procura di Ascoli Piceno, che
indaga fin dal quel giorno (era il 18 aprile 2011), prima per la scomparsa e poi
per l’omicidio di Melania, dopo il ritrovamento del cadavere, avvenuto due
giorni dopo a Ripe di Civitella. Quest’ultima località è in provincia di Teramo.
Perciò, quando a giugno l’autopsia rivela che la donna è stata uccisa nello
stesso luogo in cui viene ritrovata, la competenza passa da Ascoli a Teramo.
Dove Salvatore, già in carcere, si trova di fronte al giudice per le indagini
preliminari Giovanni Cirillo. Non un magistrato qualsiasi, lui. Basti pensare a
quel Premio Borsellino assegnatogli nel 2008 durante un incontro pubblico a
Roseto degli Abruzzi. Accanto a Cirillo, come relatori, ci sono Luigi de
Magistris e Clementina Forleo. Entrambi erano stati colpiti da punizioni
“esemplari” ad opera del Consiglio Superiore della Magistratura. La storia di de
Magistris e Forleo è nota. Per loro oggi gli effetti di una giustizia non
condizionata dai poteri forti stanno finalmente arrivando. Non così nel 2008. Il
fatto che in quel tumultuoso periodo Cirillo fosse schierato al fianco dei due
coraggiosi colleghi, la dice lunga sulla rigorosa volontà di non lasciarsi
condizionare dai ranghi “alti” del potere, quand’anche essi fossero all’interno
della stessa magistratura. Cirillo, che conosce a fondo le indagini sul caso
Rea, è il gip che il 2 agosto convalida l’arresto di Parolisi richiesto dal pm
ascolano Umberto Gioele Monti. Ed è grazie a Cirillo che le attività
investigative cominciano ad assumere una diversa fisionomia. Non solo la ricerca
spasmodica fra storie di corna a luci rosse e chat per transessuali, ma qualcosa
di più solido, quello sfondo inconfessabile di traffici che forse vedono al
centro, assieme all’istruttore delle soldatesse Parolisi, interi pezzi della
caserma Clementi di Ascoli Piceno. Sembra di essere ad una svolta. Il gip non
tralascia alcuna ipotesi, tanto che viene ascoltato il magistrato romano Paolo
Ferraro, l’uomo che aveva dettagliato l’esistenza di riti satanici dentro alcuni
complessi militari italiani. Il 9 agosto Giovanni Cirillo lascia da un giorno
all’altro il tribunale di Teramo. A sorpresa, nel pieno delle indagini sul
delitto di Melania, il Csm lo manda a presiedere la Corte d’Assise di
Giulianova. Ma lui non molla del tutto. Ed affida a Vanity Fair un’intervista
che avrebbe dovuto imprimere la giusta accelerazione alle indagini. E invece è
caduta nel vuoto. Il giudice parla con la giornalista di Vanity appena due ore
dopo aver lasciato l’incarico: «Da due ore –
esordisce – non me ne occupo più,
quindi non ho il dovere del silenzio». Cirillo ha ragionato a lungo sulle
ragioni alla base del delitto. Sa che la pista della gelosia traballa. E spiega
perchè: «Il movente passionale ipotizzato dai magistrati di Ascoli (su
cui è interamente basata l’ordinanza di custodia cautelare del pm Monti, ndr), l’idea
che Parolisi fosse finito in un “imbuto,
stretto fra moglie e amante, non corrisponde alla sua condizione». Di più: «Parolisi
non era un uomo disperato, lui con i piedi in due scarpe ci stava a meraviglia e
non avrebbe mai lasciato entrambe. I pianti continui con l’amante erano finti,
lo scrivono anche i carabinieri nelle intercettazioni: “Finge
di piangere”. Inoltre, ha avuto fino all’ultimo rapporti con la moglie. Il
movente è un altro». Non può spingersi oltre, Cirillo, consapevole com’è di
dover rispettare il lavoro che ha ormai lasciato ai colleghi. Ma uno scenario
ampiamente logico e credibile prende corpo dalle sue parole: «Melania –
dice il gip – è stata uccisa
perché aveva scoperto un segreto inconfessabile, forse legato alla caserma dove
Parolisi lavorava. In tutta l’indagine resta un margine di dubbio sul fatto che
Parolisi abbia accompagnato la moglie nel boschetto e lì sia intervenuta una
persona che, però, non ha lasciato tracce di sé». Questo, aggiunge Cirillo,
«sposterebbe tutto su un piano di premeditazione a aprirebbe scenari
inquietanti, se Salvatore Parolisi stava rendendo conto a qualcuno di qualcosa
che non sappiamo, se la moglie aveva scoperto qualcosa e lui è stato costretto a
portarla lì». Non sapremo mai come sarebbero andate avanti le indagini se
fosse stato il gip Cirillo a condurle in porto nei lunghi mesi che hanno
preceduto il rito abbreviato per Parolisi, iniziato a febbraio e tuttora in
corso. Di sicuro, però, nel numero di luglio 2011 la Voce aveva ricostruito
questa vicenda in maniera assai simile, con un Salvatore Parolisi costretto
dalle sue stesse attività illecite prima a rendersi complice (non sappiamo con
quale grado di consapevolezza) dell’assassinio di sua moglie, e poi a tacere,
per evitare che dopo la prima, orrenda ritorsione nei suoi confronti, ce ne
fossero altre.
LA
FIRMA DEI CASALESI. Sì,
su quel corpo straziato della giovane mamma di Somma Vesuviana c’è una firma a
lettere di fuoco. La firma della camorra. Dopo l’atroce fine di Melania – moglie
di un caporalmaggiore che era stato in Afghanistan, e sul cui conto corrente
erano stati trovati 100mila euro durante le prime indagini – più nessuno potrà
azzardarsi ad agire “in proprio” per trarre profitto da commerci sui canali
“esclusivi” di gente come i Casalesi. Un linguaggio, quello degli omicidi di
camorra, ben noto a pubblici ministeri e gip che abitualmente si confrontano con
corpi “incaprettati” o mutilati in zone particolari, proprio per lanciare un
avvertimento agli altri. Storie rimaste sepolte nei fascicoli giudiziari, o
sottaciute nel buio dell’omertà per decenni, poi portate alla luce per la prima
volta da Roberto Saviano e Matteo Garrone. Oggi sono patrimonio di una certa
letteratura, eppure risultano ancora lontane dalla mentalità e dalle attitudini
di taluni investigatori, «specialmente –
dice un pm antimafia con lunghissima esperienza, oggi in pensione – se
parliamo delle Procure di provincia dell’Italia centrale o del Nord, dove le
Direzioni Distrettuali Antimafia sono lontane e così pure i metodi
investigativi, soprattutto la tempestività delle prime ore, o la conoscenza
approfondita di quei dettagli che immancabilmente conducono alle organizzazioni
di stampo camorristico». Ma gli indizi, tanti, che nel delitto di Melania
Rea potrebbero portare ai clan, pare non abbiano trovato spazio in alcuna
attività investigativa specifica. Eppure sono tutti là, a formare una
impressionante sequenza. Nei primi giorni di giugno 2011 al 235esimo Reggimento
Piceno fa ritorno la soldatessa Laura Titta, napoletana, che proprio presso quel
reparto di stanza alla caserma Clementi era stata addestrata nel 2009. Dopo un
anno di servizio a Napoli, ormai congedata, stranamente fra aprile e maggio fa
domanda per tornare ad Ascoli. Tanto nel 2009 quanto nel giugno 2011, dentro
quella caserma l’addestratore delle reclute femminili è il caporal maggiore
Parolisi. Ma quando il 14 giugno le forze dell’ordine inviate dalla Dda
partenopea arrivano alla Clementi per arrestare la Titta nell’ambito delle
indagini sul boss Michele Zagaria, il fresco vedovo Parolisi dichiarerà agli
inquirenti ascolani che lui la Titta non la ricorda, non l’ha mai frequentata. E
tanto basterà, tanto sarà sufficiente ad allontanare l’immagine dei boss che
estendono il loro potere nei reparti delle caserme, infiltrandosi tra le nostre
forze armate. La reputazione dell’esercito, anche stavolta, è salva. Anche
perché nessuno fra i tanti militari che erano in quell’area il 18 aprile, a
quell’ora, per esercitazioni, ha sentito nulla, neppure un gemito della donna
colpita con 37 coltellate. E per tutti va bene così.
DA
KABUL A TOLMEZZO.
Poi c’è un’altra donna. La cui storia, ben al di là di tutte le vere o presunte
amanti di Parolisi, serve a chiarire i contorni degli inconfessabili traffici
che probabilmente andavano avanti da tempo in quella, come forse in altre
caserme italiane. Il 13 agosto del 2011 Alessandra Gabrieli, 28 anni,
caporalmaggiore dei parà nell’esercito italiano, viene arrestata a Genova, la
sua città, per spaccio di eroina. Il volto segnato dalla droga, la ragazza
racconta agli investigatori: «Mi hanno iniziato all’eroina alcuni militari
della missione Isaf di ritorno dall’Afghanistan. È successo nel 2007 ed eravamo
nella caserma della Folgore a Livorno. Ritengo che quello stupefacente, molto
probabilmente, venisse portato direttamente dall’Asia». La giovane, che a
settembre è stata condannata in primo grado a tre anni e mezzo di reclusione,
aveva raccontato agli inquirenti che quanto capitato a lei era già successo ad
altri colleghi. Aprendo di fatto la strada ad un’indagine della magistratura
militare sui traffici nelle caserme italiane di droga proveniente
dall’Afghanistan, che ne è notoriamente il primo produttore al mondo, con un
fatturato salito alle stelle dopo l’arrivo delle forze Isaf. Altra centrale di
smercio per hashish e dintorni in arrivo dalle “missioni di pace” deve poi
essere stata un’altra caserma, quella degli Alpini a Tolmezzo, dove ha peraltro
prestato servizio a lungo Salvatore Parolisi di ritorno dall’Afghanistan e prima
di arrivare ad Ascoli. Un anno fa, ad aprile 2011, proprio nello stesso periodo
in cui Melania viene assassinata, dentro la caserma di Tolmezzo qualcuno scopre
che le canne dei fucili rientrati dall’Afghanistan sono imbottite di hashish. Un
ritrovamento casuale, che porta alla scoperta di 360 grammi di sostanza
stupefacente contenuta nei fucili. Un metodo ingegnoso, che ricorda tanto l’arte
di arrangiarsi. Fatto sta che nessuno si presenta a ritirare quei fucili, benché
la notizia delle indagini non fosse stata ancora diffusa. Unico indagato, un
militare nato a Capua, che però nega ogni addebito. Ad oggi non si sa nulla né
dell’inchiesta aperta dalla Procura militare, né di quella condotta dalla
magistratura ordinaria, dopo che i fascicoli erano stati trasferiti da Tolmezzo
a Roma. Indizi, solo indizi. Ma come non soffermarsi sulla loro evidenza? Perché
ostinarsi a considerare un “depistaggio” quella siringa conficcata sul petto
dilaniato di Melania, con accanto un laccio emostatico? «Quasi un marchio –
commenta un avvocato del vesuviano da sempre alle prese con omicidi di camorra –
quella siringa sul petto. Interpretando bene certi segnali, farebbe pensare più
ad una tremenda punizione per il marito, con relativo avvertimento per gli
altri, che alla necessità di sopprimere un testimone scomodo, cosa che
generalmente i clan fanno con modalità meno appariscenti». E tutto questo,
spiegherebbe anche le frasi che Parolisi dice nei primi minuti dopo aver
denunciato la scomparsa della moglie («me l’hanno presa»), o le frasi che
bofonchia con rabbia da solo in macchina («gli devo strappare il cuore dal
petto, mi devo fare trent’anni ma lo devo fare»), e infine lo scambio di
battute con la sorella Francesca (lei: «ora esce fuori tutto». E lui: «mi
dispiace che ci ha rimesso Melania»). Salvatore sa. Conosce il volto degli
assassini, di cui è stato in qualche modo complice. Ma sa ancor meglio che non
può e non deve parlare. È la “legge” ferrea della camorra. Se parli, tu o i tuoi
familiari prima o poi farete la stessa fine.
PAOLO FERRARO,
magistrato di sinistra si candida con Forza Nuova,
scrive
Emanuele Nusca.
Alla fine anche lui si è candidato: il magistrato di sinistra Paolo Ferraro si
candida con Forza Nuova alle prossime elezioni politiche. Ferraro sarà capolista
nel Lazio delle liste di Forza Nuova. L’annuncio arriva da Roberto Fiore,
segretario nazionale del partito. Un’alleanza trasversale tra ex di destra e
sinistra che vuole andare al di là degli schemi politici per meglio
rappresentare le esigenze della società attuale. In definitiva Ferraro ha scelto
di entrare nelle fila di F.N., partito di estrema destra che lo ha accolto dopo
la contesa con la Rete dei Cittadini. Paolo Ferraro è sul web dal 201o quando
inizia la sua operazione divulgativa della personale esperienza di magistrato
controcorrente che scopre, all'interno dei palazzi, vari sistemi spaventosi di
controllo mentale, denominati Progetto MONARCH e MK-Ultra e sistemi di
massonerie deviate e sette sataniche che agiscono in seno allo stato che noi
concittadini continuiamo a credere tale e definire come Italia. Nei numerosi
blog scritti nel tempo, Ferraro riassume tutte le vicende che lo hanno portato a
documentare le più grandi porcherie che lo stato italiano sia mai stato in grado
di concepire attraverso insospettabili colleghi magistrati e militari che
operavano ed operano tutt'ora nelle strutture che dovrebbero garantire la nostra
sicurezza, quella dei cittadini Italiani. Pare
quindi, che abbia tutte le intenzioni di svelare al grande pubblico le sue
scoperte e di formare una forza politica che sia in grado di unire il più
possibile correnti di pensiero diverse. Sul blog si legge: Il creare una
alleanza trasversale e un polo alternativo UNIFICANDO insieme correnti moderate,
ed ex di destra e sinistra, con una operazione storico politica mai realizzata
, in Italia , richiede una grande elasticità e capacità di rivedere schemi ed
etichette.
DAL CASO FERRARO ATTRAVERSO LA GRANDEDISCOVERY,
ALLA ENUCLEAZIONE DEL GOLPE STRISCIANTE E DELLE ATTIVITA' E METODOLOGIE
CRIMINALI, SINO ALLA RICOSTRUZIONE DEL RUOLO TATTICO E STRATEGICO DELLA
"SUPERGLADIO" E DELLA SUA COMPOSIZIONE. SCHEDA RIASSUNTIVA E ARTICOLI RILEVANTI
SULLA "SVOLTA" del 2014 2015, si legge sul blog di Paolo Ferraro.
Solo due parole di premessa: un mobbing orizzontale e verticale
criminale e posto in essere mediante una impressionante sequenza di falsi ed
attività illecite anche a copertura, estrema, nasce da sentimenti inferiori e
accerchia un soggetto. In questo caso un soggetto che si ritiene da eliminare
per doti, qualità e per non appartenenza ad ambiti socio antropologici e
sotterranei di casta. Questa era ed è la chiave di lettura principale, ma
posizionata sul piano individuale e sottaciuta sino ad oggi. Mi venne confermato
e detto sinanche da Solange
Manfredi e
glielo aveva analiticamente detto e confermato concreta persona ben interna a
quegli ambienti e contemporaneamente cooperante coi servizi. Chiedeteglielo per
conferma (non mi costringete a dare la "solita" prova).
Mancava integralmente la lettura storico politica e questa è divenuta
completa e possibile con quattro anni di lavoro, perchè nella smania malata di
distruggere Paolo Ferraro sono stati messi in campo il top delle attività e
delle metodologie ed il TOP dei rispettivi referenti.
SE e quanto a valle dopo la "scoperta" della Cecchignola e le
ulteriori a cascata, vi sia stata una diretta valutazione ancor
più "superiore"
interferente non possiamo dire con la stessa assoluta certezza con la quale
abbiamo informato che a livello nazionale fu "una scelta condivisa".
Ma a carte scoperte detto la nitidezza di alcune nostre analisi geopolitiche
e storiche e la nostra integrale ricostruzione di forze, metodologie, strumenti
ed attività sul piano tattico e strategico, non ha giocato nel 2011 e 2012 a
nostro favore: ha "aggravato" il giudizio sulle nostre effettive qualità
personali, e reso "inevitabile" il tentare di portare a termine la nostra totale
distruzione. Senza dimenticare che i due esposti memoria dell'ottobre
novembre 2012 avevano fatto saltare sulla sedia vari sepolcrini sbiancati dalla
preoccupazione: di qui anche la sguaiata e folle reazione del
tentativo/proposta di amministrazione di sostegno nel 2013. Poi i nostri
“approfondimenti” con prove analitiche nel 2014, le azioni sotterranee e
rappresaglie tra la fine del 2013 e il giugno 2015, e le ulteriori prove che
hanno definitivamente posto allo SCOPERTO tutto ed un nucleo operativo che si
poggia su basamenti non solo nostrani. Ora
sapete bene e con prove e riscontri analitici quello che per ventitre anni è
stato fatto. LA GRANDEDISCOVERY per punti essenziali e metodo. La semplice
verità è che quello che ho inizialmente scoperto e che mi ha portato a capire è
successo a me ed in quanto tale (anche se vi sono cose simili successe a molti,
selezionati per colpirli) solo a me... e la scommessa è stata dimostrarlo in
toto ed in vitro facendo rivivere integralmente in audio ed analisi
tutto. Dovete tutti aiutare me e voi a vivere l'esperimento reale e concreto che
ho messo INTEGRALMENTE a disposizione perché ciò apre cervello cuore istinto ed
anima. Il resto, analisi e approfondimenti, viene da solo ... o si capisce solo
con la integrale intelligenza di un reale NON PROPRIO rivivendolo anche
interiormente come proprio. Solo così il sapere REALE OGGETTIVO scientifico si
trasmette profondamente e realmente. Ecco il perché della mia attenzione agli
audio ed a vari aspetti emotivi descritti o trasmissibili mediante percezione
diretta. LA GRANDEDISCOVERY E' UNA GRANDE SCOMMESSA, la prima della storia ...
Questo è certo per tutti gli elementi e le realtà che vi confluiscono e per la
intermediazione sui vari piani da me gestita e portata avanti. Entrare e capire,
far entrare e far capire. Questo il compito collettivo primario, contrastando i
disinformatori e le manovrette atte a cercare di togliere dimensione ed idea al
tutto. Poi le analisi più storiche o sofisticate ed il progetto fatto di cultura
prove e politica che andiamo costruendo. COMUNQUE ....per i
pigri inguaribili (e gli gnorri in malafede) semplifichiamo qui, segnalando che
sono le prove concrete e le analisi ed i riscontri che contano con metodo
concreto e storico documentale, empirico e investigativo ( gnosis, e cioè
conoscenza reale scientificamente riscontrabile, mediante attività di
intelligence ), non i meri "racconti":
un magistrato ( noto, impegnato e ancor più stimato nel mondo giudiziario romano
e diagnosticato per caratteristiche e doti da tempi addietro) viene “messo in
mezzo “ con tecniche varie in stile servizi deviati, sin dal 1992, e già
attenzionato da prima, ma scopre sempre qualche minuto prima quello che non
doveva scoprire e che svela un intero vaso di pandora coinvolgente anche mondi
militari ed altri ( oltre quello che gli accadeva vicino), quando nel 2008
riesce ad acquisire prove che gli consentono di capire ed avviare una vera e
propria inchiesta, "sotto attacco concentrico". Per tappargli la bocca, visto
che continuava ad approfondire e capire, lo sequestrano nel 2009 con una
attività da tempo costruita nei suoi presupposti a tavolino dalla psichiatria
deviata secondo i moduli dell'ancient Tavistock Institute (ti accerchiano,
distruggono famiglie e situazioni personali e poi cercano di tombare il tutto
compreso l'accerchiato). L'operazione non riesce per vari motivi, tra cui
carattere coriaceo e speciale attitudini della vittima predestinata, così come
falliscono ed erano falliti i vari tentativi distruttivi e di inserire step e
profili nella vita dello stesso magistrato, un po' ingenuo e puro ma tanto tanto
"odiosamente" intelligente. Di fronte ad una valanga di prove montante cercano
di delegittimarlo per la via della ignominiosa dispensa dal servizio, ma questa
è talmente incongrua sul piano della nota e reale professionalità del magistrato
che fanno l'ennesimo autogol, a prescindere dal coacervo di falsità costruite a
tavolino e manipolatorie. Non paghi perseguono la via del
distruggerlo tramite la morte civile e l'infangamento e sinanche un incredibile
tentativo di nominare amministratore di sostegno, dopo aver avviato lo
strangolamento economico, destituendolo. Da ultimo tra il settembre 2013 ed il
giugno 2015 nel tentativo a tenaglia di distruzione dell'uomo ed intellettuale,
e dell'ultimo rapporto interpersonle (quinto) emergono prove finali conclusive
su vari piani, di rilievo generale. Dalla analitica ricostruzione con prove del
tutto emerge, e viene progressivamente analizzato, uno spaccato tecnico
metodologico, storico strategico a matrice anche internazionale, e la
normalissima e vera identità di quelli che si definiscono "poteri forti" e che
forti non lo sono più perchè INTEGRALMENTE posti allo scoperto, sinanche nei
patti e legami con associazioni criminali territoriali. LA "SUPER GLADIO" come
associazione per delinquere condivisa "bicromatica", strettamente inquadrabile
nella configurazione legale delle associazioni di stampo mafioso, alla cui
scoperta finale si erano "solo" avvicinati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
LA SUPER GLADIO. RISPOSTA A CHI OSCILLAVA TRA IL CHIEDERE E PROVOCARE: "Una
organizzazione siffatta, composta ai vertici da una nomenclatura trasversale di
qualche centinaia di persone di casta pubblico privata e militare e conseguente
articolazione sociale ( non sufficientemente guidata in modo diretto), con un
cordone cultural operativo e teorico alimenta artificialmente il mito di sè
(stessa) attivando tutti i simboli, metodiche e strumenti che si poggiano su
ignoranza, subcultura e "primitività". Una volta scoperta è inerme, ma può
ancora contare sul potere individuale dei singoli e sulle coperture di sistema e
sotto alleanze. Una volta spezzata la coesione, disarticolate le alleanze perché
incrinata la subalternità, può ancora contare sulle coperture di sistema e sul
"lavoro" di "pubblicità" informativo propagandistica e di condizionamento
culturale, ma "verso il basso". Non appena disarticolata la "fascia di
copertura" inesorabilmente, in fase di crisi, è assoggettata al vaglio di
opportunità della sua sopravvivenza e il numero dei "caduti" è direttamente
proporzionale alla intensità del giudizio di inopportunità suindicato ed alla
incisività della lucida azione avversa. La banalizzazione umana di Aleppe
coincide con la sconfitta della organizzazione criminale storicamente
determinata. Si riapre poi il nuovo ciclo storico. "Satana" in terra (banali
uomini e organizzazioni segrete) è nudo e ormai, grazie al nostro lavoro la
gente, e le istituzioni non deviate vedono uomini ed associazioni criminali per
quello che sono, sotto copertura e non - di fiori colorati - " Con ciò
introducendosi una riflessione dal titolo illuminante: "LA MITIZZAZIONE AUTOGENA
DELLE MOLTEPLICI REALTA' OPERATIVE OCCULTE DELLA SUPERGLADIO tra simbolismo,
racconti terrifici, informazioni devianti e numerologie primordialiste". Ma vi è
anche un sottotitolo più semplice, per il diverso simpatico avvocato
Franceschetti e correlati disinformatori di "apparato", e per gli adepti del
blog della "crusca della scuola", ostinati nel loro infantile ruolo
denigratorio, scambiato per missione disinformativa: " Come ti mitizzo una
organizzazione criminale non legata al territorio, e le sue operazioni ed
attività, disegnandola come realtà esoterica invincibile implacabile, pericolosa
, ingenerando artificialmente omertà e mantenendone la segretezza: Non era
il sistema, non era la Rosa rossa. E' un apparato deviato e segreto che ha
"esaurito " il suo ruolo tattico, e non lo sa, lo teme solo, confusamente, e
confusamente ormai agisce. Liberiamo l'Italia. LA GRANDE DISCOVERY IL
CASO PAOLO FERRARO E LE SORTI DELLO STATO. La grande discovery, un'inchiesta
circostanziata e corredata da un concreto impianto probatorio attraverso cui si
delinea il quadro di una occupazione sistematica dei gangli vitali delle
istituzioni da parte di organizzazioni deviate incistate nel cuore dello Stato e
nelle sue articolazioni. Ruoli, metodologie, strumenti e tecniche vengono messi
a nudo così come messi a nudo protagonisti e una dimensione strategica ignota
prima. Il golpe scientifico ed il ruolo della SUPER-GLADIO ed i collegamenti
internazionali necessari emergono dettagliatamente. IL CASO PAOLO FERRARO
utilizzato come pietra di paragone, strumento di analisi con prove e passpartout
alla conoscenza dei sedimenti del vero potere sotterraneo che tiene parzialmente
in pugno Repubblica e i tre poteri dello Stato, proprio in quanto il magistrato
noto e stimato fu attenzionato e "diagnosticato" sin dal 1992 come un pericoloso
potenziale "successore" troppo capace, indipendentemente e rigoroso per non
essere fermato, accerchiato, gestito ed infine ( a scoperte avvenute) sottoposto
al tentativo di distruzione più eccellente che sia a noi noto. Il CDD (Comitato
Difendiamo la Democrazia) indica tappe e strumenti di un apparato criminale che
può essere fermato ora che sono individuati proprio i segmenti anche
istituzionali e normativi che ha posizionato in un ventennio ed oltre di marcia
sotterranea, e che ne è plasticamente raffigurata già una prima nomenclatura di
vertice. La partita si gioca sensibilizzando le quote residue degli apparati
legali e non deviati dello Stato e se così non fosse avremmo già perso in
partenza, combattendo contro un apparato illegale che ha assommato la forza
dello Stato deviata, la forza militare anche internazionale, la forza criminale
della grande criminalità organizzata, la potenza degli apparati psichiatrico
sociali magistratuali costruiti sotterraneamente per venti anni e di metodologie
tecniche e attività di controllo su vari piani frutto della “intelligence”
internazionale, mentre tutti guardavano, abbindolati, al gioco della politica
visibile. A ciò si aggiunge la potenza intrinseca del capitalismo finanziario
nonchè infine la FORZA OGGETTIVA DISTRUTTRICE DELLA CRISI STRUTTURALE DEL
CAPITALISMO, almeno nell’anziano occidente in particolare mediterraneo, ad oggi.
Il nuovo progressivo regime totalitario a copertura pseudo democratica che va
macinando diritti libertà e sicurezza sociale, e squinternando valori società e
altro, si ferma solo chiamando a raccolta tutte le risorse sociali, statuali ed
internazionali, su una analisi completa e chiara e su proposte e priorità
conseguenti.
Ascolta il video su “Vera Tv”. Si parla anche del luogotenente De
Cicco. Si parla
del luogotenente dei Carabinieri De Cicco, in gravissime condizioni all’ospedale
per un brutto incidente. E’il quarto episodio che De Cicco subisce.
Le telecamere avrebbero permesso di vedere che contro l’auto di De Cicco si è
schiantata in contromano un’altra vettura. Commenta Paolo Ferraro: Imposimato
tace imbarazzato su Paolo Ferraro, vicende denunce e contesti, e racconta che
tra MD e Falcone vi era mero dissenso su mera questione istituzionale
strategica, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, tra
l’altro senza neanche spiegare perchè Falcone voleva una maggiore garanzia di
giurisdizionalità .. VERGOGNA. Chi ha l’ardire di raccontare che vi era mero
dissenso tra Falcone e la nomeKlatura di MD e che il tema era “la separazione
delle carriere” .. fa una operazione “amplificatrice di false versioni che hanno
gestito la copertura della guerra grave e sotterranea in atto dalla seconda metà
degli anni ottanta . Una operazione pertanto semplicemente di sviamento ed
occultamento.... sul fronte protetto interno della vera supermassoneria di
apparato … E lo fa mentre era assente allora e non conosceva…
Eppure Imposimato lo conosciamo con una veste
diversa.
Quando il
giudice diventa complottista…,
scrive
John B su “Giornalettismo.
Ad alimentare il circo delle teorie complottiste ci si mettono anche i
magistrati…
Ferdinando Imposimato è uno di quei magistrati che hanno legato il loro nome ad
alcuni dei più grandi (se non grandi discussi) misteri della storia italiana
degli ultimi decenni. E’ stato responsabile
dell’inchiesta giudiziaria per il tentato omicidio di Papa Wojtyla, per il quale
fu arrestato Ali
Agca, sospettato di
aver agito per conto di servizi segreti esteri che volevano togliere di mezzo il
papa che stava mandando a rotoli il Patto di Varsavia e la Cortina di Ferro.
Prima ancora aveva diretto le indagini sul rapimento di Aldo
Moro ed
ha preso parte – sempre in qualità di magistrato – a importanti inchieste sugli
affari di mafia. Da ultimo ha detto la sua sul caso della sparizione di Emanuela
Orlandi, un
altro mistero che chiama in causa terribili intrecci tra Vaticano, servizi
segreti italiani e stranieri, mafia e banchieri. Adesso Imposimato è un
avvocato, nonché presidente aggiunto (onorario) della Cassazione. Tra le tante
cose di cui si è occupato gliene mancava una: gli attentati dell’11 settembre
2001. Ma ha rimediato con un annuncio che sta già facendo discutere Web e media.
Imposimato sostiene che
la CIA sapeva in anticipo degli attentati e non ha fatto nulla per evitare che
accadessero. Di più: secondo Imposimato i grattacieli del World Trade Center
erano infarciti di esplosivi preposizionati che ne causarono il collasso. La
teoria complottista della demolizione controllata delle Twin Tower e
dell’Edificio 7 è una tra le più datate e diffuse storielle messe in giro dopo
l’11 settembre, ancora oggi cavalcata da una nutrita schiera di sostenitori
dell’auto-attentato.
In Italia è sostenuta da
Giulietto Chiesa (giornalista), Massimo Mazzucco (regista e fotografo), Maurizio
Blondet (scrittore), Dario Fo (attore), Franco Cardini (storico medievale),
giusto per citare quelli più conosciuti. Negli Stati Uniti la tesi della
demolizione controllata è abbracciata da Steve Jones (fisico nucleare), David
Ray Griffin (teologo), Richard Gage (architetto) e una innumerevole schiera di
altri personaggi che fanno da contorno. Inutile dire che dopo dieci anni di
teorie di ogni genere (l’ultima è quella dell’utilizzo di un esplosivo
“spalmabile”, derivato da un composto chiamato nano-termite) nessuno è mai
riuscito a produrre uno straccio di prova a sostegno di queste fantasie.
Imposimato sembra convinto di poter ribaltare la situazione e di riuscire a dare
“dignità giuridica” alle teorie complottiste, portando il caso diritto davanti
al Tribunale Internazionale dell’Aja. Almeno questo è un elemento di novità:
finora i complottisti si erano guardati bene dal rivolgersi ai giudici
nonostante affermino da dieci anni che le prove del complotto sono schiaccianti
ed evidenti (infatti le hanno trovate strimpellando sui tasti del PC e navigando
sul Web). Vedremo come va a finire, considerato che la comunità scientifica
(quella vera) non solo non ha alcun dubbio sulla responsabilità di Al Qaeda ma
ha anche prodotto fior di documenti che spiegano le dinamiche dei collassi
attribuendole alle caratteristiche intrinseche del materiale strutturale
(acciaio) e all’azione combinata degli impatti e del calore sviluppato dagli
incendi.
Né va sottaciuto che un vero e
proprio processo c’è già stato: il processo Moussaoui (il cosiddetto 20°
dirottatore) ha analizzato ogni particolare relativo agli attentati, comprese le
indagini dell’FBI e le segnalazioni della CIA, senza riscontrare alcuna
responsabilità di natura dolosa a carico delle autorità americane. Tra l’altro,
gli atti delle inchieste ufficiali già hanno evidenziato che non tanto la CIA,
quanto proprio l’FBI aveva elementi utili per individuare e rintracciare alcuni
dei dirottatori (lo stesso Moussaoui, Al-Mihdhar, i fratelli Al-Hazmi) dopo il
loro ingresso in USA, ma gli investigatori ebbero le mani legate dal sistema di
garanzie procedurali previste dall’ordinamento giuridico americano (circostanza
che ha contribuito non poco alla stesura del controverso Patriot Act).
Addirittura uno degli agenti dell’FBI che lavoravano sulle tracce di quei
terroristi inviò un messaggio profetico ai suoi colleghi: “Qualunque cosa
succeda, un giorno qualcuno morirà, e procedure o meno la gente non capirà per
quale ragione non siamo stati più efficaci e non abbiamo dedicato ogni risorsa
disponibile per affrontare questa minaccia. Speriamo che la Sezione Legale
dell’FBI vorrà difendere questa decisione, specialmente nel momento in cui si
saprà che a Osama Bin Laden, la nostra più grande minaccia, sono applicate
tutte le garanzie giuridiche”. La teoria di Imposimato, secondo cui la CIA non
informò l’FBI, è quindi sbagliata già in premessa. La cosa curiosa è che tutto
questo è scritto nero su bianco sul Joint Inquiry,
il rapporto definitivo dell’inchiesta condotta dal Congresso americano
sull’operato dei servizi di intelligence e di contro-terrorismo con specifico
riferimento al fallimento nel prevenire gli attentati dell’11 settembre. Questo
rapporto ha preceduto il ben più noto 9/11 Commission Report ed è di gran lunga
più importante perché mette a nudo tutti gli errori e le manchevolezze del
sistema di sicurezza anti-terrorismo degli Stati Uniti in quegli anni.
Probabilmente nessun complottista lo ha mai letto, compreso Imposimato. Del
resto chi volete che si metta a studiare un rapporto di 838 pagine? A leggere
ciò che scrivono i complottisti, si capisce bene nessuno di loro ha letto
nemmeno il 9/11 Report, che di pagine ne ha la metà. Non è nemmeno il caso di
parlare dell’inchiesta del NIST o degli atti del processo Moussaoui: decine di
migliaia di pagine e documenti. Purtroppo l’aspetto più triste della vicenda è
la ricaduta sull’immagine e sul prestigio della magistratura, già notevolmente
compromessa da altri episodi. A Imposimato (che di recente ha dichiarato che
Emanuela Orlandi è viva e risiede in Turchia assieme ai suoi rapitori)
si aggiungono le fantasiose teorie di Priore sulla strage di Ustica, a loro
volta riprese recentemente da altri magistrati di rito civile, per non parlare
delle sconcertanti “rivelazioni” del sostituto procuratore Paolo Ferraro su
sette sataniche massoniche e poteri occulti che controllerebbero quasi ogni
aspetto della nostra società. Ci sono almeno un paio di lezioni da trarre da
queste vicende. La prima è che queste fantasiose teorie, sostenute anche da
persone così “prestigiose”, finiscono per ipotecare la possibilità che
informazioni serie e fondate riescano a emergere dal minestrone. La seconda è
che la referenzialità di un individuo non è mai sinonimo di veridicità delle sue
affermazioni. A quanto pare la paranoia del complottismo può colpire chiunque
(anche se sembra manifestarsi con maggiore frequenza con l’avanzare dell’età
anagrafica…) e qualsiasi valutazione non può prescindere dalla sussistenza di
elementi oggettivi (prove documentali innanzitutto). In conclusione, non si può
che rimanere estremamente perplessi e sconcertati, ove si rifletta sul fatto che
troppo spesso le nostre vite e le speranze di fare chiarezza su vicende molto
gravi sono affidate a persone che solo nel tempo rivelano abnormi tendenze
paranoiche. Forse sarebbe il caso di implementare meccanismi che consentano di
individuare per tempo certe anomalie, almeno per coloro che esercitano funzioni
pubbliche così delicate.
Sono le 12.48. E' il 18
aprile 2011, un lunedì. Sul Pianoro di Colle San Marco, luogo di scampagnate e
di giochi sopra Ascoli Piceno, un uomo si aggira disperato. Tiene in braccio una
bambina e cerca sua moglie. L’uomo è il caporalmaggiore dell’esercito Salvatore
Parolisi, la donna scomparsa è Carmela Rea, che tutti chiamano familiarmente
Melania.
"Lo strano caso di
Melania Rea" (edito da da Fivestore - R.T.I S.p.A e collana di una serie di
Quarto Grado) è il primo libro su un mistero fatto di bugie, tradimenti,
segreti. Un delitto che divide l'Italia.
Tutto parte da una
misteriosa sparizione e dal successivo ritrovamento del cadavere. Da lì, da quel
bosco, inizia uno dei casi più intricati, contraddittori delle nostre cronache
giudiziarie, un giallo in cui tradimenti, segreti, bugie e sesso sfociano
purtroppo in un finale orribile. La penna è quella attenta di un abile scrittore
e cronista di nera, Antonio Delitala, giornalista professionista, saggista, che
è mancato all’improvviso poco prima di veder pubblicata la sua opera. “Scrivere
di un delitto non è motivo di morbosità. E' il desiderio di capire le cose, di
scoprire l’umanità sofferente che li ha generati”. Particolari inediti,
trascrizioni degli interrogatori, confessioni di Salvatore Parolisi (unico
indiziato dell’omicidio di sua moglie) allo stesso Delitala, arricchiscono il
racconto di questo giallo che è ancora un mistero assoluto della cronaca nera
italiana. Lo Strano Caso Di Melania Rea non è dunque solo un triste eufemismo
col quale appellare uno dei casi di cronaca nera più tremendi ed inspiegabili
dell’ultimo anno. E’ una tragedia che porta a sondare i numerosi dubbi che
l’opinione pubblica si pone sulle coincidenze e le contraddizioni del caso. Ma
soprattutto è un libro in cui l'autore cerca di mostrare l’interiorità di
Salvatore Parolisi, un Parolisi diverso e leggermente psicanalizzato da colui il
quale era diventato suo speciale confidente, Antonio Delitalia appunto, un
giornalista che si era appassionato al caso dell’omicidio Rea ed aveva da sempre
portato avanti l’innocenza del Parolisi. Si mostra nel testo tutta la visione
più sofferente di un Parolisi che ha vissuto barcamenandosi tra due storie
incompatibili, quella con la moglie e quella con l’amante. E, tra sogni
premonitori ed incubi nei quali rivede il volto della moglie, Parolisi non
sembra chiarire i punti ancora oscuri di questa vicenda. Ed è proprio questo non
saper spiegare o non voler spiegare a rendere poco credibile la sua innocenza.
"Scarsa sensibilità per
il dolore di una famiglia che ancora non si capacita della perdita di Melania",
spiega l'avvocato Mauro Gionni per esprimere il proprio disappunto circa
l'iniziativa dei giornalisti Ilaria Mura e Antonio Delitala. Questi ultimi hanno
infatti realizzato il progetto di pubblicazione del volume "Lo strano caso di
Melania Rea", in cui si narra delle vicende relative all'omicidio della giovane
donna di Somma Vesuviana scomparsa il 18 Aprile e ritrovata accoltellata dopo
due giorni nel Bosco delle Casermette in zona Ripe di Civitella. Il
rappresentante legale di parte dei Rea ha chiarito che il libro è "una
pubblicazione inopportuna, considerando che le indagini sono ancora in corso, e
che - sostiene l'avvocato - contiene solo riferimenti ad atti parziali, frasi
mai dette, o comunque riportate non fedelmente di agenti, avvocati, e altri.
L'uomo, secondo quanto
riferito dai colleghi del caporalmaggiore, mentre amici e parenti cercavano la
povera Melania, trascorreva le sue ore in caserma. Gli stessi colleghi hanno
suggerito a Parolisi: "Forse tua moglie aveva una relazione con un altro uomo,
forse è scappata con un altro". I militari, peraltro, alle forze dell'ordine nel
corso di un interrogatorio hanno riferito che Parolisi tra il 18 e il 20 era
molto preoccupato in parte per la scomparsa della moglie, ma soprattutto per la
possibilità che le recenti vicissitudini potessero portare allo scoperto le
relazioni extraconiugali che intratteneva con altre donne.
Nel corso delle
indagini è stato sentito l'ex sostituto procuratore aggiunto di Roma, Paolo
Ferraro; il suddetto aveva portato avanti delle indagini sulle eventuali
presenze massonico-sataniche entro l'ambito militare. Per dar credito alle
testimonianze raccolte, l'uomo sarebbe stato sottoposto a due perizie
psichiatriche che l'hanno identificato come individuo sano di mente. Tali
accertamenti si sono resi necessari in quanto il Consiglio superiore della
magistratura lo aveva sospeso per quattro mesi per presunta infermità mentale.
Secondo quanto
dichiarato dall'uomo, le sue problematiche si sarebbero sviluppate in
concomitanza con l'inizio di quel tipo di indagini all'interno del contesto
militare nella caserma romana della Cecchignola. Ferraro, in presenza dei pm
Davide Rosati e Greta Aloisi, ha dichiarato di aver visto una donna molto simile
alla vittima in prossimità della Procura di Roma un po' di tempo prima della
inspiegabile scomparsa. Non è ancora stata resa nota l'attendibilità delle
dichiarazioni, ma tale avvenimento potrebbe trovar riscontro nella dichiarazione
rilasciata da una amica di Melania, Imma Rosa, la quale aveva sostenuto che la
donna dopo aver scoperto la relazione extraconiugale del marito con una collega
di lavoro, aveva in un primo momento pensato al suicidio e successivamente
pensato di procedere per via offensiva denunciando pubblicamente la storia dei
due amanti.
Obiettivamente la
denuncia avrebbe danneggiato a livello lavorativo tanto il marito della vittima,
Salvatore Parolisi, quanto la sua amante, Ludovica Perrone. Quest'ultima avrebbe
infatti riferito agli inquirenti di aver ricevuto minacce dalla vittima nel
corso di una conversazione telefonica.
Unico indagato del
delitto è il marito della vittima, il caporalmaggiore Parolisi, con l'accusa di
omicidio. Intanto vi è un evento strano a danno degli investigatori. É un lavoro
da esperti professionisti, ribadiscono gli investigatori: sono state prese di
mira due colonne della magistratura e delle forze dell'ordine teramane. Il
maresciallo ha condotto le indagini per tutti gli eventi criminosi avvenuti a
Teramo. Il giudice ha esaminato il caso Enichem, l'omicidio Fadani e Rea.
Nella notte tra venerdì
18 e sabato 19 novembre 2011 chi ha cosparso di benzina le auto lo ha fatto in
modo per così dire professionale, professionisti che hanno operato sapendo
esattamente cosa e come fare, ben conoscendo i possessori delle due macchine
parcheggiate in via Colombo e via Brescia a Martinsicuro. Marina Tommolini, è
stata giudice monocratico a Giulianova e Teramo prima di diventare giudice per
le indagini preliminari. È stata anche pretore a Manfredonia, si è occupata di
indagini importanti legate alla Enichem, e dell'omicidio Fadani, ed è anche il
gip che si dovrà occupare del caso di Salvatore Parolisi. Il maresciallo
Spartaco De Cicco è un uomo di spicco del reparto operativo provinciale dei
carabinieri. Ha condotto le indagini su tutti gli omicidi degli ultimi tempi,
dal caso Fadani a quello di Adele Mazza. Oltre che a vaste operazioni antidroga
effettuate in provincia. Gli orari del doppio attentato si possono desumere
dalle telefonate di allarme giunte ai vigili del fuoco: la prima alle 5.14,
quando in via Brescia brucia l’Audi A4 del maresciallo De Cicco poi alle 5.35,
l'allarme per l'incendio in via Colombo che interessa l’Audi A6 bianca del
magistrato. I piromani hanno scavalcato il recinto di cemento cospargendo di
benzina la vettura, immediatamente prendono fuoco carrozzeria e pneumatici. In
seguito all'allarme giungono il prima possibile i vigili del fuoco da Teramo,
Nereto e Roseto degli Abruzzi spegnendo il rogo, ma oramai le auto sono
carbonizzate. Le indagini si concentrano nei fascicoli delle indagini tenute
dal giudice e dal sottufficiale, si cerca anche un solo indizio che unisca i
due attentati. L'unica cosa certa per adesso è il chiaro messaggio
intimidatorio che è stato lanciato come una sfida alle istituzioni dalla
malavita.
Un magistrato di Teramo
e un ufficiale dell'arma di Teramo, che si occupano del caso Melania Rea, sono
stati entrambi vittime di due attentati incendiari ai danni delle loro vetture,
realizzati alle cinque di mattina del 20 Novembre. Pochi giorni prima era stata
acquisita per tre ore dalla Procura di Teramo la testimonianza dettagliata del
magistrato dott. Paolo Ferraro, in merito: alla denunciata "presenza di sette
esoterico sataniche a partire dall'esercito; alle possibili connessioni e
coperture; al coinvolgimento di magistrati, avvocati, e psichiatri arruolati;
alle indicazioni relative alla inquadrabilità del fenomeno in un contesto più
ampio, che lascia intravedere rapporti e intrecci tra massonerie, satanismo,
poteri deviati, aldilà delle correlazioni con il "caso" Melania Rea. E sono
stati depositati dati e banca dati che illustrano altresì ascendenze
internazionali con utilizzo di tecniche e strumenti elaborati in ambiti militari
e dei servizi ". Intimidazioni a giornalisti, silenzio della stampa ufficiale e
una miriade di piccoli fatti fanno da corollario, oltre alle intimidazioni e
persecuzioni subite dal detto ultimo magistrato. Allontanato dal C.S.M. per una
presunta e mai dimostrata "Infermità", il dott. Ferraro è il Pubblico Ministero
che indagava su una organizzazione militare che coinvolgerebbe gli alti vertici
del potere in massoneria occulta, pedofilia, sette sataniche. La reazione dei
cosiddetti poteri forti nei confronti del P.M. non è tardata ad arrivare. Ma
anche gli interrogativi.
Legislatura 16 Atto di
Sindacato Ispettivo n° 4-06272
Pubblicato il 17
novembre 2011 Seduta n. 637
LANNUTTI – Ai Ministri
della giustizia e della difesa. - Premesso che:
il pubblico ministero
di Roma, Paolo Ferraro, ha condotto in prima persona un’indagine su una presunta
setta satanica, a cui avrebbero aderito anche alcuni esponenti dell’esercito, un
gruppo segreto che si riunirebbe in eventi dove confluirebbero riti esoterici e
banchetti a base di sesso e droga. Ad avvalorare questa pista ci sarebbero anche
dei file audio che contribuirebbero a dissolvere qualsiasi dubbio sulla tesi del
magistrato;
l’indagine di Ferraro
potrebbe, a detta dello stesso, intrecciarsi anche con il delitto di Ripe di
Civitella dove il 20 aprile 2011 fu ritrovata morta Melania Rea, moglie di un
caporalmaggiore del 235° Reggimento Piceno;
successivamente il
Consiglio superiore della magistratura (CSM), nella seduta del 16 giugno 2011,
come si legge su “giustizia quotidiana.it”, ha deliberato di collocare in
aspettativa per infermità, per quattro mesi, il pubblico ministero di Roma Paolo
Ferraro. Il provvedimento è stato adottato con una procedura d’urgenza, motivata
dalla asserita gravità ed attualità dell’inidoneità del magistrato ad adempiere
convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio»;
dopo la decisione del
CSM di sospenderlo per quattro mesi dal servizio per gravi motivi di salute, il
magistrato decide di rendere pubblica la sua vicenda cominciata quando nel 2008
andò a vivere nella città militare della Cecchignola, a Roma;
pertanto ad oggi Paolo
Ferraro rimane sospeso per quattro mesi per motivi di salute, nonostante lui si
dichiari perfettamente abile e a suo sostegno ci siano diverse perizie mediche
che lo certificano;
i difensori del
pubblico ministero denunciano l’anomalia dell’azione del CSM e hanno presentato
ricorso al Tar del Lazio per denunciarne l’illegittimità. In particolare gli
avvocati Mauro Cecchetti e Giorgio Carta hanno espresso forti critiche verso
il modus operandi del CSM nei confronti del loro assistito;
si legge sul sito sopra
citato: “Il procedimento cautelare seguito dal Csm risulta non solo costellato
di violazioni delle garanzie difensive, ma addirittura atipico, perché non
previsto da alcuna norma. Non risulta fondato su alcuna perizia medica, se non
una risalente al 2008 che, peraltro, attestava l’idoneità allo svolgimento di
attività professionali anche complesse”. Un particolare alimenta ulteriori
sospetti nei due legali: “Il Csm – hanno riferito gli avvocati – ha stranamente
ritenuto ininfluenti le numerose perizie mediche di parte, private e pubblica
del 2011, attestanti la specifica idoneità ed anzi qualità intellettuale del
magistrato, ed ha ignorato una denuncia analitica e argomentata depositata in
atti, che evidenzia fatti gravissimi a suo danno patiti dal 2009 in poi”. Il
pubblico ministero Paolo Ferraro non ha mai avuto provvedimenti disciplinari di
alcun tipo, mentre ha sempre avuto giudizi di ottimo rendimento, occupandosi di
inchieste anche importanti;
considerato che la
signora Milica Cupic, cittadina italiana, lamenta una serie di comportamenti
quanto meno opinabili di organi della giustizia militare e civile in ordine a
fatti da lei denunciati;
in più occasioni ed in
data 4 ottobre 2003, la signora Cupic ha denunciato gravi fatti a sua detta
ascrivibili a personaggi identificati e identificabili. In particolare riferiti
al suo ex marito, generale a due stelle e dunque alta carica dell’Esercito
italiano, che ella ebbe a denunciare già nel 1996 in relazione alla morte
violenta della propria figlia e di un sottoufficiale dell’Esercito avvenuta il 3
febbraio 1986;
secondo quanto riferito
dalla stessa signora Cupic ella avrebbe altresì avuto modo di segnalare come un
alto grado della Guardia di finanza avrebbe favorito la promozione al suo ex
marito. Tale personaggio sarebbe poi diventato Comandante Generale della Guardia
medesima;
la Procura della
Repubblica di Roma, dopo aver ricevuto l’esposto firmato dalla signora Cupic, lo
avrebbe trasmesso al Procuratore Aggiunto, dottor Ettore Torri, come esposto
anonimo, mentre, ad avviso dell’interrogante, ne risultava esattamente
identificato il soggetto che lo aveva inviato;
tali denunce sono state
archiviate, ma è evidente che in tal caso la signora Cupic avrebbe dovuto essere
indagata per calunnia, cosa che non è mai avvenuta;
sembra per la verità
che la denuncia della signora Cupic in merito alla morte del Sottoufficiale e
della propria figlia siano state archiviate, giustificandole con il fatto che la
signora sarebbe affetta da «sindrome delirante lucida» e che di ciò la procura
militare, per quanto riferito dall’interessata, sarebbe stata informata nel
1996, in modo improprio dal Tenente Colonnello dottor Corrado Ballarini di
Bologna. La Cupic ha avuto più incontri, di sua spontanea volontà con il
Capitano psichiatra criminologo Marco Cannavici nel 1995 presso il Policlinico
Militare Celio di Roma, il quale fece in effetti un rapporto al direttore del
Celio pro tempore sullo stato psicologico della signora, nel quale tuttavia mai
pronunciò la diagnosi che avrebbe portato all’archiviazione;
in data 15 gennaio
2005, la signora Cupic presentò alla procura militare di Roma una formale
denuncia contro il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Giulio
Fraticelli, per «omissioni in atti d’ufficio», in relazione alle denunce
presentate nei confronti dell’ex marito ed alla documentazione a suo dire
inviata al generale Pompegnani. Il generale Fraticelli avrebbe comunicato alla
signora Cupic di aver relazionato al procuratore Intellisano, il quale,
peraltro, in un incontro avvenuto con la Cupic il 7 dicembre 2004, negò di aver
mai ricevuto alcuna cosa;
della denuncia di cui
sopra esiste traccia nella lettera che la Procura militare della Repubblica
presso il tribunale militare di Roma ha inviato allo studio legale Lombardi in
data 16 maggio 2005, (Numero 8/C/04INT «mod. 45» di protocollo) a firma del
Procuratore Intellisano;
nel dicembre 2004 la
Cupic ebbe a presentare una denuncia alla Procura Militare contro il Tenente
Colonnello Ballarini inviandola al A.G. Maresciallo Cervelli;
considerato infine che
la sospensione del dottor Ferraro, improvvisamente ritenuto inadatto ad
adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio,
appare all’interrogante di dubbia legittimità, si chiede di sapere:
di quali informazioni
disponga il Governo sui fatti esposti in premessa;
quali iniziative di
competenza intenda adottare.
Intervista a Paolo
Ferraro, magistrato sospeso misteriosamente dal CSM. Su Agenzia Stampa Italia
Salve e benvenuto. In
queste settimane, il caso mosso intorno al nome del Magistrato Paolo Ferraro ha
lasciato esterrefatta la pubblica opinione. Come rivelato ai microfoni
di SkyTg24, Lei sostiene di aver riscontrato in prima persona, durante il Suo
periodo di residenza presso la cittadella militare della Cecchignola,
comportamenti ed attività “non normali”, scoprendo un mondo “sotterraneo,
sconosciuto, poco chiaro, ambiguo, fumoso”. Attenendoci chiaramente ai limiti
imposti dal segreto istruttorio, può dirci più nel dettaglio cosa ha scoperto
attraverso le sue indagini?
Sporsi a suo tempo nel
Novembre 2008, una Denuncia immediata, avendo proceduto ad un primo ascolto di
registrazioni audio relative a sei mattine e due pomeriggi, registrazioni che
effettuai avendo acquisito una serie di elementi che lasciavano sospettare una
“situazione ambientale” inquietante. Ebbi dichiarazioni conformi che la
disegnavano a grandi linee, e feci ascoltare l’audio sia ad un ufficiale di P.G.
particolarmente qualificato, che ad una psicologa incaricata tramite avvocato
che ritenevo di fiducia, psicologa cui avevo conferito il compito di un sostegno
esterno e affiancamento, ovviamente alle persone da me ritenute vittime dirette
o indirette. La qualità dell’audio non era ottimale, anzi era mediocre, sicché
indicai subito la necessità di procedere ad elaborazione del volume ed ad un
attento ascolto tramite programmi adeguati. Sia l’Ufficiale di P.G., a titolo di
amicizia e stima personale, che la psicologa, vagliarono la evidente anormalità
della situazione ed anzi quest’ultima in un ascolto durato più di due ore e
mezza fornì valutazioni, preoccupate, mentre l’Ufficiale di P.G. parlò di un
fenomeno collettivo complesso e allarmante. Dall’ascolto attento emergevano
attività già indicate nella conferenza, ma più in particolare la possibilità di
individuare uso di sostanze, tecniche o procedure verbali a prima vista
inquadrabili come volte al condizionamento dei soggetti che li ricevevano, ma
soprattutto un contesto veramente anomalo con ingresso di numerose persone di
varie età, senza suonare prima, ed utilizzando chiavi in loro possesso ed una
posizione di soppesabile assoggettamento della persona che abitava
nell’appartamento. Il tutto secondo una analisi fonica poi progressivamente
approfondita da me e da un perito fonico, cui diedi il solo incarico di
trascrivere quanto emergeva dalla sola prima registrazione. Comunque alcune
frasi apparivano curiosamente pronunciate dagli astanti con tono metrico
cadenzato o musicaleggiante, in un paio di casi per fonemi riconducibili a
linguaggio “medievalistico”, e colpivano altresì alcune frasi tipiche sintetiche
espresse come comandi brevi, cui di norma le risposte erano un assenso implicito
ovvero dei “si” che colpivano per atonia ed inespressività. Tra i comandi
ricorrente una espressione “nessuno vi è adesso” ovvero “ se andiamo via non c’è
nessuno”, ovvero “ dobbiamo apparire, dobbiamo riapparire”, ma l’elenco sarebbe
lungo. Il contesto sembrava ad un ascoltatore inesperto come io ero
farneticante, torbido, non riconducibile ad esperienze ordinarie. Anche le
modalità di interazione verbale dei soggetti erano talmente inusuali, talvolta
cupe, e vocalmente atipiche da lasciare interdetti. Tutto ciò non fu sentito
dalla P.G. incaricata. Ma vi erano complessivamente nelle registrazioni più di
dieci tra adulti, maschi e donne, e almeno quattro non adulti. Almeno otto i
nomi pronunciati. Nelle registrazioni “per decreto” emergevano “frasi, parole e
rumori riconducibili alla normale attività quotidiana di una persona all’interno
della propria abitazione”. E la persona autrice dei racconti, ma assoggettata,
negò poi tutto. Nessuno gli contestò quello che si sentiva. Ma io avevo altri
accertamenti fatti, alcune registrazioni di telefonate o colloquio tra presenti,
sms ed e-mail utilmente valutabili, feci accertamenti ricordando particolari a
suo tempo raccontati, e, dopo l’archiviazione del procedimento, rimasto
sbalordito, elaborai le basi audio potenziandone il volume ed estrapolando
circa 45 frasi e contesti divisibili sulla base di una precisa griglia logica di
classificazione. Non posso dire altro, oltre che a suo tempo solo alcuni amici
miei ascoltarono e mi confermarono l’ascolto mediante adeguato strumento audio.
Feci una parziale discovery con gli “interessati” e come mi era successo nel
Gennaio del 2009 accadde un qualcosa, uno strano incendio sul terrazzo della mia
casa in villetta che mi spinse ad andarmi a lamentare della circostanza con
l’ufficio mio, che mai mi aveva ascoltato direttamente, né aveva valutato in
alcun modo la massa del materiale di prova o indiziario da me raccolto. Il
giorno dopo, trasecolando, subii una proposta di TSO eseguita a tempo
di blitz in forma coattiva, in assenza di ogni presupposto di legge formale e
sostanziale. Quanto segue è anche oggetto di procedimento penale, solo poi
scopersi di rapporti intrecciati a mia totale insaputa e alle mie spalle e del
ruolo di uno psichiatra che aveva preparato per lo strumento alcuni miei
parenti in rapporti comprensibilmente complessi con me. Oggi so che modalità,
tempistica, organizzazione e metodi hanno clamorose conferme anche in clamorosi
precedenti, basta documentarsi. Ad oggi molte persone hanno valutato, condiviso
valutazioni e pubblicato articoli coraggiosi, fedeli e suggestivi per la
suggestività della storia, su internet, nel silenzio assordante di una certa
stampa cartacea ufficiale.
Se fosse confermato un
simile quadro dei fatti, questo sconvolgente scenario esoterico potrebbe
allargarsi anche ad altri ambienti militari ed è pertinente ipotizzare dei
collegamenti internazionali con simili organizzazioni “deviate” nel resto del
mondo?
Ero concretamente a
conoscenza di viaggi a nord, e verso Napoli. Del pari di una possibile forma,
apparenza politico–militante del gruppo, della presenza ragionevole di
ufficiali, alcuni dei quali individuabili foneticamente o perché da me
osservati, della presenza tra essi di un uomo dalla voce autorevole arrogante la
cui attribuzione a persona è possibile tramite un quadro indiziario concreto e
riscontrabile. Fatti concreti, elementi verificabili, non altro. Incredibilmente
quando, uscito da un silenzio costretto, raccontai di fatti, contesto,
conseguenze patite, trovai un atteggiamento di assoluta volontà di non
ascoltare. Fatti precisi indicati sarebbero diventati “frasi criptiche”,
“allusioni incomprensibili”, o giudizi “sommari” di assoluta
“inverosimiglianza”. Chi li ha pure riportati davanti al CSM, che ha fondato su
tali giudizi un provvedimento grave di sospensione cautelare, a fronte di
statistiche ineccepibili e numerose certificazioni di sostanziale perfetta
salute, non ha tenuto conto di chi fossi, della mia storia, delle mie note
capacità, della circostanza peraltro a loro non nota, che era stato depositato
un memoriale analitico, chiaro e riferito a fatti oggettivi in una Denuncia a
Perugia. La situazione derivatane è assurda, ma presagisco molto di più. È tutto
quello che mi è accaduto dal 2009 in poi, pressioni, intimidazioni indirette,
inviti ripetuti a tacere, e gli eventi dal Marzo ad oggi che hanno squarciato
ulteriori veli. In particolare è vero che io ho notato una donna talmente tanto
simile a Carmela Rea in un orario non d’ufficio nei corridoi della procura di
Roma, da farmi affermare ancora oggi che era lei o potrebbe essere una sosia e
comunque nessuno mi ha mai detto chi fosse, perché fosse accompagnata ad un
colloquio riservato alle 19 di sera. Alcuni articoli su internet lanciavano
ipotesi parallele alle mie rilevazioni, in Roma, ma soprattutto su internet
venne fatto il nome di un alto Ufficiale dell’Esercito e qui debbo fermarmi.
Il provvedimento che ha
più lasciato interdetti è stato indubbiamente la sospensione per un periodo di
quattro mesi, stabilita dal CSM lo scorso 16 giugno 2011, ufficialmente “per
gravi motivi di salute”. Come spiegate questa decisione e quali saranno le
principali armi giuridiche cui ricorrerete per opporvi alla decisione?
La decisione, purtroppo
si spiega da sola per abnormità, atipicità, essendo carenti entrambi i requisiti
rigorosamente chiesti per un provvedimento di dispensa dal servizio . Ma
intendo precisare che in casi del genere disinformazione, assenza di conoscenza
di dati reali e presunta attendibilità di indicazione fornite da vertici di
uffici, o da presunti autorevoli soggetti con responsabilità “politiche” tra i
magistrati può avere influito. Il provvedimento allinea documenti, che risultano
oggettivamente e criticamente essere destituiti di fondamento, allegando indizi
concreti, prove documentali e informazioni ignote al CSM. Quello che colpisce è
che sembra che nulla sia accaduto, tutto viene inanellato lasciando fermi,
errori valutativi, disinformazioni su fatti precisi. Ma agli atti della
commissione è stato depositato un memoriale approfondito, in copia, neanche
letto, sembrerebbe. Ma continuo ad avere fiducia che fatti e dati verranno
realmente approfonditi. Se mancherà l’approfondimento necessario, ne potremo
trarre varie altre conclusioni. In questa vicenda è a me apparsa evidente una
particolare “collocazione” di due magistrati e ho dovuto fornirmene una
approfondita spiegazione, che si riverbera sul rilievo e sulla importanza
generale dei fatti. Un probabile epicentro. Ma è proprio la magistratura a
dovere indagare e valutare. E se non si indaga a fondo non si valuta e se non si
valuta non si indaga. Ma se si colpisce chi ha valutato a fondo per conto suo, e
ormai indirettamente tutti quelli che condividono valutazioni ed altro, i
ragionevoli inquadramenti e le ipotesi accertabili si fanno prospettive
concrete. Inquietanti, e perciò io chiedo al CSM di dissipare veli e dubbi e di
vagliare fino in fondo, a tutela della immagine e credibilità dell’organo di
autogoverno della magistratura.
Paolo Ferraro risulta
essere, da più fonti, un magistrato integerrimo e molto stimato nel suo ambiente
di lavoro. Dopo la sentenza del CSM, quali sono state le reazioni dei suoi amici
e colleghi? Ha percepito degli improvvisi cambiamenti in alcuni dei suoi
rapporti inter-personali?
Vi è stato sgomento,
sbigottimento, incredulità , nei miei confronti, e preoccupazioni per me, per
sé e generali: come starà, ammesso che stia male come dice il vertice
dell’ufficio, ma se la vicenda è vera in tutto od in parte riscontrabile, se
gli hanno fatto quello che ha poi denunciato, cosa può succedere anche a noi, se
lo appoggiamo o se ci trovassimo per sbaglio in una situazione analoga?!. Ma lo
stupore nasce da un prevalente meccanismo di autodifesa psicologica: non voglio,
non posso credere, ho paura di credere e ragionare su questi fatti. Avete
parlato mai con un malato terminale , che discetta di influenza non curata bene
o di piccola bronchite, la speranza e la paura si tramutano in negazione
psichica dei fatti, della realtà. Ma chi ha mai parlato di credere. Ho detto,
sappiate, verificate ascoltate, valutate. La paura, per me, per la storia, per
l’immagine dell’ufficio, per sé è per ora, prevalsa, ma nell’ambito ristretto e
solo in parte. Non sono invece mancati abbracci, in bocca al lupo, affermazioni
di profonda stima, da magistrati, avvocati e proprio da carabinieri che non
lavorano a stretto contatto con me. La frase detta circa quattro mesi fa, senza
preavviso, “noi stiamo con lei” e accompagnata da una duplice forte stretta di
mano. Io un po’ sbigottito, come ha fatto a spargersi la voce, visto il cupo
silenzio che circondava la vicenda..?! Il tono ?! Di chi sa di che storia si
tratti, e molti sanno, ritengo, della valenza generale della vicenda: un giovane
brigadiere di una stazione CC, sapeva tutto ed alla mia occasionale mera
battuta sulle UAV ( unità di addestramento ) ha fatto dei cenni inequivoci. So
per certo che molti sanno, e molti anche senza avere un ruolo qualunque. E
allora se di una vicenda strana, coinvolgente in apparenza solo due palazzine
sanno in tanti, in varie parti, come può essere un fatto solo locale? Non lo è,
ragionevolmente, e molto dipenderà dalle indagini di Ascoli Piceno (e a Teramo
un celebre processo ormai conclusosi in Cassazione sull’esercito bianco , a Roma
un procedimento di fatti e luogo omologhi, del 2000, e altri avvocati stanno
raccogliendo le tracce generali nella recente storia giudiziaria in merito a
circostanze che sembrano rinforzare la lettura unitaria del fenomeno).
Questa vicenda è appena
agli inizi e la battaglia che si appresta ad affrontare potrebbe non essere
delle più semplici. Nella rete, molti cittadini ed una parte dell’informazione
non-mainstream si sono stretti intorno a lei, mostrando grande attenzione e
stima per la sua storia. Quali sono le aspettative e le speranze di Paolo
Ferraro, sia come magistrato sia come uomo?
Verificare e capire,
allargando conoscenze e raccogliendo sensibilità e disponibilità. In fondo si
tratta solo di una struttura a base di setta, di gruppi di militari, di
impossibilità di accertare, di un magistrato della capitale sottoposto a TSO, e
su tutto il resto “trasversali dubbi”… un polpettone saporito non addentabile
agevolmente, ma siamo a dieta, il cuoco è un “visionario”, meglio non fare
indigestioni. I curiosi che credono alla democrazia ed ai suoi valori però non
la pensano così.
Le massonerie sono
ordini iniziatici e istituzioni gerarchiche rivolte alla conoscenza. I membri
delle massonerie sono definiti massoni e condividono valori morali, filosofici e
spirituali comuni. Nei secoli scorsi le massonerie sono sorte sotto forma di
associazioni di mutuo soccorso e come società segrete. In seguito assumono una
funzione più speculativa, trasformandosi in confraternite di tipo iniziatico e
mistico, caratterizzate dal segreto rituale. Gli affiliati di una massoneria ne
condividono gli ideali morali e le regole e sono organizzati in una rigida
struttura gerarchica dominata dalla figura del Gran Maestro. Al Gran Maestro
viene attribuito il più alto grado di conoscenza, a cui l'affiliato possa
aspirare. Le massonerie nel mondo sono migliaia e non è possibile quantificarle,
né qualificarle per i loro scopi, avendo ciascuna di esse un proprio regolamento
e proprie precipue finalità. In molti casi le massonerie sono regolari e
legalmente riconosciute dagli ordinamenti giuridici in cui operano (in Italia,
per es., la Gran Loggia Regolare d'Italia). In altri casi vi sono massonerie
spurie, che non hanno nulla a che vedere con le associazioni regolari, che
mantengono il loro carattere segreto o fenomeni di associazionismo locale che
celano il mero raggiungimento di interessi privati, favoritismo e aiuto
reciproco tra affiliati.
Dal punto di vista
storico la massoneria esiste fin dall'antichità. In origine le società segrete
hanno il fine di creare un Ordine, spesso parallelo, con obiettivi spirituali,
religiosi, culturali, economici o politici. Nel corso della storia dell'uomo si
sono avvicendate centinaia di migliaia di massonerie, tutte caratterizzate dal
numero chiuso degli affiliati, da un rito di accettazione e dalla presenza di
obiettivi comuni da perseguire. Durante il Medioevo le massonerie hanno avuto
anche il compito di conservare la conoscenza delle tecniche e del sapere. Le più
note sono le corporazioni di muratori composte dalle maestranze bizantine. Da
questo potrebbe derivare il simbolismo muratorio ancora oggi usato in molte
corporazioni. Nel corso del periodo pre-industriale le confraternite di mestiere
(corporazioni) perdono la loro ragion d'essere. Lo stesso accade con l'avvento
dell'Illuminismo alle massonerie dedicate alla conoscenza e alla ricerca
scientifica, le quali non devono più condurre in segretezza i propri studi e non
devono più temere le accuse di eresia. E' difficile tuttavia dare una
definizione generale della massoneria o riassumere un percorso storico del
fenomeno in poche righe. Ad esempio, gli Ordini massonici con finalità
spirituali o religiose non sono influenzati dall'illuminismo o dalla rivoluzione
industriale, avendo scopi diversi dalle altre corporazioni appena citate.
In genere gli storici
distinguono le organizzazioni corporative più antiche da quelle più moderne nate
alla fine del XVII secolo, in quanto non esiste un nesso di continuità tra le
corporazioni di artigiani medievali e quelle speculative nate successivamente.
Dal primo '800 all'epoca contemporanea le organizzazioni massoniche conservano
perlopiù obiettivi politici, culturali, spirituali ed economico-finanziari.
La piramide è un
simbolo antichissimo dalle origini tuttora oscure; il triangolo con l'occhio
(poi inglobato nel cristianesimo come simbolo divino) può essere fatto risalire
alla prima massoneria. L'utilizzo combinato di questi simboli si realizza
sostituendo al vertice della piramide il Delta Luminoso ed ha origine nel 1776,
quando il primo di maggio Adam Weishaput (che al tempo insegnava diritto
canonico all'università di Ingolstadt) fonda una società segreta nota come
Ordine degli Illuminati di Baviera. Weishaput definì l'occhio al vertice della
piramide "The Insinuating Bretheren" ma nell'ambiente era più conosciuto come
"Occhio Gnostico di Lucifero", od "Occhio Onnisciente". Il significato
complessivo della Piramide del Potere è l'ambizione stessa dell'ordine: un
governo mondiale guidato da una ristretta elite di sapienti, ovvero loro stessi.
Tra gli altri scopi dell'ordine vi era la trasformazione del cristianesimo in
una religione "scientifica", in cui la ragione prendesse il posto del divino.
Notare come la Piramide
abbia tredici livelli e alla base scritto MDCCLXXVI: questo simbolo è stato
studiato accuratamente in modo che chiunque conosca i significati delle metafore
utilizzate sia in grado di interpretarlo. MDCCLXXVI non è che 1776 scritto in
numeri romani, l'anno in cui nacquero gli Illuminati e in cui venne dichiarata
l’indipendenza degli Stati Uniti d’America; le tredici file di mattoni
rappresentano le 13 fasi di 13 anni l'una che gli Illuminati avrebbero seguito
per conquistare il potere: si parte dalla fondazione e si va fino al 1945.
Tuttavia, risalendo la piramide anno per anno, nel 1945 non si raggiunge il
vertice, ma lo spazio che separa il corpo della piramide (simbolicamente la
"Prima Era") dall'occhio.
Questo intercapedine va
interpretato in modo leggermente diverso: rappresenta infatti una fase di 26
anni (13+13) definita "Seconda Era" che inizia nel 1945 e termina nel 1971. Si
raggiunge così il Delta Luminoso, ovvero la "Terza Era". In progressione
geometrica, questa è formata da tre fasi di 13 anni l'una (39 anni in tutto) che
vanno dal 1971 al 2010. A questo punto, secondo i progetti degli Illuminati,
nessuno sarebbe più in grado di contestare l'ormai completo "Nuovo Ordine
Mondiale".
Questa è solo una delle
molte diverse interpretazioni di questo simbolo: il delta luminoso rappresenta
anche un elemento “divino” nettamente separato dalla materia (la piramide), ad
esso subordinata. Ingrandendo il Delta Luminoso si potrà notare come l’occhio
sia in realtà ben poco “umano” in quanto attorniato da squame. Gli illuminati si
consideravano infatti strettamente legati ad una antica specie rettile a cui
attribuirebbero l’origine della specie umana.
La Piramide del Potere
è oggi visibile a tutti sul fronte della banconota da un dollaro a sinistra del
Gran Sigillo. Qui sono presenti due scritte: in basso "Novus Ordo Seclorum" ed
in alto "Annuis coeptis". La prima è l'obbiettivo stesso degli Illuminati (il
Nuovo Ordine Mondiale), la seconda è il loro motto: "la provvidenza ha favorito
il nostro impegno" (tradotto anche come "Dio ha acconsentito"). La scritta in
basso conterrebbe un grossolano errore ortografico: la scrittura corretta
infatti sarebbe “Secolorum” e non “Seclorum”. In realtà questo non è un errore,
quanto piuttosto uno stratagemma usato dagli Illuminati per far sì che la
scritta sia composta da 13 caratteri.
La Piramide del Potere
venne mostrata al mondo per la prima volta il 4 luglio del 1776 sulla bozza
della banconota da un dollaro. Questa bozza verrà poi corretta varie volte
invertendo tra l’altro la posizione dell’Aquila calva (il Gran Sigillo) e quella
della Piramide (che al tempo si trovava a destra), prima della versione
definitiva del 20 giugno 1782. Il Congresso approverà l’utilizzo del Gran
Sigillo per rappresentare gli Stati Uniti il 15 settembre del 1792.
Successivamente, il dollaro verrà modificato numerose altre volte, nel 1933
Franklin Delano Roosvelt (Presidente degli Stati Uniti dallo stesso 1933 al
1945, nonché massone del 32° grado) fece coniare la prima banconota americana da
un dollaro con la Piramide ed il Gran sigillo sul lato posteriore (da allora ad
oggi si è mantenuta questa impostazione). La Piramide del Potere era visibile
anche sullo stemma del DARPA (Defence Advanced Reseach Projects Agency) prima
che, nel 2004, questo venisse modificato.
SIGNORAGGIO: AL VERTICE
DELLA PIRAMIDE. Che cos’è il signoraggio?
Si tratta di un diritto
dei "signori", adottato fin dal passato. Oggigiorno è una delle maggiori cause
di indebitamento pubblico e di ulteriore arricchimento dei potenti e dei ricchi.
Se ne parla poco, ma esiste, da secoli. Il procedimento è molto semplice: la
Banca Centrale Europea produce, ad esempio, una banconota con soli 5 centesimi
di spesa, ma l’affitta alle varie nazioni a 100 €. Ciò significa che la società
privata che stampa ed emette la banconota guadagna in pratica 95 €. Il
signoraggio corrisponde quindi alla differenza tra il valore nominale della
moneta (che troviamo scritto su di essa) e i costi di produzione della stessa.
Settimio Severo,
imperatore romano vissuto nel III secolo d.C., adottò anch'egli questo metodo,
dimezzando il materiale utilizzato per le sue monete, ma mantenendo identico il
valore nominale scritto su di esse. La differenza, materiale inutilizzato,
rimaneva nelle casse dello stato.
In Europa è la BCE
(Banca Centrale Europea) che detiene il diritto esclusivo di battere moneta,
arricchendosi alle nostre spalle. E, attenzione, si tratta di una banca privata!
Lo stato paga l’affitto della moneta con Titoli di Stato, indebitandosi e, alla
fine, chi ci rimette siamo sempre noi, poveri cittadini. Infatti, siamo noi a
pagare questo debito, con le tasse. Se invece fosse lo stato a battere moneta,
non vi sarebbero tasse. Ma si parla di abbattere un sistema ormai radicato da
secoli.
In passato le cose
erano diverse, perché un grammo d'oro valeva come un grammo d'oro. Una moneta
d'oro aveva un valore intrinseco, pari al suo valore nominale. Solo in seguito i
signori iniziarono a coniare monete utilizzando minor materiale prezioso, dando
vita al signoraggio. Fin dall’antichità la plebe ha sempre dovuto sottostare
alle scelte dei ricchi signori, uniti tra loro in logge di potere e società
segrete. La maggior parte dei politici presenti nei vari paesi del mondo, sia
che siano di destra sia che siano di sinistra, così come i grandi imprenditori e
i fondatori di importanti multinazionali apparterrebbero in molti casi a logge
massoniche, e dal vertice della piramide sociale controllerebbero il destino
degli uomini.
Guardacaso, la prima
banca centrale a livello mondiale fu proprio creata da un massone, William
Peterson, che la fondò assieme ad alcuni Fratelli approfittando della situazione
di debito pubblico nella quale si trovava il suo paese: si trattava della Banca
d’Inghilterra, ed era l’anno 1694. Già Karl Marx ne Il Capitale denunciava senza
mezzi termini le banche centrali, definendole “società di speculatori privati”.
La Banca d’Inghilterra venne presa come modello di riferimento da tutti gli
altri paesi del mondo. Perfino il Vaticano godrebbe del diritto di signoraggio,
per via delle molte medaglie ed emblemi messi in circolazione. Nella storia
dell’umanità ci furono persone che provarono ad abbattere questo sistema. Una di
queste è John F. Kennedy.
Nel giugno del 1964
sfidò la Fed (Federal Reserve Note), società privata che deteneva, e detiene
ancora oggi, il monopolio sul conio monetario. A novembre dello stesso anno, il
presidente venne eliminato, e proprio a Dallas, una delle sedi delle dodici
banche statunitensi. E prima di lui anche altri presidenti avevano tentato di
imporre una banconota statale; tra questi ricordiamo Lincoln, McKinley e
Roosevelt, tutti e tre uccisi. L'ex questore di Genova Arrigo Molinari citò in
giudizio Bankitalia per “la truffa del signoraggio”. Aveva l'udienza il 5
ottobre 2005, ma venne ucciso a coltellate il 27 settembre! Della serie: chi
tocca il signoraggio muore.
In Italia, il
signoraggio fino a pochi anni fa era diritto della Banca Centrale d’Italia e, in
seguito, della Banca Centrale Europea, entrambe private. Ma c’è di più. Tra le
banche socie di quest’ultima troviamo anche quella d’Inghilterra, di Danimarca e
di Svezia, associate rispettivamente al 15,98 %, 1,72 %, 2,66 %, pur non avendo
accettato di aderire all’Euro. Parte del signoraggio europeo finisce quindi
nelle tasche di queste società private estere. In pratica, noi italiani stiamo
aiutando questi tre paesi a pagare le loro tasse! Questi potenti, a parte il
signoraggio, utilizzerebbero anche altri metodi utili al loro arricchimento,
sempre alle spalle della povera plebe. I ricchi banchieri e i loro sostenitori
sarebbero infatti collegati anche a fondazioni, multinazionali e sette di
potere, come Scientology, l’Opus dei, e l’Amway corporation.
POLITICA E MASSONERIA.
Ma guarda un po’ cosa vai a scoprire da fonti notoriamente di sinistra, come può
essere un’intervista di “Repubblica” a firma di A. Statera. "Quando nel mondo la
canaglia impera, la patria degli onesti è la galera", recita ironico il Gran
Maestro del Grande Oriente d'Italia Gustavo Raffi, avvocato ravennate dal
profilo un po' risorgimentale, ex segretario locale del defunto Partito
repubblicano di Ugo La Malfa, quando gli si chiede di commentare l'improvvisa
fiammata antimassonica di parte del Partito Democratico. E l'Opus Dei? E
Comunione e Liberazione? E tutti i mariuoli, clericali o non, ormai in
circolazione per ogni dove? E tutti i seri problemi del paese che il Pd tende
spesso a rimuovere imboccando improbabili vie di fuga? Il Gran Maestro se lo
chiede, ma la delibera assunta dalla Commissione di Garanzia presieduta da Luigi
Berlinguer, proveniente da una vecchia famiglia massonica il cui capostipite
Mario, padre di Enrico e Giovanni, era Gran Maestro della Loggia di Sassari, in
fondo non gli dispiace: "Al di là della temporanea sospensione dei fratelli pd
iscritti - dice - c'è un percorso serio per capire la questione e non infliggere
una censura dogmatica; è un percorso laborioso, ma simile a quello già tracciato
saggiamente dal lodo di Valerio Zanone e Giovanni Bachelet". Ma non gli va giù
che i problemi interni di un partito in cui si è rivelata difficile la
convivenza tra l'anima cattolica ex democristiana con quella laica ex
repubblicana, ex socialista ed ex comunista, tirino inopinatamente in ballo "una
delle più importanti agenzie produttrici di etica che abbia creato dal suo seno
la storia dell'occidente, come il professor Paolo Prodi ha efficacemente
definito la massoneria".
Un fatto è certo, i
massoni del Partito democratico, che dovranno ora rivelarsi, sono a bizzeffe,
come garantisce l'ex sindaco comunista di Pistoia Renzo Baldelli. Col Gran
Maestro recalcitrante, che giura di non aver mai chiesto di mostrare la tessera
di partito ai suoi fratelli ("Se no verrei messo fuori dal consesso della
massoneria mondiale") tentiamo un computo, che ci porta a un totale di oltre 4
mila su quasi 21 mila iscritti in 744 logge, il 50 per cento dei quali
concentrati in Toscana, Calabria, Piemonte, Sicilia, Lazio e Lombardia, con la
maggiore densità assoluta a Firenze e Livorno. Di questi almeno 4 mila diessini,
molte centinaia ricoprono cariche politiche, amministrative o dirigenziali, come
in passato il Gran Maestro aggiunto Massimo Bianchi, che è stato vicesindaco
socialista di Livorno. Adesso dovranno rivelarsi ed è facile prevedere che non
sarà un'operazione indolore.
Ma Gustavo Raffi pensa
che potrebbe venirne persino un bene, cioè "la fine di questa leggenda della
segretezza, frutto avvelenato delle gesta del materassaio di Arezzo, che non ha
ragione di persistere. Ma come si fa - si accalora - a confondere il Grande
Oriente, scuola di etica e di classe dirigente, con i mariuoli che infestano il
paese anche in false massonerie? Il fascismo, perseguitandola, costrinse la
massoneria al segreto, ma oggi siamo un'istituzione trasparente tornata nella
storia. Lo dimostrano le decine di nostri convegni culturali con partecipanti
del calibro di Margherita Hack, Rita Levi Montalcini, Umberto Galimberti,
Giuseppe Mussari, Ignazio Marino, Paolo Prodi, Gian Mario Cazzaniga e tanti,
filosofi, storici, accademici di reputazione e scienza preclare. Il Pd si
accorge adesso che la sinistra è figlia anche della massoneria? Fanno fede i
nomi dei fuorusciti a Parigi durante il fascismo, le Brigate partigiane in
Spagna e la Costituente, dove su 75 membri 8 erano massoni, da Cipriano
Facchinetti ad Arturo Labriola, Meuccio Ruini... ".
Gran Maestro - lo
interrompiamo - per favore, non torniamo a Garibaldi e Bakunin e ai generi
massoni di Marx, il fatto è che in un passato più recente le vicende della
massoneria ufficiale non sempre sono apparse commendevoli. Tra l'altro, nel
governo e nella attuale maggioranza di destra si dice ci sia la più alta
concentrazione di massoni (e di Opus Dei) mai vista, come ha rilevato l'ex
presidente Francesco Cossiga, che se ne intende. A parte Berlusconi, Cicchitto,
che erano nella P2, e al consulente di Gianni Letta, quel Luigi Bisignani che ne
era il reclutatore, ce ne sarebbero molti altri, a cominciare da Denis Verdini,
che però ha smentito. Per non dire dei Lavori Pubblici, culla della Cricca degli
appalti, considerato il ministero col maggior numero di dirigenti massoni. Il
Gran Maestro non sfugge: "Io le posso dire in tutta coscienza che, tolti quelli
che giocavano a nascondino col materassaio di Arezzo e che con noi non hanno
nulla a che fare, abbiamo fatto un'attenta analisi dei nomi emersi come
appartenenti alla Cricca e delle intercettazioni telefoniche pubblicate sui
giornali. Abbiamo trovato solo un nome nelle nostre liste e l'abbiamo sospeso
immediatamente. Se ne emergeranno altri, stia certo subiranno la stessa sorte".
Inutile insistere per ottenere il nome, il Gran Maestro garantisce di non
ricordarlo, ma promette di ricercarlo, perché dice di sognare una massoneria
supertrasparente come quella americana, cui i fratelli sono fieri di
appartenere, dove le logge sono indicate al centro delle città con grandi
cartelli stradali, "come già abbiamo fatto a Ravenna mettendo la targa sulla
nostra sede, perché se ti nascondi finisci alla gogna". Ma nulla autorizza la
componente cattolica del Pd a confondere la massoneria storica con
pseudomassonerie affaristiche, "se no è come se io dicessi non che un partito è
degenerato, ma che tutti i partiti sono degenerati, mentre, pur se disastrati,
continuano ad essere il cardine della democrazia. Mai dirò che i partiti
inquinano la massoneria, ribaltando l'affermazione di quel parlamentare del Pd,
il quale ha osato dire che la massoneria inquina il suo partito". Se la teoria
del senatore di Magliano Sabina Lucio D'Ubaldo prendesse piede nel Pd, il Gran
Maestro vi scorgerebbe un arretramento clericale e culturale quasi a due secoli
fa, all'enciclica "Mirari Vos" di Gregorio XVI che condannò la separazione tra
Stato e Chiesa e qualunque libertà di coscienza.
Chissà se la delibera
dei garanti pd guidati da un Berlinguer frenerà ora le iscrizioni al partito,
notoriamente non in splendida salute, o al Grande Oriente d'Italia, che conta
1600 "bussanti" all'anno, più di un terzo dei quali respinti in attesa di
"passaggi all'Oriente Eterno" di anziani fratelli.
Bettino Craxi, l’ultimo
uomo di Stato. La storia è talvolta così distante dalla realtà, i fatti vengono
stravolti e la verità negata: così l’onore di un uomo viene sfibrato per
cancellarne la memoria e la sua stessa vita. Mentre tutti gli scagliavano contro
sentenze e ingiurie, mentre il magistrato Antonio Di Pietro spasimava per il
grande momento e qualcuno gridava “Tonino facci sognare”, sicuramente nessuno di
loro sapeva che lui aveva tentato di salvare l’Italia, e così non restava che
un’unica soluzione: andare via il prima possibile, una fuga immediata.
I fatti erano ben
diversi, alle spalle vi era un piano, chiamato “Apocalisse”, studiato nei minimi
dettagli e gestito direttamente da Londra (Secondo David Icke Londra sarebbe il
centro del controllo globale). Nacquero in quegli anni in Italia molte scuole di
lingua inglese, come copertura dei servizi segreti; molti agenti del Sisde e del
Sismi furono intimoriti, altri si suicidarono: la campagna mediatica dei
giornali, e non solo delle televisioni, avanzò impietosa. L’obiettivo di fondo
consisteva nel rovesciare i governi e porre al potere dei criminali, dei
“contadini”, di destra e di sinistra, islamici e non, per poi privare uno Stato
della sovranità monetaria, privatizzare ogni cosa e rastrellare le ricchezze
esistenti, creando così un sistema economico completamente diverso, quello del
“rent”, dell’affitto, basato dunque non più sul concetto di possesso, bensì su
quello di uso. Un ambizioso progetto da realizzare mediante la svalutazione
della moneta, la riduzione della spesa pubblica, la deregolamentazione del
mercato con politiche liberiste, la fissazione di alti tassi di interessi, con
la lotta alla corruzione, la privatizzazione del patrimonio statale e della
Banca Centrale, ed infine la rifondazione della Nato come organismo militare per
sabotare le iniziative dell’Onu.
In realtà il
signoraggio non è il solo problema, ma è un anello di un meccanismo molto più
complesso che si serve di una forma di potere centralizzata e piramidale,
andando a creare quelle che molti studiosi definiscono società “rettiliane” o
demagogie pure. Un sistema questo che si è rivelato efficace, dobbiamo
riconoscerlo, in contesti medievali in cui non esisteva la comunicazione di
massa, le attuali tecnologie e forme di crimine psicologico: la nostra società
rimane tuttora ancorata a schemi di potere antichi e arcaici.
Craxi, come qualcuno
prima di lui, aveva intuito che il sistema era concatenato perché ragionava come
un uomo di Stato, ed è stato tradito dal serpente che è dentro in noi. Voleva
salvare l’Italia, parlava di svolta, di cambiamento e di rinnovamento, parole
che certamente hanno fatto tremare gli eminenti Banchieri di Londra. Craxi
cercava di combattere uno degli anelli del sistema tramite la “lira pesante”,
che consisteva nel coniare la “5 lire in argento” con l’effigie di Garibaldi,
cosa che sicuramente non è stata ben gradita alle lobbies bancarie che scatenano
guerre sanguinarie solo per imporre il costo di una commissione bancaria in un
paese.
Mentre cercava di
salvare l'Italia, si accorse cos’è veramente il “potere”. Ho sacrificato la mia
vita e venti anni di studi e di ricerche per capire ciò che i politici
sostanzialmente dicono in frasi del tutto accidentali. Egli intendeva rifondare
il tessuto sociale, il modo di fare economia, e il concetto stesso di
partecipazione politica perché aveva intuito che il mercato si stava
trasformando: l’economia cresceva tra usura e collusione , e da tempo ormai era
in atto un etnocidio, ossia lo sterminio dell’identità etnica, delle tradizioni,
e della cultura mediante strategici piani di “globalizzazione” e
l’appropriazione dell’intelligenza dei popoli.
Tutto quello che si è
realizzato con il Trattato di Maastricht è stato accuratamente programmato nel
1978 da un piano strategico e complesso, che già allora fece le sue prime
vittime. Maastricht si è appropriato del potere democratico per antonomasia in
quanto va incidere sulla redistribuzione della ricchezza reale, trasferendo in
maniera illegittima e incostituzionale la sovranità monetaria ad un ente non
rappresentativo della volontà sovrana dei cittadini. L’unione monetaria ha
creato una macchina che distrugge, depreda e porta guerra tra i popoli; la
banca, dal canto suo, si finge un’istituzione, che entra come un parassita
nell’azienda per alimentare un sistema di denaro virtualizzato. I Grandi
Banchieri si sono resi responsabili dell’olocausto, senza che nessun tribunale
internazionale li abbia mai condannati, e continuano a sterminare popoli in
maniera sempre più subdola in forma di etnocidio.
L’eurosocialismo è
caduto. Tutte le colonie del regime comunista sono state attaccate perché i
sistemi economici ibridi tra comunismo e capitalismo andavano eliminati ad ogni
costo in modo da evitare anche lo scontro diretto con la civiltà araba: ed ecco
perché Craxi era considerato un filo arabo.
Nel 1992 non era più
possibile salvare l’Italia e Craxi aveva un compito tanto complicato quanto
impossibile da portare a termine. Mentre Maastricht vedeva nascere l’Europa dei
Banchieri Ladroni, la magistratura arrestava Mario Chiesa, e procedeva con gli
avvisi di garanzia che avrebbero portato avanti la crociata contro “la
corruzione”. Nel luglio del ’92 le parole di Craxi alla camera dei deputati
denunciano una criminalizzazione della classe politica, un vero e proprio
processo storico e politico ai Partiti, e "un finanziamento irregolare ed
illegale al sistema politico,... non è e non può essere considerato ed
utilizzato da nessuno come un esplosivo per far saltare un sistema, per
delegittimare una classe politica”.
Il Buon Tonino
probabilmente solo quando fece il grande gesto teatrale di togliersi la toga
dinanzi alle telecamere e di rassegnare le dimissioni dalla magistratura, diede
prova di aver capito che era stato usato e manipolato come una pedina in una
guerra strategica senza scrupoli. Ma il nostro ex commissario doveva capire che
il sangue sporco si deve mischiare con quello nuovo. Mani pulite è stato dunque
qualcosa di più, aveva l’obiettivo di controllare le masse, eliminare la classe
politica e sostituirla con soggetti dalla mente semplice e poco intelligente,
assolutamente inadeguati a contrastare i veri poteri, mentre le privatizzazioni
e il saccheggio dell’Italia proseguiva.
Il caso dunque volle
che i folli avevano arrestato i sani, e la storia insegna che chi si mette
contro questi poteri va eliminato: Jesus fu crocifisso perché chiedeva a Cesare
perché sulla moneta veniva coniata necessariamente la sua immagine, l’oro in fin
dei conti è sempre oro. “Dai a Cesare ciò che è di Cesare”, ma molti non sanno
cosa vuol dire realmente e se lo sapessero credo che diventerebbero tutti
improvvisamente kamikaze.
Nello stesso anno,
Giovanni Falcone in una macabra esplosione accreditata alla mafia trova la
morte; così come l’ingegnere Raul Gardini che muore per mano di un anomalo
suicidio: episodi che in realtà nascondono ben altro. Lo stesso scenario che si
è venuto a creare ultimamente in Libano con Hariri, che stava organizzando la
borsa del Petrolio in euro. In quel periodo tutti gli ambasciatori e le
Associazioni sconosciute millantavano democrazie sconosciute, e si
meravigliavano scandalizzati della corruzione in Italia, ma non ricordano ciò
che la Federal Reserve fece nel 1923, da cui il motivo che spinse gli americani
a combattere una guerra mondiale.
A colpire Craxi è stata
la finanza internazionale, i Banchieri, un mondo sconosciuto alle masse,
gerarchie ristrette e estremamente chiuse, persone che non vedrete mai camminare
tra la folla. Lo temevano così tanto che al pensiero che Craxi potesse trovarsi
in suolo italiano e rilasciare scomode dichiarazioni li preoccupava seriamente,
tanto è vero che era costantemente controllato ad Hammamet.
Le sue parole devono
essere di insegnamento a questi politici contadini, diventati i camerieri di
Banca Intesa e Unicredit e non più protagonisti della regolamentazione del
sistema economico. Si sono autodefiniti pastori del gregge, ma bisogna ricordare
che l’unico uomo di Stato che non è stato accettato dall’Inghilterra era Craxi,
contrastato dagli stessi giornali che ora santificano Carla del Ponte e additano
Slobodan Milosevic per aver condotto una pulizia etnica.
Oggi è l’era dei
pappagalli, della civiltà schiavizzata dai banchieri, agganciati a loro volta ai
servizi segreti, che hanno creato “comitati di controllo e gestione delle
crisi”, utilizzando strutture come la Gladio, e Società di sicurezza per
compiere qualsiasi tipo di attentato e di omicidio.
La velocità della
magistratura nel vendere l’ Italia è stata strabiliante. Accusare Bettino Craxi
è stato come chiudere la porta in faccia allo Stato stesso, per il quale si sono
combattute guerre, alzate barricate, in nome di una bandiera si moriva con onore
dinanzi al plotone di esecuzione, gridando “Viva l’Italia”. Tutto questo non è
servito a riunire gli uomini, ma a distruggere la fratellanza, perché alla guida
di una nazione erano stati posti piccoli uomini e non Statisti, banali
intellettuali che non sapevano cos’è davvero il potere. Spero che oggi la nostra
classe politica abbia capito che siamo posseduti dal sistema bancario, e che
hanno venduto l’Italia a dei baroni Ladroni.
IL MISTERO SULLA
MASSONERIA. Massoneria, politica e criminalità. L’importanza dell’inchiesta di
De Magistris, e la dimenticata inchiesta Cordova. Ci aiuta a capire un resoconto
del Prof. Paolo Franceschetti.
L’inchiesta portata
avanti da De Magistris probabilmente tocca quello che a nostro parere è il
problema più grosso del nostro Stato, da decenni: i rapporti tra criminalità
organizzata, politica e finanza. Pochi si ricordano dell’inchiesta che nel 1992
Cordova fece sulla massoneria calabrese. E pochi hanno notato le similitudini
con l’attuale inchiesta di De Magistris. Vale la pena di ricordarle. Prima però
segnaliamo che oggi tutte queste inchieste – ma molto altro ancora - sono
raccontate in un libro, Fratelli d’Italia, di Ferruccio Pinotti. Il libro è
grande, 800 pagine circa. E’ ben documentato, e contiene anche interviste ad
alcuni Gran maestri di diversi Riti. Ma da esso è possibile ricavare alcuni
punti fermi che possono essere oggetto di approfondimento.
Analizzare il sistema
massonico, e capire tutte le implicazioni che comporta questa istituzione, le
interferenza con la società, con la giustizia, ecc., è una cosa impossibile da
fare nelle poche righe di un articolo. Sarebbe un po’ come voler spiegare il
funzionamento del mondo in poche righe. Il nostro scopo quindi è solo fornire
alcuni spunti di riflessione per permettere poi un ulteriore approfondimento a
chi lo vorrà fare, rimandando ad altri libri o testi. Evidenziando, in
particolare, quei punti che vengono di solito trascurati quando si parla di
massoneria, che sono importanti per capire realmente il sistema nel suo insieme.
In massoneria sono
iscritte in Italia circa 50.000 persone, tra iscritti ufficiali e non ufficiali.
Questo numero immenso di persone è costituito prevalentemente da militari,
imprenditori, professionisti, docenti universitari, politici. In altre parole
buona parte dell’inteligencia italiana e delle persone che ricoprono incarichi
di potere. Tra questi ricordiamo come legati direttamente o indirettamente alla
massoneria, Cossiga, Andreotti, Prodi, Berlusconi, De Benedetti, molti
componenti legati alla famiglia Agnelli, Vittorio Valletta (dirigente Fiat per
molti anni, l’uomo che ha portato la nostra fabbrica al successo degli anni
d’oro), i governatori della Banca d’Italia Fazio, Ciampi, Carli, l’ex presidente
di Mediobanca Cuccia, l’ex presidente del senato Marcello Pera, ma anche molti
cardinali, vescovi, il Preside della facoltà di beni culturali di Bologna
Panaino, ecc…
In particolare il mondo
bancario, finanziario e imprenditoriale ha legami fortissimi con la massoneria.
Oltre ai già citati Agnelli, De Benedetti, e molti presidenti della Banca
d’Italia, troviamo Volpi, Joel, Toeplitz, Stringher, Caltagirone, De Bustis (che
apparterrebbe agli illuminati, secondo il libro di Pinotti), secondo alcune voci
Consorte, Fiorani e tanti altri.
D’altronde, per capire
i buoni rapporti tra massoneria e cariche ufficiali dello stato, basti pensare
che Prodi alla riunione di apertura del GOI (Grande oriente d’Italia) ha mandato
un messaggio di augurio e benvenuto, di cui vale la pena riportare il testo: “La
repubblica e il Governo vi salutano, la Repubblica si riconosce nei valori della
massoneria”. Il saluto è stato portato dal sottosegretario alle politiche
giovanili De Paoli.
Mentre l’ex Presidente
della Corte Costituzionale e della RAI Baldassarre ha presenziato di recente ad
una riunione del GOI, intervenendo sul tema della tripartizione dei poteri dello
stato. In altre parole: i legami tra alte cariche dello stato e massoneria sono
fortissimi ed indiscussi. Sono poco pubblicizzati e poco dichiarati, questo si.
Ma sono ufficiali. Nulla di strano in ciò. Basti ricordare che il primo
parlamento dell’Italia unita era composta in gran parte da massoni come Crispi,
Depretis, Zanardelli.
Ogni tanto poi spuntano
collegamenti con la massoneria deviata, addirittura da personaggi
insospettabili. Pannella infatti tentò di candidare nelle sue liste nientemeno
che Licio Gelli, il capo della famigerata P2 al fine, si presume, di fargli
avere l’immunità parlamentare. Ma la sua spiegazione ufficiale fu che lo
candidava perché in cambio Gelli prometteva di rivelargli i suoi segreti. Una
spiegazione delirante, che Pannella dette addirittura in commissione
parlamentare. Ma che dimostra come il potere politico vada a braccetto in
tranquillità con personaggi che hanno cospirato contro lo stato, e commissionato
delitti di ogni tipo, stragi comprese, fino a portarli dentro al parlamento.
La massoneria è un
fenomeno mondiale, organizzato cioè su scala mondiale. Il vertice del Grande
Oriente, in tutto il mondo, si trova nella corona inglese. Sono appartenuti alla
massoneria quasi tutti i Presidenti degli Stati Uniti, e personaggi come
Gheddafi e Arafat, presidenti Francesi, Re Del Belgio, di Olanda, e via
discorrendo. Ovverosia i vertici del mondo. E’ una creazione della massoneria –
come, perché, e in che misura, sarebbe un problema tutto da studiare e
approfondire – l’ONU, ma anche la Croce Rossa , il WWF (il cui presidente è
Filippo Di Edimburgo). Fu una creazione massonica il cosiddetto gruppo
Bilderberg, e lo fu anche la cosiddetta commissione Trilaterale.
Per capire il problema
che potenzialmente può crearsi, in virtù di questa fratellanza tra esponenti di
spicco di ogni parte del mondo, si cita spesso l’episodio del Britannia, del
1992; in quell’anno, sul Piroscafo Britannia, della Corona inglese, si riunirono
alcuni vertici della finanza e della politica mondiale, tra cui Draghi e Prodi e
si decise che sarebbero state privatizzate alcune aziende italiane. Passarono in
mani straniere dopo questa riunione la Buitoni, la Invernizzi, Locatelli,
Ferrarelle, ecc... Inoltre in quell’occasione, stando a quello che riportano
alcuni storici e giornalisti, pare – ma il condizionale è d’obbligo – che si
decidesse l’affossamento della lira che infatti avvenne negli anni seguenti, ove
la nostra moneta conobbe una svalutazione senza precedenti (fine della
svalutazione era quella di far acquistare le nostre aziende ad acquirenti
stranieri, per un prezzo irrisorio).
Si spiega probabilmente
così – in virtù del legame massonico mondiale - la presenza della Banca
d’Inghilterra (i cui vertici sono nominati dalla Corona Inglese) nella BCE con
il 17 per cento delle quote (nonostante non sia un paese dell’area Euro); e si
spiega così perché molte banche italiane effettuano investimenti ingenti in
azioni di Chase Manhattan Bank, Barclayrd, Morgan Stanley, ecc., tutte legate
direttamente o indirettamente alla Corona Inglese per mezzo di un complicato
gioco di scatole cinesi, creando dei conflitti di interessi spaventosi.
La massoneria ha
diverse sfaccettature. Esistono migliaia e migliaia di logge, e decine di
istituzioni massoniche o paramassoniche (organizzate cioè come la massoneria,
senza potersi chiamare ufficialmente con questo nome). Abbiamo il Grande
Oriente, la più diffusa a livello mondiale. Poi abbiamo i Rosacroce, I cavalieri
di Malta, i Templari, l’Opus Dei e chissà quante altre magari sconosciute. Tutte
queste istituzioni sono caratterizzate dal segreto per quanto riguarda il loro
funzionamento interno, e dal fatto di trasformarsi, spesso, in veri e propri
comitati di affari, anche illeciti. Queste istituzioni sono diverse tra di loro,
e talvolta sono in conflitto. Ma molto spesso collaborano e cooperano. Basti
ricordare che Gelli apparteneva contemporaneamente alla P2, che tecnicamente era
una loggia del Grande Oriente, ma era iscritto anche ai Cavalieri Di Malta e ai
Templari, per sua stessa ammissione.
In teoria la massoneria
è un istituzione in cui si entra per fare un percorso iniziatico di conoscenza e
approfondimento dei temi principali dell’esistenza. Questo è senz’altro vero per
alcuni o molti dei suoi iscritti e per numerose logge. In teoria poi la lista
degli iscritti dovrebbe essere pubblica, essendo vietate dal nostro ordinamento
le associazioni segrete. Ma in realtà esiste il fenomeno delle logge massoniche
coperte, o segrete, dove si iscrivono uomini politici che non vogliono rivelare
la loro appartenenza alla massoneria; e a queste logge si affiliano anche boss
mafiosi come Inzerillo, Bontate, Riina, Bagarella, Lo Piccolo, Mandalari (il
commercialista di Riina) che certamente non entrano in questa istituzione per
una sete di conoscenza e approfondimento della ricerca interiore.
La ragione
dell’esistenza delle logge coperte la spiega il Gran Maestro Di Bernardo, a pag.
396 del libro: “Le logge coperte sono sempre esistite. La loro funzione era
quella di salvaguardare persone di particolare importanza istituzionale,
politica e finanziaria, proteggendole da pressioni indebite da parte di altri
fratelli”. Le logge massoniche coperte insomma sono il collante tra criminalità
organizzata, politica, finanza e imprenditoria (non a caso i più grandi scandali
finanziari italiani hanno visto come protagonisti dei massoni). E le logge
massoniche coperte sono il motivo, o comunque uno dei motivi, dell’espansione
della criminalità organizzata mafiosa nelle regioni del centro e del nord.
Un esempio chiarirà
meglio la questione. Se un capo camorra deve costruire un grosso immobile al
nord, qualora sia affiliato alla massoneria, chiederà aiuto ai “fratelli” del
nord. Che, per il solo motivo di avere davanti un fratello, lo aiuteranno in
questa impresa. Se deve riciclare denaro sporco, sono ancora una volta le
collusioni con un banchiere massone che consentiranno questo riciclaggio. E il
legame massonico è la spiegazione dell’espansione della mafia negli stati
dell’Unione Europea. Considerando che la massoneria è una fratellanza “mondiale”
non sarà difficile per un mafioso trovare appoggi in Russia, in America, o alle
Cayman. Così come non è difficile, per massoni appartenenti alle varie mafie,
entrare in collegamento tra loro e stringere patti di alleanza; di qui nascono i
patti di alleanza tra mafia, ‘ndrangheta e camorra. Ecco il motivo per cui
quando un magistrato inizia ad indagare sulle cosiddette logge massoniche
coperte viene regolarmente silurato, fisicamente e/o lavorativamente.
Ora, qui sta il nodo
centrale del problema massoneria, tra gli iscritti alla massoneria esiste un
giuramento di fedeltà che li porta ad aiutarsi l’un l’altro. Questo è il nodo
cruciale del problema massonico: è possibile che un pubblico ufficiale o un
funzionario statale siano servitori dello stato ma, contemporaneamente, prestino
fedeltà ad un’istituzione non statale? Il tema, ovviamente, è tutto da
approfondire, perché ovviamente i più alti esponenti della massoneria negano che
il loro giuramento di fedeltà prevalga sulle leggi dello stato. Ma, francamente,
quando in una loggia coperta operano mafiosi, esponenti dei servizi segreti,
imprenditori, e politici, c’è perlomeno da dubitare di queste affermazioni di
lealtà allo stato. Occorre inoltre tenere presente una cosa che pochi sanno;
all’interno la massoneria ha i propri tribunali, organizzati in tre gradi
proprio come avviene nell’ordinamento giudiziario italiano.
La massoneria si
configura quindi come un vero stato nello stato. Potremmo dire uno stato al di
sopra dello stato. O perlomeno, per usare le parole della 32 Commissione
parlamentare antimafia, “le logge coperte … sono in grado di determinare gravi
interferenze nell’esercizio di funzioni pubbliche”. Ecco il motivo dell’allarme
che suscita la possibilità che un presidente del Consiglio (Romano Prodi) possa
appartenere ad una loggia coperta di San Marino o comunque avere interessi ad
essa legati. Ecco la potenziale bomba che potrebbe scoppiare se l’inchiesta di
De Magistris, nei suoi contenuti, fosse portata alla luce. Ed ecco perché il
clamore mediatico si preferisce dirottarlo sul problema del suo “presenzialismo”
in TV, per stornare l’opinione pubblica da un problema immenso, che coinvolge il
problema dei rapporti tra politica e criminalità organizzata.
C’è un dato importante
poi che non bisogna trascurare: i servizi segreti sono quasi sempre stati
diretti da appartenenti alla massoneria, con tutte le conseguenze del caso. E’
documentalmente accertato che furono diretti per quasi 30 anni da appartenenti
alla massoneria, oggi non si sa poiché mancano elenchi di iscritti recenti. Ma
non a caso è coinvolto nell’inchiesta di De Magistris l'odierno capo della
sezione calabrese del Sismi, oltre a vari politici. Per qualche decennio i
servizi segreti non rispondevano, insomma, al Governo, ma a Gelli. Ed è
probabilmente per questo – per la presenza dei servizi segreti deviati - che in
tutti i fatti giudiziari più gravi di questi ultimi anni, quando erano presenti
i servizi segreti, i testimoni sono morti in modo misterioso e sempre con le
stesse tecniche (suicidi in ginocchio; incidenti stradali; infarti improvvisi).
Diciamo “probabilmente” perché il dubbio è sempre un obbligo, quando si tenta di
ricostruire un sistema di potere senza avere prove documentali certe (cosa
peraltro estremamente facile quando chi deve indagare è legato a quel gruppo di
potere e per non tradire il giuramento fatto non indaga). Tuttavia è un fatto
che nei principali episodi stragisti dell’Italia di questi ultimi decenni (solo
per far qualche esempio: Italicus, Ustica, Moby Prince, Piazza Fontana; Strage
di Bologna; strage di Via D’Amelio e strage di Capaci) i servizi segreti deviati
erano sempre coinvolti in vario modo; e i testimoni sono sempre morti nello
stesso identico modo: con una tecnica che oltre ad essere sempre uguale, è
indizio dell’intervento di persone che adottano tecniche sofisticate (ecco il
significato dell’espressione “menti raffinatissime” usata da Falcone riguardo al
suo attentato all’Addaura). Ciò indica che probabilmente c’è un filo conduttore
tra tutte queste stragi. E questo filo conduttore probabilmente lo si troverebbe
nello logge massoniche deviate.
In conclusione: le
logge massoniche coperte sono il collante che lega tra di loro criminalità,
finanza e politica. Il giuramento massonico, e i vari legami che in queste sedi
si creano, sono la spiegazione dell’espansione della criminalità organizzata in
tutti i campi della vita sociale e politica. Ai vertici della finanza, della
politica, dell’imprenditoria, ci sono molto spesso persone legate, direttamente
o indirettamente alla massoneria. E i servizi segreti deviati sono stati, da
sempre, il braccio armato della massoneria deviata.
Ma su queste logge è
impossibile indagare, perché, appunto, chi tocca questi fili muore, o viene
delegittimato. Per questo motivo è importante seguire da vicino, per tutti noi
che ci occupiamo di queste vicende, le vicende di De Magistris, Woodcock e
Forleo. Perché, consapevolmente o inconsapevolmente, hanno toccato i vertici del
potere. Hanno toccato cioè quel filo sottile che lega politica e criminalità,
ove risiede la spiegazione della maggior parte dei disastri che affliggono il
nostro paese da decenni.
GLI INTRECCI
AFFARISTICI TRA POLITICA, IMPRENDITORIA, MASSONERIA E POTERI OCCULTI
RAPPRESENTANO ORMAI UN SISTEMA COLLAUDATO...EMERGE DA ESSO LA SPARTIZIONE DEL
DENARO PUBBLICO, IL FINANZIAMENTO AI PARTITI, IL RUOLO DI LOBBY E POTERI OCCULTI
DEVIATI. (Dagli atti del P.M. di Catanzaro, Luigi De Magistris).
Nel mese di luglio
2007, le maggiori agenzie di stampa hanno diffuso la notizia che il P.M. di
Catanzaro, Luigi De Magistris, nell'ambito di un'indagine sull'assegnazione dei
fondi comunitari, a carico di soggetti appartenenti a logge massoniche, aveva
inviato un avviso di garanzia al Presidente del Consiglio, Romano Prodi,
sospettato di appartenere alla loggia di San Marino, chiamando in causa alcune
figure vicine ai massimi vertici istituzionali. Da allora, stiamo assistendo ad
una violenta campagna di delegittimazione della parte sana della magistratura,
ad opera di vasti settori della politica, delle istituzioni e del C.S.M. che
mirano, senza mezzi termini, a paralizzare ogni indagine in corso sul rapporto
tra affari, mafia, politica e massoneria.
Secondo l'ex Gran
Maestro venerabile Giuliano Di Bernardo, in un'intervista rilasciata a Ferruccio
Pinotti, collaboratore della CNN e dell'International Herald Tribune, pubblicata
nel recente volume, "Fratelli d'Italia", edito dalla Biblioteca Universale
Rizzoli, uscito nelle librerie lo scorso novembre, vi è un'analogia tra
l'attuale situazione politica italiana e quella ai tempi della prima indagine
sulle logge massoniche dell'ex Procuratore Capo del Tribunale di Palmi, Agostino
Cordova, nel 1992. Nell'analisi dell'ex maestro reggente che, anni orsono,
lasciò il "Grande Oriente d'Italia", denunciandone le deviazioni, per fondare la
comunione dei cd. "Illuminati", la situazione della massoneria in Calabria "è
esattamente quella di allora, dai tempi di Cordova, per quanto riguarda la
collusione mafia - massoneria". Solo in Italia, continua Di Bernardo, dalla sua
posizione di esperto conoscitore del problema: "la massoneria continua a
nascondersi...". "La realtà massonica è rimasta immutata". "La differenza, oggi,
potrà farla solo la magistratura, in termini di qualità delle indagini. Quello
che è accaduto con l'inchiesta di Catanzaro è la riprova del fatto che i
problemi sui quali avevo cercato di intervenire, senza riuscirvi, sono rimasti
gli stessi di allora"... "Simili anche le condizioni ambientali."
Non è casuale, secondo
Giuliano Di Bernardo, il periodo in cui questa nuova inchiesta esplode. "Se noi
andiamo con la memoria all'inchiesta Cordova, vediamo che inizia nel 1992,
proprio quando la crisi politica era totale e si preparavano situazioni fino ad
allora imprevedibili. Secondo alcuni analisi il trasferimento dell'inchiesta
Cordova al "porto delle nebbie" romano concise con la "pax mafiosa", seguita
all'assassinio di Falcone e Borsellino del 1992". "Il 5 febbraio di quell'anno,
il Sisde inviava una nota al ministro dell'Interno: "non è da sottovalutare la
possibilità che frange eversive stipulino con la criminalità organizzata accordi
di collaborazione a fini operativi per la destabilizzazione del Paese". Mentre
al giudice istruttore di Bologna, Leonardo Grassi, arrivava il 4 marzo una
segnalazione di "fatti intesi a destabilizzare l'ordine pubblico, al fine di
instaurare "un nuovo ordine massonico deviato"(...)".
Secondo Di Bernardo
oggi ci ritroviamo alle prese con le stesse identiche situazioni politiche, lo
stato di crisi è esattamente quello che caratterizzava l'epoca in cui Silvio
Berlusconi scese in politica per "sopperire" ad una situazione che appariva
drammatica, come quella che stiamo vivendo adesso. La politica era in crisi, la
gente non aveva più fiducia della classe dirigente, "ecco che allora applaudì
l'uomo forte, lo portò sugli scudi e lo fece eleggere". In tale ottica è
indubbio sia in atto uno scontro tra un "nuovo ordine massonico" e uno "vecchio"
(sui quali vige un assoluto divieto d'indagare, senza soluzione di continuità),
nonché tra una "nuova mafia emergente" e una "vecchia" (i cui capi dei capi dopo
oltre 40 anni sono stati consegnati alla giustizia per sedare la pubblica
indignazione e ridisegnare gli equilibri del potere mafioso). Uno scontro del
tutto sommerso e dagli oscuri contorni, dove chiunque prevalga, non c'è
logicamente spazio per la legalità e la verità, a cui un Paese civile dovrebbe
ambire, ovvero per quella "differenza" in termini di qualità di indagini
poc'anzi citata.
Come noto, l'inchiesta
di Cordova sulle logge massoniche, dopo il trasferimento del magistrato alla
procura di Napoli (promuovere per rimuovere), venne infatti affossata dalla
procura di Roma nel giugno 1994 e affidata ai P.M., Lina Cusano e Nello Rossi.
Il procedimento restò pressoché fermo per quasi sei anni, eppoi nel dicembre
2000 il giudice per l'indagine preliminare Augusta Iannini dispose la formale
archiviazione dell'inchiesta, nonostante fossero stati raccolti ben 800 faldoni
e innumerevoli fonti di prova sulle attività illecite delle più importanti logge
italiane con ben 61 indagati, coinvolgenti influenti personaggi del mondo
imprenditoriale, finanziario, politico e istituzionale, nonché della stessa
magistratura, collusi con la ‘ndrangheta con cui avevano costituito delle vere e
proprie società di affari, attraverso le quali si spartivano e, tuttora,
continuano a spartirsi impunemente, i proventi leciti e illeciti derivanti dagli
accordi perversi del sodalizio criminale ("Oltre la cupola. Massoneria, mafia,
politica" di Francesco Forgione e Paolo Mondani, con prefazione di Stefano
Rodotà, 1994, Rizzoli).
A distanza di oltre 16
anni dalla strage di Capaci la "pax mafiosa" rischiava nuovamente di incrinarsi
sotto i colpi delle nuove investigazioni delle procure di Catanzaro, Potenza e
del G.I.P. di Milano, Clementina Forleo, ma con l'illegittima avocazione delle
indagini del P.M. De Magistris, da parte del Procuratore Generale e le
strumentali procedure di trasferimento avviate dal C.S.M., anche nei confronti
del G.I.P. di Milano, Forleo, la storia si ripete, dando un segnale forte alla
magistratura non asservita alle logiche delle logge e dei partiti di regime, che
oltre un certo livello non si può indagare.
Chi lo fece, come
Falcone e Borsellino, pagò con la vita. Nel nuovo ordine sociale "massomafioso"
il prezzo è il pubblico discredito, la delegittimazione, la procedura di
trasferimento, le minacce velate, gli incidenti mortali... E' ciò che
puntualmente accade quando si toccano i poteri forti e l'intreccio tra affari,
mafia, politica, massoneria.
All'interrogativo se
Stato, mafia, massoneria siano divenuti una "cosa sola" è pertanto legittimo
rispondere che sono divenuti parte di un unico sistema, attraverso il quale si
riproduce il controllo capillare del territorio e delle logiche di governo delle
istituzioni democratiche, soffocando in radice la legalità e ogni anelito di
giustizia. Tale concezione paradigmatica costituisce una nuova prospettiva
teorica per analizzare il fenomeno mafioso e il degrado delle istituzioni,
fornendo una chiave per realizzare un mutamento epocale dei rapporti tra
governati e governanti. E' indubbio che a taluni potrà risultare ostico digerire
che Stato, mafia e massoneria si siano coesi, tanto da fare parte di un unico
sistema di malaffare criminale. In specie, per chi vive troppo lontano - o
troppo vicino - all'agone politico e giudiziario, subendone il retaggio e
rimanendo, in entrambi i casi, vittima di un distorto senso dello Stato e di una
cultura dogmatica delle istituzioni che, nell'accezione più diffusa e non
condivisibile, "vanno difese ad oltranza e a qualsiasi costo per non
pregiudicare i cardini dello Stato di diritto e le basi sociali della pacifica
convivenza". In verità, così facendo, si ottiene l'effetto opposto di
distruggere nei cittadini il senso di appartenenza e di identificazione nello
Stato. Si distrugge la credibilità delle istituzioni e della magistratura,
alimentando la storica diffidenza dei cittadini verso il potere. D'altronde,
l'esistenza di una "cupola mafiosa" che controlla anche la vita giudiziaria, da
sud a nord del Paese, in grado di neutralizzare il lavoro dei magistrati onesti,
non è frutto di illazioni o di mere ipotesi sociologiche, bensì il risultato di
appronfondite indagini a cui sono approdati, ancora prima del P.M. di Catanzaro,
Luigi De Magistris, il Procuratore Antimafia di Reggio Calabria, Salvo Boemi e
il suo sostituto Roberto Pennini e l'ex Procuratore di Palmi, Agostino Cordova.
I primi, denunciarono,
ripetutamente, in alcune interviste a Panorama e L'Espresso, tra il 1995 e il
1998, di essere stati abbandonati e boicottati dal C.S.M. e dallo Stato, in
quanto ritenuti "rei" di "non essersi accontentati di colpire il braccio
militare della ‘ndrangheta" e di "avere denunciato i magistrati massoni che a
Reggio Calabria avevano deciso di mettere una pietra sui processi anticosche".
In proposito, il Dr. Boemi racconta a Panorama: "come dopo lo scandalo della P2,
nella massoneria fossero incominciati ad entrare i parenti stretti dei
magistrati (i quali volevano evitare in tal modo un coinvolgimento diretto) e
come le logge avessero sempre contrattato a Roma chi dovessero essere i capi
degli uffici giudiziari", aggiungendo, infine, di essere scampato a un attentato
alla sua vita, solo grazie alle rivelazioni di un pentito (Panorama 21.9.95 e
L'Espresso 16.7.98).
L'intensa e proficua
attività investigativa del Dr. Agostino Cordova, soffocata con il suo
strumentale allontanamento dalla Procura di Palmi è invece ben documentata in
"Oltre la cupola. Massoneria, mafia, politica" di Francesco Forgione e Paolo
Mondani, con la prefazione di Stefano Rodotà e una postfazione di Agostino
Cordova, edito da Rizzoli (1994). Il lavoro degli Autori non si limita a
ricostruire l'opera del magistrato, ma ci introduce nella più larga dimensione
dell'agire complessivo delle istituzioni e del modo in cui esse si intrecciano
con la società. Il libro è il racconto delle vicende d'una regione, la Calabria,
e del modo in cui venne perduta dallo Stato. Di come lì lo Stato, affermano gli
Autori, "abbia cambiato natura, si sia ritirato, lasciando emergere un modo
d'organizzazione dell'insieme dei poteri pubblici che perdeva progressivamente i
caratteri della legalità e ad essa sostituiva una normalità modellata, invece,
sull'accettazione di comportamenti illegali divenuti la norma fondante della
società". L'opera ben descrive la sparizione dei confini tra Stato e Antistato,
tra diritto e crimine e mette in luce come lo Stato perda i caratteri che
dovrebbero caratterizzarlo e, quasi per una forma mimetica ormai obbligata,
affermano gli Autori, assuma quelli dei suoi antagonisti, di quelli che dovrebbe
avversare". Si perde insomma la possibilità di individuare l'Antistato perché è
lo Stato ad essersi dissolto.
Nella postfazione, lo
stesso Cordova si sofferma a sottolineare come le indagini sulla massoneria
deviata, avviate dalla Procura di Palmi, siano state costellate da una serie di
anomali contrattempi, mai avvenuti in altri procedimenti: dal divieto di
utilizzare uffici provvisori a Roma (si tenga presente che i locali erano già
stati reperiti sia dalla Polizia che dai Carabinieri) dove si trovava la
sterminata mole di atti sequestrati, fatto che cagionò oltre tre mesi di ritardo
durante la fase iniziale delle investigazioni, precludendo l'immediato sviluppo
del materiale acquisito; alla soppressione della Procura Circondariale di Palmi,
determinando l'utilizzo di soli tre dei sei magistrati applicati dal Csm, e
tante altre difficoltà operative. Eppure i risultati conseguiti, pur tra tante
difficoltà, ci ricorda il Dr. Cordova, avevano consentito di riferire alla
Commissione parlamentare antimafia che "la massoneria deviata è il tessuto
connettivo della gestione del potere, e ciò sia per la natura che per il numero
delle attività illecite e degli interessi accertati, sia per la qualità e il
numero dei personaggi coinvolti, tutti occupanti appunto posti di potere, e
costituenti un enorme partito trasversale ramificato non solo in tutto il
territorio nazionale, ma collegato con corrispondenti o analoghe organizzazioni
in tutto il mondo".
In conclusione, chiosa,
il dr. Cordova, "come ho ripetutamente affermato in ogni occasione, ritengo che
la società italiana sia nelle mani di inesplorati gruppi occulti di potere e di
altre consociazioni e congregazioni e che solo di tanto in tanto, e unicamente
in occasione di vicende eclatanti, se ne renda conto. Per dimenticarsene
immediatamente dopo, spesso perché l'attenzione è subito distolta o sviata da
altre vicende: come abitualmente avviene nel nostro Paese, in cui la memoria è
corta e non si va oltre l'episodio contingente".
E' indubbio, quindi,
siamo di fronte a verità storiche ed oggettive che ci offrono il nucleo di
quello che può definirsi un vero e proprio paradigma, da cui ripartire per
analizzare i mali della società e individuare i rimedi più acconci; paradigma
che non potrà tardare a venire recepito dalla comunità scientifica, prigioniera
della decadente cultura politica masso-mafiosa, la cui sudditanza alle logiche
dei poteri dominanti, appare, abbondantemente, suffragata dalla generale
situazione di irreversibile degrado sociale ed economico, in cui versa il Paese,
da oltre 40 anni, dove la società civile è, suo malgrado, costretta a convivere,
fianco a fianco, della mafia e della corruzione politico-istituzionale. Il Paese
ha, quindi, urgente bisogno di una magistratura indipendente e senza padrini
politici, libera di indagare in ogni direzione, onde garantire le sue alte
funzioni istituzionali di controllo della legalità, conferitegli dalla
Costituzione, e il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
Il mahatma Gandhi affermava che "il livello di civiltà di un paese si misura
dalla considerazione in cui viene tenuta la giustizia". Il problema è, quindi,
quello di seguire le orme di Falcone e Borsellino e di non lasciare soli quei
magistrati come la Forleo e De Magistris che si adoperano per fare il loro
dovere fino in fondo, senza guardare in faccia nessuno, assicurando al Paese una
giustizia efficiente e uguale per tutti.
LOGGIA PROPAGANDA 2. La
data di fondazione della loggia massonica Propaganda Due si perde nel tempo,
come spesso accade per simili consorterie. E' noto, comunque, che era un antico
sodalizio che accoglieva gli elementi più importanti e prestigiosi, fin da
quando, nel secolo scorso, la massoneria, aveva avuto un ruolo centrale nelle
vicende italiane. Dopo la seconda guerra mondiale era stata riorganizzata anche
la loggia P2, con l'aiuto della massoneria USA, trasferendovi i massoni più in
vista o che dovevano restare "coperti". Nel Dicembre 1965 il Gran Maestro
aggiunto Roberto Ascarelli presenta l'apprendista Licio Gelli al Gran Maestro
Gamberini, il quale lo eleva immediatamente di grado nella gerarchia massonica e
lo inserisce nella loggia P2. Nel 1969 Ascarelli e Gamberini affidano a Gelli un
non meglio precisato incarico speciale nella loggia. Nel 1971 Gelli diviene
segretario organizzativo e ha il totale controllo della loggia. Nel frattempo
molti personaggi eccellenti, soprattutto militari e finanzieri si sono iscritti,
tra questi il generale Allavena che porterà in dote le copie dei fascicoli delle
schedature del SIFAR. Nel '69 capi massonici diranno che grazie a Gelli 400 alti
ufficiali dell'esercito sono stati iniziati alla massoneria al fine di
predisporre un "governo di colonnelli", sempre preferibile ad un governo
comunista. Nel 1972 il nuovo segretario organizzativo cambia nome alla loggia in
"Raggruppamento Gelli-P2" accentuandone le caratteristiche di segretezza
evitando qualsiasi tipo di controllo. Nel 1973 la loggia segreta "Giustizia e
Libertà" si fonde con la P2. Alla Gran Loggia di Napoli del Dicembre 1974,
qualcosa di simile a un conclave massonico alcuni tentarono di sciogliere la P2
e di abrogarne i regolamenti particolari, ma senza successo, Gelli aveva
acquisito troppo potere nel frattempo. Lino Salvini, maestro del Grande Oriente
d'Italia, quindi, nonostante non vedesse di buon occhio tanto potere concentrato
in quella loggia, il 12 Maggio 1975 decretò ufficialmente la ricostituzione
della loggia P2 elevando Gelli al grado di maestro venerabile. La loggia P2
valicherà presto i confini nazionali e conterà affiliati in diversi paesi dove
non si limiterà a fare proselitismo, ma parteciperà, nei modi che la
caratterizzano alla vita politica, economica e finanziaria di tali paesi. In
Argentina, per esempio favorirà il golpe militare, per poi perorare la causa del
ritorno di Peron, così come risulterà implicata nello scoppio del conflitto
delle isole Malvinas. La loggia P2 risulterà attiva in Uruguay, Brasile,
Venezuela, negli Stati Uniti, in diversi paesi europei e non ultima in Romania,
dove Gelli avrà importanti rapporti con il regime "socialista" di Ceausescu,
nonostante l'anticomunismo viscerale di tutti gli aderenti alla P2.
Evidentemente a Ceausescu non era rimasto niente di comunista e Gelli lo sapeva.
Analizzare gli intrighi, la partecipazione a tentativi di colpo di stato o a
colpi di stato riusciti, a stragi, attentati, omicidi, depistamenti, operazioni
finanziarie sporche e' praticamente impossibile. Basti pensare che dopo il
ritrovamento di una parte dei documenti relativi alle attività della loggia ad
Arezzo il 17 Marzo 1981 e di altri a Montevideo in Uruguay e' stata costituita
una commissione parlamentare di inchiesta presieduta da Tina Anselmi, i cui atti
sono raccolti in 76 volumi di dimensioni consistenti e che la documentazione
raccolta occupa diverse scaffalature anch'esse di dimensioni consistenti.
Semplicemente ci limiteremo a dare un parziale elenco delle vicende in cui la P2
e' implicata. Anche l'elenco degli iscritti che forniamo e' parziale, purtroppo
però è l'unico conosciuto, si calcola comunque che gli iscritti alla loggia
fossero 2500/3000 e non 963 come risulta dalle liste sequestrate ad Arezzo.
GLADIO. Quella del
gladiatore G.71 è una storia scomoda, per anni tenuta sotto silenzio. Una storia
tipicamente italiana, fatta di spie, imprevedibili retroscena, rivelazioni
importanti e supportate da documenti. Una vicenda talmente scomoda che anche
quando, per frammenti, è arrivata sulle pagine di alcuni giornali nazionali, non
ha causato alcun sommovimento politico: il solito muro di gomma l'ha fatta
tornare nell'ombra. E’ la storia di Antonino Arconte, 47 anni di Cabras, che fin
dal 1997 ha affidato al web il racconto della sua vita all'interno
dell'organizzazione Gladio. Agente di una struttura militare segreta facente
capo al Sid, Arconte è stato protagonista di operazioni che si sono svolte in
mezzo mondo: dal Vietnam alla Russia, dalla Cecoslovacchia al Libano, dagli
Stati Uniti all'Africa. Dalla sua testimonianza è emersa una struttura
profondamente diversa da quella svelata in Parlamento da Giulio Andreotti il 2
agosto del 1990: non una rete ideata per fronteggiare una possibile invasione da
parte delle truppe del Patto di Varsavia (la “Stay Behind”), ma una struttura
informativa e operativa che agiva esclusivamente all'estero. La storia ha
cominciato a emergere dall'ombra lentamente e a fatica. L'allora ministro della
Difesa Sergio Mattarella, rispondendo a un'interrogazione del senatore di
Rifondazione Giovanni Russo Spena sulla struttura supersegreta alla quale
apparteneva Arconte, si è limitato a rispondere burocraticamente: «Dagli atti
del Servizio non sono emerse evidenze in ordine a...». Risposta assolutamente
insoddisfacente. Ma il racconto di Arconte non si ferma qui e qualche mese più
avanti infittisce di nuovi particolari alcuni dei misteri italiani. Il "caso
Moro" in particolare. G.71 ha infatti svelato che, nel marzo del 1978, venne
inviato in missione in Libano per consegnare un documento al gladiatore G.219.
Si trattava del colonnello Mario Ferraro, passato poi al Sismi, morto
misteriosamente nel luglio del 1995, «suicidato», come si dice in gergo
militare, visto che è stato ritrovato impiccato alla maniglia della porta del
bagno benché fosse alto 1 metro e 90. Nel documento "a distruzione immediata"
(Arconte non ha mai distrutto il documento e lo ha esibito alla magistratura
inquirente, dalla quale attendiamo ancora un giudizio certo sull'autenticità)
viene ordinato di «cercare contatti con gruppi del terrorismo mediorientale, al
fine di ottenere collaborazione e informazioni utili alla liberazione
dell'onorevole Aldo Moro». L'aspetto inquietante di questa missione è che il
documento è datato 2 marzo 1978. Cioé 14 giorni prima del rapimento del
presidente della Dc. Qualcuno, quindi, sapeva che Moro sarebbe stato rapito.
GLADIO & CENTURIE.
Facciamo qualche passo indietro. Gladio è il nome dato in Italia ad una
struttura segreta, collegata con la Nato e istituita nel dopoguerra con la
denominazione "Stay Behind" (stare indietro), che aveva il compito di attivare
una resistenza armata in caso di invasione sovietica. L'esistenza di questa
struttura segreta venne scoperta nel 1990 e successivamente confermata
pubblicamente, nel febbraio del 1991, dall'allora presidente del Consiglio
Giulio Andreotti. Secondo quanto riferito in quell'anno dall'ex primo ministro
italiano, la Gladio "Stay Behind" sarebbe stata composta da 622 membri civili i
quali avevano il compito di svolgere operazioni dentro il territorio nazionale
riguardanti attività informative a carattere difensivo e sotto le direttive
della Nato. Quella che racconta Antonino Arconte nel suo memoriale, invece, è
tutta un'altra storia. Accanto alla cosiddetta Gladio "civile", infatti, sarebbe
stata istituita nel nostro Paese una struttura armata dei servizi segreti
militari, tenuta per 50 anni nascosta, che avrebbe operato al di là dei confini
italiani attraverso un'attività regolata da direttive nazionali e non dalla
Nato. Nel memoriale, Arconte spiega che Gladio era in realtà divisa in tre
centurie. «La Prima Centuria era chiamata Aquile, erano cioé aviatori, alcuni
paracadutisti della Folgore - scrive Arconte - la Seconda Centuria era chiamata
Lupi, io appartenevo a questa, composta da quelli provenienti dalla Marina e
dall'Esercito. Poi c'era la Terza Centuria detta Colombe. Non era composta da
militari ma da civili, anche donne, che dovevano fare da supporto per le
informazioni». Per conto dello Stato italiano, il "gladiatore" G-71 avrebbe
partecipato a diverse operazioni estere: dalle repubbliche dell'Est comunista al
Nord Africa, dal Sahara spagnolo al Vietnam. Arconte rivela, tra l'altro, del
ruolo svolto dai nostri agenti segreti armati in Maghreb per la destituzione del
presidente Burghiba. G-71 racconta anche di aver ricevuto un riconoscimento
formale da parte di Bettino Craxi il quale lo avrebbe invitato, come si
evincerebbe da documenti, a tacere per il bene del Paese. L'attività di questa
Gladio si svolgeva presso il ministero della Difesa, direzione generale Stay
Behind-personale militare della Marina e la mobilitazione dei gladiatori
avveniva tramite Consubin (comando subaquei incursori di La Spezia). Un'attività
segreta così come quella degli Ossi (operatori speciali servizio informazioni,
alle dipendenze di Gladio) che operavano armati e i cui compiti sono stati
ritenuti “eversivi dell'ordine costituzionale” da due pronunciamenti della
magistratura.
DA ARCONTE A MORO.
Arconte è forse depositario di alcuni dei segreti che formano il filo nero che
ha cucito e legato il potere dello Stato allo Stato occulto, attraverso il
terrorismo nazionale e internazionale, attraverso insabbiamenti e “suicidi”
misteriosi. Il libro di Arconte, pubblicato qualche anno fa negli Stati Uniti
(ottenendo peraltro un discreto successo e diventando oggetto di studio), ha
aperto nuovi, inquietanti scenari sulla Gladio segreta. Vi compare anche
l’immagine del documento top secret sul caso Moro. In quel documento si legge
che il 2 marzo 1978 - e cioè 14 giorni prima del rapimento di Moro e
dell'uccisione della sua scorta - la X Divisione "S.B." (Stay Behind) della
direzione del personale del Ministero della Marina, a firma del capitano di
vascello, capo della divisione stessa, inviava l'agente G71 appartenente alla
Gladio "Stay Behind" (partito da La Spezia il 6 marzo sulla motonave Jumbo M) a
Beirut, per consegnare documenti all'agente G 129, ivi dislocato, dipendente dal
capocentro, colonnello Stefano Giovannone, affinchè prendesse contatti con i
movimenti di liberazione nel vicino Oriente, perchè questi intervenissero sulle
Brigate Rosse, ai fini della liberazione di Moro. Il nome del "gladiatore" G-71,
Antonino Arconte, non figura nella lista dei 622 resa nota in Parlamento, lista
risultata, comunque, "del tutto inattendibile". «Non è vero - ha scritto più
volte Falco Accame, ex presidente della commissione difesa - che il "gladiatore"
Arconte sia un "signor Nessuno": lo può testimoniare un altro agente di Gladio
che operava come civile, il cui nome di battaglia è "Franz». Nel 1997 "Franz" si
fece ricevere a Tunisi da Craxi e portò la lettera di Arconte e di un altro
gladiatore, Tano Giacomina (ucciso in circostanze misteriose a Capoverde) che
chiedeva al leader socialista di rendere pubblica la storia della "Gladio delle
Centurie". Secondo "Franz", Craxi aveva chiesto di essere ascoltato dalla
Commissione Stragi (cosa che era stata concessa al generale Maletti) e intendeva
riferire in quella sede sulla Gladio, ma l'incontro con la commissione non fu
mai possibile. L'ipotesi di una Gladio “segreta” che operasse all'estero con
modalità di guerra non-ortodossa non è affatto peregrina, anzi, è in linea con
modelli operativi ispirati a quelli della Cia. I contatti con la Cia sono
documentati fin dall'inizio della nascita di Gladio, negli anni '50, e si
svilupparono con il memorandum di Roma del 20 dicembre '72, di cui parla nel suo
libro il generale Serravalle, capo dell’organizzazione dal '71 al '74”. Di
Gladio come "scuola di eversione" aveva parlato, nel dicembre 1991, Antonio
Maria Mira in un articolo sull'Avvenire, in relazione all'Operazione Delfino e a
«uno strano documento di Gladio che - scriveva Mira - sta preoccupando i
magistrati padovani e romani, il Comitato di controllo sui Servizi e la
Commissione Stragi. E' datato aprile '66 e riguarda un'esercitazione denominata
"Delfino" che si svolse nella zona di Trieste dal 15 al 24 aprile 1966, e che
doveva procedere ad un programma di "attività provocatorie" coordinate dai
servizi segreti ed in accordo con la Cia, che prevedevano la partecipazione
delle unità di Gladio». Sull'argomento interveniva Antonio Garzotto nel '92,
scrivendo: «La "Delfino" altro non sarebbe che un "vademecum per la guerriglia",
messo a punto dalla Cia e concepito dal generale Westmoreland, il comandante Usa
in Vietnam. Si trattava di un vero e proprio manuale di strategia della
tensione: agenti della Gladio avrebbero dovuto infiltrarsi sia nelle file e
nelle manifestazioni del Pci, ma pure nelle frange della sinistra estrema per
provocare "azioni violente, moti di piazza, uccisioni". Fare, insomma,
"insorgenza", in modo tale da sollecitare una forte reazione, la
"controinsorgenza", e legittimare un intervento di "stabilizzazione del potere"
da parte dell'Autorità di Governo».
GRADOLI STRASSE.
Recentemente è sempre Falco Accame, in qualità di presidente dell'Associazione
nazionale assistenza vittime arruolate nelle forze armate e famiglie dei caduti,
a sollecitare la commissione parlamentare d'inchiesta sul dossier Mitrokhin, per
approfondire gli elementi riguardanti la vicenda Moro, che non si esauriscono
con le dichiarazioni di Arconte. Nel silenzio generale, infatti, alle
affermazioni di Arconte (ricordiamo, sempre supportate dal documento “a
distruzione immediata” ancora da valutare), si sono aggiunte negli ultimi mesi
anche le dichiarazioni di un altro dei gladiatori che operava all'Est in maniera
segreta, Pierfrancesco Cangedda, il quale ha più volte dichiarato di aver
ricevuto, mentre operava nella Repubblica democratica tedesca durante i 55
giorni del sequestro Moro, una informazione che proveniva dalla Stasi,
contenente un'indicazione specifica sulla base dei brigatisti in via Gradoli.
Una base che era situata in “Gradoli Strasse”. Questa informazione, come risulta
anche da alcune inchieste ancora in corso alla Procura di Roma, venne raccolta
dal “terminale” della struttura, l'ufficiale dei servizi segreti Tonino La
Bruna, l'uomo che avrebbe reclutato personalmente lo stesso Arconte. Le due
“metà” della storia sembrano combaciare perfettamente. Vista la portata di
queste dichiarazioni, e le importanti conseguenze che potrebbero avere qualora
ottenessero ulteriori riscontri, è giusto cominciare a fare chiarezza da subito
senza tenere lontano i riflettori dei media nazionali dalla vicenda. Siamo a un
bivio nella ricostruzione della storia italiana degli anni '70 e '80, a partire
dalla genesi del terrorismo rosso fino al caso Moro. O i due gladiatori sono dei
cialtroni mitomani, e vanno perseguiti dalla magistratura; oppure si dovrà tener
conto di quello che dicono e finalmente si arriverà ad aprire un varco nel “muro
di gomma”.
P3 E CRICCHE ANNESSE.
Giorgio Napolitano, il 22 luglio 2010, durante la cerimonia del Ventaglio, alla
vigilia dell'approvazione finale alla Camera della manovra finanziaria, ha
lanciato molti avvertimenti al Paese e, in particolare, alla classe politica.
Uno prima di tutti gli altri: «Ci indigna e ci allarma l'emergere di fenomeni di
corruzione e di trame inquinanti, anche ad opera di squallide consorterie».«Per
ora sicuramente vedo tanto squallore. Poi vedremo cos'altro emergerà.
L'importante è che si riesca a far fare alla magistratura il proprio lavoro fino
in fondo per accertare fatti e responsabilità».
"Ha fatto bene il
presidente della Repubblica a lanciare l’allarme sulle squallide consorterie dei
modelli piduisti, ma che l’Italia abbia gli anticorpi è tutto da dimostrare". Lo
afferma il leader dell’Italia dei Valori Antonio Di Pietro in un’intervista
rilasciata a Sky Tg24 il 23 luglio 2010.
Si parla della vicenda
della cosiddetta P3, che vede coinvolti faccendieri, uomini di governo e
magistrati. Magistrati che occupano posti di rilievo, importanti, il presidente
della Cassazione Vincenzo Carbone, il presidente della Corte d’Appello di Milano
Marra; e altri. Il ministro della Giustizia ha detto: “No alle streghe”. Poi ha
aggiunto che il "sistema-giustizia" ha in se stesso "tutti gli anticorpi".
Non è questione né di
streghe né di stregoni, dice Valter Vecellio, noto giornalista rai e radicale di
lungo corso. Il problema è che tra i collaboratori stretti del ministro della
Giustizia troviamo personaggi i cui comportamenti sono perlomeno imbarazzanti.
Per riassumere i termini della questione, così come la stampa ha dato ampio
risalto. C’è questo Pasquale Lombardi che nel suo giro è conosciuto per
l’incapacità di sedere a tavola senza sporcarsi di sugo, “quanno magna se sporca
sempre”, si legge in un’intercettazione. Un tipo che sembra di casa in
Cassazione, al ministero dell’Economia e a quello della Giustizia, al Consiglio
Superiore della Magistratura, al consiglio regionale della Lombardia e alla
presidenza della Regione Sardegna e in svariate procure. I suoi interlocutori li
chiama amichevolmente “Fofò”, “Nicolino”, “Pinuccio”, “Giacomino”, fino ad
arrivare a definire il vice-presidente del CSM Nicola Mancino “un cesso” (e cosa
abbia fatto il vice-presidente Mancino per meritarsi questo poco encomiabile, ma
inequivocabile titolo, Mancino per primo e noi con lui, dovremmo chiedercelo).
Questo Lombardi fa
campagna all’interno del CSM per il suo amico “Fofò” Alfonso Marra che diventa
capo della corte d’Appello di Milano, e per altri. E’ intimo del sottosegretario
alla giustizia Giacomo Caliendo e del capo del Servizio di controllo interno del
ministero della Giustizia Angelo Gargani; e quando, a proposito della esclusione
della lista Formigoni dalle elezioni regionali, i magistrati di Milano non si
comportano come la cricca desidera, chiede consiglio ad Arcibaldo Miller, altro
magistrato, e capo degli ispettori del ministero della Giustizia, e invoca
un’ispezione ministeriale. E questo Miller, invece di mandare Lombardi a quel
paese, amichevolmente e in modo spericolato gli dà consigli su come fare per
ottenere questa ispezione. Lo stesso Miller che viene invitato da Lombardi a
riunioni, a pranzi a casa del coordinatore del PdL Verdini o in ristoranti per
definire le strategie da adottare.
Ora va bene che viviamo
in un paese dove un ex ministro come Claudio Scajola può dire che qualcuno gli
paga la casa a sua insaputa, e ristruttura la stessa casa e il conto lo paga il
SISDE; e un altro sottosegretario, Guido Bertolaso, può dire impunemente in
televisione che lui non sa nulla delle operazioni poco limpide che si sono fatte
all’ombra del vertice del G8, anche se quelle cose poco limpide erano state
puntualmente denunciate in una dettagliata interrogazione di Elisabetta
Zamparutti e degli altri parlamentari radicali un anno prima che la vicenda
esplodesse. Però è davvero incredibile, letteralmente inaudito che il ministro
della Giustizia parli di scongiurare una “caccia alle streghe”, invece di
annunciare: ho convocato il sottosegretario Caliendo, il capo del servizio di
controllo Gargani, il capo degli ispettori del ministero della Giustizia Miller,
e li ho pregati di farsi da parte fino a quando l’inchiesta sarà conclusa, e nel
frattempo ho avviato un’inchiesta interna per accertare come sono andate le
cose. Questo un ministro della Giustizia avrebbe dovuto fare. Questo il ministro
della Giustizia Alfano non ha fatto. Altro che caccia alle streghe!
Se questi sono gli
anticorpi in un sistema marcio, figuriamoci che fine possono fare gli esposti e
le denunce di semplici cittadini inviati al Ministero della Giustizia, che
rilevano abusi ed omissioni di sistema causati da apparati giudiziari.
La prima commissione
del Consiglio Superiore della Magistratura ha deciso di avviare il trasferimento
d'ufficio per incompatibilità ambientale nei confronti del presidente della
Corte d'appello di Milano, Alfonso Marra, a seguito del suo coinvolgimento nelle
intercettazioni relative all'inchiesta sull'eolico. La decisione è passata con
quattro voti a favore; in commissione ha votato contro soltanto il laico di
centrodestra, Anedda. Non ha partecipato al voto Giuseppe Berruti, che nelle
intercettazioni viene considerato il maggior ostacolo alla nomina di Marra.
In un'informativa
datata 18 giugno 2010, parlando dell'attività svolta dal gruppo occulto, i
carabinieri descrivono la "vicenda che ha visto protagonista il neo presidente
della Corte d'appello di Milano. Non appena Marra - riferiscono i militari - ha
ottenuto, dopo un'intensa attività di pressione esercitata dal gruppo (e in
particolare da Pasquale Lombardi) sui membri del Csm, l'ambita carica, i
componenti dell'associazione gli chiedono esplicitamente, peraltro dietro
mandato del presidente Formigoni, di porre in essere un intervento nell'ambito
della nota vicenda dell'esclusione della lista Per la Lombardia". Marra ha
commentato: "Sono contento che il Csm abbia aperto la procedura così si chiarirà
la mia posizione".
Intanto restano in
carcere l'affarista sardo Flavio Carboni e il magistrato tributario Pasquale
Lombardi. I giudici del tribunale del riesame di Roma hanno respinto, infatti,
le istanze di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari per
i due indagati. I pubblici ministeri avevano dato parere negativo alle richieste
dei legali.
In seguito a ciò, il 16
luglio 2010 è stato pubblicato l’editoriale del direttore di “Libero”, Maurizio
Belpietro dal titolo: “La cricca dei giudici”. "Se uno di noi fosse sospettato
di aver violato la legge e di essere al servizio di pericolosi criminali, il
minimo che gli potrebbe capitare sarebbe di essere indagato, il massimo di
finire in galera. Cosa che non accadrebbe se si trattasse di un magistrato. Nel
qual caso infatti si verrebbe trattati con mille attenzioni, anzi, con mille
attenuanti, perché la casta delle toghe è seria, non come quella dei politici,
che fa finta di essere potente e poi finisce alla berlina ogni giorno sulle
prime pagine dei giornali. Dunque, cari lettori, non fatevi ingannare dal caso
Marra, il presidente della Corte d’appello di Milano finito nelle
intercettazioni telefoniche della P3. Il suo trasferimento per incompatibilità è
infatti la manovra per mettere tutto a tacere o, peggio, per imbrogliare le
carte. Mi spiego. Se Marra fosse per davvero un magistrato in combutta con la
cricca di Flavio Carboni e si fosse macchiato della grave colpa di aver brigato
per favorire la P3 - cosa a cui io non credo - non dovrebbe essere trasferito
ad altra sede, come si appresta a fare il Csm. Semmai, dovrebbe essere radiato,
perché non ha le qualità morali per fare il magistrato. Il trasferimento al
contrario stabilisce che Marra non faccia più il giudice a Milano, ma possa
continuare a farlo altrove, come se nulla fosse accaduto. Del resto, il
Consiglio superiore della magistratura è specialista nell’assolvere i suoi
protetti.....".
Ma l'amico... l'amico
Lombardi è in grado di agire?". Al telefono Roberto Formigoni è supplichevole.
Teme che la sua lista venga esclusa dalle elezioni e invoca l'intervento
dell'"amico Lombardi": "Ti prego!". Ignora chi sia l'uomo di cui sta invocando
il sostegno: un geometra che fatica a parlare in italiano e fa replicare alla
supplica del governatore con un "dicitangill pure a chill amic tui su a Milan
(diteglielo anche a quell'amico tuo su a Milano)". Eppure l'irpino Pasquale
Lombardi, celebre nel suo giro per l'incapacità di sedere a tavola senza
imbrattarsi di sugo ("Il nostro comune amico che quanno magna se sporca
sempre..."), con il suo eloquio da Pappagone riusciva ad entrare in tutti i
palazzi del potere. Il suo motto era semplice: "Arriviamo, arriveremo dove
dobbiamo arrivare". In Cassazione, nel ministero dell'Economia e in quello della
Giustizia, nel Consiglio superiore della magistratura, nel Pirellone, nella
presidenza della Sardegna, in ogni procura d'Italia, il geometra Lombardi
trovava sempre le porte aperte. Snocciolava una serie di diminuitivi affettuosi
- Fofò, Nicolino, Pinuccio, Giacomino - con cui si rivolgeva a sottosegretari,
coordinatori di partito, governatori e procuratori della Repubblica. Fino a
incontrare "Chillu cess' e Nicola", al secolo Nicola Mancino, vicepresidente del
Csm e suo compaesano. E non era l'unico a godere di simili frequentazioni,
intime e pericolose.
Democrazia limitata. In
pochi mesi gli italiani hanno scoperto l'altro volto del potere: le cricche,
termine antico che indica "un gruppo informale e ristretto di persone che
condividono degli interessi". Aggiunge il dizionario: "Generalmente in una
cricca è difficile entrarvi". Invece di questi club esclusivi se ne sono emersi
parecchi. Un'orda che si è infilata dovunque: hanno influito e interferito su
ogni decisione importante degli ultimi dieci anni, dal Giubileo al G8, dalle
nomine al vertice della magistratura alla designazione dei presidenti di
Regione, dai processi nella Suprema corte al lodo Alfano. Centurie del
malaffare, avversarie e alleate a seconda della posta in gioco e dei loro punti
di forza, pronte a scambiarsi favori e tirarsi addosso dossier al veleno.
Deviazioni per tutti i
gusti. Ogni cricca ha la sua specialità. C'è quella degli appalti, con Diego
Anemone - geometra sconosciuto al pari di Lombardi - che riunisce a tavola e
negli affari il capo della Protezione civile Bertolaso, il gran commis di tutte
le opere pubbliche Balducci, il ministro Scajola e l'ex Lunardi, il coordinatore
pdl Verdini, il cardinale Angelo Sepe, un alto magistrato e una sterminata lista
di beneficiati eccellenti. C'è quella del riciclaggio scoperchiata dal pm
Giancarlo Capaldo, tra traffici sulla telefonia e sospetti di narcotraffico, del
pregiudicato romanissimo Gennaro Mokbel e del suo senatore Nicola Di Girolamo,
che muovono tanto denaro da non riuscire a contarlo ed esclamare "c'avete rotto
il cazzo co tutti sti milioni". C'è poi la rete su scala minore dei fratelli De
Luca, imprenditori campani delle ferrovie, con parenti al Csm, agganci in
Vaticano e intrallazzi al ministero delle Infrastrutture. E il sogno infranto di
Giampi Tarantini, che era entrato nelle notti di Villa Certosa e Palazzo
Grazioli, passando dai contratti della sanità pugliese alle holding
internazionali come Finmeccanica. Senza dimenticare sullo sfondo la nebulosa di
Why Not, la ragnatela di contatti messa a nudo dall'indagine di Luigi De
Magistris: una mappa delle relazioni altolocate, senza risvolti penali ma
comunque significative per capire cosa resta della democrazia.
Le regole dei clan.
Scordatevi delle tessere o dei cappucci: elenchi massonici come nella vecchia P2
sono ricordi del passato. E quanto c'entri la massoneria nel diffondere questo
contagio ancora non è chiaro, anche se l'aura dei liberi muratori circonda molti
protagonisti tra Toscana e Sardegna. Pur senza gran maestri e gerarchie, come in
un gioco di ruolo ogni cricca per funzionare richiede alcune figure
specializzate. C'è il tesoriere, in genere un imprenditore, che sostiene le
spese del gruppo. Il clan degli irpini poteva attingere ai capitali di Arcangelo
Martino, ex assessore socialista napoletano diventato un ras delle forniture
ospedaliere: sede legale a Lodi, base operativa nel Casertano e oltre cento Asl
nel carniere. Con Formigoni ha un filo diretto e non solo con lui: sono in molti
a scommettere che il prossimo filone riguarderà la sanità e sarà dirompente. La
gang degli appalti invece usava i fondi di Anemone, costretto a sudare quattro
camicie per ragranellare il cash prima di cene con Bertolaso e generoso nel
finanziare le dimore di Scajola, di un generale del Sisde e di altre perdine
ministeriali. Ma Anemone spesso pagava in natura, ossia faceva lavori a gratis o
a prezzo di costo a tutta la Roma che conta. In più c'era la santa alleanza con
il cardinale Angelo Sepe che aveva offerto il catalogo di Propaganda Fide, con
case da sogno a prezzi modici. Tutte le consorterie cercavano un padre
spirituale con mire materiali. Sepe era intimo di Balducci, Bertolaso e company
ma avrebbe tenuto relazioni intense anche con Arcangelo Martino e viene chiamato
a benedire un convegno dei magistrati sedotti dal geometra Lombardi. Molto
attivo e trasversale monsignor Francesco Camaldo, cerimoniere del papa e delle
raccomandazioni. Invece i fratelli De Luca si rivolgono al cardinale Fiorenzo
Angelini, ben introdotto tra i parlamentari cattolici e nell'ufficio di
Bertolaso "che ha aiutato moltissimo...".
Quella nomina fu una
ferita mai rimarginata. E con le intercettazioni sulle manovre sotterranee per
ottenerla è tornata a sanguinare. Al punto da dover correre ai ripari in tutta
fretta, per quanto si può. La decisione di far presiedere la corte d’appello di
Milano ad Alfonso Marra divise a metà il Consiglio superiore. Era il 3 febbraio
scorso. Marra ottenne 14 voti contro i 12 dell’altro candidato, Renato Rordorf.
Fu una spaccatura trasversale, anche all’interno delle correnti. Dentro Unicost
e Magistratura indipendente, i due gruppi «moderati», Berruti e Patrono si
schierarono a favore di Rordorf, considerato «di sinistra». E tra i «laici»
eletti dall’Ulivo, Celestina Tinelli preferì Marra. Come i tre membri
dell’ufficio di presidenza (Mancino, il presidente della Cassazione Carbone e il
procuratore generale Esposito); per motivi di opportunità, fecero trapelare,
legati a un precedente voto unanime in favore dello stesso giudice, e perché
Rordorf aveva lavorato al Csm.
Spiegazioni che
all’epoca non convinsero. Perché nei corridoi del palazzo dei Marescialli, sede
del Csm, si sussurrò fin da subito che dietro i voti determinanti della Tinelli,
di Mancino e di Carbone c’era qualcosa di strano. Niente di dimostrabile, ma
molto di avvertito. Nell’abituale resoconto per gli aderenti alla sua corrente,
la consigliera di Magistratura democratica Elisabetta Cesqui, già pubblico
ministero nel processo alla Loggia P2, sulla nomina di Marra si lasciò andare a
considerazioni amare: «L’aria viziata delle pressioni si è sentita fortissima...
Il Consiglio può fare tutti gli sforzi di rinnovamento che vuole, ma quando si
parla di decisioni veramente importanti, l’esigenza di presidio di certi
territori e di certi uffici prevale sistematicamente sulle logiche di merito
effettivo».
Ora le registrazioni di
alcuni colloqui messi a fondamento dell’arresto dei tre ispiratori della
presunta «associazione segreta» che si sarebbe adoperata, fra l’altro, per la
nomina di Marra, ha dato nuovi argomenti a chi sosteneva quella tesi. Al di là
della loro rilevanza penale. I dialoghi fra Pasquale Lombardi, il «ministro
della Giustizia» del gruppo, con lo stesso Marra e con il sottosegretario
Giacomo Caliendo (ex magistrato di Unicost) sembrano dare concretezza ai
sospetti. Come se avessero strappato un velo.
«Mi pare che ho
concluso, per te, col capo», diceva Lombardi a Marra dopo un incontro con
Carbone. «Ma bisogna avvicinare ’sto cazzo di Berruti... », ribatteva Marra. E
Lombardi a Caliendo: «Per quanto riguarda Berruti te la devi vedere tu». Poi
ancora a Marra: «Ho parlato con Giacomino e... stiamo operando». Alla Tinelli
chiedeva: «È opportuno che ne parli un poco con il presidente Carbone?». E lei:
«Sì, assolutamente». In altri dialoghi Lombardi faceva intendere che il voto di
Carbone si poteva conquistare prolungando la sua permanenza al vertice della
Cassazione, con un emendamento sull’età pensionabile; riferiva di incontri con
Mancino, e consigliava Marra di rivolgersi all’ex ministro Diliberto per
convincere la «laica» Letizia Vacca.
Tutte chiacchiere e
millanterie, replicano gli interessati; Carbone avrebbe persino avvisato il
ministro della Giustizia che non avrebbe accettato proroghe della sua
presidenza. Ma è difficile districarsi tra intercettazioni e giustificazioni.
Restano la puzza di bruciato che si avvertì al tempo della nomina e le
conversazioni che oggi rivelano le pressioni. Almeno tentate, visto il tempo
trascorso al telefono da Lombardi per il suo amico Marra. «Pasqualì, poi
facciamo ’na bella festa, a Milano o a Roma», diceva il giudice. E l’altro: «Eh,
ce la facimm’ ’na bella festa!». La rapidissima decisione del Csm, giunto a fine
mandato, scadrà fra due settimane, di avviare la pratica per la rimozione di
Marra sembra il tentativo di cancellare una pagina opaca della propria storia.
Quasi certamente toccherà al prossimo Consiglio decidere il destino di quel
giudice, ma chi l’ha nominato ha voluto mettere le basi per dissipare l’ombra di
una scelta condizionata da un gruppo di potere occulto e illegale, almeno
secondo l’accusa. Lo stesso Csm ha chiesto alla Procura di Roma «ogni utile
informazione» su altri magistrati i cui nomi emergono dall’inchiesta. A
cominciare da Arcibaldo Miller, il capo degli ispettori del ministero della
Giustizia, che, hanno scritto i carabinieri nel loro rapporto, «forniva il
proprio contributo alle attività di interferenza». Al pari del sottosegretario
Caliendo e dell’ex avvocato generale della Cassazione Antonio Martone, che però
hanno abbandonato la toga.
Anche la decisione
della Procura generale di aprire l’istruttoria per un procedimento disciplinare
a Marra suona come uno squillo di riscossa rispetto alla «questione morale»
nella magistratura; e così l’allarme del segretario dell’Associazione magistrati
Giuseppe Cascini, che confessa di aver provato «vergogna, indignazione e rabbia»
a leggere i dialoghi dei suoi colleghi intercettati. L’Anm ha chiesto ai
probiviri di valutare sanzioni, fino all’eventuale espulsione. Come se ci fosse
l’urgenza di fare pulizia nella corporazione, a costo di dividere i magistrati e
le loro correnti, pure al proprio interno. Per dare un esempio alla politica,
l’altro potere toccato dall’indagine giudiziaria, col quale le toghe (non tutte,
a leggere i resoconti dell'intercettazioni) sembrano in perenne conflitto.
"Prendono parte alle
riunioni nelle quali vengono impostate le operazioni e paiono fornire il proprio
contributo alle attività di interferenza". Venti nomi che scottano. Quelli delle
toghe coinvolte nell'inchiesta sull'eolico e sulla nuova loggia "P3". Il
rapporto dei Carabinieri non lascia adito a equivoci. Era fitta la rete di
giudici e procuratori attraverso la quale la banda Carboni portava avanti i suoi
piani di "interferenza" sulle istituzioni. Tutto ruotava intorno al ruolo di
Arcibaldo Miller (capo degli ispettori del ministero della Giustizia), Giacomo
Caliendo (sottosegretario alla Giustizia) e Antonio Martone (ex avvocato
generale in Cassazione). Loro gli incaricati di costruire la ragnatela da
stendere sui magistrati. Qualcuno aveva un ruolo di primissimo piano
nell'attività dell'associazione segreta, altri davano informazioni preziose.
Altri ancora erano semplicemente oggetto di tentativi di avvicinamento da parte
della combriccola che - per perseguire i propri obiettivi illeciti - si avvaleva
della copertura offerta dal centro studi "Diritti e libertà".
Sono sempre Miller,
Caliendo e Martone i commensali del famoso pranzo a casa Verdini del 23
settembre scorso in cui sarebbe stato pianificato il condizionamento della
Consulta per far approvare il Lodo Alfano. Martone era stato invitato senza giri
da parole da Lombardi all'incontro a piazza dell'Aracoeli: "Noi ci dobbiamo
vedere all'una meno un quarto". "Ma io sono impegnato con il procuratore...
Mandalo affanc. che chisto non porta voti e vieni da noi...", insiste Lombardi
mostrando una certa confidenza.
Caliendo poi è presente
in tutte le manovre. Dopo il pranzo a casa Verdini, Lombardi raccomanda al
sottosegretario di fare la conta dei giudici costituzionali a favore e contro il
Lodo: "Ci dobbiamo vedere ogni giorno, ogni settimana, capire dove sta o' buono
e dove o' malamente: vuagliò, ti hai la strada spianata per fare il ministro".
Le carte raccontano che Caliendo, su pressione di Lombardi, ha sollecitato al
vicepresidente del Csm Mancino la nomina di Alfonso Marra a presidente della
Corte d'Appello di Milano. Nomina che si è rivelata poco decisiva: Caliendo
infatti è poi intervenuto, senza fortuna, con lo stesso Marra per far accogliere
il ricorso di Formigoni contro l'esclusione della sua lista nelle elezioni
regionali lombarde. Successivamente, davanti alle pressioni dello stesso
Lombardi per far inviare gli ispettori alla Procura di Milano, il
sottosegretario ammetterà: "L'ho chiesto trenta volte al ministro!". Della
stessa vicenda è protagonista anche Miller, chiamato confidenzialmente Arci dai
membri della banda, che in una telefonata del 5 marzo 2010 suggerisce ad
Arcangelo Martino cosa fare per ottenere l'ispezione: "Ci vorrebbe un
esposto...".
Un magistrato vicino a
Lombardi, Angelo Gargani, compare frequentemente nell'inchiesta: con il
tributarista, dopo il pranzo a casa Verdini, parla della vicenda del Lodo e gli
fornisce il numero di un ex presidente della Consulta da contattare, Cesare
Mirabelli (che respingerà la "corte" del disinvolto faccendiere napoletano).
Lombardi attiva di continuo la sua rete di contatti con i magistrati. Lo fa
all'occorrenza e soprattutto in occasione dell'elezione di Marra che - secondo i
carabinieri - è avvenuta proprio grazie all'interferenza della banda. Il
tributarista ne parla il 21 ottobre 2009 con Celestina Tinelli, componente del
Csm. Alla quale chiede informazioni anche sulle chances di altri due "amici" in
corsa per incarichi di rilievo: Gianfranco Izzo per la Procura di Nocera e Paolo
Albano per Isernia. Lombardi parla in quel periodo con diversi magistrati. Fra i
voti da conquistare (e poi conquistati) per l'elezione di Marra, c'è quello di
Vincenzo Carbone, primo presidente di Cassazione: il 22 ottobre Lombardi invita
Caliendo a "lavorarselo per bene", e gli comunica di avere già prospettato un
aumento dell'età pensionabile da 75 a 78 anni. Una modifica della legge che
proprio in quei giorni il governo proporrà con un emendamento. Lo stesso
Carbone, un mese prima, aveva chiesto a Lombardi: "Che faccio dopo la
pensione?".
Un altro giudice,
Francesco Castellano, il 31 gennaio 2010 conferma all'attivissimo Lombardi di
avere segnalato alla Tinelli il nome di Marra. Ma intanto Lombardi aveva già
parlato del caso Marra a Beppe ("verosimilmente il giudice Giuseppe Grechi",
scrivono i carabinieri). Anzi, è quest'ultimo il 16 novembre 2009 a chiedere a
Lombardi qual è l'intenzione del "comune amico" Carbone in vista del voto:
"Tienilo sotto che lo tengo sotto anch'io", dice il tributarista.
Il 19 gennaio 2010
Lombardi parla con Gaetano Santamaria della candidatura di tale "Nicola" per la
Procura di Milano. A Cosimo Ferri, altro componente del Csm, arriva a chiedere
il rinvio di quella nomina. Ferri, in realtà, si ritrae imbarazzato. A Lombardi
sta a cuore, in quel periodo, anche la candidatura di Nicola Cosentino alla
guida della Regione Campania. Vede due volte il procuratore di Napoli
Giambattista Lepore per chiedergli informazione sulla situazione giudiziaria di
Cosentino, indagato per rapporti con la camorra. Dopo l'incontro del 20 ottobre
2009, Lombardi riferirà, violando tutte le procedure, ad Arcangelo Martino che
le prospettive per il sottosegretario (appena dimessosi) non sono buone:
"Negativo al 90 per cento". Agli atti anche una telefonata fra Lombardi e il
magistrato Giovanni Fargnoli: parlano del ricorso in Cassazione contro la
richiesta di arresto a carico di Cosentino: Fargnoli assicura a Lombardi che gli
farà sapere perché il ricorso è stato rigettato. Una conferma, l'ennesima, della
rete che lega i componenti della combriccola, i politici e i magistrati: il 14
ottobre 2009 Ugo Cappellacci, presidente della Sardegna, chiama Martino per
avere il numero di telefono di Cosimo Ferri: vuole evitare il trasferimento di
Leonardo Bonsignore, presidente del tribunale di Cagliari, ad altra sede:
"Perderemmo un amico carissimo e una persona valida". Martino si attiva subito e
parla con la segretaria di Ferri. Secondo i carabinieri proprio per questo
motivo Martino "poteva ritenersi creditore nei confronti di Cappellacci".
Le P...Poteri occulti,
ma non troppo!!.
La loggia di Licio
Gelli.
Propaganda Due, nota
come P2, è stata una loggia massonica segreta con fini eversivi. Dal 1970 venne
guidata da Licio Gelli (sotto), nel 1982 fu sciolta per legge. Quasi mille gli
iscritti alla loggia segreta. Il 17 marzo 1981 il colonnello Vincenzo Bianchi si
presenta a Villa Wanda, a Castiglion Fibocchi, vicino ad Arezzo, residenza
dell'allora quasi sconosciuto Licio Gelli. Ha in tasca un mandato di
perquisizione dei giudici milanesi Giuliano Turone e Gherardo Colombo, che
indagano sull'assassinio Ambrosoli e sul finto sequestro di Sindona, mandante
del delitto. Dopo qualche ora di lavoro, l'ufficiale riceve una telefonata del
comandante generale della Finanza, Orazio Giannini. Si sente dire: «So che hai
trovato gli elenchi e so che ci sono anch'io. Personalmente non me ne frega
niente, ma fai attenzione perché lì dentro ci sono tutti i massimi vertici».
Poche parole, dalle quali Bianchi è colpito per la doppia intimidazione che
riassumono. Cioè per quel «non me ne frega niente», che esprime un assoluto
senso d'impunità. E per quel «tutti i massimi vertici», che capisce va riferito
ai vertici «dello Stato e non del corpo» di cui lui stesso indossa la divisa. Ed
è proprio vero: c'è una parte importante dell'Italia che conta, in quella lista
di affiliati alla loggia massonica Propaganda Due, che il colonnello sequestra
assieme a molti altri documenti e trasporta sotto scorta armata a Milano. Ci
sono 12 generali dei carabinieri, 5 della guardia di Finanza, 22 dell'Esercito,
4 dell'Areonautica militare, 8 ammiragli, direttori e funzionari dei vari
servizi segreti, 44 parlamentari, 2 ministri in carica, un segretario di
partito, banchieri, imprenditori, manager, faccendieri, giornalisti, magistrati.
Insomma: nella P2 ci sono 962 nomi di persone che formano «il nocciolo del
potere fuori dalla scena del potere, o almeno fuori dalle sue sedi conosciute».
Una sorta di «interpartito» formatosi su quello che appare subito come un oscuro
groviglio d'interessi dietro il quale affiorano business e tangenti, legami con
mafia e stragismo, il golpe Borghese, omicidi eccellenti (Moro, Calvi,
Ambrosoli, Pecorella) e soprattutto un progetto politico anti-sistema. Quando,
dopo due mesi di traccheggiamenti, gli elenchi sono resi pubblici, lo scandalo è
enorme. Il governo ne è travolto e il 9 dicembre 1981, anche per la spinta di
un'opinione pubblica sotto shock e che chiede la verità, s'insedia una
commissione parlamentare d'inchiesta, che la presidente della Camera, Nilde
Jotti, affida alla guida di Tina Anselmi. Da allora l'ex partigiana di
Castelfranco Veneto, deputata della Dc e prima donna a ricoprire l'incarico di
ministro, comincia a tenere un memorandum a uso personale oggi raccolto in
volume: «La P2 nei diari segreti di Tina Anselmi», a cura di Anna Vinci
(Chiarelettere, pag. 576, euro 16). Tra i primi appunti, uno è rivelatore del
clima che investe la politica («i socialisti sono terrorizzati dall'inchiesta»)
e l'altro del metodo che la Anselmi intende seguire: «Fare presto, delimitare la
materia, stare nei tempi della legge». Un proposito giusto. Lo sfogo del
colonnello Bianchi le ha fatto percepire l'enormità dell'indagine e i livelli
che è destinata a toccare. Diventa decisivo, per lei, sottrarsi all'accusa di
«dar la caccia ai fantasmi» e di certificare quindi l'attendibilità delle liste
(su questo si gioca la critica principale), come pure evitare che
l'investigazione si chiuda con il giudizio minimalista accreditato da alcuni,
secondo i quali la P2 sarebbe solo un «comitato d'affari». È un'impresa dura e
difficile, per la Anselmi. Carica di inquietudini. Lo dimostrano i 773 foglietti
in cui annota ciò che più la colpisce durante le 147 sedute della commissione.
Riflette, ad esempio, il 14 aprile 1983: «Strano atteggiamento del Pci... non mi
pare che voglia andare a fondo. La stessa richiesta loro di non approfondire il
filone servizi segreti fa pensare che temano delle verità che emergono dal
periodo della solidarietà. Ipotesi: ruolo di Andreotti, che li ha traditi? O
coinvolgimento di qualche loro uomo? Più probabile la prima ipotesi. Mi pare che
Br e P2 si siano mosse in parallelo e abbiano fatto coincidere i loro obiettivi
sul rapimento e sulla morte di Moro». Altro appunto, del 26 gennaio '84, con
l'audizione di Marco Pannella: «Com'è possibile che Piccoli, Berlinguer e
Andreotti non sapessero della P2 prima del 1981?». Ragionando poi sul fatto che
gli elenchi non sono forse completi e che Gelli potrebbe essere solo «un
segretario», si chiede se la pista non vada esplorata fino a Montecarlo, sede di
una evocata super loggia. E ancora, il 16 dicembre '81 mette a verbale che il
parlamentare Giuseppe D'Alema (padre di Massimo) «consiglia di parlare» con un
poco conosciuto giudice di Palermo che cominciava a conquistarsi le prime pagine
sui giornali: Giovanni Falcone. S'incrocia di tutto in quelle carte. La
fantapolitica diventa realtà. Ci sono momenti nei quali la commissione è una
«buca delle lettere»: arrivano messaggi cifrati, notizie pilotate o false,
ricatti. Parecchi riguardano la partita aperta intorno al Corriere della Sera,
che era stato infiltrato (nella proprietà e in parte anche nella redazione) da
uomini del «venerabile» e alla cui direzione c'è ora Alberto Cavallari, indicato
da Pertini per restituire l'onore al giornale. In questo caso sono insieme
all'opera finanzieri e politici, ossessionati dalla smania di controllare via
Solferino. Si agitano anche pezzi del Vaticano, il cardinale Marcinkus, senza
che la cattolica Anselmi se ne turbi e lo dimostra ciò che dice al segretario,
Giovanni Di Ciommo: «Non ho fatto la staffetta partigiana per farmi intimidire
da un monsignore». Ma a intimidirla ci provano comunque. La pedinano per strada.
Qualche collega, passando davanti al suo scranno a Montecitorio, le sibila: «Chi
te lo fa fare? Qua dobbiamo metterci i fiori». Fanno trovare tre chili di
tritolo vicino a casa sua. Lei tira dritto. Quando, il 9 gennaio '86, presenta
alla Camera la monumentale conclusione del suo lavoro, 120 volumi, definisce la
P2 «il più dotato arsenale di pericolosi e validi strumenti di eversione
politica e morale» (il piano di Rinascita Democratica di Gelli). Nel diario
aveva profeticamente scritto: «Le P2 non nascono a caso, ma occupano spazi
lasciati vuoti, per insensibilità, e li occupano per creare la P3, la P4...».
Sono passati trent'anni e la testimonianza di Tina Anselmi, dimenticata e da
tempo malata, è da riprendere. Magari riflettendo su un dato: nella lista
compariva anche il nome di Silvio Berlusconi. All'epoca era soltanto un giovane
imprenditore rampante e i parlamentari non ritennero di sentirlo perché era
parso un «personaggio secondario».
La cricca di Carboni.
È stato ribattezzato P3
il presunto gruppo di potere occulto che ruotava intorno a Flavio Carboni,
Arcangelo Martino e Pasquale Lombardi: avrebbe tentato di condizionare la Corte
Costituzionale e altre istituzioni. Dalla scoperta della P2 di Licio Gelli sono
passati ormai trent'anni. E una legge, l'Anselmi, che ha bandito ogni
organizzazione segreta. Eppure da le indagini di due Procure (di Roma e di
Napoli) si sono concentrate sull'esistenza di nuovi circoli occulti,
ribattezzati P3 e P4, finalizzati ad ottenere indebiti vantaggi (appalti,
nomine, finanziamenti) tramite lo scambio di favori.
La Loggia P3.
Il caso nasce nel 2010,
nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Roma sugli appalti per l’eolico che
porta in carcere l’imprenditore Flavio Carboni, il geometra Pasquale Lombardi e
il costruttore Angelo Martino. Nel registro degli indagati, per associazione a
delinquere e violazione della legge Anselmi sulle società segrete, finiscono
anche il senatore del Pdl Marcello dell’Utri, il sottosegretario all’economia
Nicola Cosentino, il coordinatore del Pdl Denis Verdini e l’ex assessore
all’avvocatura della Regione Campania, Ernesto Sica. La presunta loggia, guidata
da Carboni, oltre a consorziarsi per bypassare la concorrenza nella vittoria di
appalti pubblici avrebbe anche progettato di influenzare i giudici della Corte
Costituzionale incaricati di pronunciarsi sul Lodo Alfano. Carboni, Lombardi e
Martino avrebbero tentato persino di avvicinare i magistrati della procura di
Firenze che stavano indagando sui Grandi Eventi e sugli appalti legati al G8.
Secondo gli inquirenti, il gruppo "per acquisire e rafforzare utili conoscenze
nell'ambiente della politica e della magistratura" utilizzava l'associazione
culturale "Centro studi giuridici per l'integrazione europea Diritti e
Libertà"di Lombardi.
E la Loggia P4.
E’ il nome dato ad una
presunta associazione segreta su indagine della Procura di Napoli. Il suo scopo
sarebbe quello di “interferire sull’esercizio delle funzioni di organi
costituzionali e di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo”.
L’inchiesta è condotta da due pm di Napoli, secondo i quali i membri
dell’associazione si scambiavano favori nell’assegnazione di appalti, di nomine
e di finanziamenti. Tra gli indagati ci sono un poliziotto partenopeo ed Enrico
La Monica, maresciallo nella sezione anticrimine dei carabinieri di Napoli. I pm
ritengono che La Monica abbia rivelato “in più occasioni notizie coperte da
segreto, anche attinte da altri appartenenti alle forze dell’ordine”. Gli ultimi
a finire nel registro degli indagati sono Luigi Bisigani, giornalista e
consulente aziendale, da molti considerato il personaggio chiave della vicenda,
arrestato per l'ipotesi di favoreggiamento in relazione alla rivelazione di
notizie coperte da segreto, e il parlamentare Pdl Alfonso Papa. Secondo gli
inquirenti la P4 sarebbe un sistema informativo parallelo, creato per ottenere
notizie riservate su appalti e nomine., con ogni mezzo: dal dossieraggio
clandestino al ricatto, anche attraverso organi costituzionali. Quello degli
appalti pilotati è la parte più delicata sulla quale i sostituti procuratori
napoletani stanno lavorando. La "cricca" avrebbe agito sostanzialmente in due
modi. Da un lato, acquisendo, negli ambienti giudiziari, informazioni secretate
relative a procedimenti penali in corso. Dall’altro, raccogliendo dati sensibili
sulle alte cariche dello Stato. Informazioni e notizie che poi sarebbero state
utilizzate in modo "illecito" con lo scopo di ottenere "indebiti vantaggi".
Anche il direttore de L’Avanti, Valter La Vitola era satto interrogato come
teste riguardo alla faccenda legata alla casa di Montecarlo del presidente della
Camera Fini. Ad insospettire gli inquirenti sarebbero stati alcuni scoop messi a
segno dalla testata.
Il dossier di
Bisignani.
È stato chiamato P4 il
«sistema parallelo» messo in piedi da Bisignani e Papa: un sistema finalizzato
alla gestione di notizie riservate, appalti e nomine, anche attraverso
interferenze su organi costituzionali. P4, la rete di Bisignani e Papa: finanza,
giudici e 007. Sui giornali nuove indiscrezioni sull’inchiesta sulla presunta
associazione segreta che ha portato all’arresto dell’uomo d’affari e che
coinvolge anche il deputato del Pdl. Tra i loro contatti ci sarebbero anche
Pollari e Toro.
L'inchiesta sulla
cosiddetta P4.
Nuove indiscrezioni sui
giornali sull’inchiesta sulla presunta P4 che ha portato ai domiciliari Luigi
Bisignani e alla richiesta di custodia cautelare in carcere per Alfonso Papa,
deputato eletto nel Pdl. Un’inchiesta su una presunta associazione segreta, i
cui membri avevano rapporti ad alti livelli nel mondo della politica, pubblica
amministrazione e dell'impresa, che raccoglieva informazioni riservate e le
usava per esercitare pressioni, ricatti e ottenere vantaggi personali. Una nuova
bufera che ha coinvolto anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
Gianni Letta che, secondo indiscrezioni, sarebbe stato il referente principale
di Bisignani.
In primo piano sui
quotidiani di venerdì 17 giugno 2011 i rapporti di Luigi Bisignani con la
Guardia di Finanza e i giudici. Alfonso Papa sarebbe stato il suo contatto per
costruire la rete. “Non c’è dubbio che i canali informativi di Alfonso Papa
erano prevalentemente nella Guardia di Finanza. Al riguardo, lui aveva rapporti
con ufficiali del Corpo”. Queste le parole che Bisignani avrebbe detto, secondo
quanto riporta Repubblica. Il legame tra Papa e la Guardia di Finanza risale al
2001 quando giovanissimo magistrato - pm, lascia Napoli per assumere l’incarico
di vice-capo di Gabinetto del ministro di Giustizia Roberto Castelli. Da lì in
avanti dieci anni di lavoro per agganciare lo stato maggiore della Guardia di
Finanza. Secondo il quotidiano diretto da Ezio Mauro “il parlamentare del Pdl
diceva di conoscere e vedere i generali Adinolfi, Barbi e Mainolfi”. Tra gli
amici di Papa, secondo quanto riportano sia Repubblica sia il Corriere della
Sera citando dichiarazioni di Bisignani, ci sarebbe anche l’ex direttore del
Sismi Niccolò Pollari. Non solo. L’ex parlamentare Alfredo Vito avrebbe messo a
verbale: “La candidatura di Papa fu conseguenza di un intervento diretto di
Pollari, lui era legato ai servizi segreti”. Il Corriere della Sera pubblica una
pagina dei tabulati relativi alle intercettazioni in cui Papa farebbe
riferimento a un appuntamento con “quel generale”. Per quanto riguarda invece i
contatti con i pm, Papa avrebbe avuto stretti legami con le Procure di Roma,
Napoli, Trani, Bari e Milano. In particolare, in un articolo di Repubblica a
firma di Francesco Viviano si citano i nomi del procuratore aggiunto di Roma
Achille Toro e del figlio Camillo. L’ex presidente della Corte d’appello di
Salerno Umberto Marconi, anche lui coinvolto nell’inchiesta sulla P3, avrebbe
detto al collega Woodcock secondo quanto riportano sia Repubblica sia il
Corriere della Sera: “Sono certo che Papa abbia spiegato e spieghi le proprie
energie intrecciando rapporti con i carabinieri, con i servizi segreti..
concentrato sempre ad agire sull’ombra. Papa ha praticamente a disposizione
delle truppe che utilizza per perseguire i suoi scopi personali”. La Stampa
parla anche di ricatti che Papa avrebbe fatto ad alcuni imprenditori. Come
Vittorio Casale, che "per un paio di anni ha pagato a Papa la garconnière di via
Giulia a 800 euro al mese. In cambio Papa gli aveva promesso soluzione ai suoi
problemi giudiziari. E' stato arrestato". Sul quotidiano anche un ritratto di
Alfonso Papa dal titolo "Il trafficante di segreti che mancava alla destra". Sui
giornali vicini al centrodestra continuano invece a sostenere che tutta
l’inchiesta sia solo un modo per mettere in difficoltà il governo. “Svolazzano
attorno a Berlusconi. E’ il momento dei corvi. Basta leggere Repubblica per
capire: nell’inchiesta sulla presunta loggia P4 tirano in ballo Letta per
colpire il premier” titola Il Giornale. Libero invece riprende una storia
pubblicata da l’Espresso e gli dedica la prima pagina: “Il bunga bunga dell’Idv.
Una giovane disoccupata accusa il senatore Pedica e il deputato Zazzera: “Mi
hanno estorto sesso promettendomi un lavoro. Che non ho mai visto”. Da Toro ad
Arcibaldo Miller, "Così Papa controllava le procure". Molti i nomi di magistrati
finiti nell'ordinanza del Gip di Napoli sull'inchiesta su Bisignani che dice ai
giudici: "Quando parlo di giri e giretti del deputato del Pdl mi riferisco
all'ambito napoletano. Lì lui attingeva informazioni". Di FRANCESCO VIVIANO su
La Repubblica del 17 giugno 2011.
Roma, Napoli, Trani,
Bari, Milano. Una rete che gli permetteva di entrare nelle procure di mezza
Italia. Tra fascicoli e segreti d'ufficio. Alfonso Papa, già magistrato poi
deputato Pdl, aveva amicizie importanti e, a quanto pare, loquaci. Tanto loquaci
da procuragli, a suon di informazioni riservate, uno scranno in Parlamento. Un
giro che partiva da Bisignani, toccava molti esponenti della maggioranza e
arrivava dritto al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta.
Tanti i nomi di magistrati finiti nell'ordinanza del gip del tribunale di
Napoli. Amici di una vita, colleghi di vecchia data, militanti della sua stessa
corrente, Unicost, ma anche molte toghe che non sapevano di passare informazioni
al collega assetato di potere. Che era interessato alle inchieste più
importanti: la P3 di Roma, la P4 di Napoli e quella sul G8. Ma, più in generale,
a qualsiasi fascicolo coinvolgesse qualche politico. Spuntano così il nome del
procuratore capo di Bari, Antonio Laudati, con cui Papa diceva di essere in
buoni rapporti e dell'ex procuratore aggiunto di Roma, Achille Toro, già
coinvolto nell'inchiesta sui Grandi Eventi. L'amicizia tra i due era di dominio
pubblico. Maria Elena Valanzano, assistente parlamentare di Papa, il 18 febbraio
scorso, mette a verbale: "Per quanto riguarda l'ambito giudiziario romano, Papa
spesso mi parlava dei suoi contatti e delle sue aderenze con il procuratore
Achille Toro e con il figlio, Camillo". Un legame molto stretto, tanto da
cercare di dare una mano all'amico caduto in disgrazia. Il 9 marzo 2011
Bisignani chiarisce: "Era molto amico dell'allora procuratore aggiunto di Roma
Achille Toro e del figlio Camillo. Al riguardo più volte mi chiese di poter
trovare qualche incarico per Toro". Alcune delle toghe citate sono state sentite
dal pm John Henry Woodcock. Come nel caso di Arcibaldo Miller che fu "maestro"
proprio di Woodcock. Il capo degli ispettori di via Arenula, citato in alcune
conversazioni si è difeso: "Voglio ribadire di non aver mai chiesto a Papa di
interessarsi delle vicende processuali nella quali è comparso il mio nome".
Dall'inchiesta emerge anche che l'onorevole avrebbe tentato di "contattare" il
vice presidente del Csm, Michele Vietti. A raccontarlo è la sua ex assistente,
Maria Roberta Darsena, una a cui Papa teneva parecchio, tanto da regalarle una
Jaguar. È il 12 aprile, la donna spiega: "Dissi a Papa che ero stata a una cena
con Vietti, al riguardo mi fece un sacco di domande e mi chiese con insistenza
morbosa quale fosse il ristorante, che io non ricordavo, e tutti i dettagli
della serata". La procura decide quindi di convocare Vietti, ritenuto una
"possibile vittima dell'acquisizione di fatti privati a scopo di pressione". Le
sue dichiarazioni non vengono nemmeno riportate. I contatti migliori erano,
però, quelli partenopei. "Diceva che a Napoli, in ambito giudiziario, la
"comandava lui"", ha spiegato Luigi Matacena ai magistrati. Rapporti
consolidati, a detta dello stesso Bisignani. "Quando parlo di Papa, dei suoi
"giri" o "giretti" e delle sue "fonti" dalle quali attingeva notizie riservate
di matrice giudiziaria, faccio riferimento all'ambito napoletano, nel senso che
mi ha sempre detto di avere amicizie e legami tra le forze di polizia e in
procura a Napoli". Contatti continui, le informazioni sui procedimenti a carico
dei politici sono merce di scambio. L'ex Presidente della Corte di Appello di
Salerno, Umberto Marconi, coinvolto anche nell'inchiesta P3 per il falso
dossieraggio nei confronti di Caldoro, ha detto al collega Woodcock: "Sono certo
che Papa abbia spiegato e spieghi le proprie energie intrecciando rapporti con i
carabinieri, con i servizi segreti... concentrato sempre ad agire nell'ombra.
Papa ha praticamente a disposizione delle "truppe" che utilizza per perseguire i
suoi scopi personali". La trama puntava dritto a palazzo Grazioli. Lo stesso
Giacomo Caliendo, sottosegretario alla Giustizia, il 9 dicembre racconta: "Dopo
le ultime elezioni il presidente Berlusconi, in una occasione, mi chiese notizie
su Papa dal momento che aveva ricevuto qualche segnalazione diretta a fargli
ottenere un incarico".
WALT DISNEY, IL MASSONE?
L’Uomo, il Regista, il Produttore
cinematografico e il Massone, scrive "Goilo
Lombardia". Fumettista, animatore, imprenditore, cineasta e doppiatore
statunitense, come regista e produttore cinematografico realizzò molti film
d'animazione e di storie a fumetti. Creatore di personaggi che sono diventati
famosi in tutto il mondo, diede vita a un universo immaginario basato su una
costante: la lotta e il trionfo del bene sul male, della luce sulle tenebre.
Riconosciuto da tutti come uno dei principali cineasti del XX secolo e come il
padre dei film d'animazione. Walter Elias Disney nasce il 5 dicembre 1901 a
Chicago, trascorre un'infanzia molto difficile a causa della madre che abbandona
la famiglia. A dieci anni vende giornali per la strada, ben presto nasce il suo
amore per il disegno che diverrà per lui una professione di successo: inizia a
lavorare a Kansas City presso una agenzia pubblicitaria dove incontra Ub Iwerks,
che diverrà il suo più stretto collaboratore con cui realizza una piccola serie
di cartoon satirici, successivamente fonda (1922) una piccola società di
produzione con cui realizza 7 brevi fiabe. L'impresa purtroppo fallisce e
Disney, insieme al fratello Roy e Iwerks si trasferisce a Hollywood dove fonderà
qualche anno dopo la Walt Disney Production. Nel 1928 realizza un cartone
animato con un personaggio che segnerà la storia dell'animazione: Mickey
Mouse (Topolino). Negli anni successivi realizza nuovi film di animazione, prima
muti, poi sonori creando nuovi personaggi. Nel 1933 è la volta de I tre piccoli
porcellini, la cui canzone, "Who's Afraid of the Big Bad Wolfe?", diventa l'inno
della campagna elettorale di Roosvelt. Nel 1934 compare Donald Duck (Paperino).
Nel 1937 abbiamo Biancaneve e i sette nani, il primo lungometraggio a cui
seguono Pinocchio (1939) e Fantasia (1940). Nel 1941 arriva Dumbo, seguito
da Bambi l'anno successivo. Durante lo svolgimento della 2° guerra mondiale, il
Governo USA chiese a molti editori e registi di Hollywood di fare propaganda
antinazista con i mezzi culturali a loro disposizione; nacquero film come “Il
grande dittatore” (Charlie Chaplin, 1940), “Il prigioniero di Amsterdam” di
Alfred Hitchcock, ecc , ma sono stati soprattutto i film di animazione uno dei
media più utilizzati ai fini di propaganda militare volta al rafforzamento dello
spirito patriottico. Non mancò di dare il proprio contributo anche Walt Disney
con ad esempio il cartone animato The Fuehrer’s face (Il volto del Fuhrer) in
cui il povero Paperino è vittima di allucinazioni, incubi infestati di svastiche
e altri simboli nazisti e trova pace solo in una Statua della Libertà in
miniatura. Terminata la guerra la Walt Disney Production riprende la produzione
con nuovi successi cinematografici: Cenerentola nel 1950, Alice nel paese delle
meraviglie (1951), La bella addormentata nel bosco (1958) fino ad arrivare ad
uno dei più grandi successi della Disney, La carica dei 101 (1961). I suoi film
ricevono 32 premi Oscar. Nasce Disneyland. Fumatore accanito, muore il 15
dicembre 1966 a causa di innumerevoli problemi ai polmoni.
IL MASSONE (UN POSSIBILE ENIGMA
MASSONICO) Messaggi subliminali: Walt Disney. Walt
Disney. La più grande industria di cartoni animati, film, fumetti ecc., fondata
dall'omonimo Walt Disney (membro della Massoneria), amata da milioni di famiglie
e da milioni di bambini. Non tutti però sanno che dietro a questa industria si
cela un segreto. Anzi, non proprio un segreto, perchè oramai è noto che nella
maggior parte dei film o cartoni o fumetti della Disney sono presenti messaggi
subliminali visivi. Messaggi a sfondo sessuale e satanico che colpiscono ogni
giorno l'innocenza dei bambini. Per quale motivo usano questi
messaggi? Semplice, la riduzione delle nascite, uno degli obbiettivi
degli Illuminati. Vedendo continuamente i messaggi subliminali di tipo sessuale,
dopo un po' una persona non fa altro che pensare al sesso. Ciò conduce a
infedeltà verso il proprio partner, a matrimoni brevi dove due persone non hanno
il tempo di progettare la nascita di un bambino. Quindi, quale metodo migliore
di colpire, se non colpendo un frutto non ancora maturo? Inoltre la compagnia è
stata coinvolta in un processo, nel 2004, nel quale veniva accusata di aver
inserito dei messaggi subliminali sessuali e satanici nei suoi prodotti e da
dove è venuta fuori soltanto dopo aver pagato 70 milioni di dollari, dimostrando
così la sua colpevolezza. Ovviamente, una volta resi noti, i messaggi
subliminali vengono rimossi nei nuovi DVD e nelle nuove versioni dei film. Ma
ora passiamo ai fatti. Quali sono i messaggi subliminali in questione? Il film
più contaminato è sicuramente "La Sirenetta". Questa è la copertina del film.
Notate niente di strano? Una delle torri del castello è a forma di fallo. Questo
granchio non vi ricorda forse un... fallo? Durante il matrimonio il prete ha una
erezione, o sbaglio? Ma ora guardate quest'altro video: Un altro film
contaminato è "Bianca e Bernie". A quanto pare, su una delle finestre del
palazzo appare un donna nuda. Nel cielo del film "Il Re Leone" le stelle formano
la scritta "SEX". In una scena del film "Chi ha incastrato Roger rabbit?" il
taxi che trasportava Jessica e l'attore Bob Hoskinssi si scontra contro un
lampione e i due vengono sbalzati fuori. Mentre la bella Jessica rotea nel
vuoto, il vestito rosso si alza, ed essa appare senza mutandine. In
quest'immagine, un palazzo a una forma fallica. In un fumetto "Topolino" è
presente una squadra e un compasso, simbolo massonico.
Notoriamente Walt Disney è considerato un Fratello
Massone e come tale citato in diversi elenchi dei Massoni Famosi in circolazione
e nelle citazioni che lo riguardano. Cercare di documentare e/o comprovare
questa appartenenza non è una impresa facile per la scarsissima documentazione
di merito esistente sulla sua vita, la mancanza di studi approfonditi sulle sue
opere e i legami con la nostra Istituzione; l’alternativa è stata quella di
cercare tramite ricerche mirate di ricostruire tale legame attraverso le sue
opere cinematografiche e fumettistiche sfruttando tutte le informazioni
possibili reperite. La sua produzione artistica riguarda storie, apparentemente
banali, ma che hanno segnato un’epoca e che rivediamo ancora volentieri,
specialmente se ci troviamo a svolgere il compito che fu dei nostri genitori;
spesso queste avventure sono ancora presenti nella nostra libreria di casa o
vengono da noi ancora regalate e perché no riviste. Avventure i cui protagonisti
sono animali umanizzati, fanciulle bellissime che soffrono per le angherie
subite da una matrigna/strega, oppure chi non si è identificato in un giovane
Garzone che con l’aiuto di un buon Maestro è diventato Re (e non Re comune ma
nel mitico Artù), oppure quante volte abbiamo sorriso per la danza degli
ippopotami o abbiamo assistito ai guai causati dai poteri magici di Topolino
nella veste di Apprendista stregone e infine chi non ha cantato almeno una volta
la canzone dei Sette nani che andavano al lavoro con i loro picconi in spalla;
gli esempi sarebbero ancora molti ma limitiamoci a dire che in buona sostanza
chi più e chi meno tutti siamo cresciuti con questi capolavori realizzati da
Walt Disney, un personaggio che ci ha affascinato in passato e che ora, da
grandi, ci stupisce per gli innumerevoli messaggi e simboli che scopriamo nelle
sue opere. Sicuramente possiamo dire che il tema di fondo delle sue opere è
un'esaltazione dei valori morali in fiabe a lieto fine da trasmettere ai
principali destinatari delle sue opere; i giovani (e non solo); opere in cui è
presente una costante, un tema ricorrente: la lotta e il trionfo del bene sul
male, della luce sulle tenebre. Partendo da ciò cercheremo di meglio evidenziare
questi messaggi/simboli presenti nelle sue opere quali: Una simbologia palese,
ne è un esempio il vestito di Topolino composto da un paio di braghette rosse
con due bottoni che non sorreggono nulla, il tutto completato da un paio di
guanti bianchi. La persona comune può sorridere su questo buffo modo di vestire
e accettare il tutto senza chiedersi nulla limitandosi a prestare la propria
attenzione alla sola storia che vede protagonista il nostro eroe ma un Massone
riconosce molto bene questi "elementi" e se a ciò aggiungiamo il contenuto della
storia investigativa in cui viene calato di volta in volta il personaggio
riconosce in lui un Fratello che nel mondo profano di Topolinia combatte e
sconfigge il male o se vogliamo dire meglio la sua opera permette di edificare
Templi alla Virtù, scavare oscure e profonde prigioni al vizio e lavorare al
Bene e al Progresso dell’Umanità aiutando il Commissario Basettoni e l’Ispettore
Manetta che, se pur in modo scherzoso, rappresentano l'Autorità e il rispetto
della legge (o se vogliamo dei Regolamenti) nel mondo parallelo di Topolinia. In
questo filone inseriamo tutta una serie di simboli massonici che riportiamo di
seguito; per tutti vale quanto compare in Fantasia nell’episodio della danza
degli animali attorno a un tempietto classico in cui per alcuni istanti è
visibile il simbolo della Squadra e del Compasso. Una simbologia occulta - Il
termine non è bello ma evidenzia bene il messaggio trasmesso dalle storie
raccontate ossia, come già citato, la lotta del bene contro il male e qui
possiamo citare l’esempio di Biancaneve che sfugge ai pericoli e alle paure
presenti nel bosco (il mondo profano - la vita), giunge a una casetta (la
Loggia) in cui vivono sette nani che trascorrono la vita lavorando
quotidianamente in una miniera (l'Officina massonica) da cui estraggono pietre
preziose (già squadrate e che brillano) e con il loro aiuto vince la Strega (la
cattiva matrigna) o se vogliamo il male che l’aggredisce e cerca di ucciderla e
quindi distruggere i valori positivi che rappresenta nella sua innocenza
giovanile. Oltre la storia una particolare riflessione meritano questi nostri
eroi (buffi in apparenza) che aiutano Biancaneve: sette nani o e vogliamo sette
operai che lavorano nelle profondità della loro Officina (la miniera), sette
come i Fratelli necessari per poter dare inizio ai lavori rituali di Loggia e
che giornalmente devono compiere un lavoro senza fine (il percorso massonico)
per far emergere dalle proprie profondità interiori (la caverna) le pietre
preziose (i valori positivi) da utilizzare in un costante impegno quotidiano per
migliorare il mondo profano, la loro lotta contro il male (la strega)
utilizzando i loro strumenti muratori di lavoro. Con il massimo rispetto per i
Fratelli di Loggia i sette nani sono i Liberi Muratori identificati non per i
loro nomi ma dalle caratteristiche personali che li identificano e che ne loro
insieme di diversità sono la ricchezza della Loggia e la guida per cari Fratelli
Apprendisti che, nel caso della fiaba, sono rappresentati da Cucciolo, che (come
sappiamo) non può parlare ma deve osservare e ascoltare con attenzione. Un
esempio di percorso interiore è rappresentato da Semola che nel racconto de “La
Spada nella Roccia” da una condizione di sguattero / garzone tutto fare
attraverso una serie di trasformazioni fisiche e interiori (passaggio attraverso
alcune prove) assume lo stato di Artù (il mitico Re celtico) estraendo la spada
dalla roccia (elemento di unione tra la terra e il cielo) passando da una
condizione terrena iniziale a una condizione superiore impugnando e innalzando
verso il cielo il simbolo solare per eccellenza “la croce” contenuto nella spada
stessa che, da sempre, è stata simbolo di investitura. Per inciso percorso
interiore compiuto grazie agli insegnamenti di un Maestro, Merlino che con i
suoi consigli lo aiuta a squadrare la pietra grezza che è in lui. Il discorso
della simbologia massonica nelle opere di Walt Disney è troppo vasto per essere
esaurito in poche e modeste note biografiche e quindi concludendo (ma non
considerando esaurito l'argomento) conviene limitarci a citare il tema di fondo
della Massoneria " il miglioramento dell'uomo" ricordato nell'episodio di Una
notte su Montecalvo (Fantasia) in cui le immagini e la splendida musica ci
mostrano la vittoria delle forze del bene “simboleggiate dall'apparire della
luce” che sconfiggono e cacciano le tenebre della notte (le forze del male).
Immagini di Walt Disney e di Topolino con i paramenti e le insegne dell’Ordine
De Molay.
Walt Disney, cartoni animati e Massoneria,
scrive Davide Consonni il 12 febbraio 2014 su "Radio Spada". E’ del rapporto tra
Walt Disney e l’esoterismo massonico che si vuole in questo articolo discutere.
Ma non sarò io ad argomentare e disquisire circa il costante rapporto tra le
produzioni della Disney e la massoneria statunitense. Saranno niente di meno che
due membri stessi della massoneria a parlarci di questi rapporti e della
presenza di ampi e vasti riferimenti all’esoterismo massonico all’interno delle
produzioni Disney. Infatti, qui di seguito riporterò per intero una tavola
massonica (elaborato scritto che gli iniziati leggono in loggia durante i lavori
rituali) che tratta proprio del tema sopra accennato. Il titolo di questa tavola
massonica è “La massoneria nelle opere di Walt Disney”, il cui autore è
l’anonimo Fr. E. D., iniziato alla loggia Hocma n° 182 di Trapani.
Successivamente ad aver riportato la suddetta tavola massonica, riporterò per
intero anche un articolo apparso sul sito Ritosimbolico.net ad opera del massone
Giovanni Lombardo, per dovere di cronaca va rammentato che il Lombardo fu colui
che denunziò il Gran Maestro Gustavo Raffi, come potete leggere QUI. L’articolo
di Giovanni Lombardi, massone ribelle, ovviamente tratta dei rapporti tra
l’esoterismo massonico e le opere di Walt Disney. Giusto per metterci anche del
mio in questo articolo, vi invito a visitare il sito ufficiale del Disney Club
33, un club privato con sede nel parco divertimenti di Disneyland riservato ai
finanziatori della Disney. QUI il sito ufficiale e QUI la pagina Wikipedia.
Ritengo inutile argomentare il fatto che nel mondo, anche in Italia, esistano
decine di associazioni para massoniche il cui nome è “Club 33″, le quali,
beninteso, non hanno nulla a che fare con la Disney. Cercare per credere. Prima
di procedere con l’esposizione dei sopracitati documenti massonici e articoli
ritengo doveroso proporre delle coordinate biografiche utili ad inquadrare la
controversa figura di Walter Elias Disney. Walter Disney non fu mai iniziato
alla massoneria, documenti che provino la sua iniziazione sono stati a lungo
cercati ma invano. Ciò che invece è certo che Walter Disney fu iniziato
all’Ordine DeMolay, un’istituzione dimostratamente para massonica viste e
considerate le strette connessioni e collaborazioni che nei decenni sono
intercorse tra i due ordini. La devozione di Walter Elias Disney per il DeMolay
è oltremodo evidente da questa sua celebre dichiarazione: “Mi sento molto
obbligato e grato verso l’ordine DeMolay per la parte importante che ha avuto
nella mia vita. I suoi precetti sono stati inestimabili nel prendere decisioni,
nell’affrontare i dilemmi e le crisi. DeMolay è sinonimo di tutto ciò che è bene
per la famiglia e per il nostro paese. Mi sento un privilegiato per aver fatto
parte dell’ordine DeMolay” [Fonte: Cartoon e massoneria, Ippolito Spadafora,
Edizioni ETS, 2014, p. 172] Inoltre è possibile citare una famosa lettera che
Disney indirizzò ai giovani dell’ordine DeMolay dell’Acacia Chapter in Stuart,
oggi questa lettera è conservata nel Disney History Institute. In questa
lettera, la quale può essere interamente letta a pagina 172-173 del testo
“Cartoon e massoneria” di Ippolito Spadafora, Disney scrive in merito alla sua
iniziazione all’ordine DeMolay ed in merito ai valori esoterici che grazie a
codesta iniziazione sono stati introdotti nella sua vita e quindi nel suo
operato, continua ribadendo il suo orgoglio nel ricoprire la carica di
Legionario d’onore considerando il fatto che fu uno dei primi giovani ad essere
iniziato all’Ordine DeMolay appena sorto e nato nella città statunitense Kansas
City nel 1919. Qui di seguito riporto per intero il testo della tavola massonica
sopracitata: “La Massoneria nelle opere di Walt Disney ha sicuramente aderito
alla Massoneria agli inizi degli anni ‘20, anche se non esiste alcun documento
che provi la sua appartenenza ad un’Obbedienza, se non all’Ordine DeMolay, un
Ordine che negli Stati Uniti si può considerare l’anticamera della Massoneria,
in quanto finalizzato ad avvicinare i giovani tra i 12 ed i 21 anni alla
Massoneria, nel quale Disney fu iniziato nel Capitolo “Mather” nel 1923; ad
esso, ad esempio, aderì Bill Clinton e l’Ordine ha una rappresentanza anche in
Italia.. Tuttavia egli non ha mai nemmeno smentito la sua appartenenza; e la
testimonianza inconfutabile di essere un Fratello si ha nelle sue stesse opere –
sia i disegni che i film o le produzioni televisive – in cui numerosissimi sono
i riferimenti ai principi ed alla simbologia massonica. La prima testimonianza
massonica nelle strip di Walt Disney risale al 1938 con il titolo “Mickey Mouse
Chapter”; pubblicata proprio su l’ “International DeMolay Cordon”, il bollettino
ufficiale dell’Ordine, propone Topolino che, assieme ad alcuni amici, tra cui
Orazio, fonda egli stesso una “Chapter”, cioè una Loggia; della striscia però
rimangono solo 3 tavole: la prima è proprio la Fondazione della Loggia, le altre
due si svolgono durante una Tornata. Ma nelle strisce di Walt Disney spesso
compaiono chiari simboli massonici, quali Squadra e Compasso oppure il
Pentacolo, spesso in bella vista, talvolta più defilati; Squadra e compasso sono
chiaramente visibili in una strip di Topolino del 19 febbraio 2002. Ma le stesse
“Giovani Marmotte” a cui appartengono i nipotini di Paperino Qui, Quo, Qua,
hanno una struttura più massonica che da Boys Scout, con a capo un Gran Mogol
(normalmente chiamato G.M., come Gran Maestro; ricordiamo, in ogni caso, che
anche i Boys Scout sono stati fondati da Baden Powell, anch’egli Massone). Ma
dove Walt Disney ha lasciato più marcata la sua impronta massonica è stata la
sua produzione cinematografica, sia nei film d’animazione che in quelli a
tecnica mista; ricordiamo che Walt Disney dava indicazioni ben precise sulla
sceneggiatura dei film, e controllava i disegni dei suoi operatori fotogramma
per fotogramma prima di dare il via libera; nessun simbolo poteva nascere senza
un suo ordine e la sua approvazione. Tra i suoi cortometraggi, nel 1959
“Paperino nel mondo della matematica” è un vero e proprio manifesto della
cultura massonica ed esoterica: in esso Paperino viene iniziato in una Accademia
Pitagorica, e lì gli vengono spiegati i simboli della numerologia, nonché i
segreti della geometria e della matematica ed i loro rapporti “magici” con la
musica e l’architettura; i segreti del Pentacolo ed i segreti del suo rapporto
con la Sezione Aurea; un bambino non ne può non rimanere affascinato ed
incuriosito, e da adulto probabilmente farà di tutto farà di tutto per
avvicinarsi a questa “visione diversa” delle scienze esatte. Ovviamente, è nei
film che troviamo le maggiori tracce: tal di là dei buoni sentimenti – che sono
caratteristici delle produzioni per l’infanzia – tutti hanno come fil rouge
l’iniziazione ad una nuova vita, l’abbandono dei vecchi valori materiali per
risorgere ad una nuova vita, fatta di valori più alti. Fin dal suo primo
lungometraggio – “Biancaneve e i sette nani” (1937) – Biancaneve muore (per la
Regina e per tutti è morta, uccisa dal cacciatore) per rinascere in una nuova
comunità composta da sette Fratelli; e lo fa dopo avere superato tre prove: un
corso d’acqua, un turbinio di vento, gli occhi di fuoco delle belve: vi entra al
buio, e tutto sembra terribile; ma poi arriva la luce (del giorno) e l’ambiente
diventa confortevole ed ospitale. Anche Cenerentola (1950) muore come serva e
rinasce come Principessa quando abbandona i metalli, cioè perde la scarpina di
cristallo. Ed è superfluo sottolineare i valori massonici di cui sono intrisi
film come “Alice nel Paese delle Meraviglie” (1951) – il labirinto, la
scacchiera, lo specchio – o “Le avventure di Peter Pan” (1953) – gli eterni
valori dell’Isola che non c’è -, “Pinocchio” (1940), “La spada nella roccia”
(1963), che riporta il mito di Camelot, Re Artù e Mago Merlino, e dove il
giovane Artù muore e rinasce Cavaliere dopo essere stato trasformato in
scoiattolo (terra), pesce (acqua) e uccello (aria). Fortemente simbolico è “La
Bella Addormentata nel bosco”; qui il Principe fa letteralmente ritornare alla
vita Rosaspina grazie alle Tre Fatine – Tre Luci – che materialmente non
intervengono nella rinascita, ma forniscono al Principe i mezzi per compiere
l’atto (una “spada di verità” e uno “scudo di virtù”). Ma altri riferimenti li
troviamo in “La Bella e la Bestia” (1991) ed in maniera lapalissiana in “Alla
ricerca di Nemo” (2003), dove l’iniziazione alla Massoneria viene raccontata in
maniera palese. Un’intera tavola meriterebbe “Mary Poppins” (1964); possiamo
solo citare le colonne che adornano l’ingresso della (sola) casa in cui arriva
Mary Poppins con il vento dell’Est (Oriente), la “medicina” di sapore diverso
secondo i gusti dei bambini, la “parola” – Supercalifragilisticespiralidoso –
che ti introduce in un mondo “diverso”, l’iniziazione di Banks che, con un
preciso rituale e per mezzo della parola magica, muore come essere legato ai
metalli per rinascere con nuovi valori, come padre, come marito e soprattutto
come “uomo”. Ma anche in Televisione Walt Disney non manca di lanciare messaggi
di origine massonica: tra il 1957 ed il 1959 produce 78 episodi di Zorro, della
cui origine massonica si è molto parlato: massone era l’autore del personaggio –
Johnston Mc-Culley -, alchimista era il reale personaggio storico che lo aveva
ispirato – Guillèn Lombardo de Quzman – condannato a morte dal Tribunale
dell’Inquisizione come eretico; ed infine il 4° Grado del Rito Scozzese Antico
ed Accettato – Maestro Segreto – ha come divisa il mantello nero e come lettera
simbolica la “Z”; e se non bastasse, Zorro è accompagnato da un servitore
(apprendista) che non può non rispettare l’obbligo del silenzio: infatti è muto.
Ma Walt Disney non si è limitato ad inviare
messaggi simbolicamente massonici: ha firmato massonicamente il suo film forse
più esplicito: “L’Apprendista Stregone”; in questo film, Topolino è convinto di
potersi appropriare delle arti magiche anche senza l’aiuto dello Stregone (il
Maestro); ma combina solo caos, finchè non interviene lo Stregone (il Maestro) a
mettere ordine. E sapete come si chiama lo Stregone? si chiama YEN SID!
Leggetelo al rovescio: DISNEY!
Alla Gloria del G.A.D.U. Fr. E. D.” Qui di seguito
potete leggere il suddetto articolo del massone Giovanni Lombardi: “Quando ho
appreso che anche il celebre Walt Disney apparteneva alla nostra Famiglia
confesso di avere provato un senso di stupore e pure di gioia: avevo finalmente
trovato la giustificazione del sentimento di gratificazione provata da ragazzo –
e mai del tutto scomparsa – quando leggevo le sue storie, i cui personaggi ho
sempre considerato come esseri veri, reali e a me vicini. Da adulto, in
compagnia delle mie bambine, ho spesso rivisitato le sue opere cinematografiche
più famose, che oggi considero a ragione vere e proprie “tavole
architettoniche”, essendo peraltro del tutto accidentale, e d’importanza affatto
secondaria, la circostanza che esse siano tramandate attraverso il linguaggio
‘mitico’ e mediante lo strumento del cartone animato. Di queste opere, la più
famosa è senz’altro Biancaneve e i sette Nani, ma anche le altre, quali La Bella
Addormentata nel Bosco, Cenerentola, Dumbo, La Sirenetta, per citare soltanto le
più famose, si svolgono attraverso un comune filo conduttore: la sconfitta del
Male e l’affermazione dell’Amore. A tanto il protagonista arriva attraverso una
vera e propria iniziazione, nella duplice accezione di ingresso in una comunità
esoterica, nonché di trasformazione dell’Io per effetto di una rinascita
spirituale che si verifica a seguito di varie vicissitudini, o prove
iniziatiche. La vicenda di Biancaneve è paradigmatica: la ragazza è costretta
dalla malvagia matrigna ad abbandonare la casa paterna, simbolo dei valori
pertinenti alla vita vissuta fino ad allora, e a trovare rifugio in un bosco
fitto ed oscuro, che ricorda così da vicino il gabinetto di riflessione. Dopo
aver superato un corso d’acqua, resistito a un turbinìo di vento e vinta infine
la paura suscitata dalla visione degli occhi degli animali, occhi fosforescenti
simili a fiamme lampeggianti, la fanciulla giunge presso una capanna, la casa
dei nani. Rammento che nella lingua tedesca hütte significa tanto capanna,
rifugio, quanto loggia, e ciò non è casuale: invito voi tutti, carissimi
Fratelli, a riflettere quante volte nella Storia la loggia massonica è stata
l’ultimo rifugio per idealisti, eretici o scismatici, colti e incliti, disparati
e disperati, accomunati tutti dall’essere perseguitati dal Potere. A costoro la
Massoneria ha generosamente aperto le porte dei suoi templi, chiedendogli non
già da dove venissero, ma piuttosto dove volessero andare. In questa capanna
accade un fatto apparentemente banale ma in realtà importante: Biancaneve,
anziché lasciarsi sopraffare da un ambiente nuovo e, probabilmente, ostile, lo
esplora e fa amicizia con gli animali del bosco, che vede adesso, alla luce del
giorno, in una dimensione totalmente nuova da quella, erronea e terrifica, della
sera precedente. Si parva licet… questo episodio mi fa venire in mente
l’insegnamento di Platone, secondo il quale l’iniziato deve essere, anzitutto,
“desideroso di conoscere”, e anche di Dante, esaltatore della curiosità di
Ulisse, mosso a varcare i confini dell’ignoto per soddisfare il proprio
desiderio di “virtude e conoscenza”. Ma non basta. In uno slancio di generosità
la fanciulla decide di pulire la casa dei nani, mettendo al lavoro pure gli
animaletti di cui è frattanto diventata amica. Sottolineo questo episodio perché
esalta sia il valore dell’amicizia fra i diversi che l’importanza del lavoro in
comune. Questi temi sono evidentemente cari al Fr. Disney, dal momento che li
ritroviamo in quasi tutte le sue opere. Esemplare è, a tal riguardo, la vicenda
dell’elefantino Dumbo, schernito dai suoi stessi consimili perché afflitto da
due orecchie abnormi, mostruose: ebbene, sarà un topo – questa bestia, nella
realtà, è invisa agli elefanti – a rassicurarlo e infondergli il coraggio
necessario per affrontare le difficoltà della vita. E, guarda caso, le figure da
cui il protagonista riceve aiuto sono quasi sempre le creature più umili,
volendo così sottolineare la perenne antinomia fra Essere e Divenire: i valori
del mondo della Manifestazione sono profondamente diversi da quelli del mondo
dell’Essere e chi è ‘ultimo’ nell’uno sovente è ‘primo’ nell’altro. La
disponibilità ad accettare il prossimo, ancorché diverso e quindi lontano dai
propri modelli paradigmatici, a rimettersi in discussione, è condizione
necessaria ma non ancora sufficiente perché l’opera di catarsi possa dirsi
compiuta: occorre superare varie prove, che riecheggiano molto da vicino le
“prove” iniziatiche che ciascuno di noi ha subito prima di essere proclamato
“fratello”. Sfacciatamente simili a quelle massoniche sono le prove che dovrà
affrontare il giovane Artù nella Spada nella Roccia: accompagnato dal Mago
Merlino, sarà trasformato dapprima in scoiattolo, poi in pesce, quindi in
uccello. Supererà così la prova di terra, di acqua e di aria prima di affrontare
l’ultima, la più impegnativa, quella del fuoco, nella fattispecie, tirare la
spada magica fuori dalla roccia in cui era incagliata. Ci avevano provato in
tanti, cavalieri e non, ed il suo cimentarsi è giudicato follia: ma, talvolta,
solo un “puro folle” può arrivare ai recessi negati invece alla razionalità
farisaica e conformista. La spada è un simbolo ‘assiale’, riecheggia cioè l’axis
mundi, il filo a piombo del Grande Architetto che mette in comunicazione fra
loro gli stati molteplici dell’Essere, microcosmo e macrocosmo, ma è anche un
simbolo solare perché riflette la Luce: emblematica è a tal proposito la scena
del combattimento fra il principe e il drago nella Bella Addormentata nel Bosco.
Le fate, tre come le Luci, hanno appena liberato dai ceppi il giovane principe,
affinché a sua volta egli liberi Rosaspina dal sortilegio della strega. La
quale, nel tentativo di fermare il giovane, si trasforma in un drago
fiammeggiante. Per gli studiosi di psicoanalisi il riferimento è chiarissimo:
“vincere il drago” è infatti l’equivalente di “scavare oscure e profonde
prigioni al vizio”, lottare cioè contro noi stessi per liberare il proprio Io
dalle tensioni e dalle passioni che lo ancorano alla materialità cagionandogli
frustrazioni e sofferenze. Le fate non possono più aiutare attivamente il
Nostro, ma solo assisterlo in forma totemica; tuttavia gli offrono, prima del
combattimento, una “spada di verità” e uno “scudo di virtù”. Al momento di
colpire la bestia la spada si illumina, riflettendo una luce abbagliante,
quindi, vinto il drago, esaurisce la sua funzione e perde così tutto il suo
splendore, ritornando ad essere un semplice oggetto privo di qualsivoglia
valore. Personalmente ho ravvisato in questa scena anche un’esortazione a
considerare i ‘metalli’ per quello che sono: uno strumento, un aiuto per l’uomo,
del quale però egli può e deve fare a meno se realizza che gli sono d’intoppo
per la sua crescita spirituale. Ricordate il Discorso della Montagna? Beati i
poveri di spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli. Ma cosa vuol dire
essere poveri di spirito? Difettare forse di spiritualità? Se però così fosse,
come si potrebbe aspirare al Regno dei Cieli? Osservo che nel testo greco la
locuzione di spirito è tradotta tò pnéumati, cioè è espressa con il caso del
dativo-ablativo, che è, per antonomasia, il caso corrispondente al complemento
di causa efficiente. Credo allora che si possa – e si debba – tradurre: beati
coloro che, deliberatamente, hanno optato per la semplicità, che per libera
scelta hanno privilegiato la dimensione dell’Essere piuttosto che quella
dell’Avere, e ancora, che se chiamati a posizioni di responsabilità, si sforzano
di lavorare per il perfezionamento che prelude all’elevazione di quella porzione
di umanità, più o meno grande, destinataria del loro servizio. Questo tema è
sviluppato assai chiaramente nella Sirenetta. Il vecchio Re del Mare aveva
ceduto alla strega il suo tridente d’oro – simbolo della regalità, del potere
indissolubilmente legato alla saggezza, alla luce – barattandolo con la vita
della figlia. In quel preciso istante tutte le creature marine sono trasformate
in vermi. Dopo che la strega sarà stata uccisa dal principe Erik, l’umano
innamoratosi della sirena Ariel, il tridente, lasciato cadere dalla strega
moribonda, torna ai piedi del vecchio re che, impugnatolo, ritrova le antiche
fattezze, e assieme a lui tutti i suoi sudditi. Se da ciò possiamo ricavare un
insegnamento, mi pare che esso sia il seguente: la Luce, intesa anche come
potestà di comando, non può essere affidata a mani che non sono degne di
riceverla, e di tanto ognuno di noi dovrebbe ricordarsi in tutte le occasioni
della vita, anche e soprattutto in quelle ‘profane’. Alla fine sarà poi proprio
il re Tritone, dapprima così diffidente verso gli umani, a trasformare in donna
la sirenetta sua figlia e concederla in sposa al principe, rammentandoci così
che amare una creatura non significa tenerla perennemente legata a sé, bensì
favorire l’armonioso sviluppo della sua personalità per metterla in condizione
di scegliere con cognizione di causa. Ci sia infine permessa un’ultima
considerazione, sulla magia. L’argomento meriterebbe uno studio più
approfondito, ma non è questo il momento per una trattazione esauriente. Mi
limiterò, perciò, a un breve accenno sul tema, sperando che le seguenti
riflessioni siano di stimolo a chi voglia approfondirlo. Dal latino magis – di
più, maggiormente – magus è, in ambito esoterico, colui che lavora alla
trasformazione del proprio io interiore, non già chi si avvale dei poteri
segreti della Natura per trasformare bastoni in serpenti e suscitare ammirazione
fra gli increduli, come faceva Simon Mago. Per gli alchimisti, la trasmutazione
del piombo in oro era essenzialmente simbolica: in realtà essi miravano a
un’altra metamorfosi, ben più impegnativa ma tanto più feconda: il disvelamento
del divino che è in ciascuno di noi. Chi riesce in questa impresa consegue la
Bellezza nell’accezione archetipa del termine. Così la Sirenetta, oppure la
stessa Biancaneve, a trasformazione avvenuta, estasiate dalla bellezza che le
circonda, provano una gioia prima sconosciuta, laddove Grimilde, la malvagia
regina che, accecata dall’invidia, prepara la mela avvelenata con la quale
uccidere Biancaneve, è costretta a perdere la propria bellezza esteriore e a
diventare una vecchia deforme e ributtante sol per sperare di riuscire
nell’impresa. Siamo così giunti alla fine della pellicola e, con essa, delle
nostre riflessioni. Resta da esaminare il tema della trasformazione, o meglio,
più specificamente, della rinascita, eloquentemente descritto in Biancaneve. La
fanciulla, in sonno, dunque in condizione di profanità, è adagiata in una bara
di cristallo e di oro, simboli alchemici, rispettivamente, di purezza e di
eternità. Nani e bestie la piangono, accomunati dal dolore. La risveglierà il
Principe, con un bacio di Vero Amore, e insieme si dirigeranno a ‘oriente’ dove
si staglia, confusa fra le nubi, una costruzione dai caratteri non ben definiti,
dunque ‘imperfetta’, ma dalla quale ogni spettatore si sente nondimeno attratto,
affascinato dal suo fulgore di Luce.” Non soddisfatto delle argomentazioni
fin’ora portate ritengo doveroso proporre altri esempi di come la cartoonistica
moderna sia permeata di esoterismo massonico, passo a citare esempi forse più
concreti di quelli fin qui esposti. E’ di esempi fin troppo espliciti che sto
per scrivere. Partiamo con il primo: E’ una serie di cortometraggi animati muti
il cui protagonista è Bobby Bumps, prodotti dalla Bray Productions dal 1915 al
1925, di proprietà della Paramount Pictures. La puntata che ci interessa fu
pubblicata nel 1916 col titolo “Bobby Bumps apre una Loggia” [Bobby Bumps starts
a Lodge]. La trama vede protagonista Bobby nel convincere un amichetto ad
iniziarsi nella sua Loggia, gli regala un grembiule e lo benda per
l’iniziazione, proprio come prevede la ritualità massonica. L’amico di Bobby non
ci sta ad iniziarsi nella sua loggia, fugge per la campagna e la foresta
inseguito dal massone Bobby. Giunti ad un dirupo l’amico di Bobby viene
attaccato da un orso. Bobby salva l’amico solo a condizione ch’egli dopo s’inizi
alla sua loggia massonica: Alla fine i due amici vengono iniziati insieme alla
massoneria, infatti la ritualità massonica prevede un periodo di cecità
iniziatica anteposto all’iniziazione vera e propria. Passiamo ora al secondo
esempio d’inizio 900, s’intitola Bimbo’s Initiation [iniziazione di Bimbo] ed è
del 1930. Il cartone animato è davvero molto scuro e bizzarro, ma basta una
minima conoscenza del simbolismo massonico per rendersi conto che il cartone è
tutto sulle società segrete e le tribolazioni che un iniziato deve passare per
essere accettato. All’inizio del cartone animato, Bimbo (un nome azzeccato per
un non-iniziato?) cammina lungo la strada senza curarsi di ciò che accade
attorno a lui. Improvvisamente, Bimbo cade in un tombino/trappola, tanto che è
lo stesso Topolino a intrappolarlo all’interno mettendo un enorme lucchetto.
Strano come questo personaggio sia il reclutatore che porta all’iniziazione
Bimbo. Bimbo si trova nella tana sotterranea di una strana società segreta
composta da uomini mascherati con le candele in testa (che simboleggia
l’illuminazione?). Uno gli chiede: “Vuoi essere un membro? Vuoi essere un
membro?”. Quando Bimbo risponde “NO!”, viene mandato in delle camere che
richiamano le varie prove che vengono imposte ai nuovi iniziati nelle reali
società segrete. A un certo punto, quando si trova nella stanza in cui ha i
piedi incollati al pavimento e una candela sta bruciando la corda che tiene
sopra la sua testa un pannello pieno di spunzoni, Bimbo è indotto a pensare che
sarebbe morto. Le esperienze pre-morte hanno fatto parte delle iniziazioni alle
società segrete fin dall’antichità. Nella prova della “Porta del Mistero”,
(scena in cui si trova di fronte a 4 porte) Bimbo affronta importanti simboli
associati a società segrete: Skull & Bones e il numero 13. Dietro la porta della
Skull & Bones c’è uno specchio, dunque aprendola si trova di fronte a sé stesso.
<<La cerimonia di iniziazione al primo grado prevede una domanda fatta al
profano nella quale si chiede:” Talora foste accettato nella Loggia,
riconoscerebbe colui che fino ad oggi ha ritenuto come suo nemico come
fratello?”. Alla risposta positiva seguirà questa affermazione: “Adesso vi
mostreremo chi è il vostro peggior nemico”. Tolta la benda, gli si offrirà la
sua immagine riflessa nello specchio.>> Dietro la porta numero 13 invece trova
uno scheletro che parla al telefono. Il numero 13 è anche legato ai tarocchi con
la carta della morte di cui il significato principale è relativo al cambiamento.
Può essere interpretato come il mondo materiale in contatto con l’aldilà.
Inoltre il numero tredici nella numerologia esoterica indica la rottura
dell’armonia, incarnando il disordine. Infatti, è il numero che con l’aggiunta
di una unita al dodici, interrompe la ciclicità, obbligando ad una
trasformazione radicale. Il significato del tredici è negativo, infatti è detto
aritmico, rompendo la legge dell’equilibrio e della continuità. Bimbo, dopo
essere riuscito a prendere la bicicletta, entra in una stanza dal pavimento
massonico, nella quale al centro vi è una piscina piena d’acqua. Quando apre la
porta per uscire dalla stanza, scopre che dietro ce n’è un’altra. Continua fino
a che non ha aperto altre 7 porte. Anche il 7 è un numero esoterico molto
importante. Il numero sette esprime la globalità, l’universalità, l’equilibrio
perfetto e rappresenta un ciclo compiuto e dinamico. Considerato fin
dall’antichità un simbolo magico e religioso della perfezione, perché era legato
al compiersi del ciclo lunare. Durante le sue prove terrificanti, Bimbo impara a
conoscere la natura illusoria del mondo materiale, un concetto fondamentale
comunicato nelle iniziazioni occulte. Mentre scappa nel corridoio con delle lame
dentate che si chiudono dietro di lui, ad un certo punto si trova con il cuore
in mano. Questa simbologia è ricorrente nella massoneria e nella fase
d’iniziazione alla massoneria l’iniziato deve dire: «che il mio cuore venga
strappato se tradisco i segreti». Dopo che Bimbo si è rifiutato ripetutamente di
diventare membro della massoneria, viene sedotto da Betty Boop, che gli fa
capire che se accetterà, avrà successo e donne. A quel punto Bimbo accetta di
buon grado. Questi appena esposti sono solamente due degli esempi più lampanti
d’iniziazione massonica presente nei cartoni animati d’inizio secolo. Non sembra
esserci motivo per stupirsi del fatto che con il passare degli anni la
simbologia e i riferimenti esoterici siano sempre più presenti nell’industria
culturale per giovani e giovanissimi.
Walt Disney e la Massoneria
di Antonella Albano del 9 novembre 2016. Mickey Mouse incarna
l’elemento dinamico, allegro, marinettaio, giovanile, curioso e avventuroso e
soprattutto di sostanziale moralità, qualità che permisero a Topolino, e solo a
Topolino, di sfuggire alle rigide censure autarchiche del fascismo, a cui Walt
Disney aderiva essendo stato un conservatore di estrema destra. L’intera
produzione Disney mette in luce i suoi aspetti simbolici e metaforici che fanno
apparire, per chi volesse vederlo, un senso segreto da cui emergono simbologie
massoniche, messaggi subliminali ed immagini archetipiche; una sorta di filo
conduttore magico-esoterico, intessuto di risvolti mitici, leggendari, sino al
punto che alcuni hanno parlato di “nazismo magico disneyano”. Se si vuole, però,
estrapolare da tutta la produzione Disney, la vera firma di Walt Disney, si
deve, secondo me, necessariamente, riferirsi al personaggio, eterno
protagonista, che ha dato vita ad un mondo magico, unico, originale: Mickey
Mouse. La sua prima apparizione avvenne a New York quando fu proiettato sul
grande schermo il primo cortometraggio in abbinamento, per la prima volta nella
storia del cinema, all’utilizzo del “sonoro” (all’interno della pellicola). E
già questo generò clamore e ammirazione in tutto il mondo. Mickey Mouse incarna
l’elemento dinamico, allegro, marinettaio, giovanile, curioso e avventuroso e
soprattutto di sostanziale moralità, qualità che permisero a Topolino, e solo a
Topolino, di sfuggire alle rigide censure autarchiche del fascismo, a cui Walt
Disney aderiva essendo stato un conservatore di estrema destra. Personalmente
ritengo che sia in Mickey Mouse che si concentrino le vere intenzioni di Disney
perché è il personaggio che, essendo stato da lui personalmente “ideato”,
riassume in sé tutti i processi mentali del suo creatore, quindi è impregnato di
tutti i significati, eventuali, di cui lo ha voluto corredare. Indossa guanti
bianchi, talvolta disegnato nella posizione che ricorderebbe un massone
all’ordine d’apprendista. Sua compagna d’avventura Minnie, altrimenti detta
“Minerva”, ornata, nei primi fumetti, in cui compaiono squadre e compassi, con
un non ti scordar di me. In alcune interviste Walt Disney ha dichiarato di
essere affezionatissimo al suo personaggio, di identificarsi con esso, tanto da
prestargli la sua voce nel famoso cartoon “Fantasia” in cui compare il tanto
celebre episodio l’ “Apprendista Stregone”. Donandogli la sua voce lo ha animato
e chiamato ad esistere in sua rappresentanza nel mondo della Immaginazione:
Fantasia appunto. Ed è su questo aspetto della sua produzione che voglio
soffermarmi, sulla scelta del nome “fantasia” e sul celebre episodio di chiaro
riferimento massonico. Questa storia, infatti, è ispirata, anzi identica,
seppure in forma di cartone animato, ad una altra celebre opera di un altro
celebre massone, ovvero la ballata di Goethe (ispirata alla storia del Golem)
intitolata per l’appunto L’apprendista stregone e da cui il celebre compositore
francese Paul Dukas ricavò, un secolo dopo, l’omonimo poema sinfonico. Musica
che Walt Disney ha utilizzato per il suo cartone “Animato”. Questa storia
racconta di uno stregone che lascia solo nel suo laboratorio (Officina – Atanor)
il suo apprendista, raccomandandosi di fare “pulizia”, di tenerlo in “ordine”.
L’apprendista in assenza del suo maestro, di cui indossa il cappello magico
(cappello – testa, mente – keter) si serve di un incantesimo per dare vita ad
una scopa affinché essa compia il lavoro al suo posto. La scopa una volta
attivata, continua a rovesciare acqua sul pavimento, come le è stato “ordinato”,
fino al punto però di allagare le stanze, poiché, nel frattempo, il giovane mago
apprendista non è in grado di impartire un “contrordine”, ovvero non è capace di
gestire, padroneggiare la sua volontà o energia psichica. Così tenta un rimedio,
spezza la scopa in due con una accetta, col solo risultato di peggiorare la
situazione e creare ulteriore “caos”, in quanto anziché interromperne
l’incantesimo, la duplica all’infinito, incrementando esponenzialmente l’energia
che l’attiva, e solo il ritorno del maestro, della saggezza evoluta, rimedierà
al disastro. Il maestro nel cartoon, rappresenta, secondo la mia
interpretazione, il maestro interiore dell’apprendista, o dell’iniziato in
generale; non per caso il nome che Disney ha scelto di assegnare allo stregone,
al Mago, è stato Yensid, ovvero Disney pronunciato al contrario. Fantasia, il
titolo dell’Opera, richiama alla mente il senso di ciò che si cela dietro ogni
opera di Walt Disney e più in generale dietro ogni altra favola:
l’Immaginazione. Non potremmo parlare delle sue opere, dei suoi personaggi se
prima ancora lui non gli avesse immaginati, quindi creati. La parola
Immaginazione è una parola di etimologia latina, ha la stessa radice della
parola Magia, quindi Immaginazione da Imago, aut in-mago. Il mago, nel senso
puro del termine, è colui che estrae dal caos la forma, l’ordine, disciplinando,
canalizzando e infine realizzando la sua volontà. Il Bagatto dei tarocchi. (Le
cose magistralmente pensate, immaginate, sono fatti veri, perché diventano
reali. Kremmerz – “La Scienza dei Magi”). Immaginazione, quindi, intesa come il
Potere di trasformare per mezzo della Volontà, quale vera azione mentale
creatrice, che fissa, cristallizza, la sua Forza, (energia vibratoria del
pensiero) in forme concrete. Così considerata l’immaginazione è il possibile di
cui la realtà invisibile, ovvero ancora non emersa dal regno
dell’indifferenziato, è carica a livello potenziale, è ciò che si annuncia alla
mente e che si canalizza e che, scientificamente parlando, pre-forma ed in-forma
il “campo” per farlo diventare prima progetto mentale e poi realtà. Ma è anche
ciò che vorrebbe diventare reale, ovvero Voce, Sogno, del desiderio mentale
dell’uomo che, immaginando, fantasticando, distrugge, anche solo
momentaneamente, le cristallizzazioni mentali che lo attanagliano in una realtà
quotidiana ripetitiva. Quindi opera di svago. L’immaginazione disneyana si
rivela però essere vero atto magico, destinato a far apparire l’oggetto
desiderato, la scopa si “Anima” e si moltiplica tra le mani del giovane
apprendista solo grazie alla forza del suo pensiero. Come tale ha la capacità di
far esistere (da ex-sistere-uscire dal presente, dall’eterno presente),
qualsiasi realtà e quindi immaginare è un’ azione, un atto operativo, e non solo
contemplazione passiva delle proprie immagini interiori, ma consapevolezza
fondata sulla Idea Madre, che esista un livello, un grado di realtà Energetica
suprema e superiore a tutte le altre forme energetiche e che, fondandosi sulla
onnipotenza del pensiero, ci rende mai realmente separati dalla grande Mater-ia
Eterica, a cui siamo sempre olograficamente connessi. In fondo non è da essa,
dalla Immaginazione, dal grande Vuoto, che nasce Tutto? Così come l’intera
produzione disneyana riconduce ad una corposa “fantasia” primigenia non sono
forse anche tutte le rappresentazioni di Dio, pure “creazioni” umane, fantasie
eccitate o commosse? La favola, la Fantasia, l’immaginazione, è la lingua
materna del genere umano il cui fondamento è da ricercare nella Potenza di
suggestione che essa produce a livello soggettivo. Tutte le religioni devono
riconoscersi quali invenzioni dell’uomo, sistemi cognitivi primitivi, metafore,
ma pur sempre prodotto di fantasia, quindi immaginazione figurale, creazione
visionaria, infine sistemata, cristallizzata, imbalsamata in icone di
appropriazione istituzionale. Rappresentazione scenografica del cosiddetto
sacro, quale desiderio dell’uomo, inventore, attore e autore di storie in cui
proietta se stesso per esprimere e fissare (come l’artista fa sulla tela) le sue
istanze ascendenti, dando Forma ai suoi sogni o ai suoi deliri più arditi, alle
sue Illusioni. Teatro cosmico, eterno carnevale, illusorio, consolatorio, il cui
senso è da ricercare nella esigenza umana di elevazione etica, morale, ma spesso
degradante nel fanatismo iconico, nei feticci, nella superstizione collettiva
del sacro, talvolta anche sofisticata e colta, che mistifica oggetti, statue,
luoghi, esseri umani, decadendo nella idolatria pura, spesso anche e soprattutto
per interessi Profani di un Potere che assoggetta la massa “credulona”.
Oggettivamente tutti i miti sono favole, incluse, per me, le tanto famigerate
rappresentazioni del male classificabile a mio giudizio al genere ironico o
tragicomico. Fictio o oscura sapienza antica? Si sa le favole, i miti religiosi,
restituiscono alla vita le illusioni di cui abbiamo bisogno per sorreggere il
nostro cammino, per dare senso alla vita, le restituiscono il valore
dell’avventura, del sogno, della speranza, ci riportano nel grembo materno
desiderosi di protezione e di sostegno, ci ricollegano ad una realtà sovraumana,
ipotetica, a cui vogliamo credere e a cui per molti versi ci conviene credere,
per de-responsabilizzarci da ciò che comporterebbe, in termini di caos, di
disordine interiore e sociale, la distruzione delle illusioni fondamentali,
quelle su cui abbiamo costruito la nostra instabile, precaria, identità storica
e che ci aiutano a sopravvivere in quella che pensiamo essere la realtà,
stabilendo dei criteri standard a cui fare riferimento nei momenti di crisi,
dissolvendo momentaneamente le nostre paure recondite, principalmente quella del
divenire che è la vita quale inarrestabile mistero che non sempre sembra
prometterci eternità, ma al contempo, ed è questo per me il loro grande pregio,
le favole non ci impongono alcunché, ci lasciano liberi di interpretarle come
vogliamo. La vera favola, come tutte le religioni, (riferendosi al vero etimo
della parola religione) afferma la vita così come è per ognuno di noi e non mai
tentativo di dare voce e forma ad una verità ultima inafferrabile e comunque
ineffabile. Sono storie infinite, l’eterna ricerca con cui l’uomo tenta di
calmare, placare le proprie ansie esistenziali, le proprie angosce, rivestendo
ingenuamente, a volte persino pateticamente i propri interrogativi esistenziali.
Storie di Fantasie intese a rappresentare lo scenario collettivo che ci rende
tutti figli delle stesse domande, vitali perché capaci di motivare nuove
speranze e di dirigere la nostra vita, ma è così che ad esse poi deve, secondo
me, sopravvenire la Ragione, la Scienza, che deve operare criticamente, e nel
senso benefico, demitizzando e trasformando, (convertendo), i misteri in
cognizioni, e la pretesa Conoscenza mistica in Conoscenza scientifica, quindi in
co-Scienza gradualmente elevata a misura non più di sogno, di allucinazione, ma
di Uomo e quindi di risultanze utili e applicabili alle contingenze del
presente, sdoganando il Libero Pensiero proprio in virtù della “creatività
mentale” che ci caratterizza e proprio a beneficio di una sana, decondizionata e
“civile” evoluzione individuale e collettiva. Mortificare i miti, sviscerarli
portarli fuori dal sogno, dalla visione mistica, non significa dichiararsi
agnostici, semmai può significare tentare di andare oltre il dogma, oltre il
sogno, oltre la favola, oltrepassarla, impossessarsene e riportarla a noi in
forma concreta, operativa, utile al bene/Essere personale e della collettività.
Quindi, non demolizione del mito per istaurare altro, ma tentativo di
oltrepassarlo, annichilendo, demolendo, i suoi meccanismi intrappolanti. Quell’apprendista
stregone rappresenta ciascuno di noi che, grazie al suo maestro interiore,
inteso come vera natura decondizionata da tutti i retaggi che la nascondono deve
imparare a riconoscere il suo potenziale interiore, avere il coraggio di
attraversare, esplorare il suo abisso interiore e, attraverso l’assoluta
padronanza di sé, il rigoroso controllo del suo psichismo, della sua Volontà,
riemergere dallo stato di caos e, con l’ausilio dei quella scopa (strumento)
ripulire, riordinare, la propria interiorità, elevando le facoltà intellettive
lavorando (liberi muratori) per la Luce nella Luce. (il Lumen della Ragione-
Conoscenza). Il futuro mago di Walt Disney, è colui che lavora alla sua
trasformazione interiore, non colui che trasforma i bastoni in serpenti o scope
in strumenti di convenienza per suscitare ammirazione nei creduloni come
faceva Simon Mago. In Giordano Bruno, per esempio, il tema della magia (da “de
magia”) è centrale, ma essa è essenzialmente considerata come potere cognitivo
basato sull’uso della immaginazione. Ben lontana, quindi, dall’essere un
risultato di un processo mistico, mette piuttosto in risalto l’emancipazione
interiore, che l’uomo può raggiungere tramite la Ragione, l’Intelletto,
l’Intelligenza, e non tramite superstizioni dogmatizzate. Il nolano condannava
infatti le forme di magia deviata e quindi non compresa, e rivendicava la
dignità della magia al cospetto della sua demonizzazione per mano degli iniziati
ignoranti (nel senso che ne ignoravano il vero significato). Per Bruno il mago é
un saggio con capacità pratiche, non colui che fabbrica talismani, simboli, o
che tenta invano di compiacere un essere trascendente avvalendosi di preghiere,
offerte, pozioni magiche, rituali, cerimonie o altro. Per lui magia significava
scienza (la parola scienza vuol dire conoscenza) e non esitò ad intraprendere
una vivace, forte, aggressiva, polemica contro l’oscurantismo, provocando una
discussione semantica intorno alle parole, mago, magia ed immaginazione. Il mago
di Bruno come l’apprendista stregone di Walt Disney non è in nessun caso lo
stregone che provoca o si provoca, come si suol dire, il “sonno della ragione
partoriente mostri” (come quella scopa impazzita). La magia, come rivela nei
suoi scritti, è scienza che disvela i processi, le dinamiche intrinseche della
Natura, intesa come totalità e oppone lo stregone, (il ciarlatano), al mago,
quale vero “pontefice” tra sé e la totalità. Lo stregone in questo senso è,
rispetto al mago, ciò che sono il superstizioso religioso e l’esoterista
fanatico rispetto all’uomo veramente spirituale ovvero che partecipa, spesso nel
Silenzio, dell’anima universale. Il mago, Yensid che è dentro ognuno di noi,
sperimenta su se stesso e solo in rapporto a se stesso, le dinamiche evolutive
del proprio potenziale e lo fa mettendosi alla prova; infatti dal film di Walt
Disney sono scaturiti i film ispirati alle storie dei cosiddetti “scienziati
pazzi”, ovvero che provano su di sé gli effetti delle loro scoperte. In
Fantasia, il piccolo mago, conosce se stesso commettendo errori, e come lezione
impara a non delegare a terzi la responsabilità o il merito del proprio lavoro
interiore, come ha tentato di fare nel lasciarsi sostituire, per il suo
“lavoro”, da quella scopa. In ogni caso in tutte le favole, molte dalla Disney
Production riprodotte ma di cui non è Walt Disney l’autore, si presenta un
denominatore comune e costante, i protagonisti vivono vere iniziazioni, intese
come ingresso in comunità esoteriche, da cui ha inizio la loro trasformazione
interiore per effetto di una rinascita e in tutte è presente la
Spiritualizzazione degli esseri e delle cose. Alberi e animali che parlano,
oggetti animati, ovvero ogni realtà, ad ogni dimensione, è in grado di
trasformarsi in essere animato e di entrare in rapporto con altre realtà di
altre dimensioni, quella vegetativa con quella umana, quella umana con quella
angelica o elfica, ecc, in altri termini c’è sempre una compartecipazione
“virtuale” al numinoso, in supposizione dell’esistenza di una unica Forza,
intesa come Energia, che si colloca al centro dell’universo magico e ne
costituisce l’energia madre. In effetti la nozione stessa di magia, di scienza,
presuppone l’esistenza prima di una Forza, senza la quale non sarebbe possibile
collegare, e rendere intercomunicanti i processi di conoscenza, una Forza
universale che mette in “comunicazione” fra loro, attraverso una “connessione”
sincronica, gli stati molteplici dell’Essere Universale che si manifesta in
infinite forme. L’Esistenza, l’Essere, ontologicamente, è Eterna fonte di
possibilità che si attuano all’infinito. E’ il principio mentale, Minerva,
l’Oriente, l’Eterna Sorgente, nel senso che è da lì che sorge qualsiasi tipo di
struttura. La scienza, il sale di Minerva, (Minerva, dea della sapienza, dei
fulmini e della guerra, è la controparte di Aries dio della Forza, Athena per i
greci. Rappresenta l’energia evoluta, strategica, mirata al raggiungimento di un
obiettivo, di un risultato) penetra con la sua intelligenza, con la Luce dei
suoi occhi (il suo simbolo è la civetta che vede anche nel buio) le tenebre fino
ad oltrepassare le famose colonne d’Ercole, momento in cui avviene la cosiddetta
e dolorosa “morte delle illusioni” e la rinascita ad oriente, il punto critico
in cui la mente riconosce di essere artefice e prodotto di se stessa. Noi
massoni secondo me abbiamo principalmente il dovere di interrogarci sulla realtà
di ogni giorno ed è abbastanza ovvio che la nostra esperienza esoterica ci
obblighi a mettere in discussione soprattutto la quotidianità, dalla quale non
dobbiamo allontanarci troppo rimanendo ancorati all’esperienza comune,
condivisibile, nel tentativo di risolvere questioni pratiche e sociali, oltre
che interiori; evitando di avvitarci su riflessioni sganciate totalmente dal
mondo che ci circonda; perché, a mio parere, un tipo di speculazione esoterica
che scivolasse costantemente nei meandri dell’astrattismo più radicale e si
scatenasse in fantas/mago/riche descrizioni di realtà che non sono quelle umane
andrebbe respinta o perlomeno ridimensionata e sperimentata, affrontata con
senso critico, in quanto l’Uomo è Uomo, ovvero pensiero calato nella materia e
Materia elevabile a pensiero. E vivere operativamente, “agire” nel mondo
concreto, nella società, ispirati da una sana apertura mentale che sappia
concepire ed accogliere una realtà infinitamente relativizzabile ed
interpretabile, riferendola all’uomo non più idealisticamente inteso come
spirito separato dalla materia, ma all’uomo come Natura , come Totalità, ovvero
come il risultato del continuo interagire tra il singolo e l’ambiente in cui
esso vive: Madre Terra!* In questa prospettiva, la massoneria, secondo me, non
ha esclusivamente una funzione prettamente gnostica, non propone mete di
perfezione (perché riconosce che tutto è perfezionabile all’infinito), al
contrario, essa ci rende consapevoli degli elementi di disordine e di
conflittualità che continuamente emergono nel rapporto tra l’individuo e
l’ambiente o tra individuo ed individuo e ci fornisce gli “strumenti”, insieme
intuitivi, logici ed operativi, adeguati a risolvere tali conflitti, per
instaurare evoluzione sociale, nuova armonia, sempre nuovo ordine. Soltanto
quando portiamo alla coscienza questi aspetti problematici, ovvero quando li
analizziamo, quando li ragioniamo cominciamo a riflettere su di essi, se non si
presentasse alcuna situazione di disagio, (come quella capitata all’apprendista
stregone con la sua scopa) l’esperienza non potrebbe concettualizzarsi, non
potremmo interiorizzarla, quindi non potrebbe diventare conoscenza. Usare la
logica, (il Logos, il Verbo), il Raziocinio, di cui tutti disponiamo e che ci
distingue dalle altre forme di vita, e trasformare una situazione indeterminata,
istintuale e caotica (caos) in una situazione completamente determinata
(ordine). La magia, comunque intesa, non è mai scomparsa e mai scomparirà. Le
sue promesse (la luce, spostarsi rapidamente da un posto all’altro,
comunicazione a distanza, il volo) sono state tutte, e infinite altre ne
verranno, messe in pratica dalla scienza (elettricità, trasporti, telefono,
radio, navicelle spaziali, computer quantico) e tutte inizialmente sono state
percepite come cosiddetti “fatti” del diavolo e accettate con ostilità, con
paura, con pregiudizio e per paura ed ignoranza respinte, condannate, giudicate,
ma non possiamo negare il loro indispensabile, vitale, contributo alla Società
mondiale. Né possiamo negare che l’immaginazione, le favole, i miti, ci aiutino
a mantenere il contatto con il nostro daimon interiore, che nelle vesti di
principe azzurro, si riaffaccia alle porte della torre che imprigiona la nostra
mente, per risvegliarla dal sonno della ragione e della omologazione passiva.
Distinguerci in quanto massoni, tenendoci principalmente distanti dal regno
della Volgarità esoterica, non sottomettendo al suo abominio superstizioso la
nostra Intelligenza e facendo attenzione che ogni nuova conquista intellettiva
non sia che un’altra forma insidiosa di perpetuazione mitica, un’altra favola,
un altro dogma. Tentando di schiudere in noi, invece, la Rosa d’Oriente,
l’Intelligenza di Minerva, la feconda legge della sintesi e al contempo della
espansione, la stella segreta dei “Magi” che conduceva alla caverna interiore
del “Bimbo Re”. Tutte le favole, per finire, ci proiettano in una dimensione
senza tempo e senza spazio, hanno inizio tutte con un “c’era una volta”, non si
sa dove (spazio), non si quando (tempo) ed hanno fine con un “e vissero felici e
contenti”, perché si sa ci facciamo a metà, anzi in mille pezzi, alla ricerca
dell’altra metà, alla ricerca dell’Unità, per riappropriarci di ciò che perdiamo
in ogni istante in cui ci separiamo da noi stessi”. (Solo l’immaginazione ci
rende la vita possibile salvandoci dalle contraddizioni di una ragione che, se
scatenata, produrrebbe il deserto – Hume)
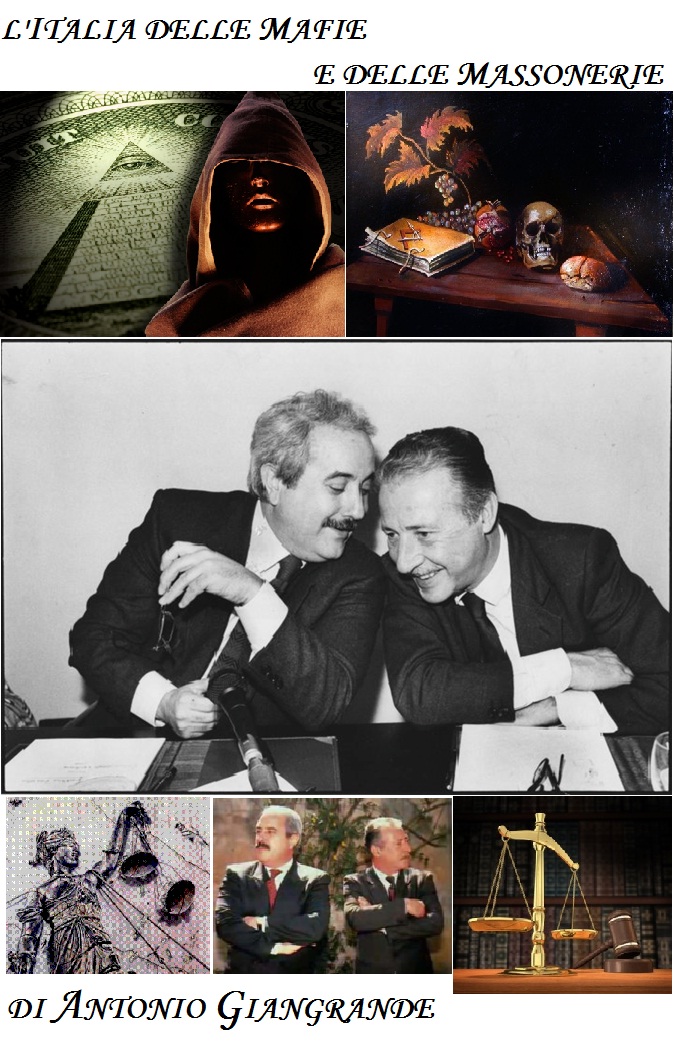



 Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge. PRESENTAZIONE SU
PRESENTAZIONE SU

 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996

 FACEBOOK:
(personale)
FACEBOOK:
(personale)
 WEB TV:
WEB TV:
 NEWS:
NEWS: